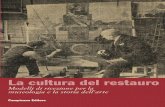Tommaso spiega Tommaso
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Tommaso spiega Tommaso
Tommaso spiega Tommaso sulla questione dell’innatismo
Il presente lavoro vuol distinguersi dalla notevole letteratura riferibile alla polemica tra neotomisti e rosminiani e proprio la lunga militanza nella suddetta polemica, al cui criterio inconcludente intendo ora sottrarmi, mi suggerisce di far precedere al seguente capitolo una
NOTA di METODO Non si può non prendere sul serio l’avvertimento del Padre Matteo Liberatore contro il malvezzo di approfittare a favore delle proprie tesi di testi più o meno isolati all’interno di tematiche disparate dove San Tommaso par dire qualcosa di diverso da quello che altrove ha scritto nel trattare di proposito determinati argomenti: “è sempre regola molto strana, scrive (riferendosi, in gran parte a torto, ai rosminiani) quello di cavare i sensi d’uno scrittore non dai luoghi dove egli prende a discutere direttamente la controversia, ma da quelli dove la tocca per incidenza o dice alcuna cosa che comunque ad essa può riferirsi” (Della conoscenza intellettuale, Vol, II, Prefazone, pag, XI).
Si tatta, però, di una regola prudenziale che va presa con discrezione nel senso che occorre distinguere i testi discrepanti in qualche modo dall’esplicito sentire dell’autore espresso altrove, da quelli, invece, che comportano integrazioni o sfumature tali che ben lungi dallo sconvolgere l’accezione dei termini più comunemente evidenziati ne precisano il senso o ne ampliano o ne limitano, a seconda dei casi, i contenuti favorendo la miglior comprensione di un tutto. Mi spiego con un esempio: San Tommaso si sofferma in 36 luoghi sul notissimo tema della tabula rasa (6 in Super Sententias, 10 nella Summa Theologiae, 3 nella Summa contra Gentiles, 12 in QQ. De veritate, 7 in altre opere), ma in uno solo di questi luoghi: in QQ. De veritate, q. 18 a. 7 co, egli limita il “nihil est scriptum” alle “species” mentre per altro verso avverte non esservi a principio nella mente umana «notitiam nisi eorum quae statim per lumen intellectus agentis cognoscuntur, sicut sunt prima principia universalia». Ora chiaramente nulla vieta ed anzi è giocoforza che ciò valga per tutti i contesti di cui sopra perché non ci si trova di fronte ad una smentita ma ad una precisazione, in questo caso limitante, del “nihil”. Una precisazione limitante che deve dunque essere sottintesa in tutti gli altri testi dal momento che la si può ritenere precisata solo nel testo in parola per particolari esigenze teoretiche all’interno della tematica del De veritate.
Questo tener conto di contesti che. meno ricorrenti, aggiungono alcunché, senza contraddirli, a quelli d’uso più comune nell’ambito di particolari tematiche riveste una grande importanza. Ci riferiamo particolarmente ai contesti dove vediamo indicati come condizione di ogni conoscenza sia il lume dell’intelletto sia i principi primi innati ivi comprese le cognitiones omnibus notae, contesti che non vanno disgiunti da quelli in cui viene affermata la funzione strumentale di detti principi in rapporto all’intelletto agente (considerato come artifex): il che sarà di non poco conto per una critica motivata in senso integrante del modo riduttivo1 in cui neotomisti “bussettiani” intendono la dinamica conoscitiva limitandosi ad attribuirla all’intelletto agente simpliciter, senza tener conto del suddetto ampiamento tematico. Questo criterio discrezionale è quello che abbiamo seguito nella nostra indagine sull’innatismo tomistico, indagine che risulta di fatto altamente favorita, tra l’altro, proprio da alcuni testi poco noti ed ospitati in ambiti tematici estranei a quello gnoseologico cui pur si riferiscono per inciso (ad esempio, come vedremo, per una esemplificazione analogica) ma con una presa di irrinunciabile valenza nella loro incontrovertibile esplicitezza.
1 Si vedano, in proposito, le proposizioni gnoseologiche tra le XXIV redatte dal Mattiussi come sintesi dell’ “autentico” tomismo, dove non si fa neppure un cenno ai principi primi.
* * * Poste le precedenti premesse veniamo ora all’auspicato chiarimento sulla questione dell'innatismo nell’Aquinate circa il quale credo (o spero almeno) d'aver potuto proporre, almeno una base di partenza per un sereno dibattito, con il mio libro "Da Tommaso a Rosmini"2. Si trattava, come ho già ampiamente rilevato, di dipanare il discorso sulla rilevata (per noi apparente) "contraddittorietà" che evidentemente contrappone tanti testi tomistici riferibili alla facoltà conoscitiva in quanto all’apriorità o meno dei principi primi e delle nozioni omnibus notae. Per chiarire prendo ad esempio e pongo a confronto due testi tra i tanti: - primo testo "Noi conosciamo astraendo dalle cose singolari anche gli stessi principi indimostrabili come insegna il filosofo in II Posteriorum" (Q. disp. de Anima, a. 5, co) - secondo testo: "Le nozioni universali la cui conoscenza ci è innata, sono come dei semi da cui
2 Da Tommaso a Rosmini, Indagine sull’innatismo con l’ausilio dell’esplorazione elettronica dei testi,. Marsilio Ed. 2003
tutte le conoscenze seguiranno" (QQ. disp. De veritate, q, 11, a. 1, ad 5). Si tratta, davvero, di due testi emblematici ai quali altri numerosissimi corrispondono negli scritti di san Tommaso. I neo-tomisti italiani, protagonisti della secolare polemica antirosminiana, sottovalutarono, come già abbiamo rilevato, la problematica indotta dalla suddetta apparente contraddittorietà e, nel farlo, ebbero la presunzione di un ruolo insindacabile quali interpreti dell'Aquinate3, mentre di fatto gli attribuivano, a danno della di lui genuina originalità, una eccessiva dipendenza dallo stagirita, quando invece tale dipendenza era piuttosto presente nel loro modo di interpretarlo. Abbiamo già osservato come essi svilivano il contenuto dei testi innatistici riferendoli ad un non ben precisato "habitus" di carattere psicologico (e perciò privo di contenuti sia pure virtuali) atto a cogliere istintivamente, posta l'astrazione dei dati intelligibili operata dall’intelletto agente, anche le correlazioni tra i dati stessi esprimibili nei principi primi.
3 Ribadisco di riferirmi particolarmente a Matteo Liberatore come ad esemplare che vale per tutti i neo-tomisti della sua stessa area interpretativa che risale al “buzzettiano” Serafino Sordi e si è estesa nel tempo fino ad oltre la prima metà del novecento.
Alla nozione di habitus così depauperato attribuivano (come se fossero delle formali ridondanze espressive o dei “come se….”) persino le affermazioni più apertamente allusive ad una nozionalità previa con il depauperamento della significanza ovvia di espressioni come “conoscenza innata” o “preesistono in noi alcune nozioni a tutti note” ed alla stessa surrettizia ateoretica nozione riduttiva di habitus assimilavano il senso dell'intellectus principiorum, che ha invece in san Tommaso, come vedremo, una ben precisa rilevanza nozionale4. Ben diversa l'interpretazione con cui i rosminiani leggevano le suddette espressioni di tenore innatistico attribuibili a parer loro ad una componente platonico-agostiniana presente in San Tommaso accanto a quella aristotelica5. Trascurare tale componente significava, a parere dei rosminiani, considerare un "fuor d'opera" tutti i testi tomistici di carattere innatistico, pur dotati di peso teoretico, e porre perciò San Tommaso in
4 Nel citato lavoro “Da Tommaso a Rosmini” abbiamo pubblicato (pp. 52-‐73) una nutrita “mappa” delle terminologia innatistica di San Tommaso generalmente disattesa o a volte equivocata dai neo-‐tomisti buzzettiani che non soltanto chiusero gli occhi sull’innatismo creazionistico di San Tommaso, ma , maldestri discepoli di Aristotele, misconoscevano persino l’a-‐priori ex natura dello Stagirita. 5 Componente aristotelica, occorre dirlo (e vi abbiamo fatto cenno nella precedente nota) che tuttavia lasciava l’adito, a sua volta, ad una certa, pur problematica, apriorità: problematica perché talvolta, dopo essere stata in qualche modo affermata, par posta in dubbio dallo Stagirita per un’eccedenza verbale a favore dei sensi cui fa tuttavia da contrappeso un non meglio identificato “universale quiescente in anima”.
contraddizione con se stesso. Basandosi su questa loro tesi i rosminiani rivendicavano a Rosmini, che ritenevano ben conscio della componente platonico-agostiniana presente in San Tommaso, una sostanziale concordia teoretica con il dettato dell'Aquinate nel segno di una continuità dottrinale espressa nel trinomio "Agostino, Tommaso, Rosmini", mentre gli avversari neo-tomisti, all'opposto, contrari come abbiamo visto ad ogni risvolto innatistico (sorvolando sul fatto che si sarebbe trattato, semmai, di un innatismo creazionistico - quo Deus loquitur in nobis - com'era invero per Tommaso così come per Rosmini) non solo contestavano ogni commistione teoretica tra Tommaso e Rosmini, ma vedevano anzi nel Roveretano anziché un erede della tradizione cristiana un epigono dell'idealismo tedesco aperto a tutti i più gravi errori facenti capo all'ontologismo e al panteismo. Le due componenti di fatto ci sono in San Tommaso e non mancò ai rosminiani l’opportunità di proporre una profluvie di testi atti a dimostrarne l'imponente valenza, ma mancò loro la possibilità e il tempo, nella foga senza sosta della polemica di giornata, di dimostrare la coesione sistematica di dette componenti in una trascendente visione onnicomprensiva atta a dimostrare la coerenza del dettato tomistico, Di qui l'inconcludenza del dibattito, aggravata dal
carattere metodologico che opponeva testo a testo nel segno di una contraddittorietà senza sbocco, un duello, si potrebbe dire, con una allegoria, "all'arma bianca" e non invece, come sarebbe stato opportuno uno scontro, o piuttosto un confronto strategico supportato da un'ampia sistematica valutazione a largo respiro delle reciproche posizioni. Di fatto, invece, questo duellare schermistico "testo a testo" disancorato da una visione d'insieme atta a segnare il divario tra l'illuminazione divina (qual era quella che i rosminiani scorgevano sia nell'Aquinate che nel Roveretano) e le devianze idealistiche che gli oppositori indicavano come un rischio incombente, offriva il destro a questi ultimi di atteggiarsi a difensori della dottrina cattolica. Fu così che con la loro abile controffensiva6 i neo-tomisti poterono auto-gratificarsi come vincenti stante anche il supporto (dopo la condanna delle 40 proposizioni tratte dai testi del Roveretano) della censura ecclesiastica. Occorreva dunque chiedersi se i testi di tenore innatistico, pur presenti nell'Aquinate, hanno un vero peso teoretico all'interno del suo sistema e se, conseguentemente, lo stridente contrasto di tali contesti con quelli che spiegano il conoscere umano
6 A ragion veduta possiamo parlare di “controffensiva” perché le dottrine rosminiane ebbero inizialmente un notevole impatto ed uscirono ufficialmente indenni con il ”dimittantur”. E’ invece dal “dimittantur” in poi che prese forza la reazione dell’anti-‐rosminianesmo che continuò senza sosta determinando l’esilio del grande Roveretano.
con l'esclusivo percorso astrattivo dai sensi all'intelletto possa veramente considerarsi apparente. Si trattava in altre parole di rintracciare nel sistema tomistico gli eventuali snodi teoretici trascendenti, ad un livello di coerenza, atti a sfatare l'apparente contraddittorietà dei testi suddetti. E' quanto ho cercato di fare con la mia ricerca nella quale mi sembra di aver potuto appurare la necessità di tener conto della componente innatistica per una retta interpretazione della gnoseologia tomistica. E se ciò era già rilevabile dall'abbondanza delle documentazioni testuali raccolte nel mio lavoro mi propongo in questo nuovo intervento di presentarne un'analisi strutturata atta a rendere ancora più convincente tale asserto, anche al di là del valore chiarificatore da me attribuito (e pur vi insisterei) al testo della Questione 51, articolo 1° della Summa Teologica I-II.ae. Tale testo mi parve atto a dirimere il problema della supposta citata contraddittorietà in quanto indicherebbe alla base della facoltà conoscitiva dell'uomo una componente innatistica (l'habitus principiorum") ed una dipendente dai sensi (per species inteligibiles a phantasmatibus acceptas). La nostra interpretazione ci è stata contestata da alcuni in quanto il testo in parola non sarebbe atto a sostenere un innatismo a carattere nozionale, stante l'interpretazione di "habitus" nell'accezione soggettiva (neo-tomista ma non certo tomista) di
disposizione naturale a recepire i principi "nel" dato dell'astrazione, il che salverebbe il "datur in creazione" (siamo dunque ben lungi dal concetto humiano di "abitudine") ma estinguerebbe la "nozionalità apriorica" dei principi. Per giustificare, dunque, ulteriormente la lettura del suddetto testo nel senso dirimente risolutorio delle due fonti del conoscere: l'una a-priori l'altra a posteriori, bisognerà ricorrere a qualche altro testo che confermi il senso oggettivamente innatistico e non psicologicamente recettivo del termine "habitus". Ora non solo esistono a tale scopo testi espliciti, ma esistono in modo da costituire una vera e propria "tesi innatistitica”, il che si può dimostrare dando una sistematica disposizione ai testi tomistici già offertoci dalla nostra esplorazione elettronica a partire dai più ovvii e utilizzando ulteriori utili rilievi testuali atti a non lasciare alcun dubbio residuo. Comincerò col citare due testi che ritengo fondamentali per stabilire l’uno il carattere creazionistico dell’innatismo tomistico, l’altro il carattere nozionale dello stesso. Traggo il primo testo da Scriptum super libros Sententiarum: “habitus infusus similis est habitui innato: quia sicut naturalis habitus datur in creatione, ita infusus in reparatione. Naturalis autem habitus, sicut intellectus principiorum, indiget ut cognitio determinetur per sensum” (lib. 3 d. 23 q. 3 a. 2 ad 1.):
qui sono subito evidenziate le due fonti del conoscere per cui già è rilevabile lo snodo teoretico atto a sfatare l’apparente contrarietà di tanti testi tomistici riferiti alla dinamica conoscitiva i quali invece si completano a vicenda privilegiando gli uni l’apporto dei sensi in riferimento ai contenuti della conoscenza e sottolineando gli altri la forza apriorica dei principi innati in ordine alle leggi del reale e alla certezza. L’altro testo lo troviamo nell'ambito tematico degli intelletti creati ed esattamente nell'affermazione che se l'intelletto umano non avesse modo di accedere alle cose materiali attraverso i sensi, sarebbe comunque dotato di una forma di conoscenza, bensì inadeguata, ma pur sempre "conoscenza": "Manifestum est autem inter substantias intellectuales, secundum naturae ordinem, infimas esse animas humanas. Hoc autem perfectio universi exigebat, ut diversi gradus in rebus essent. Si igitur animae humanae sic essent institutae a Deo ut intelligerent per modum qui competit substantiis separatis, non haberent cognitionem perfectam, sed confusam in communi. Ad hoc ergo quod perfectam et propriam cognitionem de rebus habere possent, sic naturaliter sunt institutae ut corporibus uniantur, et sic ab ipsis rebus sensibilibus propriam de eis cognitionem accipiant» (Summa Theologiae I, q 89, a 1, co). Conoscenza inadeguata, dunque, e in qualche modo “sui generis” in quanto non raggiunge la soglia della
coscienza come meglio vedremo, ma indispensabile, in connessione col corpo per una conoscenza piena (“propriam”), vale a dire, come vedremo, "scientifica" a cui i sensi di per sè non potrebbero mai dar luogo, come del resto non potrebbe mai farsi adeguata, senza l’apporto dei sensi, quella conoscenza previa. La forma ipotetica (si essent istitutae) in cui si colloca, nel suddetto contesto di tenore teologico, l’affermazione di un tal vago innatismo (poco ma importantissimo, come vedremo, pur essendo assimilato soltanto ad una “scintilla” modicum ex igne evolans - Super Sent., lib. 2 d. 39 q. 3 a. 1 co) non ne sminuisce affatto l’attendibilità anche filosofica stante una riflessione di tenore platonico-agostiniano e, a larga constatibilità, anche tomistico, sull’interiorità umana, che per altro verso, offre un punto di partenza teoretico (dall’uomo agli angeli) per giustificare, anche in forma induttiva, un discorso filosofico che sia atto a render ragione del dato teologico sul modus conoscendi delle intelligenze pure nella loro incorporeità. Non si comprende perciò la radicale opposizione angeli-uomo sostenuta dai neotomisti in fatto di conoscenza, e l’accusa di “angelismo” riservata all’innatismo rosminiano. Il fatto è, giova ripeterlo, che nel lumen intellectus agentis essi vedevano solo una virtus astrattiva e ad una semplice facoltà recettiva riducevano, come abbiamo visto, l’habitus
principiorium, recettiva nel senso che anche i rapporti stessi tra le cose dovuti ai principi primi (rapporti causali, proporzionali ecc..) sarebbero colti a posteriori nella stessa operazione astrattiva con una spontanea assimilazione gnoseologica, dimenticando il fatto che per San Tommaso, come vedremo meglio, i suddetti principi primi esercitano in rapporto all’intelletto agente una funzione strumentale condizionante la stessa dinamica astrattiva. Il fatto è che i neotomisti, come abbiamo già osservato, ritenevano genuini solo i contesti dell’Aquinate dove “anche” i principi primi si dicevano derivati dai sensi, non accettando che per la coerenza interna dello stesso discorso tomistico tali contesti dovessero limitarsi a sottolineare l’indispensabilità dei sensi perché potesse avvenire che principi primi, innati ad un livello virtuale (in perfetta corrispondenza nell’ordine creativo secondo San Tommaso - come vedremo a proposito del parallelismo angeli/uomo - con le leggi della realtà) ricevessero “statim” la loro “determinazione esplicitante” in presenza dei puri dati (species) colti per astrazione dalle cose reali indipendentemente dalle loro correlazioni riferibili ai principi. In considerazione di questa deviante lacuna esegetica imputabile ai neo-tomisti è d'obbligo osservare che fu anche il non aver approfondito, in ordine al problema della conoscenza, la tematica tomistica inerente agli
spiriti creati nel loro rapporto con l’anima umana (lacuna già fortemente denunciata dal brillante tomista domenicano Padre Raimondo Spiazzi) a favorire l'interpretazione pericolosamente riduttiva dell'habitus principiorum. E’ dunque chiaro che davvero non è una constatazione peregrina a base ipotetica (se Dio avesse stabilito ecc….) quella di una conoscenza previa "confusa in communi" (cui ben s'addice l'accostamento alla rosminiana idea indeterminatissima dell'essere… e non v'è conoscenza senza l'essere, ma di questo altrove) ma è anzi, insistiamo, una tesi basilare ed altrove fortemente e ripetutamente ribadita dall’Acquinate. Così avviene, per esempio, proprio nel testo già citato, con larghezza di motivazioni, dove si sostiene bensì la configurazione dell'intelletto umano alla stregua di una "tabula rasa", ma dove troviamo, ad un tempo, quel "nisi" molto significativo che si riferisce proprio alla conoscenza previa vaga e comune che viene qui individuata in equivalenza al complesso dei principi primi: «intellectus humanus est ultimus in ordine intelligibilium, sicut materia prima in ordine sensibilium; et sicut materia secundum sui essentiam considerata nullam formam habet, ita intellectus humanus in sui principio est sicut tabula in qua nihil est scriptum, sed postmodum in eo scientia per sensus acquiritur virtute intellectus agentis. Sic igitur
principium naturalis humanae cognitionis est esse quidem in potentia ad omnia cognoscibilia, non habere autem a principio notitiam nisi eorum quae statim per lumen intellectus agentis cognoscuntur, sicut sunt prima principia universalia» (QQ. De veritate, q. 18, a. 7, co). "Tabula rasa", dunque, in ordine alle conoscenze piene e determinate (le species rese completamente note grazie, come vederemo, all'astrazione e alla strumentalità dei principi) ma non "tabula rasa" in ordine alle nozioni previe che in quanto indeterminate sono ancora in una fase di potenzialità nella quale si verifica, come vedremo, uno scire inconsapevole che si renderà cosciente nell’addiscere. Ancora più eclatante e direi decisivo l’altro testo, sopra citato, che si potrebbe porre nell'ordine del paradosso in quanto teso a togliere ogni dubbio: «cognitio primorum principiorum determinatur in nobis per sensus, qui si etiam destruantur, non minuitur certitudo principiorum, quae non est acquisita, sed naturaliter insita» Super Sent., lib. 1 d. 17 q. 2 a. 5 ad 4. La frase si trova in un contesto riguardante la carità come virtù infusa, la quale proprio perché infusa non può venir meno a causa di peccati che non distolgano l’uomo dal suo fine: e a tal proposito San Tommaso si serve, a modo di esempio, del riferimento ai principi primi in quanto innati e perciò ineliminabili. Se ne deduce che l’innatismo dei
principi primi, proprio perché ritenuto adatto ad emergere come “esempio” in un confronto tra analogati di ben diverso ambito tematico, fa parte di una radicata convinzione dello stesso Aquinate. Si consolida così la tesi dell'esistenza in San Tommaso della componente platonico-agostinana sostenuta dai rosminiani. E più ancora che vederla confermata da questi testi possiamo vederla esplicitamente affermata dall'Aquinate sulla scorta dello stesso Aristotele, in un testo che di tale componente ci fa conoscere il senso e i limiti. Infatti ben lontano dall’innatismo platonico, Aristotele non concedeva tuttavia la sua approvazione a quanti negavano ogni tipo di cognizione previa (cfr. In Libros poster. Analyt. lb I lc 3 n. 4 ) e proponeva per parte sua, a correzione della predetta opinione, una soluzione conciliante, che San Tommaso, nel darne una chiara delucidazione, accoglie senza difficoltà: «ponit [Philosophus] veram solutionem dubitationis praedictae secundum praedeterminatam veritatem, dicens quod illud quod quis addiscit, nihil prohibet primo quodammodo scire et quodammodo ignorare». (In Libros poster. Analyt. lb I lc 3 n. 6)». I neo-tomisti, Liberatore in testa, non recepirono questa duplice accezione del fatto "nozionale", questo rapporto, cioè, tra uno "scire" (virtuale) e l'"addiscere", e di fronte alla profluvie dei testi in cui l'acquinate affermava che “anche” i principi primi si
"conoscono" partendo dai sensi finirono per deligittimare il significato proprio del "per se noti" pur ampiamente affermato dei principi e ricorsero all'accezione deviante dell'habitus come semplice disposizione naturale a recepire i principi “nei” dati del'astrazione, che invece di detti principi, noti per se, non sono rivelatori ma determinatori e occasione di esplicitazione per azione dell’intelletto agente. Eppure San Tommaso aveva chiaramente definito il senso del per se nota: .” Potest enim aliquid dici per se notum dupliciter, vel quia per nihil aliud in eius notitiam devenitur, sicut dicuntur prima principia per se nota; vel quia non sunt cognoscibilia per accidens, sicut color est per se visibilis, substantia autem per accidens” (Summa Th. I, q. 87 a. 1 ad 1) Ed aveva inoltre chiaremente giustificato, l’Aquinate in accordo con Aristotele, il duplice "modus cognoscendi": “Non enim est inconveniens si aliquis quodammodo praesciat id quod addiscit; sed esset inconveniens si hoc modo praecognosceret, secundum quod addiscit. Addiscere enim proprie est scientiam in aliquo generari. Quod autem generatur, ante generationem neque fuit omnino non ens neque omnino ens, sed quodammodo ens et quodammodo non ens: ens quidem in potentia, non ens vero actu: et hoc est generari, reduci de potentia in actum. Unde nec id quod quis addiscit erat omnino prius notum, ut plato posuit, nec omnino ignotum, ut secundum
solutionem supra improbatam ponebatur; sed erat notum potentia sive virtute in principiis praecognitis universalibus, ignotum autem actu, secundum propriam cognitionem. Et hoc est addiscere, reduci de cognitione potentiali, seu virtuali, aut universali, in cognitionem propriam et actualem (In Libros poster. Analyt. lb I lc 3 n. 6.)». Perché i principi primi, per se noti a livello indeterminato, si facciano noti "secundum propriam cognitionem" occorre, dunque, l'acquisizione astrattiva delle "species" ossia dei dati, ma le species, vale la pena ribadirlo, non portano a conoscenza le proprie reali correlazioni, ma nell'atto di "determinare" i principi vengono a loro volta conosciute nelle loro correlatività (così dicasi ad esempio della correlativita di "maggioranza" tra un tutto e una parte o di "causalità" tra un evento antecedente ed uno conseguente) in perfetta corrispondenza con la loro correlatività reale onde sarà ulteriormente approfondita la loro conoscenza. Il che San Tommaso chiaramente afferma in questo illuminante contesto: - «Ad primum ergo dicendum, quod sicut invenimus in processu cognitionis, quod in cognitionem principiorum venit quis per principiata, quibus tamen habitis, magis ipsa cognoscit quam principiata; nec indiget principiatis ad cognitionem principiorum quae jam per se cognoscit; neque tamen principiatorum cognitionem amittit; immo illa
cognitio per principia perficitur: ita est in processu hominis in Deum, qui per creaturas in deum venit: quo habito, creaturis non eget ad ipsum habendum, sed per ipsum venit in perfectum usum omnium aliorum» (In I Sententiarum ds I q. 4 a. 2 ra 1): come si va dalle creature al Creatore così si va dai principiati (per esempio dagli effetti che dipendono in re dal principio di causa) alla conoscenza attuale dei principi già per sè in mente virtualmente noti. E’ chiara in questo testo l'indicazione dei due momenti della conoscenza dei principi: quella previa (indeterminata) e quella piena intesa come una forma di "esplicitazione cosciente" in presenza dei dati dell’astrazione cui viene assegnata una funzione potremmo dire (mutatis mutandis) di “catalizzatori”, mentre viene escluso esplicitamente il bisogno di servirsene per la conoscenza stessa dei principi: nec indiget principiatis ad cognitionem principiorum quae jam per se cognoscit. Ci si potrebbe chiedere a questo punto se non si affacci un problema: quello classico del ponte: come può avvenire, infatti, che l'intelletto umano acceda alla conoscenza incontestabile dei rapporti delle cose, e quindi alla conoscenza "scientifica" del reale, avendo a disposizione soltanto i dati indipendentemente dalle loro correlazioni esprimibili nei principi? San Tommaso stesso ci suggerisce la soluzione del problema: Sicut enim omnes rationes rerum
intelligibiles primo existunt in Deo, et ab derivantur in alios intellectus, ut actu intelligant; sic etiam derivantur in creaturas ut subsistant (Summa Theologiae I, q. 105 a. 3 co). Ben sappiamo che ci si potrebbe obiettare che ciò, secondo San Tommaso, è vero per gli angeli e non per l'uomo e ci si potrebbe portare a smentita quest'altro contesto: “Sed e converso scientia nostra causata est a rebus, inquantum, scilicet, eam a rebus accipimus” (De veritate, q.2 a. 14 co) Ed è verissimo. Senza il ricorso astrattivo alla conoscenza delle cose non vi sarebbe scienza perché non esisterebbe nessun incentivo atto a rendere espliciti alla coscienza i principi primi innati su cui si basa la scienza umana ed è per la stessa ragione che San Tommaso, come già Aristotele, afferma talvolta che gli stessi principi dipendono dai sensi (intendendo che senza i sensi la presenza previa dei principi risulterebbe inefficace), ma a dimostrare che il succitato testo della Summa (q. 105 a. 4 co) vale bensì in toto per la conoscenza angelica, ma vale altresì anche per l'uomo per quanto riguarda i principi primi innati di cui egli è dotato abbiamo chiarissima la testimonianza di San Tommaso stesso secondo cui l'intelligenza umana "tenet ultimum gradum in genere intellectualium substantiarum, ut ex modo intelligendi percipi potest. Et inde est quod anima intellectualis dicitur esse quasi quidam horizon et confinium
corporeorum et incorporeorum, inquantum est substantia incorporea, corporis tamen forma" (Contra gentiles, lib, 2 cap. 68, n. 6). Non è dunque segnata la natura dell'anima umana, in rapporto alla natura angelica, da una radicale alterità, come vorrebbero i neo-tomisti che, come già abbiamo rilevato, accucavano Rosmini di "angelismo" per la sua dottrina sull'innatismo dell'essere, ma è dotata di una contiguità che la caratterizza, sia pure all'ultimo livello, come sostanza intellettiva onde può ben dirsi che "animae umanae, habent potentiam intellectivam non completam naturaliter, sed completitur in eis successive per hoc quod accipiunt species intelligibiles a rebus ( Summa Th. I, q. 55, a. 2 co) sicché, in altre parole "«quamvis cognitio animae humanae propria sit per viam rationis, est tamen in ea aliqua participatio illius simplicis cognitionis quae in substantiis superioribus immittitur, ex qua animae humanae vim intellectivam habere dicuntur» (QQ. De Veritate, q. 15 a. 1, co) ed per questo che v'è nell'uomo, sia pure ad un livello molto inferiore (quello dei principi primi) , un certo parallelismo con il modus cognoscendi dell'intelligenza angelica «Oportet ergo quod in anima rationali, quae angelis in ordine creaturarum configuratur, unde et talis virtus intellectus vocatur, secundum quod est in speculativis, quae etiam secundum quod in operativis est, synderesis dicitur: et haec virtus scintilla convenienter
dicitur, quod sicut scintilla est modicum ex igne evolans; ita haec virtus est quaedam modica participatio intellectualitatis, respectu ejus quod de intellectualitate in angelo est: et propter hoc etiam superior pars rationis scintilla dicitur quia in natura rationali supremum est» (Super Sent., lib. 2 d. 39 q. 3 a. 1 co). Il parallelismo di cui abbiamo parlato può ben dedursi dai testi suddetti, ma preferiamo che sia lo stesso San Tommaso a renderne esplicita testimonianza: «Sicut a Veritate intellectus divini effluunt in intellectum angelicum species rerum innatae, secundum quas omnia cognoscit, ita a Veritate intellectus divini exemplariter procedit in intellectum nostrum veritas primorum principiorum, secundum quam de omnibus iudicamus. Et quia per eam iudicare non possumus nisi secundum quod est similitudo primae veritatis, ideo secundum primam veritatem de omnibus dicimur iudicare» (QQ. de Veritate, q. 1, a. 4, ad 5) e ancora «...sicut intellectus noster se habet ad ista principia, sic se habet angelus ad omnia quae naturaliter cognoscit. Et cum cognitio principiorum in nobis sit altissimum nostrae scientiae, patet quod in supremo nostrae naturae attingimus quodammodo infimum naturae angelicae [...]. Unde sicut nos sine discursu principia cognoscimus simplici intuitu, ita et angeli omnia quae cognoscunt; unde et intellectuales dicuntur; et habitus principiorum in nobis dicitur
intellectus» (QQ. de Veritate q. 8 a 15 co). E' difficile poter conciliare queste esplicite affermazioni con la riduzione dei principi innati "per se noti" (e già abbiamo rilevato con l’Aquinate il senso del “per se noti”: Summa Th. I, q. 87 a. 1 ad 1) alla semplice predisposizione soggettiva a conoscerli, il che oltre al resto eliderebbe l'a priori nozionale che abbiamo visto recisamente confermato, se pur ve ne fosse bisogno, nel citato brano In I Sententiarum ds I q. 4 a. 2 ad 1 ove si legge, giova ripeterlo, "nec indiget principiatis ad cognitionem principiorum quae jam per se conoscit”. Resta quindi accertato in senso proprio che "homo ignotorum cognitionem per duo accipit; scilicet per lumen intellectuale, et per primas conceptiones per se notas, quae comparantur ad istud lumen, quod est intellectus agentis sicut instrumenta ad artificem. Quantum igitur ad utrumque, deus hominis scientiae causa est excellentissimo modo; quia et ipsam animam intellectuali lumine insignivit, et notitiam primorum principiorum ei impressit, quae sunt quasi seminaria scientiarum; sicut et aliis rebus naturalibus impressit seminales rationes omnium effectuum producendorum. (De Veritate, Q. 11, Art. 3 in co). Si tratta di un testo ricco di rilevanti implicanze che ci daranno modo di fare considerazioni importanti in rapporto ad alcuni termini assai pregnanti: lumen et conceptiones per se notas (… lumine insignivit, et
notizia primorm principorim ei impressit)7 intrumenta ad artificem (strumenti dunque, sicché l’omnia facere dell’intelletto agente non prescinde per sè dall’azione degli “strumenti” e ne avremo
7 Questo interessante coinvolgimento apriorico del lumen con i principi primi è posto in rilievo dall’Aquinate in altri importanti contesti: così in De unitate intellectus c,. 5 vede nell’intelletto agente e nei primi principi per se noti il principium naturale scientiae, e in Qudlibeta X, q. 4, art. 7, co precisa anche l’accezione di “principi primi” o “cognitiones per se notae” includendovi le nozioni semplici di base (su cui domina naturalmente la “ratio entis”): Haec autem resultatio veritatis est quantum ad duo: scilicet quantum ad lumen intellectuale, … et quantum ad prima principia naturaliter nota, sive sint complexa sive implexa (che certo sta per “incomplexa” termine che troveremo più innanzi in un altro contesto diventato famoso). Si veda anche In I Sent. ds. 34, q. 2, a. 1. ad 2; In Job. cp. 38 .Ben a ragione i Rosminiani si “appellarono” a questi testi per dimostrare confermata dall’Aquinate la loro tesi innatistica ma a nulla valsero le loro argomentazioni. Si veda, ad esempio, la faciloneria con cui Liberatore si destreggia per stroncare, come al suo solito, ogni rivalsa dei suoi avversari: “si danno a credere (i rosminiani) che il Santo Dottore sostenesse in qualche modo le idee innate… Molto più poi si ostinano in tal pensiero, quando si imbattono in quel luogo dove l’Aquinate dice espressamente … Ignotorum cognitionem per duo accipit: scilicet per lumen intellectuale, et per prima conceptiones per se notas, quae comparantur ad istum lumen … sicut instrumenta ad artificem… Ecco, essi dicono, che San Tommaso distingue due cose: la luce intellettuale e la conoscenza dei primi principi; ed ammette innata in noi non solamente la prima, ma eziamdio la seconda… nondimeno essi stessi si trovano poi grandemente impacciati nel vedere che il medesimo S. Dottore afferma in altri luoghi con non minore asseveranza che la conoscenza dei princìpi trae origine dai sensi e dall’astrazione dell’intelletto agente “(Della conoscenza intellettuale, Vol. II, pp,365-366). Ma a parte il fatto che semmai i rosminiani avrebbero potuto opporre ed opposero tanti contesti atti a contestare la tesi rivendicata dal Liberatore, stante la scelta di campo, è chiara la sua assoluta mancanza di senso critico in rapporto ai contenuti teoretici del testo contestato: nulla gli dicono infatti i termini “concepitiones per se notas”, “instrumenta ad artificem” di cui vedremo l’importtanza apriorica. Il fatto è che il Liberatore per salvaguardare il suo punto di vista, presume di farsi interprete insindacabile del senso d’uso del voci tomistiche di area apriorica sottraendole all’ovvietà.
conferme)8, seminaria scientarum (in ordine alla ragione). Diremo anzitutto, per quanto riguarda il lumen. che si è molto discusso sulla identificazione o meno in San Tommaso dell'intelletto agente con il lumen intellectus agentis (Liberatore sembra protendere per l’identificazione). A questo proposito ci sembra significativo nel presente contesto la qualificazione del lume con il "quod est intellectus agentis”, ma non intendiamo approfondire qui la questione. Vorremmo piuttosto ricordare, en passant, la convizione di Rosmini "che questo cotal lume dell’intelletto agente, che si tiene sotto la coperta della metafora, e dal quale negli scrittori antichi non si trova, o mai, o certo di rado o alla sfuggevole, levato il velo, sia pure l’idea dell’essere»9. Tale teoria fu contestata dal Liberatore senza tener conto che per il Roveretano il lumen si distingueva dalla facoltà dell'intelletto agente: comunque stiano le cose e checché ne sia dell'opinione del Roveretano10 sta di fatto che non si
8 San Tommaso parla della strumentalità dei principi primi in Super Sent. Lib. 2 q. 1. a 5 co; QQ De vertate, q. 9, a. 1 ad 2; q.10, a. 13 co; q.11. a. 1 co; q11,a. 3, co; Q De anima a. 4 ad 6; a. 5 co; Quodlbeta X, q.4 ad 2. Benché la strumentalità dei principi sia più ovvia nell’ambito della ragione che ha nel lumen la sua radice essa ha tuttavia il suo rilievo anche nell’ambito fontale del processo conoscitivo e non mancano in San Tommaso, a questo riguardo, cenni più o meno espliciti. 9 Nuovo Saggio sull’origine delle idee, Voll. 3, Città Nuova Ed. , Roma, Vol. II, nota 21 al § 467, p. 63 10 L’opinione rosminiana sembrerebbe più vicina, a dir vero, al dettato di san Bonaventura che a quello di san Tommaso il quale non identifica il lumen con
può prescindere dall'essere parlando dei principi i quali sarebbero impensabili senza l'essere, come non si dà comunque “nozione” esplicita od implicita che sia senza l'essere il che è verissimo anche per San Tommaso: "Ad huius autem evidentiam sciendum est, quod, cum duplex sit operatio intellectus: una, qua cognoscit quod quid est, quae vocatur indivisibilium intelligentia: alia, qua componit et dividit: in utroque est aliquod primum: in prima quidem operatione est aliquod primum, quod cadit in conceptione intellectus, scilicet hoc quod dico ens; nec aliquid hac operatione potest mente concipi, nisi intelligatur ens. Et quia hoc principium, impossibile est esse et non esse simul, dependet ex intellectu entis, sicut hoc principium, omne totum est maius sua parte, ex intellectu totius et partis: ideo hoc etiam principium est naturaliter primum in secunda operatione intellectus, scilicet componentis et dividenti" (Sententia metaphysicae, lib. q I. 6 n. 10). Queste considerazioni ci riportano ad approfondire l'accezione tomistica di principi primi e delle notiones omnibus notae come seminaria scientiarum e l'approfondimento ci viene favorito dal seguente contesto: "praeexistunt in nobis quaedam scientiarum
l’essere ma fa del lume, come vedremo, il rivelatore “statim” della ratio entis che tuttavia, a livello ancora inconscio avrà un ruolo strumentale e dunque sintesistico in rapporto alla dinamica astrattiva. Nel che può trovarsi analogica concordanza tra le due posizioni.
semina, scilicet primae conceptiones intellectus, quae statim lumine intellectus agentis cognoscuntur per species a sensibilibus abstractas, sive sint complexa, sicut dignitates, sive incomplexa, sicut ratio entis, et unius, et huiusmodi, quae statim intellectus apprehendit. In istis autem principiis universalibus omnia sequentia includuntur, sicut in quibusdam rationibus seminalibus". Questo importante contesto ci dice chiaramente che per l'Acquinate i principi primi da cui dipende tutto il sapere (sicut in quibusdam rationibus seminalibus) consistono non solo in alcune proposizioni per se note (complexa) ma, alla fonte, nei loro stessi elementi semplici (incomplexa): elementi semplici e principi sono appunto le "primae conceptiones intellectus" ed è in forza del lumen (“lumine intellectus agentis”) che vengono esplicitamente conosciute (e si ricordi che qui il conoscere è un addiscere) nell’istante stesso (statim) in cui vengono astratte le species che devono essere considerate come dei dati per la cui presenza intellettiva vengono determinati i principi i quali si esplicitano, appunto, per species a sensibilibus abstractas. Resta con ciò accertato che anche la "ratio entis" fa parte dell'apriorità nozionale per cui credo si possa azzardare l’ipotesi che, secondo l’Aquinate avvenga, in qualche modo, nello stesso istante (statim) l’astrazione del quod quid est e l’esplicitazione della ratio entis.
Ed è quindi stupefacente che proprio questo testo sia stato usato ripetutamente dal Liberatore (a pag. 103, 143 e 316 del II volume de “La conoscenza intellettuale”) per dimostrare "inconfutabilmente" (contro la “pretesa” di Rosmini di acquisire la complicità di San Tommaso) che l'idea dell'essere si acquisisce per l’Aquinate tramite le sensazioni. Ma, ahimè, questo contesto fu da Lui usato impropriamente con una omissione gravissima che ne sconvolge il senso anche a scapito della stessa correttezza grammaticale per cui riteniamo utile riproporlo indicando tra parentesi quadre e in rilevo tipografico la parte sottratta e sostituita con dei puntini: "praeexistunt in nobis quaedam scientiarum semina, scilicet primae conceptiones intellectus, quae statim lumine intellectus agentis cognoscuntur per species a sensibilibus abstractas, [sive sint complexa, sicut dignitates, sive incomplexa] sicut ratio entis, et unius, et huiusmodi, quae statim intellectus apprehendit" (QQ. de Veritate, q. 11 a.1 co). Viene così deviato il riferimento di ratio entis et unius ecc… al termine neutro incomplexa (riferibile a sua volta a semina) e favorita invece l’assurda identificazione della ratio entis et unius ecc … con le species a sensibilibus abstractas (species a sensibilibus abstactas… sicut ratio entis ecc….) Strano a dirsi, poco meno di un secolo piú tardi (1955 centenario della morte di Rosmini) quel testo
ricompare con la stessa omissione in un perentorio articolo di F. Olgiati (nel vol. della "Riv. di Filos. Neoscolastica", p. 297) che ostentava l’intenzione di farla finita con la pretesa dei rosminiani di accomunare l’Aquinate col Roveretano. Del resto, a parte il fatto che il testo suddetto era stato usato impropriamente in ordine a quanto si voleva dimostrare, non fa comunque meraviglia che anche la ratio entis, pur facendo parte delle concezioni che “praeexistunt in nobis”, presupponga l’astrazione universalizzante del “quod quid est” per essere perfettamente ed esplicitamente conosciuta o potremmo dire “riconosciuta”11. Il che è vero per tutti i principi complessi o incomplessi per se noti che si attingono con l’addiscere ossia si esplicitano per opera dell’intelletto agente in presenza delle species astratte onde è comunque sempre vero che i dati dell’astrazione sono soltanto una componente del conoscere in pienezza al che si giunge per opera
11 Per quanto, appunto, non faccia meraviglia che anche l’ens possa essere “detto” astratto alla stessa stregua e con la stessa riserva dei principi primi in genere, osserviamo che al di là del testo citato che gioca piuttosto a favore dell’apriori, il Liberatore si richiama, per dimostrare che l’idea dell’essere è frutto d’astrazione, a due altri luoghi dei quali l’uno (Summa th. I, Q. 85, art. ad 2) non sembra fare al caso trattando non tanto, direttamente, dell’atto d’astrarre quanto piuttosto della gradazione degli astratti, l’altro, (Super De Trinitate, pars 1 q. 1 a. 3 ad 3) non è tale da risparmiare al Liberatore stesso qualche appunto circa una svista di trascrizione di un “primo” che diventa “prima”: Il testo corretto è infatti: quamvis illa, quae sunt prima in genere eorum quae intellectus abstrahit a phantasmatibus, sint primo cognita a nobis, ut ens et unum ecc… dove quel primo (avverbio) cognita in rapporto al precedente prima (aggettivo) … pare alludere alla dinamica conoscitiva dell’addiscere che presuppone uno scire.
dell’intelletto agente in forza dei principi primi nella loro funzione strumentale: “Haec autem resultatio veritatis est quantum ad duo: scilicet quantum ad lumen intellectuale, de quo in Psal. IV, 7: signatum est super nos lumen vultus tui, domine; et quantum ad prima principia naturaliter nota, sive sint complexa sive implexa. Nihil autem possumus veritatis cognoscere nisi ex primis principiis, et ex lumine intellectuali; quae veritatem manifestare non possunt, nisi secundum quod sunt similitudo illius primae veritatis: quia ex hoc etiam habent quamdam incommutabilitatem et infallibilitatem (Quodlibet. X, q. 4. a.1 co.). E alla manifestazione della verità la strumentalità dei principi agisce fontalmente al livello della funzione astrattiva dell’intelletto agente: “quia vero principia comparantur ad intellectum agentem ut instrumenta quaedam eius, quia per ea, facit alia intelligibilia actu” ( Q. d. de anima, a. 5 co); “intellectus possibilis est in potentia ad omnia intelligibilia recipienda, quae possunt fieri per intellectum agentem, de quo etiam philosophus dicit quod intellectus agens est quo est omnia facere. Haec autem sunt quae a phantasmatibus abstrahuntur, et in quorum cognitionem devenire possumus per principia naturaliter cognita. Et ideo ad haec tantum intellectus possibilis est in potentia naturali (De veritate, q. 20 a. 6 ad 2.). Non si tratta di una constatazione di poco conto dal
momento che la dinamica conoscitiva che riguarda il rapporto delle species acquisite con i principi innati va allora estesa al rapporto previo “illustrante” (come viene esplicitato dall’Aquinate – lo vedremo – in Quodlibet. VIII, q. 2, a. 2. co) dell'essere come idea (omnibus nota) con il “quod quid est” ossia con “l’ens et verum consideratum in rebus materialibus” (Summa Th. I, q. 87, a. 3, ad 1) il che comporterebbe un accostamento (che non significa ecquiparamento) alla gnosologia rosminiana,
I rosminiani avevano già spezzato una lancia in tal senso indicando il contesto: phantasmata et illuminantur ab intellectu agente; et iterum ab eis, per virtutem intellectus agentis, species intelligibiles abstrahuntur (S,T. Q. 85, a 1 ad 4).
Liberatore ne valutò la forza, in prima istanza, e si limitò ad osservare che una rondine non fa primavera, ma poi si diede da pari suo, a confutarne il valore innatistico e il carattere “sintesistico”.
Ma non altrettanto facilmente avrebbe potuto il Liberatore sottovalutare, se li avesse presi in attenta considerazione i contesti poco sopra citati e tanto meno avrebbe potuto sminuire l’importanza di un altro testo (sfuggito anche ai rosminiani ma a noi offerto dall'esplorazione elettronica sempre fedele e completa) nel quale, dopo essersi riferito alla funzione
dei principi primi complessi nell’ambito razionale “ad cognoscendum in actu conclusiones quae in praedictis principiis potentialiter continentur”, Tommaso passa ad illustrare la funzione delle concezioni incomplesse in rapporto all’acquisizione conoscitiva delle quiddità nel’ambito intellettivo e scrive (esplicitando così il senso di sintesi implicito nella illuminatio o nella illustratio phantasmatum): “similiter in intellectu insunt nobis etiam naturaliter quaedam conceptiones omnibus notae, ut entis, unius, boni, et huiusmodi, a quibus eodem modo procedit intellectus ad cognoscendum quidditatem uniuscuiusque rei, per quem procedit a principiis per se notis ad cognoscendas conclusiones; et hoc vel per ea quae quis sensu percipit, sicut cum per sensibiles proprietates alicuius rei concipio illius rei quidditatem; vel per ea quae ab aliis quis audit... (Quodlibet VIII, q. 2 a 2 co).
Del resto il suddetto esplicito riferimento alla previa funzione delle “conceptiones omnibus notae” nell’iter conoscitivo è implicita nell’affermazione che nulla si può conoscere se non partendo da ciò che è intellettualmente innato nell’uomo (e qui è chiaro che non si parla solo del “lumen intellectus sgentis”): “Unde et in natura humana, in quantum attingit angelicam, oportet esse cognitionem veritatis sine inquisitione et in speculativis et in practicis; et hanc
quidem cognitionem oportet esse principium totius cognitionis sequentis, sive practicae sive speculativae, cum principia oporteat esse certiora et stabiliora. Unde et hanc cognitionem oportet homini naturaliter inesse, cum haec quidem cognitio sit quasi seminarium quoddam totius cognitionis sequentis; et in omnibus naturis sequentium operationum et effectuum quaedam naturalia semina praeexistant (QQ. de veritate, q. 16 a. 1 co)12
E già Aristotele, ci ricorda inoltre Tommaso, aveva sottolinearo una simile esigenza con il caratteristico simbolismo della “porta” (significativamente identificata con i principi primi) che proprio perché aperta permette di accedere a ciò che ancora nasconde l’interno della casa: “interiora enim domus difficile est scire, et circa ea facile est hominem decipi: sed sicut circa ipsum introitum domus qui omnibus patet et primo occurrit, nullus decipitur, ita etiam est in consideratione veritatis: nam ea, per quae intratur in cognitionem aliorum, nota sunt omnibus, et nullus circa ea decipitur: huiusmodi autem sunt prima principia naturaliter nota, ut non esse simul affirmare et negare, et quod omne totum est maius sua parte, et similia. Circa conclusiones vero, ad quas per huiusmodi, quasi per ianuam, intratur, contingit
12 Cfr anche In IV Sent. ds. 49, q. 1, a. 3b, co (Ad nihil intelligendum-‐-‐-‐ e oportet quof omnis) e inoltre in I Sent. Ds. 17, q. 1. A. 3, co (Omnis scientia acquisita9
multoties errare. (Sententia Metaphysicae, lib. 2 l. 1 n. 5)
Non resta dunque che ribadire l’opportunità di una revisione (non certo sconvolgente ma certamente integrante) della dinamica gnoseologica quale è intesa dall’Aquinate, tenendo conto della strumentalità dei principi innati, in particolare delle notiones omnibus notae (principi incomplessi in rapporto all’intelletto agente non solo in quanto alla “certitudo cognitionis” ma anche in rapporto ad una forma di sintesi “ratio entis - realtà sensibile” previo all’astrazione a cui, come abbiamo visto (Quodlibet VIII, q. 2 a 2 co) san Tommaso accenna esplicitamente13. Il che
13 Si potrebbero così vedere perfettamente armonizzate le due componenti che abbiamo visto rilevabili nel tomismo, ma i neotomisti sono ben lontani anche solo dal porsi il problema. Il problema se lo è posto invece C. Fabro, autorevole tomista fuori del coro, che vede bensì presenti nel processo conoscitivo di san Tommaso le due componenti (platonico-agostiniana e aristotelica) distinte ma confluenti in una sorta di “ancoraggio” che sublima il processo conoscitivo (tutto aristotelico) nella partecipazione alla verità divina (cfr. Introduzione a San Tommaso, Ed. Ares, 1979 pp 82 ss.). Non dunque si tratta di una soluzione organica ma di una strana sovrabbondanza che fa pensare, si licet magna componere pervis, alla prova del nove che s’usa nel far di conti. Benchè, comunque, tale interpretazione non combaci con quella dei rosminiani, si potrebbe però pensare che essa comporti una posizione più conciliante dell'antirosminiano Fabbro, ma non è così. Sostenitore di un anti-rosminianesimo che vorremmo definire "enigmatico" quasi a far da contrappeso al suo libro sul Roveretano L'enigma rosmini, egli in realtà, non demorde dal condividere coi neo-tomisti “aristotelizzanti” la negazione di ogni innatismo esprimendosi in questi termini: «la prima forma di conoscenza intuitiva e diretta, che attinge immediatamente l’esistenza, è data dal senso: qualità tattili, colori, suoni,... sono per l’uomo la prima attestazione della presenza dell’essere dell’ente alla coscienza» (Intr. a S. Tommaso, cit. p. 79). Egli relega nell’ambito degli scritti giovanili il riferimento di San Tommaso ai principi "innati", senza tener conto del fatto che la stessa dottrina, espressa con varietà di termini equivalenti (come
comporterebbe nuove accurate riflessioni sui succitati concetti, termini o locuzioni generalmente trascurate o equivocate in rapporto al discorso gnoseologico14 con particolare riguardo alla pregnanza del termine statim che sembra contrassegnare il culmine veritativo dell’accessso all’esplicito “sapere”. §*§
Per parte nostra riteniamo per ora eccedente allo scopo che ci siamo prefissi in questo breve saggio approfondire questo aspetto della gnoseologia tomistica e neanche ce ne riteniamo all’altezza per cui ci limitiamo all’auspicio che questa nostra “provocazione” possa essere colta con interesse da qualche esperto tomista.
Soltanto vorremmo concludere la rassegna dei testi comprovanti l’innatismo tomistico con l’interessante testimonianza di un iter conoscitivo che percorre a ritroso i passi dell'umano sapere fino alla fonte indefettibile della verità che è Dio: si tratta di un chiaro esempio del processo di "resolutio" da cui dipende l'attendibilità di tutte le nostre nozioni e lo
l’aggettivo inditum/a o il verbo inesse o altre locuzioni di cui facciamo parola in questo articolo) è largamente presente nelle opere dell’Aquinate, ivi comprese le due Summae (cfr. L’uomo e il rischio di Dio, Roma, Studium, 1967, p. 367). Per altro verso Fabro privilegia il concetto della resolutio (riferibile alla trascendentalità dell'essere) su quello dell'astrazione (ivi). L'edizione delle opere complete di questo eminente studioso ci aiuterà forse a far chiarezza su queste oscillazioni interpretative 14 Abbiamo già sottolineato l’assoluta mancanza di senso critico dimostrata dai neotomisti in rapporto alla termintologia innatistica dell’Aquiate (di cui nel nostro volume da Tommaso a Rosmini abbbiamo allestito una eloquentissima mappa).
facciamo in continuità con il testo tratto da Quodlibet VIII, q. 2 a 2 co già sopra citato: continua ivi San Tommaso: "Cum enim credimus aliquid esse in nobis divinitus datum, quo affectus noster Deo unitur, concipimus caritatis quidditatem, intelligentes caritatem esse donum dei, quo affectus Deo unitur; praecognoscentes tamen quid sit donum, et quid affectus, et quid unio" (ibidem) . Ma quale sarà, sembra chiedersi l'Aquinate a questo punto, l'ambito criteriologico nel quale possa essere assicurata a questi concetti una significanza universalmente condivisibile? Ed ecco il suo parere che certo la dice lunga sulla sua gnoseologia: "De quibus etiam quid sint, scire non possumus, nisi resolvendo in aliqua prius nota; et sic quousque perveniamus usque ad primas conceptiones humani intellectus, quae sunt omnibus naturaliter notae" (ibidem). Ogni commento è superfluo, ma c’è di più: il passo si conclude infatti con un importante richiamo a quell’ “a-priori creazionistico” che sta alla base, come abbiamo già avuto modo di osservare, dell’innatismo nozionale tomistico: "et quia naturalis cognitio est quaedam similitudo divinae veritatis menti nostrae impressa, secundum illud psalm. iv, 7: signatum est super nos lumen vultus tui, domine; ideo dicit augustinus, x de trinit., quod huiusmodi habitus cognoscuntur in prima veritate” (ibidem)