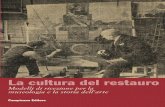C. Molle, L’iscrizione della cosiddetta Casa di San Tommaso a Roccasecca, «Latium» 25, 2008, pp....
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of C. Molle, L’iscrizione della cosiddetta Casa di San Tommaso a Roccasecca, «Latium» 25, 2008, pp....
Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale
LATIUMRivista di studi storici
25 (2008)
SOMMARIO
ANNARITA DE PROSPERIS, Innocenzo III e i monasteri di Subiaco
GIOACCHINO GlAMMARIA, Lo statuto della fraterna del Beato Andreaili~~ . .
ORSETTA BARONCELLI, FRANCESCA CONTICELLO, La chiesa di Santa Croce a
Genazzano: architettura, arte e storia . .
VINCENZO LIFRANCHI, Sermoneta pia: laici, chierici e vita di devozione in
Marittima nel XV secolo .
PIERO CAPOZI, Il lusso dei "particolari". Doti, ricchezza patrimoniale e beni
materiali della popolazione di Montelanico nel XVIII secolo ...
ANTONIO DI FAZIO, Le relazioni inedite di Trojani e di Carrara-Forcignano
nell'Inchiesta Jacini
Note e Documenti
CARLO MOLLE, L'iscrizione della cosiddetta Casa di San Tommaso
a Roccasecca .
Recensioni e segnalazioni. Libri ricevuti .
Attività dell'Istituto. Elenco dei Soci. Scambi .....
3
31
57
75
111
123
171
181
195
Note e documenti
CARLO MOLLE
L'ISCRIZIONE DELLA COSIDDETTACASA DI SAN TOMMASO
A ROCCASECCA
er accedere al cortile della cosiddetta Casa di SanTommaso, uno degli edifici più interessanti dell'antico borgo Castello di Roccasecca, si attraversa un monumentale arco a sesto acuto, al di sopra del quale èposta un'epigrafe ben nota, ma finora, per quanto mirisulta, sempre letta in maniera parziale e poco convincente.
Alcuni anni fa riesaminai l'iscrizione e riuscii a fis-sarne una nuova lettura che avrei voluto pubblicare
solo dopo aver svolto un'approfondita ricerca d'archivio; tuttavia, poichémi pare di aver differito fin troppo questa indagine, ho deciso di scrivereintanto una breve nota, ritenendo comunque"un risultato soddisfacentemettere a disposizione dei lettori la corretta interpretazione del testo,tanto più che, proprio mentre ultimavo questo articolo, ho consultatocon profitto, seppur in maniera ancora assai incompleta, il ricco archivioparrocchiale della SS.ma Annunziata al Castello di Roccaseccal
•
La "Casa di San Tommaso" è un edificio tardo medievale, se non piùrecente, situato lungo il sentiero che dalla piazza del Castello sale versola chiesa di S. Tommaso, circa a metà strada tra questi due siti, all'interno delle mura del borgo. Abitato fino ai primi decenni del secolo scorso,il complesso ha subìto numerose modifiche nel corso del tempo, fino alrecente restauro per iniziativa del Comune, a seguito del quale è statodestinato ad ospitare eventi culturali di varia natura.
Il suo nucleo principale risulta costituito da un grosso corpo di fabbrica su più piani a pianta rettangolare, al quale si sono successivamenteaddossate altre strutture. Nel suo aspetto attuale, il caseggiato presen-
l Colgo l'occasione per ringraziare la responsabile dell'archivio, sig.ra Luisa Di Sturco, edil sacerdote don Ercole Di Zazzo per la loro disponibilità.
171
72
ta una configurazione grossomodo ad L e delimita due lati del cortileinterno, a sua volta completamente circoscritto, sui lati opposti, da unalto muro di cinta e dalla parete di una casa contigua2
• Il complesso èdegno di nota per alcune caratteristiche architettoniche, tra le quali spiccano una bifora trilobata ed una monofora ad archi ogivali3, nonché perl'organicità della struttura, ripartita tra una zona signorile ed una zonadestinata alle attività di servizio ed alle stalle, sapientemente ricavate nelripido pendio del colle4•
L'ampio portale di accesso alla corte è situato presso l'angolo sudovest della stessa ed è realizzato in conci di travertino locale, con il conciochiave adornato sul lato esterno dal TOZZO rilievo di una testa diadematarivolta a destra di chi guarda5• Al di sopra del concio chiave è muratoil blocco con l'iscrizione in esame, mentre ancora più in alto è ricavatanella parete un'edicoletta cuspidata, all'interno della quale doveva esserecollocata o dipinta un'immagine sacra (fig. 1).
La deJ?ominazione tradizionale "Casa di San Tommaso" si deve proprioall'iscrizione posta sul portale, in cui si legge appunto il nome Tho(mas)6.È ampiamente condiviso, però, e a ragione, che il testo non si riferiscaaffatto a S. Tommaso d'Aquino, che quasi con certezza nacque proprionel Castello di Roccasecca alla metà degli anni '20 del XIII secolo, ma adun altro omonimo personaggio7•
2 Attualmente quest'ultimo edificio ospita i locali del ristorante-relais "La Locanda delCastello".
3 Entrambe collocate al piano più alto del corpo di fabbrica principale.4 Sull'edificio, le cui caratteristiche originarie erano osservabili soprattutto prima del
restauro, manca uno studio esaustivo, anche se vi si fa riferimento in numerose pubblicazioni,tra cui quella di W. POCINO, Le due case di S. Tommaso d'Aquino, in Lazio ieri e oggi, 9 (1973),3, pp. 52-54 ed altre, in parte citate nelle note che seguono; una planimetria è pubblicatain M. MERLINO - T. MIRENDA (con il contributo archeologico di G.R. BELLINI), Progetto"Roccasecca". Un modello sostenibile di sviluppo locale. Politiche Comunitarie, Beni Culturali,Ambiente e Territorio, Roccasecca 1998, p. 65 (con foto della bifora in copertina). Al giornod'oggi si possono facilmente reperire numerose immagini dell'edificio anche in internet (ades. nel sito www.roccaseccainarte.it - verifica 29/7/2008).
5 Forse una testa coronata era raffigurata pure in un perduto rilievo, un tempo murato soprala bifora della casa, come si evince da alcune vecchie foto (in particolare, cfr. F. RICCARDI - P.CATALDI, Roccasecca. Immagini e ricordi, Roccasecca 1997, p. 114, fig. 119).
6 I;edificio veniva ritenuto anche dal Walz quello "in cui molto probabilmente Tommasovide la luce" (A. WALZ, San Tommaso d'Aquino. Studi biografici sul Dottore Angelico, Roma1945, p. 7 s.).
7 È opportuno ricordare che un'altra iscrizione di tenore "tomistico" è ora murata pressouna porta della cinta muraria del borgo (una foto anche in M. MOLLICONE - M. RIzzELLo,Lavalle del Liri e la sua Comunità Montana, Storia, Arte, Cultura, Arce 1999, p. 369). Si tratta diun'epigrafe pesantemente rimaneggiata (se non proprio moderna), come si evince anche daltaglio delle lettere, che denotano l'uso di uno strumento meccanico. I;amico Pompeo Cataldimi informa che la pietra iscritta (probabilmente un concio chiave) sarebbe stata ritrovata
Quest'ultimo, in base all'integrazione comunemente proposta per laseconda linea dell'epigrafe, sarebbe stato uno iud(ex). Proprio la letturaThomas iudex, infatti, viene continuamente citata nella bibliografia al riguard08, che tuttavia, per quanto mi è noto, non fornisce mai una trascrizione completa del testo, evidentemente per la sua difficile leggibilità,tanto più che l'iscrizione si trova murata ad oltre tre metri d'altezza.
L'epigrafe è incisa su un blocco di calcare bianco compatto, la cui fronte ha una sagoma approssimativamente rettangolare, assai irregolare soprattutto nella parte superiore (fig. 2). L'altezza rilevabile del supportoè di 31 cm, la larghezza di 41 cm, lo spessore non è verificabile; l'altezzadelle lettere varia dai 3 ai 5,2 cm. Nella parte alta della pietra sono scolpite due mani affrontate che sorreggono una coccarda9, mentre l'iscrizionesi trova al di sotto di tale rilievo lO
• Le due linee del testo, caratterizzate
tra gli anni '60 e '70 e che il testo fu ritoccato dall'allora arciprete don Antonio Tuzi. Il testoattuale (si legge grossomodo: DVID + + / SACRS / THOM / LOCU / N. A +) dovrebbecelare un riferimento al luogo natale di S. Tommaso, argomento peraltro oggetto, soprattuttoin passato, di una vivace contesa tra Roccasecca e Aquino. Tra le epigrafi dei secoli passaticonservate nel borgo Castello, vi sono anche un inedito coperchio ad omphalos di cinerariodi età romana, su cui si legge la tipica scritta Ossa (su questo tipo di manufatti cfr., in primoluogo, S. DIEBNER, Un gruppo di cinerari romani del Lazio meridionale, in Dialoghi di Archeologia,ser. III, 1 [1983], pp. 65-78), ed altri testi di età post medievale, sui quali non mi soffermo inquesta sede. Nella grande cisterna all'interno della rocca, inoltre, ho individuato dei graffitifigurati medievali, essenzialmente costituiti da croci, tra i quali compare anche la sagomastilizzata di un cavallo.
8 Così già almeno in A. Toso, Thomas de Aquino. Il luogo di nascita e il pensiero giuridico delSanto Dottore, Sora 1936, p. 75, fig. 8, che parla di una "casa medievale, appartenente a certoThomas Judex" e, più eloquentemente, in ID., Tommaso D'Aquino e il suo tempo, Roma 1964,p. 253: "... «Thomas iudex...» si tratta evidentemente della dimora di un iudex titolo chesi dava nel Medio Evo ad un funzionario rivestito della potestà amministrativa oltre chegiudiziaria". Tale lettura è stata in seguito sostanzialmente ripresa da tutti gli altri, tra cuiricordo W POCINO, Le due case di S. Tommaso d'Aquino, cit., pp. 52-54, ID., Roccasecca patriadi San Tommaso d'Aquino, Roma 1974, p. 113 s., M. OTTAVIANI DI MURRo,Alla scoperta delmonte Asprano, il monte di S. Tommaso, Cassino 1977, p. 16 s., D. ASCOLANO, Roccasecca terradi S. Tommaso, Cassino 1979, pp. 22 e 38 (che definisce l'edificio un "monumento goticoangioino"), ID., Storia di Roccasecca, Roccasecca 1988, pp. 81 e 99 (rist. 1997, con qualcheoscillazione nella numerazione delle pagine), R RICCARDI - P. CATALDI, Roccasecca. Immagini ericordi, cit., p. 123 (cfr. p. 114, fig. 119). Anche il celebre archeologo Sabatino Moscati riportaquesta versione: "Ecco la casa tenacemente legata al nome di San Tommaso, con il suoportale gotico e la finestrella bifora: fu davvero abitata da un personaggio di questo nome,ma l'iscrizione che lo ricorda attesta che era un giudice. Come non perdonare la pietà deifedeli?" (S. MOSCATI, Seguendo le orme di San Tommaso, in Corriere della Sera, 20 marzo 1983,p.19).
9 Oppure un fiore a 5/6 petali. Non mi è chiaro il significato simbolico o araldico di questomotivo, di cui mi chiedo se non possa essere relativo al concetto dell'utrumque ius presentenel testo dell'epigrafe (su cui si veda di seguito).
lO Pur nella semplicità di questo manufatto, l'utilizzo di un blocco di calcare biancoimpreziosito dalla decorazione a rilievo denota una certa cura nella scelta di un supporto
Fig. 2. Roccasecca. L'iscrizione della "Casa di San Tommaso".
da un'esecuzione poco curata, sono prive di impaginazione simmetrica erivelano l'impiego del trapano, utilizzato sia per la realizzazione dei puntiche per agevolare l'incisione di alcune lettere. Il testo risulta integro anche se l'approssimazione dell'esecuzione ed il logorio del tempo lo rendono di difficile lettura. La scrittura si ispira vagamente ad un modello dicapitale quadrata, pur manifestando elementi anomali o corsiveggianti,quali l'uso del punto sulla Pt, la presenza della S rovesciata, le L montanti, l'utilizzo di punti di separazione di forma circolare'2• Il testo va lettocome segue:
epigrafico di relativi pregio e solidità; in alcuni casi, analoghe iscrizioni di proprietà o difondazione sono incise su manufatti antichi di reimpiego: un caso significativo nei dintorniè costituito da un bel blocco marmoreo di cornice di età romana imperiale, che individuai,anche in seguito al alcune indicazioni di Pier Giorgio Monti, nel 1999 in un casolare diS. Giovanni Incarico, nell'area urbana dell'antica Fabrateria Nova, su cui si legge: R(---)Argentina, a(nno) D(omini) 1787.
11 Questo elemento, nel nostro caso presente solo sulla I della prima linea, induce di per séa non risalire prima del tardo medioevo, tanto più che esso è insolitamente abbinato ad unascrittura vagamente capitale, che credo risenta dei gusti grafici rinascimentali.
12 I caratteri, peraltro, risultano internamente ricalcati e graffiati, evidentemente ad operadi qualcuno che ha tentato, in anni relativamente recenti, di evidenziarli.
Tho(mas) de VellisI(uris) U(triusque) D(octor).
R. 1: un punto di separazione tra THO e DE VELLIS; LL montanti; Isormontata da punto; S finale rovesciata.
R. 2: I non sormontata da punto; punto di separazione tra I e Ve tra Ved D; un tenue tratto verticale che si intravede dopo la D va consideratonon pertinente all'iscrizione.
Diversamente da quanto finora ritenuto, la presenza di punti tra lelettere della seconda linea induce a leggere la tipica abbreviazione i(uris)u(triusque) d(octor), rivelando che il personaggio era un dottore nel diritto civile ed in quello canonico.
La restituzione dell'onomastica completa e della titolatura del personaggio, inoltre, apre nuove prospettive di ricerca prosopografica. Infatti,la famiglia de Vellis, attualmente scomparsa da Roccasecca, nei secolipassati doveva essere una delle più in vista del Castello'3• I de Vellis, infatti, compaiono con frequenza nei documenti più antichi dell'archivioparrocchiale della SS.ma Annunziata'4 ed è assai significativo rilevareche il primo di essi, citato in un atto di Battesimo del 158o, è proprio unuomo di legge, "Notar Donato de Vellis"15. Scorrendo i registri parroc-
13 Tra l'altro, anche dall'onciario presentato nel 1742 alla Sommaria di Napoli risulta che"De Vellis" fosse tra i poco più che cento cognomi delle famiglie della Roccasecca dell'epoca(l'elenco dei cognomi è pubblicato in F. SCANDONE, Roccasecca, patria di S. Tommaso deAquino, in Archivio storico di Terra di Lavoro, 3 [1960-64], p. 30 s., da cui D. ASCOLANO, Storiadi Roccasecca, cit., pp. 137-139). Da una breve ricerca fatta con vari strumenti cartacei ed
6 informatici (tra cui elenchi telefonici ed il database del sito www.gens.labo.net - verifica29/7/2008), risulta che in zona i De Vellis sono ora particolarmente concentrati nella zona diStrangolagalli.
14 Si badi che il materialeche ho finora consultato con una certa sistematicità èessenzialmentecostituito dal libro dei battezzati (che inizia dal 1576) e dal registro dei defunti (che iniziadal 1617), entrambi non privi di lacune. -Canalisi è stata condotta con regolarità fino ai primianni del 1700, anche se una sommaria consultazione dei registri del periodo successivo harilevato che al Castello il cognome de Vellis subisce una fortissima rarefazione già nellaseconda metà del XVIII secolo; ciò potrebbe essere dovuto, come induce a credere anchela consultazione dello Stato delle Anime redatto intorno al 1740, alla carenza di figli maschi(peraltro sembra che i de Vellis del '700 avessero in parte perduto il prestigio sociale dei loroantenati). Si tenga presente che i registri più antichi dell'archivio ci sono pervenuti nellatrascrizione dell'arciprete don Tommaso Basi (1775-1791) che, con non comune sensibilità,li ricopiò "da libri vecchi, per conservarne la memoria ne' tempi avvenire, essendo gli antichi libriquasi in tutto laceri" (citazione autografa dalla premessa del registro dei defunti).
15 Nel documento si attesta che Maddalena Domizia, moglie di Notar Donato de Vellis,e Camilla, moglie di Giacomo de Vellis, fecero da madrine ad un bambino chiamatoMarcantonio Molle. Domizia, come risulta da altri atti, era anch'ella figlia di un notaio, Colade Giorgiis di Santopadre. Notar Donato e la moglie compaiono anche in altri documenti
chiali, d'altra parte, si intuisce, attraverso una sommaria analisi di alcuni appellativi e dei rapporti di parentela, che almeno alcuni membri diquesta numerosa famiglia dovettero godere di un certo prestigio sociale.Sappiamo che un Angelo de Vellis fu uno dei tre ufficiali (amministratoriper le frazioni) di Roccasecca nell'anno 1616'6 e che nello stesso secolo almeno quattro esponenti della famiglia furono uomini di Chiesa, i"chierici" Annibale e Tommaso de Vellis (morti rispettivamente nel 16soe nel 16SS), il sacerdote don Domenico Antonio de Vellis, attivo nel terzo quarto del secolo, e soprattutto un altro don Tommaso de Vellis, chefu l'arciprete della SS.ma Annunziata per quasi tre decenni, dal 1674 al1701'7• Anche nelle pergamene recentemente pubblicate dell'archivio della SS.ma Annunziata'8, i de Vellis compaiono ripetutamente tra il XVIIe la prima metà del XVIII secolo. Da questi documenti si ricava che essiebbero un legame privilegiato con la Confraternita del SS.mo Sacramento, all'interno della quale ricoprirono cariche di prim'ordine, quale quella di camerlengo, che fu almeno di (Giovanni) Antonio, Giovanni Battistae Giovanni Andrea'9 de Vellis. La loro posizione economica, d'altra parte,si evince pure dalla cospicuità di alcune donazioni, come quella di treappezzamenti di terreno fatta nel 1647 da un Tommaso de Vellis e da suofiglio Giovanni Battista alla Confraternita del SS.mo Sacramento o dallascito testamentario di ben cento ducati fatto da Giovanni Battista20 afavore della stessa confraternita2l
•
Tornando infine al Tommaso de Vellis che fece incidere il proprionome sul monumentale ingresso della "Casa di San Tommaso", viene dachiedersi se costui possa essere identificato con uno dei diversi omonimiche compaiono nei documenti del Castello. La datazione su base paleografica dell'epigrafe non ci aiuta molto, anche se i caratteri induconocautamente ad escludere una cronologia troppo alta e a proporre una 177
successivi, in qualità di genitori o padrini. Purtroppo, la mancanza di documenti non cipermette di conoscere le vicende della famiglia nei secoli precedenti.
16 R SCANDONE, Roccasecca, patria di S. Tommaso de Aquino, cit., p. 45 (la lettura "de Nellis" ap. 19, confluita anche in D. ASCOLANO, Storia di Roccasecca, cit., p. 117, sarà una pura svista);è facile immaginare che la frazione rappresentata da Angelo de Vellis (quasi certamenteidentificabile con l'omonimo personaggio morto nel 1629) fosse proprio il Castello.
17 Significativi di un certo prestigio della famiglia anche alcuni appellativi confluiti nelregistro dei battezzati, quali quello di M(astr)o Fabrizio de VeIlis (1601) e quello di DonnaCat(arin)a de Vellis, moglie delD(otlo)r Fis(i)co Cesare Vicini (1690 e 1694).
18 Il regesto delle pergamene dell'archivio della parrocchia SS.ma Annunziata al Castello, a curadi V. TAVERNESE, Roccasecca 2007: i numerosi riferimenti ai membri della famiglia si possonofacilmente ricavare dall'indice a p. 109.
19 Forse da identificare con il camerlengo altrove indicato solo come Andrea de Vellis.20 Forse da identificare con il personaggio appena citato e con l'omonimo camerlengo della
confraternita.21 Il regesto delle pergamene, cit., documenti nn. 45 e 198.
forcella cronologica collocabile tra la metà XV a tutto il XVII secolo, ossiaad attribuire l'iscrizione ad età rinascimentale o più tarda. Lo stesso edificio, peraltro, si situa in una zona che sembra essere stata interessata daun'intensa urbanizzazione soprattutto a partire dal tardo Medioev022 eanche l'elegante bifora trilobata non dovrebbe rimandare ad un periodoanteriore al XV secol023
• Al di là di queste considerazioni, inoltre, bisogna aggiungere che, in mancanza di un'analisi puntuale delle stratigrafiemurarie, non è neppure del tutto sicura la contemporaneità dell'iscrizione con il portale su cui essa è collocata24•
Tuttavia, se i Tommaso de Vellis furono relativamente numerosi alCastell025, finora ne ho trovato uno solo che è esplicitamente definitoU(triusque) I(uris) D(octo)r, ovvero, come lui stesso scrive, "Arcipr(ete)D(otto)re dell'una e l'altra legge": il già ricordato don Tommaso de Vellis, arciprete della SS.ma Annunziata dal 1674 al 170126
• Costui fu certa-
22 La Casa di S. Tommaso si trova tra la chiesa di S. Tommaso (verso la parte superiore e piùantica del Castello), probabilmente eretta nella prima metà del XIV secolo (cfr. M. CAGIANODE AZEVEDO, La chiesetta di S. Tommaso presso il Castello di Roccasecca, in Palladio, 13 [1963],p. 32 s.; D. ASCOLANO, La chiesa di S. Tommaso, Roccasecca 1992, p. 19 s.), e la chiesa dellaSS.ma Annunziata, già citata verso la fine del XV secolo, ma completamente ricostruita nelXVIII, come testimonia anche un'epigrafe inglobata nelle sue sostruzioni, con data 1713 (cfr.D. ASCOLANO, Storia di Roccasecca, cit., pp. 148-157). La costruzione dell'edificio potrebbeperaltro corrispondere alla grande espansione demografica documentata a Roccasecca nelcorso del XVI secolo (cfr. D. ASCOLANO, Storia di Roccasecca, cit., p. 116).
23 Cfr., ad es., P. TRONCA, Tipologìe dell'architettura minore. La media valle dell'Aterno, I.:Aquila1987, pp. 175-183.
24 La mancanza della data, che sarebbe logico aspettarsi in un'iscrizione di fondazione,potrebbe essere un labile argumentum esilentio sul fatto che Tommaso de Vellis abbia acquisitoun edificio preesistente. Il muro di cinta, nel suo complesso, risulta stratigraficamente
78 successivo al corpo principale della casa, a cui è appoggiato, ma è possibile che sia statorealizzato quasi contemporaneamente.
25 Il nome Tommaso è uno dei più cari ai Roccaseccani proprio per via dell'illustre santolocale, la cui canonizzazione, avvenuta nell'anno 1323 ad opera del pontefice GiovanniXXII, sarà stata in zona un forte incentivo per la diffusione di questo nome. I membridella famiglia de Vellis che portano il nome Tommaso (inclusi i composti) rintracciabilidai primi documenti della SS.ma Annunziata fino all'anno 1710 (che ho scelto come limiteconvenzionale) sono all'incirca una decina, dei quali però alcuni morirono sicuramentegiovanissimi.
26 La nota in latino "Archipr(esbiter) Th(omas) de Vellis U(triusque) I(urìs) D(octo)r" è appostanel registro dei battezzati all'inizio dell'anno 1674, quasi certamente per iniziativa di donTommaso Basi; quella in italiano è invece tratta dal registro di un Battesimo del 3 gennaio1683, in questo caso senz'altro copiata da quanto aveva scritto di sua mano lo stesso de Vellis.Il periodo di arcipretura di don Tommaso de Vellis (1674-1701), probabilmente desunto daglistessi atti parrocchiali, è indicato in un vecchio elenco degli arcipreti inserito nel registro deidefunti. Egli era comunque già sacerdote nel 1672, come risulta dal registro di un Battesimodi quell'anno, e dovette morire nel 1701 (anno mancante nel registro dei defunti). Per quantoriguarda la nascita, ricordo che un Tommaso e un Tommasantonio de Vellis furono battezzatirispettivamente nel 1622 e nel 1638, ma il registro relativo al nostro potrebbe anche essere
mente un personaggio di rilievo a Roccasecca, peraltro attivo anche intransazioni relative all'acquisto di case7• Forse fu lui il proprietario della"Casa di San Tommaso", al cui splendido cortile è suggestivo pensarequando, qualche anno dopo la sua morte, nel 1704, venne stipulato unatto "nell'Atrio della casa dell'Arciprete D. Tommaso de Vellis"28.
Non sembra dunque infondata l'ipotesi di identificarlo col personaggio dell'epigrafe, ipotesi che tuttavia va valutata con la massima cautela,tanto più che i de Vellis risultano essere esperti di giurisprudenza già dalsecolo precedente e che nell'epigrafe non c'è alcun riferimento al rangosacerdotale dell'arciprete. Per il momento, dunque, non mi spingo oltre,anche perché sono convinto che un prosieguo della ricerca potrebbe rivelare nuove informazioni su questi personaggi e sulle loro vicende, cosìprofondamente intrecciate con la storia di Roccasecca.
179
perduto.27 Il regesto delle pergamene, cit., documenti nn. 75 e 80 (anni 1677 e 1678).28 Il regesto delle pergamene, cit., documento n. 132 (cfr. anche n. 86).