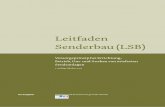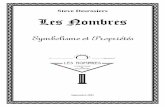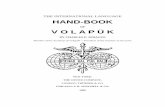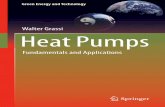Le monete, in M. T. GRASSI (ed.), Calvatone-Bedriacum. I nuovi scavi nell’area della Domus del...
Transcript of Le monete, in M. T. GRASSI (ed.), Calvatone-Bedriacum. I nuovi scavi nell’area della Domus del...
P O S T U M I A24/3 2013
UMI ACALVATONE-BEDRIACUM
I nuovi scavi nell’areadella Domus del Labirinto (2001- 2006)
a cura di
MARIA TERESA GRASSI
POSTUMIARivista quadrimestraledell’Associazione Postumiadi Gazoldo degli IppolitiN. 24/3 2013
Direttore scientificoRoberto Navarrini
Presidente dell’Associazione Postumia Lucia Ferrari
Presidente onorario dell’Associazione Postumia† Steno Marcegaglia
Direttore ResponsabileAnnibale Vareschi
Comitato scientificoPaola Artoni, Giuliana Algeri, Mario Allegri, Giorgio Bernardi Perini, Paolo Bertelli,Renato Berzaghi, † Clifford Brown, David Chambers, Francesco Mallegni, Roberto Navarrini, Loredana Olivato,Antonio Paolucci, Lionello Puppi, Gennaro Toscano
RedazioneEttore Adalberto Albertoni, Paola Artoni, Carlo Marco Belfanti, Paolo Bertelli, Claudio Boroni Grazioli, Paola Cirani, Claudia Gerola, Mario Gerola, Rosaria Guadagno, Piero Gualtierotti, Anna Maria Lorenzoni, Nanni Rossi (coordinatore editoriale), † Rinaldo Salvadori, Gianna Suitner, † Giovanni Vareschi
Segretarie di redazioneAlessia Comunian e Carla Fontana
ISSN 1120-8082
Autorizzazione del Tribunale di Mantovan. 10/91 del 6/04/1991
Sede dell’Associazione PostumiaGazoldo degli Ippoliti (Mantova)via Marconi, 113tel. 0376.327728 – 339.8959081fax [email protected]
PUBLI PAOLINIRealizzazione editoriale e stampa
a cura diMARIA TERESA GRASSI
Testi di
MARINA ALBENI, ALBERTO BACCHETTA, DANIELA BENEDETTI,FABIO BETTI, ROBERTO BUGINI, DANIELE BURSICH, ANGELA CERUTTI,
ANTONINO CRISÀ, DIANA DOBREVA, LUISA FOLLI, FEDERICA GIACOBELLO, MARIA TERESA GRASSI, STEFANO NAVA, CLELIA ORSENIGO,
FRANCESCA ARIANNA OSSORIO, LILIA PALMIERI, THEA RAVASI, MIRIAM ROMAGNOLO, GIORGIO ROSSI, FABRIZIO SLAVAZZI, LAURA SPERTI,
MARINA VOLONTÉ, GIOIA ZENONI
SOMMARIO
Indice dei contesti studiati pag. 12
Introduzione. Dal Labirinto all’olla tipo Calvatone (M.T. GRASSI) ” 13 1. FASI E CONTESTI » 39
1.1.A Prima frequentazione dell’area e impianto degli edifici residenziali (T. RAVASI) » 411.1.B I contesti » 76es 9301. Una fossa di scarico (A. CERUTTI) » 76us 8148. Una fossa di scarico (G. ZENONI) » 81us 8054. Uno scarico di materiali sotto l’Ambiente A (L. PALMIERI) » 89es 9228. Una fossa rituale nella Domus del Focolare (L. PALMIERI) » 98
1.2.A La Domus del Labirinto (A. BACCHETTA) » 137I pavimenti del settore di rappresentanza (F. SLAVAZZI) » 169Il mosaico del Labirinto (M. VOLONTÉ) » 1761.2.B I contesti » 180I contesti nella Domus del Labirinto: osservazioni generali (F.A. OSSORIO) » 180us 8125. Un livellamento precedente alla Domus del Labirinto (F.A. OSSORIO) » 196es 9226. Il riempimento del pozzo (F.A. OSSORIO) » 200es 9149. Un contesto “post-Labirinto” (F.A. OSSORIO) » 202es 9152. Un contesto “post-Labirinto” (F.A. OSSORIO) » 205es 9116. Un cumulo di macerie dopo la fase residenziale (S. NAVA) » 208 es 9011, es 9012, es 9062. Uno scarico di materiali “post-Labirinto” (G. ROSSI) » 217
1.3.A La Domus delle Esagonelle (D. BENEDETTI) » 2451.3.B I contesti » 256us 8056. Un livello di obliterazione dell’Ambiente D (D. BENEDETTI) » 256us 8070. Un livellamento precedente alla Domus delle Esagonelle (F.A. OSSORIO) » 258us 8048. Un livello di obliterazione dell’Ambiente D (F.A. OSSORIO) » 261es 9013. Il piano in pezzame laterizio (D. BENEDETTI) » 263es 9070. Una trincea di scasso nel piano in pezzame laterizio (D. BENEDETTI) » 267 us 8084. Un livellamento sopra il piano in pezzame laterizio (D. BENEDETTI) » 269
10
1.4.A La media età imperiale: rinnovamento e trasformazione (C. ORSENIGO) pag. 2831.4.B I contesti » 325es 8975. Il primo intervento nell’area dell’Ambiente C (C. ORSENIGO) » 325us 8047. Un livello “pre-Ambiente C” (C. ORSENIGO) » 329es 8905. La frequentazione dell’Ambiente C: per la cronologia dell’olla tipo Calvatone (L. SPERTI) » 337es 8905. La frequentazione dell’Ambiente C: analisi dei materiali datanti (M. ALBENI) » 344es 8968. La frequentazione dell’Ambiente C: un’anfora riutilizzata (M. ALBENI) » 349es 8908. Il crollo dell’Ambiente C (C. ORSENIGO) » 350es 8952. Una fossa di scarico di olle (C. ORSENIGO) » 356 es 8923, es 8916, es 8973. I contesti “post-Ambiente C” (L. SPERTI) » 364es 8814, es 8904, es 8963, es 8907. Una grande fossa e i suoi livelli di riempimento (M. ROMAGNOLO) » 372
1.5 Un contesto moderno: analisi dei materiali per la definizione di un orizzonte cronologico e delle più recenti attività nell’area di proprietà provinciale (D. BURSICH) » 429
2. MATERIALI E STRUTTURE » 435
2.A Le lucerne a vernice nera (G. ZENONI) » 4372.B Un frammento di Terra Sigillata con iscrizione (A. CERUTTI) » 4422.C La ceramica comune e l’olla tipo Calvatone (C. ORSENIGO) » 4442.D Alcune osservazioni sul commercio e il consumo di derrate a Calvatone-Bedriacum. I dati dei contenitori da trasporto dell’area della Domus del Labirinto (D. DOBREVA) » 461 2.E La bottiglia vitrea tipo Isings 50 (M. ROMAGNOLO) » 4702.F Un’applique in bronzo a maschera teatrale (L. SPERTI) » 4732.G Le monete (A. CRISÀ) » 4762.H Le gemme (F. BETTI) » 4972.I I pesi (F. SLAVAZZI) » 5002.L Gli alzati in terra cruda: dalla distruzione alla ricostruzione (G. ZENONI) » 5032.M Laterizi di rivestimento parietale (G. ROSSI) » 5112.N Gli intonaci. L’area della Domus del Labirinto (F. GIACOBELLO) » 5182.O Gli intonaci. Affreschi dalle domus di lusso nel Quartiere degli Artigiani (F. GIACOBELLO) » 5262.P Indagini scientifiche su materiali lapidei dagli scavi di Bedriacum (R. BUGINI, L. FOLLI) » 527
11
TAVOLE pag. 545
TABELLA FASI E CONTESTI » 561
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE (A CURA DI L. PALMIERI) » 562
CD ALLEGATO (A CURA DI L. PALMIERI E G. ROSSI)ÉQUIPE
PIANTE DI FASE
TABELLE CONTESTI STUDIATI
TABELLA CONTENITORI DA TRASPORTO APPARATI:1. LE LASTRINE DEL PAVIMENTO ES 88072. CATALOGO DELLE MONETE
3. INTONACI DI FASE I - I CONTESTI
4. INTONACI DI FASE II - I CONTESTI
5. INTONACI DI FASE III - I CONTESTI
6. GRUPPI FIGURATIVI INDIVIDUATI IN UUSS QA8141, QA8145
12
INDICE CONTESTI STUDIATI
uuss8047 (MEI): FASE III, PERIODO 1; pianta FIG. 154, materiali FIGG. 167-168 pag. 3298048 (DE): FASE II, PERIODO 1; pianta FIG. 120, materiali FIGG. 131-132 » 2618054 (PF): FASE I, PERIODO 1; pianta FIG. 12, materiali FIGG. 54-61 » 898056 (DE): FASE II, PERIODO 1; pianta FIG. 120, materiali FIG. 129 » 2568070 (DE): FASE II, PERIODO 1; pianta FIG. 120, materiali FIGG. 129-131 » 2588084 (DE): FASE III, PERIODO 3; pianta FIG. 128, materiali FIG. 133 » 2698125 (DL): FASE II, PERIODO 1; pianta FIG. 90, materiali FIGG. 100-101 » 1968148 (PF): FASE I, PERIODO 1; pianta FIG. 12, materiali FIGG. 51-54 » 81
eess8814 (MEI): FASE III, PERIODO 3 - FASE IV; pianta FIG. 134, materiali FIG. 196 » 3728904 (MEI): FASE III, PERIODO 3 - FASE IV; pianta FIG. 134, materiali FIG. 196 » 3728905 (MEI): FASE III, PERIODI 2-3; pianta FIG. 156, materiali FIGG. 169-176 » 3378907 (MEI): FASE III, PERIODO 3 - FASE IV; pianta FIG. 134, materiali FIGG. 196-197 » 3728908 (MEI): FASE III, PERIODO 3; pianta FIG. 134, materiali FIGG. 177-178 » 3508916 (MEI): FASE III, PERIODO 3; pianta FIG. 134, materiali FIGG. 190-193 » 3648923 (MEI): FASE III, PERIODO 3; pianta FIG. 134, materiali FIGG. 188-190 » 3648952 (MEI): FASE III, PERIODO 3; pianta FIG. 134, materiali FIGG. 179-188 » 3568963 (MEI): FASE III, PERIODO 3 - FASE IV; pianta FIG. 134, materiali FIG. 196 » 3728968 (MEI): FASE III, PERIODO 2; pianta FIG. 156, materiali FIG. 177 » 3498973 (MEI): FASE III, PERIODO 3; pianta FIG. 134, materiali FIGG. 194-195 » 3648975 (MEI): FASE I, PERIODO 1; pianta FIG. 18, materiali FIG. 166 » 3259011 (DL): FASE III, PERIODO 3; pianta FIG. 97, materiali FIG. 111 » 2179012 (DL): FASE III, PERIODO 3; pianta FIG. 97, materiali FIGG. 111-112 » 2179013 (DE): FASE II, PERIODO 2 - FASE III, PERIODI 1-2; pianta FIG. 117, materiali FIG. 132 » 2639062 (DL): FASE III, PERIODO 3; pianta FIG. 97, materiali FIG. 112 » 2179070 (DE): FASE III, PERIODO 2; pianta FIG. 117, materiali FIG. 133 » 2679099 (CM): pianta FIG. 18 » 4299116 (DL): FASE III, PERIODI 2-3 - FASE IV; pianta FIG. 94, materiali FIGG. 106-110 » 2089149 (DL): FASE III, PERIODO 2; pianta FIG. 94, materiali FIGG. 103-104 » 2029152 (DL): FASE III, PERIODO 2; pianta FIG. 94, materiali FIGG. 105-106 » 2059226 (DL): FASE III, PERIODO 1; pianta FIG. 90, materiali FIGG. 101-102 » 2009228 (PF): FASE I, PERIODO 2; pianta FIG. 16, materiali FIGG. 61-66 » 989301 (PF): FASE I, PERIODO 1; pianta FIG. 12, materiali FIGG. 48-50 » 76
CM= Contesto moderno; DE= Domus Esagonelle; DL= Domus Labirinto; MEI= Media età imperiale; PF= Prima frequentazione.
AVVERTENZE
Al volume è allegato un CD, in cui sono stati inseriti gli apparati iconografici completi rela-tivi alle lastrine marmoree del pavimento es 8807 (SLAVAZZI, Pavimenti), alle monete (CRISÀ, Monete) e agli intonaci (GIACOBELLO, Intonaci), oltre alle tabelle complete delle anfore (DO-BREVA, Contenitori da trasporto) e dei materiali di tutti i contesti studiati:1.1.B (Prima frequentazione): CERUTTI, es 9301; ZENONI, us 8148; PALMIERI, us 8054; PALMIERI, es 9228;1.2.B (Domus Labirinto): OSSORIO, us 8125; OSSORIO, es 9226; OSSORIO, es 9149; OSSORIO, es 9152; NAVA, es 9116; ROSSI, es 9011, es 9012, es 9062;1.3.B (Domus Esagonelle): BENEDETTI, us 8056; OSSORIO, us 8070; OSSORIO, us 8048; BENE-DETTI, es 9013; BENEDETTI, es 9070; BENEDETTI, us 8084;1.4.B (Media età imperiale): ORSENIGO, es 8975; ORSENIGO, us 8047; SPERTI, es 8905; ALBENI, es 8905, ALBENI, es 8968; ORSENIGO, es 8908; ORSENIGO, es 8952; SPERTI, es 8923, es 8916, es 8973; ROMAGNOLO, es 8814, es 8904, es 8963, es 8907.Nel CD si trovano anche le piante di fase, rielaborate per questo volume da Giorgio Rossi.
I contesti studiati sono elencati in ordine numerico alla fine del volume (con i riferimenti alle piante e alle tavole dei disegni dei materiali) e, nel testo, sono sempre segnalati in grassetto.Nei singoli contributi dedicati ai contesti sono stati analizzati e disegnati (a cura degli Au-tori) tutti i materiali diagnostici, identificati dal numero del contesto, seguito da una sigla distintiva delle varie classi e da un numero progressivo (ad es. 9228_VN1).Le sigle distintive delle classi sono le seguenti: A = anforeCC = ceramica comuneCI = ceramica invetriataD = materiale di uso domesticoDC = ceramica decorata celticaED = materiale edilizioI = intonaciL = lucerneM = moneteML = materiale lapideoMT = metalliO = ossoP = pietraPS = ceramica a pareti sottiliTS = Terra SigillataV = vetriVN = ceramica a vernice neraVRI = ceramica a vernice rossa interna.
Tutti gli altri numeri di inventario sono costituiti dal numero di us/es seguito da un altro numero le cui prime due cifre corrispondono all’anno di scavo (ad es. 8012_010876 = cam-pagna di scavo 2001, us 8012). I numeri preceduti dalla sigla QA corrispondono a materiali provenienti dagli scavi nel Quartiere degli Artigiani (loc. S. Andrea, area di proprietà pro-vinciale).
Tutte le tavole dei materiali sono state riassemblate, con una nuova impaginazione, da Lilia Palmieri.
Tutte le fotografie, ove non indicato diversamente, appartengono all’Archivio dell’Università degli Studi di Milano.
476 M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
Anche la resa stilistica differisce dagli esemplari di appliques noti: nono-stante la superficie si presenti in alcuni punti consunta, è evidente la rigida e schematica definizione dei dettagli, il trattamento poco plastico e appiattito dei tratti, ben lontani dal colorismo di alcune appliques che evidentemente rientrano nel solco della produzione più raffinata.
Ci si adegua quindi a un modello consolidato, ben noto e in circolazio-ne, ma con risultati stilistici differenti. Anche se non è possibile individuare un centro di produzione, si può comunque ipotizzare per oggetti di uso privato, come piccoli complementi d’arredo, una produzione locale; la qua-lità della lavorazione, d’altronde, riporta a un prodotto destinato all’uso quotidiano e pratico161 e la scelta del frequentissimo motivo decorativo a maschera teatrale non può che sottolineare lo stretto legame esistente tra il teatro e la vita dei Romani, a tal punto da riflettersi nella vita quotidiana, come le suppellettili d’arredo domestico, meglio di ogni altro oggetto, sono in grado di mostrare162.
L’analisi dell’applique qui presentata non può che essere parziale, osta-colata dal fatto che, come sopra si è sottolineato, i reperti analoghi non for-niscono un termine cronologico o funzionale di riferimento, così come non è possibile ricavare informazioni certe dalla conoscenza dell’arredamento romano, il cui campione vesuviano, ancor oggi il più completo, rappresenta comunque un limite geografico e cronologico. Se pertanto alcuni aspetti andranno sicuramente meglio approfonditi, col presente studio si è voluto estendere il quadro conoscitivo di elementi decorativi spesso in secondo piano, quali le appliques, mettendo così a disposizione nuovo materiale per il proseguire delle ricerche.
ANTONINO CRISÀ 2.G Le monete
INTRODUZIONE
I reperti numismatici, rinvenuti durante gli scavi 2001-2006 nell’area della Domus del Labirinto, costituiscono un lotto di 63 monete inedite non restau-rate, cronologicamente comprese tra II sec. a.C. e XX sec. (figg. 216-219).
Un cospicuo insieme di 55 monete (87.3%) si riferisce generalmente all’età romana (II sec. a.C.-V sec. d.C.), un solo esemplare rappresenta l’età moderna e recente (XX sec.) (1.6%), mentre i rimanenti 7 esemplari (11.1%) non risultano classificabili a causa della loro completa illeggibilità163.
Le nuove monete sono primariamente descritte in termini complessivi, presentando nuovi dati sulla circolazione monetaria del sito e segnalando gli esemplari più rilevanti. Lo studio è poi corredato da un catalogo, ordina-to cronologicamente e comprendente l’analisi di ciascun nummo, secondo
477M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
CAT.N.
N. INV. US/ES MET. NOMINALEAUTORITÀ
EMITTENTEDATAZIONE
1 061339 us
8077 Æ asse C. Maianius per Roma 153 a.C.
2 041207 us
8092 AR quinario
L. Rubrius Dossenus per
Roma 87 a.C.
3 021724 us8015
AR quinario M. Antonio eOttaviano per
Roma 39 a.C.
4 021619 us
8056 AR denario M. Antonio 32-31 a.C.
5 020928 us8023
AR denario M. Antonio 32-31 a.C.
6 020840 us8039
Æ asse? Roma I sec. a.C.?
7 021820 es8800b
Æ semisse Roma I sec. a.C.?
8 041703 us8107
Æ semisse? Roma I sec. a.C.?
9 010146 us8000
Cu asse Augusto 27 a.C.-14 d.C.
10 041873 us8101
Or sesterzio C. Asinius
Gallus(Augusto)
22-21 a.C.
11 010800 us
8001 Cu asse C. Asinius
Gallus (Augusto)
16 a.C.
12 031215 es
9080 Cu asse
C. Plotius Rufus
(Augusto)15 a.C.
13 010995 us8011
Cu asse C. Plotius
Rufus (Augusto)
15 a.C.
14 030928 es
9013 Cu asse
C. Plotius Rufus
(Augusto)15 a.C.
15 051603 es
9013 Cu asse
L. Naevius Surdinus (Augusto)
15 a.C.
Fig. 216 – Tabella delle monete rinvenute nell’area della Domus del Labirinto (CRISÀ, Mo-nete, Cat. nn. 1-15).
478 M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
CAT.N.
N. INV. US/ES MET. NOMINALEAUTORITÀ
EMITTENTEDATAZIONE
16 051604 es
9013 Cu quadrante
Pulcher/Taurus/ Regulus
(Augusto)
8 a.C.
17 050588 us
8105 Cu asse
M. Salvius Otho
(Augusto)7 a.C.
18 010957 es8848
Or sesterzio? Caligola? 37-41d.C.?
19 050593 us8105
Cu asse Caligola 37-38 d.C.
20 051605 es9013
Cu asse Claudio 41-54 d.C.
21 021524 us
8047 Cu asse Claudio
50-54d.C.?
22 040899 us
8090 Or dupondio Vespasiano 74 d.C.?
23 050586 us
8105 Or sesterzio? imperatoredel I sec.
d.C.?I sec. d.C.?
24 040748 us
8092 Cu asse?
imperatoredel I sec.
d.C.?I sec. d.C.?
25 010240 us
8005 Or dupondio? Antonino
Pio?138-161
d.C.?
26 031021 es
9070 Cu asse Antonino Pio
138-161 d.C.
27 031022 es
9070 Or sesterzio
Antonino Pio per la diva Faustina I
141 d.C.
28 042018 spora-dico
Cu asse Antonino Pio
per la diva Faustina I
141 d.C.
29 021884 us
8032 Or sesterzio Marco Aurelio
161-180 d.C.
30 020343 es
8923 Or sesterzio Marco
Aurelio?161-180
d.C.?
31 010297 us
8000 AR denario Caracalla 198 d.C.
Fig. 217 – Tabella delle monete rinvenute nell’area della Domus del Labirinto (CRISÀ, Mo-nete, Cat. nn. 16-31).
479M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
CAT.N.
N. INV. US/ES MET. NOMINALEAUTORITÀ
EMITTENTEDATAZIONE
32 021841 us
8031 Or sesterzio Alessandro
Severo 231-235
d.C.
33 040633 us
8085 AR antoniniano Gallieno 253-268
d.C.
34 030877 us
8063 AR antoniniano Gallieno 260-268
d.C.
35 040375 us
8084 AR antoniniano Tetrico I
270-273 d.C.?
36 040714 us
8092 Æ
frazione di radiato
Massimiano 297-298
d.C.
37 010486 us
8005 AR antoniniano imperatoredel III sec.
d.C.?
III sec. d.C.?
38 041208 us8092
Æ nummus Costantino I 329-330 d.C.
39 040303 us8061
Æ nummus Costanzo II 330-333 d.C.
40 062457 spora-dico
Æ AE3 Valentiniano I
367-375 d.C.?
41 030640 es9058
Æ AE3 Graziano 367-375 d.C.
42 050587 us8105
Æ AE3 Graziano 367-383 d.C.?
43 031097 es9037
Æ AE2 Graziano 378-383 d.C.
44 041209 us8092
Æ AE3 Valentiniano II
375-392 d.C.
45 021903 us
8048 Æ AE3?
Valentiniano II
378-383 d.C.?
46 040715 us8092
Æ AE3 imperatoredel IV sec.
d.C.?
IV sec. d.C.?
47 030656 es
9060 Æ AE4?
fine IV-V sec.?
48 030876 us
8063 Æ AE4?
fine IV-V sec.?
49 031702 spora-dico
Æ AE4? fine IV-V
sec.?
Fig. 218 – Tabella delle monete rinvenute nell’area della Domus del Labirinto (CRISÀ, Mo-nete, Cat. nn. 32-49).
480 M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
CAT.N.
N. INV. US/ES MET. NOMINALEAUTORITÀ
EMITTENTEDATAZIONE
50 010665 es
8858 Or sesterzio
51 030152 us
8061 Cu asse?
52 030154 us
8061 Æ
53 040768 us
8092 Æ
54 010655 us
8003 AR
55 031315 us
8067 AR
56 041686 us
8095 Ac 20 cent Vittorio
Emanuele III 1942
57 030153 us
8061 Æ
58 061653 es
9359a Æ
59 020914 es
8900 Æ
60 040952 us
8100 Æ
61 030608 us
8070 Æ
62 030655 es
9060 Æ
63 031142 us
8064 Æ
Fig. 219 – Tabella delle monete rinvenute nell’area della Domus del Labirinto (CRISÀ, Mo-nete, Cat. nn. 50-63).
una successione di voci descrittive (vd. CD, APPARATO 2)164.Tali nummi, recuperati durante indagini archeologiche di tipo strati-
grafico, certamente consentono di proporre una duplice analisi tanto della microcircolazione, circoscritta ad un settore del vicus con più fasi di occu-pazione, quanto della macrocircolazione, concernente le dinamiche econo-miche di Bedriacum. Lo studio di questi nuovi esemplari si assomma alle già pubblicate analisi e catalogazioni di monete bedriacensi, conformandosi come un nuovo tassello del panorama bibliografico numismatico del vicus.
BREVE STORIA DELLE RICERCHE E DEGLI STUDI TRA XIX E XX SEC.Nel corso dell’Ottocento e dei primi anni del Novecento furono saltua-
481M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
riamente comunicate scoperte fortuite di monete nel territorio di Calvatone, apparse “nel lavorare i campi e nello scavare nuovi fossi”. Tra spoliazioni ad opera di privati e ritrovamenti eccezionali, come “un piccolo tesoro en-tro una cassetta ferrata” (ante 1834) o “in una pentola di creta num. 155 monete d’argento” (1856), nella maggior parte dei casi si trattò di segnala-zioni immancabilmente generiche e poco utili allo studioso, non essendovi quasi mai riferimenti specifici alle tipologie monetali. Nel 1855 Bologni menzionò la scoperta negli anni precedenti di numerose monete, recanti le effigi di imperatori da “Ottone” a “Lucio Elio Aurelio Vero” e perciò data-bili tra I e II sec. d.C. Nel 1876 Fiorelli segnalò rapidamente la scoperta di “monete comuni appartenenti per lo più a Costanzo ed a Costantino” (IV sec. d.C.). Agli inizi del Novecento Patroni comunicò il ritrovamento di 3 monete d’argento (2 repubblicane e 1 di Tiberio), 2 bronzi tresvirali d’età augustea, 4 monete enee di Vespasiano, Domiziano, Antonino Pio e Marco Aurelio. Lo stesso Patroni nel 1912 diede notizia alquanto vaga del recupe-ro di “due monete di bronzo molto consunte”165.
A Calvatone fu scoperto nel 1911 un tesoretto di 327 denari repubblica-ni, databili tra 152 e 26 a.C., comprendenti anche 3 denari per Sextus Pom-peius di zecca siciliana. Il secondo tesoretto, meno cospicuo e ricco rispetto al precedente, dotato attualmente di 16 monete, comprese tra II sec. e 15 a.C., è emerso in un anno imprecisato ante 1942. Tali ritrovamenti lungo la via Postumia provano la necessità di occultare prezioso circolante monetario durante la travagliata fase di transizione tra repubblica e impero. Entrambi i ripostigli monetali sono stati recentemente pubblicati da N. Vismara166.
Dopo le indagini archeologiche di Mirabella Roberti, rese note in via preliminare tramite alcuni contributi di certo assai parchi nel fornire indica-zioni di argomento numismatico167, si dovettero attendere gli anni Novanta del secolo scorso per le prime pubblicazioni, interamente dedicate ai ritro-vamenti monetali nel sito di Calvatone. Si tratta di un buon numero di studi soprattutto a firma di E. A. Arslan, nei quali i reperti numismatici sono stati studiati e catalogati con criteri scientifici.
Tra essi si possono citare Osservazioni preliminari sulla circolazione monetale antica a Calvatone, inserito nella monografia Calvatone Roma-na (1991), Le monete e la circolazione monetaria e il catalogo Le mone-te, presentati nei volumi di Bedriacum: ricerche archeologiche a Calvatone (1996), per ultimo lo scritto Monete, pubblicato nell’opera Calvatone ro-mana: un pozzo e il suo contesto (1997)168. Principale merito di E. A. Arslan è stata la formulazione ex novo delle dinamiche di circolazione monetaria a Bedriacum, della quale i processi si palesano soltanto dopo un’accurata catalogazione delle monete recuperate soprattutto nei contesti stratigrafici, indagati archeologicamente. In particolare rilevanti riflessioni sul circolante monetario di Calvatone, confrontato in termini statistico-quantitativi con
482 M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
le monete rinvenute a Mediolanum e a Clastidium, sono state proposte dal-lo stesso studioso nei contributi Le monete, presente nel volume Scavi MM3 (1991), e La moneta antica e la via Postumia centrale, dato alle stampe negli atti del convegno Optima via (1998)169.
L’ETÀ REPUBBLICANA
Sono state individuate 8 monete d’età repubblicana (cat. nn. 1-8), col-locabili in un arco cronologico tra II e I sec. a.C. Si tenterà di spiegare più avanti le cause della scarsità di ritrovamenti monetali pre-imperiali. Intanto è bene soffermarsi su alcuni esemplari, descrivendoli singolarmente.
La moneta più antica è un asse di C. Maianius (cat. n. 1, fig. 220), da-tabile al 153 a.C., recante al dritto l’effige di Giano bifronte e al rovescio la prua di nave, ben leggibile e in discreto stato di conservazione. Si tratta del primo esemplare rinvenuto a Calvatone, salvo pezzi non ancora pubblicati. L’emissione di C. Maianius riveste una certa importanza, poiché è emersa da un livello di riporto (us 8077), identificato nei qq. 18 T-U, ove sono emerse le tracce della prima frequentazione romana dell’area, avvenuta nel corso del II sec. a.C. L’asse è cronologicamente assai vicino all’anno di co-struzione della via Postumia (148 a.C.)170.
Tra le monete di I sec. a.C., rinvenute nell’area della Domus del Labi-rinto, v’è un gruppo di 4 monete d’argento (cat. nn. 2-5). I pezzi più antichi, a breve descritti ed esaminati, sono 2 quinari (cat. nn. 2-3), i quali appaiono per la prima volta a Calvatone, considerati i tipi e le autorità emittenti. La circolazione del quinario nella Bedriacum repubblicana è comunque già rappresentata da precedenti e non numerosi ritrovamenti, cronologicamen-te collocabili tra II e I sec. a.C.171.
Il primo quinario d’argento è un’emissione dell’anno 87 a.C. a nome di L. Rubrius Dossenus per Roma (cat. n. 2). Tale nummo, oltre a presentarsi alquanto consunto, è stato recuperato all’interno di uno strato di livella-mento (us 8092), il quale ha restituito altre monete di datazione più recente, tra le quali spiccano soprattutto gli esemplari di Costantino I e Valentiniano II. In tali termini per il quinario si potrebbe ipotizzare una giacitura origi-
Fig. 220 – L’asse di C. Maianius 8077_061339 (CRISÀ, Monete, Cat. n. 1).
483M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
naria in uno strato più antico, forse d’età repubblicana; magari a seguito di rivolgimenti del terreno o dell’azione delle radici, effettivamente emerse in corso di scavo172, il reperto numismatico è giunto in un’unità stratigrafica con materiali più tardi.
Di estremo interesse è la scoperta di un secondo quinario d’argento (cat. n. 3), emesso da Marco Antonio e Ottaviano nel 39 a.C. Il nummo è ben conservato e poco usurato, anche se il conio di rovescio appare piuttosto decentrato. La moneta reca al dritto il profilo della Concordia e al rovescio due mani unite, le quali stringono un caduceo. Tali raffigurazioni alludono più volte e molto esplicitamente all’alleanza tra i due celebri protagonisti della storia tardo-repubblicana romana. La moneta, indubbiamente carica di un rilevante valore storico, rappresenta una delle prime emissioni ufficiali del triumvirato.
Osservando il non vistoso stato di usura del pezzo, non pare che la moneta abbia circolato a lungo. Il quinario è stato raccolto dallo strato sab-bioso (us 8015), in cui fu realizzato il taglio es 8986, forse utilizzato come piccolo vano interrato (RAVASI, Prima frequentazione). Mentre in fase di scavo si era ipotizzato su base stratigrafica che la moneta potesse costituire un valido terminus post quem, l’analisi del riempimento us 8054 ha però fornito, sulla base dello studio dei materiali, un sicuro orizzonte cronologi-co, compreso tra la fine del II sec. a.C. e l’età cesariana: la moneta si trova dunque in giacitura secondaria.
Due denari d’argento (cat. nn. 4-5) appartengono alle emissioni legio-narie di Marco Antonio (39-31 a.C.). Nel ripostiglio “Calvatone 1911” è presente una coppia di denari tipologicamente affini ai 2 nuovi nummi d’argento; anch’essi sono emissioni militari di Marco Antonio, con la diffe-rente caratteristica di recare la legenda LEG XIII LYBICAE173. Esaminan-do i 2 nuovi esemplari, entrambi coniati negli anni 32-31 a.C. da zecche itineranti, il primo denario (cat. n. 4) reca al dritto una galea pretoriana e la legenda relativa alla carica di tresvir, ricoperta da Antonio, mentre al rovescio si osservano due insegne militari, un vessillo e la legenda LEG VII. Del tutto simile appare il secondo esemplare d’argento (cat. n. 5), caratte-rizzato da un rovescio ottenuto con conio visibilmente decentrato. Le due monete sembrano aver circolato a lungo, poiché presentano tracce di usura, forse più marcata per il secondo esemplare (cat. n. 5). A tal riguardo si può osservare che pure l’esemplare n. 18 del ripostiglio “Calvatone 1911” in base al peso sembrerebbe abbastanza usurato, nonostante il pezzo sia stato tesaurizzato assieme ad altre monete d’argento174.
Il denario cat. n. 5 è stato trovato nello strato di sottocoltivo (us 8023) che copriva il piano di preparazione pavimentale (es 8902) dell’Ambiente B, nella Domus delle Esagonelle (BENEDETTI, Domus Esagonelle ). La moneta di M. Antonio si trova in tale livello superficiale a seguito di rivolgimenti
484 M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
del terreno e non è quindi purtroppo possibile stabilire la sua giacitura ori-ginaria. Essa risulta precedente all’orizzonte cronologico in cui si colloca la costruzione dell’Ambiente B, ma potrebbe aver circolato anche nel corso del I sec. d.C., testimoniando la fase d’uso dello stesso ambiente.
Questa seconda ipotesi è plausibile, anche perché diversi denari d’ar-gento di M. Antonio sono stati recuperati nelle tabernae e nelle domus di Pompei, quindi sicuramente circolanti fino alla seconda metà del I sec. d.C.; più specificatamente si vuole anche ricordare il caso dei 42 denari, rivenuti nell’insula 10 della regio I della città vesuviana175.
Posizione stratigrafica ed usura dei pezzi, riscontrata anche su un esem-plare tesaurizzato, possono confermare anche nel modesto vicus di Bedri-acum il grande successo di queste monete di Antonio, emesse in ambito militare per l’impellente e necessario pagamento delle truppe legionarie, ma coniate con un titolo d’argento tanto elevato, da mantenere successivamen-te una duratura ed ampia diffusione.
Anche tra le monete nell’area della Domus del Labirinto, come già av-venuto in passato nel sito di Bedriacum, sono apparsi alcuni nummi spez-zati176. Tra questi soltanto su un asse (cat. n. 6), databile probabilmente al I sec. a.C. e fratturato intenzionalmente a metà, si riesce a distinguere al dritto una prua di nave. Il fenomeno della moneta frammentaria è già stato esaminato in precedenti pubblicazioni e lo si vuole ancora una volta relazionare, come si è ipotizzato sia per Bedriacum che per Mediolanum, ad una periodica carenza di circolante monetario, sopperita per lo più dallo “sdoppiamento” di svariati nominali, sia nella tarda età repubblicana, sia nell’età imperiale177.
Per concludere l’analisi delle monete repubblicane, è necessario men-zionare 2 monete enee poco leggibili (cat. nn. 7-8). Per caratteristiche pon-dometriche e per la presenza del tipo della prua, associato all’effige di Sa-turno soltanto in un esemplare (cat. n. 7), le monete sono riconducibili agli standard onciale ridotto o semionciale, pertanto all’incirca inquadrabili nel I sec. a.C. La scarsa leggibilità dei pezzi impedisce più precise identificazioni e datazioni, le quali rimangono comunque generiche ed ipotetiche178.
Al contrario sono numerose le monete repubblicane di queste tipologie, rinvenute e catalogate in passato, senza contare i pezzi volutamente spezzati. Lo studio delle serie enee repubblicane rimane piuttosto complesso. Comun-que questi 2 nuovi esemplari, essendo in numero assai ridotto, non modifica-no le conclusioni già precedentemente raggiunte. Già nel II sec. a.C. la città romana di Bedriacum si annoverava tra i centri economicamente propensi ad utilizzare il sistema monetario repubblicano; vi circolavano in maggioranza assi di standard via via più ridotto, ma non era diffusa la moneta celtica (3 esemplari), invece più rappresentata a Mediolanum (52)179.
485M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
L’ETÀ IMPERIALE
Tra le monete d’età imperiale spicca un cospicuo gruppo di 9 mone-te emesse da Augusto (27 a.C.-14 d.C.) (cat. nn. 9-17), le quali meritano un’ampia analisi. Si segnala in particolare un asse (cat. n. 11), il quale ha fornito un valido termine di datazione per i pavimenti dei triclini della Do-mus del Labirinto180.
Le restanti 8 monete costituiscono un ragguardevole insieme di bronzi tresvirali, emessi nel periodo 15-7 a.C. da alcuni tresviri monetali di Au-gusto, più precisamente 6 assi (cat. nn. 11-15, 17), seguiti da due unica, rispettivamente un sesterzio (cat. n. 10) e un quadrante (cat. n. 16). Il di-screto stato di conservazione di tutti gli esemplari ha consentito una sicura identificazione dei tresviri, permettendo così maggiori riflessioni alla luce dei precedenti ritrovamenti.
Considerando i nuovi esemplari ritrovati, si segnala il sesterzio di C. Asinius Gallus (16 a.C.) (cat. n. 10), l’unico nominale di questo magistrato finora scoperto a Calvatone, recante al dritto la legenda OB CIVIS SER-VATOS; ad esso si aggiunge un più comune asse dello stesso Asinius (cat. n. 11). Quattro nuovi assi dei tresvires C. Plotius Rufus (15 a.C.) (cat. nn. 12-14) e L. Naevius Surdinus (15 a.C.) (cat. n. 15) si assommano a prece-denti ritrovamenti, i quali raggiungono addirittura il numero di 7 unità per il primo magistrato. Nuovo esemplare, da considerarsi al tempo stesso un unicum, appare il quadrante della triade tresvirale Pulcher/Taurus/Regulus (8 a.C.) (cat. n. 16), dove si osserva al dritto la testa di Augusto ed al rove-scio due mani che stringono un caduceo. L’ultimo bronzo tresvirale inedito da menzionare è un asse di M. Salvius Otho (7 a.C.) (cat. n. 17), il terzo ritrovato a Calvatone.
È significativa la presenza di un nucleo così considerevole di monete tresvirali, strettamente databili al periodo 15-7 a.C., in un’area così circo-scritta del vicus: esso rappresenta un interessante caso di microcircolazione monetaria in un ambito ristretto dell’abitato antico.
A tal proposito risulta stratigraficamente rilevante la presenza del già segnalato asse di C. Asinius Gallus (cat. n. 11), datato al 16 a.C. Esso è emerso da us 8001, uno strato di livellamento su cui si impostano i pavi-menti dei triclini es 8806 ed es 8807, e ne costituisce quindi un prezioso terminus post quem (BACCHETTA, Domus Labirinto).
Si può considerare senza dubbio ragguardevole ed estremamente signi-ficativa la restituzione, da parte del piano in pezzame laterizio es 9013, di 3 monete tresvirali degli anni 15 e 8 a.C., ovvero gli assi di C. Plotius Rufus (cat. n. 14), di L. Naevius Surdinus (cat. n. 15) ed il quadrante dei magistra-ti Pulcher/Taurus/Regulus (cat. n. 16). Sempre da es 9013 proviene anche un asse di Claudio (cat. n. 20), purtroppo non ben identificabile e databile. Dal momento che i materiali recuperati in es 9013 ne testimoniano una
486 M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
fase d’uso nei primi due secoli dell’età imperiale, non si può escludere che questi esemplari tresvirali siano pertinenti ad un originario e modestissimo ripostiglio monetale, in qualche modo intaccato durante la creazione del piano in pezzame laterizio. Oltre a riferirsi ad un periodo cronologicamente piuttosto limitato (15-8 a.C.), le monete sono emerse dalla stessa area (qq. 20-21 T-U)181.
Si deve ragionevolmente riflettere sulla circolazione di moneta tresvi-rale a Calvatone, rielaborando i vecchi dati numismatici con i nuovi ritro-vamenti degli anni 2001-2006. Si giunge ad un complesso di 32 bronzi, così distribuiti (fig. 221-223)182: C. Plotius Rufus (7 esemplari), L. Naevius Surdinus (3), M. Salvius Otho (3), C. Asinius Gallus (3), Volusus Valerius Messalla (3), C. Cassius Celer (2), C. Gallius Lupercus (2), Lamia/Silius/Annius (2), Cn. Piso Cn. f. (1), Pulcher/Taurus/Regulus (1), P. Lurius Agrip-pa (1), M. Maecilius Tullus (1), L. Valerius Catullus (1), Augustus (1), non classificabile (1).
Spicca ovviamente la prevalenza di monete di C. Plotius Rufus (15 a.C.), seguito L. Naevius Surdinus (15 a.C.), da M. Salvius Otho (7 a.C.) e da C. Asinius Gallus (16 a.C.). Diversi sono i ritrovamenti in altri siti vicini, in particolare Milano (Plotius: 0 esemplari; Naevius: 1; Salvius: 1) e Cavria-na (MN) (Plotius: 2; Naevius: 5; Salvius: 1), senza considerare eventuali monete non ancora pubblicate183.
La quantità di nominali è così rappresentata da un totale di 31 pezzi identificabili: 26 assi, 4 quadranti, 1 sesterzio, 0 dupondi. È lampante la pre-dominanza degli assi, numericamente molto distaccati dai quadranti. Alla luce di questi valori pare che sesterzi e dupondi non trovassero molto spazio nella circolazione monetaria tresvirale di Calvatone, a parte un solo ritrova-mento per il primo nominale, il quale rimane comunque un caso isolato.
La massiccia presenza di moneta tresvirale a Calvatone, collocabile tra 16 a.C. e 12 d.C., in un periodo durante il quale “gli invii quindi erano periodici e regolari”, prova la necessità da parte di Roma di uniformare de-finitivamente la circolazione monetaria del vicus, dove la riforma monetaria augustea è stata applicata con successo; lo stesso evento è documentato a Mediolanum. Inoltre la massa di circolante dimostra l’inizio di una ricca fase per il centro cremonese, a partire dall’età augustea economicamente più prospero ed urbanisticamente più sviluppato. Pertanto sono ulterior-mente confermate le ipotesi già formulate in passato184, sottolineando che esse sono state dimostrate nel contesto archeologico dell’area della Domus del Labirinto.
Dopo Augusto (9 esemplari) i ritrovamenti dei restanti membri della gens giulio-claudia trovano riscontro nelle monete degli imperatori Caligo-la (37-41 d.C.) (cat. nn. 18-19) e Claudio (41-54 d.C.) (cat. nn. 20-21). Più precisamente un sesterzio di Caligola (cat. n. 18), nonostante si debba con-
487M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
16 a.C. C. Asinius Gallus n. 3 esemplari RIC Nominale Quantità Peso
(g) Ø
(mm)Bibliografia
370 sesterzio 1 16.88 33 cat. n. 10 371/2 dupondio 373 asse 2 9.24 25 cat. n. 11
ARSLAN 1996c, p. 251, tab. n. 24a
16 a.C. C. Cassius Celer n. 2 esemplari RIC Nominale Quantità Peso
(g) Ø
(mm)Bibliografia
374 sesterzio 375 dupondio 376 asse 2 9.38 26 VALENTI 1991, p. 200, n.
19 8.52 27 ARSLAN 1997, p. 214, n. 1
16 a.C. C. Gallius Lupercus n. 2 esemplari RIC Nominale Quantità Peso
(g) Ø
(mm)Bibliografia
377 sesterzio 378 dupondio 379 asse 2 11.30 29 ARSLAN 1996c, pp. 247-
248, n. 34 PATRONI 1908, p. 311
15 a.C. Cn. Piso Cn. f. n. 1 esemplare RIC Nominale Quantità Peso
(g) Ø
(mm)Bibliografia
380 sesterzio 381 dupondio 382 asse 1 11.49 27 VISMARA 1992b, p. 14, n.
15 15 a.C. L. Naevius Surdinus n. 3 esemplari
RIC Nominale Quantità Peso (g)
Ø(mm)
Bibliografia
383 sesterzio 384 dupondio
385/6 asse 3 10.45 26 VALENTI 1991, p. 200, n.
20 9.55 28 cat. n. 15
ARSLAN 1996c, p. 251, tab. n. 24a
Fig. 221 – Le monete tresvirali rinvenute a Calvatone (16-15 a.C.).
488 M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
15 a.C. C. Plotius Rufus n. 7 esemplari RIC Nominale Quantità Peso
(g) Dm
(mm)Bibliografia
387 sesterzio 388 dupondio
389 asse 7
12.12 21 VISMARA 1992b, p. 14, n. 16
10.84 27 cat. n. 12 9.67 26 VALENTI 1991, p. 200, n.
21 9.65 24 VALENTI 1991, p. 200, n.
22 9.63 26 cat. n. 14 8.89 27 cat. n. 13 8.26 24 VALENTI 1991, p. 200, n.
23 9 a.C. Lamia/Silius/Annius n. 2 esemplari RIC Nominale Quantità Peso
(g) Dm
(mm)Bibliografia
420/2 q A2 etnardau RSLAN 1996c, p. 251, tab. n. 24a
ARSLAN 1996c, p. 251, tab. n. 24a
8 a.C. Pulcher/Taurus/Regulus n. 1 esemplare RIC Nominale Quantità Peso
(g) Dm
(mm)Bibliografia
423/5 quadrante 1 3.06 18 cat. n. 16 7 a.C. P. Lurius Agrippa n. 1 esemplare RIC Nominale Quantità Peso
(g) Dm
(mm)Bibliografia
426 dupondio P1 essa 8/724 ATRONI 1908, p. 311
7 a.C. M. Salvius Otho n. 3 esemplari RIC Nominale Quantità Peso
(g) Dm
(mm)Bibliografia
429/30 dupondio 431/2 asse 3 9.97 27 VALENTI 1991, p. 201, n.
26 9.41 27 cat. n. 17
ARSLAN 1996b, p. 114, nota n. 15
Fig. 222 – Le monete tresvirali rinvenute a Calvatone (15-7 a.C.).
489M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
7 a.C. M. Maecilius Tullus n. 1 esemplare RIC Nominale Quantità Peso
(g) Dm
(mm)Bibliografia
433/4 dupondio 435/6 asse 1 5.36
(½) 26 VALENTI 1991, p. 201, n.
27 6 a.C. Volusus Valerius Messalla n. 3 esemplari RIC Nominale Quantità Peso
(g) Dm
(mm)Bibliografia
441/2 asse 3 10.68 25 ARSLAN 1997, p. 214, n.
28.39 26 VALENTI 1991, p. 201, n.
28 ARSLAN 1996c, p. 251,
tab. n. 24a 4 a.C. L. Valerius Catullus n. 1 esemplare RIC Nominale Quantità Peso
(g) Dm
(mm)Bibliografia
468 quadrante 1 3.01 15 VALENTI 1991, p. 201, n. 29
10-12d.C.
Augustus n. 1 esemplare
RIC Nominale Quantità Peso (g)
Dm(mm)
Bibliografia
471 asse 1 9.44 29 VALENTI 1991, p. 200, n. 24
- Non identificabili n. 1 esemplare RIC Nominale Quantità Peso
(g) Dm
(mm)Bibliografia
- asse 1 8.06 25 VALENTI 1991, p. 201, n. 25
Fig. 223 – Le monete tresvirali rinvenute a Calvatone (7 a.C. - 10/12 d.C.).
siderare d’attribuzione dubbia a causa del marcato stato d’usura, è emerso nel riempimento (es 8848) del taglio es 8849 nei qq. 23 P-Q-R, interpretato come una canalina di scolo della Domus del Labirinto (BACCHETTA, Domus Labirinto).
Al contrario la seconda moneta di questo imperatore (cat. n. 19) si distingue per il buono stato di conservazione. È un asse, emesso nel 37-38 d.C., dotato di un diritto perfettamente leggibile ed un rovescio con tracce del tipo di Vesta drappeggiata. Tra i giulio-claudi, tanto in questo nuovo lotto di monete, quanto nei precedenti lotti già pubblicati e qui segnalati in nota185, prevale per quantità totale di ritrovamenti totali Augusto (35
490 M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
esemplari), seguito da Tiberio (5), Claudio (4), Nerone (3), Caligola (2), Caio (2), Druso (1).
Alla seconda metà del I sec. d.C. risale una moneta di Vespasiano (69-79 d.C.) (cat. n. 22) per Tito, con il caduceo tra due cornucopie incrociate al rovescio186. Inoltre si aggiungono 2 monete (cat. nn. 23-24), da collocarsi in questo secolo, ma purtroppo non completamente classificabili.
Rispetto alla situazione riscontrata nei ritrovamenti dell’area della Do-mus del Labirinto, l’assenza di emissioni di molti imperatori tra I e III sec. d.C. non è stata precedentemente documentata. Al contrario in questo lun-go periodo sembra esservi stata a Calvatone una “scansione regolare di pez-zi” sia di imperatori sia di auguste, non dimostrata dai ritrovamenti degli anni 2001-2006, caratterizzati da un quantitativo non elevato di esemplari e da una loro parziale leggibilità. In generale il regolare afflusso di moneta è indice di un’evidente e continua frequentazione di Bedriacum, provata an-che dalle fonti archeologiche, ma anche di una forte espansione economica, verificatasi soprattutto tra I e II sec. d.C.187.
Sopperisce in parte a tale assenza, evidenziata nell’analisi di questo lot-to di monete, un gruppo di 4 monete emesse da Antonino Pio (138-161 d.C.). Tralasciando un dupondio d’attribuzione incerta (cat. n. 25), tra esse meritano una segnalazione un asse (cat. n. 26) ed un sesterzio (cat. n. 27), pertinenti al riempimento (es 9070) di un taglio (es 9071) di incerta natura - uno scasso per lavori agricoli o per l’asportazione di una struttura - effet-tuato nel già menzionato piano in pezzame laterizio es 9013 e nello strato sottostante us 8072. In tale livello si trovano rimescolati vari materiali (ol-tre ad alcuni elementi dello stesso es 9013) che forniscono una cronologia per la fase d’uso di es 9013 ai primi due secoli dell’età imperiale.
Dello stesso imperatore si evidenziano due emissioni per la diva Fau-stina I, recanti al rovescio tipi di figure femminili stanti con le comunissime legende AETERNITAS (cat. n. 27) ed AUGUSTA (cat. n. 28), una coppia di esemplari che si assommano ad un precedente nummo dell’augusta divi-nizzata188.
Per il II sec. d.C. si segnalano due sesterzi di Marco Aurelio (161-180 d.C.) (cat. nn. 29-30), entrambi purtroppo non ben classificabili a causa della loro evidente consunzione189.
L’ultima moneta di questo periodo è un denario di Caracalla (198-217 d.C.) (cat. n. 31), il primo scoperto a Calvatone di tale imperatore e tipolo-gia; è stato coniato nel 198 presso la zecca di Laodicea e reca al rovescio il tipo della dea Moneta stante con bilancia e cornucopia; purtroppo la collo-cazione stratigrafica non è molto significativa, essendo stato recuperato dal livello d’interro degli scavi di Mirabella Roberti del 1959 (us 8000).
Nell’area della Domus del Labirinto sono venute in luce 6 monete del III sec. d.C. (cat. nn. 32-37). La prima moneta, già nota fotograficamente,
491M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
è un sesterzio di Alessandro Severo (222-235) (cat. n. 32, fig. 162), data-bile agli anni 231-235. Esso si distingue per ottimo stato di conservazione del dritto, perfettamente leggibile e tecnicamente ben impresso in fase di coniazione, mentre al rovescio si osserva la dea Providentia stante. Questa moneta è stata restituita da uno strato (us 8031) che è stato interpretato come un livello naturale formatosi in seguito all’abbandono delle strutture collegate all’Ambiente C (ORSENIGO, Media età imperiale).
Due sono gli antoniniani di Gallieno (253-268). La prima moneta (cat. n. 33) proviene da un livello (us 8085) che documenta l’ultima fase di fre-quentazione dell’area ove si era sviluppata, nella prima età imperiale, la Domus del Labirinto (BACCHETTA, Domus Labirinto). Il secondo nummo (cat. n. 34) reca al rovescio la comune raffigurazione della Fides.
Di Alessandro Severo e Gallieno sono già stati ritrovati a Calvatone al-tri reperti numismatici, ma le monete summenzionate appaiono per tipolo-gia del tutto nuove. Un identico sesterzio di Alessandro Severo del tipo RIC n. 645 è stato trovato negli scavi 1982-1984 di piazza Duomo a Milano.
Va segnalato anche un altro antoniniano (cat. n. 35), emesso da Tetrico I (270-274) e restituito dallo strato limo-sabbioso us 8084, un livello che si estende prevalentemente nella zona a E del triclinio orientale della Domus del Labirinto e copre parte del piano in pezzame laterizio es 9013 e del cumulo di macerie es 9116; ritrovamenti dell’imperatore gallico e del suo successore si sono per lo più riscontrati a Milano190. Al gruppo delle monete del III sec. d.C. si aggiungono pure una frazione di radiato di Massimiano (286-307) (cat. n. 36) ed un antoniniano poco leggibile (cat. n. 37).
L’ETÀ TARDOANTICA
Le monete leggibili del IV sec. raggiungono il numero di 10 unità, attri-buibili agli imperatori Costantino I (307-337) (cat. n. 38), Costanzo II (337-361) (cat. n. 39), Valentiniano I (364-375) (cat. n. 40), Graziano (367-383) (cat. nn. 41-43), Valentiniano II (375-392) (cat. nn. 44-45), i quali a Calvato-ne hanno già trovato riscontro in precedenti ritrovamenti numismatici191.
Un’altra moneta con testa diademata al dritto (cat. n. 46) è anch’essa riferibile allo stesso periodo, probabilmente agli ultimi decenni del IV sec. Tra i nuovi esemplari leggibili si può menzionare il nummus di Costantino (cat. n. 38) con legenda VOT XXX, coniato dalla zecca di Roma nell’anno 329-330.
Si possono proporre alcune riflessioni di carattere stratigrafico. Il num-mus di Costanzo II (cat. n. 39) è emerso purtroppo da un livello di sotto-coltivo (us 8061) e quindi in questi termini non ha grande rilevanza. La prima moneta di Graziano (cat. n. 41), coniata ad Aquileia, proviene dal riempimento (es 9058) di una fossa (taglio es 9059), riconducibile ad alcuni interventi presso lo spazio aperto a E della Domus del Labirinto, posteriori
492 M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
alla fase d’uso della residenza. È ugualmente di grande interesse l’AE2 di Graziano del 378-383 (cat. n. 43), perché fornisce un orizzonte cronologico preciso per una delle numerose azioni di spoliazione che interessano tutto il vicus e che sono risultate ben evidenti anche nell’area oggetto di indagine. Frammisto ad abbondanti laterizi ed intonaci, è stato recuperato all’interno del riempimento (es 9037) della grande trincea di scasso che ha intaccato l’angolo NE dell’ambiente definito dal pavimento cementizio es 9009 (BAC-CHETTA, Domus Labirinto). La moneta data questo intervento all’ultimo quarto del IV sec., evidentemente uno dei periodi di sporadica frequenta-zione dell’area della Domus, forse soprattutto con lo scopo di recuperare materiale edilizio, quando più contratta era l’economia del vicus, rispetto alla più florida fase di Mediolanum192.
Un gruppo di 3 monete (cat. nn. 47-49) di basso peso e di modulo ristretto (0.61-0.76 g; dm 9-16 mm), caratterizzate da una quasi completa illeggibilità, si può verosimilmente ritenere costituito da nominali di esiguo valore, collocabili alla fine dell’età romana. Resta ancor oggi difficile esa-minare la circolazione monetaria bedriacense del V sec. (fig. 224), a causa della costante presenza di reperti alquanto illeggibili, quasi mai recuperati e studiati in passato, quando era assolutamente diffusa la prassi di seleziona-re le monete da scavo in base al loro stato di conservazione.
In effetti il numero totale di 21 esemplari (0.20-1.55 g; dm 7-16 mm) fi-nora rinvenuti non dovrebbe rispecchiare un’effettiva realtà del dato archeo-logico, in passato a volte alterato dagli scarti in sede di scavo. Secondo Arslan il circolante, rappresentato da monete di scarsissima fattura e di ridottissimo peso, ugualmente ben testimoniato a Mediolanum e nell’area di Bergamo, si affermava in una “vitale economia monetaria”, in qualche modo penalizzata da annosa e costante mancanza di freschi approvvigionamenti monetali. Si sarebbe così creata una “circolazione sussidiaria”, composta anche da pezzi più antichi e addirittura frammentati, ma anche da queste monetine, forse prodotte come falsificazioni di circolante non giunto nel centro193. La pre-senza di questi pezzi nel terreno dell’area della Domus del Labirinto può dimostrare un’ulteriore frequentazione dell’area anche nel V sec.
L’ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA
A Calvatone scarseggiano alquanto i ritrovamenti monetali d’età mo-derna e contemporanea, comunque generalmente compresi tra XV e XX sec., finora pari a 24 esemplari totali. La sola nuova moneta d’età post antica, emersa da uno strato limo-argilloso d’abbandono (us 8095), è un comunissimo 20 centesimi in acmonital di Vittorio Emanuele III (cat. n. 56, fig. 225), risalente al 1942. Questo ritrovamento isolato può soltanto indi-care un’ulteriore e recente frequentazione del sito di Costa S. Andrea, dove i terreni sono stati sfruttati, dopo l’età antica, per lavori agricoli194.
493M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
Peso (g oilbiB )mm( mD ) grafia1.55 16 VALENTI 1991, p. 215, n. 1251.05 15 VALENTI 1991, p. 215, n. 1271.04 11 VALENTI 1991, p. 215, n. 1260.80 12 VALENTI 1991, p. 215, n. 1280.80 10 ARSLAN 1997, p. 220, n. 31
74 .n .tac 9 67.084 .n .tac 11 27.0
0.64 11 ARSLAN 1991b, p. 188, nota 1, n. 19a; ARSLAN
1996c, p. 249, n. 50 0.64 11 ARSLAN 1991b, p. 188, nota 1, n. 19b; ARSLAN
1996c, p. 249, n. 51 94 .n .tac 61 16.0
0.56 11 ARSLAN 1997, p. 220, n. 280.55 10 ARSLAN 1997, p. 220, n. 290.38 8 ARSLAN 1996b, p. 118, nota n. 221 0.36 10 ARSLAN 1996b, p. 118, nota n. 222 0.33 9 ARSLAN 1996b, p. 118, nota n. 220; ARSLAN 1997, p.
219, n. 27 0.29 9 ARSLAN 1996b, p. 118, nota n. 223; ARSLAN 1997, p.
220, n. 32 0.28 8 ARSLAN 1991b, p. 188, nota 1, n. 19c; ARSLAN
1996c, p. 249, n. 52 0.26 ? ARSLAN 1991b, p. 188, nota 1, n. 16; ARSLAN 1996c,
p. 249, n. 47 0.25 8 ARSLAN 1996b, p. 118, nota n. 220; ARSLAN 1997, p.
220, n. 30 0.22 8 ARSLAN 1991b, p. 188, nota 1, n. 17; ARSLAN 1996c,
p. 249, n. 48 0.20 7 ARSLAN 1991b, p. 188, nota 1, n. 18; ARSLAN 1996c,
p. 249, n. 49
Fig. 224 – Le monete di V sec. d.C. (AE4?) di peso e modulo ridotti, rinvenute a Calvatone.
Fig. 225 – Il 20 centesimi in acmonital di Vittorio Emanuele III 8095_041686(CRISÀ, Monete, Cat. n. 56).
494 M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
ANALISI QUANTITATIVE
È possibile proporre alcune riflessioni di natura statistica. La prima si può applicare all’arco cronologico, nel quale sono comprese le monete qui esaminate. Considerato un totale di 50 esemplari databili (cat. nn. 1-49, 56), si delinea questa scansione: 8 monete d’età repubblicana (16%; cat. nn. 1-8), 41 d’età imperiale (82%; cat. nn. 9-49), 1 d’età moderna e contem-poranea (2%; cat. n. 56). Spicca ovviamente la netta predominanza delle monete imperiali, seguite dai nummi del periodo repubblicano, mentre non deve sorprendere l’assoluta esiguità di monete d’età moderna o recente, quest’ultimo dato sintomo di una scarsa e rada frequentazione del sito, uti-lizzato soltanto per svolgervi lavori agricoli o scassi nel terreno. Del resto, effettuando un confronto bibliografico tra i recenti ritrovamenti da scavo e i dati già pubblicati, questi rapporti numerici appaiono come noti per il sito di Calvatone, dove pure in passato si è effettivamente riscontrata la suddet-ta scansione quantitativa e cronologica195.
Considerato un totale di 56 pezzi d’età antica o moderna totalmente o parzialmente identificabili (cat. nn. 1-56), i metalli documentati possono es-sere così riassunti, enucleando i seguenti indicatori numerici: 19 di bronzo (Æ) (34%), 15 monete di rame (Cu) (26.8%), 11 di argento (AR) (19.6%) (fig. 226), 10 di oricalco (Or) (17.8%), 1 di acmonital (Ac) (1.8%). Di certo non può sorprendere la mancanza della moneta d’oro, alquanto rara nei ritrovamenti da scavo. Tuttavia a Calvatone sono testimoniate antiche sco-perte di aurei, ormai irrimediabilmente dispersi, il che potrebbe aumentare la speranza di futuri ritrovamenti196.
Esaminato un totale di 29 monete (cat. nn. 9-37), comprese nell’arco cronologico tra la fine del I sec. a.C. (età augustea) e il III sec. d.C., è ap-
Cat. n. Nominale Autorità emittente Datazione 2 quinario L. Rubrius Dossenus per Roma 87 a.C. 3 quinario Marco Antonio ed Ottaviano per
Roma 39 a.C.
4 denario Marco Antonio 32-31 a.C. 5 denario Marco Antonio 32-31 a.C. 31 denario Caracalla 198 d.C. 33 antoniniano Gallieno 253-268 d.C. 34 antoniniano Gallieno 260-268 d.C. 35 antoniniano Tetrico I 270-273 d.C.? 37 antoniniano imperatore del III sec. d.C.? III sec. d.C.?
?oiraned 45 55
Fig. 226 – Monete d’argento e di mistura rinvenute nell’area della Domus del Labirinto.
495M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
parsa questa successione quantitativa di nominali: 13 assi (44.8%), 7 se-sterzi (24.1%), 4 antoniniani (13.9%), 2 dupondi (7%), 1 denario (3.4%), 1 quadrante (3.4%), 1 frazione di radiato (3.4%). Nelle precedenti analisi di materiale numismatico bedriacense è già stata evidenziata la prevalen-za numerica degli assi, in tale sede riconfermata, nominali evidentemente utilizzati durante l’alto e medio Impero per un commercio ed un’economia molto dinamica; lo stesso si è detto per i dupondi, ma tra le monete del 2001-2006 in qualche modo identificabili con buon grado di certezza il loro numero non è apparso elevato.
Non coincide, invece, con la documentazione precedente la percentuale di sesterzi, solitamente assai elevata nel sito di Mediolanum, caratterizza-to da un’economia più dedita alle grandi transazioni di denaro e verosi-milmente legata alle rendite fondiarie197. Per Calvatone si consideri questo nuovo dato una sorta di anomalia, magari più legata a dinamiche di micro-circolazione di questo settore del vicus.
CONCLUSIONI
Ultimata la descrizione degli esemplari numismatici, arricchita da una revisione dei vecchi dati bibliografici, è bene delineare le conclusioni di que-sta nuova analisi inerente all’economia monetaria bedriacense, seguendo ancora una macro scansione di tipo cronologico.
Per la circolazione monetaria d’età repubblicana di II sec. a.C. i nuovi ritrovamenti degli anni 2001-2006 hanno sostanzialmente offerto una novi-tà di rilievo, ovvero l’asse di C. Maianius, significativo per la sua posizione nel settore in cui sono emerse le tracce della prima frequentazione romana dell’area oggetto d’indagine. Nell’ambito di una circolazione più ristretta alla zona di scavo, si può ritenere che l’area della Domus del Labirinto non sia stata molto frequentata prima dell’età tardo repubblicana, oppure che precedenti fasi d’occupazione siano state parzialmente o del tutto eliminate a seguito degli interventi costruttivi della seconda metà del I sec. a.C. Così dunque si spiegherebbe l’esiguità di ritrovamenti d’età repubblicana, salvo smentite a seguito di future indagini archeologiche. Interessante è la presen-za di 4 monete d’argento (due quinari e due denari). Tra esse ben 3 monete sono state emesse da Marco Antonio; la coppia di denari “legionari” d’ar-gento segna la fine del periodo repubblicano.
L’età augustea è ben rappresentata da un cospicuo gruppo di bronzi tre-svirali, ampiamente descritti e confrontati con i precedenti ritrovamenti, già in passato considerati la prova discriminante dell’imposizione a livello ter-ritoriale (inteso come “regionale”) di una circolazione monetaria standar-dizzata e regolarizzata dal governo centrale romano. La microcircolazione di tali monete all’interno dell’area oggetto di indagine rafforza l’ipotesi, confermata dall’analisi dei dati archeologici, di un’effettiva ricchezza di tale
496 M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
fase d’occupazione, confermata dalle successive emissioni dei giulio-claudi, comunque numericamente ben rappresentati.
Tra la fine del I sec. e il II sec. d.C.198 si è riscontrata la presenza di poche monete, soprattutto emissioni di Antonino Pio ed un isolato denario di Caracalla, quest’ultimo proveniente purtroppo da uno strato superficiale non significativo.
La frequentazione dell’area continua anche nel III sec. d.C., con un pro-babile cambiamento di destinazione funzionale, ormai non più solo residen-ziale, ma anche finalizzata ad attività artigianali e/o commerciali, collegate alla presenza dell’Ambiente C, in cui si segnala il ritrovamento di un bel sesterzio di Alessandro Severo.
Sempre seguendo un criterio di circolazione interna monetaria, un’altra fase certa di frequentazione dell’area si può ascrivere al IV sec. La posizione stratigrafica di alcune monete tardoantiche su un totale di 10 esemplari ha consentito di datare le attività nell’area, forse prevalentemente finalizzate al recupero di materiale edilizio. Infatti proprio all’ultimo quarto del secolo si data lo scasso per una trincea di asportazione dei muri e di parte di un pa-vimento cementizio (es 9009), secondo l’attestata presenza di una moneta di Graziano.
Più rarefatta ed ardua da interpretare risulta la circolazione moneta-ria nel V sec. Non andrebbe comunque sottovalutato il ritrovamento di alcune monete di infimo peso, evidentemente associabili ad una massa di circolante poco controllata da Roma, già studiata in passato per il sito di Bedriacum. L’area della Domus del Labirinto risulta in qualche modo utiliz-zata o comunque frequentata alla fine dell’Impero. Basandosi su scarsissimi ritrovamenti numismatici e su risultanze archeologiche a volte difficili da ricostruire, si delinea maggiormente sporadica la frequentazione in età mo-derna e recente della località Costa S. Andrea di Calvatone, quasi certamen-te sfruttata soltanto per lavori agricoli e asportazioni di materiali antichi da reimpiegare.
Infine si può ragionevolmente ritenere utile questa ricerca numisma-tica, poiché ha consentito non solo di confermare precedenti ipotesi sulla circolazione monetaria di Bedriacum, ma anche di offrire ulteriori dati per la definizione della cronologia delle fasi dell’area oggetto di indagine, pro-ponendo per la prima volta un’analisi della microcircolazione in un’area limitata del vicus, destinata tra la fine dell’età repubblicana e la prima età imperiale a funzione residenziale, ma oggetto di frequentazione almeno fino al V sec. d.C.
532 M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
NOTE
1 GRASSI 1997.2 GRASSI 1997, p. 227, cat. 1-2 e CORTINOVIS 2008, p. 78, tav. 26.7.3 GRASSI 1997, p. 227, cat. 3-5 e CORTINOVIS 2008, p. 203, tav. 25.3-4.4 Misure: h serbatoio 3.8 cm, h max (inclusa ansa) 5 cm, diam piede 3.6 cm, diam max ser-batoio 5.4 cm, diam foro di alimentazione 2 cm, distanza fra foro di alimentazione e foro di bruciatura 1.5 cm.5 H serbatoio 4.5 cm, diam stimato del serbatoio 5 cm, diam piede 3.6 cm.6 DI FILIPPO BALESTRAZZI 1988, p. 252.7 GRASSI 1997, p. 222.8 GRASSI 2007c.9 CUOMO DI CAPRIO, SANTORO BIANCHI 1983, p. 85.10 GRASSI 1997, p. 223.11 INDAGINI 1998, pp. 329-401.12 GRASSI 1997, pp. 215-216 e CORTINOVIS 2008, p. 75.13 Us 8077 è uno strato di livellamento situato a NE dei pavimenti dei cubicula es 8804 ed es 8805, contenente materiale di scarto e macerie cronologicamente inquadrabili nel I sec. a.C., in particolare anteriori all’età augustea.14 Misure: diam serbatoio alla base 3 cm, diam serbatoio alla sommità 3.4 cm, h 3.2 cm, lunghezza totale 7.5 cm, diam foro di alimentazione 1.8 cm, larghezza del disco 0.7 cm.15 Vd. GRASSI 1997, p. 218.16 Il muro di fondazione es 9048 appartiene all’Ambiente E (fase I, periodo 2): RAVASI, Prima frequentazione.17 Vd. GRASSI 1997, p. 217.18 Ringrazio il prof. A. Sartori per la sua disponibilità e il suo aiuto.L’iscrizione proseguiva certamente su tre lati: a destra, a sinistra e sotto, infatti, sono presenti solo parti di segni, che continuavano nella parti non conservate.19 GIOVÉ MARCHIOLI 1993, p. 41; p. 49.20 Il denarius corrisponde a 10 assi, perciò è indicato dal segno della decina (X), barrato da un titulus (-) per distinguerlo dalla lettera, cfr. GIOVÉ MARCHIOLI 1993, pp. 31-32.21 GIOVÉ MARCHIOLI 1993, p. 28.22 Vd. a titolo di esempio CIL IV, 4000, 4422, 4888 e 8566.23 Le tavolette lignee di Vindolanda sono state pubblicate a più riprese da A.K. Bowman e J.D. Thomas: BOWMAN, THOMAS 1983; BOWMAN, THOMAS 1994; BOWMAN 1994; BOWMAN, THOMAS 2003. Documenti contabili avvicinabili a questo fr. sono ad esempio in BOWMAN, THOMAS 1983, n. 5 pp. 93-97; BOWMAN, THOMAS 1994, nn. 181-185 pp. 129-145; n. 192 pp. 159-161; BOWMAN, THOMAS 2003, n. 582 pp. 34-36; n. 588 pp. 40-41; n. 596 pp. 53-58.24 I graffiti di La Graufesenque sono stati pubblicati per la prima volta da HERMET 1934; nuovi ritrovamenti sono stati editi da ALBENQUE 1951, AYMARD 1952 e AYMARD 1953; l’edi-zione comprendente tutti i graffiti scoperti fino al 1980 si deve a MARICHAL 1988, integrata recentemente da LAMBERT 2002 con gli ultimi rinvenimenti.25 Fra cui si ricorda il Lamboglia come pioniere degli studi sulla ceramica romana in Italia (LAMBOGLIA 1950).26 OLCESE 1993, pp. 44-45.27 MASSARI 1979, p. 39. Gli ambiti di utilizzo della ceramica comune sono molteplici: viene utilizzata in cucina per cuocere e per preparare cibi e sostanze, in dispensa per conservare solidi e liquidi, sulla tavola, per lavare e per lavarsi, per la cura personale, per le attività
533M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
domestiche e per quelle artigianali e produttive, per il culto, ma vi sono anche recipienti con funzioni insolite e curiose (LAVAZZA, VITALI 1994, pp. 18-19).28 MANNONI 1970, p. 298.29 RICCI 1985b, p. 1130 Fra i molti, si ricorda SCAVI MM3 1991, S. GIULIA 1999.31 Si ricordano, fra le pubblicazioni, CORSANO 1990; DELLA PORTA 1991; GRECO 1991; DEL-LA PORTA, SFREDDA 1993; CORSANO 1996; DELLA PORTA 1996; GRECO 1996; PAOLUCCI 1996; MEDICI 1997a.32 DELLA PORTA, SFREDDA 1996 e 1997.33 DELLA PORTA, SFREDDA 1996, pp. 133-134.34 PREDIERI, SFRECOLA 1996.35 Per produzione si intende un insieme di forme distinte che presentano lo stesso impasto e le stesse modalità di fabbricazione, riconducibili ad un’unica officina o a più officine che possiedono uno stesso bagaglio tecnologico-culturale (GUGLIELMETTI, LECCA BISHOP, RAGAZZI 1991, p. 133).36 DELLA PORTA, SFREDDA c.s.37 I nuovi gruppi/tipi dello scavo Sud sono i seguenti: Calv I.A.9-13; Calv I.C.4-6; Calv I.G.2; Calv I.H.7-31; Calv I.J.20-37; Calv I.K.2-4; Calv I.M.4-12; Calv I.N.2-6; Calv I.O; Calv I.P; Calv I.Q; Calv I.R.1-6; Calv II.A.6-8; Calv II.B.2; Calv II.C.2; Calv II.D.4; Calv II.E.4-5; Calv II.H.2; Calv II.K.3-8; Calv II.L.2-3; Calv II.M; Calv II.N; Calv II.O; Calv II.P. Una sintesi di tutta la ceramica comune di Bedriacum organizzata in tabelle e tavole riassuntive è stata pubblicata in CALVATONE-BEDRIACUM 2008.38 MEDICI 1997a.39 Si ricorda che in tutti i testi e le tabelle si è utilizzata la presenza o meno della spalla come discriminante per distinguere gli orli-parete dagli orli (in prevalenza ritagliati).40 Ad eccezione di alcuni frr. presenti in us 8047, un livello di preparazione precedente all’im-pianto delle strutture di fase III, dove sono probabilmente intrusivi.41 ORSENIGO 2003-2004.42 Il numero minimo è calcolato sulla base della percentuale di circonferenza rappresentata dai frr. di orlo con uguale diametro e identica tipologia recuperati e permette di ricostruire il numero di recipienti che potrebbero teoricamente essere ricostruiti con i frr. di orlo conser-vati.43 Il termine produzione indica i procedimenti tecnici che portano alla realizzazione di un manufatto, di un oggetto o di un bene; produzione è, però, anche un termine tecnico ar-cheologico che si riferisce a insiemi di forme realizzate con uguale impasto e con le stesse modalità di fabbricazione; una produzione comprende manufatti riconducibili ad uno stesso contesto storico, geografico e culturale (OLCESE 1993, p. 89).44 Definizione in: GLOSSARIO 1985, pp. 24-25; LAVAZZA, VITALI 1994, p. 34; MASSA, PORTULANO 1999, p. 146.45 Alcuni autori, come NOBILE 1991, p. 63, hanno recentemente considerato l’olla una for-ma aperta. Per aperta si intende una forma in cui il diametro dell’imboccatura è uguale o superiore all’altezza, e, in caso di frr., si segue la regola empirica che considera forme aperte quelle in cui è possibile introdurre comodamente una mano per lavarle e manipolarne il contenuto (LAVAZZA, VITALI 1994, p. 32).46 REBAUDO GRECO 1977, p. 34, ipotizza un uso come bicchieri per le ollette con il diametro alla base di 9-10 cm.47 Citate in GLOSSARIO 1985, pp. 24-25.48 GIORDANI, CORTI 1997, pp. 174-175: per patrimonio tecnologico si intende un insieme di tecniche di lavorazione e cottura, comprendendo “le modalità di scelta, preparazione e lavo-
534 M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
razione dell’argilla (grado di depurazione ed eventuale aggiunta di degrassanti), le tecniche di fabbricazione e di trattamento delle superfici, ed infine le caratteristiche del manufatto derivate dal processo di cottura”.49 Si precisa la differenza fra i termini “impasto”, che indica il tipo di argilla utilizzata, e “corpo ceramico”, che caratterizza il prodotto finito, in quanto è esito di lavorazione e cot-tura, vedi CUOMO DI CAPRIO 1985, pp. 87-89.50 GIORDANI, CORTI 1997, p. 175.51 FABBRI, GUALTIERI, SANTORO 1997, p. 183.52 Per tipo si intende un insieme di oggetti reali che presentano un alto numero di caratteristi-che comuni (RICCI 1985b, p. 12). In ultima istanza, si può considerare il tipo un’associazione costante di impasto e forma (NEGRO PONZI MANCINI 1996, p. 132).53 La sabbiatura era un procedimento utilizzato in fase di tornitura per impedire che il fondo aderisse al piano di lavoro, ma aveva anche la funzione di impedire che il recipiente scivolas-se durante l’uso, garantendo maggiore stabilità al piano d’appoggio.54 Questa caratteristica è già stata riscontrata in alcuni recipienti di età imperiale e tardoan-tica ad Angera e Milano, vd. TASSINARI, COMPOSTELLA 1995, p. 181.55 SANTORO BIANCHI 1990, pp. 393-394.56 La presenza di un occhiello è una caratteristica che è stata qui considerata distintiva, anche se questo dettaglio è stato indicato solo in pochissimi confronti, forse perché assente o forse perché considerato poco importante. Forme con occhiello, in questo caso coperchi, sono state messe in evidenza fra i materiali di Monte Barro, dimostrando che l’occhiello può essere un elemento valido al fine della creazione di un tipo: NOBILE 1991, tav. XLII, 8-11, coperchi I.h, p. 70.57 MEDICI 1997a, tav. XV, 15, p. 113.58 MEDICI 1997a, tav. XV, 16, p. 113.59 DELLA PORTA, SFREDDA c.s., tav. IX, 5, olla con orlo ripiegato tipo Calv I.J.31.60 DELLA PORTA, SFREDDA c.s., tav. IX, 4, olla con orlo estroflesso tipo Calv I.J.30.61 DELLA PORTA, SFREDDA c.s., tav. IX, 3, olla con orlo ingrossato tipo Calv I.J.29.62 DELLA PORTA, SFREDDA 1996, fig. 217, p. 151, olla tipo Calv II.B.1.63 DELLA PORTA, SFREDDA, TASSINARI 1998a, tav. LVII, in particolare, n. 1 (I.S.1), n. 4 (I.S.3), n. 5 (I.S.4), olla/olletta n. 50, var. A e B, pp. 148-149.64 Olla tipo Calv I.S.1: GUGLIELMETTI, LECCA BISHOP, RAGAZZI 1991, tav. C, f. 7, p. 219, olle tipo 17. Olla tipo Calv I.S.3: GUGLIELMETTI, LECCA BISHOP, RAGAZZI 1991, tav. LXXXV, f. 6, p. 185, olle tipo 50; CROCI 1996b, tav. 21, n. 11, p. 87; tav. 28, n. 11, p. 96. Olla tipo Calv I.S.4: GUGLIELMETTI, LECCA BISHOP, RAGAZZI 1991, tav. LXIII, f. 17, p. 115, olla tipo 20; LA CITTÀ E LA SUA MEMORIA 1997, fig. a p. 156, d, p. 195; CROCI 1996b, fig. 106, A2, pp. 203-204; tav. 17, n. 5, p. 83; tav. 38, n. 8, p. 111.65 Olla tipo Calv I.S.1: BUTTI RONCHETTI 1986, tav. VI, 41, p. 126, da sepoltura di I sec. d.C.; MIEDICO 2005b, p. 95, tav. XII, 10, olla da dispensa tipo 5 (in strati di II-III sec. d.C.). Olla tipo Calv I.S.3: BUTTI RONCHETTI 1985, tav. V, 15, p. 17 (tomba 3, metà I sec. d.C.); BUTTI RONCHETTI 1986, tav. VI, 40, p. 126; NOBILE 1992, tav. 6, 7.1, p. 19.66 Olla tipo Calv I.S.1: DONATI, BUTTI RONCHETTI, BIAGGIO SIMONA 1987, tav. p. 103, n. 05, p. 100 (tomba S12, 120-170 d.C.); tav. p. 103, n. 03, pp. 100-102 (tomba S13, 120-170 d.C.); BIAGGIO SIMONA 1999, tav. 141, n. 5, p. 237, H.7 Ascona (tomba 2, 100-150 d.C.). Olla tipo Calv I.S.2: DONATI, BUTTI RONCHETTI, BIAGGIO SIMONA 1987, tav. p. 97, n. 01, p. 96 (tomba S10, I sec. d.C.); tav. p. 109, n. 03, pp. 106-108 (tomba S15, 200-250 d.C.). Olla tipo Calv I.S.4: DONATI, BUTTI RONCHETTI, BIAGGIO SIMONA 1987, tav. p. 129, n. 185, p. 128; tav. p. 139, n. 242, pp. 138-140 (II sec. d.C.); BIAGGIO SIMONA 1999, tav. 143, n. 2, H10 Losone2, pp. 238-239 (180-230 d.C.).
535M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
67 Olla tipo Calv I.S.4: SELLER, VIETTI 1985, tav. 4, 4, p. 231; tav. 4, 5, p. 231.68 Olla tipo Calv I.S.1: LAVIZZARI PEDRAZZINI 1980, tav. 10, 2-4, pp. 222-224; SACCARDO 1985, tav. 93, 8 di età traianeo-adrianea; tav. 93, 11 di età flavia, p. 471. Olla tipo Calv I.S.3: LA-VIZZARI PEDRAZZINI 1980, tav. 9, 2, pp. 222-224; MACCABRUNI, SCHIFONE 1985, tav. 39, 9, pp. 137-138 (tomba 18 di inizio II sec. d.C.). Olla tipo Calv I.S.4: SACCARDO 1985, tav. 93, 6, p. 471; LAVIZZARI PEDRAZZINI 1980, tav. 9, 3, pp. 222-224; TASSINARI, COMPOSTELLA 1995, tav. 50, 6, gruppo II, tipo 8, pp. 114-115; tav. 51, 3, gruppo III, tipo 10, p. 117.69 Olla tipo Calv I.S.1: PISTAN 1999, fig. 102, 6-7, tipo 38a e fig. 102, 8, tipo 38b, pp. 246-247, gruppo K7, impasto 41; fig. 115, 10, tipo 91d, p. 276, gruppo K6, impasto 1 (da Vercelli). Olla tipo Calv I.S.2: CONUBIA GENTIUM 1999, fig. 248, 2, p. 231 (dalla necropoli di Oleggio, NO); PREACCO ANCONA 2000, fig. 113, A5 b, p. 17; tav. 14, n. 3, tomba 42 (seconda metà del I - II sec. d.C.), olletta decorata sulla spalla (da Biella). Olla tipo Calv I.S.4: PISTAN 1999, fig. 113, 9, p. 271, gruppo K2, olle tipo 91a; fig. 114, 3, p. 272, gruppo 32, olle tipo 52b (da San Michele di Trino, VC); PREACCO ANCONA 2000, fig. 113, a, p. 117; tav. 15, 4, (tomba 44); tav. 29, 3, (t. 108); tav. 35, 2, (t. 139); tav. 44, 3-4, (t. 201); tav. 19, 2, (t. 56); tav. 36, 2, (t. 146); tav. 45, 3, (t. 202); tav. 74, 1, (t. 365B); tav. 84, 1, (t. 473) (da Biella); REBAUDO GRECO 1980, tav. XLVII, 8 e 10 (da Caselette, TO).70 Olla tipo Calv I.S.1: BONINI, FELICE, GUGLIELMETTI 2002, tav. XII, 2-3, p. 247. Olla tipo Calv I.S.3: necropoli di Nave, BS: BESSI TREVALE 1987, tav. 31, 2, p. 196. Olla tipo Calv I.S.4: necropoli di Nave, BS: BESSI TREVALE 1987, tav. 30, 7, p. 196; S. Giulia, BS: MASSA, PORTULA-NO 1999, fig. 125, 3, p. 185.71 Olla tipo Calv I.S.1: MORANDINI 2000, tav. I, 9, pp. 166-168. Olla tipo Calv I.S.3: MORAN-DINI 2000, tav. I, 10, pp. 166-168.72 Essenziale, infatti, alla comprensione della ceramica comune è ricordare che esiste un rapporto molto stretto fra forma-funzione-impasto (su questo tema si ricorda il convegno IL CONTRIBUTO DELLE ANALISI ARCHEOMETRICHE 1997).73 SANTORO BIANCHI 1990, p. 338.74 MANNONI, GIANNICHEDDA 1996, pp. 148-154.75 Confronto segnalato in GRASSI 2007a, p. 249, nota 28.76 CAGNANA 2000, pp. 103-106; GELICHI 1986.77 Le osservazioni vanno espresse con cautela, poiché il quadro basato solo sulle anfore risulta parziale. Difficilmente ricostruibile, infatti, è il commercio del grano, trasportato in sacchi, e del vino, trasportato in dolia o botti (sul problema cfr. PANELLA 2002, p. 178, nota 4 e CARRE 1993, pp. 9-31).78 Da ultimo si veda RAVASI 2006, p. 317, nota 13 (con la bibliografia precedente).79 Il prototipo della tabella è stato elaborato dalla dott.ssa Stefania Mazzocchin, che rin-grazio vivamente, nel corso del suo Dottorato di Ricerca presso l’Università degli Studi di Padova e modificato da chi scrive secondo le esigenze del materiale preso in esame e anche per consentirne una migliore visualizzazione a video. La tabella è suddivisa nelle seguenti sezioni: 1) dati di scavo (numero di us/es, numero di inventario, quantità e stato di conser-vazione); 2) analisi tipo-morfologica dell’anfora (tipo, area di produzione, contenuto); 3) descrizione del fr. preso in esame; 4) misure indicate in cm; 5) apparato epigrafico 1/2 per indicare l’eventuale presenza di due cartigli; 6) caratteristiche del corpo ceramico (colore, indicato con i valori della tabella Munsell, durezza dell’impasto, inclusi, ingobbio); 7) in-terpretazione: note, osservazioni, informazioni bibliografiche e cronologiche; 8) numero di disegno del fr. analizzato.80 Si è fatto riferimento alle analisi a sezione sottile del materiale di Milano, Scavi MM3: BRUNO, BOCCHIO 1991, pp. 258-262; BRUNO, SFRECOLA 1995, pp. 83-118 (per le anfore Lamb. 2). Per le anfore rinvenute a Calvatone nel Campo del Generale: VOLONTÉ R. 1996, Appendice p. 199.81 Del resto del materiale si è tenuto conto per le osservazioni generali su consumo e commercio.
536 M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
82 8054_A2; 8054_A3; 9226_051783; Per i frr. di us 8054 cfr. anche PALMIERI 2008, p.112, tav. 27, 28-29. Il fr. 8062_030052 presenta orlo-collo caratterizzato da un impasto molto depurato (7.5YR 8/6 pink) con inclusi bianchi, chamotte finissima e mica a frequenza me-dia. Con le stesse caratteristiche ma con ingobbio ocra sulla superficie (10YR 8/4 very pale brown) si presenta il fr. 8015_021723.83 BRUNO 1995, pp. 57-58, figg. 26-27 (Gruppo 2).84 BRUNO, BOCCHIO 1991, p. 262, tav. CXII, f. 1; SCIALLANO, SIBELLA 1991, p. 29 (Epave du mont Rose, Marseille).85 FACCHINI 1991, p. 110; VOLONTÉ R. 1996, p. 189, tab. 20; MASSEROLI 1997c, p. 91; RAVASI 2006, pp. 317-318, nota 18 (per un probabile centro produttivo a Piacenza).86 BRUNO 1995, pp. 51, 53-54, 60, figg. 21, 3; 23, 12; 28, 25 (Gruppo 1 e 3).87 Gli esemplari trovano stretti confronti in BRUNO 1995, pp. 62-64, figg. 30-31 (Gruppo 4); pp. 67-68, fig. 34 (Gruppo 6B).88 BRUNO 1995, pp. 70, 77, figg. 35, 48; 42, 4 (Gruppo 7).89 Per questo motivo nella Tabella (vd. CD, TABELLA CONTENITORI DA TRASPORTO) compaiono alcuni frr. identificati come “Lamb. 2 o Dressel 6A”. Bisogna tenere conto inoltre che an-che le analisi macroscopiche degli impasti mostrano caratteristiche simili: leganti naturali (calcite bianca e nera di media frequenza) e degrassanti (chamotte). Anche se difficilmente attribuibili all’uno o all’altro tipo essi sono un indicatore importante per le informazioni riguardanti il contenuto e l’area di produzione.90 D’AMBROSIO, DE CARO 1989, fig. 50, 2634; D’ANDRIA 1969, p. 61, n. 2, tav. 13, 2.91 RAVASI 2006, p. 320.92 Per le indagini sulle fornaci dell’ager brindisino (Apani e Giancola) cfr. MANACORDA 1988, pp. 91-108; MANACORDA 1990, pp. 375-415; MANACORDA 1994, pp. 277-284; PALAZZO, SIL-VESTRINI 2001, p. 61.93 CIPRIANO, CARRE 1989, p. 79, fig. 10 (da Cologna Marina). BRUNO, BOCCHIO 1991, p. 267, tav. CXV, fr. 64.94 FACCHINI 1991, p. 138, tavv. II, 2 - IV, 2 (tra i tipi non identificati).95 PALMIERI 2008, p. 112, tav. 27, 21.96 TASSAUX, MATIJASIC, KOVACIC 2001 (sulle fornaci a Loron); BEZECZKY 1998 (a Fasana).97 CARRE, PESAVENTO MATTIOLI 2003 (cfr. anche per la classificazione interna del tipo).98 Il bollo si presenta lacunoso. Non è quindi possibile sapere se fosse presente anche il co-gnomen Bassus: la sua presenza o assenza potrebbe infatti differenziare il marchio sia dal punto di vista cronologico, che della organizzazione della produzione. Cfr. CIPRIANO, MAZ-ZOCCHIN 1998, p. 378, nota 9.99 Sull’attività della gens Laecanii vd. BEZECZKY 1998, TASSAUX 2001.100 Per stretti confronti vd. BEZECZKY 1987, pp. 41-64; CIPRIANO, MAZZOCCHIN 1998, p. 372, tav. 2, 9.101 FACCHINI 1991, p. 138, tav. II, 2; PAOLUCCI 1996, p. 245.102 Sulla diffusione vd. MUFFATTI MUSSELLI 1987.103 Una sintesi dei tituli picti è stata proposta da PESAVENTO MATTIOLI 2009.104 Cfr. BRUNO BOCCHIO 1991, p. 271, tav. CXVII, ff. 102-104.105 BEZECZKY 1987, p. 75, n. 290, fig. 26 (da Savaria).106 MASSEROLI 1997c, p. 96, tav. XII, 4-5.107 Questi esemplari si aggiungono agli altri già segnalati per il territorio del vicus: cfr. FAC-CHINI 1991, p. 134; FACCHINI 1997, pp. 42-43, tav. 2 (nn. 2-3-4-5), 3 (n. 1); MASSEROLI 1997c, pp. 96-97; RAVASI 2006, p. 320, nota 36.108 SCIALLANO, SIBELLA 1991, p. 89, fig. 5.
537M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
109 Cfr. CIPRIANO 2003, p. 242 dove la presenza di vini provinciali ad Altino è stata collegata non necessariamente a prodotti di pregio, ma invece giustificata con l’esistenza di etnie di origine diversa.110 Sul problema vd. RAVASI 2006, p. 320 (con la bibliografia precedente).111 Il fr. è caratterizzato dall’impasto granuloso e ruvido al tatto con inclusi di quarzo, punti neri e mica di media frequenza e porosità esterna.112 Cfr. BRUNO, BOCCHIO 1991, p. 275, tav. CXX, fr. 152.113 Cfr. PANELLA, FANO 1977 (per i materiali di Pompei) e FARIÑAS DEL CERRO 1977.114 Per le attestazioni dai vecchi scavi cfr. FACCHINI 1997, p. 48, tav. 6, 7-8-9-10; VOLONTÉ R. 1996, p. 192; RAVASI 2006, p. 321, nota 50.115 Cfr. CARRE, PESAVENTO MATTIOLI 2003, pp. 468-470.116 Il fr. in esame trova confronti in KEAY 1984, p. 100, fig. 37, 9.117 Per i problemi della cronologia e la diffusione delle anfore africane cfr. BONIFAY 2004.118 CORSI-SCIALLANO, LIOU 1985, p. 84, n. 44, fig. 68; pp. 160, 162, 165; CARRE, GAGGADIS-ROBIN, HESNARD, TCHERNIA 1995, pp. 69-70, nn. 179-180.119 Da ultimo vd. RAVASI 2006, pp. 315-329.120 Per un aggiornamento su queste tematiche vd. PANELLA 2002, p. 212, nota 4 (con la bi-bliografia precedente).121 ISINGS 1957, pp. 63-67.122 BIAGGIO SIMONA 1991, pp. 177-185.123 MASSEROLI 1998b, pp. 362-363.124 CESELIN 2003, pp. 22-24.125 ROFFIA 1993, pp. 149-151.126 MASSEROLI 1998a, pp. 41-45.127 MACCABRUNI 1983, pp. 90-96; BONOMI 1996, pp.128-129.128 MASSEROLI 1998b, pp. 362-363.129 MASSEROLI 1998a, pp. 41-45; BONOMI 1996, pp. 128-129; CESELIN 2003, pp. 22-24.130 LARESE 2004, pp. 58-60.131 DE FRANCESCHINI 1998, pp. 377-378, fig. 91.132 MEDICI 1996a, p. 215.133 MACCABRUNI 1983, pp. 90-96.134 BIAGGIO SIMONA 1991, pp. 177-185.135 MAGICHE TRASPARENZE 2000, p. 39; CESELIN 2003, pp. 22-24.136 Vd. ad esempio ROFFIA 1993, pp.149-151, con esemplari da Milano, Luni, Adria, Este e Canton Ticino.137 FACCHINI 1999, pp. 19-20.138 MASSEROLI 1998b, pp. 362-363.139 ZAMPIERI 1998, pp. 141-145.140 ROFFIA 1993, pp. 149-151.141 Solitamente i bolli presentano i tria nomina abbreviati, la scritta disposta su 2 linee e delle figure complementari sia geometriche che zoo-fitomorfe.142 CCVL CREMONA 2004, p. 184.143 ROFFIA 1993, pp. 149-151; FACCHINI 1996, pp. 53-55; BIAGGIO SIMONA 1991, pp. 177-185; CESELIN 2003, pp. 22-24; LARESE 2004, pp. 58-60.144 FACCHINI 1996, pp. 53-55; FACCHINI 2004, pp. 19-24.145 Nei corredi di Albenga è sempre associata a elementi legati all’uso del vino, PAOLUCCI 2000, pp. 55-62.
538 M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
146 MACCABRUNI 1983, pp. 90-96; MASSEROLI 1998b, pp. 362-363.147 LARESE 2004, pp. 58-60.148 FACCHINI 1999, pp. 19-20.149 MASSEROLI 1998b, pp. 362-363; FACCHINI 2004, pp. 19-24.150 Riguardo i materiali bronzei di Bedriacum già oggetto d’indagine vd. PATRONI 1908; MAS-SEROLI 1997b; CASTOLDI 2005.151 Per considerazioni generali riguardanti i materiali bronzei vd. IL BRONZO DEI ROMANI 1990. Sulle appliques decorative vd. anche BABELON, BLANCHET 1895; CASTOLDI 1995; BRONZI 2001; ALICU 2003; CASTOLDI 2005; FACCHINI 2005; GIOVANNINI 2007; UTTOVEGGIO 2007.152 Per gli studi riguardanti l’arredamento domestico delle città di Pompei, Ercolano e Oplon-tis vd. RICHTER 1926; SPINAZZOLA 1928; INSTRUMENTUM 1977; BELLEZZA E LUSSO 1992; RISCO-PRIRE POMPEI 1993; ERCOLANO 1993; POMPEI 1996; STORIE DA UN’ERUZIONE 2003; DE CAROLIS 2007. Sulle pitture pompeiane vd. PPM 1990-2003.153 DE CAROLIS 2007, pp. 163-170. Si può escludere, con una certa sicurezza, l’appartenenza dell’applique a un letto, il cui apparato decorativo, destinato ad arricchire lo spazio ondula-to delle spalliere (fulcra), presenta per lo più protomi a tutto tondo e medaglioni con busti aggettanti. (DE CAROLIS 2007, pp. 80-93, fig. 47 p. 82). Per gli armadi invece sono note al momento decorazioni applicate in osso, mentre in bronzo erano realizzate per lo più mani-glie e serrature (DE CAROLIS 2007, pp. 93-113, 189-191).154 Vd. PRADEL, QUONIAM 1989, fig. 23.155 Accanto agli esemplari in semplice struttura lignea (vd. DE CAROLIS 2007, fig. 106 p. 141, proveniente dal porticato del Decumano Massimo di Ercolano), si sono rinvenute anche casse, destinate a una committenza più esigente, rivestite esternamente di lamine in bronzo o in ferro (arcae ferrata), fissate con chiodi la cui testa, oltre ad avere il valore funzionale di fissare la lamina al legno, costituisce anche un motivo decorativo; completano la decorazio-ne appliques in bronzo, disposte sul coperchio e sul lato frontale (vd. RICHTER 1926, fig. 341 p. 145; PERNICE 1932; RISCOPRIRE POMPEI 1993, pp. 204-233; MASTROROBERTO 1992; ROCCO 2003; CIVALE 2003, p. 75; DE CAROLIS 2007, pp. 140-143, 188-189). Sono noti anche esem-plari in territorio transalpino (vd. KEMKES 1995; DYCKZEK 2002).156 Si può ricordare una rappresentazione pittorica di una ragazza che porta una scatola da Ercolano (vd. RICHTER 1926, fig. 338 p. 142).157 Dalle composizioni musive (vd. per esempio il mosaico dal vestibolo della Casa del Fauno di Pompei in POMPEI 1996, tav. 8 p. 55, tav. 67 pp. 276-277) a quelle pittoriche (PPM 1990-2003; ma anche la cosiddetta Villa di Poppea a Oplontis e la Sala delle maschere nella Casa di Augusto sul Palatino in BETTO 1993, figg. 12-13 p. 23); dai rilievi dei sarcofagi a quelli delle lastre dei peristili dei giardini (RISCOPRIRE POMPEI 1993, p. 310); dalle fontane (vd. Casa della Fontana Grande di Pompei, DE CAROLIS 2007, fig. 38 p. 64; AEMILIA 2000, p. 470) agli oscilla (vd. BACCHETTA 2005); dagli oggetti d’uso quotidiano (le anse di vasellame: CASTOLDI 1993, n. cat. 10 tav. LXIX; TASSINARI 1993, p. 219, tav. CXLI nn. 2, 3, 5; tav. CXLII nn. 2, 4, 7; tav. CXLIII nn. 2, 4, 6; la suppellettile in terracotta: BERNABÒ BREA 1981) agli oggetti d’ornamento personale (vd. a titolo d’esempio l’anello con cammeo in sardonica con raffigurazione di una maschera teatrale. Napoli, Museo Archeologico Nazionale in BETTO 1993, fig. 10 p. 21).158 Vd. BOUCHER 1973, pp. 119-120 nn. cat. 184-185; PETIT 1980, pp. 133- 136; TOMBOLANI 1981, n. cat. 70; BIONDANI 2005, p. 301, fig. 181 n. 2.159 Per un’accurata indagine sulla maschera teatrale dello schiavo vd. WEBSTER 1961.160 BIEBER 1961, p. 155. Corone/ghirlande simili si ritrovano anche in alcune statuette fittili raffiguranti il personaggio teatrale dello schiavo presso il Museo Vaticano e il British Mu-seum, o in un rilievo romano con maschera dionisiaca e di menade, i quali, tuttavia, presen-tano tratti iconografici distanti dalla nostra applique (BIEBER 1961, p. 150 figg. 156-158; p. 578 fig. 573b).
539M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
161 Sull’arredamento di lusso vd. BELLEZZA E LUSSO 1992; SLAVAZZI 2001a e 2001b.162 Sull’importanza e l’influenza del teatro nella società romana vd. BETTO 1993.163 Età romana: cat. nn. 1-49 (totalmente o parzialmente classificabili), 50-55 (recanti tracce di tipi d’età romana a lettura piuttosto incerta). Età moderna e contemporanea: cat. n. 56. Illeggibili: cat. nn. 57-63.164 Le voci nel Catalogo delle monete (vd. CD, APPARATO 2) sono così organizzate: I riga: nu-mero identificativo della moneta, numero inventario, us/es di provenienza; II riga: metallo, valore nominale, modulo (mm), peso (g); III riga: autorità emittente, zecca, anno; IV riga: legenda e tipo del dritto; V-VI riga: legenda e tipo del rovescio e dell’esergo; VII riga: biblio-grafia. È bene precisare che talvolta, appurata la totale o parziale illeggibilità delle monete, non è stato possibile completare tutte le voci sopraindicate.165 BOLOGNI 1855, pp. 145-146; FIORELLI 1876, p. 178; PATRONI 1908, pp. 310-311; PATRONI 1912, p. 426; PONTIROLI 1972, pp. 92-99; TOMASONI 1990, p. 139; PASSI PITCHER 1991, pp. 45-46; PONTIROLI 1993, pp. 41-45.166 VISMARA 1992a e 1992b; ARSLAN 1998b, pp. 366-367; CHIARAVALLE 1998a, p. 393; CHIARA-VALLE 1998b, p. 393; CRISÀ 2008, p. 253: per la monetazione di Sextus Pompeius.167 MIRABELLA ROBERTI 1972, p. 110: “Da notare un asse semiunciale e un MB di Marco Au-relio trovato nella sede del muro divisorio presso l’angolo Nord dell’aula b” (l’unica e strin-gata segnalazione di monete trovate nella Domus del Labirinto). Per gli scavi di Mirabella Roberti si rimanda a SENA CHIESA 2007, pp. 217-218.168 ARSLAN 1991b, IDEM 1996b, IDEM 1996c, IDEM 1997. Vd. anche VALENTI 1991, pp. 197-216; EADEM 1996, pp. 305-307.169 ARSLAN 1991a, IDEM 1998a.170 PASSI PITCHER 1990, p. 247; ARSLAN 1991b, p. 189; SENA CHIESA, GRASSI 2004, p. 84; SENA CHIESA, GRASSI 2006, p. 164; GRASSI 2007a, p. 244; SENA CHIESA 2007, pp. 220-222. Per le prime testimonianze di frequentazione dell’area, vd. RAVASI, Prima frequentazione.171 ARSLAN 1996b, p. 106 (si parla di un totale di “4 Quinarii”, ritrovati a Calvatone); ARSLAN 1996c, p. 247, nn. 30 (Q. Pompei Rufi), 33 (Octavianus); ARSLAN 1998a, p. 370; CHIARA-VALLE 1998c, pp. 394-395, nn. IV.74 (T. Clouli Q e C. Egnatulei C.F.), IV.75 (T. Clouli Q), IV.77 (Q. Titus), IV.81 (Octavianus) (= ARSLAN 1996c, p. 247, n. 33). A Mediolanum pro-babilmente non circolava moneta repubblicana d’argento; a tal riguardo vd. ARSLAN 1991a, p. 75.172 Lo strato di livellamento (us 8092) ha restituito un cospicuo numero di monete, pari a 7 unità. Si tratta di materiale numismatico molto eterogeneo in termini cronologici, il che confermerebbe la derivazione di tali reperti da strati differenti. La presenza di radici nello strato è stata ricavata dalla documentazione d’archivio. Le 7 monete pertinenti ad us 8092 sono rispettivamente: cat. nn. 2 (L. Rubri Dosseni), 24 (imperatore del I sec. d.C.?), 36 (Massimiano), 38 (Costantino I), 44 (Valentiniano II), 46 (imperatore del IV sec. d.C.?), 53 (illeggibile).173 VISMARA 1992a, p. 18, nn. 17-18.174 VISMARA 1992a, p. 18, n. 18 (3.05 g).175 SAVIO 2001, pp. 134-135: denari legionari di M. Antonio; GIOVE 2003, pp. 27-30: per i 42 denari emersi nell’insula 10 della regio I di Pompei; SAVIO 2007, pp. 85-89: ancora sui denari legionari di M. Antonio.176 Cat. nn. 6 (frattura intenzionale), 53 (frattura intenzionale), 62 (frattura non intenziona-le), 63 (frattura probabilmente non intenzionale).177 ARSLAN, CHIARAVALLE 1988, pp. 400-401: moneta frammentaria a Mediolanum; ARSLAN 1991a, p. 78: idem; ARSLAN 1991b, pp. 190-191, 194; VALENTI 1991, p. 199, n. 17 (½ asse di Sesto Pompeo, 42-38 a.C.), p. 201, n. 27 (½ asse di Augusto, 7 a.C.), p. 212, nn. 100 (frazio-ne di radiato di Diocleziano, 297-299 d.C.), 101 (frazione di radiato di Costanzo I, 294-305
540 M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
d.C.); ARSLAN 1996b, pp. 104, 112, 118, nota n. 208 (2x½ monete con feltempreparatio FH; ½ moneta con spesreipublicae); ARSLAN 1996c, p. 246, nn. 9 (frazione di asse sestantale, dopo il 215 a.C.), 16-17 (2x½ assi onciali, II sec. a.C.), p. 248, n. 43 (½ antoniniano di Te-trico, 270-273 d.C.); ARSLAN 1997, p. 217, n. 14 (frazione di Æ, 364-375 d.C.), p. 222, n. 48 (frazione di Æ, non datato).178 È interessante notare che un semisse (cat. n. 7) è stato recuperato in uno dei livelli di macerie (es 8800b) che coprivano l’ambiente A (RAVASI, Prima frequentazione); SAVIO 2001, p. 85: assi Giano/prua; ARSLAN 2007, pp. 316-317: diffusione di monete di peso sestantale e unciale nella bergamasca e a Bedriacum.179 ARSLAN 1991a, pp. 72-76: confronto Mediolanum-Bedriacum; ARSLAN 1991b, pp. 189-190; ARSLAN 1996b, pp. 102-104; ARSLAN 1998b, pp. 364-365.180 GRASSI 2007a, p. 248, nota n. 24: “asse di Augusto”.181 Allo stesso ambito cronologico (età augustea) appartengono anche pochi frr. ceramici, considerati residuali (BENEDETTI, es 9013).182 I dati inseriti nella tabella derivano da una revisione della bibliografia numismatica di Calvatone; ad essi si aggiungono i nuovi ritrovamenti degli anni 2001-2006. Alcuni esem-plari risultano pertanto privi di indicazione di peso e di modulo, non essendo stati segnalati nei precedenti contributi. Per ulteriori confronti con altri siti lombardi vd. ARSLAN 1996c, pp. 251-252, tab. n. 24a.183 ARSLAN, CHIARAVALLE 1988, p. 426, n. 133 (Salvius Otho), p. 430, n. 159 (Naevius Surdi-nus); ARSLAN 1991a, pp. 93-94, n. 3 (Salvius Otho = ARSLAN, CHIARAVALLE 1988, p. 426, n. 133), p. 120, n. 515 (Naevius Surdinus = ARSLAN, CHIARAVALLE 1988, p. 430, n. 159); ARSLAN 1996c, pp. 251-252, tab. n. 24a; ARSLAN 1999, pp. 190-191, 194-198, tab. n. 2, tombe nn. 87, 94B, 104, 105, 111, 117, 119, 128, 130, 134, 146, 147, 154; ARSLAN 2007, pp. 322-324: per altri ritrovamenti nell’area lombarda.184 ARSLAN 1991a, p. 76; ARSLAN 1991b, p. 191; ARSLAN 1996a, pp. 56-57; ARSLAN 1996b, p. 107; ARSLAN 1997, p. 207; ARSLAN 1998a, p. 372.185 VALENTI 1991, pp. 200-203, nn. 18-29 (Augusto: 12 monete), 30 (Druso: 1), 31-34 (Ti-berio: 4), 35 (Caio: 1), 36 (Claudio: 1), 37-39 (Nerone: 3); VISMARA 1992a, p. 18, nn. 20-22 (Augusto: 3); VISMARA 1992b, p. 14, nn. 15-16 (Augusto: 2); ARSLAN 1996b, pp. 107, 114, nota n. 15 documento G. Cattaneo 1836 (Augusto: 6; Claudio: 1; Agrippa: 1); ARSLAN 1996c, pp. 247-248, nn. 34 (Augusto: 1), 35 (Tiberio: 1), 36 (Caio: 1); ARSLAN 1997, p. 214, nn. 1-2 (Augusto: 2).186 Per altri esemplari di Vespasiano, rinvenuti a Calvatone, vd. VALENTI 1991, p. 203, n. 40; ARSLAN 1996c, p. 248, n. 37.187 ARSLAN 1991a, pp. 76-77, 79; ARSLAN 1991b, pp. 190-192; ARSLAN 1996a, pp. 57-58; ARSLAN 1996b, pp. 107-108; ARSLAN 1998a, pp. 372, 374, fig. 8: “Monete di I-III sec. a Bedriacum: percentuali”, p. 375; ARSLAN 1998b, pp. 367-368: riflessioni sulla circolazione di III sec. lungo la via Postumia.188 Per le altre monete bedriacensi di Antonino Pio si rimanda a VALENTI 1991, pp. 205-206, nn. 58-64 (in particolare la n. 64 è un asse per Faustina I, 141-161 d.C.); ARSLAN 1996b, p. 114, nota n. 15 documento G. Cattaneo 1836 (asse di Antonino Pio).189 Per le altre monete di Marco Aurelio, rinvenute precedentemente a Calvatone, vd. VALEN-TI 1991, pp. 206-209, nn. 65-80.190 ARSLAN, CHIARAVALLE 1988, pp. 402, 412-413, nn. 41-43 (Mediolanum, Piazza Duomo, Tetrico I: 3 monete; Tetrico II: 2), p. 430, n. 162 (Mediolanum, via Rugabella 1987, Tetrico I: 1); ARSLAN 1991a, p. 96, n. 56 (Mediolanum, piazza Duomo 1982-1984, sesterzio di Ales-sandro Severo RIC n. 645); VALENTI 1991, pp. 209-211, nn. 85-90 (Alessandro Severo: 6), 92-95 (Gallieno: 4); ARSLAN 1996a, p. 57: si segnala un “perfetto parallelismo” tra Bedria-cum e Mediolanum dalla fine II sec. all’età gallienica; ARSLAN 1996c, p. 248, n. 43 (Tetrico II:
541M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
1; si menziona ugualmente questo antoniniano, anche se non è emesso da Tetrico I); ARSLAN 2002b, p. 173. Il sesterzio di Alessandro Severo è stato riprodotto fotograficamente sulla terza di copertina in NotALomb 2001-2002.191 VALENTI 1990, pp. 248-249, nn. 4 (Costantino I: 1 moneta), 5 (Costanzo II: 1), 8 (Valen-tiniano I: 1); VALENTI 1991, p. 212, n. 103 (idem = VALENTI 1990, p. 248, n. 4), pp. 212-215, nn. 103-108 (Costanzo II: 6; la n. 107 corrisponde a VALENTI 1990, p. 248, n. 5), 109-110 (Costanzo II o Costanzo Gallo: 2), 117 (Costanzo II: 1 = VALENTI 1990, pp. 248-249, n. 8), 119, 122 (Valentiniano I: 2; si osservi il n. 122, probabilmente dello stesso tipo di cat. n. 40); ARSLAN 1997, p. 215, n. 5 (Costanzo II: 1), p. 217, nn. 15-18 (Valentiniano I: 4).192 ARSLAN 1991a, p. 82: per Mediolanum; VALENTI 1996, pp. 305-306; ARSLAN 1998b, p. 368: la via Postumia nel IV sec.193 ARSLAN, CHIARAVALLE 1988, p. 400: “gran quantità di bronzi di modulo decrescente”; CHIARAVALLE 1989, pp. 91-94: anche un ripostiglio milanese di AE4 presenta monete in catti-vo stato di conservazione; ARSLAN 1991a, pp. 84-88 (“miserabile moneta” di peso 0.12-0.40 g a Mediolanum), 125-126, tabb. 7-8; ARSLAN 1991b, p. 194; VALENTI 1991, pp. 215-216, nn. 125-128; ARSLAN 1996b, pp. 112-113, 118, note nn. 221-222 (refusi: cat. n. 28→48, n. 29→49); ARSLAN 1996c, p. 249, nn. 47-52; VALENTI 1996, p. 306; ARSLAN 1997, pp. 219-220, nn. 27-32; ARSLAN 1998a, p. 376; ARSLAN 1998b, p. 368; ARSLAN 2007, p. 337.194 VALENTI 1991, p. 216, n. 129: quattrino di Filippo III d’Asburgo, 1598-1621; ARSLAN 1996b, pp. 113-114, nota n. 15 documento G. Cattaneo 1836: 3 sesini di Mantova, 2 quat-trini di Mantova, un denaro di Novellara, 3 denari di Milano, un Blutzger dei Grigioni, 1 Æ e 1 AR veneti; ARSLAN 1996c, pp. 249-250, nn. 53 (quattrino di Francesco II Gonzaga, 1484-1519), 54 (quattrino di Guglielmo Gonzaga, 1550-1575), 55 (parpagliola di Filippo III, dal 1603), 56 (5 soldi di Vittorio Amedeo II, 1680-1713), 57-58 (3 cent e 1 cent di Napoleone, 1807-1813), 59-60 (1 cent e 1 cent di Francesco I d’Asburgo, 1822 e 1828), 61 (5 cent di Vittorio Emanuele II, 1862), 62 (5 cent di Vittorio Emanuele III, 1923).195 VALENTI 1991, pp. 198-216 (129 monete databili): 17 d’età repubblicana (13.2%; nn. 1-17), 111 d’età romana (86%; nn. 18-128), 1 d’età moderna (0.8%; n. 129); ARSLAN 1996c, pp. 245-250 (62 monete databili): 33 d’età repubblicana (53%; nn. 1-33), 19 d’età romana (31%; nn. 34-52), 10 d’età moderna (16%; nn. 53-62); ARSLAN 1997, pp. 214-221 (34 mo-nete databili): 34 d’età imperiale (100%; nn. 1-34).196 PONTIROLI 1972, p. 92: “una moneta d’oro assai larga”, p. 99: “due di Giulio Cesare tro-vate nel fondo Gamba ed altre vendute al Consigliere di Tribunale Signor Pagliari” e “una d’oro trovata nel fondo Regonella di Gorni Santo, comunissima di Arcadio, venduta a Boz-zolo al prezzo favoloso di L. 50”; PONTIROLI 1993, pp. 42-43: “monete d’oro”, “una d’oro di Nerone”; ARSLAN 1996b, p. 107: è già stata segnalata l’assenza di moneta aurea da scavo.197 Ciò detto, si osservi che tra le monete recanti tracce di tipi d’età romana a lettura piutto-sto incerta (cat. nn. 50-55) vi potrebbero essere altri esemplari di quei nominali, purtroppo non identificabili con sicurezza e quindi non conteggiati nel calcolo di percentuale. ARSLAN 1991a, pp. 77, 79; ARSLAN 1991b, p. 191; ARSLAN 1996a, p. 58; ARSLAN 1996b, p. 108; VA-LENTI 1996, p. 305; ARSLAN 1998a, p. 375; ARSLAN 1999, p. 188; ARSLAN 2007, p. 326.198 SENA CHIESA, GRASSI 2004, p. 85.199 SENA CHIESA 2001, p. 17.200 SENA CHIESA 2001; SENA CHIESA 2002.201 SENA CHIESA 2001, p. 21.202 SENA CHIESA 2001, p. 19; SENA CHIESA 2002, p. 168.203 SENA CHIESA 2002, p. 168.204 SENA CHIESA, FACCHINI 1985, pp. 14-16, con indicazioni bibliografiche.205 GRASSI 1997; ZENONI, Lucerne.206 Ad es. MAASKANT-KLEIBRINK 1986, pp. 3-4, fig. 2.
542 M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
207 SENA CHIESA 2002, p. 175.208 Vd. MAASKANT-KLEIBRINK 1978, I, p. 122, n. 151, II, p. 31, figg. 151a-b; MAASKANT-KLEI-BRINK 1986, pp. 3-4, fig. 2; HENIG 1994, p. 85, fig. 150.209 SENA CHIESA, FACCHINI 1985, pp. 16-17.210 In proposito, MARINI CALVANI 1980, pp. 7-14; CHIAPPORI 1994, pp. 143-145.211 Vd., rispettivamente, SENA CHIESA 1966, pp. 362-364, nn. 1142-1144, 1147-1157, tav. LVIII, figg. 1142-1144, 1147-1157; MAASKANT-KLEIBRINK 1978, I, p. 343, nn. 1063a-b, II, p. 166, figg. 1063a-b; HAMBURGER 1968, p. 33, nn. 107-108, tav. V, figg. 107-108; MANDEL ELZINGA 1985, p. 277, fig. 49, p. 279, n. 49.212 SENA CHIESA 1966, p. 363, con la citazione; cfr. MICHEL 2001, pp. 156-157, tav. 36, n. 257 (con bibliografia); LANCELLOTTI 2003, pp. 122-123; MICHEL 2004, p. 102 e inoltre MASTRO-CINQUE 2008, pp. 221-223, con ulteriori indicazioni.213 SENA CHIESA 1966, p. 365, n. 1166, tav. LIX, fig. 1166, p. 367, n. 1176, tav. LIX, fig. 1176; MAASKANT-KLEIBRINK 1978, I, p. 342, n. 1062, II, p. 166, figg. 1062a-b (con zampa anteriore sollevata).214 BMCRE IV, p. 232, n. 1436, tav. 34, 4; pp. 402-403, nn. 132-135, tav. 55, 17-18.215 ZWIERLEIN DIEHL 1991, p. 82, n. 1776, tav. 28, fig. 1776; p. 89, n. 1820, tav. 35, fig. 1820.216 Si tratta della faccia con diametro minore. Secondo CORTI, PALLANTE, TARPINI 2001, p. 283, l’incisione sarebbe ottenuta a bulino.217 Si tratta della faccia con diametro minore.218 Libra: MICHON 1904, pp. 1222-1229. Trutina: MICHON 1919. Vd. anche DI PASQUALE 1999; TARPINI 2001.219 In generale MICHON 1907; CORTI 2001.220 CORTI, PALLANTE, TARPINI 2001, p. 276.221 CORTI, PALLANTE, TARPINI 2001, pp. 274-275, figg. 203, 247; PONDERA 2001, pp. 351-352 nn. 27-29.222 CORTI 2001, p. 196; alla nota 62 p. 210 elenco di esemplari con indicazione ponderale. Un esemplare da Pompei: HOMO FABER 1999, p. 300 n. 372.223 Vd. CORTI, PALLANTE, TARPINI 2001, pp. 292-293. La certezza della provenienza sarebbe possibile solo tramite analisi chimiche e sezioni sottili, che non sono state effettuate.224 CORTI, PALLANTE, TARPINI 2001, pp. 283-290; PONDERA 2001, pp. 355-357 nn. 36-40.225 Sulle problematiche relative all’identificazione delle strutture in materiali deperibili nel corso di un’indagine archeologica si veda DE CHAZELLES-POUPET 1985.226 Per la terminologia tecnica vd. GINOUVÈS, MARTIN 1985.227 Per trattazioni più approfondite sulle tecniche edilizie che si avvalgono di materiali depe-ribili, si rimanda a: ARCHITECTURES 1985; BARDOU, ARZOUMANIAN 1978; DE CHAZELLES 1997; DESBAT 1981; HOUBEN, GUILLAUD 1989. Un ottimo quadro sull’impiego di tali tecniche nella Cisalpina romana è offerto da BACCHETTA 2003. Per contributi specifici su Calvatone-Bedria-cum si vedano, inoltre, MEDICI 1996d, ROTTOLI 1996, MAGNI 1996-1997, SENA CHIESA 1998, MEDICI 1998a, MAGNI 2000, ZENONI 2005-2006.228 Fra le poche attestazioni certe, si segnala una porzione di muro in adobe ancora in situ rin-venuta a Calvatone in un edificio tardo-repubblicano, vd. BISHOP, PASSI PITCHER 1991, p. 129.229 L’analisi, condotta da R. Bugini presso l’Istituto CNR per la Conservazione e la Valorizza-zione dei Beni Culturali, Sezione “Gino Bozza” del Politecnico di Milano, è stata realizzata mediante microscopia ottica in luce polarizzata su sezione sottile e mediante diffrattometria ai raggi X su polveri: i campioni analizzati appartengono a un mattone crudo e a frr. di in-cannucciata provenienti da un saggio nello scavo Sud: vd. ZENONI 2005-2006, pp. 85-97.230 Caratteristica del pisé è la presenza di inclusi minerali quali sabbia o ghiaia. Vd. ADAM 1984, p. 63.
543M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
231 BEDRIACUM 1996, p. 172.232 Vd. DE CHAZELLES 1997, p. 94.233 LUGLI 1957, p. 34.234 Molti altri sono i termini con cui vengono definite strutture di tal genere: “strutture a telaio”, “costruzioni a ossatura”, strutture “à pans de bois” o “à colombage”.235 Cfr. le case etrusche di Marzabotto, i cui muri ad intelaiatura lignea sono riempiti da mattoni (BERTANI 1990, pp. 21-34) e le case di Oderzo, con tamponamenti parietali in pietra (ABITARE IN CISALPINA 2001, p. 233).236 BACCHETTA 2003, pp. 121-122.237 Vd. ZENONI 2005-2006.238 Vd. ROTTOLI 1996.239 Scavi di Piazza Duomo, via Tommaso Grossi, piazza Missori, via Rugabella, via Roma-gnosi, via Cesare Correnti 24, corso di Porta Romana 2, via Santa Maria Fulcorina, via Santa Maria in Podone, via Moneta, Università Cattolica, Palazzo dell’Arivescovado. Vd. i relativi articoli in SCAVI MM3 1991.240 Per i confronti con fondazioni a strati rinvenute in territorio transalpino vd. SCAVI MM3 1991, pp. 135-136.241 Vd. CERESA MORI 1996, p. 29 e CERESA MORI 2000, p. 83.242 L’impiego delle canne a tale scopo è segnalato già da Plinio, Naturalis Historia, 35, 169.243 Le canne con un diametro così ridotto appartengono alle varietà Arundo Pliniana o Phragmites Australis, ben differenti rispetto alla comune Arundo Donax applicata al torchis per tamponare la struttura delle pareti, vd. ROTTOLI 1996, p. 165.244 Il campione di riferimento è un fr. di intonaco proveniente da us 8047.245 Gli intonaci di es 9116 appartenenti al gruppo 2, caratterizzati da evidenti segni di com-bustione e dall’assenza di cocciopesto nella preparazione, sono stati datati al I sec. d.C. e dunque ritenuti pertinenti a edifici di fase II (GIACOBELLO, Intonaci).246 Cfr. MAURINA 1998, pp. 93-94.247 Come confronto per l’Ambiente C si è considerato l’Edificio 3 degli scavi nel Campo del Generale (periodo II).248 NIELSEN 1993, p. 14.249 ADAM 1984, p. 290.250 NIELSEN 1993, p. 14.251 ADAM 1984, pp. 290-294; Vitr., De Arch., V, 10, 2.252 ADAM 1984, p. 294.253 ADAM 1984, p. 294; NIELSEN 1993, p. 15.254 NIELSEN 1993, p. 15.255 Vitr., De Arch., VII, 4, 2.256 UBOLDI 1991, p. 149.257 UBOLDI 1991, pp. 149-150.258 ADAM 1984, p. 294.259 UBOLDI 1991, p. 149.260 Sen., Ep. XC, 25-26.261 ADAM 1984, p. 295; UBOLDI 1991, p. 149; UBOLDI 2005b, p. 485.262 MEDICI 1996d, p. 146; MEDICI 1997c, pp. 174-175.263 GRASSI 1988, p. 182, fig. 2.264 MEDICI 1996d, p. 146.265 SENA CHIESA 1996, p. 92.
544 M AT E R I A L I E S T R U T T U R E
266 BERGAMO 1986, fig. 126, p. 129.267 GRASSI, PALMIERI 2011, p. 119.268 In accordo con quanto sostenuto in MEDICI 1996d, p. 146.269 Per gli intonaci dello scavo Sud e del saggio Nord: MARIANI 1997, EADEM 1998, EADEM c.s.; per quelli del Campo del Generale: PAGANI 1996.270 MARIANI, PAGANI 2005, p. 295; GIACOBELLO 2008.271 Bedriacum si caratterizza per intraprendenza produttiva: ricettiva rispetto ai modelli esterni, fu creatrice anche di tipologie proprie, come dimostra la produzione ceramica. Cfr. per la vernice nera GRASSI 2008a.272 Vitr., De Arch., VII, 4. Cfr. MARIANI 1998, p. 497.273 L’uso del cocciopesto nel tettorio e nell’intonachino è ben testimoniato a Brescia e Cre-mona: vd. MARIANI 2004, p. 307; MARIANI, PAGANI 2005, p. 293; PASSI PITCHER, MARIANI 2007b.274 Oltre al caso degli intonaci dell’Ambiente A, vd. il gruppo I/9116 databile alla fase II ed es 8907 in fase III, tutti con alzati murari in argilla. Diversamente gli alzati murari in mattoni sembrano essere stati rivestiti di intonaci privi di cocciopesto: vd. il caso del gruppo II/9116. Cfr. G. ZENONI, Gli alzati in terra cruda.275 Tracce di canne sugli intonaci sono conservate anche nell’insieme di us 8047, fase II. Per tali tecniche e importanti osservazioni vd. ZENONI, 2005-2006; EADEM, Gli alzati in terra cruda.276 Per altri significativi esempi cfr. Villas, maisons, sanctuaires 2007.277 Ringrazio la dott.ssa Elena Mariani per le importanti indicazioni.278 A Pompei tali rifacimenti (normale manutenzione, cambiamento di gusto, passaggio di proprietà) sono ampiamente documentati: vd. ZEVI 1991, p. 271; per le tecniche di ristruttu-razione della decorazione parietale vd. MARIANI, PAGANI 2005, p. 293.279 I ritrovamenti d’intonaci con impronte di canne non sono inusuali a Calvatone: cfr. MARIA-NI 1997, pp. 197-199. Per la tecnica dell’opus craticium vd. ZENONI, Alzati in terra cruda.280 Cfr. BACCHETTA 2003, pp. 127-132.281 Vd. le considerazioni espresse per la fase I.282 GRASSI 2007b, GRASSI 2008b.283 GIACOBELLO 2010.284 Gli intonaci, frammisti a malta, risultavano particolarmente compattati nell’area centrale e presso il limite S del q. 33C. L’accumulo di materiale non è stato completamente messo in luce: continuava infatti a S dell’area di scavo, come evidenziato nella sezione del q. 34C.285 Affreschi di buona qualità che presentano un articolato sistema decorativo sono stati individuati anche nello scavo Sud: MARIANI 1998 e MARIANI c.s.286 BACCHETTA 2009a, IDEM 2010.287 Per una completa ed esauriente trattazione di tale tecnica muraria si rimanda a BACCHETTA 2003, pp. 127-130; per l’area della Domus del Labirinto, si vedano, in particolare, gli affre-schi pertinenti all’Ambiente A, gli intonaci del gruppo I/9116 e di es 8907 (vd. supra).288 Per esempi eccellenti si vedano la Casa di Livia sul Palatino (ala destra), e la Casa del Bracciale d’oro a Pompei: PITTURA ROMANA 2002, p. 137 e pp. 192-196. Per la Cisalpina cfr. la Domus di via Trieste a Brescia: PITTURA ROMANA 2002, p. 259. Per la raffigurazione di maschere e rilievi sospesi nella pittura romana vd. BACCHETTA 2006, pp. 90-98.289 Cfr. MARIANI, PAGANI 2005, p. 297.290 Tale sistema associativo è significativamente documentato nella Domus di Dioniso a Bre-scia: MORANDINI 2003, p. 43.
562
ABITARE IN CISALPINA 2001, Abitare in Cisalpina. L’edilizia privata nelle città e nel territorio in età romana, AAAd 49, Trieste.
ADAM J.P. 1984, L’arte di costruire presso i Romani. Materiali e tecniche, Milano.
AD MENSAM 1994, S. Lusuardi Siena (ed.), Ad mensam. Manufatti d’uso da contesti archeo-logici fra tarda antichità e medioevo, Udine.
AEMILIA 2000, Aemilia. La cultura romana in Emilia Romagna dal III secolo a.C. all’età costantiniana (Catalogo Mostra Bologna 2000), Venezia.
AIROLDI F. 2003, Note per una lettura generale della fase insediativa nell’area dell'Uni-versità Cattolica alla luce degli scavi 1997-98 (UC VIII), in Ricerche archeologiche nei cor-tili dell’Università Cattolica. Dall’antichità al medioevo. Aspetti insediativi e manufatti (Atti Giornate Studio Milano 2000-2001), Milano, pp. 33-53.
AIROLDI F., LOCATELLI D. 2000, L’espansione extraurbana di Milano nei risultati dei recenti scavi nell’area dell’Università Cattolica, in MILANO 2000, pp. 217-232.
ALBENQUE A. 1951, Nouveaux graffites de La Graufesenque, in REA 53, pp. 71-81.
ALICU D. 2003, Furniture Mounts in Dacia, in BRONZES ROMANIA 2003, pp. 46-49.
AMADORI C. 1996, La terra sigillata proveniente dai “vecchi scavi” di Cremona, in CREMO-NA E BEDRIACUM 1996, pp. 99-124.
ANDRÉ J. 1981, L’alimentation et la cuisine à Rome, Paris.
ANFORE ROMANE 1992, S. Pesavento Mattioli (ed.), Anfore romane a Padova: ritrovamenti dalla città, Modena.
ANGANUZZI A., LAVAZZA A., TIZZONI M. 1986, La ceramica comune, in SANTA MARIA ALLA PORTA 1986, pp. 173-240.
ANGELUCCI D.1996, Geomorfologia, stratigrafia e evoluzione paleogeografica del territorio bedriacense,
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE
Gli unici aggiornamenti bibliografici rispetto all’edizione su DVD del 2008 riguardano le pubblicazioni su Calvatone-Bedriacum (segnalate da *).
Per le abbreviazioni di riviste e collane, ove non indicate, si fa riferimento all’Archäologische Bibliographie online(http://www.dainst.org/sites/default/files/medien/de/red_Abkuerzungen_Zeitschriften.pdf)
AAAd Antichità altoadriaticheAIS Archeologia dell’Italia SettentrionaleFlos Italiae Flos Italiae. Documenti di archeologia della Cisalpina RomanaGalliaCis Studi e ricerche sulla Gallia CisalpinaQuadAcme Quaderni di AcmeQuadInfo Quaderni d’InformazioneStALomb Collana di Studi di Archeologia lombarda
A CURA DI LILIA PALMIERI
563A B B R E V I A Z I O N I B I B L I O G R A F I C H E
in BEDRIACUM 1996, 1.1, pp. 25-43.1997, Calvatone-Bedriacum nel suo contesto territoriale: il quadro geoarcheologico, in
CALVATONE ROMANA 1997, pp. 3-20.
ANGERA ROMANA
1985, G. Sena Chiesa, M.P. Lavizzari Pedrazzini (edd.), Angera romana. Scavi nella necro-poli 1970-1979, Roma.
1995, G. Sena Chiesa, M.P. Lavizzari Pedrazzini (edd.), Angera romana. Scavi nell’abitato 1980-1986, Roma.
ANTICHE GENTI 2000, J. Ortalli, P. Poli, T. Trocchi (edd.), Antiche genti della pianura. Tra Reno e Lavino: ricerche archeologiche a Calderara di Reno, in Quaderni di archeologia dell’Emilia Romagna 4, Firenze.
ANTICHI SILENZI 1996, Antichi silenzi. La necropoli romana di San Lorenzo di Parabiago, Cassano Magnano.
ARCARI L. 1996, Un deposito di anfore in via Massarotti a Cremona, in CREMONA E BEDRIA-CUM 1996, pp. 185-203.
ARCHEOLOGIA IN PIEMONTE 1998, L. Mercando (ed.), Archeologia in Piemonte. II. L’età romana, Torino.
ARCHEOMETRIA DELLA CERAMICA 1993, Archeometria della ceramica. Problemi di metodo (Atti 8 SIMCER - Simposio internazionale della Ceramica Rimini 1992), Bologna.
ARCHITECTURES 1985, Architectures de terre et de bois. L’habitat privé des provinces occi-dentales du monde romain. Antécédents et prolongements: Protohistoire, Moyen Age et quel-ques expériences contemporaines (Actes IIe Congrès archéologique de la Gaule Méridionale Lyon 1983), Paris.
ARDOVINO A.M., GAGETTI E., MASSEROLI S. 1999, Un progetto di scheda tecnico-conservati-va per il mosaico, in Atti V Colloquio AISCOM Roma 1997, Ravenna, pp. 503-514.
ARREDI DI LUSSO 2005, F. Slavazzi (ed.), Arredi di lusso in età romana. Da Roma alla Cisal-pina, Flos Italiae 6, Firenze.
ARSLAN E.A.1991a, Le monete, in SCAVI MM3 1991, 3.2, pp. 71-130; 4, tavv. CLXXVIII-CXCI.1991b, Osservazioni preliminari sulla circolazione monetale antica a Calvatone, in CALVA-
TONE ROMANA 1991, pp. 187-195.1996a, La moneta e la circolazione monetaria, in MILANO 1996, pp. 55-58.1996b, Le monete e la circolazione monetaria, in BEDRIACUM 1996, 1.1, pp. 101-118.1996c, Le monete, in BEDRIACUM 1996, 1.2, pp. 245-258.1997, Monete, in CALVATONE ROMANA 1997, pp. 205-225.1998a, La moneta antica e la via Postumia centrale, in OPTIMA VIA 1998, pp. 369-381.1998b, Romanizzazione e romanità attraverso la circolazione monetale, in TESORI POSTU-
MIA 1998, pp. 364-370.1999, La moneta in tomba, in Trouvailles monétaires de tombes (Actes X Colloque Inter-
national Groupe suisse pour l’étude des trouvailles monétaires Neuchâtel 1995), Lausanne, pp. 181-199.
2002a, I mortaria, in CAPITOLIUM 2002, pp. 309-321.2002b, Ritrovamenti monetali in Lombardia: venticinque anni di lavoro per la documen-
tazione, in Ritrovamenti monetali nel mondo antico: problemi e metodi (Atti congresso inter-nazionale Padova 2000), Padova, pp. 159-176.
2007, Le vicende della circolazione monetaria, in M. Fortunati, R. Poggiani Keller (edd.), Storia economica e sociale di Bergamo. I primi millenni. Dalla Preistoria al Medioevo, Berga-mo, I, pp. 306-363.
ARSLAN E.A., CHIARAVALLE M. 1988, Monete dai recenti scavi di Milano (età romana impe-
564 A B B R E V I A Z I O N I B I B L I O G R A F I C H E
riale ed età medievale), in RItNum 90, pp. 395-432.
ARS MEDICA 1991, Ars Medica. La medicina nell’antica Roma (Catalogo Mostra Milano 1991), Milano.
ATLANTE
1981, Atlante delle forme ceramiche. I. Ceramica fine romana nel bacino mediterraneo (medio e tardo impero), EAA, Roma.
1985, Atlante delle forme ceramiche. II. Ceramica fine romana nel bacino mediterraneo (tardo ellenismo e primo impero), EAA, Roma.
AYMARD A.1952, Nouveaux graffites de La Graufesenque. II, in REA 54, pp. 93-101.1953, Nouveaux graffites de La Graufesenque. III, in REA 55, pp. 126-131.BABELON J., BLANCHET J.A. 1895, Catalogue des bronzes antiques de la Bibliothèque Na-
tionale, Paris.
BACCHETTA A.2003, Edilizia rurale romana. Materiali e tecniche costruttive nella Pianura Padana (II sec.
a.C. - IV sec. d.C.), Flos Italiae 4, Firenze.2005, Gli oscilla in Italia Settentrionale, in ARREDI DI LUSSO 2005, pp. 73-118.2006, Oscilla. Rilievi sospesi di età romana, Milano.*2009a, Calvatone (CR). Costa di Sant’Andrea - Area di proprietà provinciale. Un nuovo
mosaico dal vicus di Bedriacum, in Lanx. Rivista della Scuola di Specializzazione in Archeolo-gia - Università degli Studi di Milano 3, pp. 63-71.
*2009b, Edilizia residenziale e sviluppo urbano di un vicus della Cisalpina romana: il caso di Calvatone-Bedriacum, in Intra illa moenia domus ac Penates (Liv. 2, 40, 7). Il tessuto abitativo nelle città romane della Cilsapina (Atti Giornate Studio Padova 2008), Roma, pp. 175-187.
*2010, Un nuovo mosaico dal vicus di Calvatone-Bedriacum (Cremona), in Atti XV Col-loquio AISCOM Aquileia 2009, Tivoli, pp. 97-106.
*BACCHETTA A., GRASSI M.T. 2010, Dalla “Domus del Labirinto” al “Quartiere degli Ar-tigiani”. Nuove scoperte a Calvatone romana, in G. Zanetto, M. Ornaghi (edd.), Documenta Antiquitatis, QuadAcme 120, Milano, pp. 27-54.
BALDONI D. 1986, Materiali di scavo: gli strati della fase repubblicana, in J. Ortalli, Il tea-tro romano di Bologna, Bologna, pp.121-155.
BANZI E. 1991, Considerazioni topografiche sulla via Postumia nel territorio di Bedriacum, in CALVATONE ROMANA 1991, pp. 71-99.
BARDOU P., ARZOUMANIAN V. 1978, Archi de terre, Marseille.
BASSA MODENESE 1997, M. Calzolari, P. Campagnoli, N. Giordani (edd.), La bassa Mode-nese in età romana. Sintesi di un decennio di ricognizioni archeologiche, StDocA Quaderni 7, S. Felice s/P.
BÉAL J.C.1983, Catalogue des objets de tabletterie du Musée de la Civilisation gallo-romaine de
Lyon, Centre d’Etudes Romaines et Gallo-romaines de l’Université Jean Moulin Lyon III - Nouvelle Série 1, Lyon.
1984, Les objets de tabletterie antique du Musée Archéologique de Nîmes, Cahiers des musées et monuments de Nîmes 2, Nîmes.
BEDRIACUM 1996, L. Passi Pitcher (ed.), Bedriacum. Ricerche archeologiche a Calvatone, 1.1, Studi sul vicus e sull’ager, Il Campo del Generale: lo scavo del saggio 6; 1.2, Il Campo del Generale: i materiali del saggio 6; 1.3 Tavole, Milano.
BELLEZZA E LUSSO 1992, Bellezza e lusso. Immagini e documenti di piaceri della vita (Cata-logo Mostra Roma 1992), Roma.
565A B B R E V I A Z I O N I B I B L I O G R A F I C H E
BENEDETTI D.1999-2000, Vetri e lucerne da Calvatone romana: gli anni di scavo 1995-2000, Tesi di
specializzazione, Università degli Studi di Milano (Relatore: prof. G. Sena Chiesa), A.A. 1999-2000.
2007a, Vasi antropoprosopi in Italia settentrionale e in Canton Ticino. Un riesame della questione alla luce di recenti ritrovamenti inediti, in Acme 60.1, pp. 85-119.
2007b, Vasi antropoprosopi in Italia settentrionale, in PRODUZIONI E COMMERCI 2007, su CD e online, http://www.archeologicacomo.it/conferenza_nov2006/pages/benedetti.htm
BENEDETTI D., DIANI M.G. 2003, Contributo alla conoscenza della diffusione di una forma vitrea di età romana: le coppe-piatto con “presette a festoncino” da Calvatone (CR) (Scavi 1988-1993), in Il Vetro in Italia meridionale e insulare (Atti II Convegno Multidisciplinare, VII Giornata Nazionale di Studio, Comitato Nazionale Italiano AIHV Napoli 2001), Napoli, pp. 241-251.
BERGAMINI M. 1980, Centuriatio di Bologna. Materiali dello scavo delle tre centuriae, Roma.
BERGAMO 1986, R. Poggiani Keller (ed.), Bergamo dalle origini all’altomedioevo. Docu-menti per un’archeologia urbana, Modena.
BERNABÒ BREA L. 1981, Menandro e il teatro greco nelle terrecotte liparesi, Genova.
BERTANI M.G. 1990, I muri di fondazione e le tecniche costruttive, in G. Sassatelli, A.M. Brizzolara (edd.), I nuovi scavi dell’Università di Bologna nella città etrusca di Marzabotto, Bologna, pp. 21-34.
BESCHI L. 1974-1975, Corredi funerari da S. Pietro Incariano a Vienna, in AquilNost 45-46, pp. 445-478.
BESSI TREVALE V. 1987, Olle e urne, in SUB ASCIA 1987, pp. 194-201.
BETTO P. 1993, Il teatro dei Romani: uno specchio della società, in CIVILTÀ DEI ROMANI 1993, pp. 15-30.
BEZECZKY T.1987, Roman amphorae from the Amber Route in Western Pannonia, BARIntSer 386,
Oxford.1998, The Laecanius amphora stamps and the villas of Brijuni, Wien.
BEZZI MARTINI L. 1987, Necropoli e tombe romane di Brescia e dintorni, Brescia.
BIAGGIO SIMONA S.1991, I vetri romani provenienti dalle terre dell’attuale Canton Ticino, I-II, Locarno.1999, 7.9 Regione H: Ticino, in C. Schucany, S. Martin-Kilcher, L. Berger, D. Paunier
(edd.), Römischer Keramik in der Schweiz, Antiqua. Pubblicazione Società Svizzera Preistoria e Archeologia 31, Basel, pp. 224-241.
BIANCHI C.1995, Spilloni in osso di età romana. Problematiche generali e rinvenimenti in Lombardia,
StALomb 3, Milano.2005, Oggetti in osso, in SCAVI DI VIA BENZI 2005, pp. 319-325.
BIANCHINI S. 1998, La ceramica a vernice nera di Lucca, in RStLig 62, pp. 169-210.
BIEBER M. 1961, The history of Greek and Roman theater, Princeton.
BIONDANI F. 2005, Metalli lavorati, in RIMINI 2005, pp. 301-312.
BISHOP J., PASSI PITCHER L. 1991, CALVATONE (CR) Località costa di S. Andrea. Vicus di età romana: Campo del
Generale, in NotALomb 1990, Milano, pp. 78-81.1996, Il saggio 6, in BEDRIACUM 1996, pp. 131-160.
566 A B B R E V I A Z I O N I B I B L I O G R A F I C H E
BLOCKLEY P. 2004, CALVATONE (CR). Località Costa di Sant’Andrea, area di proprietà provinciale. Prospezione geofisica, in NotALomb 2001-2002, Milano, pp. 86-88.
BLOCKLEY P., PASSI PITCHER L. 2001, CALVATONE (CR) Località Costa di Sant’Andrea. Necropoli tardoromana, in NotALomb 1998, Milano, p. 88.
BMCRE IV, M.A. MATTINGLY, Coins of the Roman Empire in the British Museum, IV, London, 1940.
BOLLA M.1985, Ceramica comune, in G. Massari, E. Roffia, M. Bolla, D. Caporusso, La villa tardo-
romana di Palazzo Pignano (Cremona), in Cremona romana (Atti Congresso Cremona 1982), Cremona, pp. 197-204.
1988, Le necropoli di Milano, in NotMilano suppl. 5, Milano.
BOLOGNI B.M. 1855, Memorie storiche dei comuni di Rivarolo Fuori, Piadena, Calva-tone o città di Vegra e del Vico Bebriaco aggiuntevi quelle di Bozzolo e del presente secolo, Cremona.
BONIFAY M. 2004, Études sur la céramique romaine tardive d’Afrique du Nord, BARIntSer 1301, Oxford.
BONINI A., FELICE M., GUGLIELMETTI A. 2002, La ceramica comune, in CAPITOLIUM 2002, pp. 239-271.
BONINI A., MASSEROLI S. 1998, Lo stoccaggio e la distribuzione delle merci: il dato dei co-perchi per anfora, in TESORI POSTUMIA 1998, pp. 499-500.
BONOMI S. 1996, Vetri antichi del Museo Archeologico Nazionale di Adria, Corpus colle-zioni vetro Veneto 2, Venezia.
BONORA MAZZOLI G. 1991, Ricognizioni topografiche lungo la via Postumia, in CALVATONE ROMANA 1991, pp. 61-70.
BOTTURA E. 1988, Il Basso Mantovano in epoca romana. Catalogo dei materiali rinvenuti durante le ricerche di superficie, Brescia.
BOUCHER S. 1973, Bronzes Romains figurés du Musée des Beaux Arts de Lyon, Lyon.
BOWMAN A.K. 1994, Life and letters on the Roman frontier: Vindolanda and its people, London.
BOWMAN A.K., THOMAS J.D.1983, Vindolanda: the Latin writing-tablets, London.1994, The Vindolanda writing-tablets (Tabulae Vindolandenses) II, with contributions by
J.N. Adams, London.2003, The Vindolanda writing-tablets (Tabulae Vindolandenses) III, with contributions
by J. Pearce, London.
BRECCIAROLI TABORELLI L.1990, Segusio: nuovi dati e alcune ipotesi, in QuadAPiem 9, pp. 65-157.1998, Il vasellame da mensa in età tardoantica, in ARCHEOLOGIA IN PIEMONTE 1998, pp.
271-289.2000, La ceramica a vernice nera padana (IV - I secolo a.C.): aggiornamenti, osservazioni,
spunti, in PRODUZIONE CERAMICA 2000, pp. 11-30.
BRECCIAROLI TABORELLI L., GABUCCI A., QUIRI E. 2007, Produzione e commercio a Eporedia - Ivrea tra I secolo a.C. e tarda antichità: terra sigillata e anfore, in PRODUZIONI E COMMERCI 2007, su CD e online, http://www.archeologicacomo.it/conferenza_nov2006/pages/brecciaroli.htm
BREDA A.1986, Sermide (Mantova). Edificio rurale tardoantico, in NotALomb 1985, Milano, pp.
76-77.
567A B B R E V I A Z I O N I B I B L I O G R A F I C H E
1996, La ceramica della fornace romana di via Platina in Cremona, in CREMONA E BEDRIA-CUM 1996, pp. 49-63.
BROGIOLO G.P. 1985, Materiali invetriati del Bresciano, in CERAMICA INVETRIATA 1985, pp. 55-63.
BRONZES ROMANIA 2003, L. Petculescu (ed.), Antique Bronzes in Romania: exhibition ca-talogue, Bucharest.
BRONZI 2001, M. Luni, G. Gori (edd.), I bronzi di Forum Sempronii. L’utile e il bello, Quaderni di archeologia nelle Marche 9, Urbino.
BRUNO B.1986, Le anfore, in S. MARIA ALLA PORTA 1986, pp. 246-276.1995, Aspetti di storia economica della Cisalpina romana. Le anfore di tipo Lamboglia 2
rinvenute in Lombardia, GalliaCis 7, Roma.
BRUNO B., BOCCHIO S. 1991, Anfore, in SCAVI MM3 1991, 3.1, pp. 259-298.
BRUNO B., SFRECOLA S. 1995, Gli impasti delle anfore Lamboglia 2 e il problema delle aree di produzione, in BRUNO 1995, pp. 83-119.
BUCHI E. 1975, Le lucerne del museo di Aquileia. I. Lucerne romane con marchio di fab-brica, Treviso.
BUORA M. 1994, Ceramica a vernice nera da Sevegliano, in Alba Regia 25, pp. 155-163.
*BURSICH D., NAVA S. 2013, Il mosaico del labirinto di Calvatone-Bedriacum: dallo scavo al 3D, in Atti XVIII Colloquio AISCOM Cremona 2012, Tivoli, pp. 51-60.
BUSANA M.S. 1990, Il materiale, in Asolo. Teatro romano: indagine 1989, QuadAVen 6, pp. 102-108.2002, Architetture rurali nella Venetia romana, Le Rovine Circolari 3, Roma.
BUTTI RONCHETTI F.1985, La necropoli romana della “Cascina Benedetta” di Lurate Caccivio, in RAComo
167, pp. 5-111.1986, Materiale di età romana da Olgiate Comasco, in RAComo 168, pp. 105-153.2005, Terra sigillata in PORTA PRETORIA 2005, pp. 45-56.
CAGNANA A.1994, Un contesto ceramico di età imperiale dagli scavi in Palazzo Calissano di Alba (Cn),
in QuadAPiem 12, pp. 107-126.2000, Archeologia dei materiali da costruzione, Manuali per l’archeologia 1, Mantova.
CALVATONE-BEDRIACUM 2008, M.T. Grassi (ed.), Calvatone-Bedriacum. I nuovi scavi nell’area della Domus del Labirinto (2001-2006), Milano, su DVD.
CALVATONE ROMANA
1991, G.M. Facchini (ed.), Calvatone romana. Studi e ricerche preliminari, QuadAcme 13, Milano.
1997, G. Sena Chiesa, S. Masseroli, T. Medici, M. Volonté (edd.), Calvatone Romana. Un pozzo e il suo contesto. Saggio nella zona nord dell’area di proprietà provinciale, QuadAcme 29, Milano.
CAMPAGNOLI P. 1997, I laterizi, in BASSA MODENESE 1997, pp. 171-190.
CAPITOLIUM 2002, Nuove ricerche sul Capitolium di Brescia. Scavi, studi e restauri (Atti Convegno Brescia 2001), Milano.
CARANDINI A. 1981, Ceramica narbonese, in ATLANTE 1981, pp. 3-7.
CARINI A. 2008, La ceramica a vernice nera dagli scavi di Palazzo Farnese a Piacenza, in GRASSI 2008a, pp. 123-167.
CARRE M.B. 1993, L’épave à dolia de Ladispoli (Etrurie Méridionale). Etude des vestiges
568 A B B R E V I A Z I O N I B I B L I O G R A F I C H E
de la coque, in Archaeonautica 11, pp. 9-31.
CARRE M.B., GAGGADIS-ROBIN V., HESNARD A., TCHERNIA A. 1995, Recueil de timbres sur amphores romaines (1987-1988), Travaux Centre Camille Jullian 16, Aix-en-Provence.
CARRE M.B, PESAVENTO MATTIOLI S. 2003, Anfore e commerci nell’Adriatico, in L’archeolo-gia dell’Adriatico. Dalla Preistoria al Medioevo (Atti convegno internazionale Ravenna 2001). Firenze, pp. 268-285.
CARTA BRESCIA 1996, F. Rossi (ed.), Carta archeologica della Lombardia V. Brescia. La città, II, Saggi, Modena.
CASSI R. 1996, La ceramica a pareti sottili proveniente dai “vecchi scavi” di Cremona, in CREMONA E BEDRIACUM 1996, pp. 83-97.
CASTELRAIMONDO 1995, S. Santoro Bianchi (ed.), Castelraimondo. Scavi 1988-1990. II. Informatica, archeometria e studio dei materiali, Cataloghi e monografie archeologiche dei civici musei di Udine 5, Roma.
CASTELSEPRIO 1978-1979, M. Dabrowska, L. Leciejewicz, E. Tabaczynska, Castelseprio. Scavi diagnostici 1962-1963, in Sibrium 14, pp. 1-132.
CASTIGLIONCELLO 1999, Castiglioncello, la necropoli ritrovata: cento anni di scoperte e scavi (1896-1997) (Catalogo Mostra Rosignano Marittimo 1998-1999), Firenze.
CASTOLDI M.1993, Un gruppo di bottiglie in bronzo tardoromane, in NotMilano 53, pp. 105-128.1995, Applique bronzea per manico mobile in ANGERA ROMANA 1995, I, pp. 243-245.2005, Cremona e l’ager Cremonensis. Elementi d’arredo in bronzo, in ARREDI DI LUSSO
2005, pp. 187-204.
CATTANEO P. 1996, La ceramica a pareti sottili e terra sigillata dagli scavi di Piazza Marconi a Cremona, in CREMONA E BEDRIACUM 1996, pp. 153-170.
CAZORZI C., CERESA MORI A., PAGANI C., VALLE G. 1985, Milano. Via S. Maria Fulcorina. Scavo preventivo, in NotALomb 1985, Milano, pp. 124-126.
CCVLCREMONA 2004, Corpus delle Collezioni del vetro in Lombardia. Volume uno - Cremona
e Provincia, Milano.PAVIA s.d. (ma 2006), Corpus delle Collezioni del vetro in Lombardia. Volume due, tomo
uno - Pavia. Età antica, Cremona.
CECCHINI N. 2005, Le classi dei materiali: vasellame da mensa ad impasto depurato, in CERAMICA COMUNE 2005, pp. 81-92.
CEIPAC, Centro para el Estudio de la Interdipendencia Provincial en la Antigüedad Clasi-ca (Universitat de Barcelona), http://ceipac.gh.ub.es/
CERAMICA COMUNE 2005, A. Marensi, C. Miedico, N. Cecchini, M.G. Manzia, S. Pellegris, Ceramica comune, in SCAVI DI VIA BENZI 2005, pp. 61-142.
CERAMICA INVETRIATA 1985, La ceramica invetriata tardoromana e altomedievale (Atti Convegno Como 1981), Como.
CERAMICHE IN LOMBARDIA 1998, G. Olcese (ed.), Ceramiche in Lombardia tra II secolo a.C. e VII secolo d.C. Raccolta dei dati editi, Documenti di archeologia 16, Mantova.
CERAMIQUES HELLENISTIQUES ET ROMAINES 1987, P. Lévêque, J.-P. Morel (edd.),Céramiques hellénistiques et romaines. II, Centre de Recherches d’Histoire ancienne 70, Paris.
CERESA MORI A.1986, La ceramica a pareti sottili, in SANTA MARIA ALLA PORTA 1986, pp. 136-151.1991, Ceramica a pareti sottili, in SCAVI MM3 1991, pp. 41-56.1996, L’evidenza archeologica e il suo significato, in MILANO 1996, pp. 27-39.
569A B B R E V I A Z I O N I B I B L I O G R A F I C H E
2000, Stratigrafia archeologica e sviluppo urbano a Mediolanum, in MILANO 2000, pp. 81-91.
CERESA MORI A., OWES B., PAGANI C., WHITE N. 1988, Milano. Via Moneta, in NotALomb 1987, Milano, pp. 137-141.
CERRI P.1987-1988, Materiali da Calvatone all’Antiquarium di Piadena (CR), Scavi 1957-1962, Tesi
di laurea, Università degli Studi di Milano (Relatore: prof. G. Sena Chiesa), A.A. 1987-1988.1991, Scavi a Calvatone romana: terra sigillata proveniente dall’area della “strada porti-
cata”, in CALVATONE ROMANA 1991, pp. 147-166.1996, Materiali da Calvatone all’Antiquarium di Piadena (scavi 1957-62), in CREMONA E
BEDRIACUM 1996, pp. 237-240.
CERUTTI A. 2004-2005, Ceramica fine da mensa da Calvatone Romana (scavo 2001), Tesi di laurea, Università degli Studi di Milano (Relatore: prof. M.T. Grassi), A.A. 2004-2005.
CESELIN F. 2003, Bottiglie a ventre prismatico e a ventre cilindrico, in C. Casagrande, F. Ceselin, Vetri antichi delle province di Belluno, Treviso e Vicenza, Corpus collezioni vetro Veneto 7, Venezia, pp. 23-24.
CHIAPPORI M.G. 1994, Il leone, in La seta e la sua via (Catalogo Mostra Roma 1994), Roma, pp. 143-145.
CHIARAVALLE M.1989, Un ripostiglio di monete di fine IV - inizi V secolo d.C. dagli scavi di via S. Maria
Fulcorina in Milano 1985, in NotMilano 43-44, pp. 91-94.1998a, IV.55 Calvatone - Ripostiglio di monete romane repubblicane in argento, in TESORI
POSTUMIA 1998, p. 393.1998b, IV.56 Calvatone - Ripostiglio di monete romane repubblicane e imperiali in argen-
to e bronzo, in TESORI POSTUMIA 1998, p. 393.1998c, Casteggio-Clastidium - Monete romano-repubblicane da scavo, in TESORI POSTUMIA
1998, pp. 394-395.
CHIECO BIANCHI A.M., CALZAVARA CAPUIS L. 1985, Este I. Le necropoli Casa di Ricovero, Casa Muletti Prosdocimi, Casa Alfonsi, Roma.
CIMA M. 1988, Il territorio 1: a nord della Vaude, in G. Cresci Marrone, E. Culasso Ga-staldi (edd.), Per pagos vicosque. Torino romana tra Orco e Stura, Padova, pp. 95-150.
CIPRIANO S. 2003, Il consumo di derrate ad Altinum tra I secolo a.C. e II secolo d.C.: i dati dei contenitori da trasporto, in Produzioni, merci e commerci in Altino preromana e romana (Atti convegno Venezia 2001), Venezia, pp. 235-259.
CIPRIANO S., CARRE M.B. 1989, Production et typologie des amphores sur la cote adriatique de l’Italie, in Amphores romaines et histoire économique: dix ans de recherche (Actes colloque de Sienne 1986), École française de Rome, 1989.
CIPRIANO S., MAZZOCCHIN S. 1998, I bolli di C. LAECANIUS BASSUS: un aggiornamento alla luce di nuovi dati da Patavium, in AquilNost 69, pp. 362-378.
CIPRIANO S., MAZZOCCHIN S., ROSSIGNOLI C. 2006, Un nuovo centro di produzione ceramica a Patavium, in TERRITORIO E PRODUZIONI 2006, pp. 245-255.
CIVALE A. 2003, Villa di Lucius Tertius, in STORIE DA UN’ERUZIONE 2003, pp. 74-79.
CIVILTÀ DEI ROMANI 1993, S. Settis (ed.), Civiltà dei Romani. Un linguaggio comune, Mi-lano.
COCCONCELLI L. 1996, Ceramica fine da mensa da Calvatone. Lotto III. Le forme e la de-corazione a gemme impresse, in CREMONA E BEDRIACUM 1996, pp. 277-284.
COMPOSTELLA C. 1995, Ceramica comune decorata, in ANGERA ROMANA 1995, pp. 190-199.
570 A B B R E V I A Z I O N I B I B L I O G R A F I C H E
CONSPECTUS 1990, Conspectus formarum terrae sigillatae italico modo confectae, Materia-len zur Römisch-Germanischen Keramik, Heft 10, Bonn.
CONUBIA GENTIUM 1999, G. Spagnolo Garzoli (ed.), Conubia gentium. La necropoli di Oleggio e la romanizzazione dei Vertamocori, Oleggio.
CORSANO M.1990, Materiali da Calvatone. La raccolta del Museo di Cremona e lo scavo del pozzo del
mappale n. 50, in RAComo 172, pp. 6-103.1991, Le fonti antiche, in CALVATONE ROMANA 1991, pp. 51-59.1996, Ceramica romana da Bedriacum: la raccolta del Museo Civico “Ala Ponzone” di
Cremona, in CREMONA E BEDRIACUM 1996, pp. 229-236.
CORSANO M., TASSINARI G., ROZZI A. 1995, Ceramica comune (LottoVI), in ANGERA ROMA-NA 1995, pp. 326-347.
CORSI-SCIALLANO M., LIOU B. 1985, Les épaves de Tarraconaise à chargement d’amphores Dressel 2-4, in Archaeonautica 5, pp. 5-178.
CORTI C. 2001, Pesi e contrappesi, in PONDERA 2001, pp.191-212.
CORTI C., PALLANTE P., TARPINI R. 2001, Bilance, stadere, pesi e contrappesi nel Modenese, in PONDERA 2001, pp. 271-313.
CORTINOVIS F.2004-2005, Materiali e stratigrafia dei pavimenti della Domus del Labirinto di Calvatone-
Bedriacum, Tesi di specializzazione, Università degli Studi di Milano (Relatore: prof. M.T. Grassi), A.A. 2004-2005.
2008, Lucerne, in GRASSI 2008a, pp. 71-78.
CREMONA E BEDRIACUM 1996, G.M. Facchini, L. Passi Pitcher, M. Volonté (edd.), Cremona e Bedriacum in età romana. 1. Vent’anni di tesi universitarie, Milano.
CRISÀ A. 2008, La monetazione di Tindari romana con segni di valore e legende in lingua latina, in RItNum 109, pp. 235-268, tavv. I-II.
CROCE DA VILLA P. 1985, Concordia Sagittaria: scavi 1984. La domus dei signini, in QuadAVen 1, pp. 39-41.
CROCI A.1996a, Ceramica a vernice nera dagli scavi di Piazza Marconi a Cremona, in CREMONA E
BEDRIACUM 1996, pp. 139-151.1996b, La ceramica d’uso domestico, in ANTICHI SILENZI 1996, pp. 201-208.
CRYPTA BALBI 2001, M.S. Arena, P. Delogu, L. Paroli, M. Ricci, L. Saguì, L. Venditelli (edd.), Roma dall’Antichità al Medioevo, archeologia e storia nel Museo Nazionale Romano Crypta Balbi, Milano.
CUOMO DI CAPRIO N.1985, La ceramica in archeologia. Antiche tecniche di lavorazione e moderni metodi d’in-
dagine, Roma.2007, Ceramica in archeologia 2, StA 144, Roma.
CUOMO DI CAPRIO N., SANTORO BIANCHI S. 1983, Lucerne fittili e bronzee del Museo Civico di Lodi, Quaderni di Studi Lodigiani 1, Lodi.
DAL RI L. 1994, Le macine come problema archeologico. Alcune considerazioni, in IL GRANO E LE MACINE 1994, pp. 51-72.
D’AMBROSIO A., DE CARO S. 1989, Un contributo all’architettura e all’urbanistica di Pom-pei in età ellenistica. I saggi nella casa VII 4, 63, in AnnOrNap 2, pp. 173-215.
D’ANDRIA F. 1969, Catalogo dei bolli e delle iscrizioni doliari, in AA. VV., Missione archeo-logica italiana a Malta. Rapporto preliminare della campagna 1968, Roma, pp. 61-64.
571A B B R E V I A Z I O N I B I B L I O G R A F I C H E
DASZEWSKI W.A. 1977, Nea Paphos. II. La mosaïque de Thésée. Études sur les mosaïques avec représentations du labyrinthe, de Thésée et du Minotaure, Varsovie.
DE CAROLIS E. 2007, Il mobile a Pompei ed Ercolano: letti, tavoli, sedie e armadi. Contri-buto alla tipologia dei mobili della prima età imperiale, StA 151, Roma.
DE CHAZELLES A.C. 1997, Les maisons en terre de la Gaule méridionale, Montagnac.
DE CHAZELLES A.C., POUPET P. 1985, La fouille des structures de terre crue: définitions et difficultés, in Aquitania 3, pp. 149-160.
DÉCOR 2002, Le décor géométrique de la mosaïque romaine. II. Répertoire graphique et descriptif des décors centrés, Paris.
DE FRANCESCHINI M. 1998, Le ville romane della X Regio (Venetia et Histria). Catalogo e carta archeologica dell’insediamento romano nel territorio dall’età repubblicana al tardo impero, Roma.
DEIMEL M. 1987, Die Bronzekleinfunde vom Magdalensberg, Klagenfurt.
DELL’ACQUA F. 2004, Le finestre invetriate nell’antichità romana, in VITRUM 2004, pp. 109-119.
DELLA PORTA C.1991, Considerazioni sulla ceramica comune proveniente da Calvatone romana: le olle, in
CALVATONE ROMANA 1991, pp. 166-179.1996, Tipologie e caratteristiche tecnologiche di alcune forme in ceramica comune da Cal-
vatone romana (scavi 1957-1961), in CREMONA E BEDRIACUM 1996, pp. 299-303.1998a, Terra sigillata di età alto e medioimperiale, in CERAMICHE IN LOMBARDIA 1998, pp.
81-124.1998b, Ceramica a vernice rossa interna, in CERAMICHE IN LOMBARDIA 1998, pp. 231-232.
DELLA PORTA C., SFREDDA N.1993, La ceramica comune da Calvatone romana. Osservazioni preliminari su alcuni
gruppi di impasto, in ARCHEOMETRIA DELLA CERAMICA 1993, pp. 87-98.1996, La ceramica comune, in BEDRIACUM 1996, 1.2, pp. 133-186.1997, La ceramica comune da Calvatone romana. Alcuni esempi di applicazione delle
indagini archeometriche, in IL CONTRIBUTO DELLE ANALISI ARCHEOMETRICHE 1997, pp. 143-148.c.s., Ceramica comune di Calvatone. Scavi 1988-1993, in SCAVO SUD c.s.
DELLA PORTA C., SFREDDA N., TASSINARI G.1998a, Ceramiche comuni, in CERAMICHE IN LOMBARDIA 1998, pp. 133-229.1998b, Ceramica invetriata di età tardoantica-altomedievale, in CERAMICHE IN LOMBARDIA
1998, pp. 233-249.
DE MARCHI P.M. 1999, Reperti metallici e miscellanea, in S. GIULIA 1999, pp. 315-331.
DE MARINIS R.C. 1986, L’età gallica in Lombardia (IV - I secolo a.C.): risultati delle ultime ricerche e problemi aperti, in La Lombardia tra Protostoria e Romanità (Atti II Convegno Archeologico regionale Como 1984), Como, pp. 93-173.
DESBAT A.1981, L’architecture de terre à Lyon, à l’époque romaine, BARIntSer 108, Oxford.1987, La sigillée claire B de la vallée du Rhône: état de la recherche, in CERAMIQUES HELLE-
NISTIQUES ET ROMAINES 1987, pp. 267-277.
DE VANNA L. 1991, Ceramica a vernice rossa interna, in SCAVI MM3 1991, pp. 129-132.
DIANI M.G.1998, Contributo alla carta di distribuzione di alcune forme vitree di età romana colate
a stampo e soffiate a stampo. Note su alcuni recenti ritrovamenti in Lombardia, in Il vetro dall’antichità all’età contemporanea: aspetti tecnologici, funzionali e commerciali (Atti 2e Gior-nate Nazionali di Studio AIHV - Comitato Nazionale Italiano Milano 1996), pp. 31-42.
572 A B B R E V I A Z I O N I B I B L I O G R A F I C H E
2000, Nuove attestazioni di vetro a mosaico e di bottiglie con bolli in Lombardia, in An-nales 14e Congrès AIHV (Venezia-Milano 1998), Lochem, pp. 76-81.
s.d. (ma 2006), Musei Civici. Rinvenimenti lungo il corso del Ticino a Pavia, in CCVL PAVIA s.d. (ma 2006), pp. 219-297.
DI FILIPPO BALESTRAZZI E. 1988, Lucerne del Museo di Aquileia, II, 1-2. Lucerne romane di età repubblicana e imperiale, Aquileia.
DI GIUSEPPE H. 2007, I materiali indicatori di pratiche rituali e di culto, Periodi 3 e 4 (fase 1), in A. Carandini, M.T. D’Alessio, H. Di Giuseppe (edd.), La fattoria e la villa dell’Audito-rium nel quartiere Flaminio di Roma, Roma, pp. 463-484.
DI PASQUALE G. 1999, Strumenti per pesare, in HOMO FABER 1999, pp. 283-285.
DONATI P. 1979, Locarno. La necropoli romana di Solduno, QuadInfo 3, Bellinzona.
DONATI P., BUTTI RONCHETTI F., BIAGGIO SIMONA S. 1987, Ascona. La necropoli romana, QuadInfo 12, Bellinzona.
DONDERER M.1984, Münzen als Bauopfer in römischen Privathäusern, in BJb 184, pp. 177-187.1986, Die Chronologie der römischen Mosaiken in Venetien und Istrien bis zur Zeit der
Antonine, Berlin.
DONNER M., MARZOLI C. 1994, La macinazione. Evoluzione delle tecniche e degli strumen-ti, in IL GRANO E LE MACINE 1994, pp. 73-98.
DRESSEL H. 1880, La suppellettile dell’antichissima necropoli esquilina. Parte II: le stovi-glie letterate, in AdI 52, pp. 265-342.
DYCZEK K. 2002, Bronze appliqués of wood caskets from Valetudinorum at Novae, in From the parts to the whole (Acta 13th International Bronze Congress Cambridge Massachu-setts 1996), Portsmouth, pp. 145-150.
ERCOLANO 1993, Ercolano 1973-1988: 250 anni di ricerca archeologica (Atti Convegno Internazionale Ravello - Ercolano - Napoli - Pompei 1988), Roma.
ERMETI A.L. 2001, Oggetti dell’abbigliamento e dell’ornamento personale. Fibbie, in BRONZI 2001, pp. 189-199.
FABBRI B., GUALTIERI S., MASSA S. 2002, Terra sigillata della media e tarda età imperiale di produzione padana. Il contributo delle analisi archeometriche, in CAPITOLIUM 2002, pp. 353-369.
FABBRI B., GUALTIERI S., SANTORO S. 1997, L’alternativa chamotte/calcite nella ceramica grezza: prove tecniche, in IL CONTRIBUTO DELLE ANALISI ARCHEOMETRICHE 1997, pp. 183-190.
FACCHINI G.M.1991, Appunti sulle anfore provenienti da ricerche di superficie nel territorio di Calvatone,
in CALVATONE ROMANA 1991, pp. 131-146.1996, La circolazione dei vetri romani in area mediopadana: il ruolo di Calvatone-
Bedriacum, in Il vetro dall’antichità all’età contemporanea (Atti Giornata Nazionale di Studio AIHV - Comitato Nazionale Italiano Venezia 1995), Venezia, pp. 53-58.
1997, Anfore da Calvatone Romana. Osservazioni sulle vie commerciali in area mediopa-dana, in Acme 50.2, pp. 39-58.
1999, Vetri antichi del Museo Archeologico al Teatro Romano di Verona e di altre colle-zioni veronesi, Corpus collezioni vetro Veneto 5, Venezia.
2000a, Aspetti del commercio nella Cisalpina romana tra l’età repubblicana e l’età augu-stea. Mediolanum, Cremona, Calvatone-Bedriacum: tre città a confronto, in MILANO 2000, pp. 255-273.
2000b, Merci e mercati lungo il fiume Po: Calvatone-Bedriacum e Hostilia, due centri a confronto. Prime osservazioni, in QuadAMant 2, pp. 101-109.
573A B B R E V I A Z I O N I B I B L I O G R A F I C H E
2004, Considerazioni sulla circolazione dei vetri romani nel territorio cremonese, in CCVL CREMONA 2004, pp. 19-24.
2005, L’applique con rappresentazione di Dioniso in SCAVI DI VIA BENZI 2005, pp. 295-296.
FACCHINI G.M., JORIO S. 1995, Le anfore, in ANGERA ROMANA 1995, pp. 581-593.
FACCHINI G.M., LEOTTA F.M. 2005, Anfore, in SCAVI DI VIA BENZI 2005, pp. 147-218.
FAILLA A., GROSSETTI E. 1997, Ceramica grezza da Pianello di Val Tidone: forme e analisi archeometriche, in IL CONTRIBUTO DELLE ANALISI ARCHEOMETRICHE 1997, pp. 169-173.
FARIÑAS DEL CERRO L. 1977, Contribution à l’établissement d’une typologie des amphores dites “Dressel 2-4”, in Méthodes classiques et méthodes formelles dans l’étude des amphores (Actes colloque Rome 1974), CEFR 32, pp. 181-206.
FAUDUET I. 1992, Musée d’Évreux. Collections Archéologiques. Bronzes Gallo-Romains. Instrumentum, Argenton-sur-Creuse.
FAVARO 1996, Ceramica fine da mensa da Calvatone romana. Lotto II. Le forme e la deco-razione a rotella, in CREMONA E BEDRIACUM 1996, pp. 267-275.
FERRARESI A. 1986, Le lucerne di Bedriacum nelle raccolte archeologiche di Mantova, Cre-mona e Piadena, in AnnBenac 8, pp. 77-202.
FINOCCHI S. 1996, L’edilizia privata, in S. Finocchi (ed.) Libarna, Castelnuovo Scrivia, pp. 145-234.
FIORELLI G. 1876, Cremona, in NSc 1876, p. 178.
FIORENTINI G. 1963, Prime osservazioni sulla ceramica campana nella valle del Po, in RStLig 29, pp. 7-52.
FONTANA S. 2005, Le ceramiche da mensa italiche medio-imperiali e tardo-antiche: imita-zioni di prodotti importati e tradizione manifatturiera locale, in LA CERAMICA E I MATERIALI DI ETÀ ROMANA 2005, pp. 259-278.
FORME E TEMPI 2007, Forme e tempi dell’urbanizzazione nella Cisalpina (II secolo a.C. - I secolo d.C.) (Atti Giornate di Studio Torino 2006), Firenze.
FORTUNATI ZUCCALA M. 1987, ARZAGO D’ADDA (Bergamo). Via Leopardi, campo “La Rovere”. Villa romana, in NotALomb 1986, Milano, pp. 70-73.
FORTUNATI ZUCCALA M., VITALI M. 1996, L’insediamento romano di Casazza in Val Caval-lina (Bergamo), in AnnBenac 11, pp. 91-135.
FORUM SEMPRONII 2007, M. Luni (ed.), Domus di Forum Sempronii. Decorazione e arredo, StA 159, Roma.
FRONTINI P.1985, La ceramica a vernice nera nei contesti tombali della Lombardia, AIS 3, Como.1986, Rondineto, area delle camere scavate in roccia, in Como fra Etruschi e Celti (Cata-
logo Mostra Como 1986), Como, pp. 65-72.1991, Ceramica a vernice nera, in SCAVI MM3 1991, 3.1, pp. 23-39.GALLI G. 1996, La ceramica a vernice nera di Cremona: i “vecchi scavi” (1953-1970), in
CREMONA E BEDRIACUM 1996, pp. 69-81.GARBESI A., MAZZINI L. 1994, Ricerca sulla centuriazione imolese, in Archeologia del terri-
torio nell’Imolese, Imola, pp. 77-129.GELICHI S. 1986, La ceramica ingubbiata medievale nell’Italia nord-orientale, in La cera-
mica medievale nel Mediterraneo occidentale (Atti Congresso Internazionale Siena - Faenza 1984), Firenze, pp. 353-407.
GEORGE M. 1997, The Roman Domestic Architecture of Northern Italy, BARIntSer 670, Oxford.
574 A B B R E V I A Z I O N I B I B L I O G R A F I C H E
GERVASINI L. 2005, La ceramica a pareti sottili, in LA CERAMICA E I MATERIALI DI ETÀ ROMANA 2005, pp. 279-310.
GHEDINI F., BAGGIO M., TOSO S. 1998, Cultura musiva lungo la via Postumia, in OPTIMA VIA 1998, pp. 177-187.
GIACOBELLO F.2008, Pitture e mosaici nella Lombardia romana, in M. Cadario (ed.), Lombardia roma-
na. Arte e architettura, Milano, pp. 213-243.*2010, Testimonianze pittoriche delle domus di lusso nel Quartiere degli Artigiani: nuo-
vi ritrovamenti a Calvatone-Bedriacum, in Atti X Congresso Internazionale AIPMA Napoli 2007, Napoli, pp. 805-808.
s.d., La Vittoria di Calvatone.
GINOUVES R., MARTIN R. 1985, Dictionnaire méthodique de l’architecture grecque et ro-maine, Roma.
GIORDANI N. 1989, S. Damaso (MO): un impianto agricolo-produttivo di età romana, in MODENA 1989, pp. 496-512.
GIORDANI N., CORTI C. 1997, La ceramica grezza nel Modenese: analisi del materiale pro-veniente dalla media e basa pianura, in IL CONTRIBUTO DELLE ANALISI ARCHEOMETRICHE 1997, pp. 174-182.
GIOVANNINI V. 2007, Appliques in bronzo, in FORUM SEMPRONII 2007, pp.157-159.
GIOVE T. 2003, La circolazione monetale a Pompei, in STORIE DA UN’ERUZIONE 2003, pp. 26-33.
GIOVÉ MARCHIOLI N. 1993, Alle origini delle abbreviazioni latine. Una prima ricognizione (I secolo a.C. - IV secolo d.C.), Messina.
GLOSSARIO 1985, M.G. Celuzza, M. De Vos, E. Papi, E. Regoli, Glossario, in SETTEFINESTRE 1985, pp. 21-30.
GNOLI R. 1988, Marmora romana, Roma (2^ edizione).
GOUDINEAU C.1968, La ceramique aretine lisse. Fouilles de l’Ecole Française de Rome à Bolsena (Poggio
Moscini) 1962-1967, IV, in MEFRA suppl. 6, Paris.1970, Note sur la céramique à engobe rouge-pompéien (“pompeianische-rote Platten”),
in MEFRA 82, pp. 158-186.
GRANDI M., GUIDOBALDI F. 2006, Proposta di classificazione dei cementizi e mosaici omoge-nei ed eterogenei, in Atti XI Colloquio AISCOM Ancona 2005, Tivoli, pp. 31-38.
GRASSI M.T.1988, Nuovi materiali provenienti dal centro del vicus romano al Civico museo di Angera
(VA), in RAComo 170, pp. 177-239.1990-91, Romani e Insubri: un modello di integrazione, in Sibrium 21, pp. 279-291.1991, Ricerche di superficie condotte a Calvatone negli anni 1986/87, in CALVATONE RO-
MANA 1991, pp. 101-130.1995, La romanizzazione degli Insubri. Celti e Romani in Transpadana attraverso la do-
cumentazione storica e archeologica, StALomb 1, Milano.1996a, La ceramica a vernice nera, in BEDRIACUM 1996, 1.2, pp. 53-75.1996b, Le lucerne, in BEDRIACUM 1996, 1.2, pp. 77-81.1997, Lucerne di tipo biconico e cilindrico. Il caso di Calvatone nel quadro delle produ-
zioni di età tardo-repubblicana, in Acme 50.1, pp. 213-234.1998a, Le manifatture locali, in TESORI POSTUMIA 1998, p. 501.1998b, Gli Insubri, in TESORI POSTUMIA 1998, pp. 84-87.1998c, Bedriacum, in TESORI POSTUMIA 1998, pp. 489-492.
575A B B R E V I A Z I O N I B I B L I O G R A F I C H E
2000a, Una produzione fittile di tradizione celtica: la diffusione della ceramica decorata a Milano e nel suo territorio, in MILANO 2000, pp. 19-29.
2000b, Gli Insubri, i Leponzi, il Ticino: le tracce della ceramica, in Leponzi tra mito e realtà (Atti Convegno Locarno - Verbania 2000), su CD.
2001a, Ceramica a vernice nera con impressioni di gemme da Calvatone-Bedriacum, in MODELLO ROMANO 2001, pp. 43-58.
2001b, Sistemi decorativi delle domus di Calvatone romana, in ABITARE IN CISALPINA 2001, pp. 411-424.
2003, La ceramica a vernice nera aretina a Calvatone-Bedriacum: osservazioni prelimina-ri, in ReiCretActa 38 (Atti 23° Congresso Roma 2002), Abingdon, pp. 93-98.
2007a, I nuovi scavi nell’area della domus del Labirinto a Calvatone-Bedriacum, in AnnBenac 13-14, pp. 243-256.
2007b, CALVATONE (CR) Località Costa di S. Andrea, area di proprietà provinciale. Vicus di età romana: la fase pre-Labirinto e l’ambiente 2005, in NotALomb 2005, Milano, pp. 109-116.
2007c, Contatti e scambi tra il Mediterraneo orientale, l’Adriatico e la Pianura Padana: merci, artigiani, tecnologie, in PRODUZIONI E COMMERCI 2007, su CD e online, http://www.archeologicacomo.it/conferenza_nov2006/pages/grassi.htm
2007d, La mensa ponderaria di Calvatone-Bedriacum, in S. Fortunelli (ed.), Sertum Peru-sinum Gemmae oblatum, Quaderni di Ostraka 13, Napoli, pp. 213-223.
2008a, La ceramica a vernice nera di Calvatone-Bedriacum, Flos Italiae 7, Firenze.2008b, CALVATONE (CR) Località Costa di S. Andrea, area di proprietà provinciale.
Vicus di età romana: scavi oltre la Domus del Labirinto e nel Quartiere degli Artigiani, in NotALomb 2006, pp. 73-81.
*GRASSI M.T., PALMIERI L. 2011, Calvatone (CR). Località Costa di S. Andrea, area di proprietà provinciale. Vicus di età romana: l’area della Domus del Kantharos, in NotALomb 2008-2009, Milano, pp. 114-120.
GRASSI M.T., SLAVAZZI F. 2007, Calvatone-Bedriacum, in FORME E TEMPI 2007, pp. 103-108.
GRASSIGLI G.L. 1998, La scena domestica e il suo immaginario. I temi figurati nei mosaici della Cisalpina, Aucnus 9, Napoli.
GRECO C.1991, Studio di una forma di ceramica comune da Calvatone romana: i tegami, in CALVA-
TONE ROMANA 1991, pp. 181-186.1996, Ceramica comune romana da Calvatone, in CREMONA E BEDRIACUM 1996, pp. 289-
298.
GROS P. 2001, L’architecture romaine, du début du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut Empire, Paris.
GUGLIELMETTI A., LECCA BISHOP L., RAGAZZI L. 1991, Ceramica comune, in SCAVI MM3 1991, 3.1, pp. 133-257.
GUIRAUD H. 1988, Intailles et camées de l’époque romaine en Gaule (territoire français), 1, Gallia suppl. 48, Paris.
HAMBURGER A. 1968, Gems from Caesarea Maritima, Atiqot 8, Jerusalem.
HAYES J.W. 1972, Late Roman Pottery, London.
HENIG M. 1994, Classical gems: ancient and modern intaglios and cameos in the Fitzwil-liam Museum, Cambridge.
HERMET F. 1934, La Graufesenque (Condatomago), I. Vases sigillés - II. Graffites, Paris.
HOMO FABER 1999, Homo faber. Natura, scienza e tecnica nell’antica Pompei (Catalogo Mostra Napoli 1999), Milano.
576 A B B R E V I A Z I O N I B I B L I O G R A F I C H E
HOUBEN H.,GUILLAUD H. 1989, Traité de construction en terre. L’encyclopédie de la con-struction en terre, Marseille.
IL BRONZO DEI ROMANI 1990, L. Pirzio Biroli Stefanelli (ed.), Il bronzo dei Romani. Arredo e suppellettile, Roma.
IL CONTRIBUTO DELLE ANALISI ARCHEOMETRICHE 1997, Il contributo delle analisi archeometri-che allo studio delle ceramiche grezze e comuni. Il rapporto forma/ funzione/ impasto (Atti 1 Giornata di Archeometria della Ceramica Bologna 1997), Imola.
IL GRANO E LE MACINE 1994, Il grano e le macine. La macinazione di cereali in Alto Adige dall’Antichità al Medioevo (Catalogo Mostra Castel Tirolo 1994), Castel Tirolo.
INDAGINI 1998, Indagini archeometriche relative alla ceramica a vernice nera: nuovi dati sulla provenienza e la diffusione (Atti Seminario internazionale di Studio Milano 1996), Como.
INSTRUMENTUM 1977, A. Carandini et alii (ed.), L’instrumentum domesticum di Ercolano e di Pompei nella prima età imperiale, Roma.
INVERNIZZI R., BOLLA M., ARSLAN E.A. 1998, Due ricche cremazioni di III sec. d.C. da Ca-steggio, in Vetro e vetri. Preziose iridescenze (Catalogo Mostra Milano 1998-1999), Milano, pp. 97-104.
ISINGS C. 1957, Roman Glass from dated Finds, Archaelogica Traiectina, II, Groningen-Djakarta 1957.
ISTENIC J. 1995, Glazed pottery from western cemetery of Poetovio, in Alba Regia 25, pp. 23-26.
JORIO S.1987a, Ciotole-coperchio, in SUB ASCIA 1987, p. 202.1987b, Ceramiche di tradizione locale, in SUB ASCIA 1987, pp. 205-207.1987c, Ceramica a vernice rossa interna, in SUB ASCIA 1987, p. 159.1987d, Terra sigillata, in SUB ASCIA 1987, pp. 160-168.1991, Terra sigillata, in SCAVI MM3 1991, 3.1, pp. 57-88.1998, Terra sigillata di età medio e tardo imperiale, in CERAMICHE IN LOMBARDIA 1998, pp.
125-132.1999, Le terre sigillate di produzione non africana, in S. GIULIA 1999, pp. 81-95.2002, Terra sigillata della media e tarda età imperiale di produzione padana. Contributo
alla definizione di un repertorio lombardo, in CAPITOLIUM 2002, pp. 323-352.
KEAY S.J. 1984, Late Roman Amphorae in the Western Mediterranean. A typology and economic study: the Catalan evidence, BARIntSer 196, Oxford.
KEMKES M. 1995, Zwei römische Truhenbeschlagsätze aus der Villa Rustica von Eigel-tingen-Eckartsbrunn, Kr. Konstanz (D), (Acta 12th International Congress Ancient Bronzes Njmegen 1992), Amersfoort, pp. 389-396.
LABATE D. 1989, Rozza terracotta e ceramica comune: una proposta tipologica, in MODENA 1989, pp. 60-88.
LA CERAMICA E I MATERIALI DI ETÀ ROMANA 2005, D. Gandolfi (ed.), La ceramica e i materiali di età romana. Classi, produzioni, commerci e consumi, Quaderni della Scuola Interdiscipli-nare delle Metodologie Archeologiche 2, Bordighera.
LA CITTÀ E LA SUA MEMORIA 1997, La città e la sua memoria. Milano e la tradizione di S. Ambrogio (Catalogo Mostra Milano 1997), Venezia.
LAMBERT P.-Y. 2002, Recueil des inscriptions gauloises, II.2, pp. 85-146.
LAMBOGLIA N.1950, Gli scavi di Albintimilium e la cronologia della ceramica romana. Campagne di
scavo 1938-1940, Bordighera.
577A B B R E V I A Z I O N I B I B L I O G R A F I C H E
1952, Per una classificazione preliminare della ceramica campana, in Atti I Congresso Internazionale di Studi Liguri Bordighera 1950, Bordighera, pp. 139-206.
1971, Appendice a C. Simonett, Necropoli romane nelle terre dell’attuale Canton Ticino, in Archivio Storico Ticinese 45-46, 12, pp. 207-234.
LAMBRUGO C. 2005, Oggetti e strumenti in metallo, in SCAVI DI VIA BENZI 2005, pp. 255-281.
LANCELLOTTI M.G. 2003, Le gemme e l’astrologia, in A. Mastrocinque (ed.), Silloge gem-marum gnosticarum, BNumRoma 8/2.I, Roma, pp. 113-124.
LARESE A.1983, Le lucerne fittili e bronzee del Museo concordiese di Portogruaro, Roma.2004, Vetri antichi del Veneto, Venezia.
LA ROCCA E. 2006, Presentazione, in R. Meneghini, R. Santangeli Valenzani (edd.), Roma. Lo scavo dei Fori Imperiali 1995-2000. I contesti ceramici, CEFR 365, Roma, pp. 1-2.
LAVAZZA A. 1986, La ceramica a vernice rossa interna, in S. MARIA ALLA PORTA 1986, pp. 244-245.
LAVAZZA A., VITALI M.G. 1994, La ceramica d’uso comune: problemi generali e note su alcune produzioni tardoantiche e medievali, in AD MENSAM 1994, pp. 17-54.
LAVIZZARI PEDRAZZINI M.P.1980, Terra sigillata e ceramica comune della necropoli romana di Angera, in Acme 33.2,
pp. 205-250.1985, Terra sigillata, in ANGERA ROMANA 1985, pp. 341-371.1987, Ceramica romana di tradizione ellenistica in Italia settentrionale. Il vasellame “tipo
Aco”, Firenze.1997, Nuove osservazioni sul vasellame “tipo Aco”, in Athenaeum 85.1, pp. 233-251.1998, Produzioni e commerci in Italia settentrionale, in OPTIMA VIA 1998, pp. 273-281.2004, Il vasellame da mensa, in S. Santoro (ed.), Artigianato e produzione nella Cisalpina.
Parte I. Proposte di metodo e prime applicazioni, Flos Italiae 3, Firenze, pp. 199-213.
LAZZARINI L. 2002, La determinazione della provenienza delle pietre decorative usate dai romani, in I marmi colorati della Roma imperiale (Catalogo Mostra Roma 2002-2003), Ve-nezia, pp. 223-265.
LEONARDI G., MAIOLI M.G. 1976, 23-Rinvenimenti sparsi, in Padova preromana (Catalogo Mostra Padova 1976), Padova, pp. 165-169.
LEONARDI G., RUTA SERAFINI A. 1981, L’abitato protostorico di Rotzo (Altipiano di Asiago), in PreistAlp 17, pp. 7-75.
LEOTTA M.C. 2005, La ceramica a vernice rossa interna, in LA CERAMICA E I MATERIALI DI ETÀ ROMANA 2005, pp. 115-120.
LOCATELLI D., RIZZI E. 2000, La ceramica a vernice nera dallo scavo di via Moneta: relazio-ne preliminare, in MILANO 2000, pp. 111-124.
LOESCHCKE S. 1919, Lampen aus Vindonissa, Zürich.
LORENZI J. 1996, Il territorio di Calvatone in epoca preistorica, in BEDRIACUM 1996, 1.1, pp. 45-54.
LUCHINI L. 1878, Bebriaco illustrato dai suoi scavi archeologici. Prima pagina di storia cremonese, Casalmaggiore.
LUGLI G. 1957, La tecnica edilizia romana con particolare riguardo a Roma e Lazio, Roma.
LUSUARDI SIENA S. 1977, Anfore, in A. Frova (ed.), Scavi di Luni. Relazione delle campagne di scavo 1972-74, Roma, pp. 218-270.
578 A B B R E V I A Z I O N I B I B L I O G R A F I C H E
MAASKANT-KLEIBRINK M.1978, Catalogue of the engraved gems in the Royal Coin Cabinet the Hogue, The Hague.1986, The engraved gems roman and non-roman, Nijmegen.
MACCABRUNI C.1983, I vetri romani dei Musei Civici di Pavia. Lettura di una collezione, Pavia.1994, Ceramica invetriata con decorazione a rilievo: nuovi ritrovamenti dal territorio pa-
vese, in Alba Regia 25, pp. 49-61.
MACCABRUNI C., DIANI M.G. s.d. (ma 2006), Musei Civici. Le collezioni museali, in CCVL PAVIA s.d. (ma 2006), pp. 21-112.
MACCABRUNI C., SCHIFONE C. 1985, Lotto III. Scavi 1973-74. Le tombe, in ANGERA ROMA-NA 1985, pp. 129-147.
MAGGIANI S. 1979, Liguri Orientali: la situazione archeologica in età ellenistica, in RStLig 45, pp. 73-101.
MAGICHE TRASPARENZE 2000, Magiche trasparenze. I vetri dell’antica Albingaunum (Cata-logo Mostra Genova 1999-2000), Milano.
MAGNI A.1996-1997, Una tecnica edilizia romana in Italia settentrionale: l’opus craticium, Tesi
di specializzazione, Università degli Studi di Milano (Relatore: prof. G. Sena Chiesa), A.A. 1996-1997.
2000, Edilizia in materiale deperibile in area mediopadana: fonti archeologiche e fonti letterarie, in MILANO 2000, pp. 441-452.
MAIOLI M.G.1973, Terre sigillate ravennati con impressione di gemma, in FelRav 5-6, pp. 3-9.1986, Appunti sulla tipologia delle case di Ravenna in epoca imperiale, in La Macedonia
iugoslava (XXXIII Corso di cultura sull’arte ravennate e bizantina Ravenna 1986), Ravenna, pp. 195-220.
1990, La topografia della zona di Classe, in G. Susini (ed.), Storia di Ravenna. I. L’evo antico, Venezia, pp. 375-414.
2000, Edilizia privata: gli aspetti culturali e architettonici, in AEMILIA 2000, pp. 173-185.
MALNATI L. 1988, L’origine di Regium Lepidi e il problema della romanizzazione dell’Emi-lia-Romagna alla luce degli ultimi scavi, in La formazione della città in Emilia Romagna. Prime esperienze urbane attraverso le nuove scoperte archeologiche, 3, in StDocA 4, Bologna, pp. 103-152.
MANACORDA D.1988, Per uno studio dei centri produttori delle anfore brindisine, in La Puglia in età
repubblicana (Atti I Convegno di Studi sulla Puglia romana Mesagne 1986), Galatina, pp. 91-108.
1990, Le fornace di Visellio a Brindisi. Primi risultati dello scavo, in VeteraChr 27, pp. 375-415.
1994, Le anfore di Giancola (BR): archeologia, archeometria, storia, in Ceramica romana e archeometria: lo stato degli studi (Atti Giornate Internazionali di Studio Castello di Monte-fugoni 1993), Firenze, pp. 277-284.
MANDEL ELZINGA U. 1985, Eine Gemmensammlung aus Alexandria im Akademischen Kunstmuseum der Universität Bonn, in BJb 185, pp. 243-298.
MANGANI E. 1982, Adria (Rovigo). Necropoli in loc. Ca’ Garzoni. Prima campagna di scavo, 1966, in NSc 1982, pp. 5-107.
MANNONI T. 1970, La ceramica d’uso comune in Liguria prima del secolo XIX (Prime notizie per una classificazione), in Atti III Convegno Internazionale della Ceramica Albisola 1970, Savona, pp. 297-334.
579A B B R E V I A Z I O N I B I B L I O G R A F I C H E
MANNONI T., GIANNICHEDDA E. 1996, Archeologia della produzione, Torino 1996.
MANZIA M.G.2004a, Vetri antichi, in CCVL CREMONA 2004, pp. 27-108.2004b, Il Museo Civico di Crema e del Cremasco, in CCVL CREMONA 2004, pp. 153-
162.2005, I coperchi, in CERAMICA COMUNE 2005, pp. 99-104.
MARABINI M.T. 1973, The Roman thin walled pottery from Cosa (1948-1954), MemAmAc 32, Roma.
MARCHI S. 1996, La ceramica comune dagli scavi di Piazza Marconi a Cremona, in CRE-MONA E BEDRIACUM 1996, pp. 171-179.
MARENSI A.2005a, I tegami a vernice rossa interna, in CERAMICA COMUNE 2005, pp. 76-77.2005b, I mortai, in CERAMICA COMUNE 2005, pp. 77-80.
MARIANI E.1997, Intonaci, in CALVATONE ROMANA 1997, pp. 185-203.1998, Gli affreschi in TESORI POSTUMIA 1998, p. 497.2004, Gli Intonaci dipinti, in V. Mariotti (ed.), Il teatro e l’anfiteatro di Cividate Camuno.
Scavo, restauro e allestimento di un parco archeologico, Firenze, pp. 307-322.c.s., Gli intonaci dello Scavo Sud, in SCAVO SUD c.s.
MARIANI E., PAGANI C. 2005, Gli intonaci: considerazioni generali, in G.P. Brogiolo, F. Mo-randini, F. Rossi (edd.), Dalle domus alla corte regia. S. Giulia di Brescia. Gli scavi dal 1980 al 1992, Firenze, pp. 291-300.
MARICHAL R. 1988, Les graffites de La Graufesenque, Paris.
MARINI CALVANI M. 1980, Leoni funerari romani in Italia, in BdA 6, pp. 7-14.
MARMI ANTICHI 1989, G. Borghini (ed.), Marmi antichi, Roma.
MARMO E COLORE 1998, P. Pensabene, M. Bruno (edd.), Il marmo e il colore. Guida foto-grafica. I marmi della collezione Podesti, Roma.
MASELLI SCOTTI F. 1981, Terra sigillata dalla Gallia ad Aquileia, in Aquileia e Occidente, in AAAd 19, pp. 239-257.
MASSA S.1988, Ceramica comune romana: recipienti in argille mediamente depurate, in VIA ALBER-
TO MARIO 1988, pp. 91-94.1990, Terra sigillata africana e ceramica comune dai contesti tardoantichi dello scavo di S.
Giulia (1986), in MILANO CAPITALE 1990, pp. 158-159.1997, Aeterna Domus. Il complesso funerario di età romana del Lugone (Salò), Man-
tova.
MASSA S., PORTULANO B.
1990, Brescia, S. Giulia, scavo 1987 (Ortaglia, settore Y2). Dati preliminari sulla ceramica comune: V-VII sec., in AMediev 17, pp. 111-120.
1999, La ceramica comune, in S. GIULIA 1999, pp. 143-173.
MASSARI G. 1979, Metodologia della ricerca applicata alla ceramica d’uso comune di Luni, in ReiCretActa 19-20, pp. 38-52.
MASSARI G., RATTI G. 1977, Osservazioni sulla ceramica comune di Luni, in A. Frova (ed.), Scavi di Luni. Relazione delle campagne di scavo 1972-74, Roma, pp. 590-630.
MASSEROLI S.1996, La ceramica a pareti sottili, in BEDRIACUM 1996, 1.2, pp. 83-104.1997a, Ceramica a pareti sottili, in CALVATONE ROMANA 1997, pp. 65-75.
580 A B B R E V I A Z I O N I B I B L I O G R A F I C H E
1997b, I metalli, in CALVATONE ROMANA 1997, pp. 147-157.1997c, Anfore, in CALVATONE ROMANA 1997, pp. 91-107.1998a, Analisi di una forma vitrea: la bottiglia Isings 50 nella Cisalpina romana, in Il
vetro dall’antichità all’età contemporanea: aspetti tecnologici, funzionali e commerciali (Atti 2e Giornate Nazionali di Studio AIHV - Comitato Nazionale Italiano Milano 1996), Milano, pp. 41-45.
1998b, Le bottiglie Isings 50, in TESORI POSTUMIA 1998, pp. 362-363.2001, Produzioni di ceramica a pareti sottili a Cremona e nel suo territorio, in MODELLO
ROMANO 2001, pp. 113-126.
MASSEROLI S., VOLONTÉ M. 2000, Le produzioni ceramiche di Cremona romana, in PRODU-ZIONE CERAMICA 2000, pp. 159-164.
MASTROCINQUE A. 2008, Il leone con la testa di toro, in A. Mastrocinque (ed.), Silloge gemmarum gnosticarum, BNumRoma 8/2.II, Roma, pp. 221-223.
MASTROROBERTO M. 1992, Gli arredi, in BELLEZZA E LUSSO 1992, pp. 145-147.
MAURINA B. 1998, Tecniche di realizzazione dei rivestimenti parietali in età romana: il caso di Isera, in Introduzione all’archeologia degli spazi domestici (Atti Convegno Como 1995), Como, pp. 89-99.
MAYET F. 1975, Les céramiques a parois fines dans la Péninsule Ibérique, Publications du Centre Pierre Paris, 1, Paris.
MAZZEO SARACINO L. 1985, Terra sigillata nord-italica, in ATLANTE 1985, pp. 175-230.
MAZZEO SARACINO L. ET ALII 1997, Una produzione di ceramica da cucina da Suasa (AN): esame tipologico e studio archeometrico, per la definizione della funzione, in IL CONTRIBUTO DELLE ANALISI ARCHEOMETRICHE 1997, pp. 200-213.
MAZZINI L. 1998, Elementi lapidei di decorazione architettonica e pavimentale, in C. Guarnieri (ed.), La domus di palazzo Pasolini a Faenza, Faenza, pp. 87-102.
MAZZOLA A. 1992, I materiali della necropoli di Fino Mornasco (località Socco), in RAComo 174, pp. 45-129.
MEDICI T.1996a, I vetri, in BEDRIACUM 1996, 1.2, pp. 215-222.1996b, Gli ossi lavorati, in BEDRIACUM 1996, 1.2, pp. 233-238.1996c, Materiale vario, in BEDRIACUM 1996, 1.2, pp. 239-244.1996d, Tecniche edilizie e materiali da costruzione dall’abitato di età romana di Calvatone
(Cr), in AnnBenac 11, pp. 137-148.1997a, Ceramica comune, in CALVATONE ROMANA 1997, pp. 109-131.1997b, Vetri, in CALVATONE ROMANA 1997, pp. 139-145.1997c, Materiale da costruzione, in CALVATONE ROMANA 1997, pp. 168-183.1998a, Tecniche costruttive delle fasi di età repubblicana e protoimperiale, in TESORI PO-
STUMIA 1998, pp. 493-494.1998b, Tessere musive, in TESORI POSTUMIA 1998, pp. 567-568.2000, Aspetti dell’edilizia residenziale a Milano: i materiali e le tecniche di costruzione, in
MILANO 2000, pp. 453-467.2005, Ceramica a vernice rossa interna, in PORTA PRETORIA 2005, pp. 107-109.
MEDICI T., NOBILE DE AGOSTINI I. 2005, Ceramica comune, in PORTA PRETORIA 2005, pp. 61-102.
MEDICI T., TOFFETTI L. 1994, La Domus di via Arena (Bergamo), in NotMilano 54.
MEMORIE DAL SOTTOSUOLO 2006, Roma. Memorie dal sottosuolo. Ritrovamenti archeologi-ci 1980/2006 (Catalogo Mostra Roma 2006-2007), Roma.
MERCI, MERCATI E SCAMBI 1981, A. Giardina, A. Schiavone (edd.), Merci, mercati e scambi
581A B B R E V I A Z I O N I B I B L I O G R A F I C H E
nel Mediterraneo, Società romana e produzione schiavistica, II, Roma-Bari 1981.
MICHEL S.2001, Die magischen Gemmen im Britischen Museum, London.2004, Die magischen Gemmen, Berlin.
MICHON E.1904, Libra, in Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, dir. Ch. Daremberg, E.
Saglio, III.2, Paris, pp. 1222-1231.1907, Pondus, in Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, dir. Ch. Daremberg,
E. Saglio, IV.1, Paris, pp. 548-559.1919, Trutina, in Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, dir. Ch. Daremberg,
E. Saglio, V, Paris, pp. 520-522.
MIEDICO C.2005a, Le classi dei materiali: vasellame da fuoco. Le olle, in CERAMICA COMUNE 2005, pp.
67-75.2005b, Le classi dei materiali: vasellame da dispensa. Le olle, in CERAMICA COMUNE 2005,
pp. 92-99.
MIELSCH H. 1985, Buntmarmore aus Rom im Antikenmuseum Berlin, Berlin.
MIGANI S. 1997, I mortai in pietra, in M. Calzolari, P. Campagnoli, N. Giordani (edd.), La Bassa modenese in età romana: sintesi di un decennio di ricognizioni archeologiche, S. Felice s/P, pp. 201-209.
MILANO
1996, Milano in età imperiale I-III secolo (Atti Convegno di Studi Milano 1992), Mila-no.
2000, Milano tra l’età repubblicana e l’età augustea (Atti Convegno di Studi Milano 1999), Milano.
MILANO CAPITALE 1990, Milano capitale dell’impero romano. 286-402 d.C. (Catalogo Mo-stra Milano 1990), Milano.
MIRABELLA ROBERTI M. 1972, Scavi a Bedriacum, in Archeologia e storia nella Lombardia padana. Bedriacum nel XIX centenario delle battaglie (Atti Convegno Villa Monastero di Varenna, Lago di Como 1969), Como, pp. 103-122.
MODELLO ROMANO 2001, G. Sena Chiesa (ed.), Il modello romano in Cisalpina. Problemi di tecnologia, artigianato e arte, Flos Italiae 1, Firenze.
MODENA 1989, Modena dalle origini all’anno Mille, Studi di Archeologia e Storia, II (Ca-talogo Mostra Modena 1989), Modena.
MONTE BARRO
1991, G.P. Brogiolo, L. Castelletti (edd.), Archeologia a Monte Barro. I. Il grande edificio e le torri, Lecco.
2001, G.P. Brogiolo, L. Castelletti (edd.), Archeologia a Monte Barro. II. Gli scavi 1990-97 e le ricerche al S. Martino di Lecco, Lecco.
MONTE TORTO 2001, Monte Torto di Osimo. L’impianto produttivo, Falconara.
MORANDINI F.1999, La ceramica a pareti sottili, in S. GIULIA 1999, pp. 65-68.2000, Produzioni ceramiche di media età imperiale a Verona. Impianti produttivi e scari-
chi da vecchi ritrovamenti e recenti indagini, in PRODUZIONE CERAMICA 2000, pp. 165-174.2003, La domus di Dioniso, in F. Morandini, F. Rossi, C. Stella (edd.), Le domus dell’Or-
taglia, Milano 2003, pp. 41-50.
MOREL J.-P. 1981, Céramique campanienne: les formes, Roma.
MORRICONE M.L. 1980, Scutulata pavimenta. I pavimenti con inserti di marmo o di pietra
582 A B B R E V I A Z I O N I B I B L I O G R A F I C H E
trovati a Roma e nei dintorni, Roma.
MUFFATTI MUSSELLI G. 1987, Diffusione dell’anfora troncoconica da olive nel I sec. d.C., in RAComo 168, pp. 187-215.
NEGRIOLI A. 1932, Bologna. Villa suburbana del I secolo dell’Impero fornita di pavimenti musivi con “emblema” policromo, in NSc 1932, pp. 51-88.
NEGRO PONZI MANCINI M.M. 1996, Il contributo dell’analisi impasto/forma allo studio della ceramica di uso comune tra tardo antico e medioevo. Trino S. Michele (VC), in G.P. Bro-giolo, S. Gelichi, Le ceramiche altomedievali (fine VI-X secolo) in Italia Settentrionale: produ-zione e commerci, 6° Seminario sul tardoantico e l’altomedioevo in Italia centrosettentrionale (Monte Barro - Galbiate Lecco 1995), DocA 7, Mantova, pp. 129-142.
NIELSEN I. 1993, Thermae et Balnea, the architecture and cultural history of Roman public baths, Aarhus.
NOBILE I.1991, Ceramica grezza, in MONTE BARRO 1991, pp. 63-79.1992, Necropoli tardoromane nel territorio lariano, AIS 6, Como.
NOBILE DE AGOSTINI I.2001, Ceramica grezza, in MONTE BARRO 2001, pp. 105-122.2005, Vetri, in PORTA PRETORIA 2005, pp. 154-168.
OLCESE G.1993, Le ceramiche comuni di Albintimilium. Indagine archeologica e archeometrica sui
materiali dell’area del Cardine, Firenze.1995, Ceramica comune (Lotto Cadorna), in ANGERA ROMANA 1995, pp. 409-438.2003, Ceramiche comuni a Roma e in area romana: produzione, circolazione e tecnologia.
Tarda età repubblicana - prima età imperiale, Mantova.
ONGARO G. 1999, Il materiale preromano, in S. GIULIA 1999, pp. 25-54.
OPTIMA VIA 1998, Optima Via. Postumia. Storia e archeologia di una grande strada roma-na alle radici dell’Europa (Atti Convegno Internazionale di Studi Cremona 1996), Cremona.
ORSENIGO C.2003-2004, Nuovi dati sulla ceramica comune di Calvatone-Bedriacum dallo scavo della
Domus del Labirinto (ES 8952), Tesi di laurea, Università degli Studi di Milano (Relatore: prof. M.T. Grassi), A.A. 2003-2004.
2006-2007, Calvatone-Bedriacum. I nuovi scavi nell’area della Domus del Labirinto (2001-2002). L’ambiente C e la terza fase, Tesi di specializzazione, Università degli Studi di Milano (Relatore: prof. M.T. Grassi), A.A. 2006-2007.
OSSORIO F.A. 2002-2003, La terra sigillata africana in Lombardia: nuovi dati e future prospettive di ricerca, Tesi di laurea, Università degli Studi di Milano (Relatore: prof. M.T. Grassi), A.A. 2003-2004.
OXÉ A., COMFORT H. 2000, Corpus Vasorum Arretinorum: a catalogue of the signatures, shapes and chronology of Italian Sigillata, seconda edizione ampliata, P. Kenrick (ed.), Bonn.
PAGANI A. 1953, Monete italiane moderne a sistema decimale da Napoleone console alla Repubblica Italiana (1800-1952), Milano.
PAGANI C. 1996, Gli intonaci dipinti, in BEDRIACUM 1996, pp. 179-184.
PALAZZO P., SILVESTRINI M. 2001, Apani. Anfore brindisine di produzione aniniana, in Dai-dalos 3, pp. 57-107.
PALMIERI L.2004-2005, La Domus del Labirinto di Calvatone-Bedriacum: analisi di un contesto della
I fase (US 8054), Tesi di specializzazione, Università degli Studi di Milano (Relatore: prof. M.T. Grassi), A.A. 2004-2005.
583A B B R E V I A Z I O N I B I B L I O G R A F I C H E
2007, La diffusione degli spatheia nell’XI Regio: osservazioni sui flussi commerciali tra l’Africa e la Transpadana in età tardoantica, in PRODUZIONI E COMMERCI 2007, su CD e online, http://www.archeologicacomo.it/conferenza_nov2006/pages/palmieri.htm.
2008, Un contesto nell’area della Domus del Labirinto: analisi della ceramica a vernice nera e degli altri materiali per la definizione della fase I di Calvatone-Bedriacum, in GRASSI 2008a, pp. 105-119.
*2009, “Progetto Calvatone”: dallo scavo all’edizione multimediale, in ACalc 20, pp. 397-419, http://soi.cnr.it/archcalc/indice/PDF20/27_Palmieri.pdf.
PANELLA C.1986, Le anfore tardoantiche: centri di produzione e mercati preferenziali, in A. Giardina
(ed.), Società romana e impero tardoantico, II, Le merci, gli insediamenti, Bari, pp. 251-272.2002, Le anfore di età imperiale del Mediterraneo occidentale, in CÉRAMIQUES HELLÉNISTI-
QUES ET ROMAINES 2002, pp. 177-275.
PANELLA C., FANO M. 1977, Le anfore con anse bifide conservate a Pompei: contributo ad una loro classificazione, in Méthodes classiques et méthodes formelles dans l’étude des ampho-res (Actes colloque de Rome 1974), CEFR 32, Roma, pp. 133-177.
PAOLUCCI C.1987-1988, Materiale sporadico da Calvatone conservato al Museo Platina di Piadena
(CR), Tesi di laurea, Università degli Studi di Milano (Relatore: Prof. G. Sena Chiesa), A.A. 1987-1988.
1996, Materiale sporadico proveniente da Calvatone conservato al Museo Platina di Pia-dena, in CREMONA E BEDRIACUM 1996, pp. 241-257.
PAOLUCCI F.1997, I Vetri incisi dall’Italia settentrionale e dalla Rezia nel periodo medio e tardo impe-
riale, Firenze.2000, Il vasellame da mensa e da dispensa, in MAGICHE TRASPARENZE 2000, pp. 55-62.
PASSI PITCHER L.1988, L’età romana e barbarica, 218 a.C. - 618 d.C., in L. Simone, S. Tiné (edd.), Il Civico
Museo Archeologico Platina. Guida, Milano, pp. 87-110.1990, 4b.4 Calvatone: il sito e gli scavi, in MILANO CAPITALE 1990, pp. 247-248.1991, Storia degli scavi, in CALVATONE ROMANA 1991, pp. 39-50.1996a, L’economia, in BEDRIACUM 1996, 1.1, pp. 85-99.1996b, L’urbanistica del vicus, in BEDRIACUM 1996, 1.1, pp. 61-84.2003, Archeologia della colonia di Cremona: la città e il territorio, in STORIA DI CREMONA
2003, pp. 130-229.
PASSI PITCHER L., BISHOP J. 1993, CALVATONE (CR) Località Costa di S. Andrea. Vicus di età romana: saggio 3, in NotALomb 1991, pp. 49-50.
PASSI PITCHER L., MARIANI E.2007a, Un quartiere residenziale di lusso di età augustea a Cremona, in FORME E TEMPI
2007, pp. 215-222.2007b, Intonaci dipinti da una domus di età augustea a Cremona, in VILLAS, MAISONS,
SANCTUAIRES 2007, pp. 329-354.
PASSI PITCHER L., NATTA E., SARTORI A. 1996, I materiali dei vecchi rinvenimenti, in BEDRIA-CUM 1996, 1.1, pp. 119-128.
PASSI PITCHER L., VOLONTÉ M. 2001, L’edilizia residenziale di Cremona romana, evoluzione delle strutture e delle decorazioni alla luce delle recenti scoperte, in ABITARE IN CISALPINA 2001, pp. 377-397.
PATRONI G.1908, Calvatone. Oggetti romani ritrovati presso l’abitato, in NSc 1908, pp. 310-311.
584 A B B R E V I A Z I O N I B I B L I O G R A F I C H E
1912, X. Calvatone. Tombe romane, in NSc 1912, p. 426.
PAVOLINI C. 1981, Le lucerne nell’Italia romana, in MERCI, MERCATI E SCAMBI 1981, pp. 139-184.
PELLEGRINI G.B., PROSDOCIMI A.L. 1967, La lingua venetica, I, Padova.
PERNICE E. 1932, Hellenistische Tischen, Zisternenmündungen, Bechenuntersätze, Altäre und Trhuen, Die Hellenistische Kunst in Pompeji 5, Berlin.
PESAVENTO MATTIOLI S.1998, I commerci di Verona e il ruolo della via Postumia. Un aggiornamento sui dati delle
anfore, in OPTIMA VIA 1998, pp. 311-327.2009, Le anfore troncoconiche da olive: spunti di riflessione, in Olio e pesce nell’epoca
romana: produzione e commercio nelle regioni dell’Alto Adriatico (Atti Giornate di Studio Padova 2007), Roma, pp. 335-348.
PETIT J. 1980, Bronzes antiques de la Collection Dutuuit, Paris.
PIANA AGOSTINETTI P. 2007, Dai vasi a trottola alle olpi nella Transpadana preaugustea, in PRODUZIONI E COMMERCI 2007, su CD e online, http://www.archeologicacomo.it/conferenza_ nov2006/pages/piana.htm
PIGNOCCHI G.2001a, Ceramica comune e ceramica da fuoco (fasi III-IV), in MONTE TORTO 2001, pp. 115-
130.2001b, Vetri, in MONTE TORTO 2001, pp. 155-157.
PISANO A.2000, Milano, piazza Erculea: la ceramica fine da mensa, in MILANO 2000, pp. 301-306.2004, Il Museo Civico Archeologico “Platina” di Piadena, in CCVL CREMONA 2004, pp.
171-207.
PISANO BRIANI A.2005a, Terra sigillata, in SCAVI DI VIA BENZI 2005, pp. 9-51.2005b, Ceramica a pareti sottili, in SCAVI DI VIA BENZI 2005, pp. 53-60.
PISTAN F. 1999, Ceramica comune dall’epoca della romanizzazione al primo alto medioevo, in SAN MICHELE DI TRINO 1999, pp. 207-308.
PITTURA ROMANA 2002, I. Baldassarre, A. Pontrandolfo, A. Rouveret, M. Salvadori (edd.), Pittura romana, Milano.
PLESNICAR-GEC L. 1972, Severno emonsko grobiš e, Ljublyana.
POLETTI ECCLESIA E. 1997, Indagine su una forma in terra sigillata particolarmente diffusa nella Cisalpina: la patera Dragendorff 17/B con decorazioni a rilievo applicato, in RAComo 179, pp. 27-69.
POMPEI 1996, Pompei. Abitare sotto il Vesuvio (Catalogo Mostra Ferrara 1996), Ferrara.
PONDERA 2001, C. Corti, N. Giordani (edd.), Pondera: pesi e misure nell’antichità, Cam-pogalliano.
PONTIROLI G.1972, Gli scavi di Bedriácum nell’Ottocento, in Archeologia e storia nella Lombardia
padana. Bedriacum nel XIX centenario delle battaglie (Atti Convegno Villa Monastero di Varenna, Lago di Como 1969), Como, pp. 89-101.
1993, Tesoretti numismatici nel territorio cremonese, Padova.
PORTA PRETORIA 2005, I. Nobile De Agostini (ed.), Indagini archeologiche a Como. Lo scavo nei pressi della Porta Pretoria, Como.
PORTULANO B.1994, I materiali, in Studi sulla villa romana di Desenzano, 1, Milano, pp. 164-172.
585A B B R E V I A Z I O N I B I B L I O G R A F I C H E
1999, La ceramica invetriata, in S. GIULIA 1999, pp. 125-142.PPM, Pompei, Pitture e mosaici, I-X, Roma 1990-2003.
PRADEL L., QUONIAM M.P. 1989, Musée de la Civilisation gallo-romaine à Lyon, Lyon.
PREACCO M.C. 1996, La terra sigillata, in G. Pantò (ed.), Monastero della Visitazione a Vercelli. Archeologia e storia, in QuadAPiem Monografie 5, pp. 163-170.
PREACCO ANCONA M.C. 2000, Il vasellame ceramico: terra sigillata, pareti sottili, ceramiche comuni, in L. Brecciaroli Taborelli, Alle origini di Biella. La necropoli romana, Torino, pp. 105-134.
PREDIERI G., SFRECOLA S. 1996, Analisi minero-petrografiche, in BEDRIACUM 1996, 1.2, pp. 209-214.
PRODUZIONE CERAMICA 2000, Produzione ceramica in area padana tra il II secolo a.C. e il VII secolo d.C.: nuovi dati e prospettive di ricerca (Atti Convegno Internazionale Desenzano del Garda 1999), Mantova.
PRODUZIONI E COMMERCI 2007, Produzioni e commerci in Transpadana in età romana (Atti del Convegno Como 2006), su CD e online, http://www.archeologicacomo.it/conferen-za_nov2006/
PUCCI G. 1975, Cumanae testae, in PP 30, pp. 369-371.
QUERCIA A. 1997, Ceramica comune: la cucina, la dispensa, la tavola, in F. Filippi (ed.), Alba Pompeia. Archeologia della città dalla fondazione alla tarda antichità, in QuadAPiem Monografie 6, pp. 493-515.
RAVASI T. 2006, Olio, vino, garum. Le relazioni commerciali di Calvatone-Bedriacum alla luce dei ritrovamenti di anfore, in Old Pottery in a New Century. Innovating Perspectives on Roman Pottery Studies (Atti Convegno Internazionale di Studi Catania 2004), Catania, pp. 315-329.
RAVASI T., BENEDETTI D. 2003, Prodotti di importazione a Calvatone-Bedriacum. Il caso delle anfore di forma Richborough 527 e di un vetro del Gruppo di Linceo, in Acme 56.2, pp. 5-50.
REBAUDO GRECO G.1977, Ceramica comune, in G. Molli Boffa, G. Rebaudo Greco, G. Wataghin Cantino, La
villa romana di Caselette. Risultati e problemi di uno scavo in corso nel territorio di Augusta Taurinorum, Torino, pp. 30-37.
1980, La decorazione della ceramica comune di Caselette, in Studi di archeologia dedicati a Pietro Barocelli, Torino 1980, pp. 135-149.
RIC, AA.VV., The Roman Imperial Coinage, London 1930-1984.
RICCI A.1981, I vasi potori a pareti sottili, in MERCI, MERCATI E SCAMBI 1981, pp. 123-138.1985a, Ceramica a pareti sottili, in ATLANTE 1985, pp. 231-357.1985b, Introduzione, in SETTEFINESTRE 1985, pp. 11-19.
RICHTER G.M.A. 1926, Ancient Furniture, Greek, Etruscan and Roman, Oxford.
RIDOLFI G. 2007, La ceramica a vernice nera di importazione dagli scavi di Piazza Marconi a Cremona: analisi preliminare, in PRODUZIONI E COMMERCI 2007, su CD e online, http://www.archeologicacomo.it/conferenza_nov2006/pages/ridolfi.htm
RIMINI 2005, L. Mazzeo Saracino (ed.), Il complesso edilizio di età romana nell’area dell’ex vescovado a Rimini, Bologna.
RINALDI F. 2007, Mosaici e pavimenti del Veneto: province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza (I sec. a.C. - VI sec. d.C), Roma.
RISCOPRIRE POMPEI 1993, Riscoprire Pompei (Catalogo Mostra Roma 1993), Roma.
586 A B B R E V I A Z I O N I B I B L I O G R A F I C H E
RIZZI E. 1999, La ceramica a vernice nera, in S. GIULIA 1999, pp. 55-64.
ROCCO T. 2003, Casa di M. Pilius Primigenius Grenianus, Insula Orientalis I,1a, in STORIE DA UN’ERUZIONE 2003, pp. 56-60.
ROFFIA E.1979, Vetri romani del Palazzo Ducale di Mantova, in AnnBenac 5, pp. 97-128.1991, Ceramica africana, in SCAVI MM3 1991, 3.1, pp. 89-105.1993, I vetri antichi delle Civiche Raccolte Archeologiche di Milano, Milano 1993.1996, I vetri, in CARTA BRESCIA 1996, pp. 211-224.
ROSSI F., PORTULANO B. 1994, Nuovi scavi nell’area della villa romana 1988-1990, in Studi sulla villa romana di Desenzano, Milano, pp. 145-181.
ROTTOLI M. 1996, La tecnica edilizia, in BEDRIACUM 1996, 1.1, pp. 161-170.
RRC, M.H. Crawford, Roman Republican Coinage, Cambridge 1974.
RÜTTI B. 1991, Die römische Gläser aus Augst und Kaiseraugst, FiA 13/1-2, Augst.
SACCARDO L. 1985, Ceramica comune: urne e ciotole coperchio, in ANGERA ROMANA 1985, pp. 469-481.
SALANDRINI C. 1996, Materiali rinvenuti in un pozzo romano a Bedriacum, in CREMONA E BEDRIACUM 1996, pp. 229-235.
SALVO E. 2007, Elementi metallici per edilizia e arredo, in M. Bergamini (ed.), Scoppieto I. Il territorio e i materiali (Lucerne, Opus doliare, Metalli), Firenze, pp. 199-231.
SALZANI L. 1986, Verona, in QuadAVen 2, pp. 96-97.
SALZANI L., BIONDANI F. 1998-1999, Santa Maria di Zevio (Verona). Insediamento rustico di età romana, in Padusa 34-35, pp. 119-176.
SAN MICHELE DI TRINO 1999, M.M. Negro Ponzi Mancini (ed.), San Michele di Trino (Vc). Dal villaggio romano al castello medievale, Ricerche di archeologia altomedievale e medievale 25-26, I, Firenze.
S. GIULIA 1999, G.P. Brogiolo (ed.), S. Giulia di Brescia, gli scavi dal 1982 al 1992. Reperti preromani, romani e altomedievali, Firenze.
S. LORENZO DI PEGOGNAGA 1996, A.M. Tamassia (ed.), Archeologia di un ambiente padano. S. Lorenzo di Pegognaga (Mantova), Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere e Arti. Classe di Lettere e Arti 4, Firenze.
S. MARIA ALLA PORTA 1986, A. Ceresa Mori, M. Tizzoni (edd.), Santa Maria alla Porta. Uno scavo nel centro storico di Milano, Studi archeologici 5, Bergamo.
SANTELLI M. 1996, Ceramica fine da mensa da Calvatone romana. Lotto IV. I graffiti e il problema LPS, in CREMONA E BEDRIACUM 1996, pp. 285-288.
SANTORO S. 2006, La localizzazione delle attività produttive della Cisalpina: commento ai dati di una ricerca in corso sull’artigianato romano, in TERRITORIO E PRODUZIONI 2006, pp. 165-178.
SANTORO BIANCHI S. 1990, La ceramica grezza romana di Castelraimondo: problemi di metodo e prospettive di ricerca, in Aquileia e l’arco adriatico, AAAd 36, Udine, pp. 375-404.
SANTROT M.H., SANTROT J. 1979, Céramiques Communes Gallo-Romaines d’Aquitaine, Paris.
SAPELLI M. 1981, La villa romana di Ghisalba (Bg). Campagna di scavo 1980, in AnnBenac 7, pp. 143-203.
SAVIO A. 2001, Monete romane, Roma.2007, Destini diversi. “Denarii” di Antonio e “denarii” di Bruto, in Acme 60.3, pp. 84-98.
587A B B R E V I A Z I O N I B I B L I O G R A F I C H E
SCAGLIARINI D. 1969, L’insediamento residenziale e produttivo nel suburbio di Bologna romana, in AttiMemBologna 20, pp. 137-192.
SCAGLIARINI CORLAITA D.1975, La villa romana, in Russi. La villa romana. La città, Faenza, pp. 47-76.1983, L’edilizia residenziale nelle città romane dell’Emilia Romagna, in G.A. Mansuelli
(ed.), Studi sulla città antica. L’Emilia Romagna, StA 27, Roma, pp. 283-334.2000, Edilizia privata: l’apparato decorativo, in AEMILIA 2000, pp. 186-194.
SCAVI AD AQUILEIA
1991, M. Verzár-Bass (ed.), Scavi ad Aquileia I. L’area ad Est del foro. Rapporto degli scavi 1988, GalliaCis 3, Roma.
1994, M. Verzár-Bass (ed.), Scavi ad Aquileia I. L’area ad est del foro. Rapporto degli scavi 1989-91, GalliaCis 6, Roma.
SCAVI DI VIA BENZI 2005, Extra moenia. 2. Gli scavi di via Benzi. I reperti, in RAComo 187.
SCAVI MM3 1991, D. Caporusso (ed.), Scavi MM3. Ricerche di archeologia urbana a Mila-no durante la costruzione della linea 3 della Metropolitana 1982-1990, Milano.
SCAVO SUD c.s., G. Sena Chiesa (ed.), Calvatone-Bedriacum: Scavo Sud, c.s.
SCIALLANO M., SIBELLA P. 1991, Amphores. Comment les identifier?, Aix-en-Provence.
SCOTTI C. 1989, Anfore, in MODENA 1989, pp. 89-98.
ŠEBESTA G. 1977, La via dei mulini. Dall’esperienza della mietitura all’arte di macinare (molinologia), Trento.
SELLER E., VIETTI C. 1985, Fontana Gregoretti: tracce di un insediamento rurale d’epoca romana presso la Morsella di Vigevano, in AUTerr 4, pp. 225-239.
SENA CHIESA G.1966, Gemme del Museo Nazionale di Aquileia, Padova, I-II.1985, Ceramica e pareti sottili, in ANGERA ROMANA 1985, pp. 389-426.1987, Calvatone (Cremona). Piano di intervento, in NotALomb 1986, Milano, pp. 224-
225.1991a, Introduzione, in CALVATONE ROMANA 1991, pp. 29-34.1991b, Calvatone (CR), località Costa di S. Andrea. Vicus di età romana: area di proprietà
provinciale, in NotALomb 1990, Milano, pp. 81-86.1995, Lotto V. Lo scavo: le fasi dell’edificio, in ANGERA ROMANA 1995, pp. 47-71.1996, Calvatone (CR), località Costa di S. Andrea. Vicus di età romana: area di proprietà
provinciale, in NotALomb 1994, Milano, pp. 90-98.1998, Calvatone-Bedriacum: un vicus commerciale lungo la via Postumia, in OPTIMA VIA
1998, pp. 345-367.2001, Glittica padana. Gemme incise e impressioni di gemme da Calvatone-Bedriacum, in
MODELLO ROMANO 2001, pp. 15-42.2002, Gemme incise romane da scavo: il caso di Calvatone-Bedriacum, in V. De Angelis
(ed.), Sviluppi recenti nella ricerca antichistica, QuadAcme 54, pp. 163-178.2007, Cinquant’anni di ricerche a Calvatone-Bedriacum, in AnnBenac 13-14, pp. 217-
241.
SENA CHIESA G., FACCHINI G.M. 1985, Gemme romane di età imperiale: produzione, com-merci, committenze, in ANRW II/12.3, pp. 3-31.
SENA CHIESA G., GRASSI M.T.2004, CALVATONE (CR) Località Costa di S. Andrea, area di proprietà provinciale.
Vicus di età romana, in NotALomb 2001-2002, Milano, pp. 79-85.2006, CALVATONE (CR) Località Costa di S. Andrea, area di proprietà provinciale. Vi-
cus di età romana: la domus del Labirinto, in NotALomb 2003-2004, Milano, pp. 158-164.
588 A B B R E V I A Z I O N I B I B L I O G R A F I C H E
SETTEFINESTRE 1985, A. Ricci, A. Carandini (edd.), Settefinestre. Una villa schiavistica nell’Etruria romana, Modena.
SFREDDA N. 1998, Ceramica a vernice nera, in CERAMICHE IN LOMBARDIA 1998, pp. 21-27.
SFREDDA N., TASSINARI G. 1998, Ceramica invetriata di età alto imperiale, in CERAMICHE IN LOMBARDIA 1998, pp. 75-232.
SLAVAZZI F.1996, Edilizia residenziale a Bedriacum: i pavimenti, in Atti III Colloquio AISCOM Bor-
dighera 1995, Bordighera, pp. 117-128.1998a, Le domus del vicus, in TESORI POSTUMIA 1998, pp. 494-497.1998b, Pavimenti in battuto nei centri antichi lungo il tracciato della via Postumia in OP-
TIMA VIA 1998, pp. 259-272.1999, Pavimenti di triclini a Bedriacum (Cremona), in Atti V Colloquio AISCOM Roma
1997, Ravenna, pp. 1-10.2000, I pavimenti in battuto di Mediolanum, in MILANO 2000, pp. 233-243.2001a, L’arredo delle domus norditaliche dall’età tardorepubblicana alla media età impe-
riale, in ABITARE IN CISALPINA 2001, pp. 127-139.2001b, Sostegni scanalati e modanati. A proposito degli arredi in marmo e pietra di età
romana in Cisalpina, in MODELLO ROMANO 2001, pp. 93-111.2004, Il pavimento della domus, in A. Ceresa Mori (ed.), L’anfiteatro di Milano e il suo
quartiere. Percorso storico-archeologico nel suburbio sudoccidentale, Milano, p. 64.*2010, Lusso rustico. Sui pavimenti cementizi a base marmorea e sull’uso del marmo
nei pavimenti nella Cisalpina centrale in età protoimperiale, in Atti XV Colloquio AISCOM Aquileia 2009, Tivoli, pp. 87-95.
SPINAZZOLA V. 1928, Le arti decorative in Pompei e nel Museo Nazionale di Napoli, Na-poli.
STELLA C., MORANDINI F. 1999, Lucerne, in S. GIULIA 1999, pp. 69-80.
STERNINI M. 1989, Una manifattura vetraria di V secolo a Roma, Firenze.
STORIA DI CREMONA 2003, P. Tozzi (ed.), Storia di Cremona. L’età antica, Cremona.
STORIE DA UN’ERUZIONE 2003, Storie da un’eruzione. Pompei, Ercolano, Oplontis (Catalogo Mostra Napoli 2003), Milano.
STORTI A. 1996, I metalli, in BEDRIACUM 1996, 1.2, pp. 223-232.
SUB ASCIA 1987, Sub ascia, una necropoli romana a Nave (Catalogo Mostra Milano 1987), Modena.
SYDENHAM E.A. 1952, The coinage of the Roman Republic, New York.
TAMASSIA A.M. 1981, Mosaico romano dal territorio di Cavriana, in AnnBenac 7, pp. 81-90.
TAMASSIA K. 1996, Ceramica comune, in S. LORENZO DI PEGOGNAGA 1996, pp. 209-234.
TARPINI R.1997, La ceramica a vernice nera e la ceramica grigia, in BASSA MODENESE 1997, pp. 81-
93.2000, La forma Isings 42 a var. Limburg 1971. Aspetti morfologici-tecnologici e sua dif-
fusione nell’Italia settentrionale, in Annales du 14e Congrés AIHV (Venezia-Milano 1998), Lochem, pp. 95-98.
2001, Bilance e stadere, in PONDERA 2001, pp. 179-190.
TASSAUX F. 2001, Production et diffusion des amphores a huile istriannes, in Strutture por-tuali e rotte marittime nell’Adriatico di età romana, AAAd 44, Trieste, pp. 501-543.
TASSAUX F., MATIJAŠIC R., KOVACIC V. 2001 (éds.), Un grand centre de production d’ampho-res à huile istriennes (I - IV s. p.C.), Santanbria-Cantabria.
589A B B R E V I A Z I O N I B I B L I O G R A F I C H E
TASSINARI S. 1993, Il vasellame bronzeo di Pompei, Roma.
TASSINARI G. 1998, Ceramica a pareti sottili, in CERAMICHE IN LOMBARDIA 1998, pp. 37-65.
TASSINARI G., COMPOSTELLA C. 1995, Ceramica comune (Lotto V), in ANGERA ROMANA 1995, pp. 95-189.
TERRITORIO E PRODUZIONI 2006, Territorio e produzioni ceramiche. Paesaggi, economia e società in età romana (Atti Convegno Internazionale Pisa 2005), Pisa.
TESEI L. 1988, Ceramica comune romana: i recipienti in argilla depurata, in VIA ALBERTO MARIO 1988, pp. 85-91.
TESORI POSTUMIA 1998, Tesori della Postumia. Archeologia e storia intorno a una grande strada romana alle radici dell’Europa (Catalogo Mostra Cremona 1998), Milano.
TIRELLI M. 1987, La domus di via Mazzini ad Oderzo (Treviso), in QuadAVen 3, pp. 171-192.
TIZZONI M.1981, La cultura tardo La Tène in Lombardia, StArcheo 1, Bergamo, pp. 3-39.1984, I materiali della tarda età del ferro nelle civiche raccolte di Milano, in NotMilano
suppl. 3.1990-1991, Prime osservazioni sui materiali preromani provenienti dagli scavi di via Mo-
neta e della Biblioteca Ambrosiana in Milano, in Sibrium 21, pp. 259-263.
TOMASELLI C.M. 1985, Ceramica comune: piatti-tegame e coppette, in ANGERA ROMANA 1985, pp. 451-467.
TOMASONI P. 1990, Rinvenimenti monetali di età romana a Cremona e nel territorio cremo-nese, in RItNum 92, pp. 129-146.
TOMBOLANI M. 1981, Bronzi figurati etruschi, italici, paleoveneti e romani del Museo pro-vinciale di Torcello, Roma.
TONSO E. 1995, Terra sigillata chiara (lotto VI), in ANGERA ROMANA 1995, pp. 318-323.
TORELLI M. 1998, Via Postumia: una strada per la romanizzazione, in OPTIMA VIA 1998, pp. 21-28.
TORTORELLA S. 1996, Considerazioni sulla sigillata tarda dell’Italia centro-settentrionale, in M.G. Picozzi, E.F. Carinci (edd.) Studi in memoria di Lucia Guerrini, in Studi Miscellanei. Seminario di archeologia e storia dell’arte greca e romana dell’Università di Roma 30, Roma, pp. 323-335.
TOSATTI A.M. 1991, Materiali in osso e corno, in SCAVI MM3 1991, pp. 63-69.
TOZZI P. 2003, La storia politica repubblicana, in STORIA DI CREMONA 2003, pp. 230-273.
TRAVERSO E. 1994-1999, I cosiddetti incensieri: una forma in ceramica comune dallo scavo di Piazza Missori a Milano, in Sibrium 23, pp. 237-252.
TREMEL L. 1967-1969, Ceramica domestica da una casa romana da Bergamo, in Sibrium 9, pp. 283-300.
UBOLDI M.1991, Vetri, in SCAVI MM3 1991, 3.1, pp. 39-50.1999, I vetri, in S. GIULIA 1999, pp. 271-308.2004, Vetri, in V. Mariotti (ed.), Il teatro e l’anfiteatro di Cividate Camuno. Scavo, restau-
ro e allestimento di un parco archeologico, Firenze, pp. 267-276.2005a, Vetri, in SCAVI DI VIA BENZI 2005, pp. 219-254.2005b, Laterizi e opus doliare, in LA CERAMICA E I MATERIALI DI ETÀ ROMANA 2005, pp. 479-
490.UGGERI G. 1998, Le vie d’acqua nella Cisalpina romana, in OPTIMA VIA 1998, pp. 73-84.UTTOVEGGIO F. 2007, Bronzi decorativi, in FORUM SEMPRONII 2007, pp. 151-156.
590 A B B R E V I A Z I O N I B I B L I O G R A F I C H E
VALENTI M.G.1990, 4b.4a Monete, in MILANO CAPITALE 1990, Milano, pp. 248-249.1991, Catalogo delle monete provenienti da Calvatone romana. Scavi 1957/61, in CALVA-
TONE ROMANA 1991, pp. 197-216.1996, Ritrovamenti monetali da Calvatone, in CREMONA E BEDRIACUM 1996, pp. 305-307.
VANNACCI LUNAZZI G.1977, Le necropoli pre-romane di Remedello Sotto e Cà di Marco di Fiesse (BS), Reggio
Emilia.1983, Un aspetto della romanizzazione del territorio: la necropoli di Gambolò-Belcreda
(Pavia), in RAComo 165, pp. 199-254.
VASA RUBRA 2007, Vasa rubra. Marchi di fabbrica sulla terra sigillata da Iulia Concordia, Padova.
VASSAL V. 2006, Les pavements d’opus signinum. Techniques, décor, fonction architectu-rale, BARIntSer 1472, Oxford.
VEGAS M. 1973, Cerámica común romana del Mediterráneo occidental, Barcelona.
VERNICE NERA
1995, P. Frontini, M.T. Grassi, D. Locatelli, E. Mello, Contributo delle analisi chimiche mediante fluorescenza X per la determinazione di provenienza della ceramica a vernice nera in Italia settentrionale, in Sibrium 22, pp. 329-401.
1998, P. Frontini, M.T. Grassi, D. Locatelli, E. Mello, Aggiornamenti a: contributo delle analisi chimiche mediante fluorescenza X per la determinazione di provenienza della ceramica a vernice nera in Italia settentrionale, in INDAGINI 1998, pp. 39-61.
VIA ALBERTO MARIO 1988, G.P. Brogiolo (ed.), Lo scavo di via Alberto Mario, in G. Panaz-za, G.P. Brogiolo, Ricerche su Brescia altomedievale, I, Gli studi fino al 1978. Lo scavo di via Alberto Mario, Brescia, pp. 37-218.
VILLA L. 1994, Le anfore tra tardoantico e medioevo, in AD MENSAM 1994, pp. 335-341.
VILLAS, MAISONS, SANCTUAIRES 2007, Villas, maisons, sanctuaires et tombeaux tardo-républi-cains: découvertes et relectures récentes, (Actes colloque international de Saint-Romain-en-Gal en l’honneur d’Anna Gallina Zevi Vienne - Saint Romain-en-Gal 2007), Roma.
VINCENZI M. 1993, Ricerche archeologiche di superficie nel comune di Villa Poma, in QuadAOst 3, pp. 81-94.
VISMARA N.1992a, Il ripostiglio di Calvatone. Cremona 1911, Milano.1992b, Il ripostiglio di Calvatone. Cremona 1942, Milano.
VITRUM 2004, Vitrum. Il vetro fra arte e scienza nel mondo romano (Catalogo Mostra Firenze 2004), Firenze-Milano.
VOLONTÉ M.1995, Forme di transizione dalla ceramica a vernice nera alla Terra Sigillata: il caso di
Calvatone, in Sibrium 22, pp. 217-229.1996a, Le terre sigillate, in BEDRIACUM 1996, 1.2, pp. 105-118.1996b, La ceramica a vernice rossa interna, in BEDRIACUM 1996, 1.2, pp. 127-132.1996c, Ceramica fine da mensa da Calvatone romana (scavi 1957-61). Lotto I, in CREMO-
NA E BEDRIACUM 1996, pp. 259-266.1997a, Lo “scarico” di ceramica, in CALVATONE ROMANA 1997, pp. 27-31.1997b, Il portico, in CALVATONE ROMANA 1997, pp. 33-36.1997c, Ceramica a vernice nera, in CALVATONE ROMANA 1997, pp. 59-63.1997d, Ceramica a vernice rossa interna, in CALVATONE ROMANA 1997, pp. 77-78.1997e, Terre sigillate, in CALVATONE ROMANA 1997, pp. 79-90.1997f, Ceramica invetriata, in CALVATONE ROMANA 1997, pp. 133-136.
591A B B R E V I A Z I O N I B I B L I O G R A F I C H E
2001, Terra Sigillata con impressioni di gemme da Calvatone-Bedriacum, in MODELLO ROMANO 2001, pp. 59-72.
2003a, Produzioni e commerci, in STORIA DI CREMONA 2003, pp. 182-191.2003b, Le domus: i pavimenti, in STORIA DI CREMONA 2003, pp. 177-179.2008, Dopo la ceramica a vernice nera: i rapporti con la produzione di Terra Sigillata, in
GRASSI 2008a, pp. 120-122.
VOLONTÉ R. 1996, Le anfore, in BEDRIACUM 1996, 1.2, pp. 189-208.
WATAGHIN CANTINO G., LANZA R., CROSETTO A. 1980, Scavo di una villa romana presso Caselette (Torino). Relazione preliminare delle campagne 1973-1975, in Studi di archeologia dedicati a Pietro Barocelli, Torino, pp. 109-134.
WEBSTER T.B.L. 1961, Leading slaves in New Comedy 300 B.C. - 300 A.D., in JdI 76, pp. 100-110.
WHITEHOUSE C. 1997, Roman Glass in the Corning Museum of Glass, I, New York.
ZABEHLICKY-SCHEFFENEGGER S. 2006, La sigillata padana, in TERRITORIO E PRODUZIONI 2006, pp. 233-237.
ZACCARIA C. 1989, Per una prosopografia dei personaggi menzionati sui bolli delle anfore romane dell’Italia nordorientale, in Anfore romane e storia economica: un decennio di ricer-che (Atti Colloquio Siena 1986), Roma, pp. 469-488.
ZACCARIA RUGGIU A. 2001, Abbinamento triclinium-cubiculum: un’ipotesi interpretativa, in ABITARE IN CISALPINA 2001, pp. 59-101.
ZAMPIERI G. 1998, Vetri antichi del Museo Civico Archeologico di Padova, Corpus colle-zioni vetro Veneto 3, Venezia.
ZAMPORI VANONI M.L.1987a, Ceramica a pareti sottili, in SUB ASCIA 1987, pp. 172-178.1987b, Olpai, in SUB ASCIA 1987, pp. 187-193.
ZENONI G. 2005-2006, L’incannucciata di Calvatone-Bedriacum: analisi di una tecnica edi-lizia, Tesi di laurea magistrale, Università degli Studi di Milano (Relatore: prof. M.T. Grassi), A.A. 2005-2006.
ZEVI F. 1991, L’arte “popolare”, in La pittura di Pompei. Testimonianze dell’arte romana nella zona sepolta dal Vesuvio nel 79 d.C., Milano, pp. 267-273.
ZUCCA I. 1996, Le anfore romane rinvenute a Cremona e nel suo territorio, in CREMONA E BEDRIACUM 1996, pp. 125-134.
ZUFFA M. 1944, Mosaici di Bononia, in Emilia Romagna, II, Firenze, pp. 3-27 [in seguito in M. ZUFFA, Scritti di archeologia, Roma 1982, pp. 13-37].
ZWIERLEIN DIEHL E. 1991, Die antiken Gemmen des Kunsthistorischen Museums in Wien, III. Die Gemmen der späteren römischen Kaiserzeit, 2. Masken, Masken-Kombinationen, Phantasie- und Märchentiere, Gemmen mit Inschriften, christliche Gemmen, magische Gemmen, sasanidische Siegel, Rundplastik aus Edelstein und verwandtem Material, Kameen, München.