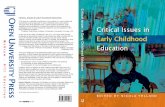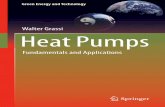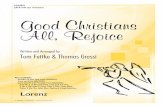Novità su Nicola Grassi.
Transcript of Novità su Nicola Grassi.
27
19
85
97
r23
Sommario
Mauro Minardi 164Pittura venet a fraTrce Quattrocentonelle Marche. Note in calcea una mostra
Paola Rossi 169Enrico Merengo: I'attività veneziana
Amalia PaciaAntonio Guardi per i Giovanelli:precisazioni e aggiunte IB2
Enrico LuccheseNovità su Nicola Grassi
Monica De Vinceruti"Domino Horatio et FratelliMarinali bassanesi, illustri scultori I84della città di Venezia"
Giuseppe PauanelloAffreschi veneziani del tardo 190
Settecento
Segnalazioni
Tatiana Kustodieua"La sfida tra Apollo e Marsia"di Agnolo Bronzino: 202originale e copia
Amalia Donatella BassoDue sorelle di nome Cecilia: 203la pala diJacopo Tintorettoper la chiesa dei Santi Cosmae Damiano
Francesca Cocchiara 208Palma il Giovane e Schiavone:un intreccio ritrovato r
di cronaca su una nota
^6Vincenzo MancíniIl Tinelli perduto
Ugo Ruggeri 222Gaspare Dizianie il Maesrro dei fioriguardeschi: una collabor azione
Giuseppe Saua
Per il catalogo di Francesco Androsi:le sculilre della chiesa di SanGiovanni Nepomuceno a Telve
Ambra SponchíadoDisegni di Pietro Antonio Novelliper I'edizioneZatta delle Operedi Carlo Goldoni
Nina StadrcichukIl ritorno di un quadrodi Angelica Kauffmann a Pavlovsk
Carte d'archivio
Isabella CecchiniPer I'identificazione di FrancescoMantovano
Elena Granuzzo"Description duJardinde Picenardes": un ineditojappelliano?
Convegni
Sonia BrinkAntonio Molinari e I'arte veneziananel Sei e Settecento
Bernard AikemaMolinari & co.: riflessioni sulmomento intemazionale della pitturaveneziana fra Sei e Settecento
Roberto ContiniBerlino per Fra Semplice
Stefan MorétAlcuni disegni sconosciuridi Fra Semplice da Veronaa \X/ùrzburg
Corinna HòperGiuseppe Diamantini: i disegnipreparatori per le acqueforti
235 Alberto CraieuichAntonio Molinari: gli esordit67r-1682
242 JuliaScheaski-BockDisegni di Antonio Pellesrinia Francoforte
Restauri
250 Enrico NoèRecuperi nella pittura seicen:-caaYenezia: Palma il Gior-ane.Fialetti, Langetti. Lazzann-
Letture
266 Giordana Mariani Canot.;Bibliografiq delle opere d'anedella basilica di Sant'.{.nroniodi Padova
267 \X/illian BarchantI Sagredo, comminend e collez.onl.rd'arte nella Venezia del Seie Settecento
Ricerche
270 Per un Atlante della sraruariaveneta da giardino. IIa cura di Simone Guenierr,Monica De Vincenti
307 Bibliografia dell'arte veneta: )r-rtr)
a cura di Daniele D'An:a
r34
118
150
155
161
85
Enrico Lucchese
Novità su Nicola Grassi
ome spesso accade per I'arte veneta, è An-ton Maria Zanetti con il suo trattato dell71I a dare la miglior definizione delle
qualità pittoriche di Nicola Grassi (I682-t748).
Nel quinto libro della sua Pittura Veneziarca e delle
Opere Pubbliche de' Venezianì Maestri, subito do-
po il profilo dedicato a Rosalba Carriera "grande
amica delle pittoresche muse", Zanetti ricorda in-fatti che "non è da omettersi" un altro ritrattistavissuto "in quei giorni" che "dipinse con bel ma-
neggio di colore, convaghezza e lucidità"': il gran-
de critico considera quindi Grassi pienamentepartecipe alla civiltà artistica di Venezia, indicandoinoltre un alunnato presso Nicolò Cassana, an-
ch'egli maestro specialista in ritratti e in contattocon il cosiddetro clan Caniera.Le origini carniche di Nicola Grassi, nato in una
frazione della valle del Bút, nonché la cospicuapresenza di sue opere in Friuli (a lui è dedicataun'intera sala nel Museo Civico di Udine)'hannoorientato la critica, fin dagli scritti fondamentali diGiuseppe Fiocco', a reputare il pittore legato inmodo strettissimo alla terra dei propri padri. Taleprospettiva, reale per quanto riguarda rapporti dicommittenza e vicende biografiche dell'artista, è
stata da parte degli studi trasposta e ampliata pure
sul versante creativo, arrivando spesso a intenderel'apporto stilistico di Grassi quale fenomeno indis-solubilmente locale, a volte quasi in antitesi con ilcontesto veneziano, arrecando conseguenti effettidi sfortuna critica' e fraintendimenti filologici dinon facile superamentot.
Nonostante alcuni saggi chiarificatori, tra cui quel-
lo di Lino Moretti che documenta una permanen-za stabile di Nicola fin dall'infanzia nella città diSan Marco., oggi mancano alla sua opera unosguardo complessivo capace di meglio sostanziareil giudizio diZanettie una seria collocazione all'in-terno dell'ambiente veneto dell'epoca, espungen-
do - nella formazione di un catalogo - lavori dibottega, di seguaci. di altri maestri-.
Artista dotato di uno stiie fìgurativo riconoscibi-
le, il carnico è pittore non sempre agevole da indi-viduare quando si cimenta nella ritrattistica, argo-
mento su cui si è avuto modo di riflettere recente-
mente prendendo le mosse proprio dalle autore-voli parole del critico settecentesco'. È il caso del-
la pergamena di piccole dimensioni (17 ,5 x 22,5
cm) con unRitratto di prelato con Sacra Famiglia e
san Girolamo (fig. 1)', felice aggiunta alla ridottaserie delle effigi note di Nicola Grassi: il peculia-
re panneggio di Maria dal velo leggermente pie-gato sul capo e le consuete fisionomie di tutti ipersonaggi, da confrontare per esempio con quel-li della Sacra Famiglia e san Giouanni Battistabambíno del Museo di Padova'", il leone tutto inombra di Girolamo che pare ingaggiato tra quelliche pascolano attorno Daniele nella fossa ad Am-pezzott, ma anche la stessa quinta arborea a sini-stra sono elementi tipici del repertorio dell'arti-sta, fattori che sostanziano la paternità grassianapure per il ritratto in ovale, il brano di maggioreoriginalità e per questo meno decifrabile dal pun-to di vista attributivo. Cammeo incastonato in unmonumento in miniatura, I'immagine del giovanein mozzeffa violacea si dimostra eseguita con una
tenuta calligrafica distante dalla routine stilisticaimpiegata per il vicino gruppo sacro; se il coloredella sua veste e la croce pettorale possono farpensare al ritratto di un vescovo, mancano invece
altri attributi episcopali specifici quali mitra e pa-
storale: al momento attuale egli deve essere alloraconsiderato prelato di rango, meritevole di vede-re appoggiato alla propria effigie il galero cardi-nalizio di san Girolamo, suo patrono e forse omo-nimo; il blasone retto dal putto, finta scultura de-
corativa nella parte superiore del monumento.sembrerebbe riconducibile, più che alla famigliadegli Aleardi di Verona'', ai friulani Cortelazis"che, originari di Treppo Carnico, si stabilirononel Settecento a Udine'' e nella vicina Remanzac-
co''. Se di costoro ben poco si sa. almeno perquanto riguarda la prima metà del XYIII secolo' .
la loro provenienza dalla terra natale di Grassi si
1. \icola G,..;...: ì::::::di prelato con S.:;:: i-::e san Girolamc '.
, ,:, :-.:
colle:ion, t,::.::.:
. : R::-llÌ(r.-': . -ia:l-':.: .i- P.rcc.
, ::.',J;: l,.i.i/,;.
l . . R::.rn,.-r.,r l.l.i:zl.r Laisell
- . i ...
dimostra importante punto di partenza per la fu-tura identifi cazione del sacerdote immortalato inquesto piccolo capolavoro della piena maturitàdel pittore, caratterizzata - per usare un'efficaceclausola di Rodolfo Pallucchini - da "stabilità dilinguaggio in cui un colore vibrante e luminoso va
di pari passo con una forma arguta e di tenuta sot-tilmente rococò"'t.Di una fase precedente, molto più acerba e speri-mentale, sono altri due nuovi importanti ritratti diNicola Grassi, quelli della Contessa Marzia Caisel-
li de Pace (figg. 3-4)'' e di suo marito Conte Gict-
uan ni Giuseppe Carlo de Pace $ig. 2)'" . Dall'alberogenealogico della nobile famiglia friulana, gentil-mente messomi a disposizione dai discendenti, si
evince che il conte Giovanni Giuseppe Carlo dePace nacque nel 1652 e morì nel I722: poiché nel-la lunga iscrizione viene detto di sessantatré anni,il suo ritratto, come quello della consorte sessanta-
cinquenne, va datato con sicurezza al tlt5.Nate evidentemente come ovali, le due opere han-no un formato rettangolare almeno dal 1964,
quando furono fotografate, senza indicazioni diattribuzione stilistica, per conto del Museo Civicodi Udine'". Il mutamento delle forme originariecertifica che tutte le iscrizioni presenti su entram-be le tele sono da ritenersi posteriori, con ogniprobabilità trascrizioni di precedenti scritte forse
tracciate sul retro e ora scomparse. Quest'ultimodato si offre come prezioso punto di riflessioneper il problema della paternità artistica dei due ri-tratti: la firma "Io:s Vicentinus" leggibile nel Rr-
tratto del conte Giouanni Giuseppe Carlct de Pace e
il monogramma di difficile interpretazione a sini-stra del Ritratto della contessa Marzia Caiselli de
Pace vanno quindi intesi non autografi. Non esi-
ste, del resto, alcun artista di nome Giovanni \Ii-centino né ci sono testimonianze di un maestroproveniente da Vicenza a cui si possono imputarele tele de Pace''. La datazione sicura al 1715 esclu-de inoltre I'affascinante ipotesi, formulata di re-cente per il solo ritratto femminile", di trovarsi difronte all'unica prova in tale genere pittorico delcanonico di Aquileia Giovanni Giuseppe Cosatti-ni, seguace del Padovanino e ritrattista della corteimperiale a Vienna: questo poco conosciuto arti-sta morì infatti nel1.699". Nel panorama della pit-tura nel Friuli di primo Settecento subito il pen
siero corre allora a un grande specialista in effigicome l'udinese Sebastiano Bombelli, defunto a
Venezia nel 1719: in realtà i dipinti in esame nonriescono a collocarsi con convinzione tra le opereestreme bombelliane "dall'impaginazione psico-logica del personaggio sempre più stringata e sa-
gace"". Un risconro più puntuale per le immagi-ni dei coniugi de Pace è invece individuabile nella
Not,itri str Nicold Grassi 87
produzione squisitamente ritrattistica di Nicolò
Cassana, il maestro di Grassi partito da Venezia
alla fine della primavera del 171 I per I'Inghilterradove morì tre anni più tardi, soprattutto in lavori
come il Ritratto di luer Rosenkranz del 1709", che
"nonostante lo schema aulico e diparata,nella pa-
stosità del colore e nella úcchezza dell'impiantodecorativo indica lo sviluppo del gusto ritrattisti-co del Cassana in senso internazionale, forse a
contatto della ritrattistica francese""'. Che Nicola
Grassi fosse considerato I'erede dei modi cassane-
schi è assodato dalla testimonianza del collezioni-
sta Giovanni Castelli, il quale nell'autunno del
1711" ricorda a Venezia "il ritratto d'altre due
mie figlie fatto dal Cassana, et nello stesso per non
esservi più il Maestro, ho fatto fare dal Grassi suo
scolare il ritratto del Mio Putelo, et della signora
Lucia sopra la stessa tella"". Segnalato nel 1711
tra i pittori veneziani "comendabili soprattutti in
Ritratti"z", Grassi si dimostra infatti continuatoredi Nicolò Cassana nel Ritratto di Federico Marcel-
lcl" e in quello dí Alessandro Pandolfo", opere che
hanno come termine ante quem I'anno I7!2: "no-nostante il diverso colorito - acceso di rossi il Pro-
curatore, spento di bruna cenere il vecchio prete -e sebbene il primo abbia sguardo arguto ed occhi
pungenti e il secondo l'espressione di un vecchio
cadente e fastidioso", questi due ultimi dipintihanno in comune tra loro e con la coppia de Pace
"la condotta pittorica, i guanti dalle dita affloscia-
te, le mani con quelle luci trascorrenti"", elemen-
ti formali che si rawisano pure nel grassiano Rz-
tratto di SebastianoVarese - che, "facondo quanto
uno Strozzi"", dovrebbe essere dello stesso anno
dei Corcti de Pace - e nell'incisione con l1 Ritrattodi Andrea Zuccbi, del 1719", confermando quindila persistenza nella ritrattistica grassiana del se-
condo decennio del Settecento del "gusto del ri-tratto improuisé del Cassana"". Se il volto del
Conte Giouanni Giuseppe Carlo de Pace trova, nel-
la decisa ricerca del dato veristico, un modello nel
Ritratto di Alessandro Pandolfo, altre determinan-
ti somiglianze tra le opere citate sono rintracciabi-li nell'esecuzione delle vesti: medesima pare la cu-
ra nella definizione delle parti in pelliccia o rica-
mate, d'impressionante identità è, ancora, I'atten-
zione ai corposi lustri sugli abiti dei personaggi
immortalati, Testimonianza di fervidi contatti dicommittenza con la nobiltà friulana già nel 1715,
ben trent'anni prima dei ritratti degli Strassoldo
oggi presso la Pinacoteca Martini a Ca' Rezzoni-
co. i due dipinti de Pace appaiono importantepreambolo per I'imminente e rivoluzionaria espe-
rienza neotenebrosa di Nicola Grassi all'Ospeda-
letto. di cui la prima eco ritrattistica è il \'eccÌ:io
Jel \luseo Ji L'Jine .
Al primo periodo creativo dell'artista sono state ri-
condotte anche quattro tele nella sacrestia della
chiesa venezianadi San Francesco della Vgna, raf-
figuranti la Coruunione di san Bonauentura (fig. 5),
San Francesco confortato dall'angelo ffig. 6), San'
t'Antonio da Padoua con il Bambino (fig.l) e San
Giouanni da Capestrano (fig. 8)". Furono rese note
da Egidio Martini, il quale è riuscito, nonostante
uno stato di conservazione non perfetto, a ipotiz-
zarne I'esecuzione intorno al U18 per la "intona-
zione rossastra del colore, delle carnagioni ed an-
che, in parte,la modellazione più robusta del soli-
to" di indirizzo ancora cassanesco".
In seguito al restauro del 1987, i quattro dipinti so
l. \rcnl; G,-: : ?-'-:'-'della cont.'s.,1 )'l::::' -.--de Pace. a,:,.':, ..: , , :
tliL',liri,. e,,...-: ":: -
\rrili str .\'itt,lr ( ìrt:st 89
no stati anticipati, senza ulteriori commenti, da
Sandro Sponza ^l
l1 rc-I7 l5'", un parere da accet-
tare e approfondire.La presenza di Nicula Grassi nell'ambito della
chiesa di San Franccsco della Vigna non è una no-
vitzì. A parte la celebre Rebecca al pozzct nella cap-
pella dello Stellario, lì però approdata con le aitre
opere compagne in tempi relativamente recenti,
Anron MariaZanetri nel ll)) elencava cinque sue
Storic tli sar Frdncesco nella vicina scuola'", finoraconsiderate disperse ma forse da identificare pro-
prio con i dipinti di soggetto francescano ora in sa-
crestia. Infatti, in un documento riportato da Giu-seppe Gallo con data 17 B " dal Catastico del P. Girolamo da Venezia e dal libro della Maricgola della
scuola delle Stimrnate, si ha notizia della già com-
piuta decorazione della Cappella della scuola di
San Francesco della Vigna"t' successivamente sop-
pressa; una cronologia al 1713 circa per i quattroSanti francescani potrebbe essere allora proposta
vista la loro distanza drr opere dagli stilcmi spicca-
ti quali gli Apostoli dell'Ospedaletto (concorde-
mente rcputati della secor-rda metà di quel decen-
nio) e anche in virtù della contiguità stilistica con
le altre operc sacre riconosciute a Grassi a tali an-
ni: la pala di Cabia d'Arta del 1710" e, soprattutto,
la Marlonnt del Musco cli Padova in cui una luce
diretta evidenzia il "forte risentimento plastico
della figura sul fondo" ed è deciso il "contrasto tra
le partiture chiare e scure delle vesti, il senso dispessore conferito a queste ultime per un panneg-
giare largo e pesante, il contorno cor-ne ondulatodcl volto"''.Rispetto alla tela di Nicola del 1710 - omaggio
9. \r.t,:l; C'.c Pruc['rtz.tCt.iiD:,,1rl. \;.r,..: (;c'Ceriti 1,,
90 \ot'it,ì tt Niuút ('rdsst
'.:, ..; (,-'.:r.r,'. \[adonna-- l--r::::::.. c isanti..: . G.rlÌo E1ti,t. cl:tL,s,r
.. '. '.;
' : Ii::'f:.
. ::-ìJJ:o nrrschilc.
; . _;.. \-.,:-;,1;t1l11yg).
provinciale al capolavoro neoveronesiano di Seba-
stiano Ricci dipinto due anni prima per la chiesa
veneziana di San Giorgio Maggiore - la Coruunict-
fte di sail Bctnauentnra, San Francesco coftforttttodall'angelc.,, Sant'Antonio da Padoua con il Batnbi-
no e San Giouanni da Capestrano possiedono un
respiro compositivo più maturo e una gamma lu-ministica decisamente meno accesa, staccandosi
così, seppur di non moltissimo, dalle due interes-
santi tele conla Matlonna con il Barnbino (di colle-zione privata" e presso il Museo "Luigi e MicheleGortani" di Tolmezzo"), le quali invece stretta-
mente discendono dalla pala di Cabia.I Santi di San Francesco della Vigna, assieme ai ri-tratti dei coniugi de Pace del 1715, diventano pre-
ziosa testimonianza di una fase di Grassi interme-dia e interlocutoria, all'indomani dell'emigrazioneall'estero degli innovatori Ricci e Pellegrini ma pu-
re del proprio maestror'': se nella ritrattistica, I'ab-biamo appena visto, I'influenza di Nicolò Cassana
pare essere imprescindibile per tutto il secondo
decennio del Settecento, nelle tele della sacrestia
veneziana si rivelano suggestioni da altri artisti al-
lora attivi con successo, da quella di Nicolò Bam-
bini pittore dei Dolfin aYenezia e Udine, in notirapporti professionali con lo stesso Cassana", ad
Antonio Balestra, all'emergente e più giovane Ge-
rolamo Brusaferro - del resto chiamato in causa da
Giorgio Fossaluzza per la citata Madonna di Pado-
va" - che negli anni dieci del Settecento abbando-na il gusto chiaroscurale della fase anteriore, anco-
ra di carattere tenebroso, per un'intonazione dicolore riccesco, pur mantenendo nei primi piani
una "densa integrità formale baroccheggiante"'ritrovabile nei quattro frati del carnico.
A quest'identica fase creativa paiono spettare inol-tre le due sovrapporte della veneziana Ca' di Dioraffiguranti Consiglio e Prudenza (fig. 9)-" da una
parte, Giustizia e Carità (fig. 10)'' dall'altra, pub-
blicate con antica attribuzione a Francesco Fonte-
basso", restituite a Nicola Grassi e segnalatemi ge-
nerosamente da Adriano Mariuz. Partendo di
nuovo dalla pala del tz to fino alle tele della sacre-
stia di San Francesco della Vigna, si possono repe-
rire valide analogie sia nei robusti tipi (ancora una
volta di matrice cassanesca, ad esempio nel vec-
chio barbuto") sia soprattutto nella condotta pit-torica larga, attenta ai lustri dati a corpo e non an-
cora intaccata dai volumi violentemente chiaro-
scurati impiegati all'Ospedaletto.Solo infatti dopo il contatto con Gianbattista Tie-
polo "tutto spirito e ioco"" e la conseguente cono-
scenza della cultura neotenebrosa di Piazzetta e
Bencovich. il lessico iigr-rr,rtii-o di \icola Grassi
potrà essr.turere unir iisic-tnor.nir e rtna sostanza .le-
9INouità su Nicola Crassi
stinate a rimanere costanti grazie anche all'utllizzo
di tortunate sigle di chiaro gusto settecentesco.
A questo indirizzo può essere ricondotta la M*dottna con il Bambino e i santi Nicola e Gallo (fig.
11)" collocata sull'altar maggiore della chiesa par-
rocchiale di Egna, in Alto Adige, feudo degli Ze-
nobio dal 1.648"'. L'opera è stata pubblicata da El-
rio Mich come lavoro del 1751 di Antonio Vincen-
zi'-, il poco noto nipote dei pittori di Fiemme Mi-chelangelo e Francesco Unterperger, quale prova
della sua "totale dipendenza dallo stile di Nicola
Grassi"t*, maestro peraltro fondamentale specie
nei confronti dell'ultimo artista citatot''La recente ricognizione documentaria di Elisa-
beth von Lutterotti-\íelser nell'archivio della par-
rocchiale di Egna ha precisato che l'edificazione
dell'attuale altar maggiore della chiesa "awenne
nel 1746 (non nel 1750 come si riteneva finora) e
ce ne è rimasta una relazione molto accurafa da
tabbriciere Johann Baptist Fioreschky"uo. Dalle
carte si evince che effettivamente \a pala d'altare,
otterta daFranz Mantuan, risulta in quello stesso
anno "dipinta dall'artista Marco Antonio Vincen-
zi. che ricevette sette fiorini. In riconoscimento
per Ia donazione fatta, si riservò al signor Mantuan
e ai suoi discendenti un nuovo banco della chiesa,
vicino a quello del clero ed al portale""'. Llesigua
cifra pattuita a Vincenzi, ben poco rispetto agli
81i fiorini stabiliti per lo stuccatore dello stesso al-
tare'", spinge a rivedere questa importante notizia,
anche di fronte alla mediocre qualità delle altre
opere riconosciutegli come I'Ultima Cena di Ca-
stello di Fiemme, copia inerte dell'analogo sogget-
to di Grassi inciso da Philipp Andreas Kilian"'.
Lintervento documentato di Antonio Vincenzi a
Egna potrebbe essere quindi l'attestazione di sue
aggiunte pittoriche a un dipinto già portato a ter-
mine: un'op etazione simile a quella f.atta a Ronce-
gno, quando fu eseguita una "malaccorta aggiunta
di quattro cherubini" alla celebre pala di France-
sco Guardi"' . La Madonna con ìl Bambino e i sartti
\icola e Gallo del ll46 presenta infatti nelle parti
principali assoluta omogeneità stilistica con le ope-
re certe di Nicola Grassi dell'ultima stagione: san
Nicola, dal piviale mosso dall'aúa e dalla luce, èprossimo nel volto al veneziano San Francesco da
Pdola diuide in due un albero, databile con sicurez-
za a\ 1715-L746"'; i tesi lineamenti di san Gallo ri-compaiono puntuali nel San Vincenzo Ferreri diVilla del Conte, di norma collocato con gli altri di-
pinti della parrocchiale veneta aL17 4J""; la Madon-
na di Egna infine - nonostante sia offuscata da an-
tiche vernici e ridipinture - si dimostra debitricenella posa e nella definizione formale delle analo-
ghe tìgure presenti nell'Adorazione dei Magi del17-10 e nella pala di Fielis commissionata nel
174loì, nella Madonna e angeli della pieve di Ca-
stoía di Socchieve dello stesso l74lu" e nella Ma-
donna della cintura e i santi Fortunato, Ermagora,
Agostino e Maddalena di Colcerver di Zoldo da
collocare tra l7)9 e 1741"". Ad Antonio Vncenzipotrebbero dunque andare imputati alcuni ritoc-
chi che oggi appesantiscono la pala di Egna, ad
esempio nell'angiolotto sgraziato che regge gli at-
tributi del vescovo di Mira. A pochi chilometri da
Cavalese, dove sono conservate opere di Nicola
Grassi legate agli Unterperger, esiste dunque un
nuovo dipinto del carnico, realizzato per la parroc-
chiale del feudo degli Zenobio aggregati al patriziato veneziano dal I646'n, esattamente un secolo
prima la committenza di Mantuan.
La pala di Egna del t7 46 va posta quindi nella pa-
rabola finale del pittore,la cui ultima opera impor-tante può essere individuata nel Ritratto del cardi-
nale Daniele Dolfin oggi a Torino''. Protagonista
minore del Settecento veneziano, Grassi riuscì co-
munque ad avere una sua autonoma originalità. ri-scuotendo successo come singolare ritrattista ma
1). \ico!,í Gr.î.::
con il Bambino\at ion,i 1,,;:'s,:,"
anche come pittore specialmente sacro. Come altrimaestri del suo tempo fu un versato autore di 'te-
ste di fantasia"' a cui si legano con forza i celebriApostoli, alcuni dei quali con il monogramma di
Jacopo Linussio, conservati nel duomo di Tolmez-zo"; "figurazioni gustosissime tanto per I'atteg-giarsi dei vari tipi umani presi a modello, di rusti-cità contadina, quanto perl'arguzia con la quale ilpittore sa trarre partito dal movimento dei mantinel trascorrere delle luci, in un arricchimento divalori locali, che comporta un più raffinato impie-go di contrasti cromatici"tt, assumendo quasi lavalenza di interpretazioni in chiave tutta settecen-tesca dei ritratti di genere sperimentati dal maestroCassana alf inizio secolo".Tali doti erano d'altronde riconosciute da uno deipiù importanti collezionisti d'arte veneta dell'epo-ca, il maresciallo von der Schulenburg. Tra i cento-
no\-antano\-e ritratti e îeste di carattere possedutidal militare. solo cinquanraserre furono considera-ti "degni della galleria e per Ia maggior parre spe-
diti in Germania'": nell'Inuentario Generale delloGalleria del tZlS compare di "Nicolo Grasso
Quadro rapresenta Ritratto di Fra Pauolo Sarpiconsultore di Stato della Serenissima Republica diVenezia, tela spedita da Yenezia nel dicembre17)7"" . Da questa collezione proviene un interes-sante quanto malconcio dipinto attribuito finoraalla cerchia di GiambattistaPiazzetta da restituireinvece decisamente a Grassi (fig. l2)".In un'altraraccolta di prestigio, quella formara nel castello diDrottningholm dalla principessa di Svezia LovisaUlrika, la quale si awaleva dei consigli del conteCarlo Gustavo Tessin, era pervenut a una Madonnacon il Bambino (già. inventariata nel 1760) ora alNationalmuseum di Stoccolma e adesso resa a Ni-cola (fig. 13)".E a un mecenatismo di livello, di cui per il momen-to nulla si sa, vanno ricondotti infine i dipinti dipiccolo formato di Grassi che replicano, pur man-tenendo lo stile peculiare del carnico, grandi paled'altare della Venezia di primo Settecento: è il ca-
so del Ritrouamento della uera croce della Residen-zgaleríe di Salisburgo - "a metà strada tra il mo-delletto e la pala d'altare" - pubblicata da AldoRizzi, d'après la grande tela della chiesa di San
Rocco di Sebastiano Riccin", a cui va ora aggiunta la
Madonna con il Bambino e i santi Marco, StanislaoKostka, Luigi Gonzaga e Francesco Borgia delloStatens Museum for Kunst di Copenaghen (fig.
14)'', reputata finora copia autografa o perfinomodello preparatorio di Antonio Balestra per lapala della chiesa veneziana dei Gesuitin'. Nel di-pinto danese rimandano palesemente al carnico e
non al veronese I'intonazione generale dell'opera, ivolti e i panneggi dei vari personaggi raffigurati: si
veda a titolo di esemplificazione, i tratti di France-sco Borgia awicinabili non tanto a quelli nffigwa-ti nella pala veneziana di Balestra quanto a quellidi Giovanni da Copertino in estasi a Lesina", o igruppi angelici prossimi agli analoghi presenti nel-le note tele seriori di Nicola conl'Adorazione deiMagi el'Assunzíone, rispettivamente nei musei diStoccarda e di Udine. E una cronologia tarda puòessere stabilita pure per la tela di Copenhagen, ca-
pitolo particolare dell'attività di Grassi, da inten-dere probabilmente come una delle personali in-terpretazioni virtuosistiche su invenzioni di altrimaestri eseguite per un pubblico di conoscitori*'che di questo "rielaboratore intelligente di modiespressivi a lui affini" amavano il "fervido e gene-
roso"" carattere pittorico.
Uniuersità dí Trieste
Vtl
. ..: '--: ,:. \ladonna::::--:::-. c istnti
::.:-:r-.r.. KOStka.
-' ::::-r: Francesco. r:':: l.':. \tatent
Nouità su Nico/a Grasst 93
Lc ricerche nei paesi scandinaui sono state condrliie glazie allaBor-sa di studio Adriano Maríuz conccssa dall'Istituto Veneto tli Scien-:e Lettere e Arti per I'anno 2006.
A.M. Zanetti, Della Pittura Veneziana e delle Opere Puhblìche tle'Yenezìani Maestri Libù V,Yenezia 177I, pp. 117 ,450.' Cfr. G. Bergamini, E. Lucchese, schede in La Galleria d'Arte An-ttca dei Ciuici Musei di Udine,Ii. Dipinti dalla tnetà del XVII seco-lo dIXIX sacolo, a cura di G. Bergamini e T. Kbezzi,Yicenza200i,pp. 108-121 cat. 78-90, 255 cat. 2lJ.' G. Fiocco, Grassi, Nicola, in Allgemeines Lexileon dcr BildendenKiinstler, XIV, Leipzig 1921, pp.54l-542;Id., Niccola Grassi, "De-dalo", X, fasc. VII, 1929, pp. 127 -145:Id., Anrcru di Nicola Gras-.rr. "Rassegna marchigiana", 1-2, l%0, pp. 5-18; kl., Terzo contri-iruto a Nicola Grassi, "Le Panarie", XIII, novembre-dicembre1937, pp. )79-)87.- Sintomatica al proposito è la recensione alla mostra del 1961 di F.Haskell, Nicola Grussi at Udine,"The Burlington Magazíne", CIV,gennaio 1962, pp. 43-14.' Si veda il caso delle semilune (probabilmente lati interni di anted'organo) della chiesa di San Michele a Formeaso di Zuglio, a unpasso dalla casa natale di Grassi, raffiguranti Cristo nell'orto e Crírto deùso, assegnate al carnico nel I92l da Fiocco (Gra.rsz,
\ tcoltt . . ., cit., p. 5'11) e poi da tutti gli studiosi seguenti, da G. Gal-lo l\fostra di Nicola Gras.rz, catalogo della mosrra di Udine, Udine1961. pp. 8-9 cat. ,1-5) a<l A.Nzzi, Nicola Grassi, catalogo dellarrrostra dí Tolmezzo, Udine 1982, pp.2, 1,6, 18,10-11 , cat. l -,+ (conbibliografia). Nonostante il parere negarivo di L. Moretti, Nouzà.ioatnentaric su Niaia Gtassi, in Nicctla Grassi e ílRococò eilropeo,.\tti del congresso internazionale di studi (Tolmezzo 1982), Udine198{, p. 16, quello di V Sgarbi, Per il catalogo di Nicola Grassí (con:!tld prccisaziolte per il Ricci e un'aggiunta al Pcllegrini), in NicolaCrdssi e il Rococò..., cit., pp. 186, 188, e, piu recentemente, quelloJi G. Fossaluzza, scheda in Da Padouanino a Tiepob. Dipinti dei\[trsei Ciuici di Pat]oua del Seicento e Settecento, catalogo della mo-stra di Padova a cura di D.Banzato, G. Pavanello, A. Mariuz, Mi-lano 1997, pp.257 -258, c r.201, I'attribuzione a Grassi per queste:ele è stata mantenuta nella voce di M. Di Monte,Grassi, Nicòla,inDi:irtnaio Bíografico degli ltaliani, LVIII, Roma 2002, p. 666. St:ratta invece di opere in modo assoluto non riferibili allo stile di\icola (cfr. E. Lucchese, Nicola Grassi "pittore ualente nei ritratti",ín \lcola Grassi Ritrattístd, catalogo della mostra di Tolmezzo acura di E. Lucchese e M. Valoppi Basso, Udine 2005, p. B, n.1061. tanto da essere ora più coerentemente discusse all'internodel catalogo della giovinezza di Antonio Molinari (A. Craievích,.htonio Molinari, Soncino 2005, p. 135, cat. 1).
L. Iloretti, N ou i tà docu n e n t a ri e..., cit., pp. 15 -23 .
Come ad esempioja tela (166 x I 1l cm) con Vanerc ctl Enca ([ig.1{ I passata in asta il 16 aprile 1999 (Christie's Londra, Old MasterPicttrrc,s, lono 112) con attribuzione al carnico, e poi con la mede-sima paternità presentata dalle Anrichità Cosarini di San QuirinoPor<lenone) come "uno tra i più bei dipinti del Grassi che raffigu-
ra \tnere mentre consegna le armi ad Enea in partenza per la bìt-raglía" (Proposte di antiquariato in tnostra,Pordenone 20b0, p. 2 1 ):si tratra invece con ogni evidenza di un'opera tipica di FrancescoPolazzo, da confronrare ad esempio con le pale dèl 1737 dilJrgna-no e di Cazzago San Martino (cfr. L. De Rossi, Francescct Polàzzo.-\lontalcone 2004, pp. 22028, 226-227 ).' E. Lucchese, Nicola Gnssi "pittore ualente nei ritratti". . ., cit., pp.i ):
\tnezia, collezione privata. Pergamena incollata su tavola. Il par-:icolare supporto indica che presumibilmente I'opera sia stata inorigine la parte figurata di un diploma riferibile al personaggio ri-: ratto.
Cfr. G. Fossaluzza, scheda, in Da Padouanino a Tiepob..., cít.,pp.2)8-259 c^t.205.
Cir. .{. Rizzi, Nicola Grassi..., cit., pp.70-71 cat.20.' E. \lorando di Custoza, Blasonaio Veneto,Yerona 1985, ad no-
E. \lorando di Custoza, Blasonario..., cit., tav CDLXVI, pre-senta l'aquila in capo non coronara: nello Stenztnaio del TorsoL'dine. Biblioteca Civica "VincenzoJoppi", Fondo del Torso, ms.
1jS. cc. 1078r-1082r) compare sia questa versione dello stemmac. 1llE2r) che la variante con I'aquila coronata (c. 1080r, stemmaii Zuanne Correllecis cameraro dell'Ospitale di Santa Maria della-\lisericordia negli anni 1738-17)9, forse lo stesso il cui stemma,:Jenrico al precedente, è riprodotto con dara 17i0 alla c. 1078r). Il.(rsnome Correlazis risuha noto in Friuli anche nella variante Cor-:ehzzis: in Carnia è arresr:ìra la fbrma Cortolezzis: dagli schedaritriioienreschi della Biblioreca Cir.ica di Udine si appre;de. infine.;hq l: tornr.r Irrina è Correlecius.- L. C.rrunelurri. Llsrtla rtÌtre tl pr,nte. ll teccl:n pdlo::o c()t1/tlttdle.::. l.' P.;,);::,t C,t',i',,it!r' ,it L',/t rtc'. Dtll,t Loggirt Ji .\ icolò Lionello ol-.',,:. '.; .i.- R,;i";t,i:,it, D .1rr'11;q. Ldine 2006. p. 60: comntercianri.'-s..n!. iscri:ti lr: i ci:r.rJinr Jell'ordine popolàre di Udine nel
1.7J1" . Udine che sconpdle. . ., "Patria del Friuli", 5 marzo 1910, p.l, cita il palazzo udinese detto "casa veneziana", allora in corso àidemolizione, appartenuro "famiglia Cortelazis, da Treppo Carni-co, venuta a Udine nel 1700; famiglia che ebbe la cittadinanza udi-nese assumendo uno stemma che si trova conservato nel Museo.scolpito sopra la ucra del pozzo di casa: e cioè, un'aquila con coro-na sovrapposta a quartro corsi di rombi e che i cultori d'araldicacon termine tecnico chiamano losangato"; cfr. inoltre G.B. DellaPorfa, Mcmoric su le antichc casc tli Udine, a cura di V Masutti.Udine 1987, pp.271-27 5, c'ar.791. Per la vera da pozzo cfr. le fbrodei Civici Musei di Udine, negativi nn.3819-3852: lo stemma scol-pito è riprodotto nello Stemmario tlcl Torso (c. 1079r).'' Cfr. A. Tagliaferri, Uomini c tcrre. Storia di Remanzacco,lJdine2006, p.50, segnala che I'attuale casa Rigo del paese friulano ven-ne costruita per volontà della famiglia Cortelazzís nel 17.12: I'edifi-cio conserva tuttora sulla facciata lo stemma con "aquila con coro-na sovrapposta ad un losangato"."'Udine, Biblioteca Civica "VincenzoJoppi", Ms. Del Torso, Gc-ncabgie popolari, 1.07. Cortelazzis (documenti rratri daeli archividel duomo di Udine, della parrocchiale di Remanzacèo e dalleCarte Venerio-Raccolte del Torso della stessa biblioteca civica udi-nese): il primo Cortelazis menzionato nasce nel 1721; I'unica reli-giosa della famiglia lì ricordata è Caterina, nel 1802 professa do-menicana (cfr. G. Valentin elli. Bi bl iogrnfia de I F ri t r I i. Vènezîa 186I.p. .111). Nel manoscritro viene segnalato di nuovo che i Cortelazis"possedevano la 'casa veneziana' già Susana in via Rialto a Udine.Nel 1876 il comune la comperò da fu Osvaldo e dai creditori diFrancesco suo fratello, il quale fu dichiarato fallito e condannatoalla_prigione in seguito alle sue malversazioni dei depositi di dena-ro dei suoi clienti. Causa dellc suc dissipazioni la funesta piìssionedel giuoco del lotto". Cfr. inoltre L. Cargnelutti, L'Ist,l,i oltrc ilpon tc..., cit., pp. 56-58, 60-61.'' R. Pallucchini, La pittura nel \/eneto. ll Setteccnto. I. Nlilano1991, p. 515 .
'' Olio su tela, 110 x 90 cm. Pavia di Udine, collezione pritara. Re-ca le seguenti iscrizioni: in alto a sinistra "Nlartia Com. Cais.ielliIo. Ioseph Caroli"l in alto a destra "Con.ritis De Pace / uxor aeta-tatis sue / LX\r"; sotto quest'ultima iscrizione una sorta di tìrma inmonogramma "Io.s N. [o \'] G.[o C.]s P".' Olio su tela. 110 x 90 cm. Borgosesia. collezione privara. Reca leseguenti iscrizioni: in alto a sinistra "Io. ioseph Carolus ComesdePace i S.R.L": in alto a desrra "Lib. Bar. De Frid. Ensberc.ìe-tat. sueLXIII" e-pocopiu sorro- "lo:s Vicentinus pinriÌr-'.
1 5. Fntncescrt Pr'..:::Venere ed Enea. C,,priuata.
94 Nouità su Nicola Grasst
Lopera,- recentemente restaurata, presenta antichi danni e lacunesu runa. la superficíe pittoríca. La pìù vistosa integrazione è loca.liz-zata dal gomito sinistro alla parre esrerna in pelliccia della manicadel personaggio, un'altra còrre invece ue.iicalmente sul fon,loneutro, a sinistra del volto.'" Udíne, Museo Civico, Archivio fotografico Friuli, nesativo Mu_seo 5159: il dipinto allora si trovava nel capoluogo friulano pressoil conte Odorico de Pace mentre I'altro era già a p"ua Jiù,lin.,lalconte Bernardino de Pace., Per quanto riguarda la presenza del nome Giovanni in entrambele iscrizioní, si ricordi che Nicola Grassi venne battezzaro comeGiovanni Nicola: cfr. G. GaÌlo, Rettificha su Nicola Grassi,,,SotlaNape", X, 1, 1958, pp. 16-17.
.' Q, Be5Samini, Da Grffini a Tiepob: ritratti e rítrattisti in Friuli,in Nicola Grassi Ritrattista..., cit., p. 26." Per un.profilo, cfr. G. Bergamini, Cosattini (Cosattino), Ginsep_p e,
_in - A I I ge n e i n e s Kù n s t I e r-Le x i ko n, 2 l, Mun chen Leip zig 7999,
p.3)8." R..Pallucchini, La pittura ueneziana del Seicento,I, Milano 19g1,p. 308.
" Hillerod, casrello di Fredericksborg, Museo di Storia Nazionale.' R. Pallucchini, La pittura ucn.'zianà....cit.. p. 31 L' I Z?yuBoccazzi, Conrributo alla ritrattistiia di Nicotò Cassana,"Arte Veneta", XXVIII, 1984, p. 101, n. 6." Cfr. F. Zava Boccazzi, N icolò Cassana a Ve n ezia,,,Atti dell,Istitu-to Veneto di Scienze, Lettere ed Arti", CXXVII, 197g-1979, p.622.t
.V Coronelli, GuiJa tle' forestieri sacro-profana per r.tsseruare il piùrtgtnrdeuolt' nc,lla città di Venezia, Venezia I7 I l. p. 10.' Venezia, Gallerie dell'Accademia; cfr. E. Lucchèse ,Caralogo dcl_le opere, in Nicola Grassi Ritrattista. . . , cir., pp. 64-67 . cat. I.' \'enezia. IRE; cfr. E. Lucchese. Catalog,'jcll,,operc.... cit., pp.68-7 I, car. 2." L. I\{oretti, Nouità docutnentarie.. ., cit., pp. 16-17 ." G. Fiocco, Niaia Grassi, Udine 19ó1. ' ''- Cfr. per I'incisione e per il precedente Ritratto di Scbastìano Va-rcsc,. E. Lucchese, Nicola Grassi "pittore ualentc nei ritrattí', . .., cit.,pp.1{-15.' R..Pillucchini, La pittura ncl Venctrt....cir.. p. 518.
. Cfr..E. Lucchese. Catalogo dellc opcrc.... cii., pp.72-75, cat.3:,la collocarsi in vicinanza Ael Sant"Antonio do PàJ,,ro con GtsùBawbino, nello stesso museo. datato 1722.'- Olio su tela, 190 x 100 ciascuna, sotto ogni santo è tracciato ilnome in caratteri capitali.''.E. Nlartini, Prohlemi e precisazioni su tlipinti e tlisegni dí JacopoJlarieschì, Gaspare Diziani e Nicr,tla Grassi,' "Norizie dà palaízo Al-bani". XIII, 2., 1984,,pp.90-l0J: come dimostrano le riproduzionia corredo dell'articolo, le quattro tele erano allora moltà alterate er elate nel colore da fortissime ossidazioni. Lo studioso, inoltre, in-dii'idua già in tali opere alcuni accenti tipici del Grassi più matu-ro. nella nervosirà della forma, nella rípologia dei prolili dei sanri enel Gesù bambíno della tela con san Antònio, cÉe ricorda quellodel sopra citaro Sant'Antonio da Padoua del Museo di Udine data-to 1"i 22. Lattribuzione e la cronologia sono ribadite dallo sresso E.-\lartini. Pithrra ueneta e altra italiana dal XV al XIX secolo,Rjmi-ni 1992. p.352.' S. Sponza, Castello, Decorazioni Istituzioní di Ricouero ed Educa-:iotte. tn Restaurì a Venezìa 1987-1998, Milano 2001 , pp. 41, g-19.Questo parere è acceîrato da S. Onda, La chiesa di 3àn Froncesco.ielld Yigna. \renezia 2001, pp. 126, t29.' .{..\1. Zanetti, Descrizione di tutte le pubbliche pitturc della città,ii \ ene:ia e lsole circonuicine, Venezía 17 33 , p.2i 6: ,.Cinque
qua-Jri con miracoli di S. Francesco tli Nicola Giassi cioè li due piimielll porta. elasciando il primo, che seguita, gl'altri tre".- G. Gallo. trIo s t ra d i N ico la Gra s s i..., cit., p. 3. L. Moretri, N r,tu i t à,locirrue!tdrie..., cit., p.20 ha segnalato inojtre che delle copie del1708 di alcuni documenri scritriln Carnia relativi alla famiglia delprttore risuhano indirizzate a due religiosi francescani di Vinezia,di nome Bonavenrura e Serafino Grasii: se è "possibile fossero pa-renri di Nicola". è allora alîretanro plausibile che quesri due r;li-uio:i posseno essere stati pure suoi còmmittenti.-' Cfr. .\. Fjzzi. Xicola Grassi..., cir., pp. )6-17 , cat. l. A mio pare-re l opera carnica. oggi molto compromessa da una storia conser-variva infèlice tcfi E. Lucchese, Níatla Grassi ,,pittore
ualcnte ne,ir:!Li!lr..... cit.. p. 11) r'a identicata con una rappresentazione del-\t \l.i,io,t,ra crttt il Bdnbino t'i santi Gctttardo, Aìrnrio tla padoua e(r, .r44 -\('.a///:i?i ú. quest ultimo patrono del committente Gre-rtrrio Leschiurra rprobabile parenré Jella famiglia notabile di Zu_clir. Cirrnico che possedera il palazzo ora se,le Jel locale Àluseo.\rchcologico r
'' G. Fossìluzza. scheda in Dd Pd rloL,r rt i rt o,r Tiepo I o....cir.. p. 2)7..-:r. l"{. ConironranJo.poi il !r,r B,)tt,rr'(.'ttt!r,ià \enezi,r rfig. 5,e:l '.;scoro Gort.lrdo nell.r plla del t;1tì. si nora lo r,.r.o n.,ò,lo,li. :.i.:- r. i.rpo Jcl pcrson.rruio. J.rl mcJesrnro proiilo.rJunco rir.r.i-:::.. .-:- :onio. J.r une situazit ne Ji luce Jireiì,r .r un.r riù con:r;,
stata da ombre, con le vene del collo tirate dallo sforzo." Lopera venne presentata con la corretta datazione durante ilcgng_re_sso del 1982 (cfr. Moreni, Nouità document.lrie..., cit., p.l6: V Sgarbi. Per il catalogt di Nicola Crassi.... cit.. p. lg6, I'accàsta a modelli di Sebastiano Ricci, come la Sacra Faiiglia confrnta_y dagli Angeli de,lle collezioni reali inglesi, urgornEniu.,.lo .h."certamenre più che il Cassana, suo traàizionalÉ maesrro, porè iiRicci, che sarà anche la guida per il rinnovato cromatismò ed ilprogressivo schiarimento della iavolozza del Grassi") e subito se_gnalata da A. Rizzi, Nicola Grassi. . . , cit., p. i ó, . pubbii.utu d, EManini, La pittura del Settecento ueneto,Udine tgSZ, come di col-lezrone privata veneziana. Lattribuzione al carnico è stata accetta_ta anche da G. Fossaluzz a, in Da padouanino a Tiepokt. . . , cir., p.2r7." Segnalara come replica autografa con varianti della precedenredurante il congresso del 1982 (cfr. Moretti. Nouità Jttcutncntaric...,cit., p. 16; V Sgarbi,Per il catalogo di Nicola Grassi...,cit., p. lg6)I'opera. di q.ualità superiore, è Jtata riprodoma fotograficàmentenella terza edizione dí M. Gortani. L'art,,poprtlarc in Carnia. Il Mtrsrc Canico delle Arti e Tradizioni popola;i, lJdine 2000. D. 34.'i Cfr. F. ZavaBoccazz| Nora per'íl Grassi a Ventzia. Lo',,Reb"crn"di S. Fnncesco della Vigna, ii Nìcola Grassi e il Rococò..., cit., p.28." Cfr. R. Radassao, Nicolò Banbini "pitrorc pronto spedito ctÌ uni_yylal,e'l, "Saggi e Memorie di Storia dell'Arte", 22, t998, pp. 117 -139,. 14 I. 1 42, 16) - 164 cat. 62, t6i - 166, cat. 66-7 i." qf.. G. Fossaluzza, in Da Padouan i no a Tiepokt..., cit.. o. 25-/ .
' R..Pallucchini . La pitrura ncl Venero.... cit.. p. 7g.' Olio su tela. 50 x i20. Venezia, IRE, inv. n. i0.'' Olio su tela, 50 x 120.Yenezia,IRE, inv. n. ,17.
'_M. Magrini, Francesco Fontebasso (1207-1269),Vicenza l9gg, p.189, cat. 170." Assimilabile a certa 'rirrarrisríca di genere'frequenrara dal mae-stro-di Nicola Grassi, cfr. F. Zava Boccazzi, ,,Istàntunee
familiari,'di Nimlò Cassana, " Ane Documento", 13, ig99, pp. ZZS-ZIS."-V Da Canal, Vita Ji Grcgolio Lazurini lI7)2j,'a cura di G.A.Y*Shli.Venezia 1809, p. 31.Il ciclo di pennacchi e sottarchi di_p^inti della chiesa veneziàna di Santa Maria dei Derelirti, uulgoOspedaletto, è stato oggetto - come si sa - di un not"uole óibaù_to critico, ben riassunto da S. Sponza, La dca.trazionc Dittorica dcl-la chilsa Jell'OspcJaletto terminala con la pala ìsepuiia in occasu,nc dclla bcati[icaziont'di S. Girolamo,in San Girolinc, Miatti a Vc.nezia. Nel 5" centcnario della nascita, Atti delle celebrazioni tenu-tesi nella chiesa di Santa Maria dei Derelitti, Venezia 19g6, pp. 1g-6l: ld., Dtlla decorazione pirtorica della chiesa Jell'Osp,,,laic)ro ,,Ji.l
-prohten_a dclla p,rima auiuirà di Ciatnhartista Ticpttio,.'Ani del.I'Istituto Venero di Scienze, Lettere ed Arti,', CXLV 19g6-19g7,pp.213-2)4. Per quanro riguarda I'attribuzione di alcuni di dettidipinti.a.Nicola Grassi, cfr. S. Lunardon, G. Ellero, Guida al_l'OspeJaletto. Itinerario storico, artistico e musìcale della chiesa egspedale dei Derclitti, Venezia 2005, pp. )7 -tg e, ultimamente, E.I ucchese, Nicola Grassi "pittor?..., cit., p. t+, nel quale si accetral^a parernità del carnico per i soli Sa,n Marat. San Luta, San Filippo.S.an^Ciacomo il minore, respingendo così i pareri (G.M. pilo Njco-la.Grassi..lacopo Anigoni, Jacopo Marieschi le altril; aspcti c lrro.bleni della pittura ucnezian"a dell St'rrccento nilla pro'spcitiua dci R,r-cocò europeo,in Nicola Grassi e il Rococò..., cii., pp. 15ó-159; R.Palluc_chini, la p ì t t u ra n e I Ve n e t o. . ., cit., p. 5 12 ; L.' De Rossi, F ra n -ccsco Polazzo; . . , cit., _pp. 3 5. 132- lj3 . l j,6 di .'assegnare
come pri-ma opera di Nicola Grassi all'interno della decorazìone della cÈie-sa veneziana i Santi Pietro e Paolo (in cui è stata notata la dataI 7.1 6 ), teia per Ia quale è meglio indirizzarsi verso il giovane Tiepo.lo" (probante sembra il confronto tra le illustrazioni sempre in9.M. Pilo, Nicola Grassi..., cit., pp. 148-149)." Olio su tela. 280 x l.l0 circa: la'Madonna in gloria ha ai suoi pie-di i santi titolari nel Serrecenro della chiesa di Egna {E. von Lutre-rotti-\X/elser, .tlo ria ecclesiast ica di Egna, in Egni. Atto Ad;ge - Sud-1ir2l9, a.cya di H. Gritsch, Egna l9-b7 , p. 2i0) ora dedica"ta al so-Io Nicola. La superficie pittorica del dipínto si presenra coperra dauno denso srrato di anriche vernici e polvere: à causa dellì formamistilinea del telaio si regisrrano, inolire, danni nelle zone angola-ri del dipinto con conseguenti anriche ridipinture." Cfr. G. Tengler, Storii'Jel nedio"ro e dàll'inizk dell'euo modar-n.o,in_Egna , cit., p. 115: Egna faceva parte del feudo ereditariodegli Zenobio, tirolari del disiretto giudiiiario di Enn e KaldifT, ri-coprendo I'importante ruolo di porìo sull'Adige per il traffico dellegname verso la Serenissima. Un inrenento dèi ioblll veneziani aEgna dara_ al 1729, quando comprarono e abbellírono la cosidder-ta,Sreinerhaus, cfr. E. E-gg. L'arte a Egna, ín Egna..., cit.. p. 3)J:"decorata con sremmi aiirescari recanti la dara ùi acquisro da par.te del conte Carlo Zenobio. essa fu adibira a sede del Giudizìo".Cir. inoltreE. Tolomei. Pttri:i Lc,rtcti irt \hl J'AJrge. Zettobio e.A!-,!r r::r. ---\rchivio per I'.{1to .{dige'. XXXVII. 19.+). pp. 2 1 9-28;.' E..\lich. (r,1!, r,1!1;!;,.i:tt.)ar,ìt'.,,.,ii l,t,tLt; ,;t11,ì ir.i,it:.;,,,;, t',;.,'. .:.:", .., -.: L',.:, ".-. "-,, .r',.. i.,,.,...,. \f . ;.-'-;.-: 1, it,.,,,.,',t.,
Nouità su Nicola Grassi 95
169t-1758), caîalogo della mostra di Salisburgo, Trento e Cavale-se a cura diJ. Kronbichler ed E. Mich, Trento 1995, pp. 169-170.L'artribuzione a Grassi e la datazione 1751 sono state ribadite sem-pre da E. Mich, Presenze rccocò nella cultura figuratiua del Sette-;cnlo trentino fla remore barocche e aspirazioni classiciste, in Il Ge-,:io della Alpi. Capolauoi pittolici del Rococò eulopeo, caralogodella mostra dí Gorizia a cura di A. Antonello, Udine 2000, pp. 62,t-{. e da E.Egg, L'arte a Egna..., cit., pp.328,354-155. Lo sressoE. llich, In margine alla pala di Roncegno, in I Guardi. Vedute, ca-:ricci, feste, disegni e "quadri turcheschi", a cura di A. Bettagno, Ve-nezia2002, pp.7-8, è tornato su questo dípinto, considerandolosempre di Vincenzi (? , post 77 18 - Borgo Valsuga na, post 17 84ìr,
^f-termando che l'opera è "firmata e databile al, 175I ca". A un esa-rne diretto dell'opera non è stata individuata alcuna iscrizione.' E. Nfich, In nargine..., cit., p. 7.' Si veda I'uso evidente di tipologie grassiane nella pala di France-so Unterperger del 1741 per Lavis (specialmente nel san Giovanni\epomuceno), in alcuni volti della Cena in casa di Simone pressoil convento cappuccino di Trento (cfr. E. Mich, in Il Genio delle-{.pr'.... cit., pp. 172-1751nonché nel dipinto per la parrocchiale di\ìrena (cfr. E. Mich, Presenze rococò..., cit., p.61, in partícolare:ella iigura della Madonna). Sulla presenza ab antiquo di opere di; Ja ,r..icola Grassi a Cavalese, cfr. i documenti pubblicati e analiz-z.rri da E. Mich, Copie, repliche autografe..., cit., pp. 169-170; E.-\lich. in Il Genio delle Alpi...,cit., pp. 170-171 ;E. Mich, Il ruokt.i,.' c'olle:ionismo priuato nella fornazione della pinacoteca della),".;yífica Comunità di Fietnme a Caualese, "Studi Trentini díScienze Storiche", LXXK-LXXXII, sez. 1I,2002-2003, pp. 166-lti. Su questo artista si veda il recente contributo di E. Mich,F,-;,tct,sco Unterperget sacro e profano, "Nuovi Studi", 9-10,2004-l, ltrt. pp. 269-275.
E. r'on Lutterotti-\X/elseq Storia ecclesíastica di Egna..., cit., p.l,tf: 'Dopo aver constaîato che I'altar maggiore era in cattivo sta.:o per la sua vetustà ed altri difeni e danni, si stabilì di farne uno:uolo 'in gesso, di bell'aspetto' e di eseguire il gradino ed il pavi-:rento del coro in marmo rosso. Alcuni signori e specialmente il:=,.'.do curato Leopold Payr zu Kaldiff ed Altlehen diedero sponra-:írmente un contributo'per quel progetto salutare e caro à Dio'.I- .'lrntratto firmato con lo stuccatore Hannibal Pinter di Bolzano::eledeva il pagamento di 815 fiorini a lavori ultimati; egli fu coa-jiurato dallo scalpellino Teodoro Berodotto di Mori per lo scali-:o. ,Jal capomastro Dominicus Pichler, dal muratore Jakob Pfal-:.r'.rner. dal falegname Josef Weyhrer, dall'indoratore Giovanni Co-.:.rnzi di Faver; fornì la calcina Andreas Kainz di Trodena".
E. r'on Lutterotti-\felser, Storia ecclesiastica di Egna..., cir., p.:,,,1.
' \'edi nota 60.Cfr E. ì\lich, in Il Genio delle Alpi..., cit., pp. 180-181; E. Mich,
i,; 'ì,1vging..., cit., p.8 sg.: anche le opere più tarde assegnate aVincenzi non paiono stilisticamente e qualitativamente confronta-rili con il dipinto di Egna.
Ctr II. ÌVluraro, Asteischi guardeschi, in Problemi gaardeschi,-ìrri del convegno di studi (Venezia, 1965),Yenezia 1967 , pp. 161--69: la citazione è di E. Mich, In margine..., cit., p.7.' Cfr. R. Privato, 1/ ciclo pittorico settecentesco della chiesa di S.
F,:':cesco di Paola, "Venezia Arti", 5, 1991, pp. 150, 152.Resi noti da F. Valcanover, Giunte a Nicola Gzassr, "Arte Vene-
::". XI. 19i7. pp.220-,222:la datazione al 1747 proposta da que-s:o srudioso, l'anno della consacrazione della chiesa veneta, è siata::essa in dubbio ultimamente da L Tonin, Chiesa parrocchiale di1.':..!,i ,lel Conte (Padoua). La storia - Le opere - I suoi min^tri,P^do-',r :0t12. pp.63-66,81-85, il quale, pur accerrando la proposta di\.-eìcanoter. afferma che "non vi sono riferimenti storiói pèr stabi-.ir< in quali anni_questi dipinti siano giunti a Villa del Cónte; pos-:irmo avanzare due ipotesi: o don Carrara [vicario fino il 18 óno-::e l7-{61. per decorare il soffitto del Sacro edificio commisionòji:erramente all'artista le opere, che poi vennero applicate dal suo:.r.cessore don Zaneni, oppure giunsero ín parrocchia alcuni de-.-erni dopo la morte del pinore, acquistate da commercianti", ri-.^..:J.rndo a tale proposito che Carlo Ronconi, r'icario della chiesa:.:- 1E08 al 1827 prima di divenire canonico della cattedrale di Pa-jorr. "era cugino del nobile veneziano Girolamo Molin famoso:..llezionisra e mercanre di opere d'arte".'
Cfr. .\ fuzzi. \icola Grassi..., cit., pp. 1{{-1-15 caî. t7, 1j0-li1..r:. bù. Per quanro riguarda la pala di Fielis, G. Fiocco, .\ricolaC,.;:s: ... cit.. pp. -128. {10. l-+-+. ha pubblicaro alcuni documenti:: .-ui l'alrrimenti oscuro pitrore carnico Anronio Venturini (defì-:-::o.i nelle cane "allielo" di Grassi e membro dell'Accademia diBt ltrsnJ, emerge come importante mediatore. ruolo che potrebbe
-:ere sraro ricoperto tbrseanche da .\ntonio Vincenzi cin,1r. rn-:.: qiu t.r-rdi in virru dei probabilissimi rapporri del ci rr Unterper-:.: .on \icoh Grassi a \tnezia, Riguardo aLl'.-1,,rora:ione ,lei i[agi;:- 1-r,'r. cfr. E. Lucchese. L-4,Jr'r.i:ic,t:e ,iet \It3i e gli tltrt ,!ipirlt;: ,\':--"..: G'.;ii.' '.'.-' C::.';: -\f:'-t.,i i L-j,r,,. "L dine. Bolletrino del-.. (-i,.:c:e ]s:ituzionl-. 1ll.:rlt-lb.in corso di srempa'.
* Cfr. E. Lucchese, Nicola Gmssi "pittore ualeflîe nei litratti"...,cít., p.22."'Presentata da A. Ruggeri Augusti, Un'opera sconosciuta di Nico-la Grassi, "Critica d'arte", XXI, 14r, 1975, pp. 66-68, cone M*donna in gloria che potge lo scapolare ai santi Maddalena, Lorenzo,Ermagora e Fortunato, la pala raffigura in realtà la Vergine che stadonando la propria cintura (cfr. F. Vizzutti, Le chiese della foraniadi Zoldo - Documenti di storia e di arte,Belluno 1995, pp.484-487,cat. 1; G. Bergamini, scheda in Patriarchi. Quindici secoli di ciuiltàfra l'Adriatico e I'Europa centrale, catalogo della mostra di Aquile-ia e Cividale del Friuli, a cura di S. Tavano e G. Bergamini, Milano2000, p. )09, cat. XXIII.T): se i due santi a sinistra sono i patronidella chiesa di Colcever, il vescovo scrittore al centro può allora es-sere individuato non con Nicolò o Tiziano (come proposto dubita-tivamente daYizzuri nel 1995) ma con Agostino, devoto al cultodella cintura di Maria. La chiesa fu edificata su commissione dellafamiglia Pancieratrall lTJ9 e il l7 4l (cfr.F.Yizzurti,I-a pittuta nelbellunese na Seicento e Setteento, in L. Boranga,.4 ntonio Lazzarinipittore bellunese del Settecento, Belluno 1995, pp. 19-20\, data acui ancorare anche I'esecuzione della tela di Grassi."'Cfr. Famiglie Venete diuise in tre classi,Yenezia 1774, p.27.t' Conservato presso il Centro salesiano di documentazione e po-polare mariana, ínv. 200 (cfr. E. Lucchese, Cataktgo delle opere...,cit., pp. 86-89, cat.7) m^ provenienîe dalla Carnia, dove fu com-prato (a Terzo di Tolmezzo dalla famiglia Cescutti come segnalatosul telaio dell'ovale) da Giuseppe Gallo." Cfr. ad esempio 1l suo Ragazzo appoggiato a un plifito recente-mente esposto: R. Mangili, Catalogo delle opere,inTeste difantasiadel Settecento ueneziano, catalogo della mostra di Venezia a cura diR. Mangili e G. Pavanello, Yenezia 2006, pp. 92-93 , cat. 15 .
" Cfr. A. Rizzi,Nicola Grassi..., cit., pp.68-69 cat. 19,80-111 car.25-41,722-12) cat.46." R. Pallucchini La pittura nelVeneto..., cit., p.515." Cfr. E. Lucchese, Nicola Grassi "pittore ualente nei ritratti"....cit., p. 18.
"'A. Binion, La Galleria scomparsa del tnaresciallo uon der Scbulen-burg. U n mecenate ne lla Venezia del Settecento,Milano 1990, p.7 6.
'7 A. Binion La Galleria sconpalsa. . ., cit., pp. 208, 265; cfr. inoltreE. Lucchese, Nicola Grussi "pittore ualente nei ritratti"..,, cir., p.18.
'" Olio su tela, 70 x 54, presentato da Sotheby's Londra, OltÌ l[a-ster paintings,9 dicembre 1987, lotto 215, con il titolo di Monttco.Recava in alto a destra, tracciato con gesso, I'indicazione, fbrsed'inventario, "76 R"; la superficie pittorica risultava coperra da treapplicazioni in carta giapponese al fine dí arginare cadute di colo-re. La cautela esige di non identificare questo personaggio, dai ge-nerici tratti somatici simili a tanti Santi e Apostoli di Grassi. conPaolo Sarpi, personaggío storico di cui la fisionomia era ben nota.''' E. Lucchese, Nuoue opere sacre di Nicola Grussi, " Arte in FriuliArte a Trieste", 24,2005, pp. 44-45 (la numerazione delle note èerrata). Si segnala che una copia della Madonna con il Bdtnbinrtsvedese è conservata a Torino, presso il Centro salesiano ( riprodot-ta da M. Mona, Nuoua donazione dei Fratelli Gallo al lluieo \h-riano, "Mal:ia Ausiliatrice. Rivista del Santuario Basilica di llariaAusiliatrice - Torino", XXV,9, otrobre 2004,pp. {0-{l ): pubblica.ta da G. Gallo, Nicola Grassi inedito,in Veneiia e I'Erropt. Atti delXVIII congresso internazionale di storia dell'arte (\'enezia 19)i r.
Yenezia 1956, pp. )50-)54, come autografa di Nicola, il dipinropiemontese nel confronro diretto con I'opera di Stoccolma iirelale già precedentemente intuibili carenze qualitatii'e che la scheda-no come lavoro di seguace, certificando in modo detinitivo l'anri-buzione della rela del Nationalmuseum. Lopera sr.edese. pur regi.strando leggeri danni e abrasioni della supertìcie pirtoriia. si di-mostra di un livello esecutivo rale da giustificarne la presenza nel-la collezione di Lovísa Ulríka.-" A. Rizzi Alla Residenzgalerie di Salisburgo rn Sebastiono Ricú ,!trteno e ufl Nícola Grassi di pizi, "Prl,oziPot'ijesti Umjetnosri u Dal-maciil" , )) , 1992, pp. )7 5- j81
.
"' Inv. 126. Olio su tela, cm 1-15 x 97.-' Cfr. H Olsen, Italian pnitttings and sarlpture in Deuuarè. Co-penhagen 1961, pp. 36-37 M.Polazzo. Antctttio Bdlestrtt Pttortlleronese 1666-1740, Verona 1978, pp.59,62. car. I lper un erroretipografico le fotografie sono invertire rispetto all'indìcazione geo-gratica delle opere): L. Ghio, E. Bacchesóhi..lrironio Btlc'str,;.in Ipittori berganascbi dal XIII al XIX secolc,. Il Settecerilo. II. Bersa-mo 1989. p. 19-1. cat. 16." Cfr. E. Lucchese. Episoli .li pittutit L.eileaidtîLt in lstri,; e D,;.'.;.;-:rir. "Arte in Friuli Ane a Trieste". 18-19. 1999. pp.2i1-2i2. Unulreriore contronro può essere istiruiro pure con il san Gillo dell.rpala di Egna appena discussa.'Cfr A. Kzzi. Alla Resirlen:galerre.... cit.. p. l7E: è -r.erosin:leche \icola alternasse queste incursioni al prodono auronomo c(r.me un ,rtierlls,re",,c,/l o che lavorasse per qualche stravagJ.ntè --r,.--,.'.;.'-rc .'rt" R. Pallucchini. L; :::::,,;';1.' \',.';, ;,'....cir.. p. 52r-r.