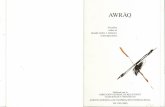Musica e spettacolo nel «Diario napoletano» di Carlo de Nicola (1798-1825), in "Fonti musicali...
Transcript of Musica e spettacolo nel «Diario napoletano» di Carlo de Nicola (1798-1825), in "Fonti musicali...
MARINA MARINO – MUSICA E SPETTACOLO NEL «DIARIO NAPOLETANO» 105
Musica e spettacolo nel «Diario napoletano» di Carlo de Nicola (1798-1825)
MARINA MARINO
Da quando venne alla luce il corposo manoscritto rilegato insei tomi di complessivi 2385 fogli conservato presso la So-cietà Napoletana di Storia Patria,1 la cui attribuzione a CarloDe Nicola si deve a Giuseppe De Blasiis2 che ne curò laprima edizione a stampa nel 1906, il Diario napoletano è statospesso oggetto e fonte per numerosi storici e studiosi. GiàBenedetto Croce nel suo discorso nell’adunanza annualedella Società Napoletana di Storia Patria tenuto il 25 marzo1899 affermava:
autore di esso fu un avvocato napoletano di cui finora non ci èriuscito di scoprire il nome, osservatore intelligente e narratoreaccurato degli avvenimenti del suo tempo, che fu quello di maggiorrivolgimento pel nostro paese, avendo compreso la rivoluzione del’99, il decennio francese, la rivoluzione del 20-1 [...] Nessun altrascrittura ci porge tanti e così svariati ragguagli su ogni parte dellavita sociale di allora.3
Nella sua fondamentale monografia sui teatri napoletani4Croce si riferisce più volte, nel paragrafo dedicato al teatrodella rivoluzione, al Diario. Anche Salvatore di Giacomo nellasua Storia del teatro San Carlino5 riporta alcuni passi relativi ai
teatri contenuti nella fonte allora a lui risultante ancora ano-nima, e ancora una volta l’anno dal quale sono attinti è il1799. Molti altri studiosi del teatro rivoluzionario in tempi anoi più vicini hanno continuato a sfruttare efficacemente lafonte di De Nicola,6 ma il Diario si estende in un arco tem-porale ben più ampio giacché inizia il 29 novembre 1798 eprosegue fino alla morte di Ferdinando I di Borbone, termi-nando dunque nel 1825. Vero è che all’anno rivoluzionarioDe Nicola aveva dedicato il più ampio spazio: i tre volumidell’ultima edizione7 – che riproducono anastaticamentel’edizione del 1906 – consistono rispettivamente di 542 pa-gine (novembre 1798-dicembre 1800), 832 pagine (gennaio1801-maggio 1815) e 293 pagine (maggio 1815-gennaio1825).8
1 I-Nsn, fondo manoscritti, S.B.N. XXI B. 16-21.2 Giuseppe De Blasiis fu «per quarant’anni presidente e animatore
della Società napoletana di storia patria e titolare per quarant’anni dellacattedra di storia nazionale nell’Università di Napoli». Cfr. PAOLO RICCI,Note a CARLO DE NICOLA, Diario napoletano, Milano, Giordano, 1963, p. XXXVII.
3 «Archivio Storico per le Province Napoletane», XXIV/1, 1899, pp. 182-187: p. 183.
4 BENEDETTO CROCE, I teatri di Napoli: secolo 15-18, Napoli, L. Pierro,1891; ed. consultata I Teatri di Napoli. Dal Rinascimento alla fine del secolo de-cimottavo, a cura di Giuseppe Galasso, Milano, Adelphi, 1992.
5 SALVATORE DI GIACOMO, Cronaca del Teatro San Carlino: contributo allastoria della scena dialettale napoletana: 1738-1884: relazione al Ministerod’istruzione publica d’Italia, Napoli, S. Di Giacomo, 1891; ed. consultata Mi-lano, Mondadori, 1935.
6 Si veda almeno la parte dedicata a Rivoluzione, linguaggi, strategie eforme di comunicazione, in Napoli 1799 fra storia e storiografia. Atti del con-vegno internazionale, Napoli, 21-24 gennaio 1999, a cura di Anna MariaRao, Napoli, Vivarium, 2002 con i saggi di BEATRICE ALFONZETTI, Teatro e ri-voluzione: il caso napoletano (pp. 493-517), RENATO DI BENEDETTO, “La filosofiain soccorso dei melodrammi”: la riforma dell’opera in musica nel pensiero de-gl’Illuministi napoletani (pp. 547-563), MARINA MAYRHOFER, Drammaturgie dellaRivoluzione: tre drammi per musica di scuola napoletana (pp. 565-595), LUCIO
TUFANO, Teatro musicale e massoneria: appunti sulla diffusione del melologo aNapoli (1773-1792) (pp. 597-631). Cfr. anche MÉLANIE TRAVERSIER, «Transfor-mer la plèbe en peuple». Théâtre et musique à Naples en 1799, de la procla-mation de la République napolitaine à la première restauration, «Annaleshistoriques de la Révolution française», 335/2004, pp. 37-70.
7 Nel 1963 l’editore Giordano di Milano ristampò il primo volume delDiario che ricopre il biennio 1798-1800 e solo nel 1999, in occasione dellecelebrazioni del bicentenario della rivoluzione partenopea, vi fu una riedi-zione completa in tre volumi, a cura di Renata de Lorenzo per l’editoreLuigi Regina di Napoli che è quella consultata per il presente studio.
8 «Si tratta complessivamente di 27 anni che riguardano la storia delregno e quella di un uomo che nel 1798-99 era già avvocato, di 41 o 42anni». Cfr. RENATA DE LORENZO, Introduzione, in CARLO DE NICOLA, Diario na-poletano, 3 voll., Napoli, Luigi Regina, 1999, I, p. IX.
13 31 gennaio 1799, DE NICOLA, Diario, I, p. 41.14 27 gennaio 1799, ivi, p. 36.15 9 gennaio 1800, ivi, p. 410. La notizia è stata riportata anche in ROSA
CAFIERO-MARINA MARINO, La musica della real camera e cappella palatina diNapoli fra restaurazione e unità d’Italia. II: organici e ruoli (1815-1864), «Studimusicali», XXXVIII/1, 2009, pp. 133-205: 152.
16 17 febbraio 1799, DE NICOLA, Diario, I, p. 56.17 Sono frequentissimi i casi in cui le notizie riportate vengono intro-
dotte dai «si dice», «mi dicono», «mi è stato riferito», quasi a voler osten-tare una insofferenza nei confronti di tale genere di frequentazioni.
9 Renata de Lorenzo afferma anche che tale concentrazione «dà ilsenso della drammaticità del momento». Ibidem.
10 Come si è detto il 1799 è stato già ampiamente sviscerato ancheper tutto quello che concerne le attività di spettacolo e musica. Cfr. supranota 6.
11 27 gennaio 1799, DE NICOLA, Diario, I, p. 36.12 Ibidem. Sul Nicaboro di Tritto riferisce anche, citando la fonte del Dia-
rio, ANTHONY R. DELDONNA, Eighteenth-century politics and patronage: musicand the republican revolution of Naples, «Eighteenth-century music», 4/2,2007, pp. 211-250: p. 214. DelDonna osserva tuttavia che nel libretto ve-niva riportata una dedica a Ferdinando IV definito «nostro amabilissimo so-vrano». L’episodio è ripreso anche da Croce che, attingendo ugualmente alDiario, riferisce di un cambio di «intenzione» dell’opera dopo l’entrata deifrancesi a Napoli che passò dunque dalla dedica al sovrano a quella piùconsona alla nuova situazione, cioè a «sollennizzare la espulsione dell’ul-timo tiranno». Cfr. CROCE, I teatri di Napoli, p. 298.
sizione del SS.° che nelle quattro domeniche di carnovale per cin-que giorni consecutivi si fanno in Napoli con gran pompa e divo-zione, egli rispose, che facessero tutto quello che per lo passatofatto erasi, ed ugual risposta diede per le prediche.13
Come per tutte le grandi occasioni anche per l’arrivo delgenerale francese a Napoli viene eseguito un Te Deum:«Questa mattina poi [Championnet] è stato con gran pompaad assistere al Tedeum cantato nell’arcivescovado seguito daigenerali Moliterno e Roccaromana ed altri suoi ufficiali dipiana maggiore».14 Nelle numerosissime cronache di TeDeum De Nicola mette in evidenza il lato ‘mondano’ di talioccasioni: «Girano biglietti d’invito della deputazione Regiapel Te Deum da cantarsi in s. Chiara domenica per la nascitadel Re, che solevasi cantarsi nella chiesa di s. Lorenzo,quando ivi era il Tribunale di Città. Girano per lo stessogiorno biglietti pel Te Deum nella Real cappella, con inter-vento del luogotenente principe del Cassero».15
Altro tema spesso evidenziato da De Nicola è quellodegli accompagnamenti musicali che enfatizzano le manife-stazioni pubbliche della repubblica giacobina:
Si è innalzato questa mattina l’arbore nella piazza del Mercato congrande musica: vi ha assistito Championnet, ed ha perorato al po-polo Carlo Laubert; indi si è sparso fra lo stesso un complimentodi dolci e biscotterie. Il popolo ha chiesto al Generale che si per-mettesse il suono delle campane come prima, Laubert in di luinome lo ha promesso.16
In altre cronache dai teatri, quasi tutte a lui riferite daamici e conoscenti,17 De Nicola mostra tutto lo scandalo da
Le notizie che riportano cronache di spettacoli, feste civilie religiose, parate militari, notizie su compositori, cantanti,attori o ballerini ricavate dall’intera opera di De Nicola sonoaltrettanto concentrate negli anni rivoluzionari.9 Per il solo1799 tali notizie sono 85, poi gradualmente la frequenza vadiradandosi con 18 notizie per il 1800, 13 per il 1801, 12 peril 1802, 5 per il 1803, una per il 1804, nessuna per il 1805.C’è poi una ripresa: 44 notizie per il 1806, 32 per il 1807, 27per il 1808, 30 per il 1809, 25 per il 1810, 31 per il 1811, 6per il 1812, 20 per il 1813, 29 per il 1814, 19 per il 1815, 13per il 1816, 12 per il 1817, 7 per il 1818, 6 per il 1819, 9 peril 1820, 3 per il 1821, una per il 1822, 2 per il 1823, nessunanel 1824 e 2 per il 1825.
L’anno della rivoluzione10 viene inaugurato nel Diario conl’arrivo del generale Championnet che si mostra spesso nelTeatro ora definito ‘nazionale’11 dove si allestiscono opere‘rivoluzionarie’: è il caso del Nicaboro in Yucatan di Tritto, ese-guito, scrive De Nicola, «per sollennizzare la espulsione deltiranno».12 Championnet viene presentato come personaequilibrata e saggia: prevedendo disordini nei festini in teatroil generale decide di vietarli e questa decisione viene salutatafavorevolmente dal diarista che è molto compiaciuto poi nelnotare come
Ai superiori dei Geronomini e della Trinità maggiore, che furono adomandarli se potessero fare i carnevaletti, ossia la solenne espo-
106FONTI MUSICALI ITALIANE
MARINA MARINO – MUSICA E SPETTACOLO NEL «DIARIO NAPOLETANO» 107
18 Ne riferisce anche DI GIACOMO, Cronaca del Teatro San Carlino, p. 183.19 29 gennaio 1799, DE NICOLA, Diario, I, p. 38.20 17 febbraio 1799, ivi, p. 56.21 16 febbraio 1799, ivi, p. 55.22 21 marzo 1799, ivi, p. 83.23 10 maggio 1799, ivi, p. 134.
24 19 maggio 1799, ivi, p. 144. La notizia è commentata anche da ALFONZETTI, Teatro e rivoluzione, p. 513, e da TRAVERSIER, «Transformer la plèbeen peuple». Quest’ultima scrive: «Lorsque, le 19 mai 1799, l’Inno alla libertàcréé à Milan le 21 janvier précédent par Vincenzo Monti à l’occasion del’anniversaire de la mort de Louis XVI résonne sur la place de l’ancien Pa-lazzo reale de Naples, la République Napolitaine vit ses derniers momentsd’ébullition» (pp. 37-38). Più avanti la Traversier torna su quella giornata:«Ainsi, la dernière grande cérémonie républicaine qui a lieu le 19 mai est lafesta del bruciamento delle bandiere. Elle se déroule de nuit autour de l’ar-bre de la liberté planté devant l’ancien Palais royal […] Alors retentis-sent les hymnes patriotiques choisis pour l’occasion et exécutés par lesélèves des conservatoires. Le recours à de tels chants pour exalter lesvertus de la République et condamner les vices de la Tyrannie, est récur-rent pendant les six mois révolutionnaires […] La fête nationale du 19 mai1799 a peut-être été imprégnée de cette fièvre lyrique, c’est en tout cas lavision que veulent en donner les journaux jacobins. Si l’on en se fie au té-moignage de Carlo De Nicola et aux gazettes, les hymnes entonnés par lafoule à cette occasion furent les suivant: l’Inno alla libertà de VincenzoMonti, déjà mentionné, et une composition de Luigi Rossi, mis respective-ment en musique par Giovanni Paisiello (il s’en défendra plus tard) et parDomenico Cimarosa» (pp. 54-55). Luigi Rossi, l’autore dell’inno musicatoda Cimarosa, era conosciuto con lo pseudonimo di Eugenio Palumbo o diCittadino Eugenio. Eleonora Pimentel Fonseca, nel «Monitore repubbli-cano», afferma che ad intonare l’inno di Cimarosa in quell’occasione fos-sero stati «I Giovani del Conservatorio di Musica». Cfr. il «Monitorerepubblicano», LIX, 30, 6 pratile (25 maggio) 1799, citato da ELEONORA PI-MENTEL FONSECA, Il monitore repubblicano del 1799, a cura di BenedettoCroce, Bologna, Il Mulino, 2000, p. 143.
25 1 giugno 1799, DE NICOLA, Diario, I, pp. 163-164. Nelle righe prece-denti De Nicola faceva riferimento alla «cantata, Inno patriottico, e balloanalogo» previsti per il giorno successivo al Teatro del Fondo: si tratta delTimoleone di Alfieri sul quale cfr. anche DELDONNA, Eighteenth-century politicsand patronage, p. 226. Nella cronaca del 2 giugno inoltre si legge: «La festadi ballo a s. Carlo vi è anche questa sera, ed al Fondo la cantata porta il ti-
sti uno da Vincenzo Mundo [Monti], l’altro da Eugenio Pa-lumbo e posti in musica da Cimmarosa e Paisiello».24
Ma è più frequente il tono moralizzatore con cui si scan-dalizza di fronte agli sprechi: «Si crederebbe? mentre si an-nunziano tali feste, e si fa illuminazione, Napoli è strettadagl’insorgenti, è vicina ad una rivoluzione, e se non altro, adessere affamata. [...] Napoli è stretta da tutti i lati, ed a mo-menti per sentirsi scoppiare la insurrezione anco in Napoli;ed il Governo fa fare illuminazione e feste di ballo».25 Nes-suno scandalo tuttavia di fronte alla sontuosità profusa per lefeste religiose alla conclusione della stagione repubblicana:
lui provato nei confronti di un episodio moralmente discuti-bile: in una cronaca dal Teatro dei Fiorentini18 il nostro riferi-sce che
si vide ballare la prima ballerina, mezzo denudata quasi sino al-l’obelico, ed essersi replicatamente baciata col ballerino. Se ciò èvero, mi rincresce, perché non mi pare che corrisponda alle mas-sime del Governo, che annunzia Virtù e Libertà, ma non libertinag-gio; ed il Teatro se si corrompe, anco i costumi si corromperanno;mi auguro perciò che si dia riparo a tali laidezze.19
Ai giacobini musica e festeggiamenti servono a coinvol-gere la popolazione e l’installazione dell’albero della libertà aPiazza Mercato viene accompagnata da «grande musica»20
eseguita da «nientemeno che centoventi professori di mu-sica».21 Da fervente cattolico De Nicola è rammaricato nelvedere trascurata la religione.
Le funzioni sacre del corrente giovedì Santo si sono fatte con lasolita solennità, ma con niuna pompa, ed i Santi Sepolcri non hannoavuta manco la terza parte del solito splendore, anzi la maggiorparte delle Chiese non hanno manco parato l’altare, essendosicontentate di mettere il monumento nudo sull’altare con lumianche scarsi e niente più. La Chiesa di Donna Regina, solita a faregrande macchina ad olio e cera, non ha fatto che piccola macchi-netta con poca cera.22
La poca osservanza delle feste religiose è compensatadall’abbondanza di feste ‘patriottiche’ assai discutibili nella vi-sione del Nostro: «Per domenica prossima si è annunziatauna festa patriottica: sta a vedere che si farà qualche altraminchioneria, che invece di cattivare, disgusterà il pubblico.Sarà così se verrà regolata da qualche testa calda e sven-tata».23 Il 19 maggio tuttavia riferisce dell’allegria generalealla festa delle bandiere e grande parata davanti al Palazzo‘Nazionale’ in cui «si sono ancora cantati alcuni Inni compo-
FONTI MUSICALI ITALIANE108
tolo di Vero patriottismo, ed il soggetto non è altro che un giovane il qualevuole allontanarsi dalla sua amante per andare a battere con degl’insor-genti, arriva a tempo la notizia che sono quelli battuti, ed egli resta a piedidella sua bella. Molto poco sa la storia greca e romana l’autore, se riduce aquesto esempio solo il vero patriottismo» (DE NICOLA, Diario, I, p. 166).
26 24 luglio 1799, ivi, p. 257. La notizia del Diario, che riferisce dellacantata Il disinganno di Tritto su testo di Diodati, è riportata anche daLUCIO TUFANO, «Partenope consolata». Rivoluzione e reazione nelle cantate ce-lebrative per il ritorno dei Borboni a Napoli (1799-1802), «Studi settecente-schi», n.s., 19, 1999 [ma 2000], pp. 293-342. Tufano osserva che la cantatavenne eseguita «alla presenza di Ferdinando IV nei brevi giorni in cui il re,interrompendo la cattività palermitana, staziona nella baia di Napoli» (p.297).
27 Di Pagano De Nicola era stato allievo ed in seguito, proprio du-rante il ’99, discusse ripetutamente con lui di questioni legali. Cfr. DE LO-RENZO, Introduzione, p. XI.
28 29 ottobre 1799, DE NICOLA, Diario, I, pp. 361-362. Sul contributo diMario Pagano al genere del melologo si veda TUFANO, Teatro musicale emassoneria, e ID., Un melologo inedito di Francesco Saverio Salfi: «Medea», inSalfi librettista, studi e testi a cura di Francesco Paolo Russo, Vibo Valentia,Monteleone, 2001, pp. 97-131.
29 29 ottobre 1799, DE NICOLA, Diario, I, p. 360.30 1 agosto 1799, ivi, p. 267.31 9 dicembre 1799, ivi, p. 391. 32 3 gennaio 1800, ivi, p. 407. Benedetto Croce, nel ricordarlo insieme
agli altri esponenti del mondo teatrale che persero la vita nella reazioneborbonica, ne parla come il «riduttore napoletano del Comte de Commin-ges» (CROCE, I teatri di Napoli, p. 301).
33 23 febbraio 1800, DE NICOLA, Diario, I, p. 425.
anni [...] Fu invaso dalla mania di esser poeta tragico e co-mico, si fece piantare un teatrino su di un suo casino, ove fa-ceva rappresentare le sue tragedie e comedie nei mesi divilleggiatura».29
In merito alla situazione dei due compositori coinvoltinella passata repubblica, Paisiello e Cimarosa, De Nicola sulprimo commenta che è «ragionevolmente in disgrazia, per-ché dichiarato maestro di cappella compositore della Re-pubblica, pose in musica gl’inni cantati innanzi al Real Palazzosotto l’albore, ed andò in Roma a mettere in musica l’Aristo-demo»;30 e sul secondo riferisce semplicemente del suo ar-resto.31 Segue il buio periodo delle esecuzioni e fra icondannati a morte ve ne sono alcuni per aver scritto opereteatrali considerate sediziose, come ad esempio «d. GiacomoAntonio Gualzetti, noto per le sue opere teatrali»,32 e inquesto clima di terrore, come se nulla fosse, c’è chi pensa adorganizzare feste:
In mezzo a questi torbidi non mancano feste e divertimenti fra laNobiltà e mezzo ceto. Questa sera in casa del conte della Saponaravi è magnifica festa di ballo, che comincia con un pantomino, con-certato dal primo ballerino Giannini, ed eseguito da giovani dame ecavalieri. É questo il secondo, del primo fui spettatore; questa seranon mi ha dato l’animo di esserlo.33
Nel periodo fra la caduta della repubblica ed il ritornodel re Borbone le attività musicali e teatrali subiscono pro-fondi disagi a causa dei numerosi sospetti di collusioni con laprecedente gestione politica e anche per il grande disordineamministrativo.
Ieri sera d. Onorato Gaetani portò una serenata a S.M. con unlegno illuminato, con disegno del machinista di s. Carlo, Domenico
Le feste che si fanno solenni per le chiese son tali e così sontuoseche fanno stupore. Se ne prepara una alla Trinità maggiore a spesedei professori legali per la prossima domenica, la di cui musica solacosta D/. 300. Altra se ne prepara in Monte Santo, altra a s. Nicolaalla Carità, ed una con triduo nella chiesa di s. Lorenzo maggiore.Anche un triduo a s. Gennaro è cominciato oggi.Ieri sera la serenata portata a S.M. riuscì vaghissima. La cantata fi-gurava l’ingresso della Regia armata e l’arrivo di S.M. espressa indialogo drammatico da Partenope e Sebeto, poesia di Diodati, mu-sica di Tritto.26
Terminata l’effimera stagione della repubblica De Nicolasegnala tutte le manifestazioni di giubilo ad ogni minima vocesul ritorno dei Borboni. Deciso oppositore della causa rivo-luzionaria De Nicola rinnega anche i rapporti molto strettiavuti con uno dei massimi esponenti della classe colta napo-letana coinvolta nel precedente regime, Mario Pagano,27 te-nendosene alla debita distanza. Di lui dice che «voleva adispetto delle Muse esser poeta e tragico, aveva in pensierodi essere, in quanto al teatro, il Voltaire dell’Italia. Il suo Cor-radino però e il suo Gerbino saranno dimenticati prima dilui».28 E in margine aggiunge anche: «Io lo conobbi nei primi
MARINA MARINO – MUSICA E SPETTACOLO NEL «DIARIO NAPOLETANO» 109
34 3 agosto 1799, ivi, p. 270.35 3 novembre 1799, ivi, pp. 368-369.36 In questo punto De Nicola annota che «Questo maestro si sta giu-
stificando, perché in disgrazia, essendosi detto che fosse andato in Romaper servizio della Repubblica» (ivi, p. 372).
37 7 novembre 1799, ibidem.38 12 giugno 1800, ivi, p. 473.39 22 giugno 1800, ivi, p. 476.40 17 novembre 1799, ivi, pp. 378-379. I pochi ma fondamentali studi sul
mottetto settecentesco hanno cercato di evidenziare il contrasto fra la se-vera critica dei letterati e della Chiesa nei confronti dei testi messi in mu-sica ed il grande successo che invece questo genere riscuoteva presso leplatee degli ascoltatori. Si veda in proposito almeno PIER GIUSEPPE GILLIO, Ilmottetto a voce sola: un oratorio in miniatura, in Nuovi Studi Vivaldiani, edizionee cronologia critica delle opere, a cura di Antonio Fanna e Giovanni Morelli,Firenze, Olschki, 1988, pp. 501-510; LUCIO TUFANO, «Ma qual necessità ci è dicantar questi mottettacci infelici?»: Giuseppe Giordani e il mottetto tardo-sette-
nonico Guglione ha recitato l’orazione funebre. Quest’oggi tutte lereligioni sono andate a cantarci la Libera, per cui è durata la fun-zione fino alle ore 24.37
La festa del Corpus Domini è riuscita propiissima, e ci si è rivedutol’antico decoro.38
La festa fatta a spese dei complatearii a s. Antonio di Padova è riu-scita solennissima, ed il concorso del popolo lungo la strada di s.Lorenzo maggiore è stato oltre ogni credere, nel tempo stessoche vi era una grande allegria, vi regnava pure grandissima tran-quillità. La sera oltre la solita illuminazione, vi è stato anche grandefuoco artifiziale.39
Su una diffusa forma di musica sacra, il mottetto, De Ni-cola ci offre un aneddoto che certamente dà nuovi spunti diriflessione e di conoscenza:
Nella città di Pozzuoli ieri accadde un altro rumore cagionato peraltro da indiscreto zelo del vescovo Mons. Rosini, che quest’oggiforse a tale oggetto è corso a Napoli. Il fatto fu, che celebrandosinon so che festa della città, Monsignore volle impedire che si can-tasse il mottetto, forse seguendo un enciclica che anni sono publicòil nostro arcivescovo, dicendo che quella era musica più da Teatroche da chiesa. La città ed il popolo di Pozzuoli intese male tal proi-bizione, e cominciò a strepitare e dire che il vescovo era Giaco-bino, perché impediva la musica che facevasi in onore di Dio. E iltumulto crebbe a segno che volevano arrestarlo; non so come sifosse sedato. Sicuramente quel Vescovo è venuto quest’oggi in Na-poli.40
Chelli, che incontrò moltissimo il piacere di S.M. Vi fu la sera pre-cedente la compagnia del Teatro Fiorentini, ed avendo S.M. dettaqualche parola al primo buffo Gennaro Luzio, costui lo pregò di faraprire i Teatri, dicendo mancarli da vivere. Il Re gli disse: «e perchésiete voi giacobini?» - «Signò, non simme nuje» rispose Luzio, e ilRe disse: «non è tempo ancora».34
A novembre finalmente arrivano le prime notizie di ria-perture di teatri:
Questa sera dopo un anno ho riveduto il Teatro: si rappresentavauna cantata a tre voci con balletto analogo. Il soggetto è l’entratadelle armi Regali in Napoli; all’apparire di queste nella scena ultimacomposta da truppe figuranti, Moscoviti, Inglesi, e truppe di masse,si è innalzato dal popolo spettatore sull’ultima ringhiera, che ora di-cesi «palco dei Calabresi» un grido d’allegria risuonante «viva ilRe» seguito dal «morano i Giacobini» che mentre mi ha cagionatal’allegria per lo battimento delle mani, mi ha svegliato insieme il ri-brezzo che queste voci cagionano, ricordando le stragi che produ-cevano nei giorni della sofferta anarchia. Tali grida son continuatefino al terminarsi del ballo. Il Teatro in cui rappresentasi è quellodei Fiorentini.35
Le notizie maggiormente segnalate sono le ripristinatefeste religiose:
Questa mattina nella chiesa della Trinità maggiore, per impedi-mento di quella dell’arcivescovado, si sono solennizzati i solennifunerali di Pio VI Grandiosa machina era nel mezzo col suo cenota-fio e ritratto, sopra sparsa di emblemi e stemma. La chiesa parata abruno e sparsa d’iscrizioni, due orchestre, ove ha diretta la musicail celebre maestro Pajesiello,36 ch’è riuscita bellissima. Vi è interve-nuto il Governo, la Giunta Regia di Città, il clero, i vescovi e prelatiRomani che qui si trovavano, che sono seduti in una stessa grada-zione coi vescovi, molta nobiltà, ed il corpo della magistratura. Il ca-
FONTI MUSICALI ITALIANE110
centesco tra prassi e censure, di prossima pubblicazione in Atti del convegnointernazionale di studi La figura e l’opera di Giuseppe Giordani (Napoli 1751-Fermo 1798), Fermo, 3-5 ottobre 2008.
41 13 agosto 1800, DE NICOLA, Diario, I, p. 492.42 14 agosto 1801, DE NICOLA, Diario, II, p. 78.43 9 settembre 1801, ivi, p. 83.44 24 maggio 1802, ivi, p. 116.45 10 giugno 1802, ivi, pp. 117-118.46 27 giugno 1802, ivi, pp. 120-122.
47 31 gennaio 1803, ivi, p. 135.48 6 gennaio 1806, ivi, p. 180. De Nicola qui osserva trattarsi di Cate-
rino Titus d’Auchy, «primo ballerino del gran Teatro di Parigi».49 27 febbraio 1806, ivi, p. 223.50 3 maggio 1806, ivi, p. 248. Uno dei due milanesi è Barbaja sul quale
De Nicola tornerà in seguito ad esporre il suo aspro giudizio.51 Si veda nel testo p. 106.
subito a girare in carrozza andando di chiesa in chiesa eprende di nuovo possesso del suo palco in teatro. De Nicolaha ancora in serbo severe critiche alle spese per i festini:«Ieri sera cominciarono le feste publiche di ballo al Real Tea-tro di S. Carlo con tanto concorso che mai simile è stato neiprimi festini. La nostra situazione è un continuo paradossopolitico; tutti sono in miseria e tutti spendono più di quelloche in tempi meno critici spendevano».47
Le prime notizie del 1806 riferiscono delle mode impor-tate dalla Francia: «Ieri sera S.M. la Regina fu al Teatro di s.Carlo, ove applaudì con battere le mani al primo ballerino».48
E fra le novità più malviste vi è quella del grande ritornodella moda dei giochi d’azzardo presso la nobiltà:
Si dice che saranno rigorosamente proibiti i giuochi di azzardo,ossia il Rosso e il Nero, oggi dominante in Napoli, nella casa special-mente di D. Emmanuela Zurlo, duchessa di Ruffano, Capparelli, Pas-sarelli, e Salonna, case tutte ove si divorano migliaia.49
Si sono affittati per annui ducati sessantamila i giuochi tutti di az-zardo, e nel giorno primo maggio si aprì nella galleria, al disopra delcaffè della Meridiana il giuoco Rosso e Nero, il di cui banco è per-manente dalle undici del mattino fino all’una della notte. Il valsentedel banco è di ducati ottomila, gli appaltatori sono due Milanesi.50
Sono i primi commenti meravigliati su questo pericolosopassatempo che porterà più tardi a registrare veri e propritracolli finanziari spingendo qualcuno anche al suicidio.
Con l’arrivo di Giuseppe Bonaparte le notizie tornano adinfittirsi51 e con il solito tono contraddittorio De Nicola simostra esaltato di fronte alla magnificenza delle pubblichemanifestazioni:
Ecco un’altra giornata che forma epoca nella storia del Regno no-stro. Giuseppe Primo Bonaparte è entrato pigliando possesso da
A corte si festeggiano di nuovo le ricorrenze dei realianche in loro assenza: «Per la ricorrenza della nascita di S. M.la Regina questa mattina vi è stato circolo e questa sera can-tata e festa a Palazzo. La Regina intanto a quest’ora sta aVienna».41 Tuttavia anche ora De Nicola non manca di con-dannare la politica di sperpero in feste e divertimenti:
Essendosi ieri sera aperto il Real Teatro s. Carlo, vi fu la più grandegala, e sento che si pagarono i palchi sino a ducati trenta per quellasera, e le sedie un’oncia, tanto che dovette la Giunta dei Spettacoliproibire il potersi esigere più di Duc. 12 il palco e di carlini cinquela sedia. Ecco il carattere della nostra Nazione: siamo tutti ridotti alverde, e si gitta il denaro come nello stato di opulenza.42
Il principe ereditario, mandato da Ferdinando a Napoli,invece di preoccuparsi dei tanti problemi della nazione va ateatro e addirittura la gente vi si reca per vederlo riderenegli spettacoli dello «stomachevole nostro Pulcinella dettoGiancola».43 Gli anni passano, il ritorno di Ferdinando si faancora sospirare e per tranquillizzare il popolo si organiz-zano continue manifestazioni spettacolari: «La venuta del Renon pare che possa più mettersi in dubio di essere prossima,perché si son cominciate ad alzare le machine per l’illumina-zione e per festeggiarsi il suo arrivo».44 Si demoliscono i sim-boli rivoluzionari e in loro luogo si innalzano obelischi estatue per far trovare pronta e trionfante la città in quell’oc-casione, ma le ingenti somme sborsate sono viste malvolen-tieri dal diarista.45
Tuttavia quando finalmente Ferdinando giunge a NapoliDe Nicola si sofferma a descrivere nei minimi dettagli lemacchine adibite in suo onore e non può nascondere il suototale apprezzamento.46 Nei giorni successivi il re riprende
MARINA MARINO – MUSICA E SPETTACOLO NEL «DIARIO NAPOLETANO» 111
52 10 maggio 1806, DE NICOLA, Diario, II, p. 249.53 4 agosto 1807, ivi, p. 362.54 16 agosto 1807, ivi, pp. 364-365.55 29 agosto 1807, ivi, p. 368.56 8 settembre 1807, ivi, p. 371.
Dello stesso tenore le annotazioni sulla devozione al pa-trono san Gennaro («La liquefazione del sangue di s. Gen-naro non è seguita questa mattina. In altri tempi faceva piùrumore»),57 sulla chiusura dei teatri in Quaresima («Ieri seraultimo giorno di Carnevale, dovendosi chiudere i teatri, s’in-tese esservi ordine che si continuassero: non si è sospeso senon il ricorso degli attori e ballerini di s. Carlo che protesta-rono terminato l’obbligo delle loro scritture»)58 e durantela novena di Natale:
Grandi precauzioni per la vigilia di Natale. Lo sparo dei fuochi arti-fiziali a mano come tuoni, botte, risposte, fiaschetti e simili, proibitosotto la multa da dieci sino a 200 ducati, e due mesi di carcere. Lailluminazione non solo delle strade ma anche dei palazzi, ed altriprovvedimenti, si sentono. [...] Difatti per antichissimo solito ri-spetto al più augusto mistero di nostra Religione nella novena diNatale i Teatri si chiudevano, in quest’anno anche questo esteriorerispetto si è tolto, ed i Teatri sono aperti poco curando lo scandaloche il popolo ne riceve.59
E ancora, commenta la proibizione dei consueti spari nelperiodo natalizio:
La proibizione di ogni sorta di sparo solito a farsi nella nostra cittàla notte della vigilia di Natale, che oggi ricorre, fu rinnovata nelprimo della Novena col dispiacere del basso popolo, e con dannodi coloro che avevano comprato dai fuochisti di tal merce perismaltirla questa sera, e che a ragione si lagnano; mentre vi era ilpermesso di lavorarsi tali fuochi.60
Questo sovrano trascura il bene e i piaceri del popolonapoletano ma pensa ai suoi:
Il Re Giuseppe intanto pensa a divertirsi con tavole a Capodi-monte. Ieri fu illuminata la grotta di Pozzuoli, e vi fu una scom-messa fatta da un Milanese di mille oncie per una corsa di cavallodi disfida col cavallo del barone Zona di Capua. Seguì la corsa fuori
Re di Napoli, ed eccone il cerimoniale […] Alle dieci tutta la stradadel passaggio, cominciando dal Reclusorio fino al Real Palazzo, erasgombra di carrozze, tutta abbellita dai parati nei balconi, e fronti diChiese, botteghe e simili, da tratto in tratto di orchestra per mu-sica strumentale.52
Diverse altre sono le notizie sulla musica strumentaleeseguita per le strade cittadine: in occasione di una pubblicamanifestazione in onore del compleanno di Napoleone Bo-naparte e della pace con la Russia De Nicola riporta i detta-gli tratti da un manifesto che prevedevano delle orchestreappositamente predisposte nella Real Villa di Chiaia cheavrebbero suonato musiche da ballo e dei «teatrini di varj di-vertimenti».53 Pochi giorni dopo si legge la descrizione dellastessa festa, in un altro luogo della città, nella quale «tre-cento persone, alle quali si diede un abito villereccio, e por-tando in una mano varj strumenti di agricoltura, deitriccaballacchi, sampogne, tamburi, e simili, andavano saltando,suonando, e gridando viva il Re».54
Ma molto più spesso egli critica aspramente i molli co-stumi del nuovo sovrano che ama i divertimenti togliendodenaro alla popolazione: «Si fecero le feste nei giorni 13, 14,e 15, come notai, e si è imposto il pagamento di una mezzadecima sulle case, per due terzi a carico degl’inquilini, e unterzo dei padroni, per le spese fatte in tale occasione sa-rebbe stato meglio risparmiare le feste ed evitare il nuovopeso».55
A De Nicola il re francese non piace, di lui critica anchel’inosservanza delle tradizioni locali come quella di guidare ilcorteo processionale alla chiesa di Piedigrotta:
[...] quest’oggi essendo la giornata della festa di Piedigrotta è statala città interamente tranquilla, sebene priva di quella solennepompa che in questa ricorrenza soleva esserci per la uscita in granforma che faceva la passata Corte portandosi a visitare quella Chie-sa così detta di Piedigrotta, perché a piedi della grotta di Pozzuoli.56
57 16 dicembre 1807, ivi, p. 385.58 11 febbraio 1807, ivi, pp. 318-319.59 18 dicembre 1806, ivi, p. 309.60 24 dicembre 1807, ivi, p. 385.
FONTI MUSICALI ITALIANE112
61 13 ottobre 1806, ivi, pp. 293-294. Il ‘milanese’ è ancora una volta Barbaja.62 14 febbraio 1807, ivi, p. 319.63 5 dicembre 1806, ivi, pp. 306-307.64 9 ottobre 1808, ivi, p. 427.65 2 dicembre 1810, ivi, pp. 542-543.66 7 ottobre 1808, ivi, p. 425. Dopo appena un paio d’anni tuttavia
Murat già mostra di trascurare questo compito: «Ricorre nella giornata dioggi la solennità del primo Santo Protettore di Napoli, s. Gennaro, le cuireliquie si espongono nella cappella detta del Tesoro nell’Arcivescovato,ed ivi succede la tanto nota liquefazione. Questa festa era preceduta da tresere di lumi sulla strada della guglia di s. Gennaro, ove si ergeva una mac-china illuminata con musica, e vi era gran concorso di gente; niente ditutto questo vi è stato. Questa mattina poi il solito era che il cannone
dei forti annunziava al pubblico la seguita miracolosa liquefazione, ma ne-anche questo vi è stato» (19 settembre 1810, ivi, p. 533).
67 «La festa fu bastantamente allegra, e ballarono tanto il Re che, laRegina, anzi si dice che il Re balli benissimo» (23 ottobre 1808, ivi, p. 431);«La prima contradanza Inglese la ballò la Regina col Sindaco Filangieri chedava la festa in nome del Corpo Municipale, arrivò fino all’ultima coppia erisalì sopra. Il Re ballò poi la seconda contradanza alla francese» (30 otto-bre 1809, ivi, p. 500).
68 8 settembre 1808, ivi, p. 420.69 4 febbraio 1809, ivi, pp. 446-447.70 27 marzo 1809, posa della prima pietra del foro Murat (ivi, pp. 456-458).71 20 aprile 1809 (ivi, p. 462). Si tratta del monastero – soppresso nel
1807 – di san Lorenzo ad Septimum ad Aversa che conservò la funzione dieducandato femminile fino al 1812. Ringrazio l’amica Serena Bisogno per lasegnalazione.
72 «I teatri di prosa sono aperti non essendosi sospese le recite nean-che in questi primi quattro giorni di quaresima. Si apriranno anche per lamusica nell’entrante settimana» (13 febbraio 1807, ivi, p. 319).
73 19 marzo 1807 (ivi, pp. 326-327). La cronaca di De Nicola prosegue
Il re balla bene,67 è di bell’aspetto.68 Certamente De Ni-cola non può accettare il lusso sfrenato diffusosi anchepresso ministri e dignitari,69 ma la dovizia di particolari usatanel descrivere ogni cerimoniale lascia trasparire la simpatia etutto sommato l’approvazione.70 Anche la regina è spessodescritta per le sue numerose opere di carità:
Quest’oggi il Re e la Regina sono andati in Aversa. Il Re a passare inrivista le truppe che ivi stanno; la Regina a vedere il locale del giàmonastero di s. Lorenzo dei PP. Cassinesi adattato ad un luogo dieducazione per le nobili donzelle Napoletane, ove avranno maestreper le arti donnesche, per le lingue, la musica, e il ballo.71
Con tono a volte polemico, altre volte compiaciuto, altreancora forzatamente neutrale De Nicola continua ad offrireun quadro delle attività musicali e spettacolari nella Napoli diquegli anni. Vi sono alcuni riferimenti ad esempio al teatro diprosa, relativamente alla continuazione delle recite durante laquaresima72 e all’esibizione di celebri compagnie come quelladegli “Straccioni”:
La sera vi fu illuminazione per la città, e si distinse la compagniacosì detta degli Straccioni che al largo della Carità innalzò un tem-pio col ritratto di Giuseppe Napoleone tutto illuminato con son-tuosa orchestra che la sera cantò un inno in di lui lode.73
Grotta, ed il cavallo di Zona guadagnò la scommessa ed il premio,lasciandosi indietro quasi per un tiro di schioppo il cavallo del Mi-lanese. Costui fece giorni sono simile scommessa per una giocataal bigliardo con un nostro celebre giocatore di cognome Persico, eseguì, avendola guadagnata il Milanese, dopo di avere cominciatada capo la partita, perché ne avevano passata la metà ed erano apari. Questo Milanese è della compagnia di coloro che tengonol’appalto dei pubblici giochi.61
Infatti Giuseppe trascorre molto tempo nelle tenute fuoricittà: «È l’anniversario quest’oggi dell’entrata delle truppeFrancesi. Domani è quello del Re Giuseppe, per cui dicesi visia salva, e vi sarebbe stato Circolo, se non fosse partito,come dissi, o per Persano, o per Eboli, essendo ancoradubio»,62 e si concede poco ai suoi sudditi. A Giuseppe Bo-naparte De Nicola attribuisce la colpa della licenziosità deicostumi introdotti a corte.
Sere sono vi fu una gran festa in casa del Ministro della Guerra, oveintervenne anche il Re. Vi era la figlia del Ministro Saliceti venuta difresco per essere sposa del principino di Torella. Il Re la compli-mentò particolarmente e le diede in pubblico il bacio di onore.Qui non si capisce bene questa galanteria usuale in Francia, ovel’embrasser porta il baciare la donna per puro complimento.63
Gioacchino Murat al contrario entra da subito nelle gra-zie del nostro: egli passeggia in carrozza con moglie e figli,64
passa spesso in rassegna le truppe, offre grandi rinfreschi allapopolazione,65 osserva le tradizioni.66
MARINA MARINO – MUSICA E SPETTACOLO NEL «DIARIO NAPOLETANO» 113
accennando ad uno spettacolo di gala gratuito offerto dal Governo al tea-tro di San Carlo ed il curatore della prima edizione, De Blasiis, rimanda alladescrizione dello stesso evento nel «Monitore» n. 112 in cui si specificatrattarsi dell’Elisa di Mayr con «intermezzo composto dall’avvocato Nico-lini e musicato da Paisiello» (ivi, p. 327).
74 3 settembre 1807, ivi, pp. 369-370.75 Per l’arpista Caterina Rega si rimanda a PAOLOGIOVANNI MAIONE, Or-
ganizzazione e repertorio musicale della corte nel decennio francese a Napoli(1806-1815), «Fonti musicali italiane», XI, 2006, pp. 119-173: 126 e a CA-FIERO- MARINO, La musica della real camera, p. 141.
76 17 agosto 1807, DE NICOLA, Diario, II, pp. 365-366.
77 26 settembre 1808, ivi, p. 423.78 13 gennaio 1817, DE NICOLA, Diario, III, p. 100.79 8 novembre 1810, DE NICOLA, Diario, II, p. 541.80 30 maggio 1818, DE NICOLA, Diario, III, p. 142.81 21 giugno 1815, ivi, p. 22. Calvarola era già noto alle forze dell’ordine
per aver fatto parte della Guardia civica nel periodo della repubblica gia-cobina. Quest’ultima notizia è riportata in DELDONNA, Eighteenth-centurypolitics and patronage, p. 227.
pompa e grandi decorazioni, a spese della Città, che ha distribuiti ipalchi ed i biglietti d’ingresso. La illuminazione la sera è stata bellis-sima.77
Ieri sera fu aperto il nuovo Real Teatro di s. Carlo con una cantataanaloga intitolata il Sogno di Partenope, e col ballo della Virtù pre-miata, quello stesso che stava sulle scene allorchè accadde l’incen-dio. Il concorso fu grande, ed i palchi e le sedie si vendettero aprezzi indiscretissimi, anche oltre la tariffa.78
In altre cronache vi sono notizie su taluni personaggi chepossono fornire agli studiosi nuovi dettagli sulle loro vicendebiografiche e sulle loro carriere: ad esempio a causa diun’epidemia di peste «Molti che volevano uscire dal Regno,fra i quali Crivelli tenore di s. Carlo, sono stati impediti, es-sendosi postati i cannoni per impedire l’uscita».79
Oggi è l’anniversario del nome di S.M. Dopo della gala partiràCarlo IV. La duchessa di Floridia nei passati giorni diede un pranzoed una festa a S.M. ed al suo augusto fratello nella di lei villa dellaFloridiana al Vomero. Circa la sera andarono a pranzo, indi nel bo-schetto illuminato fu cantato un inno allusivo, seguito da un con-certo di balletto eseguito dai ballerini di s. Carlo. L’inno fu cantatodalla Dardanelli.80
O ancora, nel riferire – cosa assai frequente nelle paginedel Diario – fatti di cronaca nera:
È accaduto un caso tragico quest’oggi [...] Una ragazza di quindicianni [...] fu colpita in fronte da una palla di fucile venuta da una fi-nestra dirimpetto, che fece saltarle il cervello, e cadere morta. Sivide che il colpo era uscito dalla casa di un primo ballerino grotte-sco del Real Teatro per nome Antonio Calvarola, detto Tognino, diNazione Veneziano.81
La compagnia detta dei Straccioni dà una festa in mezzo al largodella Carità. Questa compagnia ha per centro d’unione una pic-ciola bottega di tabaccaio ch’è a quel largo; ora si dice che si trovòaffisso alla porta un cartello con presso a poco le seguenti parole:”Straccione, straccione-Non fa lo festone-Ca vene Nasone-E teporta pane e sapone”.74
In alcune cronache il Diario diventa assai ricco di dettaglisu nomi di cantanti e strumentisti, e addirittura sui titoli deibrani eseguiti:
Ieri sera vi fu grande appartamento con l’invito anco del decurio-nato, ma non alle magistrature, cosa che si è notata. Il Re non fecetrovarsi a Palazzo, perché girò per vedere i lumi, indi fu al teatrodel Fondo; tornato a Palazzo, trovò cominciato il pranzo. Accaddeche preparate le tavole e credenze sulle Reali loggie, circa un’ora dinotte, cadde improvvisamente una dirotta pioggia che rovinò tutto,ed obligò a portarsi entro l’appartamento quanto sulle loggie erapreparato. Nella Villa il concorso della gente era immenso a goderela illuminazione [...] dopo il pranzo vi fu gran musica sulle loggiemedesime di Palazzo, essendosi cantata sull’arpa suonata dalla ce-lebre dilettante Rega75 la preghiera di Guglielmi nel Saulle, ove ilcoro ripigliava col versetto renda la pace al Re, che fu accomodatocosì: conserva il nostro Re. I cantori furono la Correa e Velluti, primadonna e prim’omo di s. Carlo, e Crivelli, tenore del teatro mede-simo. Terminata la musica, il Re fece rientrare le dame nelle stanze,ov’erano le tavole che si trovarono tutte coverte di gelati. Terminòla festa circa le ore otto d’Italia.76
Ieri sera la Corte fu al teatro di s. Carlo, ove vi fu una cantata edun ballo analogo intitolato Marte ed Achille, eseguito con infinita
FONTI MUSICALI ITALIANE114
82 DE LORENZO, Introduzione, p. VIII.83 Ivi, p. XIII.84 4 dicembre 1806, DE NICOLA, Diario, II, p. 306.85 Sul problema della sostituzione delle voci dei castrati nelle musiche
ecclesiastiche si dibatté a lungo nel corso di tutto l’Ottocento e per buonaparte del Novecento. Su tale argomento la chiesa romana fu quella princi-palmente interessata, vedi LEOPOLD M. KANTNER-ANGELA PACHOVSKY, LaCappella musicale pontificia nell’Ottocento, Roma, Hortus musicus, 1998 (Sto-
La festa del Corpus Domini, ossia la grande processione, è statamolto languida essendovi mancata la Corte e la Casa Reale chene formava la magnificenza. [In marg.] La sola novità è stata vedersile canterine sull’orchestra di s. Chiara, avendoci cantato la Sessiche recita da prim’omo in s. Carlo con otto corifee. Questa è di-sposizione dell’Eccellet.mo Ministro dell’Interno Monsignor Cape-celatro che l’introdusse prima sull’orchestra della Real Cappella.86
[La Regina] Ha ordinato che si facciano pubbliche nella Real Cap-pella le funzioni di Settimana Santa con pompa infinita, cosa tuttanuova. Le Lezioni saranno cantate dalle prime donne dei Teatri diNapoli.87
Delle novità introdotte dai francesi ciò che invece pro-prio risulta profondamente insopportabile a De Nicola è il‘milanese’ Barbaja.88 Fin dal suo primo apparire a Napoli come
De Nicola è nettamente schierato politicamente dallaparte borbonica; la ragione stessa del Diario sta nella forzatafuga di Ferdinando IV a Palermo alla vigilia della rivoluzionegiacobina e la durata stessa delle cronache, nelle intenzioniiniziali, sarebbe dovuta coincidere con tutta l’assenza del re edella sua famiglia da Napoli. Il 12 luglio 1799 scrive di averpensato di «“terminare la prima parte di questo giornale”ma – osserva Renata De Lorenzo – ritiene più opportunodilungarsi e cominciare la seconda parte dal momento delrientro in città della famiglia reale “perché mi lusingo che al-lora saranno interamente terminati i nostri guai”».82 TuttaviaDe Nicola approva parte delle novità introdotte dai francesi:
Come i costituenti francesi e i riformisti napoletani si scoprironorivoluzionari e giacobini, senza che questo percorso fosse apriori-sticamente scontato, così un avvocato napoletano si ritrovò daborbonico, murattiano inconsapevole, poi di nuovo borbonico scar-samente convinto, in un iter cui non fu estraneo il diario, il raccon-tarsi come confronto, come presa di coscienza di un nuovo mododi vivere la biografia collettiva, la dicotomia pubblico/privato.83
Nell’ambito delle annotazioni qui prese in esame adesempio De Nicola saluta con favore l’abolizione degli eunu-chi introdotta da Bonaparte: «Si è ordinato che si mettano inpiedi i Conservatorj di musica, ma si son proibite le vocibianche, o siano gli eunuchi; questo è molto ben fatto, es-sendo una barbarie contraria ad ogni legge il degradare degliuomini per farli servire al piacere di un orecchio che puol es-sere anche senza di essi dilettato».84 E descrive con natura-lezza l’esecuzione di musica sacra da parte di cantanti donne,argomento di fatto considerato dai regnanti e dalla chiesaassai scabroso e addirittura inconcepibile sia prima che dopoil decennio francese.85
ria della Cappella Musicale Pontificia, a cura di Giancarlo Rostirolla, 6), passim;per quanto riguarda la situazione napoletana si rinvia nuovamente a CA-FIERO- MARINO, La musica della real camera, pp. 160-161.
86 1 giugno 1809, DE NICOLA, Diario, II, pp. 469-470.87 31 marzo 1814, ivi, p. 704. In altre cronache De Nicola segnala
l’apertura dell’istruzione, compresa quella musicale, alle donne: si è già os-servato a proposito della visita della regina Carolina Murat al monasterodi Aversa (v. supra nota 71) e per quanto riguarda Napoli «Il Conservato-rio delle donne allo Spirito Santo è stato destinato ad essere scuola dicanto, musica, ballo, ed arte di recitare per le donzelle» (5 dicembre 1806,ivi, p. 307).
88 Sulla presenza e l’attività a Napoli di Domenico Barbaja si veda JOHN
ROSSELLI, The opera industry in Italy from Cimarosa to Verdi, Cambridge Uni-versity Press, 1984, ed. it. L’impresario d’opera. Arte e affari nel teatro musicaleitaliano dell’Ottocento, Torino, EDT, 1985, nonché i numerosi studi di PAOLO-GIOVANNI MAIONE e FRANCESCA SELLER: Napoli nel viaggio musicale di Rossini, inProtagonisti nella storia di Napoli. Grandi napoletani. Gioachino Rossini, Napoli,Elio De Rosa, 1994, pp. 2-27; Musicisti, cantanti e impresari a Napoli, in Prota-gonisti, pp. 30-31; I Reali Teatri di Napoli nella prima metà dell’Ottocento. Studisu Domenico Barbaja, Bellona, Santabarbara, 1995; Domenico Barbaja a Napoli(1809-1840): meccanismi di gestione teatrale, in Gioachino Rossini 1792-1992il testo e la scena, a cura di Paolo Fabbri, Pesaro, Fondazione Rossini, 1994,pp. 403-429; L’ultima stagione napoletana di Domenico Barbaja (1836-1840):organizzazione e spettacolo, «Rivista italiana di musicologia», XXVII/1-2, 1992,pp. 257-325; Gioco d’azzardo e teatro a Napoli dall’età napoleonica alla Restaurazione borbonica, «Musica/Realtà», XV/43, 1994, pp. 23-40; Il Tribu-nale di Commercio di Napoli: una fonte sconosciuta per lo studio dell’attività teatrale, «Fonti musicali italiane», I/1996, pp. 145-162; Da Napoli a Vienna:
MARINA MARINO – MUSICA E SPETTACOLO NEL «DIARIO NAPOLETANO»
scommettitore alle corse dei cavalli o al biliardo89 a tuttal’epoca del suo impresariato dei Reali Teatri De Nicola nonperde occasione per vituperare il cinismo con cui Barbaja siarricchisce ai danni dei giocatori che affollano i suoi ‘ridotti’.
Durante il 1815 c’è un avvicendarsi di regnanti: il 13 aprilenel Teatro San Carlo siedono nel «palchettone» con la Re-gina «in grande etichetta, Madama Letizia ed il Re di WestfaliaGirolamo Bonaparte»;90 due mesi più tardi un Te Deum e la‘salva’ annuciano l’arrivo a Napoli dell’arcivescovo Ruffo e laresa di Gaeta91 ed il 19 giugno De Nicola scrive:
Ieri sera S.M. fu al Teatro. Per consenso universale non si è più ve-duta una simile illuminazione, nè un simile spettacolo, nè una gioiapiù viva, più perfetta, più decente. Il Re ne fu commosso fino alle la-grime; ma al comparire del suo mezzo busto sul Teatro in mezzoalle bandiere di tutte le Potenze alleate, il Teatro rimbombò di ap-plausi e di evviva continuati per una mezz’ora. Il Re fu veduto asciu-garsi gli occhi, e corrispondere coi più vivi ringraziamenti aitrasporti del pubblico; le dame ancora nei palchi gridavano “ev-viva”.92
I Te Deum ora vengono cantati anche per festeggiare lanotizia della disfatta e dell’arresto di Napoleone.93
Un grave episodio di cronaca apre il 1816, l’incendio delTeatro di San Carlo avvenuto la notte del 13 febbraio.94 Neigiorni seguenti De Nicola descrive l’accaduto riportando levarie opinioni su colpevoli e cause scatenanti, descrivendole opere di soccorso guidate prontamente dal premurosoprincipe Leopoldo, e riporta la decisione di affidare a Barbaja
i lavori di ricostruzione che hanno inizio il 6 marzo.95 Comeè noto già alla fine dell’anno era pronto il prospetto d’ap-palto del nuovo Teatro San Carlo con l’inaugurazione previ-sta per il 12 gennaio, giorno del compleanno del sovrano.De Nicola, sempre attento al lato economico in ogni suoaspetto, annota con esattezza i prezzi richiesti per palchi esedie, a suo avviso esorbitanti, e come al solito il suo ultimocommento è sull’insensatezza dei suoi concittadini semprepronti a sperperare.96
All’attento orecchio del nostro giungono subito com-menti e opinioni discordi sul risultato della ricostruzione, dataluni giudicata «difettosa» e «disarmonica»:
Il Teatro rifatto di s. Carlo ha dei lodatori e detrattori. Vi è chi diceche la costruzione è difettosa, disarmonica, che il palcoscenico siatroppo alto, cosicchè le prime file di platea non possono goderenel ballo del gioco dei piedi dei ballerini. Che l’ornato è cattivo e dipoca durata. Del resto il P. Taddei estensore del nostro giornale, cene ha dato colle stampe un cenno storico. Nei festini la sala èmolto ristretta, perché divisa dal palcoscenico, a cui si accede perdue scalinate. Parlo per relazione non avendolo veduto. I primi fe-stini sono stati affollatissimi ma in compenso il Ridotto raccoglievaquanti ne capitarono, e fece il suo profitto.97
L’opera rappresentata un mese più tardi è poi un solennefiasco. Si tratta dell’Aganadeca, argomento tratto dai poemiossianici, scritta da due esponenti del governo. De Nicola sidilunga, quasi compiaciuto, nel riportare il clamore dei fischidel pubblico e riferisce che nell’opinione degli autori la pes-sima esecuzione era stata un determinante contributo all’in-successo:
Ieri sera andò in scena a s. Carlo l’Aganateca, poesia di d. Vincenzode Ritis, imitazione dal greco, e musica di d. Carlo Saccente, questocapo di divisione, quello uffiziale del Ministero di Giustizia. V’inter-venne S.A. il Principe di Salerno d. Leopoldo. Il Teatro era affollatis-
115
Barbaja e l’esportazione di un nuovo modello impresariale, «Römische Histo-rische Mitteilungen», 44/2002, pp. 491-506; FRANCESCA SELLER, La copisteriamusicale del teatro San Carlo tra Sette e Ottocento, in «… Et facciam dolçicanti». Studi in onore di Agostino Ziino in occasione del suo 65.o compleanno, acura di Bianca Maria Antolini, Teresa M. Gialdroni, Annunziato Pugliese,Lucca, LIM, 2003, II, pp. 1019-1028.
89 13 ottobre 1806, DE NICOLA, Diario, II, pp. 293-294. Vedi supra nota 61.90 13 aprile 1815, ivi, p. 800.91 10 giugno 1815, DE NICOLA, Diario, III, p. 17.92 19 giugno 1815, ivi, p. 20.93 6 luglio 1815, ivi, p. 26 e 21 luglio 1815, ivi, p. 30.94 13 febbraio 1816, ivi, p. 59.
95 14 febbraio (ibidem), 15 febbraio (ivi, pp. 59-60), 16 febbraio (ivi, p.60), 17 febbraio (ibidem), 21 febbraio (ivi, p. 61), 28 febbraio (ivi, pp. 61-62)e 6 marzo 1816 (ivi, pp. 64-65).
96 31 dicembre 1816, ivi, p. 98.97 17 gennaio 1817, ivi, p. 101.
FONTI MUSICALI ITALIANE
simo, il prezzo dei biglietti di platea numerosi fu di carlini 8, quellodei palchi in 10 carlini più dell’ordinario. Ma da più giorni nonv’erano più né biglietti né palchi. Saccente se ne avea presi, chi dice300, chi 150, pei suoi amici. Lo spettacolo fu spesoso e sorpren-dente, ma la composizione fu fischiata, non ostante la presenza diS.A. Cominciarono i fischi sotto voce, ma crebbero poi a segnoche si arrivò a fischiare colle dita e colle chiavi, e mi si dice anchecolla tofa così detta. Mi si dice pure che il duca d’Ascoli fosse an-dato a ricevere gli ordini di S.A. per procedere a qualche arresto,ma S.A. non volle. E questa di lui tolleranza fece crescere i fischi. Ipartegiani del compositore dicono che fu tutto spirito di partito,che i stessi cantanti e l’orchestra concorsero a farla fischiare. Chela stessa celebre cantante Signorina Colbrand uscì di tuono e l’or-chestra di tempo. Dicono che il pubblico non gusta la musica sen-timentale, ed il gusto greco della poesia. Il soggetto di questo èpreso dai canti di Ossian. Il ballo analogo, che comprende l’interoterzo atto fu sollevato essendo musica fatta appostatamente dalconte di Callemberg, grande compositore di musiche per ballo.Di apparenze vi è nel libretto quanto si puol desiderare. Sole chespunta, Aurora boreale, mare, e navi che approdano, marcie, carri,caccia, tempesta, folgori, baleni, tumulto, fatti d’arme. E finisce com-parendo in scena il cadavere di Aganateca fatta uccidere dal padre.Ogni nazione ha i suoi gusti, e se si vedessero ora, o i giuochi gla-diatorii che facevano le delizie di Roma antica, o quei della Grecia,e le donzelle nude discendere nell’arena e lottare con giovanetticome le Spartane, la Nazione inorridirebbe.Il Ministro dell’Interno che ha molto appoggiato questo tentativodrammatico, come lo chiamano i loro autori, era sulle spine al Tea-tro. Colle mani faceva segno al publico che si frenasse. Barbaja, cheprofitta di tutto, mi si dice, che sia corso dal Ministro questa mat-tina, dicendo aver perduto ieri sera ottomila ducati, ed aver sof-ferto il Teatro moltissime migliaia di guasto per gli ornati, rovinatidal fracasso si faceva dai spettatori sui palchi e sulle sedie. La suabanca nel festino fu in perdita, ma tanto ha ottenuto che il Ridottosia aperto in tutte le sere che ci è rappresentazione.98
Vi sono poi notizie su accademie di scherma,99 spettacolidi giochi di prestigio nei teatri,100 esibizioni di acrobati chepromettono numeri spettacolari con ascese aereostatiche«nelle acque della darsena».101
L’atteggiamento di De Nicola nei confronti dei divi – can-tanti o ballerini – idolatrati dal pubblico, è sempre quello so-spettoso del cittadino onesto che si scandalizza di fronte agliesagerati compensi.
È venuto un ballerino per S. Carlo che durante la fabrica di questoTeatro, che da più anni a questa parte si rinnova ogni anno, dicoche San Carlo è chiuso, balla nel Teatro del Fondo. Or costui ha dipaga ducati 1200 al mese, casa a Toledo, carrozza, e nelle sere cheballa vi è porta doppia al Teatro, e ciò nel mentre che le primesere di s. Carlo con illuminazione, il prezzo dei biglietti era di cin-que carlini, ora quello dei biglietti serali al Fondo è di carlini nove.Ai Teatrini dei Fiorentini e Nuovo il biglietto, ch’era di carlini due,oggi è cinque e sei, e pure si va al Teatro.102
Le notizie musicali maggiormente menzionate nel Diarioriguardano le esecuzioni di musica sacra. In alcuni casi le in-dicazioni del diarista permettono di scoprire nuovi dettagliancora sconosciuti.
Nella Real Cappella anco S.M. celebrar fece i solenni funerali [perla morte del papa Pio VII] con musica nuova portata da Vienna, eBianchi, l’ingegnere che regola la fabbrica dell’anfiteatro e chiesa allargo del Real Palazzo, fece il disegno della machina funebre chenon fu gran cosa.
116
98 17 febbraio 1817, ivi, pp. 105-106. In quel periodo si trovavano aNapoli Stendhal e Louis Spohr che riportarono nei loro appunti di viaggiole vicende legate alle aspettative per l’Aganadeca, definita tentativo dram-matico e, dopo aver assistito alla rappresentazione, le aspre critiche che neseguirono. Si veda STENDHAL, Roma, Napoli e Firenze, II, Prefazione di CarloLevi, Introduzione critica di Glauco Natoli, Milano-Firenze, Parenti, 1960,
pp. 29-32 e LOUIS SPOHR, Lebenserinnerungen, erstmals angekürzt nach demAutographen Aufzeichnungen, hrsg. von Folker Göthel, Tutzing, Schneider1968, p. 22 e passim. Ampi stralci delle due testimonianze sono riportati inROSA CAFIERO, Vita musicale a Napoli negli appunti di viaggio di Louis Spohr(febbraio-marzo 1817), «Bollettino del Centro rossiniano di studi», XLVI,2006, pp. 33-66. Questa cronaca di De Nicola è citata anche da JOHN ROS-SELLI, Artisti e impresari, in Il Teatro di San Carlo, 2 voll., Napoli, Guida, 1987, I,pp. 27-60.
99 19 agosto 1817, DE NICOLA, Diario, III, p. 130.100 22 agosto 1817, ivi, pp. 130-131.101 14 marzo 1819, ivi, p. 163.102 29 giugno 1814, DE NICOLA, Diario, II, pp. 740-741. Il ballerino cui De
Nicola si riferisce – lo nota De Blasiis – è Duport.
MARINA MARINO – MUSICA E SPETTACOLO NEL «DIARIO NAPOLETANO»
Monsignor Nunzio li fece più solenni nella chiesa di s. Giacomodei Spagnoli, chiesa di sua giurisdizione, ove celebrò pontifical-mente alzando trono. La machina fu ideata e diretta dall’ingegnered. Antonio Barletta presa dalla mole di Traiano. L’orazione la re-citò Monsignor Colangelo Vescovo di Castellammare. La musica ladiresse il maestro Perla.103
I teatri cittadini sono menzionati molto spesso: in realtànella maggioranza dei casi i commenti sono più a propositodell’aspetto mondano, delle circostanze politiche che si cele-bravano, dell’elevato costo dei biglietti più che di vere re-censioni. Il San Carlo è naturalmente quello più ricorrente(trova spazio in ben 86 giornate dell’intero Diario), ma ven-gono citati anche il Fondo,104 il Fiorentini,105 il teatrino di
corte,106 il San Ferdinando,107 il «gran teatro eretto al largodel Castello»,108 il Nuovo.
De Nicola, pur non essendo un grande conoscitore dellamateria, mostra tuttavia una speciale sensibilità per talune‘usanze’ teatrali come nel caso della riflessione sull’uso dirappresentare drammi sacri in teatro («I Teatri che si apri-rono ieri cogli Oratorii sacri e tragedie, giusta il costume daqualche anno introdotto, si sono chiusi pel triduo della de-funta Sovrana»),109 o come nell’attenzione alle politiche legi-slative in materia teatrale:
117
103 22 settembre 1823, DE NICOLA, Diario, III, pp. 287-288. Questa noti-zia, che dà un’ulteriore prova della diffusione napoletana della Messa da re-quiem di Peter von Winter, è stata riportata in CAFIERO- MARINO, La musicadella real camera, p. 152.
104 Citato per la presenza del generale Championnet il 27 gennaio1799 (DE NICOLA, Diario, I, p. 36), per i disagi dovuti al clima poliziescodegli ultimi momenti della stagione giacobina vissuti da un violinista di quelteatro (22 aprile 1799, ivi, p. 115), per il già menzionato Timoleone (1 giu-gno 1799, ivi, p. 163), ancora per la cantata Vero Patriottismo (2 giugno 1799,ivi, p. 166). Il teatro è poi sede di feste: «La nobiltà Napoletana si prepara adare una festa al Principe ereditario nel Teatro del Fondo di Separazione, eseguendo l’etichetta spagnuola, che si vuol restituire in Napoli, sarà l’invitoin abito di spada e borsa» (6 febbraio 1801, DE NICOLA, Diario, II, p. 13); «Es-sendosi portata questa mattina una deputazione di Cavalieri a pregare S.A.per una festa che nel giorno del di lui nome pensavano di dare nel Teatrodel Fondo di Separazione. S.A. ha risposto che gradiva l’offerta, come lafesta medesima, ma sapendo le circostanze di tutta Napoli, non voleva ches’interessasse, e però la rinunziava ed aveva la festa come fatta» (13 marzo1806, ivi, p. 234). Negli anni successivi alla restaurazione borbonica il teatroospita per lo più spettacoli di giochi: 4 agosto 1817 (DE NICOLA, Diario, III,pp. 128-129), 19 agosto 1817 (ivi, p. 130), 22 agosto 1817 (ivi, pp. 130-131).
105 A proposito del già citato scandalo della ballerina seminuda (29gennaio 1799, DE NICOLA, Diario, I, p. 38), di una cantata e ballo analogo cuiassiste lo stesso De Nicola (3 novembre 1799, ivi, pp. 368-369), di spetta-coli di prosa come uno rappresentato dalla «compagnia Lombarda» (6febbraio 1801, DE NICOLA, Diario, II, p. 13), o di quello – di cui si discuteràoltre – intitolato Amor di patria (12 febbraio 1821, DE NICOLA, Diario, III, pp.249-251).
106 Il teatrino diventa sede delle riunioni della commissione legislativa(16 aprile 1799, DE NICOLA, Diario, I, p. 108), pochi mesi dopo torna adospitare spettacoli teatrali (4 novembre 1799, ivi, p. 369) che durante il ‘de-cennio’ sono per lo più rappresentazioni francesi (1 gennaio 1808, DE NI-COLA, Diario, II, p. 386).
107 9 settembre 1801, ivi, p. 83. 108 «Avanti al gran Teatro eretto al largo del Castello, sul modello dei
Teatri di Pompei, era innalzata su di un piedistallo una statua dinotante laDiscordia, che al passare di S.M. è precipitata, e n’è surta invece una di unGenio alato che corona il busto di S.M. Tutto l’interno del vasto Teatro eracoverto da popolo spettatore vestito alla Romana. La sera le machine sisono illuminate, e le principali sono state: quella che ho accennata al largodl Castello Nuovo, all’incontro della quale altra se n’è innalzata sulle fabri-che della Reale Armeria che figurava la base di due tempietti alusivi, unodedicato alla Pace colla iscrizione Sacrum hoc Paci, un altro a Pallade colmotto greco dedicato a Pallade. Nel mezzo un obelisco alla Egizia che illu-minavasi a lume trasparente. Avanti la porta del Real Castello altra ma-china si è inalzata figurante un fronte di attacco secondo le ultime regoledi fortificazione con due trofei di armi antiche e moderne e con una sta-tua colossale di S.M. sulla porta colla seguente iscrizione: Arx Fernandavocor nomen mihi Regis adoptans Fulmine terrificans nomine corda traens» (27giugno 1802, ivi, pp. 120-121); «Anche quest’oggi, il dopo pranzo, S.M. èuscito per andare a visitare la Madonna del Carmine, ed ha voluto nelpassaggio pel largo del Castello vedere di nuovo il Teatro vestito collagente sopra, e rinnovare la caduta della statua della Discordia, non essendoarrivato a vederla nel giorno del suo ingresso» (29 giugno 1802, ivi, p.122).
109 8 marzo 1802. La defunta sovrana è la Regina di Sardegna MariaAdelaide Borbone, sorella di Luigi XVI. Si veda FRANCO PIPERNO, “Stellatisogli” e “immagini portentose”: opere bibliche e stagioni quaresimali a Napoliprima del “Mosè”, in Napoli e il teatro musicale in Europa tra Sette e Ottocento.Studi in onore di Friedrich Lippmann, a cura di Bianca Maria Antolini e Wolf-gang Witzenmann,Firenze, Olschki, 1993, pp. 267-298.
FONTI MUSICALI ITALIANE
Altro editto si è pubblicato direttamente da S.A.I. riguardante lapolizia che trascrivo integralmente [...] Noi, Napoleone GiuseppeBonaparte [...] Vi sarà per tutto il Regno di Napoli un ministro diPolizia generale [...] Avrà [...] il dritto di fare dei regolamenti sullastampa e sopra i Teatri [...] Farà vegliare sulle case di giuoco e luo-ghi di dissolutezza. [...] Napoli addì 28 febbraio 1806.110
Fra i compositori del periodo il più citato è Paisiello. Dilui si riferisce costantemente, mai per le opere teatrali, bensìper due forme di composizioni sacre: i Te Deum e le messeda requiem:
La festa fatta da nostro ceto è riuscita magnifica questa mattina. Viè intervenuto il Card. Vicario Ruffo, il maresciallo Micheroux, moltiCavalieri dell’Ordine di s. Gennaro, il marchese Simonetti colle Se-greterie, e tutto il Corpo del Ministero [...] il concorso è statonumerosissimo, e che il Ministero abbia risoluto di fare un’altrafesta a sue spese domenica ventura nella chiesa di s. Chiara. Do-menica pure l’ordine dei Cavalieri di Malta farà lo stesso a s. Nicoladella Carità. Domani al giorno Paiesiello, per sua particolare devo-zione, farà cantare un Te Deum nella chiesa di s. Lorenzo, ove siprepara solenne festa poi del popolo per giovedì. Per Napoli poitutto è festa e musica e fuochi artificiali per le strade che fa piacere[...].111
S. Eminenza Ruffo ha presa la benedizione in s. Lorenzo maggiorequesta mattina, ed ha assistito al Te Deum cantato dal popolo indetta chiesa, ove prima si son benedette le bandiere del Corpo diRealisti formato da d. Camillo Santucci. [...] Quest’oggi si è can-tato il solenne Te Deum, musica di Paisiello, da lui diretta nella d.ªchiesa di s. Lorenzo. Si era detto che al d.° maestro erasi proibitolo battere, ma egli lo ha chiesto in grazia, dicendo averlo promessoin voto. È ragionevolmente in disgrazia, perché dichiarato maestrodi cappella compositore della Repubblica, pose in musica gl’innicantati innanzi al Real Palazzo sotto l’albore, ed andò in Roma amettere in musica l’Aristodemo [...] Questa sera, dopo il solenneTe Deum cantato in s. Lorenzo, musica del Paisiello, vi è stato fuoco
d’artifizio innanzi alla detta chiesa, e la solita illuminazione, con-corso immenso di popolo, ma senza disturbo.112
Nella chiesa di Donna Romita si è cantato solenne Te Deum per laesaltazione del Sommo Pontefice con musica del Pajesiello, e vi èintervenuto il generale Moscovita, che questa notte è partito perPalermo.113
Il Senato solennemente ha fatto celebrare i funerali della Real Prin-cipessa in s. Chiara con sontuosa e nuova macchina e musicagrande diretta dal maestro Paisiello.114
Alle dodici di Francia è passata per Toledo l’esequie del Ministro[...] Arrivato alla chiesa di s. Giacomo vi è stata salva di cannoni si-tuati al largo del Castel Nuovo. [...] La chiesa mi si dice che fossedisposta colla più magnifica pompa di lutto che possa immaginarsi.La musica funebre è stata di Paisiello.115
In questo foglio medesimo n.° 238 [del «Monitore»], sotto la datadi Napoli, si portano le dimostrazioni di allegria per la ricorrenzadel nome della Regina il dì 4 novembre, cioè teatri gratis la seraprecedente Tedeum la mattina con musica nuova di Paisiello, e cir-colo in corte. Trentatré carri di vettovaglie ed abiti girarono la cittàdestinati ai Stabilimenti di publica beneficenza, tavole inbandite lasera in tutti i quartieri pei poveri, parata nella riviera di Chiaia, lasera festa di ballo a Palazzo.116
Questa matina si è cantato solenne Tedeum con musica del Pai-siello nella cattedrale per la liberazione del Pontefice.117
Si celebrano quest’oggi i solenni funerali di Maria Carolina d’Au-stria già nostra Regina in s. Paolo maggiore chiesa: [...] Il concerto èstato grande, l’orazione funebre è stata recitata da Mons. Pinto Ar-civescovo di Salerno, la musica del Paisiello [...].118
118
110 3 marzo 1806, DE NICOLA, Diario, II, pp. 225-227.111 28 luglio 1799, DE NICOLA, Diario, I, pp. 260-261.
112 1 agosto 1799, ivi, pp. 266-268. Il riferimento all’Aristodemo è er-rato giacché quest’opera non risulta fra quelle composte da Paisiello.
113 29 aprile 1800, ivi, p. 451.114 9 dicembre 1801, DE NICOLA, Diario, II, p. 97.115 29 dicembre 1809, ivi, p. 511. Il ministro defunto era Saliceti.116 1 novembre 1811, ivi, p. 587.117 12 aprile 1814, ivi, p. 707.118 7 settembre 1815, DE NICOLA, Diario, III, p. 37.
MARINA MARINO – MUSICA E SPETTACOLO NEL «DIARIO NAPOLETANO»
Così come si era passata in modo neutrale la notizia dellapartecipazione di Paisiello alla causa giacobina,119 a distanza didue anni si afferma con orgoglio che «Il celebre maestro Pai-siello è stato chiesto da Bonaparte a Parigi per la festa dellaPace, e con dispaccio gli si è ordinato di partire. Egli si è scu-sato, ma sento abbia avuto altro dispaccio che subito parta.La Francia vuole il migliore che vi è in Europa in ogni ge-nere».120
Se le numerose citazioni di Paisiello non stupiscono, me-raviglia invece non poco un’unica menzione a Rossini, nep-pure riferita ad alcuno dei suoi melodrammi.121 Il periodo èquello dei moti del 1820-21, da poco si è ottenuta la Costi-tuzione di Spagna ma la situazione politica è ancora moltosurriscaldata per le trame di Metternich che mirano a con-solidare le monarchie assolute, prima fra tutte quella di Fer-dinando I di Borbone. Il 9 febbraio 1821 al Teatro deiFiorentini una commedia in prosa entusiasma ed accende ilpubblico per il suo contenuto libertario. De Nicola, nel rife-rire ogni dettaglio, addirittura descrive le forti recriminazionidegli spettatori contro l’attore che impersonava il tiranno,costretto ad uscire momentaneamente dal ruolo per giustifi-care la sua finzione scenica, ma precisando il suo orienta-mento politico. Sull’onda del travolgente successo si chiede, esi ottiene, di poter replicare la commedia al Teatro San Carlo.Al termine della commedia – De Nicola scrive nella stessagiornata annunciando l’imminente avvenimento – sarebbestato eseguito un inno su testo del «deputato Borrelli» emusicato da Rossini.
Si rappresentò la sera del giorno 9 nel Teatro dei Fiorentini unaprosa che porta il titolo di Amor di Patria. Si fece un chiasso di voci«mora il tiranno, viva la libertà» in un momento in cui l’attore Tes-
seri, che faceva la parte del tiranno, come suol dirsi, recitò alcuniversi contrarii alla libertà. Tanto che l’attore medesimo fece cessarecolui che suggeriva, si fece sul davanti del teatro e si protestò averegli recitate le parole del libretto, ma che i suoi sentimenti eranoper la libertà. Ebbe applausi e si chiese la replica della comedia in S.Carlo, ove si è annunziata per questa sera con appalto sospeso.Il deputato Borrelli ha composto un inno, ed ha fatto metterlo inmusica dal maestro Rossini per farlo cantare dopo la recita questasera stessa.122
De Nicola riporta quindi interamente il testo123 dell’Innointitolato Inno di guerra, consistente in tre stanze di otto versidecasillabi, ciascuna seguita da un’altra coppia di versi affi-dati al coro.
Inno di guerra.
1.Chi minaccia le nostre contrade?L’innocenza chi ardisce assalir!Cittadini snudiamo le spade,Pria si cada che i ceppi soffrir.Vecchio padre qual tema ti rode,A che muto mi guardi così?Piangerai sulla tomba del prode,Non sull’onta del vil che fuggì.Coro – Cittadini son nude le spadePria si cada che i ceppi soffrir.
2.O straniero che guerra ci portiChi ti offese? quell’ira perché?Va rispetta la terra dei forti,È servile profano quel piè.
119
119 19 maggio 1799, DE NICOLA, Diario, I, p. 144. Vedi supra nota 24.120 21 dicembre 1801, DE NICOLA, Diario, II, p. 98.121 Oltre a Paisiello e Rossini De Nicola fa riferimento a Cimarosa
(nella più volte citata giornata del 19 maggio 1799, DE NICOLA, Diario, I, p.144 – per la quale si rimanda nuovamente alla nota 24 – e a proposito delsuo arresto il 9 dicembre 1799, ivi, p. 391, vedi supra nota 31) e a GiacomoTritto (il 27 gennaio 1799, ivi, p. 36, menzionando unicamente il Nicaborosenza citare tuttavia il nome dell’autore – vedi supra nota 12 – e il 24 lu-glio 1799, ivi, p. 257 per cui si rinvia alla nota 26).
122 12 febbraio 1821, DE NICOLA, Diario, III, pp. 249-250.123 In alcune altre occasioni De Nicola annota con scrupolo testi di
canzoni, poesie e filastrocche. Si veda ad esempio la notizia del 20 giugno1799 in cui l’autore racconta come, per trascrivere le parole di una can-zone che aveva udito cantare sulle note della Marsigliese da alcune guardiesotto casa sua, avesse fatto salire queste ultime per farsele dettare (DE NI-COLA, Diario, I, p. 204).
FONTI MUSICALI ITALIANE
Ma sprezzante l’iniquo c’invadeHa di sangue nell’occhio il desir.Cittadini tocchiamo le spade,Qui si giuri svenarlo o morir.Coro - Cittadini tocchiamo le spadeQui si giuri svenarlo o morir.
3.Ombre bieche degli avi possentiDeh squarciate dei nugoli il vel,E la strage dell’estere gentiRimirate dai nembi del Ciel,Libertà, libertà si difende,Si difende la gloria, la fè.Già gli allori Giustizia ci stende.Viva viva la Patria ed il Re.Coro – Libertà libertà ec.124
Quella sera al San Carlo – stando a quanto ci dice lostesso De Nicola il giorno successivo – almeno la commediafu rappresentata,125 mentre nulla di più sappiamo da De Ni-
cola riguardo all’inno rossiniano. Questa vicenda è stata direcente discussa nelle Lettere e Documenti di Rossini:126 ildramma Amor di patria viene segnalato al teatro dei Fioren-tini l’8 febbraio e replicato il 12 febbraio al San Carlo senzaalcuna menzione per l’inno che risulta invece cantato al SanCarlo il 2 marzo 1821 e ripetuto il 5 marzo. Il «Giornale delRegno delle due Sicilie» del 4 marzo attribuiva la paternitàdell’inno al cantante Ciccimarra. I curatori del volume rossi-niano fanno poi notare che il metro del testo Chi minaccia lenostre contrade è in decasillabi come quello dell’inno che Ros-sini aveva scritto per l’arrivo di Murat a Bologna nel 1815,Sorgi Italia, venuta è già l’ora, che non è sopravvissuto.127 Nonè improbabile quindi che nel 1821 si sia riutilizzata una mu-sica scritta in precedenza.128 Questa rimane comunque perora ancora una teoria, tutta da dimostrare o da smentire, edunque il caso della reale paternità musicale dell’inno è an-cora aperto.
120
124 Si veda la riproduzione delle due pagine autografe del Diario relativea questa giornata.
125 13 febbraio 1821 (DE NICOLA, Diario, III, p. 252). Ciò è confermatoanche nel n. 57 del 6 marzo 1821 del «Giornale costituzionale del Regnodelle due Sicilie» in cui si legge: «Mentre il Signor Calvarola rilascia indono patriottico quella parte d’introito che gli spetta nella serata di suobeneficio, il Signor Barbaia, non men generoso, consacra allo stesso nobi-lissimo oggetto l’altra parte che per patto di scrittura a lui appartiene. Intal modo una metà dell’introito vien donata dal primo l’altra metà dal se-condo. In questa stessa occasione giova aggiungere, che nella sera in cui furappresentata in S. Carlo l’Amor di Patria, l’impresario cedette in dono pa-triotico ducati quattrocento, che, in vigore del suo contratto, avea dritto diesigere dando in quella sera il teatro. Noi non dubitiamo che questi belliesempli non sieno per essere imitati e da altri attori e da altri impresari.Tutto giova al Tesoro Nazionale; le grandi somme sono formate di picciolielementi». Ringrazio l’amica Rosa Cafiero per la segnalazione.
126 Gioachino Rossini. Lettere e Documenti, a cura di Bruno Cagli e SergioRagni, Pesaro, Fondazione Rossini, 1992, I, p. 482n.
127 Sull’inno per Murat vedi anche MARCO BEGHELLI, Bologna, nobile pa-tria di aggressioni e di mortadelle, in Rossini 1792-1992, a cura di Mauro Bu-carelli, Perugia, Electa, 1992, pp. 71-98: 87.
128 Philip Gossett – che mi ha scritto in proposito la sua opinione eche ringrazio – non trova affatto strano che ci si possa essere serviti diuna stessa musica per un testo con lo stesso metro e trova inoltre moltodifficile che Borrelli possa aver fatto scrivere un brano nuovo a Rossini.
MARINA MARINO – MUSICA E SPETTACOLO NEL «DIARIO NAPOLETANO» 121
Fig. 1 e 2: Pagine autografe del Diario napoletano di Carlo De Nicola, relative al 12 febbraio 1821 (I-Nsn, fondo manoscritti, S.B.N. XXI B. 16-21: 21, cc. 180r. -181r.).