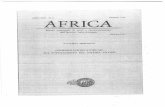Le necropoli romane della pianura bresciana: i dati della Carta Archeologica e aggiornamenti
Il popolamento del territorio veronese durante l’età del ferro (con F.Candelato e M.Saracino), in...
Transcript of Il popolamento del territorio veronese durante l’età del ferro (con F.Candelato e M.Saracino), in...
Anche la cultura veneta, analogamente alle altre facies protostoriche italiane,fino a poco tempo fa era conosciuta soprattutto per le testimonianze delle necro-poli. Nel caso del Veronese, dobbiamo soprattutto alle ricerche e alle campagnedi scavo organizzate e dirette negli ultimi venticinque anni da Luciano Salzaniuna conoscenza, sia pure ancora lacunosa, degli abitati e dei luoghi di cultodell’età del Ferro1. Salzani aveva cominciato collaborando con il Museo di StoriaNaturale di Verona, cui si devono le prime “pionieristiche” ricerche in questocampo; negli ultimi anni all’attività di queste due istituzioni – la Soprintenden-za e il Museo – si è aggiunta quella dell’Università di Verona, soprattutto perquanto riguarda la ricerca sul campo a Oppeano.
Seguendo sostanzialmente la più recente sintesi archeologica sull’età del Ferronel Veronese pubblicata da Salzani (2002a), si cercherà qui di esaminare, pergrandi linee, il popolamento delle due aree meglio conosciute, la fascia collinareposta lungo i margini meridionali dei Lessini e l’area delle Grandi Valli Verone-si, tentando anche di ricostruire la fisionomia, nell’età del Ferro, dell’area su cuisarebbe sorta la Verona di età romana.
Le poche presenze significative della riva sinistra del medio corso dell’Adige,come l’abitato dell’VIII-VII secolo a.C. di Cologna Veneta (Salzani 1990, p.48), relativo alla nota necropoli di Baldaria2, quello di Pressana (Salzani 1990,p. 50) e il piccolo nucleo insediativo di Veronella (Salzani 1993), la cui datazio-ne si inquadra nel primo periodo atestino, non verranno qui trattate, data l’ap-partenenza di tale territorio, destinata a durare fino all’età romana, all’Agro Ate-stino (Salzani 2002a, p. 166); un ritrovamento isolato, ancora sostanzialmenteinedito, è infine quello, effettuato a Sommacampagna, di materiali di abitatodel V secolo a.C.
La seconda parte dell’articolo sarà invece dedicata a una breve rassegna dei ri-sultati delle ricerche, in particolare la campagna di scavo del 2003, effettuatedall’Università di Verona a Oppeano.
Alessandro Guidi, Federica Candelato, Massimo Saracino
Il popolamento del territorio veronesedurante l’età del Ferro
1. Abitati del Veronese (fig. 1)
1.1. Verona
A parte alcune sepolture dell’età del Ferro, individuate e scavate a Ponte Flo-rio e relative alle fasi più antiche di occupazione dell’abitato di Montorio (Sal-zani 1996a; De Angelis 2002), fino a pochi anni fa si conoscevano solo alcunenotizie di rinvenimenti di età protostorica sul sito attualmente occupato dallacittà di Verona.
La recente pubblicazione di una carta archeologica di tutti i siti preistoricidel comune, effettuata riunendo le notizie relative ai materiali conservati dalMuseo di Storia Naturale e quelle dell’archivio del Nucleo Operativo della So-printendenza Archeologica del Veneto (Aspes et alii 2002), permette ora diconfermare, in base all’evidente addensamento di presenze dell’età del Ferro(fig. 2), l’ipotesi espressa recentemente da Luciano Salzani (2002a, p. 186)dell’esistenza di un nucleo abitativo di discrete dimensioni, posto sulla riva si-nistra dell’Adige.
All’abitato potrebbero esser attribuiti i materiali databili alla prima età delFerro da via San Carlo (Aspes et alii 2002, n. 13) e soprattutto quelli della tar-da età del Ferro (IV-II secolo a.C.) di Santo Stefano (ibid., n. 14), via RegasteRedentore (ibid., n. 15), Castel San Pietro (ibid., n. 16) e Binastrova (ibid., n.19); materiali in gran parte databili alla stessa fase provengono da Monte Suel-lo (ibid., n. 12, fig. 7/4-6 e 8/1 e 7), anche se non mancano frammenti riferibi-li a un momento forse avanzato della prima età del Ferro (ibid., n. 12, fig. 7/1-3). Monte Suello è inoltre l’unica località dove viene registrata la presenza deimateriali all’interno di tre “fondi di capanna”, uno forse riconoscibile nellestrutture fotografate nella breve nota presentata da Salzani sul rinvenimento nel1983 (Salzani 1983, fig. 4). Ancora più interessante è il dato relativo alle tre pre-senze databili a questa fase, poste a una certa distanza dal gruppo principale dirinvenimenti (fig. 2, nn. 8, 11 e 22). Ben due di esse, in base sia al tipo di og-getti (bronzi) – Porta San Giorgio (Aspes et alii 2002, n. 8, fig. 6) e vicolo Di-sciplina (ibid., n. 22, fig, 12), che alle pur scarse notizie relative alle condizionidi giacitura e all’associazione con materiali scheletrici o resti di cremati (ibid., n.22), sono quasi certamente pertinenti a sepolture collocabili cronologicamentetra l’VIII e gli inizi del VII secolo a.C.
I dati raccolti ci permettono di ipotizzare l’esistenza di un primo nucleodell’abitato, sorto agli inizi dell’età del Ferro, nell’area posta in pianura, a pocadistanza dall’Adige, a ovest dell’altura di Castel San Pietro; in un secondo mo-mento (almeno dal IV secolo a.C.), tale abitato avrebbe inglobato l’altura e le suependici orientali, raggiungendo un’estensione non inferiore ai 20 ettari (vedi areaipotetica a fig. 2).
Alessandro Guidi, Federica Candelato, Massimo Saracino16
Il popolamento del territorio Veronese durante l’età del Ferro 17
Figura 1. Distribuzione dei principali siti dell’età del Ferro citati nel testo (elaborazione M. Saracino):1. Verona, 2. Cologna Veneta, 3. Pressana, 4. Sabbionara di Veronella, 5. Sommacampagna, 6. Roccadi Caldiero, 7. Monte Zoppega, 8. Monte Casteggioni, 9. San Briccio di Lavagno, 10. Castejon di Mo-lina, 11. San Zeno di Colognola ai Colli, 12. Castel Sottosengia, 13. Gargagnago, 14. Sant’Ambrogio diValpolicella, 15. Sant’Ambrogio di Valpolicella, fondo Matio, 16. Monte San Giovanni, 17. Monte Cor-netto del Semalo, 18. San Giorgio di Valpolicella (Torre, Pieve, Borgo Aleardi, Casaletti), 19. Monto-rio, 20. Monte Sacchetti di Castelrotto, 21. Archi di Castelrotto, 22. Castellazzo della Garolda, 23. Ca-stiglione Mantovano, 24. Terranegra (Legnago), 25. Lovara di Villabartolomea, 26. Castion di Erbè,27. San Vito di Cerea, 28. Crosare di Bovolone, 29. Gazzo Veronese, 30. Oppeano.
1.2. Gli abitati d’altura
Prima delle ricerche effettuate, a partire dagli anni Ottanta, da Luciano Salzani,si riteneva che si trattasse di insediamenti sviluppatisi quasi tutti nella tarda età delFerro, con forti connotazioni “retiche”. Oggi si sa che molti di essi (Monte Zoppe-ga, Monte Casteggioni, San Briccio di Lavagno, San Giorgio di Valpolicella, loca-lità Torre e, probabilmente, Montorio) iniziano già nel corso del IX secolo a.C. esono caratterizzati da una cultura materiale tipicamente veneta3, destinata ad esse-re gradualmente soppiantata dagli influssi retici solo a partire dal IV secolo a.C.
Alessandro Guidi, Federica Candelato, Massimo Saracino18
Figura 2. Verona, presenze di età protostorica; è indicata l’estensione presumibile dell’abitato a partire dalIV secolo a.C.; i pallini più chiari sono le presenze dell’età del Ferro (rielaborato da Aspes et alii 2002).
In un recente articolo, Luciano Salzani ha tentato di sintetizzare i dati archeo-logici relativi a questo tipo di abitati (Salzani 2002a, pp. 186 e 190, tav. XVI), ca-ratterizzati dalla posizione difesa, a volte con vere e proprie mura di cinta (è il ca-so dell’abitato, purtroppo completamente distrutto nel 1973, di Castel Sottosen-gia), con strutture poste lungo le pendici e/o sulla sommità, in genere di tipo se-minterrato a uno o più vani, con murature realizzate utilizzando anche lastre dicalcare o arenaria per le fondazioni (o in alcuni casi perfino per le coperture), sca-le d’accesso, panche e sedili scavate nella roccia, tetti a uno o due spioventi, nellatradizione della “casa retica”, un tipo di edificio ben diffuso in tutto l’arco alpinoorientale (Migliavacca 1993, 1998).
A un primo gruppo, nell’area pedemontana a est di Verona, appartengonoSan Briccio di Lavagno, Rocca di Caldiero, San Zeno di Colognola ai Colli,Monte Zoppega e, soprattutto, il sito pluristratificato di Montorio. Qui è stataidentificata una casa di circa 81 metri quadrati (fig. 3), il cui primo impianto ri-sale al V secolo a.C., con pianta rettangolare, divisa da una fila di pietre (inter-rotta forse in corrispondenza di una porta) in due ambienti, uno dei quali occu-pato da un grande focolare quadrato e da un vano in cui furono rinvenuti gran-di vasi schiacciati, semi e molti carboni, interpretato dallo scavatore come “ripo-stiglio-deposito”(Salzani 1992a, 2002c).
Un certo numero di abitati d’altura, il cui massimo sviluppo è collocabile traV e I secolo a.C., è stato individuato in Valpolicella. In quest’area, Salzani indi-vidua tre “comprensori”:a) il primo è posto sulle colline di Castelrotto, a poca distanza dall’Adige. Qui,
uno scavo condotto nei primi anni Ottanta in località Archi (Salzani 1987) hapermesso di recuperare, oltre a diverse strutture del V-IV secolo a.C., tra i re-sti incendiati di una casa, più di 1500 semi di vite domestica (Nisbet 1987),a testimonianza della precoce vocazione dell’area per questo tipo di coltiva-zione. Un secondo scavo effettuato nel 1987 a Monte Sacchetti (un abitatodatabile al IV secolo a.C.), ha permesso di dimostrare l’esistenza di case a duepiani (Salzani 1996b, 2002a, tav. XVI, in basso).
b) il secondo è localizzato nelle colline tra Gargagnago, Sant’Ambrogio e SanGiorgio di Valpolicella. Le scoperte più importanti sono proprio quelle effet-tuate sull’altura dove sorge il paese di San Giorgio, posto in posizione strate-gica, su una delle ultime propaggini dei Lessini verso la pianura.Qui, proprio nel centro storico, accanto alla Pieve, gli scavi condotti tra il1985 e il 1989 (Salzani 1992b) hanno permesso di individuare almeno set-te strutture disposte lungo il ripido versante orientale dell’altura (vedi pla-nimetria generale in Salzani 1992b, fig. 4), databili tra la fine del V e il IIIsecolo a.C. Una prevalente utilizzazione di quest’area per le produzioni ar-tigianali è dimostrata, oltre che dai resti della lavorazione dell’osso, del cor-no e della pietra, dall’eccezionale testimonianza delle due fasi di attività del-
Il popolamento del territorio veronese durante l’età del Ferro 19
Alessandro Guidi, Federica Candelato, Massimo Saracino20
Figura 3. Montorio, pianta della strutturaa due vani (da Salzani 2002a).
Figura 4. San Giorgio di Valpolicella, pianta dellestrutture rinvenute in località Pieve (da Salzani1992b).
Figura 5. San Giorgio di Valpolicella, localitàPieve: prima (A) e seconda (B) fase di attivitàdella struttura H (da Guida et alii 1992).
Figura 6. Terranegra di Legnago, planimetriadelle strutture (da Salzani 2002a).
la struttura H (Guida et alii 1992; fig. 5 A e B), una vero e proprio “labora-torio metallurgico”, dove venivano effettuate “la forgiatura e produzione dioggetti in ferro” e il “riciclaggio e rifusione di oggetti ornamentali di bron-zo vecchi o rotti” (Salzani 2002a, p. 1904); da segnalare la scoperta di unanalogo laboratorio in un recente scavo (2002) in località Casaletti, lungo lependici della collina di San Giorgio (Rizzetto 2004).Che San Giorgio fosse abitato nella prima età del Ferro lo dimostra il già cita-to rinvenimento di materiali sulla piccola altura in località Torre che delimitaa nord la collina. Tali materiali erano riferibili a un luogo di culto all’aperto,un podio cui si accedeva da una larga strada, destinato ad essere sostituito, traV e IV secolo a.C., da uno più grande, di forma trapezoidale. La presenza diaree di roghi con materiale votivo tradisce l’influsso dei noti Brandopferpflätzedell’area alpina, mentre una certa tendenza alla monumentalizzazionedell’area, delimitata da un fossato e da un grande muro di cinta, ha fatto pen-sare all’influenza della cultura etrusca (Salzani 2002b; Rizzetto 2004). Va in-fine citato il recente rinvenimento a fondo Matio, un pianoro a sudest di SanGiorgio, di ceramiche e bronzi di età arcaica assieme a un frammento di aes si-gnatum con il ramo secco (Salzani 2002a, p. 190, fig. 16).
c) nel terzo comprensorio, posto nei Monti Lessini, sono presenti, oltre al giàcitato sito di Castel Sottosengia, gli abitati di Monte San Giovanni, Castejondi Molina, Monte Cornetto del Semalo e Monte Loffa. Proprio in quest’ul-tima località uno dei pionieri della paletnologia veronese, Stefano De Stefa-ni, condusse tra il 1883 e il 1886 delle campagne di scavo che permisero diindividuare ben ventisette strutture databili tra il V e il III secolo a.C. (Sal-zani 2001-2002, anche sulle successive campagne di scavo del Battaglia neglianni Trenta). L’analisi attenta delle notizie raccolte da De Stefani ha permes-so di stabilire che alcune delle case erano occupate solo a scopo abitativo, al-tre in realtà erano anche veri e propri laboratori per la lavorazione dei tessu-ti, dell’osso e del corno o per la lavorazione dei cereali, altre infine erano sem-plici granai o stalle (Migliavacca 2001-2002; per la ricostruzione di una del-le case, vedi De Angelis 2001-2002).Proprio a Monte Loffa, in uno scavo d’emergenza diretto da Salzani nel 1986
è stata individuata una capanna rettangolare con pareti e tetto in lastre di calca-re, che dimostra come non tutte le strutture abitative del villaggio fossero di tiposeminterrato (Salzani 2002a, p. 190, tav. XVI, in alto a destra).
1.3. L’area delle Grandi Valli Veronesi
Dobbiamo a Raffaele De Marinis (1999) un’accurata ricostruzione delle vi-cende del popolamento tra IX e V secolo a.C. in questo comparto territoriale.
Già nel periodo compreso tra IX e VII secolo a.C. (De Marinis 1999, fig. 14)
Il popolamento del territorio veronese durante l’età del Ferro 21
Alessandro Guidi, Federica Candelato, Massimo Saracino22
Figura 8. Carta di distribuzione delle presenze di età pro-tostorica di Gazzo con indicazione dell’estensione presu-mibile dell’abitato nella prima età del Ferro (rielaboratoda De Marinis 1999).
Figura 9. Oppeano, planimetria dellastruttura rinvenuta in località Fratte(da Salzani 2004a).
Figura 7. Castion di Erbè, planimetria (da Bettinardi, Leonardi 2002).
si può osservare un’evidente “incorporazione” della maggior parte degli abitati at-torno ai due centri protourbani di Oppeano e Gazzo Veronese, veri e propri cen-tral places dell’area.
Inoltre, va sottolineata la presenza, nel Mantovano, dell’abitato di Castellazzodella Garolda, ubicato su un basso dosso nel paleoalveo del Mincio, più volte in-cendiato e ristrutturato, caratterizzato da una cultura materiale prettamente ve-neta (De Marinis 1999, pp. 536-537, con bibliografia precedente).
Nella fase compresa tra la fine del VII e gli inizi del V secolo a.C. – l’epocadella prima espansione territoriale etrusca – il popolamento dell’area presentauna maggiore concentrazione dell’insediamento a Gazzo e a Oppeano (De Mari-nis 1999, fig. 20); è di questo periodo la fondazione di un altro abitato veneto,Castiglione Mantovano, esteso più di quattro ettari e mezzo, nella zona “di fron-tiera” compresa tra il Tione e il Mincio (Menotti 1999, 2005, infra).
Quando, nel corso del V secolo a.C., gli Etruschi occupano definitivamentequest’area, il quadro del popolamento muta in modo radicale (De Marinis 1999,fig. 25). Scompaiono, oltre a Castellazzo della Garolda e Castiglione Mantovano,quasi tutti i centri minori dell’area compresa tra Adige e Tione, mentre Gazzo5 siridimensiona e soprattutto appare permeato da forti influssi etruschi; in questanuova situazione, come ha giustamente notato Raffaele De Marinis, “...Oppeanodiventa l’avamposto occidentale del mondo veneto” (De Marinis 1999, p. 558).
Due dei centri “minori” dell’area delle Grandi Valli, Terranegra di Legnago eLovara di Villabartolomea, risultano essere stati già sede di abitati dell’età delBronzo, abbandonati alla fine dell’età del Bronzo recente e rioccupati tra VIII eVII secolo a.C. (c’è anzi evidenza di un riutilizzo e un rinforzo delle strutture di-fensive – palizzate e fossati – dell’età del Bronzo nella prima età del Ferro).
A Terranegra (Rizzetto1996, Salzani 2002a, p. 176), un abitato con materialidatabili tra il VII e il V secolo a.C., sono presenti due capanne di 10x5 m (fig. 6),separate tra loro da una canaletta con funzione sia di drenaggio che di scarico deirifiuti, caratterizzate dalla presenza di pavimenti in limo e suddivise in più vani,con focolari costruiti su “vespai” di cocci. I buchi di palo posti lungo i marginiindicano che l’alzato doveva essere di legno e frasche.
Nella pianta sono inoltre ben visibili due pozzetti utilizzati, secondo Salzani,come fosse di scarico nella fase di abbandono del villaggio. Anche a Terranegra,infine, è ben attestata la lavorazione dell’osso e del corno.
A Lovara di Villabartolomea (Salzani 2002a, pp. 170-171) gli scavi di emer-genza hanno accertato la presenza di una rete di canali e di gruppi di strutturecon materiali databili per la maggior parte tra VII e VI secolo a.C., alternati aspazi liberi. Le capanne, a pianta rettangolare, sono delimitate da canalette in cuisono stati trovati numerosi frammenti di intonaco (in un caso 1150 kg). Oltre aelementi “strutturali” sono stati trovati anche resti di grandi “vasi-silos”, realizza-ti con concotto e decorati da motivi plastici e da figurine fittili (Moffa 2002).
Il popolamento del territorio veronese durante l’età del Ferro 23
Altre evidenze insediative sono quelle di Castion d’Erbè (Leonardi 2002; Bet-tinardi, Leonardi 2002), un abitato oggetto di campagne di scavo dell’Universitàtra il 1972 e il 1976 (fig. 7). Qui le fotografie aeree hanno permesso l’individua-zione di un fossato che delimitava un’area di circa 4 ettari e gli scavi l’aggere rela-tivo e al suo interno almeno una grande struttura (di nuovo di 10x5 m).
I materiali sono databili tra l’VIII e la metà del VI secolo a.C.; importante ilrinvenimento di un crogiuolo per il vetro dell’VIII secolo a.C.
Va anche citato l’abitato di San Vito di Cerea (Salzani 1991, 2002a, p. 176),posto su un dosso vallivo lungo il fiume Menago, con strutture abitative analo-ghe a quelle di Terranegra.
Di un certo interesse, infine, il rinvenimento a Crosare di Bovolone di unafornace per ceramica del tipo a struttura orizzontale del V secolo a.C., con ca-mera di combustione, camera di cottura e distanziatori (Salzani 2002d).
Passiamo ora a trattare di quelli possono essere senza dubbio definiti i duecentri maggiori dell’intero territorio veronese nella prima età del Ferro, GazzoVeronese e Oppeano.
Conosciamo ormai diversi corredi delle necropoli di Gazzo Veronese; dell’abi-tato, posto alla confluenza tra i fiumi Tartaro e Tione e documentato fino ad og-gi solo da ricerche di superficie, sappiamo poco, se non qualcosa della presenzadi strutture, in particolare di un fossato difensivo, messe in luce nel corso di in-terventi della Soprintendenza6. Ciò che in questa sede appare possibile, è tentarequanto meno di ipotizzare quale fosse l’estensione di un centro così importante.
Nella letteratura si oscilla tra i 15 (Salzani, in Malnati et alii 1999, pp. 365-371)e i 25 (Franchi 1996) ettari. In realtà, se analizziamo la carta recentemente pubbli-cata da De Marinis (fig. 8)7, escludendo – nella singolare eventualità che l’insedia-mento non si estendesse alla vera e propria area della confluenza tra i due fiumi –sia il piccolo insediamento della fine dell’età del Bronzo (n. 2), sia quello (consi-derato come nucleo “autonomo”) del V-IV secolo a.C. (n. 3), si può ipotizzare chel’area dell’abitato paleoveneto (Le Coazze), databile dunque tra IX e VI secoloa.C., fosse estesa almeno 30 ettari (vedi zona limitata dalla linea grigia a fig. 8).
Di ben altra complessità sono i dati di cui disponiamo riguardo a Oppeano.
2. Oppeano
2.1. Gli interventi di emergenza e la ricognizione: un quadro d’insieme
Prima delle ricognizioni e delle campagne di scavo che l’Università, in accordocon la Soprintendenza e con la direzione di chi scrive e di Luciano Salzani, portaavanti dal 2000, i dati conosciuti sull’abitato derivavano da alcuni rinvenimenticasuali, dalle ricerche di superficie non sistematiche effettuate da Gianluigi Cor-
Alessandro Guidi, Federica Candelato, Massimo Saracino24
rent e, soprattutto, dagli scavi effettuati dalla Soprintendenza alla Montara, neipressi dell’area ex Fornace, al campo sportivo e al cimitero (Franchi 1996; Malna-ti et alii 1999, pp. 365-371; Salzani 2004a; va anche ricordata la notizia data dalZorzi di una struttura con pavimentazione in lastre di calcare, in via Franchi8).
Negli scavi della Soprintendenza si sono potute individuare alcune parti dell’in-sediamento, come quella della Montara, caratterizzate dalla presenza di buche pra-ticate nel terreno forse per recuperare materiale sabbioso, databili a partire almenodall’VIII secolo a.C., in una seconda fase utilizzate come fosse di scarico (in un ca-so vi si rinvenne parte di uno scheletro), che indicherebbero la presenza di struttu-re di servizio e/o produttive ai margini dell’abitato (vedi Salzani 2004a, p. 3)9.
Per quanto riguarda le abitazioni, oltre al tratto di pavimento e al focolare diuna capanna del IX-VIII secolo a.C. messi in luce nel 1981 nella parte centraledell’insediamento (Salzani 1983), l’evidenza più importante è quella messa in lu-ce nell’area del campo sportivo, in località Fratte (Salzani 2004a, p. 3, tav. IV).Qui buche di palo e pozzetti disegnano la pianta di una o più capanne a piantarettangolare (fig. 8), divise in più vani con focolari e distanziate tra loro in mododa far pensare all’esistenza di veri e propri assi viari. Sebbene nell’area si siano rac-colti materiali databili tra IX e V secolo a.C., le capanne, più volte ristrutturate ericostruite, sembrano essere state occupate tra VIII e VII secolo; di particolare in-teresse il rinvenimento, accanto al tradizionale repertorio della ceramica, di unacerta quantità di miniaturistici10.
Il quadro che risultava, unito a quanto già sappiamo delle centinaia di sepol-ture databili tra X e IV secolo a.C., rinvenute attorno al dosso su cui sorgeva Op-peano, facevano ritenere che il centro fosse un grande abitato dell’estensione dipiù di 70 ettari già nel corso della prima età del Ferro.
Le ricognizioni effettuate dall’Università tra il 2000 e il 2003 hanno permes-so di precisare ulteriormente il quadro dell’evoluzione nelle diverse fasi cronolo-giche di Oppeano (Guidi et alii 2002, 2005; Guidi, Peloso 2004; Chiaffoni, Mo-randini 2004).
Tra i risultati ottenuti, in attesa dell’edizione definitiva dei dati, si possono citare:1. la verifica dell’utilità delle diverse tecniche, estensive e intensive, di survey uti-
lizzate nei 28 campi in cui è stata suddivisa l’area dell’abitato;2. la definizione, negli stessi campi, di una “densità archeologica” che può costi-
tuire un utile strumento anche per la pianificazione territoriale;3. il riconoscimento, in base sia a specifiche ricerche che allo studio della docu-
mentazione esistente, della probabile estensione del dosso su cui sorgeva ilcentro di Oppeano, da noi attualmente calcolata attorno agli 82 ettari;
4. una serie di carte “diacroniche” (Guidi et alii 2005, fig. 2) con le presenze ar-cheologiche raccolte nei diversi campi o settori di campi, sia nell’area dell’abi-tato che in quella immediatamente circostante (campi 29-101), che dimo-strerebbero come già nelle fasi più antiche il dosso fosse occupato in maniera
Il popolamento del territorio veronese durante l’età del Ferro 25
unitaria e diffusa, sul modello di quanto sappiamo per tutti i coevi centri“protourbani” dell’Italia centrosettentrionale (Guidi 1998, 2006), e come ta-le tipo di configurazione dell’abitato sia proseguito almeno fino alla primametà del IV secolo a.C., forse anche con l’inglobamento di terreni posti al difuori del dosso (un fatto ben spiegabile con la già menzionata graduale incor-porazione di diversi abitati vicini);
5. l’ipotesi, formulabile sia in base ai dati delle ricognizioni che a quelle di vec-chi e nuovi scavi, che le presenze databili a un momento terminale dell’età delBronzo finale possano far ancora retrodatare il momento iniziale della forma-zione del centro protourbano11.Un ulteriore risultato delle nostre ricerche è l’individuazione delle opere di-
fensive costruite attorno all’abitato nella parte nordoccidentale (la più bassa inrelazione alle campagne circostanti), con il riconoscimento di tre fasi (Balista2004; per la loro datazione vedi Saracino 2004), la cui crescente complessitàstrutturale non può non far pensare al crescente ruolo di “avamposto” della cul-tura veneta che Oppeano andava assumendo:a) scavo di un fossato alla base della scarpata, resa artificialmente più ripida, del
dosso (Balista 2004, fig. 6/1) – VIII-VII secolo a.C.;b) realizzazione di un fossato più grande e costruzione, con la terra di risulta, di
un terrapieno contenuto “...da una palizzata con un fronte irrobustito da unaccumulo ordinato di filari di ciottoli” (Balista 2004; p. 34; fig. 6/2-3) – VIsecolo a.C.;
c) ristrutturazione, dopo il degrado del precedente sistema difensivo, con realiz-zazione di un aggere formato da grosse travi disposte in orizzontale, le cuitracce sono purtroppo troncate dalle moderne superfici agrarie (Balista 2004,fig. 6/5-6) – V-IV secolo a.C.Da alcuni anni l’Università è impegnata in campagne di scavo nell’area del
campo ex Fornace. A una prima illustrazione dei risultati effettuati nel 2003 è de-dicata la parte che segue del presente contributo.
Alessandro Guidi
2.2. Ricerche archeologiche dell’Università di Verona a Oppeano.La campagna di indagine 2003 in località ex Fornace (campo 6)
Tra settembre e ottobre 2003 il Dipartimento di Discipline Storiche, Artisti-che, Archeologiche e Geografiche dell’Università degli Studi di Verona in accor-do con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto ha condotto un’in-dagine stratigrafica nell’area ex Fornace12 nel settore nord-occidentale corrispon-dente alla fascia B1 della suddivisione operata nel corso della ricognizione di su-perficie nel 2002, i cui dati sono stati in parte pubblicati ed in parte in fase di ela-borazione (Guidi et alii 2005; Guidi, Salzani in corso di stampa).
Alessandro Guidi, Federica Candelato, Massimo Saracino26
Grazie ad accordi con il proprietario del fondo Sig. Bonisegna, si è dapprimaoperato documentando 35 sondaggi preventivi attestanti materiali archeologici cro-nologicamente compresi tra il Bronzo finale e il IV secolo a.C. (Guidi et alii 2005)e poi sono stati realizzati un primo scavo a cura della Società Archeologica Padanaper conto del Nucleo Operativo di Verona nel settore orientale (Salzani 2004b) edun secondo controllo, più limitato nell’estensione, seguito dagli scriventi e direttodal professor A. Guidi, per appurare la consistenza del deposito archeologico13.
Federica Candelato, Massimo Saracino
2.2.1. L’indagine archeologicaL’area indagata nel corso dell’anno 2003 è situata nella parte nord-occidenta-
le del “dosso” di Oppeano (riquadro nella fig. 10) caratterizzato da una forma ap-prossimativamente ellittica e allungato in senso nordovest-sudest, con l’asse mag-giore di circa 2 km e l’asse minore di 500 metri. Verso nordest l’orlo del risalto
Il popolamento del territorio veronese durante l’età del Ferro 27
Figura 10. Oppeano, ex fornace-campo 6. Stralcio della CTR in cui sono evidenziate le aree oggetto degliinterventi di scavo 2002-2003 e nel riquadro il limite antico del dosso sabbioso su cui sorgeva l’abitato (ela-borazione F. Candelato).
Alessandro Guidi, Federica Candelato, Massimo Saracino28
Figura 12. Oppeano, sezioni della trincea realizza-ta con mezzo meccanico ed in generale, della paretesud dello scavo (rilievo Vittorio Rioda).
Figura 11. Oppeano, area dello scavo2003 con evidenziata la posizione dellesezioni stratigrafiche descritte nel testo.
morfologico è definito in maniera netta, poiché coincide con la scarpata erosivache racchiude il piano di divagazione dell’Adige. A sudovest il limite del dosso èmeno pronunciato, ma ben evidente nelle fotografie aeree.
Lo scavo, ubicato all’interno del Lotto numero 214 di un progetto di edilizia pri-vata, forma un rettangolo lungo 20 m e largo 5 (fig. 11) e ha raggiunto unaprofondità variabile tra i 50 cm e i 2 m. La ricchezza e l’abbondanza del materialearcheologico presente nel campo 6 erano già note in seguito alle ricognizioni di su-perficie effettuate dall’Università di Verona negli anni 2000-200315. Gli scavi siste-matici, intrapresi a partire dall’anno 2002, hanno permesso di confermare le ipo-tesi formulate in precedenza e hanno consentito di precisare più adeguatamente itempi, la durata e le modalità dell’insediamento in questa porzione dell’abitato.
Il piano di calpestio attuale (US 100), che testimonia l’utilizzo dell’area inepoca recente16, è caratterizzato dal tritume di laterizi che deriva dagli scarti diuna fornace attiva fino a circa 25 anni fa (fig. 10). Poco ad ovest della fornace erasituato il cosiddetto “piazzale”, luogo solitamente adibito al movimento dellemacchine e allo stoccaggio della merce in attesa di spedizione. Il cumulo di ar-gilla, lasciato depositare e decantare prima dell’utilizzo per la realizzazione deimattoni, era posto, invece, sul lato settentrionale della fornace, come si può no-tare nello stralcio della Carta Tecnica Regionale (fig. 10). La porzione del campoche non era occupata dal corpo di fabbrica, fortunatamente, non è stata intacca-ta in profondità, ma ha comunque subito interventi di livellamento che hannoavuto come esito la rasatura degli strati archeologici più recenti. Lo spessore deiriporti di laterizi moderni varia considerevolmente da sud verso nord, da pochicentimetri in corrispondenza della parte centrale e naturalmente più elevata deldosso, a più di un metro in corrispondenza delle sponde del fosso che corre sullato nord dell’alto morfologico17.
Poiché nel corso delle operazioni di splateamento è emerso che le evidenze ar-cheologiche superstiti erano frammentarie e discontinue, si è deciso di interveni-re con metodi differenti nei due settori, occidentale ed orientale. La zona centra-le dello scavo, infatti, è risultata priva di tracce evidenti di interventi antichi, se-gno che, come già noto in altri contesti, le aree riservate ad abitazione o ad atti-vità artigianali erano intervallate da spazi pressoché vuoti.
Il settore occidentaleIl settore occidentale è caratterizzato dall’approfondimento di due trincee or-
togonali fra loro, realizzate con il mezzo meccanico (fig. 11), la cui sequenza stra-tigrafica è riportata nelle sezioni “E-W 1º” e “S-N”.
Sezione E-W 1º e S-NPer un inquadramento d’insieme della successione sedimentaria si descriverà
innanzitutto la sezione E-W 1º (fig. 12): posta l’origine a ovest, nella parte ini-
Il popolamento del territorio veronese durante l’età del Ferro 29
ziale raggiunge una profondità di circa due metri, per risalire verso est dove rag-giunge una profondità di circa un metro.
La sequenza in essa evidenziata è così costituita18:– US 100: strato arativo caratterizzato da frammenti di laterizi moderni mesco-
lati con ciottoli arrotondati di diametro compreso fra uno e cinque centimetri.– US 101: sabbia medio fine leggermente limosa con sparsi piccoli ciottoli arro-
tondati di diametro compreso fra un centimetro e mezzo e cinque centimetri.Questi primi due strati rappresentano il sottofondo del piazzale di manovra e
di stoccaggio dei laterizi prodotti dall’attività della fornace moderna.– US 126: limo marrone scuro con rari ciottoli di diametro compreso fra mezzo
centimetro e due centimetri. Si rinvengono, inoltre, dispersi nel sedimento,frammenti di argilla cotta; questo corpo di forma lenticolare si chiude versoovest a circa 7 m.
– US 115: riempimento di limo marrone scuro, con forte presenza di frustolicarboniosi orientati per la maggior parte parallelamente al piano di sedi-mentazione e lunghi fino a due-tre centimetri, con sparsi ciottoli arrotonda-ti di quattro-cinque centimetri di diametro. Si notano patine verdastre adandamento verticale interpretate come tracce di radici. Diffusi frammenticeramici.
– US 120: taglio riferibile ad un canale artificiale orientato in senso NNE-SSW.– US 116: riempimento di limo sabbioso grigio chiaro con presenza di frustoli
carboniosi privi di orientazione preferenziale e rari ciottoli di diametro com-preso fra mezzo centimetro e due centimetri. Si osservano diffuse tracce di ap-parati radicali e si riscontra la presenza di una discreta quantità di frammenticeramici. Verso ovest questo livello è stato compromesso dalla realizzazione diun grande canale scavato in epoca moderna (vedi US 120).
– US 117: sabbia rossastra, leggermente limosa (diametro dei granuli circa undecimo di millimetro), con rari frustoli carboniosi. Verosimilmente si tratta diuno scivolamento dello strato 104 posto al margine della parte più profondadell’US 121 e leggermente collassato verso l’interno.
– US 118: è il riempimento più antico di US 121, in limo sabbioso grigio chia-ro con frustoli carboniosi privi di un orientamento preferenziale, rari ciottoli(diametro da mezzo centimetro a due centimetri) e tracce di apparati radicali.Sono presenti rari frammenti ceramici.
– US 121: taglio riferibile ad una depressione di forma irregolare, caratterizzataa circa sei metri dall’origine da una zona più profonda (circa 0,5 m), con fian-chi debolmente inclinati verso l’asse di drenaggio principale allungato in sen-so nord-sud.
– US 104: sabbia quarzosa rossastra medio grossa (diametro dei granuli circa unmillimetro). Questo livello rappresenta una rielaborazione parziale dell’unitàsottostante, a differenza della quale non presenta le strutture sedimentarie na-
Alessandro Guidi, Federica Candelato, Massimo Saracino30
turali riconoscibili nello strato 119, ma ha plaghe di sedimento più fine, so-stanza organica e rari frammenti ceramici.
– US 119: substrato sterile costituito da depositi sabbiosi di natura alluvionale.È formato da sabbia quarzosa medio grossa (diametro dei granuli da 0,8 a 1mm) con clasti subarrotondati, laminazioni piano parallele di spessore milli-metrico e presenza di bande orizzontali di colore verdastro nella parte medio-superiore (terminanti verso l’alto a circa 1,5 m dall’attuale piano campagna).Nella parte bassa sono visibili piccole strutture da iniezione legate a pressionidi carico, esercitate in presenza di acqua nel terreno.La sezione S-N delimita lo scavo verso ovest e raggiunge una profondità di cir-ca due metri. Lo zero è posto a sud. Il canale moderno che si trova in corri-spondenza dell’angolo sudoccidentale dello scavo, già parzialmente descrittonella sezione E-W 1º, a 3,5 metri circa dall’origine prosegue articolandosi inuna probabile canaletta di chiara origine antropica, allungata in senso NNE-SSW (US 120). Tali strutture tagliano il soggiacente livello sterile di sabbiemedio grosse (US 119). Per la descrizione delle unità stratigrafiche si rimandaal commento della sezione E-W 1º.
Il settore orientaleLe evidenze archeologiche documentate in pianta (fig. 13) sono costituite pre-
valentemente da tre fosse di scarico molto diverse tra loro, scavate nelle sabbienaturali parzialmente rimaneggiate (US 104).
La struttura contraddistinta dalle UUSS 105-108, la più piccola e la menoprofonda delle tre scavate, era caratterizzata dalla presenza di grossi frammenti diconcotto, pertinenti forse ad un focolare e da pochi reperti ceramici tra cui unframmento tornito e depurato, decorato a fasce parallele.
Nell’angolo nordorientale dello scavo è stata intercettata, e parzialmente inve-stigata, una depressione di forma allungata in senso nordovest-sudest (per quan-to è stato possibile indagare), caratterizzata da tre livelli di riempimento (UUSS103, 103a, 103b) abbastanza omogenei la cui distinzione si deve, sostanzialmen-te, agli inclusi e dalla presenza di una buca di palo tagliata e obliterata dai suc-cessivi interventi di scavo e riempimento della fossa. In generale questi tre livellisono costituiti da un sedimento limoso con forte presenza di cenere, probabileindizio di uno scarico pertinente ad un vicino focolare. Tra i reperti si segnala ilrinvenimento di un vasetto quasi integro ma privo dell’orlo, assieme a sparsiframmenti ceramici e una mandibola di caprovino.
L’area che ha restituito un gran numero di frammenti ceramici di medie egrandi dimensioni, è localizzata nei quadrati B6 (quadranti II-III) e B7 dove, inparticolare, è stata scavata una terza struttura con doppio riempimento (vedi se-zione W-E, fig. 14). Misti al ghiaino che caratterizza il sedimento (soprattuttonella parte sudoccidentale, ai margini della fossa), sono stati rinvenuti pochi
Il popolamento del territorio veronese durante l’età del Ferro 31
frammenti ossei e sparsi frustoli di concotto di dimensioni mediamente piccole.Solo in un punto, una volta asportato il livello 107, all’interno di una depressio-ne di circa 40 cm di diametro (US 111) caratterizzata da sedimento limoso ver-de chiaro, sono stati rinvenuti, in posizione di crollo nella buca, grossi frammen-ti di concotto, alcuni dei quali presentavano una faccia piana.
Vicino a questa fossa di scarico va notata, inoltre, la presenza di un vaso con-servato parzialmente (Vaso A), in giacitura primaria, collocato nelle sabbie e con-tenente frammenti ceramici pertinenti ad un secondo vaso.
Sezione E-W 2º (vedi riquadro nella figura 12)Tale sezione rappresenta il naturale proseguimento verso est della sezione E-
W 1º, a cui si rimanda per la descrizione dei livelli 100 e 101, 104.– US 105: sabbia molto fine (diametro dei clasti circa un decimo di millimetro)
con sparsi piccoli ciottoli calcarei. Si tratta dello strato di riempimento di unabuca (US 122) larga un metro e mezzo, con fondo articolato, conservata per unaprofondità di circa quindici centimetri, che taglia le sabbie rossastre (US 104).
Sezioni W-E e N-SI rapporti spaziali e giaciturali delle unità stratigrafiche individuate nel setto-
re orientale dello scavo sono riportati nella figura 14. Tralasciando, anche qui, glistrati già descritti, si osservano:– US107: riempimento sabbioso, parzialmente rimaneggiato al tetto, di una
fossa di scarico (US 124) in cui sono stati rinvenuti numerosi frammenti ce-ramici di medie e grandi dimensioni e sparsi resti di fauna.
– US 112: primo livello di riempimento della struttura di scarico (US 124) ca-ratterizzato da matrice sabbiosa e dalla presenza di abbondante ceramica.
– US124: taglio della fossa di scarico.– US106: livello a matrice sabbiosa, debolmente limosa bruno rossastra, con
piccoli clasti ghiaiosi; sono numerosi i frammenti ceramici e i frustoli di con-cotto, sparsi nello strato che presenta uno spessore esiguo.
– US103: riempimento costituito da cenere mista a limo, con frustoli carbo-niosi, pochi frammenti ceramici e fauna.
– US 123: taglio di fossa.– US 125: riempimento di buca di palo.– US 129: taglio di buca di palo.
Federica Candelato
2.2.2. I materialiLa cultura materiale dei diversi depositi indagati è principalmente testimo-
niata dalla produzione ceramica; rari invece i manufatti in metallo (ad eccezionedi una fibula spezzata in più parti, in avanzato stato di corrosione e di difficile at-
Alessandro Guidi, Federica Candelato, Massimo Saracino32
Il popolamento del territorio veronese durante l’età del Ferro 33
Figura 13. Oppeano, planimetria cumulativa delle strutture rinvenute nel settore orientale dello scavo (ela-borazione F. Candelato).
tribuzione tipologica rinvenuta nell’US 106, una molla molto abrasa dall’US 107e qualche altro minuto frammento in bronzo proveniente dagli strati di riporto),in materiale litico e i prodotti in corno (solo un paio di frammenti di corno dicervo, provenienti dalla trincea, hanno evidenziato segni lavorazione) ed osso.Pochi anche i dati faunistici studiati dalla dottoressa Claudia Minniti, di cui qui,per motivi di spazio, si presentano unicamente i risultati preliminari.
Nei frammenti ceramici rinvenuti in posto sono ampiamente documentate ti-pologie differenti che abbracciano un arco cronologico compreso tra il Bronzo fi-nale e la II età del Ferro (in termini di cronologia assoluta, tra X e V secolo a.C.).
Da una macroscopica disamina dei principali aspetti tecnologici, si può parla-re essenzialmente di una produzione d’impasto con differenti gradi di depurazio-ne della materia prima (argille reperite localmente nei sedimenti alluvionali e/onei pressi dei paleoalvei dell’Adige ed inclusi costituiti principalmente da granulicalcarei e in misura minore da sabbia ben classata, scarsa la presenza di chamotte esoprattutto nelle tipologie più antiche), diverso trattamento delle superfici inter-ne ed esterne e realizzazione manuale (nel periodo più antico) ma utilizzo di si-stemi di modellazione più avanzati (tornio lento e/o veloce) nei periodi successi-vi. Le superfici presentano principalmente tonalità bruno-grigiastre nella fase piùantica (BF e IFe) e bruno-rossastre o rosa-arancio in quella più recente (IIFe). Par-ticolarmente frequente e visibile in sezione l’effetto sandwich ovvero la presenza diun nucleo centrale scuro e superfici interne e/o esterne ossidate (di color rosa-arancio soprattutto per le fasi più recenti) imputabile probabilmente ad una nonperfetta cottura in ambiente riducente iniziale e fase terminale ossidante.
Di seguito, si farà riferimento a prodotti ceramici rinvenute nelle UUSS più
Alessandro Guidi, Federica Candelato, Massimo Saracino34
Figura 14. Oppeano, sezioni relative al settore orientale dello scavo (elaborazione F. Candelato).
significative e meno compromesse dai livelli antropici moderni. Tralasciandoquindi l’US 101, contraddistinta da strati di riporto in cui il materiale risultacronologicamente composito, nelle UUSS 103, 103a e 103b (interpretato comescarico di ceneri) la presenza di olle ovoidali provviste di labbro svasato arroton-dato, profilo interno articolato da concavità per alloggiamento di un probabilecoperchio e incisioni interposte tra una fila di tacche oblique (fig. 15, 1-2), unascodella troncoconica con orlo indistinto (fig. 15, 3), un dolio con labbro svasa-to ed orlo arrotondato e due incisioni sulla spalla poste sopra e sotto un “cordo-ne” (fig. 15, 4), due ollette a labbro svasato e corpo ovoide, di cui una provvistadi tacche disposte orizzontalmente e obliquamente (fig. 15, 5-6), nonché fram-mento di olla ad orlo rientrante (fig. 15, 7) e due frammenti con cordone a tur-bante e tacche oblique (fig. 15, 8-9), permettono una generica attribuzioneall’VIII-VII secolo a.C.
Il frammento privo di orlo, ma pertinente molto probabilmente ad un’ollaovoidale con solcature sulla spalla (fig. 15, 11) nonché un frammento di cerami-ca estremamente depurata (colore superfici esterna ed interna 10YR 8/4 very pa-le brown, Munsell Soil Color Chart) con profili esterno regolare ed interno irre-golare ove si evidenziano anche labili segni di tornitura e fasce di “vernice” ester-ni notevolmente compromessi (7.5YR 7/6 reddish brown) riconducibile a cera-mica etrusco-padana (fig. 15, 10), permettono un inquadramento cronologicodell’US 105 ad almeno il V secolo a.C. Recuperati anche due schegge residuali inselce, una parete con cordone a sezione arrotondata e piccoli frammenti irregola-ri di concotto. La sottostante US 108 è caratterizzato dalla presenza di una ven-tina di blocchetti informi di concotto (soltanto due frammenti presentano unafaccia piana) realizzati con un impasto limo-argilloso di color chiaro pertinentiad un focolare defunzionalizzato.
L’US 106 (probabile piano di calpestio in posto) essendo a contatto nei livel-li sommitali con l’US 101 (strati di riporto) e nei livelli basali con l’US 104 (sab-bie rosse presterili) ed essendo inoltre tagliato dall’US 107, presenta cospicuomateriale ceramico pertinente alla I età del Ferro, ma anche prodotti cronologi-camente eterogenei di natura residuale tra cui frammenti di olle ovoidali con sol-cature sulla spalla e di ciotole troncoconiche con orlo dritto o rientrante generi-camente attribuibili alla II età del Ferro così come frammenti di impasto grosso-lano notevolmente abrasi da ritenersi molto più antichi come ad esempio un coc-cio ricco di inclusi calcarei e litici fini e decorato a impressioni ed unghiate (fig.15, 12). Quest’ultimo potrebbe essere riferibile a fasi finali del Neolitico (VBQIII) o Eneolitico, ma soltanto uno studio associativo e comparativo con altro ma-teriale tecnologicamente e tipologicamente affine e rinvenuto nel corso delle suc-cessive campagne di scavo realizzate sempre in quest’area, potrebbe essere a talproposito chiarificatore19.
Gran parte del materiale sia per tipologia che per tecnologia è comunque at-
Il popolamento del territorio veronese durante l’età del Ferro 35
Alessandro Guidi, Federica Candelato, Massimo Saracino36
Figura 15. Materiale ceramico da US 103 (1-9), US 105 (10-11), US 106 (12-17), US 107 (18-23) (di-segni M. Saracino).
Il popolamento del territorio veronese durante l’età del Ferro 37
Figura 16. Materiale ceramico da US 107 (24-35), US 110 (36-38), US 128 (39) (disegni M. Saracino).
tribuibile alla I età del Ferro: soprattutto labbri più o meno svasati pertinenti aolle ovoidali e globose (fig. 15, 13-14) o a vasi situliformi, orli dritti di vasi tron-coconici (fig. 15, 15) con decorazione a tacche oblique sull’orlo (fig. 15, 16) edun frammento pertinente ad una piccola ciotola con labbro svasato e decorazio-ne a turbante sulla spalla (fig. 15, 17). Presenti anche due grossi frammenti dialari a mattonella e un fondo piatto ricomposto di una forma chiusa contraddi-stinto da una buona presenza nell’impasto di chamotte. Nonostante la presenzadi residui di cui sopra, il suddetto materiale può essere attribuito almeno al IXsecolo a.C.
L’US 107 (scarico di materiali a secco) presenta il maggior numero di fram-menti ceramici pertinenti soprattutto a forme chiuse ed in misura minore a for-me aperte. Il taglio artificiale operato però nella parte sommitale del deposito co-sì come il contatto con la soprastante US 101 (livelli di riporto) ne ha però di fat-to compromesso una definizione cronologica puntuale. Le principali forme ri-componibili20 sono dolii ovoidi o globosi di differenti dimensioni ed elementi ti-pologici21 (fig. 15, 18-23, fig. 16, 24-26): presentano orli aggettanti, ingrossati esvasati, tese interne singole e/o doppie con funzione di alloggiamenti per even-tuali coperchi nonché decorazioni a solcature, incisioni orizzontali e parallele ecordoni plastici a profilo spigoloso o arrotondato. In alcuni casi sono presentiesternamente ed internamente (soprattutto all’altezza dell’orlo) anche ingobbirossastri in associazione a cordoni plastici, così come ingobbi nerastri (un solo ca-so) associato a solcature orizzontali e parallele.
Il gruppo delle olle è ben documentato dal tipo ovoidale con orlo svasato leg-germente ingrossato provvisto di incisioni o solcature sulla spalla sfuggente (fig.16, 27-29). Di questi un esemplare è decorato a fasce rosse e nere e due solcatu-re parallele rinvenuto all’interno di un fondo piatto e a questo pertinente (fig. 16,31). Altri due frammenti zonati cordonati, di mediocre fattura, sono probabil-mente da attribuire a vasi situliformi provvisti di piede circolare leggermenteespanso (fig. 16, 32). Presente anche un frammento di olla ovoidale con orlorientrante e provvisto di quattro solcature orizzontali sotto l’orlo e sulla spalla etracce di ingobbio bruno-rossastro all’interno e all’esterno (fig. 16, 30). Rico-struito per gran parte è un’olla ad orlo leggermente aggettante ed ispessito di for-ma globosa con sintassi decorativa composta da tre solcature parallele sotto la go-la e più cordoni a spigolo disposti orizzontalmente su gran parte del corpo appli-cati a distanze irregolari (fig. 16, 33).
Le forme aperte sono documentate da ciotole troncoconiche principalmente conorlo dritto e profilo a calotta (fig. 16, 34) e tre esemplari a pareti leggermente con-vesse ed orlo rientrante. Di questi ultimi, uno presenta all’esterno una decorazione(in gran parte consumata) a fasce rosse e nere suddivisa da un cordone (fig. 16, 35).
Recuperati anche 14 frammenti di fondi piatti pertinenti a forme chiuse dimedie e grandi dimensioni, 8 piccoli pezzi irregolari di concotto, una macina
Alessandro Guidi, Federica Candelato, Massimo Saracino38
fratturata in trachite del tipo a sella a sezione piano-convessa e superficie leviga-ta per usura ed un macinello parzialmente fratturato di forma sferoidale.
Il suddetto materiale è inquadrabile tra la seconda metà del VI ed il V secolo a.C.Nell’US 110 il tipo di impasto ed i pochi materiali raccolti, tra cui un orlo
rientrante di coppa troncoconica (fig. 16, 36), una porzione di carena arroton-data provvista di solcature oblique probabilmente pertinente ad una tazzina (fig.16, 37) ed una parete con cordone a tacche verticali (fig. 16, 38), permettono diavere una datazione compresa tra la fine del IX e gli inizi del VIII secolo a.C.
Il frammento di vaso biconico (fig. 16, 39) rinvenuto nel riempimento del Va-so “A” (US 128) e ricomposto, presenta oltre ad evidenti segni di steccatura e li-sciatura internamente ed esternamente, tracce di fuoco nella parte inferiore, tesainterna, profili delle pareti irregolari, coni pressoché uguali con spigolo d’unionevivo e su cui si imposta una piccola presa rettangolare e labili incisioni orizzonta-li sulla gola e su parte del labbro. Tale tipologia se da un lato rimanda per di-mensioni a due biconici rinvenuti sempre a Oppeano in località Isolo (Borghesa-ni, Salzani 1974), dall’altro è confrontabile, come già evidenziato a suo tempo daidue autori e recentemente da Cecilia Colonna (2006)22, ad urnette biconiche pre-senti soprattutto in contesti sepolcrali del Bronzo Finale come Garda (VR) e SanGiorgio di Angarano (VI). Per quanto riguarda un preliminare inquadramentocronologico, i primi due studiosi fanno riferimento all’età del Bronzo finale par-lando di “un momento ancora abbastanza antico di tale evoluzione” (Borghesani,Salzani 1974, p. 364), mentre la seconda, in relazione alle tombe 5 e 9bis delGarda, attribuisce la forma alla fase avanzata del medesimo periodo23.
Per quanto riguarda infine i dati faunistici raccolti in tutte i livelli di frequen-tazione, una prima disamina evidenzia una prevalenza del suino seguito dai ca-pro-ovini, mentre la frequenza di bovini (di molto inferiore) è similare a quelladegli animali selvatici (cervo, capriolo e forse lepre), segno che la caccia aveva an-cora una sua, seppur ridotta, rilevanza sociale.
2.3. Considerazioni conclusive
Nonostante l’area indagata sia stata notevolmente compromessa da antropiz-zazioni e da processi postdeposizionali successivi alla frequentazione protostori-ca, la correlazione dei dati planimetrici, stratigrafici e cronotipologici, ha co-munque permesso di verificarne, scandirne e proporre una sua probabile desti-nazione d’uso.
Il vaso interrato “A” contenente frammenti ricomposti di un piccolo vaso bi-conico del Bronzo Finale ed attribuito a quest’epoca, rimanda a confronti con al-tri contesti del Triveneto come ad esempio Padova - P.zza Castello 18 (Antonel-lo 2006, pp. 153-154), Este, via Augustea - Serraglio Albrizzi (Pirazzini 2000),Concordia Sagittaria (VE) (Sainati, Salerno 1996, pp. 213-216; Bianchin Cit-
Il popolamento del territorio veronese durante l’età del Ferro 39
ton, Panozzo 1996, pp. 271-275), Variano di Basiliano (UD) (Cassola Guida,Corazza 2005) e Montagnana - Borgo San Zeno (PD) (Bianchin Citton, Panoz-zo 1998, pp. 300-303). Tale sistema è connesso in prevalenza con attività arti-gianali (nei primi tre casi con la produzione ceramica, a Variano con la prepara-zione e conservazione dei cibi), ma anche a strutture abitative (è il caso di Mon-tagnana). A livello invece etnografico e sperimentale (Zifferero 2003), tale siste-ma, tuttora utilizzato nell’Africa centrale, risulta utile alla conservazione del cibo:si tratta di una tecnica nota con il nome di pot-in-pot che, sfruttando un sempli-ce principio di fisica, consiste nell’inserire un vaso più piccolo all’interno di unvaso più grosso; lo spazio tra i due vasi è riempito con sabbia umida, creando co-sì uno strato isolante, ed il tutto viene coperto con un panno umido.
Nel nostro caso, la mancanza nelle immediate vicinanze di strutture artigia-nali coeve non può sostenere al momento alcuna ipotesi, sebbene la collocazioneperiferica dell’area e la vicinanza ad un canale d’acqua (rilevato nel corso dellacampagna di scavo del 2004 ed in fase di studio), induce a dare una connotazio-ne produttiva del singolo contesto.
Per quanto riguarda invece le altre tre strutture, ci troviamo di fronte a 3 dif-ferenti sistemi di fosse di scarico di “defunzionalizzazione”: una strettamenteconnessa a diversi episodi di smaltimento dei resti di uno o più focolari (US103), uno è probabilmente da ritenersi uno scarico del tipo “a secco” di un ma-gazzino data la forte presenza di diverse tipologie di dolia e di forme chiuse(UUSS 107/112), mentre il più recente (UUSS 105/108) rappresenta una fos-setta contenente i resti materiali di un focolare smantellato.
I dati qui proposti, seppure nella loro limitatezza, permettono al momento diconsiderare l’area indagata una zona deputata nella fase più antica a probabili at-tività di tipo artigianale, mentre nel corso della II età del Ferro, sempre per la suamarginalità, veniva impiegata per “defunzionalizzare” diverse tipologie di strut-ture. Sarà eventualmente l’accorpamento dei dati derivanti dal susseguirsi di in-dagini in questa parte dell’abitato dagli anni Ottanta, a fornire ulteriori spunti diriflessione e fornire modelli interpretativi utili soprattutto per la comprensione,da un lato, dello sviluppo del centro di Oppeano già dal Bronzo Finale fino al suoabbandono tra il V e il IV secolo a.C. e, dall’altro, del fenomeno protourbano nelterritorio degli antichi Veneti.
Massimo Saracino
Alessandro Guidi, Federica Candelato, Massimo Saracino40
Il popolamento del territorio Veronese durante l’età del Ferro 41
1. Dal presente contributo sono escluse (a me-no che non costituiscano fasi recenti di abitatiiniziati in periodi precedenti) le presenze ar-cheologiche databili tra la seconda metà delIV secolo a.C. e l’epoca della romanizzazione(II-I secolo a.C.).Nelle more della stampa, abbiamo potuto con-sultare un articolo a sua volta derivato da un in-tervento tenutosi in un convegno dell’ÉcoleFrançaise de Rome del 1999, ma pubblicatosolo nel 2004, sulle origini di Verona (G. CA-VALIERI MANASSE, L. MALNATI, L. SALZANI,Verona: la formazione della città, in S. AUGU-STA-BOULAROT, Des Ibères aux Vénètes, Rome2004, pp. 347-378). Oltre a un’aggiornata car-tografia delle presenze di età protostorica, l’ar-ticolo presenta una ricca documentazione di re-perti ceramici, in gran parte inediti. La tesi de-gli autori è che in base ai materiali conosciuti sipossano distinguere due fasi, una databile allaprima età del Ferro (periodo compreso tra IX eprima metà del VII secolo a.C.), l’altra databiletra V-IV e I secolo a.C., caratterizzata daun’evidente espansione dell’area abitata e corri-spondente a quanto le fonti tramandano su unaformazione “cenomane” di Verona. Lo “hia-tus” della seconda metà del VII e del VI secoloa.C. si spiegherebbe, secondo questi studiosi,con un temporaneo spostamento degli abitantinel villaggio di Montorio, dove molte delletombe individuate si datano a tale periodo.
2. La recentissima pubblicazione di un con-tributo sulla localizzazione topografica dellenecropoli e dell’abitato (ROSSI 2005), oltre afar ipotizzare un inizio ancora più antico (fi-ne del IX secolo a.C.), consente di individua-re un’estensione notevole (poco meno di 100ettari) per l’abitato.
3. In realtà, anche tra i materiali dei vecchi sca-vi di Monte Loffa sono presenti due fibule asanguisuga in bronzo (RIZZETTO 1976, fig.39/1-2) ben collocabili nel periodo compresotra l’VIII e il VI secolo a.C.
4. Un interessante tentativo di correlare l’orga-nizzazione territoriale degli abitati d’altura delVeronese in funzione dei principali affiora-menti minerari si trova in GUIDA et alii 1992,pp. 69-71, fig. 1.
5. Va notata anche la fine, già nel corso del VIsecolo a.C., dell’abitato di Castion di Erbè,posto tra il Tione e il Tartaro.
6. Inedito; comunicazione personale ClaudioBalista.
7. DE MARINIS 1999, p. 535, fig. 15.
8. Dopo il convegno di Isola della Scala, un al-tro scavo di emergenza, effettuato alla Monta-ra, ha permesso di portare in luce, secondo Lu-ciano Salzani, tracce di arature.
9. I materiali sono stati studiati per tesi di lau-rea dell’Ateneo veronese, in vista di una pros-sima edizione definitiva, in GUIDI, SALZANI, incorso di stampa, dalle dottoresse Erika Bellone Sara Rosi.
10. I materiali sono stati studiati per tesi di lau-rea dell’Ateneo veronese, in vista di una prossi-ma edizione definitiva, in GUIDI, SALZANI, incorso di stampa, dalle dottoresse Francesca Ca-sarotto, Veronica Cherubini e Ilaria Starita.
11. Va anche sottolineato il dato del rinveni-mento, alla Montara (ma anche nei nostri sca-vi e in quelli di emergenza nel campo 6) di re-sti scheletrici in tombe (un caso, SALZANI
2004b) o gettati in modo assai meno formalein fosse di scarico (due, uno dei quali in con-nessione anatomica) (SALZANI 2004a), a testi-monianza della presenza, già notata in diversicentri protourbani medio-tirrenici, di singolesepolture, con diverso significato (riti di fon-dazione, riti di espiazione, tombe di addetti alculto ecc.) (GUIDI 2006; all’argomento è statodedicato anche un convegno internazionaledal suggestivo titolo “Sepolti tra i vivi”, tenu-tosi a Roma nel 2006).
Note
Alessandro Guidi, Federica Candelato, Massimo Saracino42
12. L’area corrisponde al campo 6 delle rico-gnizioni condotte tra il 2000 e il 2003.
13. La prima campagna di scavo, finanziatadalla Presidenza di Lettere dell’Università de-gli Studi di Verona, è stata altresì possibile gra-zie alla disponibilità e cortesia del Comune diOppeano. Si coglie inoltre l’occasione di rin-graziare quanti vi hanno partecipato a vario ti-tolo: Angelita Avesani, Anna Bedoni, PaoloBellintani, Michele Brunetto, Francesca Casa-rotto, Alessandro Falcone, Cristina Ferrari,Carlotta Lavarini, Samuela Malizia, ValentinaMezzani, Francesco Novelli, Vania Passarini,Federico Recchia, Vittorio Rioda, Andrea To-niolo, Debora Trevisan.
14. Questa definizione deriva dalla suddivisio-ne in due aree edificabili del terreno denomi-nato durante le ricognizioni “ex fornace ocampo 6”. Mentre lo scavo archeologico pro-grediva all’interno del Lotto numero 2, nel co-siddetto Lotto 1, già compromesso dalla co-struzione negli anni Sessanta del secolo scorsodella fornace per laterizi, si andava realizzandoun imponente capannone industriale.
15. GUIDI et alii 2005, pp. 725-727.
16. Un piccolo saggio è stato praticato nel cor-so del 2002 a meno di 10 metri dallo scavo del2003. Poco al di sotto del terreno di riportosono state rinvenute tracce di arature recenti,
segno che l’area è stata interessata anche da at-tività agricola fino a non molto tempo primadella sua destinazione industriale.
17. GUIDI et alii 2005, pp. 725-727.
18. Si ringrazia il dott. Vittorio Rioda per laconsulenza geologica e per l’elaborazione dellesezioni riportate nella figura 12.
19. Sono state di fatto rinvenute oltre ad unapunta di freccia romboidale, tre diverse tipolo-gie di anse canaliculate, qualche orlo provvistodi digitate e pareti cordonate.
20. Il materiale è in fase di restauro da partedel dott. Marcello Tranchida.
21. Si tratta della principale forma documen-tata anche dalla presenza di 85 frammenti didiverse dimensioni provvisti di cordoni plasti-ci orizzontali attribuibili con certezza a tale ti-pologia vascolare sulla base dell’impasto e del-lo spessore delle pareti.
22. Potrebbe corrispondere ai tipi 23 e 24.
23. Non essendo questo lo spazio per trattareuna problematica come quella della scansionecrono-tipologica del Bronzo finale nel nostroterritorio ed in attesa di una sistematizzazionedel materiale di raccolta e di scavo da partedegli scriventi, si rimanda a prossime pubbli-cazioni.
Il popolamento del territorio Veronese durante l’età del Ferro 43
ANTONELLO I. 2006, La produzione ceramica, in A. Ruta Serafini, C. Sainati, A. Vigoni (a curadi), pp. 153-154.
ASPES A. (a cura di) 2002, Preistoria Veronese. Contributi e aggiornamenti, Memorie del Museo Ci-vico di Storia Naturale di Verona, IIs., 5
ASPES A., BORGHESANI G., CASTAGNA A., LONGO L., NICOLIS F., SALZANI L., ZORZIN R. 2002,Carta archeologico-preistorica del comune di Verona, in Bollettino Civico del Museo di StoriaNaturale di Verona, 26.
BALISTA C. 2004, Oppeano 2001-2002; la geomorfologia e le difese meridionali dell’area insediati-va dell’età del ferro, in A. Guidi, S. Ponchia (a cura di), pp. 27-36, tavv. XXI-XXVI.
BELLUZZO G., SALZANI L. (a cura di) 1996, Dalla terra del museo (catalogo della mostra), Verona.BETTINARDI I., LEONARDI G. 2002, Gestione e analisi informatizzata dei dati dell’abitato arginato
di Castion di Erbè (VR), in C. Peretto (a cura di), Analisi informatizzata e trattamento dati del-le strutture di abitato di età preistorica e protostorica in Italia, Firenze 2002, pp. 287-302.
BIANCHIN CITTON E., PANOZZO N. 1996, Concordia Sagittaria. Via Fornasatta-Area Coop, in Laprotostoria tra Sile e Tagliamento (catalogo della mostra), pp. 271-284.
BIANCHIN CITTON E., GAMBACURTA G., RUTA SERAFINI A. (a cura di) 1998, ...“presso l’Adige ri-dente” ...Recenti rinvenimenti archeologici da Este a Montagnana, ADLE Edizioni, Padova.
BIANCHIN CITTON E., PANOZZO N. 1998, Il vasellame ceramico, in E. Bianchin Citton, G. Gam-bacurta, A. Ruta Serafini (a cura di), pp. 295-321.
BORGHESANI G., SALZANI L. 1974, Materiali atesini da Oppeano Veronese, in Memorie del MuseoCivico di Storia Naturale - Verona, pp. 361-387.
BRUGNOLI G., SALZANI L. (a cura di) 1992, San Giorgio di Valpolicella. Scavi archeologici e siste-mazioni museali, Verona.
CASSOLA GUIDA P., CORAZZA S. 2005, Variano presso Basiliano (prov. di Udine), in Notiziario,Rivista di Scienze Preistoriche, LV, p. 523.
CHIAFFONI B., MORANDINI A. 2004, Materiali ceramici dalle ricognizioni di superficie svolte adOppeano Veronese, in A. Guidi, S. Ponchia (a cura di), pp. 23-25, tavv. XVIII-XX.
COLONNA C. 2006, Necropoli dell’ultima età del bronzo nell’area padana. Per una loro cronologia re-lativa, Fonti Archeologiche per la Protostoria Italiana - 1, Edizioni San Marco Litotipo, Lucca.
DE ANGELIS D. 2001-2002, La capanna n. 4 del Monte Loffa, in Annuario Storico della Valpoli-cella, pp. 235-244.
DE ANGELIS D. 2002, La necropoli di Ponte Florio (Montorio-Verona), in Aspes (a cura di), pp.188-189.
DE MARINIS R. 1999, Il confine occidentale del mondo proto-veneto / paleo-veneto dal Bronzo fina-le alle invasioni galliche del 338 A.C., in Venetorum angulus, pp. 511-564.
FRANCHI G. 1996, Il popolamento nell’area compresa tra Adige e Mincio-Tione-Tartaro nella primaetà del ferro, in G. Belluzzo, L. Salzani 1996, pp. 191-203.
GUIDA G., VANZETTI A., VIDALE M. 1992, Un laboratorio metallurgico nell’abitato protostorico, inBrugnoli, Salzani (a cura di), pp. 69-80.
GUIDI A. 1998, The Emergence of the State in Central and Northern Italy, in Acta Archaeologica 69,1998, pp. 139-61.
GUIDI A. 2006, The Archaeology of Early State In Italy, in Social Evolution & History, 6: 1, pp. 55-90.GUIDI A., PELOSO D. 2004, Oppeano Veronese: i risultati delle campagne di ricognizione del 2000
e del 2001, in A. Guidi, S. Ponchia (a cura di), pp. 13-22; tavv. X-XVII.
Bibliografia
GUIDI A., PONCHIA S. (a cura di) 2004, Ricerche archeologiche in Italia e in Siria (atti del Conve-gno, Verona 2002), Padova.
GUIDI A., CANDELATO F., PELOSO D. 2002, Nuovi dati sul centro protourbano di Oppeano Vero-nese, in Aspes (a cura di), pp. 168-70.
GUIDI A., CANDELATO F., PELOSO D., RIODA V., SARACINO M. 2005, Il centro protourbano di Op-peano Veronese, in P. Attema, A. Nijboer, A. Zifferero (a cura di), Papers in Italian ArchaeologyVI, BAR, IS 1452, Oxford, vol. II, pp. 720-728.
GUIDI A., SALZANI L. (a cura di) in corso di stampa, Oppeano: vecchi e nuovi dati dal centro pro-tourbano, in Quaderni di Archeologia, Numero Speciale.
La protostoria tra Sile e Tagliamento. Antiche genti tra Veneto e Friuli 1996, catalogo della mostra,Esedra, Padova.
LEONARDI G. 2002, Castion di Erbè, in Aspes 2002, pp. 185-186.MALNATI L., RUTA SERAFINI M., BIANCHIN CITTON E., SALZANI L., BONOMI MUNARINI S.
1999, Nuovi rinvenimenti relativi alla civiltà veneta nel quadro dell’Italia settentrionale, in Ve-netorum angulus, pp. 347-376.
MENOTTI E.M. 1999, Archeologia del territorio mantovano, Mantova 1999.MENOTTI E.M. 2005, La realtà del territorio mantovano in età preromana, con particolare riferi-
mento al V secolo a.C., in P. Attema, A. Nijboer, A. Zifferero (a cura di), Papers in Italian Ar-chaeology VI, BAR, IS 1452, Oxford 2005, vol. II, pp. 802-812.
MIGLIAVACCA M. 1993, Lo spazio domestico nell’età del ferro. Tecnologia edilizia e aree di attività traVII e I secolo a.C. in una porzione dell’arco alpino orientale, in Preistoria Alpina, 29, pp. 5-161.
MIGLIAVACCA M. 1998, Diversificazione dei sistemi di accesso alla casa retica, in G. Ciurletti, F.Marzatico (a cura di), Die Räter. I Reti (Atti Simposio 1993), Archeologia delle Alpi 5, Tren-to, pp. 106-133.
MIGLIAVACCA M. 2001-2002, I materiali del Monte Loffa dagli scavi De Stefani conservati al Mu-seo di Storia Naturale di Verona, in Annuario Storico della Valpolicella, pp. 223-228.
MOFFA C. 2002, Frammenti di concotto dall’area della struttura 1 dell’abitato della prima età delferro di Lovara, in Aspes (a cura di), pp. 172-174.
NISBET R. 1987, I vegetali carbonizzati nell’insediamento dell’età del ferro di Casterotto (Verona),in Prima della storia, pp. 121-130.
PIRAZZINI C., 2000, Indicatori di attività artigianale ad Este, in Archeologia Veneta, XXIII, pp.23-70.
Prima della storia. Inediti di 10 anni di ricerche (catalogo della mostra), Verona 1987, pp. 171-173.Protostoria e storia del “Venetorum angulus”, Atti del XX Convegno di Studi Etruschi e Italici (16-
19/10/1996), Pisa-Roma 1999.RIZZETTO G. 1976, Monte Loffa, in 3000 anni fa a Verona (catalogo della mostra), Verona 1976,
pp. 175-177, figg. 39-40.RIZZETTO G. 1996, Terranegra (Legnago), in G. Belluzzo, L. Salzani (a cura di), pp. 287-290.RIZZETTO G. (a cura di) 2004, I cigni del sole. Culti, riti, offerte dei Veneti nel Veronese (catalogo
della mostra), Verona.ROSSI S. 2005, La “necropoli del Fiume Nuovo”. Topografia dei rinvenimenti, aggiornamento e
spunti critici sulla protostoria di Baldaria di Cologna Veneta, in G. Leonardi, S. Rossi (a curadi), Archeologia e idrografia del Veronese a cent’anni dalla deviazione del fiume Guà (1904-2004), Padova 2005, pp. 267-290.
RUTA SERAFINI A., SAINATI C., VIGONI A. (a cura di) 2006, Lo scavo pluristratificato di Piazza Ca-stello n. 18 a Padova, in QdAV, XXII, pp. 150-167.
SAINATI C., SALERNO R. 1996, Concordia Sagittaria. Le buche della trincea 12, in La protostoriatra Sile e Tagliamento (catalogo della mostra), pp. 213-216.
Alessandro Guidi, Federica Candelato, Massimo Saracino44
Il popolamento del territorio Veronese durante l’età del Ferro 45
SALZANI L. 1983a, Località Fornace (Oppeano), in Bollettino del Museo Civico di Storia Naturaledi Verona, X, pp. 523-553.
SALZANI L. 1983b, Via Monte Suello (Verona), in Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale diVerona X, pp. 534-538.
SALZANI L. 1987, Archi di Castelrotto, in Prima della storia, pp. 171-173SALZANI L. 1990, I siti preistorici e protostorici, in R. Zorzin, L. Salzani, B. Dal Cero, A. Toniolo,
A. Buonopane (a cura di), La preistoria e l’età romana nel territorio sinistra Adige, Cologna Ve-neta, pp. 41-52.
SALZANI L. 1991, La preistoria, in B. Chiappa, A. Sandrini (a cura di), Cerea. Storia di una co-munità attraverso i secoli, Vago di Lavagno (Verona), pp. 23-30.
SALZANI L. 1992a, Abitato dell’età del ferro al castello di Montorio, in Fabbri, guerrieri, vasai. Ri-cerche su Neolitico-Età del bronzo-Età del Ferro nel territorio veronese (catalogo della mostra),Verona, pp. 42-45.
SALZANI L. 1992b, Il recente scavo archeologico, in G. Brugnoli, L. Salzani (a cura di), pp. 27-68.SALZANI L. 1993, L’abitato e la necropoli di Sabbionara a Veronella, Cologna Veneta.SALZANI L. 1996a, Ponte Florio (Verona), in G. Belluzzo, L. Salzani (a cura di), pp. 295-297.SALZANI L. 1996b, M. Sacchetti (San Pietro in Cariano), in G. Belluzzo, L. Salzani (a cura di), pp.
299-300.SALZANI L. 2001-2002, Note sul Monte Loffa dall’archivio privato De Stefani, in Annuario Storico
della Valpolicella, pp. 229-234.SALZANI L. 2002a, Età del ferro, in Aspes (a cura di), pp. 157-215.SALZANI L. 2002b, Un santuario, in Aspes (a cura di), p. 191.SALZANI L. 2002c, La casa retica, in Aspes (a cura di), p. 187.SALZANI L. 2002d, Una fornace per la ceramica, in Aspes (a cura di), p. 178.SALZANI L. 2004a, Vent’anni di ricerche della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto a
Oppeano, in A. Guidi, S. Ponchia (a cura di), pp. 1-4, tavv. I-IV.SALZANI L. 2004b, Ex Fornace (Oppeano, prov. di Verona), in Notiziario, Rivista di Scienze Prei-
storiche, LIV, p. 622.SARACINO M. 2004, Oppeano Veronese (VR): i materiali archeologici del saggio esplorativo n. 3 nei
pressi della località Montara, in A. Guidi, S. Ponchia (a cura di), pp. 37-39, tav. XXVII.ZIFFERERO 2003, Archeologia sperimentale e parchi archeologici, in P. Bellintani, L. Moser (a cura
di), Archeologie sperimentali: metodologie ed esperienze fra verifica, riproduzione, comunicazionee simulazione, Atti del Convegno, Comano Terme-Fiavè 13-15/09/2001, Provincia Autono-ma di Trento, Servizio Beni Culturali, Ufficio Beni Archeologici Trento, pp. 49-76.