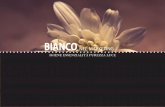‘De mandato Frederici imperatoris’. L’origine e il popolamento di Altamura nel secolo XIII,...
Transcript of ‘De mandato Frederici imperatoris’. L’origine e il popolamento di Altamura nel secolo XIII,...
149
“De mandato Frederici Imperatoris”.L’origine e il popolamento di Altamura
nel XIII secolo
Cristina Andenna
“Dicta terra posita et fundata fuit de mandato Frederici Impe-ratoris”, con queste parole l’origine della terra di Altamura è di-rettamente collegata al nome dell’imperatore Federico II1. L’idea di un imperatore attivo nella fondazione di nuovi centri e di città non è certo nuova. Fra il 1258 e il 1266, un cronista di corte, lo Pseudo Jamsilla2, nel narrare le gesta dell’imperatore svevo, ri-cordava fra le altre attività anche quella di “fondatore e costrutto-re” di città. Incentrandosi tuttavia solamente sulla prospettiva del regno di Sicilia, egli elencava sette civitates sorte in area meridio-nale per intervento e volontà dell’imperatore: Augusta e Eraclea in Sicilia, Monteleone in Calabria, Ordona e Lucera in Puglia,
1 Le carte di Altamura (1232-1502), a cura di A. Giannuzzi, Bari 1935 [CDB 12], la testimonianza piú ricca e importrante circa la ricostruzione delle origini di Altamura è riportata nelle deposizioni del 25 luglio del 1299, pp. 93-220, doc. 89, qui in particolare p. 111.
2 Sullo Pseudo Jamsilla cfr. anche la voce E. Pispisa, NicolòdiJamsilla, in Enc. Frid., Roma 2005, pp. 392-394 e la monografia dello stesso autore Id., Nicolò di Jamsilla. Un intellettuale alla corte di Manfredi, Soveria Mannelli 1984. Sulla Cronica si veda anche il breve ma interessante testo di M. Thumser, Der König und sein Chronist. Manfred von Sizilien in der Chronik des sogenannten Nikolaus von Jamsilla, in Die Reichskleinodien. Herrschaftszeichen des Heiligen Römischen Reiches, Göppingen 1997 [Schriften zur staufischen Geschichte und Kunst 16], pp. 222-242.
criStina andenna150
Flagella nella Terra di Lavoro e una certa, non meglio identificata, Alitea, che l’autore collocava in Calabria3. L’opera dello Pseudo Jamsilla, il De rebus gestis Frederici secundi imperatoris, com-posto durante il regno di Manfredi, presenta un carattere estre-mamente sintetico e selettivo nella ricostruzione degli eventi del periodo federiciano. Nella sua introduzione l’autore presenta la figura di Federico II e descrive le sue gesta, mantenendo tuttavia una prospettiva volutamente limitata al solo Regno. La seconda, e più consistente, parte dell’opera fu dedicata prevalentemente alla narrazione delle gesta di Manfredi, vero protagonista della Cro-nica. Pur nella voluta brevità della narrazione, il fatto che l’autore ricordi l’attività di Federico II come fondatore e costruttore di città, è segno che negli ambienti di corte tale gesto era conside-rato uno dei connotati costitutivi del potere regio4. Si tratta di un elemento che ben si inquadra nel generale progetto di legittimare e rendere stabile, nella seconda metà del secolo XIII, il controllo politico degli Svevi in Italia meridionale. L’affermazione del cro-
3 Mancava nell’elenco il nome di Altamura. Secondo Sanfilippo [M. Sanfilippo, Divagazioni e considerazioni sul tema delle civitates novae federiciane, in «Studi bitontini» 75 (2003), pp. 33-40, in particolare p. 37] non è possibile individuare l’insediamento di Alitea. A mio parere il termine andrebbe verificato meglio nella tradizione manoscritta, potrebbe trattarsi di una cattiva lettura o trascrizione dell’antico nome di Altamura, Altilia, riportato nel processo di età angioina come un precedente insediamento saraceno; Le carte di Altamura (1232-1502), p. 111. Errata tuttavia sarebbe in questo caso anche la sua collocazione geografica in Calabria. Sulla antichità del sito di Altamura una breve ricognizione compie V. Tirelli, L’universitas hominum Altamure dallasuacostituzioneallamortediRobertod’Angiò, in «ASP» 9 (1956), pp. 51-144, in particolare pp. 52-62.
4 Nicolai de Jamsilla Historia de rebus gestis Friderici II Imp. ejusque filiorumConradietManfrediApuliaeetSiciliaeregum: ab anno MCCX usque ad MCCLVIII; adnectitur anonymi supplementum de rebus gestis ejusdem Manfredi, Caroli Andegavensis et Conradini regum ab anno MCCLVIII usque ad MCCLXV [Rerum Italicarum scriptores 8], pp. 489-616: quasdam quoque civitates in regno fundavit et construxit videlicet Augustam et Eracleam in Sicilia, Montem Leonis et Aliteam in Calabria, Dordoniam et Luceram in Apulia, Flagella in Terra Laboris contra Cepranum; cito qui da M. Sanfilippo, Divagazioni e considerazioni, p. 35.
“De mandato Frederici Imperatoris” 151
nista, unita alla dichiarazione del testimone riportata in apertura, non contrasta, anzi ben si accorda, con l’immagine consolidatasi dell’imperatore come un sovrano anche dedito alla costruzione di castelli e di rocche e alla fondazione di città, sia nel Regnum Siciliae, sia nei territori dell’impero.
Significativa in questa prospettiva celebrativa del potere regio era la fondazione nel 1231 di terra ipsa Auguste. È qui forse su-perfluo ricordare che il nome di Augusta richiamava immediata-mente l’antica tradizione romana, ma il termine offriva anche un collegamento immediato con la volontà dell’imperatore. Colloca-ta su un istmo, Federico II ne aveva disposto un’ampliatio e un incrementum con le terre confiscate, non di proprietà del demanio regio. Il nuovo insediamento fu inoltre dotato di mura e di un castello fortificato, che nel 1242 era già terminato. Per la sua par-ticolare posizione geografica Augusta fu pensata sin dalle origini come una città portuale, una funzione che la caratterizzava sin dal 1239, ma anche come base privilegiata della flotta imperiale sulla costa orientale e come postazione per meglio controllare le città vicine di Siracusa e Messina, che si erano ribellate all’im-peratore5. Altrettanto significativo in un’ottica di pianificazione politica fu il progetto della fondazione della fortezza di Flagella (in origine Civitas nova). In un diploma del 1242 l’imperatore sottolineava la funzione strategico-militare di cui il nuovo sito era investito: CivitatemnostramFlagelleadflagellumhostiumineo
5 Cfr. W. Stürner, Friedrich II., Teil II, p. 227, nota 125 e testo corrispondente; E.P. Wipfler, Die Städtegründungen Friedrich II. von Hohenstaufen in Italien. Eine quellenkritische Studie, in «Die alte Stadt. Vierteljahreszeitschrift für Stadtgeschichte, Stadtsoziologie, Denkmalpflege und Stadtentwicklung» 32 (2005), pp. 185-213, qui in particolare pp. 207-211; M. Sanfilippo, Divagazioni e considerazioni, pp. 35-36; ed infine il più datato P. Scheffer-Boichorst, Die Gründung Augustas und die Wiederherstellung Regalbutos, in Id., Zur Geschichte des XII. und XIII. Jahrhunderts. Diplomatische Forschungen, Berlin 1897, pp. 371-407 e H. Niese, NormannischeundstaufischeUrkundenaus Apulien, in «QFIAB» 9 (1906), pp. 221-270 e 10 (1907), pp. 57-100, qui in particolare 6 (1906), p. 263.
criStina andenna152
situfundari…quoinfidelibustransitushabiliorcernebatur6. La città era concepita, nei disegni di Federico II, come un avamposto ai confini dei territori della Chiesa romana, da cui si sarebbe potu-to più agilmente sterminare i nemici e bloccare l’ingresso di sud-diti infedeli nel Regno. L’attribuzione del nome, oltre al richiamo alla sua specifica funzione, si ispirava forse anche alla tradizione toponomastica di un antico insediamento, distrutto dai romani nel 125 a. C., Fregellae, nei pressi di Ceprano, sulla via Latina7.
Destinato a una duratura fortuna abitativa e commerciale è il sito di Eraclea, poi Terranova, edificato sulle rovine dell’antica colonia greca di Gela. Anche in questo caso, come in altri luo-ghi, Federico II costruì le mura e le torri della città utilizzando i resti di precedenti insediamenti, trasferendo in modo forzato gli abitanti provenienti per lo più dal territorio della Calabria, cui erano promesse in cambio dell’abbandono della loro patria nuove terre e sgravi fiscali. Nel 1239 gli abitanti ottennero il consen-so dell’imperatore alla costruzione di una plagia, per facilitare il commercio delle granaglie, ut barce possint ingradari8. Un ap-prodo che si sviluppò poi nel porto presso Capo Soprano9.
Un altro progetto di Federico II, assente nella notizia dello Pseudo-Jamsilla, ma emblematico per il nostro discorso, è quello di Vittoria, la cui vicenda è nota grazie alle vivaci descrizioni di Salimbene e alla cronaca di Rolandino Patavinus10. Nella fon-
6 HB, VI,1, pp. 51-52; BFW 3303, p. 580.7 Maggiori particolari sono narrati nella Chronica di Riccardo di San
Germano (Ryccardi de Sancto Germano Notarii Chronica, ed. C.A. Garufi, Muratori2 7,2 Bologna 1936-1938, ad annum 1241, p. 211; ad annum 1242, p. 215 e ad annum 1243, p. 216); cfr. W. Stürner, Friedrich II., Teil II, p. 226, nota 122 e E.P. Wipfler, Die Städtegründungen Friedrich II., pp. 193-194.
8 HB V,1, p. 633.9 Cfr. W. Stürner, Friedrich II., Teil II, p. 226; E.P. Wipfler, Die
Städtegründungen Friedrich II., p. 193; M. Sanfilippo, Divagazioni e considerazioni, p. 36.
10 Rolandini Patavini Chronica, ed. Ph. Jaffé, Hannover 1886 [MGH SS 19], Liber V, pp. 32-147. Cfr. anche W. Stürner, Friedrich II., Teil II, pp. 573-577.
“De mandato Frederici Imperatoris” 153
dazione e nei gesti che l’accompagnarono si intravede l’eco di una scelta politica intenzionale da parte dell’imperatore non solo nell’attribuzione del nome, ma ancor prima nell’apparato scenico della sua fondazione.
Nel racconto delle fonti Federico II avrebbe personalmente scavato con l’aratro i confini della città, il cui sito insediativo sa-rebbe stato collocato e orientato sulla base di precisi, ma compli-cati, calcoli astrologici11.
La nuova città sarebbe stata poi celebrata con il conio di una moneta. Attraverso questi gesti rituali Federico II intendeva con-ferire al nuovo sito un’aurea quasi mitica, ricollegandosi non solo alla grande tradizione imperiale romana, ma al tempo stesso an-che alla cultura araba. La città era assente dall’elenco dello Pseu-do-Jamsilla, sia perché situata in Italia settentrionale, un territorio privo di interesse nell’ottica ‘meridionalistica’ del cronista, sia forse anche per il suo carattere di breve esperimento, mai com-piutamente realizzato, a causa della sconfitta dell’imperatore nel 124812.
11 E.P. Wipfler, Die Städtegründungen Friedrich II., pp. 199-207. A questo proposito si veda la descrizione della fondazione della città in Rolandini Patavini Chronica, pp. 85-86: “Et in contrarium civitatis quodammodo ante portas aliam civitatem construxit, quam nomine Victoriam appellavit. Et quia scivit, quod antiqui magnates respiciebant ascendens, cum volebant condere civitates et faciebant ipsimet urvum cum aratro, quo circumdabant civitates, unde dicte sunt urbes, incepit et ipse designare hanc suam novam civitatem signo Arietis ascendente, tum quia signum est Martis qui dicit Deus belli, tum quia erat Libre ascendenti contrarium in occasum, quod est signum Veneris, qui planeta Parme dicitur et esse fortuna eius. Quasi per hoc forsitan cogitaret, quod Parmensium fortuna, qui oppositi ei erant, tenderet in occasum, quod est signum Veneri, qui Planeta Parme dicutur et esse fortuna eius. Quasi per hoc forsitan cogitaret, quod Parmensiuum fortuna, qui oppositi ei erant, tenderet in occasum. In astrologicis namcque et in hiis, que subtilitatem astrologicam imitantur, primum operanti et optimum adversario datur. Set puto, quod non notavit quartum ab ascendente fuisse Cancrum. Quartum enim edificia domos et civitates disignat; et sich civitas, sub tali ascendente incepta, cancrizare debebat”.
12 Sulla distruzione della città cfr. Salimbene de Adam, Cronica, ed. G.
criStina andenna154
Anche gli altri centri menzionati dallo Pseudo-Jamsilla, Dor-donia13, Lucera14, Monteleone15 e Alitea, erano il risultato del ripopolamento di antichi insediamenti di origine greca, dauna o romana, a volte ripresi in età successive dai longobardi, dai bizan-tini o dai normanni e poi nuovamente decaduti o abbandonati.
In questo senso si potrebbe affermare che gli interventi di “fondazione” da parte dell’imperatore non sono il risultato di una scelta casuale, ma lasciano intendere una certa intenzionalità.
Nella rivitalizzazione degli antichi siti, nel riutilizzo delle ro-vine ancora esistenti, nell’assunzione degli antichi nomi di luoghi scomparsi, ma ancor più nella ritualità e nella funzione simbo-lica che spesso accompagnava tali atti fondativi, come nel caso eclatante di Vittoria, Federico II intendeva non un semplice rife-rimento alla tradizione antica16, ma una sua consapevole ripresa,
Scalia, 2 voll., Turnhout 1998-1999 [Corpus Christianorum Continuatio Medievalis 125], vol. 1, pp. 297-298 e 307-309.
13 Secondo Mario Sanfilippo l’attuale Ordona, di antica origine dauna, poi rivitalizzata in età romana e trasformata in un castrum in età normanna, ormai abbandonato quando Federico II ne ordinava il ripopolamento attraverso lo strumento della revoca. In tal modo anche la rivitalizzazione di questo territorio aveva come obbiettivo la ricostruzione di una rete di controllo per valorizzare il patrimonio regio. Tale progetto tuttavia fu privo di una duratura fortuna, ma rimase un casale fortificato; M. Sanfilippo, Divagazioni e considerazioni, p. 37 e W. Stürner, Friedrich II., Teil II, p. 225, nota 122.
14 Antico centro dauno, poi romano, bizantino, longobardo e normanno; fu rivitalizzato da Federico II nel 1224/1225 con un’azione di trasferimento forzato di una colonia di Saraceni provenienti da Girgenti in Sicilia e deportati sul continente; M. Sanfilippo, Divagazioni e considerazioni, pp. 37-38; E.P. Wipfler, Die Städtegründungen Friedrich II., pp. 197-198.
15 Monteleone, l’attuale Vibo Valentia, ebbe origini greche, fu poi trasformata in un municipio romano, ma mantenne una certa continuità sino all’età bizantina, quando poi scomparve a causa di una invasione saracena nel 983. Nell’XI secolo divenne un castrum ad opera di Ruggero il Gran Conte. Tra il 1233 e il 1237 Federico II affidava l’ampliamento del castrum e ordinava il ripopolamento dell’abitato; M. Sanfilippo, Divagazioni e considerazioni, p. 37 e W. Stürner, Friedrich II., Teil II, p. 225, nota 122.
16 A. Esch, Friedrich II. und die Antike, in Friedrich II. Tagung des Deutschen Historischen Instituts in Rom im Gedenkjahr 1994 / Federico II.
“De mandato Frederici Imperatoris” 155
in una nuova semantica di significato. Come ha giustamente af-fermato alcuni decenni or sono Eugenio Dupré Theseider, è tut-tavia giusto chiedersi cosa si intenda precisamente con il termine “fondazione”17, dato che nella realtà l’essenza di una città con-siste per lo più nel suo divenire e, proprio il momento della sua nascita, si presenta come il meno significativo.
Se da un lato in ogni atto fondativo è presente una volontà da parte di un’autorità, in questo caso si tratta di un imperatore, che attribuisce a quel gesto una carica di significato che trascende la dimensione dell’atto stesso, d’altro lato tuttavia questi momenti “creativi”, o “ideativi” come preferiva definirli il Theseider, sono pur sempre da collocare in un’ottica di pragmatismo politico.
La fortificazione di antichi luoghi, che rinascevano così a nuo-va vita, rispondeva a necessità difensive. Al tempo stesso poi la politica di ripopolamento, proposta da Federico II in molte terre del Regnum, e la costruzione, o meglio molto spesso la riscoperta e la risistemazione di centri fortificati e di castelli, erano parte di un progetto inteso alla ricostituzione di una solida base demania-le, condizione indispensabile per la realizzazione dell’idea di un regno centralizzato18.
In quest’ottica è forse da collocare anche la “fondazione” di Altamura, quel luogo che Hans Niese all’inizio del secolo scorso definiva giustamente il risultato della “colonizzazione di un cen-tro demaniale, fatta con intenti fiscali”19. Se nella scelta del nome è possibile rilevare l’eco di un voluto richiamo al passato, d’altro
Convegno dell’Istituto Storico Germanico di Roma nell’VIII Centenario della nascita, hg. von A. Esch e N. Kamp, Tübingen 1996 [Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 85], pp. 201-234.
17 E. Dupré Theseider, Federico II, ideatore di castelli e città, in «ASP» 26 (1973), pp. 25-40.
18 A questo proposito si veda W. Stürner, Friedrich II. Teil 1: Die Königsherrschaft in Sizilien und Deutschland 1194-1220, Darmstadt 1992 und Teil II: Der Kaiser 1220-1250, Darmstadt 2000, qui in particolare Teil II, pp. 222-242.
19 H. Niese, NormannischeundstaufischeUrkunden, qui in particolare 6 (1906), pp. 256-263.
criStina andenna156
canto la documentazione di natura pubblica superstite non pre-senta alcuna esplicita dichiarazione di un intento dal significato politico sovraordinato. L’intenzione di dare inizio all’insediamen-to di Altamura si inserisce solo in un progetto che risponde alle logiche più serrate di una politica di ripopolamento demografico delle aree appartenenti al demanio e di freno nei confronti della diminutio feudorum, un fenomeno sul quale sarebbero intervenu-te in modo più decisivo anche le costituzioni emanate a Melfi.
In questa logica ha ben poco valore allora l’ostinata ricerca di individuare nella documentazione superstite un atto che at-testi l’ufficiale inizio della storia di Altamura, un atto per così dire di “fondazione”, prospettiva questa che ha in un certo senso inutilmente occupato l’interesse della storiografia locale. Tutta-via soffermarsi nuovamente a riflettere sui documenti prodotti da Federico II e sulle testimonianze che di quel centro abitativo ci sono pervenute non è affatto superfluo e permette, liberi da precondizionamenti, di riconsiderare in sede storica anche il loro significato.
Nel settembre del 1232, da Melfi, dopo essere stato dal pon-tefice reintegrato nella comunità dei fedeli e aver recuperato una posizione di forza sia nel regno, che nell’impero, Federico II pre-miava coloro che lo avevano aiutato a tener salda la sua posizio-ne. In un privilegio dichiarava: “Avendo raggiunto il culmine del nostro dominio e avendo conferito ai nostri successi una gloria perenne, intendiamo ora proseguire [la nostra opera] con imperia-le munificenza attribuendo benefici a coloro che ci hanno aiutato con costanza e servito con pura fedeltà, in modo da manifestare [loro] la nostra gratitudine”. Con queste parole Federico II a circa un anno dalla proclamazione delle Costituzioni di Melfi ricom-pensava coloro che a lui erano stati fedeli. Beneficiario del privi-legio era un chierico della cappella imperiale, Riccardo di Brin-disi, al quale Federico II, come premio per la fedeltà e il sostegno dimostrato, attribuiva la carica di archipresbiter della chiesa di Altamura, che l’imperatore definiva da lui “fondata di nuovo (de novo fundata) e dedicata alla Vergine”, sita nel giustiziariato della
“De mandato Frederici Imperatoris” 157
terra di Bari20. Nel privilegio era stabilito che l’arciprete sareb-be stato soggetto solamente alla Chiesa romana, definita caput omnium ecclesiarum, e all’imperatore, che l’aveva fatta edificare nella predetta terra e l’aveva resa libera e immune. La chiesa era concessa a Riccardo libera ed esente da ogni pretesa di giurisdi-zione da parte di arcivescovi e vescovi. Nel documento inoltre Federico II stabiliva per sé e per i suoi successori il diritto di col-lazione, cioè di nomina dell’arciprete21.
Lungi pertanto dall’essere un documento di fondazione di una città, il privilegio imperiale si presenta come un puro atto politi-co. Il suo interessamento nei confronti della chiesa di Altamura presenta un carattere del tutto differente rispetto alle consuete do-nazioni da parte di sovrani a chiese o enti religiosi. Nel documen-to non traspare alcun sentimento di pietà religiosa, né alcun ge-sto mosso da un desiderio di particolare devozione. L’imperatore agisce in questo caso come semplice attore politico, interessato a tutelare il proprio ruolo su una terra che apparteneva al demanio
20 HB IV,I, pp. 389-390.21 HB IV,I, pp. 389-390. La chiesa arcipresbiterale è considerata una realtà
istituzionale tipica del Mezzogiorno, in essa è presente, secondo Cosimo Damiano Fonseca, un capitolo non cattedrale, nel quale vi è tuttavia una sola dignità, quella dell’archipresbiter, con funzioni più di capo del collegio dei chierici, non rare volte indicati con il termine di canonici, che di titolare di una parrocchia; cfr. C.D. Fonseca, Le istituzioni ecclesiastiche lucane dal tardoantico al tardomedioevo, in Storia della Basilicata, vol. 2, Roma 2005, pp. 231-306 e Id., Aspetti istituzionali dell’organizzazione ecclesiastica meridionale dal VI al IX secolo, in Particolarismo istituzionale e organizzazione ecclesiastiche del Mezzogiorno medioevale, Galatina 1987 [Università degli Studi di Lecce – Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali, Saggi e Ricerche, 25], pp. 3-20. Cfr. anche B. Ruggiero, Potere, istituzioni, chiese locali: aspetti e motivi del Mezzogiorno medioevale dai Longobardi agli Angioini, Spoleto 1991 [Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo. Reprint 2] e G. Vitolo, Pievi, parrocchie e chiese ricettizie in Campania, in Pievi e parrocchie in Italia nel basso Medioevo (secc. XIII-XV). Atti del VI convegno di storia della Chiesa in Italia (Firenze, 21-25 settembre 1981), Roma 1984, vol. II, pp. 1095-1107 e Id., Dalla pieve rurale alla chiesa ricettizia, in Storia del Vallo di Diano, vol. II, a cura di N. Cilento, Salerno 1982, pp. 127-173.
criStina andenna158
e di cui la chiesa costituiva con i suoi beni un nucleo fondamen-tale. Nel 1248 il pontefice Innocenzo IV confermava al chierico Riccardo il titolo e la funzione di arciprete, secondo quanto un tempo aveva disposto l’imperatore Federico II, con tutti i diritti e gli onori ad essa connessi. La chiesa di Altamura figurava tuttavia nel documento papale come collocata nella diocesi di Gravina22.
Le informazioni contenute nel documento presentano tuttavia un significato più compiuto se sono correlate con quanto ci è tra-mandato nei fascicoli di un processo conclusosi il 25 luglio del 1299, a circa sessant’anni e più dalla redazione del diploma23.
Il processo era stato istituito per ordine di Carlo II con lo scopo di risolvere alcune controversie in materia giurisdizionale relati-ve ai diritti della chiesa di Altamura, rivendicati sia dal vescovo di Gravina, Giacomo, sia da Pietro de Angeriaco, tesoriere della chiesa di San Nicola di Bari, al quale per investitura regia nel maggio del 1296 era stata conferita anche la carica di arciprete della chiesa altamurana24. La decisione del sovrano di unire l’ar-cipretura di Altamura alla tesoreria di San Nicola di Bari era il risultato di una serie di contrasti sorti negli anni precedenti con i vescovi dei territori limitrofi sul diritto di designazione del sa-cerdote dell’arcipretura, che sin dalle origini per volere di Fede-rico II, per diritto di collazione, spettava al re. Nel 1293 Carlo II aveva stabilito di assegnare la carica arcipresbiterale, rimasta vacante, al chierico francese Dionisio Juppart de Cenomanis, al quale con una lettera del 26 aprile dello stesso anno il sovrano as-segnava la cappella di Altamura cum iuribus, rationibus et perti-nentiis suis omnibus25. Parallelamente il logoteta Sparano da Bari, al quale la terra di Altamura apparteneva per diritto feudale, si era arrogato il diritto di interferire e aveva nominato come arciprete suo nipote Giovanni, che, insediandosi nella chiesa, aveva osta-
22 Le carte di Altamura (1232-1502), pp. 7-8, doc. 3.23 Le carte di Altamura (1232-1502), pp. 93-220, doc. 89.24 Le carte di Altamura (1232-1502), p. 66, doc. 66.25 Le carte di Altamura (1232-1502), p. 44, doc. 44.
“De mandato Frederici Imperatoris” 159
colato la piena attuazione degli ordini del re26. Nell’aprile dell’an-no successivo Sparano era deceduto e Dionisio Juppart aveva preso possesso dell’arcipretura27. Nel 1295, per garantire la sua posizione e godere dei diritti a lui spettanti, Dionisio si era fatto autenticare dal sovrano i documenti principali che giustificavano e rendevano valida la sua nomina: il privilegio di Federico II del 1232, la conferma papale della arcipretura a Riccardo di Brindisi da parte di Innocenzo IV del 1248 e un breve concesso dal vesco-vo Pietro di Gravina nel 1284, con il quale si elencavano i diritti dell’arcipretura e la conferma della collazione regia28. Il 10 mag-gio del 1295 il sovrano aveva poi incaricato il vescovo di Bitetto, Marino, e il milite, Angelo da Pisticci, di recarsi ad Altamura e di fare un’inchiesta per stabilire la linea da tenere nei confronti dei diritti dell’arcipretura e dei suoi effettivi legami con la diocesi di Gravina. Il presule Giacomo si era lamentato del fatto che Alta-mura era compresa sotto la sua giurisdizione e che il nuovo ar-ciprete gli impediva di riscuotere quanto a lui spettava tamquam diocesano pleno iure e di esercitarvi la sua giurisdizione29. Una seconda lettera rivolta al re denunziava poi Dionisio Juppard di aver presentato, per tramite del suo vicario e procuratore Dionisio de Galliano, in curia regia carte false riguardanti le modalità di nomina dell’arciprete e i privilegi connessi alla chiesa30. Il 27 set-tembre del 1295 Dionisio Juppart deponeva la carica di arciprete di Altamura e Carlo II nominava in sua sostituzione il chierico
26 Le carte di Altamura (1232-1502), p. 46, doc. 46.27 La lettera di incarico da parte del giustiziere di decorare con il cingolo
militare il figlio di Sparano è del 28 aprile 1294; Le carte di Altamura (1232-1502), p. 47, doc. 47. Il 6 giugno del 1294 il sovrano inoltre domandava al giustiziere della Terra di Bari di deporre il chierico Giovanni, voluto da Sparano di Bari, e di investire Dionisio Juppart della arcipretura di Altamura, costringendo i detentori indebiti dei beni a restituirli all’arciprete e ad assegnargli le rendite a partire dalla data del 26 aprile 1293; Le carte di Altamura (1232-1502), pp. 48-49, doc. 48.
28 Le carte di Altamura (1232-1502), p. 56, doc. 56.29 Le carte di Altamura (1232-1502), p. 59, doc. 58.30 Le carte di Altamura (1232-1502), p. 61, doc. 60.
criStina andenna160
Guglielmo de Venza, il quale tuttavia, come veniamo a conoscere da una lettera del sovrano, nell’aprile del 1296 non era ancora entrato in possesso della chiesa e dei suoi beni31. Il 1 maggio del 1296 anche Guglielmo, ora indicato come magister, rinunciava alla regia cappella di Altamura, che il sovrano, come ricompensa dei servizi prestati, intendeva conferire al tesoriere della chiesa di San Nicola di Bari32. Dopo lunghe procedure, il 17 ottobre del 1298 Carlo II comunicava ufficialmente ai signori e a tutti gli uomini della terra di Altamura che, sulla base dell’autorizzazione apostolica contenuta in una bolla di Bonifacio VIII33, aveva an-nesso ed unito l’arcipretura di Altamura, di collazione regia, alla tesoreria della chiesa di San Nicola di Bari e ne aveva investito il tesoriere Pietro de Angeriaco34. Lo stesso giorno inoltre il re notificava l’annessione dell’arcipretura di Altamura a Francesco di Eboli di Capua, giustiziere della Terra di Bari, e gli ordinava di costringere il vescovo di Gravina a restituire i beni e gli animali impropriamente sottratti alla chiesa e alla comunità di Altamu-ra35. L’ingiunzione al giustiziere fu ripetuta il 20 ottobre 1298 con l’ordine di aiutare il tesoriere Pietro de Angeriaco a recuperare il denaro e gli animali e quant’altro il vescovo di Gravina aveva indebitamente sottratto ai chierici e alla chiesa altamurana36. La causa non si concluse, poiché alcuni mesi dopo, nel gennaio del 1299, Carlo II chiese al giustiziere di esaminare la questione ver-tente fra Giacomo, vescovo di Gravina, e Pietro de Angeriaco, te-soriere di San Nicola di Bari e arciprete della chiesa di Altamura.
31 Le carte di Altamura (1232-1502), p. 65, doc. 65.32 Le carte di Altamura (1232-1502), p. 66, doc. 66 e pp. 66-67, doc. 67.33 La lettera di Bonifacio VIII è del 1296 e riguarda la concessione, su
richiesta di Carlo II, di poter accrescere le rendite della chiesa di San Nicola di Bari, aggiungendo qualche altra chiesa di collazione regia; Le carte di Altamura (1232-1502), p. 69, doc. 70.
34 Le carte di Altamura (1232-1502), p. 76, doc. 78 e pp. 80-81, doc. 81.35 Le carte di Altamura (1232-1502), p. 77, doc. 79.36 Le carte di Altamura (1232-1502), p. 78, doc. 80.
“De mandato Frederici Imperatoris” 161
La lite doveva essere definitivamente risolta con un processo37. Il 4 marzo del 1299 tuttavia il tesoriere Pietro chiedeva al giusti-ziere barese di annullare il processo, in quanto il vescovo aveva promesso di restituire spontaneamente i frutti, i diritti e i proventi, ammesso che ve ne fossero, da lui percepiti dalla chiesa di Alta-mura dopo l’annessione alla tesoreria di San Nicola di Bari38. Era troppo tardi: infatti il 7 e il 13 marzo del 1299 erano compilate le liste contenenti le posizioni dell’una e dell’altra parte, necessarie per iniziare gli interrogatori del processo39, che ebbero luogo a partire dal 25 luglio del 129940.
Le ricche testimonianze processuali, anche se a volte palese-mente divergenti, costituiscono una documentazione di gran pre-gio per la ricostruzione della vita politica, economica, sociale e religiosa di un centro abitato costituitosi nel corso del secolo XIII in Italia meridionale.
Gli interrogatori, affidati per volontà regia al vescovo di Bi-tonto, Leucio, e al giudice Lupone della stessa città, erano stati eseguiti sulla scorta di una lunga lista di domande che cercavano di delimitare il cuore del problema, ricercando quali legami giu-risdizionali erano esistiti alle origini fra le due parti in causa. I quesiti e le risposte ricapitolano nella sostanza le tappe salienti della storia dell’arcipretura, cui era direttamente collegata anche la storia della terra di Altamura.
Pur nella dissonanza delle informazioni, dettate non solo dalla necessità di difendere gli interessi di una parte piuttosto che di un’altra, ma anche dalla lente deformante della memoria, i te-stimoni sembrano nel complesso concordi nel riferire che dicta terra posita et fundata fuit de mandato Frederici imperatoris. L’origine del centro abitato era pertanto ricondotta in modo indu-bitabile a Federico II, e con ogni probabilità, date le caratteristi-
37 Le carte di Altamura (1232-1502), p. 79, doc. 82.38 Le carte di Altamura (1232-1502), p. 82, doc. 84.39 Le carte di Altamura (1232-1502), pp. 83-90, doc. 85-86.40 Le carte di Altamura (1232-1502), pp. 93-220, doc. 89.
criStina andenna162
che del nuovo insediamento, alla sua politica di ripopolamento. Alcuni testimoni ricordavano che il sito in cui l’imperatore aveva ordinato la costruzione della terra di Altamura aveva una storia precedente. Essi riferivano infatti di aver sentito dire che in quel luogo, in tempi antichi, si trovava un centro, il cui nome era Alti-lia, in cui avevano abitato i saraceni41. In seguito quella terra era stata soggetta ad un progressivo spopolamento, sino a divenire un luogo deserto, che secondo il ricordo dei più anziani, era stato destinato al pascolo e alle attività di lavoro agricolo42, fra cui la
41 Le carte di Altamura (1232-1502), Sire Mundea de Gravina, p. 111, r. 640-642: “ut dicebat, recordatur quando in terra Altamure nullus habitabat, tamen vocabatur tunc eodem nomine locus ita desertus. Antiquo tamen tempore, ut audivit ab antiquioribus suis, vocabantur idem locus Altilia quando erat locus Sarracenorum, et a sexaginta annis parum plus vel parum minus dicta terra posita eu fondata fuit de mandato Frederici imperatoris”.
42 Le carte di Altamura (1232-1502), Nicholaus archidiaconus Gravine, p 105, r. 440-444: “dixit quod ipse testis recordatur, quando posita fuit predicta terra Altamure tempore Frederici imperatoris, et antequam esset posita dicta terra audivit dici ab antiquioribus suis quod bauli Gravine ibant usque ad dictum locum Altamure et etiam ultra, et affidabant ove set alia animalia tamquam pascentia in territorio Gravine, et affidagia recipiebant a patronis dictorum animalium”; Magister Tancredus Malignus de Gravina, p. 118, r. 896-904: “recordatur quando terra Altamure nondum erat posita per Fredericum imperatorem, set erat locus desertus et inhabitatus, nihilominus tunc ipse locus vocatur Altamura, et ipse testis habebant unum sororium nomine Robertum, qui tenebat curte ovium suarum in loco ubi modo est ecclesia Sancti Marci, que ecclesia sita est parum extra ipsam terram Altamure, et ipse testis sibat ad predictas curtes et morabatur cum predicto sororio, et morando ibi vidit plures Baiulos Gravine venire ad dictum locum, et affidabant ibi animalia exterorum, tamquam pascentia in tenimento Gravine, tamen de nominibus dictorum baiulorum dixit se non ricordari et postquam dicta terra Altamure fuit fondata et constructa per Fredericum imperatorem vocata fuit Altagusta, et ex tunc non vidit ipse testis baiulos aliquos Gravine venire ad dictum locum ad faciendam affidationem predictam”. Gli altri testimoni ricordano invece gli interessi agricoli ed economici degli abitanti di Bitetto, ad esempio Iohannes Paniscalidus de Binecto, p. 193, r. 3527-3533: “recordatur quando locus ubi est posita Altamura erat desertus et inhabitatus, nec erat ibi posita adhuc Altamura, et quia homines Bitecti qui sunt vicini habebant tunc et nunc etiam habent aquas et herbas comune, idem testis cum esset custos baccarum
“De mandato Frederici Imperatoris” 163
coltivazione delle fave43. In quei luoghi erano incentrati gli inte-ressi agricoli ed economici di molti degli abitanti di Gravina, di Matera e di Bitetto e dei centri circostanti.
Conosciuta l’esistenza di quella antica terra, e appurato che vi si potesse abitare, negli anni della prima scomunica, l’imperatore, perseguendo come ha affermato Vito Tirelli una politica econo-mica sempre più orientata verso il centralismo, aveva ordinato che in quel luogo sorgesse lentamente un centro abitato44. Le te-stimonianze ci informano sulle modalità con le quali l’imperatore
tam suarum, quam extranearum aliarum, ducebant predictas baccas suas ad predictum locum, nec affidabat predicta baccas, nec affidagium solvebat pro eis subendo pascua in dicto loco, propter communitatem predictam, et quia dictus locus erat de tenimento Bitecti”; Angelus dompni Nicolai de Binetto, p. 201, r. 3815; Angelus de Syclo de Ioha, p. 202, r. 3858; Stephanus Nicolai Manci de Aquaviva, pp. 207-208, r. 4050-4051; Sanctorus Alechie de Grumo, p. 213, r. 4259-4267; Caytaldus Romeus de Grumo, p. 215, r. 4234-4334: “recordatur quando locus ubi est sita Altamura erat desertus et inhabitatus, et arabatur et seminabatur ad hominibus Bitecti, pro eo quod erat de tenimento Bitecti, quod etiam extendebatur ultra dictum locum versus fronteriam Gravine fere ad duo milliaria et dimidium et plus, et ipse testis habebat quondam victrinum, qui tenebat campus iuxta locum, ubi non sita est dicta terra, et ipse testis erat gualanus eius, et tunc vidit predictos homines Bitectenses, et etiam dominum Bonumconsilium Episcopum Bitectensem tenere campos in dicto loco et circa, et etiam ultra versus fronteriam Gravine usque ad milliaria supradicta tamquam in tenimento Bitecti, et vidit idem testis plures diversos baiulos Bitectenses excercere baiulationem suam, usque ad predicta milliaria cum usque illuc extenderetur dictum tenimentum Bitecti, ut supra dictum est affidando affidagia et terraglia recipiendo”.
43 Le carte di Altamura (1232-1502), Sanctorus Alechie de Grumo, p. 213, r. 4262: “recordatur quando locus ubi sita est Altamura et ecclesia, erat desertus, et inhabitatus, et cum ipse testis esset oriundus de Bitecto et tunc etiam habitator Bitecti, aravit in dicto loco, una cum quodam patro suo, qui vocabatur Marcus et plantabat ibi fabas et solvit terragium baulis Bitecti”; Matheus Leonis Zappatoris de Binetto, p. 217, r. 4377-4380: “iuratus et interrogatus super I articulo dixit per omnia ut proximos, excepto quod ipse testis non plantavit ibi fabas, set vidit proximum testem contenere in area fabas suas in eodem loco et postmodum contrita set recollectas portare ad domos suos apud Bitecto”.
44 V. Tirelli, L’universitas hominum Altamure, pp. 71-72.
criStina andenna164
dispose il popolamento e sulle dinamiche con cui fu realizzato l’insediamento. I testimoni più anziani, ormai ottuagenari, sono accomunati dal fatto di essere stati, insieme ai loro padri, revocati e costretti, per mandato dell’imperatore, a trasferirsi in quella ter-ra. Due di loro, magister Nicolaus Canii de Altamura e dompnus Ligorio de Altamura, ricordavano inoltre di essersi trasferiti in-sieme ai loro padri da un luogo detto Castellanum, sito nella terra di Bari45. Altri ancora dicevano di essere stati trasferiti dalle terre di Bitetto46, di Binetto47 e di Gravina48. I testimoni più anziani nar-rarono inoltre che agli inizi vi erano pauca focolaria, cioè esigui gruppi familiari, segno questo che si trattava effettivamente di un primo insediamento. Vivo nella memoria dei testi anziani era an-che il ricordo della presenza degli ufficiali regi, che operavano in quella terra e nelle terre vicine per mandato dell’imperatore, per organizzare l’insediamento di quelle famiglie trasferite, o meglio revocate, cioè costrette ad andare ad abitare sul luogo. Non sem-pre coloro che erano stati revocati avevano accolto con piacere il mandato imperiale, sire Mundea de Gravina narrava ad esempio di aver visto piangere parecchi di coloro che erano stati obbligati a trasferirsi49.
45 Le carte di Altamura (1232-1502), magister Nicolaus Canii de Altamura, p. 141, r. 1683-1692; dompnus Ligorio de Altamura, p. 147, r. 1887-1904.
46 Le carte di Altamura (1232-1502), Bartholomeus Riccardi de Clerico, p. 133, r. 1398-1403; Andreas Briscii de Altamura, p. 170, r. 2705-2714.
47 Le carte di Altamura (1232-1502), Meliciacca Nicolai Massafre de Binetto, p. 195, r. 3609-3618; Bartolomeus de Saraceno de Binetto, p. 196, r. 3647-3654; Stephanus Nicolai Manci de Aquaviva, p. 207, r. 4060-4065. Da Turitto era stato costretto a trasferirsi: Angelo de Barisano de Turitto, p. 211, r. 4166-4172, da Grumo: Sanctorus Aiechie de Grumo, p. 213, r. 4268-4279. Angelus dompni Nicolai de Binetto affermava di essersi trasferito con il padre spontaneamente per via delle immunità concesse dall’imperatore, p. 201, r. 3807-3812.
48 Le carte di Altamura (1232-1502), Nicholaus Melis de Gravina, p. 129, r. 1266-1270; Nicolaus Marcualdi de Altamura, p. 165, r. 2546-2551; Iudex Batholomeus Russus de Altamura, p. 173, r. 2820-2826.
49 Le carte di Altamura (1232-1502), Sire Mundea de Gravina, p. 111, r.
“De mandato Frederici Imperatoris” 165
Si può pertanto rintracciare nelle testimonianze una prima fase insediativa, caratterizzata da una popolazione, proveniente dalle terre vicine, e costretta dall’imperatore ad abitare i nova loca50. Un commissario imperiale risiedeva nella nuova fondazione e aveva il compito di ricevere e registrare coloro che si trasferiva-no, mentre altri commissari erano stati inviati nelle località circo-stanti, dalle quali reclutare nuova popolazione51.
I testimoni favorevoli alla tesi del vescovo di Gravina ricor-dano inoltre che Gravina e Altamura possedevano acque e terre comuni, indicazione questa che ci permette di arguire che il ter-ritorio dei due centri abitativi non era stato ancora a quel tempo chiaramente definito. In tal modo si potrebbe spiegare anche la presenza attiva di uomini di Gravina in Altamura e soprattutto i ripetuti interventi del presule di Gravina, Samuele, per l’esercizio degli atti di giurisdizione ordinaria e delle funzioni di competen-za in genere del vescovo diocesano. Sempre Samuele, secondo alcune deposizioni, avrebbe posto la prima lapide della chiesa di Santa Maria di Altamura, sulla quale avrebbe mantenuto i dirit-ti di giurisdizione ordinaria e di correzione dei chierici52; inoltre tamquam ordinario ipsius loci avrebbe nominato in Santa Maria
650. La strategia di popolamento per revocationes è tipica della fondazione di nuove città, si veda anche l’esempio di Manfredonia; P. F. Palumbo, La fondazione di Manfredonia, in «ASP» 6 (1953), pp. 371-407.
50 La prima fase potrebbe coincidere con la ripopolazione dell’antico sito saraceno al quale fu dato il nome di Altagusta o Augusta; a proposito alcuni testimoni Le carte di Altamura (1232-1502), Iohannes Paniscalidus de Binecto, p. 193, r. 3531-3539; Angelus de Syclo de Ioha, pp. 202-203, r. 3865-3876; Magister Tancredus Malignus de Gravina, pp. 118-119, r. 896-915; Angelo de Barisano de Turitto, p. 211, r. 4166-4172, Sanctorus Aiechie de Grumo, p. 213, r. 4268-4279.
51 Le carte di Altamura (1232-1502), Sanctorus Aiechie de Grumo, p. 213, r. 4268-4279: .
52 Le carte di Altamura (1232-1502), Sire Mundea de Gravina, pp. 111-112, r. 639-675; Dominus Vallarianus miles de Gravina, pp. 112-113, r. 695-735; Dompnus Iohannes Stambus de Gravina, p. 123, r. 1055-1074; Nicolaus Melis de Gravina, p. 129, r. 1266-1275.
criStina andenna166
un certo clericus Domenico, detto il Vecchio, attivo per parecchi anni nella chiesa di Altamura53 e divenuto poi in un secondo mo-mento vicario di Riccardo da Brindisi54.
Si tratterebbe allora di una prima fase insediativa di poco pre-cedente agli anni della prima scomunica di Federico II; durante questa fase il piccolo centro altamurano si presentava come una realtà insediativa piuttosto fluttuante, nella quale i nuovi abitanti avrebbero mantenuto dei legami forti con i centri di provenienza, soprattutto con Bitetto e con Gravina, quest’ultima da un punto di vista geografico e territoriale più vicina e maggiormente interes-sata a preservare i suoi antichi diritti non solo di natura agraria, ma anche, almeno in origine, di natura ecclesiastica. Ma se nei primi anni di regno Federico II non aveva avuto motivo di entrare in contrapposizione con il vescovo Samuele di Gravina, anzi nel 1222 aveva rinnovato alla sua Chiesa i privilegi concessi dai suoi genitori55. Dopo la prima scomunica il vescovo si era allontanato dalla fedeltà all’imperatore, collocandosi nelle schiere di coloro che erano rimasti fedeli al pontefice, come testimonia anche una lettera inviatagli nel 1233 da Gregorio IX. Con quello scritto il pontefice assegnava a Samuele la facoltà di sciogliere i canonici del suo capitolo cattedrale dal giuramento di non ricevere tra le loro file altri esponenti delle famiglie aristocratiche56.
53 Le carte di Altamura (1232-1502), Sire Mundea de Gravina, pp. 111-112, r. 669-674: “vidit tamen dictum dompnum Dominicum tenere et possidere dictum archipresbiteratum Altamure, et dicebatur publice quod tenebat et possidebat pacifice et quiete, ex collactione sibi facta a dicto episcopo Samuele tamquam ordinarius ipsius locis”; Iudex Urso de Gravina, p. 115, r. 787-790; Magister Tancredus Malignus de Gravina, pp. 118-119, r. 926-945.
54 Le carte di Altamura (1232-1502), Dompnus Ligorius de Altamura, pp. 147-148, r.1905-1922 e r. 1927-1935.
55 Samuel (17 Luglio 1219-Febbraio 1238); N. Kamp, Kirche und Monarchie imstaufischenKönigsreichSizilien, Bd. 2: Apulien und Kalabrien, München 1975 [Münstersche Mittelalter-Schriften 10/I,2], pp. 788-790; W. Hagemann, Kaiserurkunden aus Gravina, in «QFIAB» 40 (1960), pp. 188-200, qui p. 198.
56 N. Kamp, Kirche und Monarchie, p. 789; Documenti tratti dai registri
“De mandato Frederici Imperatoris” 167
In questo contesto di rottura tra il sovrano e la Chiesa episco-pale di Gravina e a causa di un consistente ampliamento demo-grafico dell’originario insediamento, potrebbe essere collocata la costruzione di una seconda chiesa, fatta edificare con il permesso e il sostegno economico dello stesso imperatore. Gli abitanti della terra, ricorda Nicolaus magistri Canii, “si erano radunati (conve-nerunt in unum) e, dopo aver assunto una decisione, avevano in-viato presso l’imperatore un certo prete di nome Domenico … per ottenere che gli homines potessero costruire una nuova chiesa”, in modo tale da poter vivere tamquam cristiani e ricevere i sacra-menti57. Concesso il permesso i nunzi imperiali si erano poi reca-ti dal vescovo Samuele, cui spettava secondo la consuetudine la giurisdizione ecclesiastica su quella terra, pregandolo di porre la prima pietra del nuovo edificio sacro. Il presule di Gravina aveva rifiutato, affermando in modo chiaro che non intendeva accettare l’invito, in quanto la chiesa non era di sua competenza ed inol-tre non voleva intromettersi in questioni che avevano a che fare con l’autorità imperiale58. L’imperatore, accolto il diniego, aveva domandato ai suoi ufficiali di informarsi da quale circoscrizione ecclesiastica dipendesse la terra di Altamura e, scoperto che si trovava in tenimento Bitecti, aveva imposto al vescovo di quella diocesi, Buonconsilio59, di recarsi ad Altamura e di consacrare
vaticani (da Innocenzo III a Nicola IV), a cura di D. Vendola, Trani 1940, pp. 164-165, doc. 185.
57 Le carte di Altamura (1232-1502), Nicolaus magisteri Canii de Altamura, pp. 141-142, r. 1683-1697; “Dompnus Ligorius de Altamura, p. 147, rr. 1905-1923: quod homines habitantes in dicta terra volentes habere ecclesiam, convenerunt in unum et de comunicato consilio miserunt ad dictum imperatorem quedam presbiterum nomine Dompnum Dominicum … ut impetrarem ab eodem quod dicti homines possent construere dictam ecclesiam”.
58 Le carte di Altamura (1232-1502), Nicolaus magisteri Canii de Altamura, p. 142, r. 1697-1702 e p. 147, r. 1877-1883: “quod nolebat venire, quia non pertinebat ad eum, nec volebat se intromictere de factis tangentibus imperialem maiestatem”; Bartholomeus Russus de Altamura, p. 176, r. 2938-2943; Bartholomeus de Saraceno de Binetto, pp. 196-197, r. 3647-3674.
59 Bonconsilius (Settembre 1232-4 Maggio 1241); N. Kamp, Kirche und
criStina andenna168
la prima pietra di quel nuovo edificio ecclesiastico, pietra che fu posta nella chiesa di San Nicola dei Greci, all’interno dell’antica cinta muraria60, forse quella parte più antica che era di spettanza, come aveva affermato anche Bartholomeus Riccardi de Clerico, del vescovo di Bitetto61.
Analizzando il rifiuto del vescovo Samuele comprendiamo al-lora meglio il significato del documento imperiale del 1232 diretto a Riccardo de Brundusio. Sottomettere la chiesa di Altamura solo a Roma e all’imperatore, significava sottrarla a qualsiasi legame giurisdizionale nei confronti delle circoscrizioni diocesane cir-costanti, ed in particolare escludere che proprio quel vescovo di Gravina, che aveva rifiutato la consacrazione, potesse rivendicare un qualsiasi diritto. Inoltre porre la chiesa arcipresbiterale sotto il patronato regio significava controllare direttamente la nomina dei chierici e garantire che nessuno dei vescovi, neppure il pontefice romano, potesse intromettersi nella scelta dei candidati e potesse rivendicare diritti sui beni e sulle cappelle da essa dipendenti.
La disposizione di Federico II non rimase senza conseguen-ze, sappiamo infatti che nel 1234 Samuele si era recato presso la curia imperiale per ottenere per la sua Chiesa la conferma di una donazione di un campo di olivi presso Bitonto, ma con Norbert Kamp riteniamo che tale motivazione fosse con buona probabilità solamente un pretesto62. Anche dopo la nomina da parte dell’im-
Monarchie, pp. 603-604.60 Le carte di Altamura (1232-1502), Nicolaus magisteri Canii de Altamura,
p. 142, r. 1702-1712.61 Le carte di Altamura (1232-1502), Bartholomeus Riccardi de Clerico,
p. 133, r. 1398-1408.62 N. Kamp, Kirche und Monarchie, p. 789, nota 26. Sulla politica die vescovi
dell’Italia meridionale nei confronti dell’imperatore si veda ora H. Hοuben, I vescovi e l’imperatore, in questo volume; N. Kamp, Der Episkopat und die MonarchieimstaufischenKönigreichSizilien, in «QFIAB» 64 (1984), pp. 84-115; Id., Monarchia ed episcopato nel Regno svevo di Sicilia, in Potere, società e popolo nell’età sveva. Atti delle seste giornate normanno-sveve Bari-Castel del Monte-Melfi, 17-20 ottobre 1983, Bari 1985, pp. 123-149 e Id., Potere monarchico e chiese locali, in Federico II e il mondo mediterraneo, a cura di
“De mandato Frederici Imperatoris” 169
peratore di Riccardo de Brundusio ad arciprete, i testimoni ocu-lari ricordavano che spesso il vescovo di Bitetto era stato visto celebrare la santa messa e amministrare i sacramenti nelle chiese altamurane. Essi tuttavia non ricordavano se il vescovo avesse agito con il consenso di Riccardo da Brindisi, oppure in qualità di vescovo diocesano (tamquam diocesano)63.
Gli interessi in gioco erano molteplici e il nuovo centro abita-to non godeva delle migliori simpatie da parte dei vicini. Nicola magistri Canii raccontò che “poiché gli uomini dei luoghi cir-costanti, in particolare quelli di Gravina, depredavano quelli di Altamura”, a causa di antichi diritti di cui sostenevano di essere depositari sul territorio. Per protestare gli abitanti della terra nova si erano rivolti all’imperatore, il quale aveva inviato un ufficiale di Matera, di cui il teste non ricordava più il nome, con il compito di definire e delimitare “il territorio di Altamura, in modo tale che questo fosse diviso da quello di Gravina”. “Ne risultava pertanto, come affermò il testimone, che il vescovo di Bitetto e tutti coloro che rivendicavano dei diritti, non avrebbero più avuto alcun mo-tivo di avanzare pretese sui terreni posti su quel territorio, poiché esso apparteneva ora in modo definitivo ad Altamura”64.
In questa confusa situazione, dettata parzialmente anche dal-la sorte dell’imperatore, si spiegano molto bene i due mandata datati 27 dicembre 1242 e 11 gennaio 1243, con i quali l’impera-tore incaricava alcuni funzionari regi di proseguire la politica di ripopolamento della terra, che da antica data era detta Altamura con i suoi nuovi abitanti (ut terra que dicta est antiquitus Alta-mura, novis incolis incolatur videlicet revocatis tantum deputa-tis et scriptis), affinché eiusdem terre comoditas dudum omissa veteribus et presentibus et posteris reparetur. Il diploma faceva appello alla fedeltà dei suoi funzionari, Filippo di Matera, scri-
P. Toubert e A. Paravicini Bagliani, Palermo 1994, pp. 84-106.63 Le carte di Altamura (1232-1502), Iohannes Paniscalidus de Binecto,
p. 194, r. 3580-3589.64 Le carte di Altamura (1232-1502), Nicolaus magisteri Canii de Altamura,
p. 144, r. 1774-1783.
criStina andenna170
niario imperiale, e Benedetto, comestabulo di San Quirico, che avrebbero dovuto recarsi sul posto e valutare con molta diligenza la qualità e la quantità del territorio da assegnare ad Altamura. Essi avrebbero sottratto delle terre ai territori di Gravina, Matera, Binetto e Bitetto, affinché quel centro, da poco costituitosi, fosse delimitato nei suoi confini e non sorgessero più controversie di alcun genere. Gli ufficiali regi erano inoltre incaricati di fissare l’ammontare del censo che gli abitanti di Altamura avrebbero do-vuto corrispondere. Dopo aver eseguito gli ordini il 12 febbraio del 1243 lo scriniario imperiale Filippo di Matera e Benedetto Comestabulo di San Quirico sottoscrivevano due documenti uno da destinare agli archivi dell’imperatore e l’altro da consegnare alla universitas degli uomini di Altamura, a quella data già costi-tuitasi65. La delimitazione dei confini corrisponderebbe pertanto ad una successiva fase di ripopolamento, caratterizzata da nuove revocationes e da nuovi trasferimenti che aumentarono il numero degli abitanti a circa un centinaio di focolaria66.
Quando poi ormai, dopo la definitiva scomunica comminata da Innocenzo IV, era iniziata la parabola discendente della domi-nazione federiciana, l’arciprete Riccardo di Brindisi era passato dalla parte papale e il 9 agosto 1248 era riuscito a farsi confer-mare la carica arcipresbiterale assegnatagli da Fredericus olim Romanorum imperator, (…) cum omnibus iuribus et honoribus. Nell’Inscriptio del documento papale Riccardo era tuttavia consi-derato clericus de Altamura, Gravinensis diocesis, segno questo che la chiesa arcipresbiterale e i chierici in essa attivi dipende-vano giuridicamente pur sempre dalla circoscrizione diocesana di Gravina67. Ma le controversie relative da un lato alla rivendi-
65 Le carte di Altamura (1232-1502), pp. 4-7, doc. 2 e H. Niese, Normannische undstaufischeUrkunden, pp. 267-270.
66 Le carte di Altamura (1232-1502), Angelus dompni Nicolai de Binetto, p. 201, r. 3823-3826.
67 F. Nitti di Vito, Le pergamene di San Nicola di Bari (1195-1266) Bari 1906 (CDB 6), p. 136, doc. 87 e Le carte di Altamura (1232-1502), pp. 7-8, doc. 3.
“De mandato Frederici Imperatoris” 171
cazione dei diritti episcopali del vescovo di Gravina e dall’altro alle pretese di autonomia da parte della chiesa arcipresbiterale di Altamura erano tutt’altro che sopite. Ancora nel 1284 il neoeletto vescovo di Gravina Pietro68 intendendo visitare, secondo l’usan-za, il clero delle chiese soggette alla sua diocesi, si era recato ad Altamura, che a suo parere sorgeva su una terra sita in tenimento dicte terre Gravine quondam Fredericum Romanorum impera-torem iurisdictioni nostre fore subiecta. L’arciprete di Altamura si era tuttavia rifiutato di accogliere il vescovo affermando che sia lui, sia il suo clero non erano tenuti a rispondere di nulla, né ad obbedire, essendo stata la sua chiesa, fondata dall’imperatore, soggetta a nessun altro se non alla Chiesa romana, come dimostra-vano i documenti conservati in archivio relativi alla concessione imperiale dell’arcipretura a Riccardo di Brindisi, sia la conferma di Innocenzo IV. Il vescovo Pietro chiese allora che gli fossero esibite quelle chartae e le portò con sé a Gravina per esaminar-le con maggiore comodità. Accertatane la validità e vagliatone il contenuto riconobbe le prerogative del clero altamurano e per garantire che in futuro la chiesa di Altamura non fosse più turbata nel godimento delle sue immunità fece trascrivere quelle chartae inserendole in una lunga lettera testimoniale69.
Durante la seconda metà del secolo XIII i sovrani angioini continuarono a investire gli arcipreti di Altamura, scegliendoli fra candidati a loro fedeli, e a intervenire in difesa dei diritti della universitas dei cives contro le prepotenze dei baroni70. La memo-ria delle disposizioni federiciane si era pertanto mantenuta e con-tinuava ad essere il punto di riferimento fondamentale al quale i sovrani si appellavano nella difesa dei diritti del centro abitato di Altamura e della sua chiesa arcipresbiterale.
68 L’episcopato di Pietro inizia, secondo Norbert Kamp, nel 1283. Nel 1282 il legato papale Gerardo di Sabina aveva ricevuto da parte di Martino IV l’incarico di insediare un nuovo vescovo nella diocesi di Gravina. Pietro morì nel novembre del 1284; N. Kamp, Kirche und Monarchie, pp. 792-793.
69 Le carte di Altamura (1232-1502), pp. 31-33, doc. 34.70 Le carte di Altamura (1232-1502), p. 13, doc. 11.