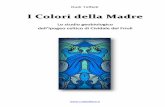Il credito in Friuli nel Trecento
Transcript of Il credito in Friuli nel Trecento
STVDI MEDIEVALI
S E R I E T E R Z A
X L I V
2 0 0 3
FONDAZIONE
CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL’ALTO MEDIOEVOSPOLETO
Il credito in Friuli nel Trecento
Fino alla fine del XIII secolo il Friuli restò quasi totalmente le-gato alla produzione agricola, vendendo le modeste eccedenze inVeneto, in Istria e nelle regioni d’Oltralpe. Durante il Trecento ilFriuli smise di produrre dei prodotti agricoli commerciabili perl’aggravarsi della già difficile situazione dell’agricoltura e per il di-vieto di esportare grano che il Parlamento Friulano aveva impostoper limitare le endemiche crisi frumentarie gravanti sulle terre friu-lane. Le continue guerre tra il patriarca, le comunità cittadine, lanobiltà, i conti di Gorizia e le forze esterne come il comune di Tre-viso avevano generato una situazione di instabilità accentuata dalfatto che il potere patriarcale non era più in grado di assicurare lasicurezza del transito lungo le vie che percorrevano il paese, con laconseguente proliferazione dei rapinatori di strada che godevanodell’esplicita e tacita copertura dei signori locali (1).
Tuttavia i dati che emergono dalla documentazione esistentemostrano gli effetti, in maniera lunga e generalizzata, di uno svi-luppo economico generato dalla crescita delle comunità cittadi-ne. Un decollo che non interessò solamente i centri di antica tra-
(1) Più volte il Parlamento friulano fu chiamato a esercitare un’adeguata opera di pre-venzione dei furti e di punizione nei confronti dei colpevoli. Le leggi deliberate in queste se-dute sono raccolte in P. S. LEICHT, Parlamento friulano, I, Bologna, 1917-1925 (Atti delle As-semblee Costituzionali italiane dal Medio Evo al 1831, s. I: Stati generali e provinciali, sezio-ne VI). Alcuni esempi di queste leggi si trovano nei docc. CIV, p. 114, CLII, p. 150, CLXXIX,p. 175. La situazione di perdurante instabilità è evidentemente riscontrabile nei frequenti sal-vacondotti chiesti e concessi ai mercanti e ai viaggiatori sia dal Parlamento che dagli amba-sciatori veneziani. Su questo problema si vedano le disposizioni registrate in A. S. MINOTTO,Documenta ad Forumjulii Patriarchatum Aquileiensem, Tergestum, Istriam, Goritiam spectan-tia inde a recessiore tempore usque ad medium seculum XV regesta, Venezia, 1860.
MIRIAM DAVIDE640
dizione urbana, come Cividale e Aquileia, ma anche una serie dicittadine che divennero degli importanti centri di consumo conflussi costanti in entrata di materia prima, di derrate e generi ali-mentari. Questi centri costituirono dei poli d’attrazione per lacomplessità di beni e di servizi che erano in grado di offrire, nonsolo ai propri abitanti ma anche a coloro che risiedevano nelcontado (2). Sul piano economico la crescita di questi nuclei ur-bani portò alla creazione di un mercato locale con discrete possi-bilità economiche e dai bisogni in crescita. Questa situazione sicoglie nello sviluppo delle attività artigianali sempre più differen-ziate tra loro e con un aumento degli addetti. La clientela, ini-zialmente composta da nobili, si allargò a notai, famiglie di feu-datari di abitanza, medi proprietari residenti nel contado e unnumero cospicuo di mercanti e artigiani (3).
Dalla documentazione esistente si può rilevare come in Friulistentasse a formarsi una solida e duratura organizzazione degliscambi sostenuta da un gruppo di figure professionali di mercan-ti. Spesso coloro che si occupavano di questa professione lo face-vano per brevi periodi impegnandosi in altre attività. Si creavanodelle compagnie bilaterali in cui un socio metteva a disposizioneil capitale mentre l’altro si occupava di condurre le operazioninecessarie all’affare. Queste società venivano costituite solamenteper singole operazioni commerciali ed erano sciolte dopo un bre-ve lasso di tempo. La specificità di queste società giustificava lascelta compiuta frequentemente dagli artigiani di associarsi ainobili locali, tra i quali spicca il nome di Federico Savorgnan, e apersonaggi emergenti delle élites cittadine per avviare delle soli-de attività commerciali. Queste società commerciavano preferi-bilmente in ferro, pellami, vino, animali con una preferenza per isuini e solo marginalmente, a quanto sembra, in cereali (4).
L’arretratezza del settore agricolo, incapace strutturalmentedi fornire con regolarità delle eccedenze commerciabili, contri-
(2) D. DEGRASSI, Il Friuli tra continuità e cambiamento: aspetti economico-sociali e istitu-zionali, in Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo. Tredicesimo Convegno di Studi(Pistoia, 10-13 maggio 1991), Pistoia, 1993, pp. 273-300.
(3) Per un inquadramento generale sull’economia friulana vedi D. DEGRASSI, L’economiadel tardo medioevo, in P. CAMMAROSANO, F. DE VITT, D. DEGRASSI, Il Medioevo, a cura di P. CAM-MAROSANO, Udine, 1988 (Storia della società friulana, dir. G. MICCOLI, 1), pp. 269-435.
(4) M. ZACCHIGNA, Lavoro sottoposto e commerci in una comunità friulana: Udine fra crisie sviluppo (secoli XIV-XV), Trieste, 2001, pp. 135-150.
IL CREDITO IN FRIULI NEL TRECENTO 641
buiva a mantenere assai basso il livello di vita della popolazionerurale divenuta dipendente dai pochi elementi economici in gra-do di accantonare delle scorte di cereali e per questo capaci dioffrire, oltre a delle scorte di derrate alimentari, anticipi di dena-ro e attrezzature agricole necessarie per la buona riuscita deiraccolti. I grandi e medi proprietari fondiari e i monasteri diven-nero quindi i punti di riferimento a cui chiedere sostegno nellefrequenti crisi frumentarie (5). Il prestito di consumo, divenutouna necessità a cui era soggetta tutta la popolazione contadina,nonostante fosse molto diffuso, non aveva creato un circuito cre-ditizio ben definito facente capo a figure professionali di presta-tori di denaro. Il denaro in gioco non era, ovviamente, mai moltodato che i tempi di restituzione erano scanditi dal calendario del-le attività agricole con piccole possibilità di guadagno.
Il ritardo con cui si costituirono dei ceti urbani interessati aicommerci e al campo creditizio e la predisposizione della nobiltàall’utilizzo della maggior parte delle risorse economiche per leguerre non garantirono una struttura del credito capace di fornireun valido supporto allo sviluppo economico. Diversamente daquanto accadeva in altre zone d’Italia, non si misero in operametodi di gestione della finanza pubblica e di reperimento dellastessa diversi da quelli tradizionali, basati sostanzialmente sullapercezione dei redditi patrimoniali, sull’imposizione straordina-ria di imposte dirette e sull’appalto dei profitti daziari.
Questa particolare situazione lasciò ampio spazio all’interven-to di agenti economici esterni tra i quali i toscani e i lombardi.
Per cercare di ricostruire un quadro complessivo della situa-zione creditizia friulana è necessario ricorrere sia a fonti pubbli-che sia a fonti private (6). Tra le prime vanno presi in esame iQuaderni dei Camerari della città di Udine, dove tra le entrate siindividuano quelle derivanti dalle imposte dirette, quelle ottenutecon depositi e prestiti e il denaro proveniente dalla vendita di be-ni di proprietà del comune (7). Particolarmente importanti erano
(5) DEGRASSI, L’economia del Tardo Medioevo cit.(6) Per un panorama complessivo sulle fonti scritte sul Friuli medioevale si possono
prendere le mosse dalla Nota sulla bibliografia e le fonti in CAMMAROSANO, DE VITT, DEGRASSI, IlMedioevo cit., pp. XXIII-XXXI.
(7) Ai lavori citati nel testo di cui alla nota precedente, p. XXX, vanno adesso aggiuntesoprattutto le edizioni di R. GIANESINI, Quaderni dei Camerari del comune di Udine. La camera-ria di Maffeo di Aquileia (1348-1349), Udine, 1991 (Quaderni della Biblioteca Comunale
MIRIAM DAVIDE642
le entrate provenienti dall’appalto dei dazi. La facoltà di imporredazi e di riscuotere le “colte” era stata elargita alla città di Udinedal patriarca Bertoldo di Andechs-Merania l’11 marzo del1248 (8). I dazi colpivano i beni di più largo consumo: farina, ce-reali, olio e sostanze grasse, pane, carne, pesce, misure, tessuti. Ildazio del pane riguardava la fabbricazione di pane di frumento ela vendita al minuto di grano saraceno e di sorgo. Il pane, inol-tre, era venduto, essendo un bene di prima necessità, ad un prez-zo e ad un peso che veniva di volta in volta stabilito dai magi-strati. Le prime notizie che ci sono giunte del calmiere di Udine,chiamato allora assagio o sazo, risalgono al XIV secolo. Annual-mente erano acquistati dal comune dei carichi di frumento per lapanificazione. Si ha notizia che il 29 ottobre del 1347 il consigliodi Udine elesse due cittadini per ogni forno del territorio incari-candoli di pesare il pane prima che fosse venduto. Il dazio eraaffidato dal comune tramite appalto ad un esattore chiamato da-ziario del pane per un anno. Veniva precisata la quantità e la de-stinazione del grano portato ai molini, controllata tutte le notti,sino alla totale preparazione del pane che, una volta sfornato,era bollato dal daziario sotto vincolo di giuramento (9).
Il dazio del vino era applicato sulla vendita al minuto dellostesso ed era l’imposta che garantiva l’entrata maggiore in quasitutti i comuni. Il dazio dell’olio era imposto sulla vendita all’in-grosso e al minuto dell’olio.
Il dazio delle drapperie colpiva i tessuti di lana e di seta conaliquote variabili in relazione alla qualità. Esistevano dazi per ilpanno di lino, per il panno grigio, per il borcando, una qualitàparticolare di lana, per il pontrembulo, una sorta di drappo pro-veniente da Pontremoli, per il villeno, una tela di cotone non spi-nato proveniente dalla Francia, per il buchiramo, una tela sottilelavorata inizialmente in Asia e a Cipro, per quello dei cavezzi,
“V.Joppi”. Fonti e documenti, I); Quaderni dei Camerari del comune di Udine. La cameraria diOldorico notaio, Francesco e magistro Marino (1297-1301), Udine, 1996 (Quaderni della Bi-blioteca Comunale di Udine cit., II).
(8) Statuta e ordinamenti del comune di Udine pubblicati dal municipio per cura dellaCommissione preposta al Civico Museo e biblioteca, Udine, 1898, Appendice, Decreto III, pp.140-141.
(9) N. MANTICA, Degli ordinamenti del comune di Udine sul pane dal 1300 in poi e dei prez-zi del frumento e del pane; nota estratta dalla Relazione Mantica sopra i forni rurali, il pane ela pellagra in Friuli, Udine, 1888. Per i dazi in genere rinvio a DEGRASSI, L’economia del tardomedioevo cit., p. 432.
IL CREDITO IN FRIULI NEL TRECENTO 643
costituito da scampoli di panno o di tela, per la lana e per i pan-ni oltremontani (10). I primi dazi sulle drapperie risalivano al1324. Dopo l’emanazione dello statuto sui cimatori nel novembredel 1353 fu elaborato uno statuto sul dazio delle drapperie. Suc-cessivamente, nel 1363, fu emanato su questo dazio un nuovostatuto che contemplava i prezzi delle vendite e del materialelavorato (11).
Il dazio delle quarte si pagava sui grani venduti all’ingrosso etalvolta fu appaltato insieme a quello delle misure applicato sulletele e su tutte le mercanzie importate dai mercanti provenientidalla Germania e dalla Carniola. Il dazio delle beccarie era paga-to dagli appaltatori di beccarie per le bestie macellate. Il daziodella carne garantiva sovente ai comuni delle cospicue entrate fi-scali come testimonia la decisione presa a Spilimbergo nel 1382che decretava l’aumento del gettito ottenuto con il dazio dellebeccarie e con quello sul vino per poter costruire le ultime muradifensive (12).
Il dazio del sale infine era molto importante perché diventavanelle mani dei governanti un vero e proprio strumento di imposi-zione. Tutti i sudditi, infatti, di qualsiasi età e classe sociale, era-no obbligati ad acquistare determinati quantitativi di sale ad unprezzo molto superiore al suo costo sul mercato libero. La cittàdi Udine si rivolgeva a Venezia per l’approvvigionamento del sa-le, un’importazione che era regolata da clausole particolari che,pur salvaguardando gli interessi veneziani, concedevano un rap-porto sufficientemente favorevole al patriarca (13).
Durante il XIV secolo nella vicina Gemona fu imposto un da-zio per il pepe, un genere alimentare non strettamente indispen-
(10) Per i pontremoli elencati insieme ai buchirami si veda il lemma in P. SELLA, Glossariolatino italiano. Stato della Chiesa-Veneto-Abruzzi, Città Del Vaticano, 1944, ed. anast. 1965(Studi e Testi, 109), p. 88. I due tipi di tessuto, uniti ai barcandi e ai villessii, ibid., p. 58. Peril cavezzo ivi, p. 141 e F. EDLER, Glossary of Mediaeval Terms of Business. Italian Series 1200-1600, Cambridge, Mass., 1934, p. 71. Copiose referenze a questi termini nell’eccellente M. F.MAZZAOUI, The Italian Cotton Industry in the Later Middle Ages, Cambridge, 1981.
(11) Per quanto riguarda i dazi imposti sui prodotti tessili si veda A. DI PRAMPERO, Il daziodei panni e l’arte della lana in Udine dal 1324 al 1368 (per nozze Rossi-Kechler), Udine, 1881,p. 13. Più in generale sulla lavorazione e sullo smercio dei panni cfr. DEGRASSI, L’economia deltardo medioevo cit., pp. 410-417.
(12) S. BORTOLAMI, Spilimbergo Medioevale. Dal libro di imbreviature del notaio Supertino diTommaso (1341-1346), Spilimbergo, 1997, p. 47.
(13) A. S. MINOTTO, Documenta ad Forumjulii Patriarchatum Aquileiensem, Tergestum,Istriam, Goritiam spectantia inde a recessiore tempore usque ad medium seculum XV regestacit.
MIRIAM DAVIDE644
sabile che suggerisce un ampliamento dei consumi in tutta l’areafriulana riscontrabile nell’incremento degli acquisti e delle vendi-te di questa spezia testimoniati in parecchi atti notarili gemonesie di Venzone (14).
I proventi di queste imposte erano destinati al pagamento deisalari dei dipendenti comunali, alle spese per l’amministrazionepubblica e alla costruzione e manutenzione di opere di interessecollettivo, e soprattutto alle spese straordinarie legate alla guerra.Ovviamente non è possibile conoscere le somme effettive riscossedalle persone che acquistavano dal comune il diritto di riscuote-re le entrate determinate dai dazi per un anno. Sono invece notele somme versate da queste persone e che costituivano l’effettivointroito del comune. La procedura utilizzata dal comune per ap-paltare i dazi constava di diverse fasi. Inizialmente veniva offertoagli interessati il diritto di riscuotere, per il comune, uno o piùdazi per un periodo prestabilito, nella maggior parte dei casi unanno, in cambio di una somma inferiore necessariamente all’in-troito che si prevedeva realizzabile attraverso la riscossione deidazi stessi. Generalmente le persone che acquistavano il dirittodi riscuotere i dazi si dichiaravano disponibili a versare il denarodovuto in tre rate. Se successivamente erano trovati altri acqui-renti, disposti a versare al comune una somma di poco inferiorea quella pattuita, ma in un’unica soluzione, questi ultimi suben-travano ai precedenti, ferma restando la facoltà di opzione deiprimi. In questo caso i nuovi acquirenti godevano di un ulterioremargine di guadagno.
L’elevata entità delle somme richieste per l’acquisizione deidazi rivela le caratteristiche degli acquirenti, uomini dalle note-voli possibilità economiche, provenienti dalle classi mercantili,anche forestiere, da quelle artigianali e dalle casate nobiliari cheusufruirono largamente delle possibilità a loro offerte realizzan-do probabilmente guadagni cospicui.
Analizzando i dazi appaltati nel 1346 a Udine risulta evidente laforte presenza della componente toscana ormai inserita nel tessutosociale udinese (15). A quest’epoca l’immigrazione toscana in Friuliera un fenomeno già decisamente avviato da un secolo. Risalgono
(14) DEGRASSI, L’economia del tardo medioevo cit., pp. 339-340.(15) Biblioteca Civica di Udine, Fondo Joppi, Camerari, III.
IL CREDITO IN FRIULI NEL TRECENTO 645
infatti alla metà del Duecento notizie di toscani stabilitisi a Gemo-na, a Cividale e nei territori circostanti, e impegnati sia in attività dimercatura e di prestito che nella produzione artigianale (16). L’im-migrazione era divenuta sempre più consistente nella prima metàdel Trecento. Secondo il Battistella, al quale si deve ancora ricorre-re per un profilo generale della questione (17), il fenomeno fu dovu-to alle continue lotte intestine che insanguinavano le città divise traguelfi e ghibellini, tra bianchi e neri, e al tipico carattere toscanoaperto ad avventure commerciali e bancarie in terre che prive diuno sviluppo economico definito offrivano ai toscani la possibilitàdi diventare, in un periodo breve, gli unici gruppi economici capacidi ottenere grossi profitti. Il Friuli, pur essendo una zona di transitoper i mercanti che si recavano nelle terre tedesche, era ancora in ri-tardo in campo creditizio. I toscani non trovarono quindi difficoltànell’aprire i loro banchi di cambio e di prestito e le filiali delle gran-di società commerciali come quelle dei Bardi, nel prendere in affit-to le rendite delle gastaldie e podesterie patriarcali, nell’acquistarein appalto i dazi, le imprese delle gabelle, dei pedaggi e delle mute.Molte inoltre furono le attività artigianali create da toscani soprat-tutto nel settore della lana (18).
Nel comune di Udine fin dal 1299 è menzionata una societasTuscorum con regole e armi proprie obbligata, in tempo di guer-ra, a concorrere alla difesa del Comune. Questi vincoli scompar-vero con il passare del tempo e con l’aggregazione alla cittadi-nanza o alla vicinanza, condizione a cui aspiravano i toscani. Ilpatriarca Pietro Gera, già nell’anno 1300, lodava la comunità diUdine per aver ascritto nella sua cittadinanza numerose famiglietoscane, residenti da più di dieci anni nel comune (19). Molti to-scani, una volta entrati nell’entourage patriarchino, riuscirono adavere incarichi importanti nell’amministrazione del principe e inquella comunale (20).
(16) L. DE BIASIO, I Toscani a Gemona, in I Toscani in Friuli, a. c. di A. MALCANGI. Atti delConvegno (Udine 26 - 27 gennaio 1990), Firenze, 1992, pp. 143-155.
(17) A. BATTISTELLA, I Toscani in Friuli. E un episodio della guerra degli Otto Santi. Memoriastorica documentata, Bologna, 1898; della scarsa letteratura successiva basti ricordare I To-scani in Friuli, a. c. di A. MALCANGI cit.
(18) B. POLESE, Organizzazione economica e attività di prestito, in I Toscani in Friuli, a. c.di A. MALCANGI cit., pp. 11-60.
(19) P. ANTONINI, Il Friuli orientale, Milano, 1864, p. 141.(20) L. CARGNELUTTI, I toscani nell’Archivum Civitatis Utini: le aggregazioni alla cittadinan-
za, in I Toscani in Friuli, a c. di A. MALCANGI cit., pp. 83-99.
MIRIAM DAVIDE646
In molte carte relative all’appalto dei dazi figurano come ac-quirenti o come fideiussori persone di origine toscana. Moltospesso le persone che compravano gli appalti dei dazi erano noticome prestatori di denaro al Comune. Ad esempio il fideiussoretoscano Argumento figlio di Matteo di Firenze, appartenente allafamiglia dei Bardi, figurava in diverse occasioni come acquirenteo si prestava nella figura di fideiussore in contratti di appalto didazi e frequentemente prestava, poi, il proprio denaro in mutuoal comune di Udine. Dall’analisi degli atti si comprende come Ar-gumento si associasse spesso con altri toscani e in alcune occa-sioni con i membri della nascente borghesia locale costituita da-gli artigiani, dai maestri, dai proprietari di bottega, dai notai edagli avvocati (21). La famiglia dei Bardi era presente in Friuli sindai primi del Trecento dopo aver stretto alcuni legami con i pa-triarchi duecenteschi, oltre che ad Udine, dove la famiglia otten-ne la cittadinanza, a Cividale, a Gemona e in altre sedi ancora.Operava in terra friulana una filiale della compagnia dei Bardi diFirenze intestata a Rodolfo Bardi il cui funzionamento era ga-rantito da personale stipendiato. Oltre ai membri della compa-gnia propriamente detta avevano scelto di risiedere in Friuli altriesponenti che autonomamente avevano ruoli politici all’interno
(21) Ad esempio Argumento è fideiussore nel seguente contratto: « Provisio dacii salisvendita et delivrata fuit Venuto, quondam Martini Longi, solvendo in tribus terminis consue-tis de festo Sancti Michaelis ad unum annum proximum completum; cum precibus fideiusso-res extiterunt Argumentus tuscanus etc. » (Biblioteca Civica di Udine, Fondo Joppi, Camera-ri, III, c. 5 ). Lo stesso Argomento nel registro del 1349 figura come acquirente del dazio del-le beccarie a nome suo e del socio Sinibaldo dei Bardi: « Item die vigesimosecundo mensisiunii recepit dictus camerarius ab Argumento quondam Matthei de Florentia (...) Castroni deBardis pro vendita excosse daci becariorum sibi suo nomine et nomine et vice Johannisquondam Synibaldi de Bardis de Florencia vendita et delivrata per marchas denariorumaquilegensium centum septuaginta et sunt marchae centumoctuaginta, quas solvere teneturdictus Henricus de Carnea pro dicto dacio becariorum sibi vendito sub cameraria Manfei deAquilegia: marchas denariorum aquilegensium CLXX » (Biblioteca Civica di Udine, FondoJoppi, Camerari, V, c. 4). Argumento prestava spesso denaro al comune nel modo seguente:« Item die eodem recepit dictus camerarius a Argumento tusco, familiar(i) domini Castronide Bardis de Florencia ad mutuum, dante et mutuante vice et nomine Johannis de Bardis deFlorencia et (...) et Pallo fratre filiorum dicti Castroni ad mutuum ab usuris in racione XXpro centenario de mandato duorum capitaneorum procuratorum et consilii vice et nominedicti communis (...); precibus camerarii, procuratoris et Consilii, dominus Federicus de Sa-vorgnano, Hermannus de Carnea et Leonardus Archolonianus se obligaverunt penes dictumArgumentum recipientem nomine quo supra (...) debitores hinc ad unum annum; quem ca-merarius et procuratores cum obbligacione bonorum dicti communis et de mandato Consiliipredicti promiserunt indempnem conservare dicto debito et conservatores continentur perinstrumentum scriptum manu Francisci Zili scribe comunis » (Biblioteca Civica di Udine,Fondo Joppi, Camerari, III, c. 4).
IL CREDITO IN FRIULI NEL TRECENTO 647
dell’organizzazione patriarchina e altri interessi in campo econo-mico (22).
L’acquisto dell’appalto dei dazi, oltre ad interessare la compo-nente artigianale della città, era spesso praticato dalle famiglienobiliari. Tra queste spiccavano i membri della famiglia Savor-gnan che, appoggiati dal Patriarcato, divennero abili uomini d’af-fari e prestatori di denaro accanto alle famiglie toscane o comesoci. Federico Savorgnan e Nicola degli Arcoloniani furono tra inobili più interessati all’acquisto dell’appalto di dazi. Tra gli ac-quirenti di dazi figurano anche alcuni rappresentanti delle comu-nità ebraiche di origine askenazita che si stavano allora costi-tuendo nell’Italia nord-orientale. I prestatori ebrei furono chia-mati dai comuni friulani per praticare il prestito ad interesse at-traverso la stipulazione di condotte nelle quali erano definite conprecisione le modalità caratterizzanti l’attività economica e unaserie di diritti che andavano dalla possibilità di praticare la reli-gione ebraica al diritto di residenza temporanea. La presenzaebraica era strettamente legata alla necessità che avevano le co-munità cittadine in crescita di ottenere denaro liquido di cui eracostante la mancanza. I prestatori ebrei per lungo tempo furonointeressati a praticare prestiti di piccola entità richiesti dalle per-sone per le necessità di tutti i giorni piuttosto che a prestare illoro denaro alle istituzioni pubbliche, campo in cui erano favori-ti i prestatori toscani. Tuttavia tra i prestatori al comune di Udi-ne e gli acquirenti di dazi figurano alcuni ebrei residenti in cit-tà (23). La presenza ebraica in città durante il Trecento è testimo-
(22) D. DEGRASSI, I rapporti tra compagnie bancarie toscane e patriarchi d’Aquileia (metàXIII secolo - metà XIV secolo), in I Toscani in Friuli, a. c. MALCANGI cit., pp. 169-199; sui Bardiin particolare: pp. 190-195. Il principale testo di riferimento sui Bardi rimane A. SAPORI, Lacrisi delle compagnie mercantili dei Bardi e dei Peruzzi, Firenze, 1926 (Biblioteca storica tosca-na a c. della R. Deputazione toscana di Storia Patria, III).
(23) Uno dei prestatori ebrei che fu maggiormente operante nei confronti delle istituzionipubbliche fu Martino figlio di Federico. Fu acquirente del dazio del pane durante la camera-ria di Olderico (Biblioteca Civica di Udine, Fondo Joppi, Camerari, I, c. 5r; ibid., c. 32v) e diquello del vino (ibid., cc. 30v, 42v, 48v) nonché fideiussore nell’acquisto di un appalto: « Inprimis quidem dacium panis per Bartholomeum preconem. Deliberatum et datum Blancholi-no beccario in septuaginta sex marchas et XX denarios solvendis in tribus terminis infra-scriptis, videlicet terciam partem hinc ad festum Sancte Margarite proxim(um) venturum etsecundam partem terciam in festo Beati Martini et reliquam terciam in festo Beati Helleri.Cuius videlicet precibus dicti Blancolini et pro ipso domino Petro castaldione Utini et Danie-le Guerçio camerario Comunis Utini, recipientibus pro dicto comune, Nicholaus filius Ma-nutti et Martinus filius Federici iudei fideiussores extiterunt. Actum Utini in mercato novoante domum Marchuçii beccarii » (ibid., c. 34r).
MIRIAM DAVIDE648
niata, ancor prima della condotta del 6 giugno del 1387 attraver-so la quale il Consiglio Cittadino concedeva all’unanimità il per-messo di prestare denaro ad alcuni ebrei, nelle delibere cittadi-ne (24). Nel 1347 infatti fu concessa a Rizzardo qui fuit judeus l’e-sclusiva di tenere aperto un banco sotto la loggia comunale (25)per alcuni mesi fino a quando fu affiancato nell’attività da un al-tro ebreo tenuto a versare al camerario quaranta denari per po-ter professare l’attività di prestatore (26). Secondo quanto stabili-to attraverso la condotta gli ebrei si impegnarono a concedere alComune di Udine un prestito di 500 ducati d’oro al tasso del 10%per un biennio e a prestare denaro agli abitanti della cittadina adun tasso di interesse di 8 piccoli per marca alla settimana e di unpiccolo per venti soldi la settimana (dunque nell’ordine del 20%).
Sin dal 1382 il comune di Gemona aveva espresso la volontàdi trovare dei prestatori come dimostra una delibera del MaggiorConsiglio che stabiliva che fossero eletti due cittadini incaricatidi trovare dei feneratori, che potevano essere indifferentementeebrei o cristiani, per trovare una soluzione alla mancanza di de-naro liquido (27). Nel 1395 furono stipulati dei patti tra il Comu-ne e l’ebrea Mina che accettava a nome suo e dei propri figli, cherappresentava in quanto tutrice, di prestare denaro per due annicon un tasso di interesse di 10 piccoli per marca di denari e di 8piccoli per marca di soldi per i prestiti superiori a mezza marcadi denaro e ad un tasso di 2 piccoli per lira al mese per quantoriguarda le somme inferiori (28).
Negli stessi anni anche Venzone aveva stipulato dei patti condei prestatori ebrei tra cui Aron del fu Ysrael, Abramo di Civida-le e Daniele figlio di Geremia di Gorizia (29). Gli ebrei di Venzonesi occuparono sia di prestito al consumo sia di vendite a credito,come fece ad esempio l’ebreo Giacomo figlio di Geremia di Gori-zia vendendo una fornitura di pepe per 30 lire di piccoli veronesia Nicolò detto Caydes, impegnatosi a rendere la somma entro 8
(24) La condotta in Statuta e ordinamenti del comune di Udine cit., pp. 123-126. La con-dotta sarebbe stata rinnovata sin verso la fine del secolo: Biblioteca civica di Udine, FondoJoppi, Camerari, XV, cc. 13v, 44r.
(25) Biblioteca civica di Udine, Fondo Joppi, Annales Civitati Utini, I, c. 38v.(26) Ibid., I, c. 51r.(27) L. BILLIANI, Dei toscani e degli ebrei prestatori di denaro in Gemona. Note e documenti,
s. l., 1895, p. 8.(28) Ibid., pp. 15-24.(29) V. JOPPI, Di un banco di prestiti a pegno a Venzone, Udine, 1895.
IL CREDITO IN FRIULI NEL TRECENTO 649
settimane e trascorso il termine a pagare l’interesse secondo gliaccordi stipulati (30). In seguito alla resa di Venzone al Patriarca-to del 1336 gli ebrei furono temporaneamente banditi per ritor-nare nella cittadina alla metà del XV secolo durante la domina-zione veneziana (31).
Il comune di Udine si avvaleva inoltre, quale fonti di entrata,sia di prestiti o depositi di privati cittadini e talora di enti, comel’Ospedale di Santa Maria Maddalena, sia di prestiti ad usura. Ladistinzione esistente tra i due tipi di prestiti dipende dai diversitassi d’interesse richiesti al comune. Generalmente sui capitalidepositati in comune dai privati era corrisposto un interesse an-nuo calcolato in uno staio di grano per ciascuna marca di dena-ro prestata o in uno staio di grano per ogni settimana di deposi-to. I creditori ricevevano il corrispettivo in moneta corrente dellaquantità che a loro spettava. Secondo le norme vigenti era presocome riferimento il costo di uno staio di grano alla conclusionedel periodo per il quale era contratto il prestito. Questo sistemapuò essere definito ad indicizzazione automatica dal momentoche il prezzo del grano, sebbene calmierato ed amministrato, erasempre soggetto a forti fluttuazioni in relazione all’andamentodei raccolti, ai frequenti eventi bellici e soprattutto alle variazioniclimatiche e alle calamità naturali. In questa maniera il creditorepoteva godere di un reddito effettivo per quanto riguarda il pote-re d’acquisto del capitale impiegato. La redditività ottenuta conquesti prestiti garantiva un discreto guadagno.
Il comune aveva bisogno di continui flussi di denaro e spintodalle esigenze escogitò ulteriori metodi di incentivazione. Il me-todo più frequente per attirare un maggior numero di creditorifu quello di rilasciare al creditore uno strumento redatto dal no-taio in cui il comune si dichiarava debitore del doppio della som-ma effettivamente ricevuta. Il contratto era definito con la for-mula di carta de duplo. L’interesse dovuto al creditore veniva
(30) I. ZENAROLA PASTORE, Appunti di vita economico-sociale nella Venzone del Trecento, inBollettino dell’Associazione Amici di Venzone, II (1973), pp. 11-30.
(31) JOPPI, Di un banco di prestiti a pegno a Venzone cit. Oltre alla condotta del 1444 esi-stono altre testimonianze dell’attività feneratizia ebraica in loco in atti rogati a partire dal1440 dal notaio Antonio del fu Cristoforo di Portogruaro: Archivio di Stato di Treviso, b. 221,volume contenente gli atti tra il 1436 e il 1446, c. [14r.]; ibid., c. [14v.]; ibid., c. [15v.]; ibid.,c. [16rv.]; ibid., c. [17r.]; ibid., c. [18v.]; ibid., c. [19v]; ibid., c. [24r.]; ibid., c. [25r.]; ibid., c.[28v]; ibid., c. [29r].
MIRIAM DAVIDE650
computato sulla somma dichiarata nel contratto e non su quellache realmente era stata versata (32). Questa procedura fu seguitain quasi tutti i casi che riguardavano il prestito di somme parti-colarmente elevate o quando il comune si trovava nella necessitàdi prolungare per molto tempo il prestito per l’impossibilità di ri-pagarlo. In parecchi mutui fu stabilito un tasso di interesse anti-cipato in forma di percentuale, in genere tra il 15% e il 20%, sen-za riferimento al prezzo del grano né ad un’eventuale indicizza-zione. Quando le somme prestate al comune erano molto elevatei creditori si tutelavano attraverso la richiesta di un’ipoteca suibeni del comune o chiedendo la fideiussione da parte di personeche disponevano di ingenti ricchezze.
In alcuni casi un’analisi incrociata tra le spese e le entrate del co-mune permette di ottenere una maggiore chiarezza sull’estinzionedei debiti e sul pagamento corrispettivo degli interessi. La maggiorparte dei debiti contratti durante una cameraria era pagata nellastessa, ma non mancano casi di estinzioni molto differite nel tempo.
Tra i prestatori più frequenti negli atti compaiono i toscani,spesso agenti delle filiali delle grandi società commerciali aventila sede centrale in Toscana. Frequenti erano i prestatori toscaniresidenti a Gemona, cittadina in cui risiedevano settantasei fami-glie toscane (33).
Un altro importante gruppo di feneratores era costituito dailombardi. L’emigrazione lombarda in Friuli fu stimolata daiquattro patriarchi della famiglia Della Torre che portarono consé notai, commercianti, ecclesiastici, medici e persino lavoratori
(32) Per un esempio toscano di questa pratica di riferimento a un valore nominale doppiodel valore reale cfr. W. M. BOWSKY, The Finance of the Commune of Siena (1287-1355),Oxford, 1970, pp. 190-191.
(33) Chelo fu, tra i prestatori toscani residenti a Gemona, particolarmente attivo nei pre-stiti al comune di Udine. Nel 1333 prestò al comune una somma di 100 denari al tasso di in-teresse del 15%: « Item die vigesimo quinto augusti recepit idem camerarius a Chelo quon-dam Banchi de Florencia, comorante Glemone, dante pro se et Galeano et Francisco fratri-bus suis, quos mutuavit comuni, marchas centum denariorum, in racione quindecim procentenario per annum completum; et habet cartam de duplo scriptam per me Wecelum dePortogruaro notarium comunis Utini in hoc presenti die » (Biblioteca Civica di Udine, FondoJoppi, Camerari, II, c. 8). Lo stesso Chelo stipulò in seguito molti contratti alzando il tassod’interesse richiesto al 20%: « Item quas mutuavit Chelus quondam Banchi Bonb(e)n, resi-dens Glemona pro se et fratribus suis Galeacio et Francisco, in racione viginti pro centenarioper annum completum; cartam habet de duplo scriptam per Wecelum notarium de Porto-gruaro in millesimo CCC XXX III, die undecimo. Item utilitatem dictorum denariorum a dic-to die mutui hinc ad diem presentem. Solutum marchae centum » (Biblioteca Civica di Udi-ne, Fondo Joppi, Camerari, III, c. 64).
IL CREDITO IN FRIULI NEL TRECENTO 651
della terra. La maggior parte della colonia lombarda era costitui-ta da casate imparentate con la famiglia Della Torre. I lombardiriuscirono ad ottenere ambascerie, gastaldie, appalti e importantiincarichi in grado di garantire elevate entrate annue utilizzate inparte per riconquistare Milano, tolta ai Torriani dalla famigliaVisconti. I lombardi, diversamente dai toscani, non si mescolaro-no molto alla popolazione locale e solo dopo molto tempo inizia-rono ad imparentarsi con la nobiltà friulana (34). Molti lombardipraticavano l’usura, come documentano i tanti testamenti neiquali è frequente la formula “pro male ablatis”, prestando spessodenaro al comune e associandosi con i nobili locali, soprattuttocon la famiglia Savorgnan. Ne è testimonianza un prestito cospi-cuo fatto al comune da Gabriele di Cremona, città che fornì ungrosso contingente militare a Pagano Della Torre quando fuchiamato come patriarca ad Aquileia:
Item die ultimo mensis octubris recepit dictus camerarius, vice et nomi-ne dicti comunis, de mandato duorum capitaneorum procuratorum etConsilii, a domino Gabriele quondam Sini de Cremona, habitante Utino,ad mutuum et de utilitate ad beneplacitum comunis hinc ad unum an-num proximum; cum precibus dictorum camerarii et procuratorum, vi-ce et nomine dicti comunis, fideiussores in sol(idum) extiterunt domi-nus Federicus de Savorgnano, Hermannus de Carnea et Leonardus Ar-cholinianus in solido; habet cartam de duplo de marchas denariorum[...] manu Francisci Zili scribe comunis, ducatos trecentos (35).
Esponenti delle famiglie nobiliari friulane accettarono spessodi comparire come fideiussori in contratti di prestito, ma figura-vano anche come prestatori. La presenza più interessante tra iprestatori provenienti dalla borghesia locale è costituita dalledonne, figure pressoché assenti nell’acquisto degli appalti dei da-zi. Le prestatrici erano spesso vedove che potevano disporre dicapitali o sorelle o figlie di prestatori che stipulavano i mutui aloro nome ottenendo degli interessi sufficientemente elevati (36).
(34) A. BATTISTELLA, I lombardi in Friuli, Milano, 1911. Sui patriarchi torriani si deve ades-so ricorrere all’ampia sintesi di G. BRUNETTIN, L’evoluzione impossibile. Il principato ecclesia-stico di Aquileia tra retaggio feudale e tentazioni signorili (1251-1350), in Il Patriarcato di Aqui-leia. Uno stato nell’Europa Medievale, a c. di P. CAMMAROSANO, Udine, 1999, pp. 65-226, segna-tamente da p. 101; sulle presenze di lombardi al seguito dei Della Torre si vedano in partico-lare le pp. 102, 106-108.
(35) Biblioteca Civica di Udine, Fondo Joppi, Camerari, III, c. 6.(36) Tra gli atti in cui compaiono delle donne riporto il mutuo di Chiara che prevedeva
un tasso d’interesse di uno staio di frumento per marca per un anno: « Item die vigesimo oc-
MIRIAM DAVIDE652
Anche gli enti privati, soprattutto ospedali, partecipavano so-vente a questo tipo di attività creditizia. L’ospedale di Santa Ma-ria Maddalena, rappresentato dai suoi camerari, è uno dei piùcitati (37).
La comparazione tra i debiti estinti e quelli contratti dimostracome fosse difficile riuscire a pagare nei tempi previsti i debiti ingenerale e come molto spesso accadesse che un camerario fossecostretto a provvedere all’estinzione di debiti contratti da prece-denti camerari anche molti anni prima. La situazione debitoriadel comune di Udine doveva essere piuttosto grave se per tutto ilcorso del XIV secolo si accettarono dei mutua sub usuris contassi d’interesse molto elevati. Tuttavia questi testi non permetto-no di conoscere tutte le entrate del comune e quindi non forni-scono un quadro completo dell’intera situazione.
I dati che emergono dalla documentazione privata indicanoche nel XIV secolo si iniziarono a sentire gli effetti di un decolloeconomico che era stato stimolato dalla crescita di alcune comu-nità cittadine. Uno sviluppo che era iniziato durante il XIII seco-lo e aveva interessato non solamente Aquileia e Cividale, centridi antica tradizione urbana, ma anche una serie di cittadine chedivennero centri di produzione e scambio per ampie zone circo-stanti senza riuscire, tuttavia, ad estendere anche un potere di ti-po istituzionale (38). Sul piano economico la crescita di questicentri portò alla creazione di un mercato locale i cui bisogni era-no in aumento e all’espansione del settore creditizio legato a ne-cessità contingenti e immediate più che a finanziamenti di ope-razioni di tipo speculativo o commerciale. Un sistema creditiziocosì poco strutturato permetteva comunque di realizzare guada-gni modesti ma sufficientemente sicuri impiegando piccoli capi-tali in operazioni commerciali a raggio limitato.
tavo maii recepit dictus camerarius a domina Clarra quondam Walcherii de Utino, quas mu-tuavit comuni, marchas viginti quinque de puro capitali in racione unius starii frumenti promarca per annum completum, et habet cartam solummodo de dicto capitali scriptam perWecelum notarium comunis Utini in hoc presenti die » (Biblioteca Civica di Udine, FondoJoppi, Camerari, II, c. 70).
(37) « Item Nicolussio Pacifici camerario hospitalis Sancte Marie Magdalene pro utilitatemarcharum novem denariorum quas hospitale habet de quibus dicto hospitali fuit provisum,quam utilitatem non receperat a Mancotto pro utilitate camerarie Harmanni de Percoto, inracione denariorum XXIII pro quolibet stario » (Biblioteca Civica di Udine, Fondo Joppi, Ca-merari, VI, c. 17r).
(38) Su questi aspetti si veda DEGRASSI, L’economia del tardo medioevo cit., cap. IV: I centriurbani, pp. 355-388.
IL CREDITO IN FRIULI NEL TRECENTO 653
La pratica di richiedere prestiti semplici e di effettuare vendi-te a credito era estremamente diffusa nel Trecento friulano ecoinvolgeva tutte le classi sociali.
Nei vari contratti l’auctor prometteva il pagamento di una de-terminata somma, nel qual caso è sempre specificato il motivodel debito. La complessità e la varietà di schemi ed eccezionigiuridiche in cui poteva essere inserita un’azione non era proba-bilmente una scelta obbligata ma dipendeva dall’abilità e dallecapacità del notaio, dalla cultura e dalle conoscenze giuridiche. Iprestiti hanno sempre un termine di scadenza che va da pochesettimane ad un anno. Frequentemente il denaro doveva esserereso durante festività religiose, spesso quella di San Michele oquella di San Martino, entrambe legate al calendario agricolo.Quando non era precisato alcun luogo di pagamento pare che dinorma esso fosse eseguito a casa del debitore, nella residenza delcreditore o dove era stato stipulato il contratto. I debitori, secon-do la trentanovesima norma delle Constitutiones Patriae Foriiulii,potevano rispondere del loro debito in diversi luoghi e di fronte apiù giudici, sempre all’interno del territorio del patriarcato (39).
Se tra il momento in cui era stato stipulato l’atto e quello delsuo adempimento era mutata la moneta, qualora fosse stato mu-tato l’intrinseco era dovuto il numero di monete con cui si ugua-gliava l’intrinseco del momento in cui aveva avuto avvio l’obbli-gazione; se invece fosse stato toccato soltanto il valore legalequesto non influiva sulla quantità dovuta dal debitore.
I debitori che non restituivano la somma ottenuta in prestitonel tempo stabilito erano sottoposti al pagamento di una penaleche era nella maggior parte dei casi il duplum della cosa aliena-ta, il terzo del debito o una cifra precisa, in genere quaranta de-nari. Anticamente le obbligazioni si estinguevano alla morte deldebitore o com’era naturale quando il creditore rinunciava alproprio diritto. Era contemplata la possibilità di prescrizione.Dai trenta anni previsti dal diritto romano si arrivò nelle terredel patriarcato a quindici anni (40). Nel caso di prestiti legati ad
(39) Norma XXXIX delle Constitutiones Patriae Foriiulii, in P. S. LEICHT, Parlamento friula-no, I cit., p. 227.
(40) Il parlamento friulano decretò nel 1277 « quod quodcumque debitum quod non re-quireretur per XV annos, ex tunc peti non possit et debitor absolutus exsistat ». In P. S. LEI-CHT, Storia del diritto privato, 2a ed., III parte, Milano, 1946, p. 483.
MIRIAM DAVIDE654
usure la prescrizione era limitata ad un periodo quinquennale se-condo la norma 141 delle Constitutiones Patriae Foriiulii (41).
Le obbligazioni erano assicurate tramite un giuramento inDio, con la consuetudine di dare la mano o un bacio e in casi li-mite con il rendersi ostaggio del debitore che andava ad abitareinsieme ai suoi parenti in luogo scelto dal creditore fino a quan-do non aveva pagato la somma richiesta (42). Questa usanza fuvietata per decisione del patriarca Marquardo di Randeck nel1366, nel quadro della promulgazione delle Constitutiones PatriaeForiiulii (43).
Le obbligazioni si garantivano inoltre con la designazione diun pegno o con l’istituzione di una fideiussione, entrambe prati-che molto diffuse in Friuli.
Nelle Constitutiones Patriae Foriiulii la norma settantatreesi-ma stabiliva le circostanze nelle quali i fideiussori dovevano esse-re considerati debitori principali:
quod sibi preiudicare voluerit fideiussor altero de tribus modis, videlicetse obligando in solidum simul cum principale debitore vel rinunciandobeneficio iuris, dicentis debitorem principalem debere primitus conveni-ri quam fideiussorem, vel precibus et instantia debitoris constituendo sefideiussorem et principalem debitorem. In quibus casibus licitum sitcreditori convenire quem ex ipsis voluerit non obstante quod fideiussorsit cum principali in solidum obligatus, vel qui sic, ut premittitur, bene-ficio iuris renunciaverit, vel qui sic precibus et instantia debitoris seconstituerit fideiussorem et principalem debitorem velit assignare de bo-nis principalis debitoris expeditis ipsi creditori; sed omnino teneatur ipsicreditori integraliter satisfacere. Quod autem supradictum est in casuquo fideiussor se obligaverit cum principali in solidum, vel renunciaveritbeneficio iuris predicti, locum sibi vindicet etiam in casu in quo duo velplures se obligant simul et in solidum cum pacto ut creditor se tenerepossit ad quem voluerit.
In genere se il fideiussore risolveva il pagamento per il debi-tore otteneva di diritto le ragioni del creditore da lui soddisfatto
(41) Norma CXLI delle Constitutiones Patriae Foriiulii: « Quaelibet persona mutuans subusuris, factis publice vel privatis instrumentis, ipsis uti vallet usque ad quinquenniumtantum ».
(42) Carlo Fabrizi riporta un esempio di questa pratica relativa al 1312: « promiserunt da-re pignus infra octo dies post dictum terminum et venire personaliter Civitatem et stare inosteria et inde non recedere donec ei fuerit satisfactum, alioquin possit de bonis eorum acci-pere »: C. FABRIZI, Delle usure in Friuli nel XIV secolo e della marca ad usum curiae. Disserta-zioni dell’Accademia di Udine, Udine, 1774, p. 76.
(43) Constitutiones Patriae Foriiulii, CLX.
IL CREDITO IN FRIULI NEL TRECENTO 655
e per la norma sessantacinquesima delle Constitutiones acquista-va il diritto di procedere contro il « principalem debitorem proquo fuerint obligati et eius bona, etiam contra possessores bono-rum alienatorum vel obligatorum per ipsum debitorem post pre-fatam fideiussionem debiti de quo agitur et que privilegia et fa-vores habebat creditor ». Il mallevadore, saldato il debito del de-bitore principale, poteva comportarsi come se egli stesso fosse ilcreditore nei confronti del debitore principale avendo la possibi-lità, in alcuni casi, di ottenere un pegno legale sui beni dello stes-so debitore (44).
Dal momento che l’istituto della fideiussione fu retto nel Me-dioevo dalle norme del diritto romano e comune fu in genere ri-conosciuta la validità del beneficium divisionis, ovvero dei prov-vedimenti ordinati a favore dei fideiussori coobbligati con la ce-lebre Epistola Divi Adriani. Queste normative del diritto romanooffrivano ai fideiussori coobligati la possibilità di richiedere ladivisione dell’obbligazione secondo quanto prevedeva la settanta-seiesima norma delle Constitutiones.
La pratica della fideiussione rappresentava una garanzia mol-to usata per soddisfare i creditori nel Friuli trecentesco. Frequen-temente i mallevadori erano scelti all’interno dello schema paren-tale o erano direttamente consigliati dal notaio. Il notaio Nico-lussio figlio di Cignotto ad esempio aveva l’abitudine di suggerireai debitori come fideiussore il fratello Cristoforo, che di volta involta decideva di obbligare tutti i propri beni (45). Molto spesso sipresentavano come mallevadori alcuni rappresentanti della nobil-tà friulana chiamati a garantire prestiti di somme non necessa-riamente elevate. In molti contratti scelsero di divenire garanti imembri della famiglia Savorgnan, capaci di ottenere un ruoloeconomico e politico in crescita all’interno della realtà friulana.Odorlico Savorgnan, attivo anche come prestatore a Cividale do-ve risiedeva (46), fu designato ad esempio come fideiussore daBertollo figlio del fu Giovanni di Gagliano in un contratto di pre-stito rogato dal notaio Odorlico di due marche di denari aquileie-
(44) Ibid., CXIV.(45) Un esempio di questa pratica in Archivio di Stato di Udine, b. 5125, registro XII, cc.
8v-9r.(46) Archivio di Stato di Udine, b. 687, Odorlico, IV, cc. 5v-6r.
MIRIAM DAVIDE656
si ottenute dal cividalese Giustino (47). Un’altra famiglia nobiliareattiva nel mondo creditizio fu quella degli Strassoldo (48).
Un’altra pratica di garanzia molto usata fu l’istituto del pe-gno, ampiamente regolato nel corpo di leggi delle ConstitutionesPatriae Foriiulii. I giuristi ordinarono che la vendita dei beni mo-bili e immobili del debitore « non possit fieri nisi per cedulam, inqua creditor volens [facere vendi, teneatur] et debeat bona fidefacere scribi bona vendenda et fructus qui ex ipsis comuniter sol-vuntur et onera alia si qua incumbunt illis bonis cum manuten-tore contra quem venduntur ». Qualora il debitore dovesse rite-nersi insoddisfatto del modo in cui era condotta la vendita, pote-va intervenire (49).
I giuristi avevano stabilito i termini precisi nei quali potevanoessere venduti all’incanto i pegni. Ai debitori che intendevano ri-scattare le loro malleverie erano concesse tre occasioni, distantil’una dall’altra una settimana di tempo. Se il debito non era statopagato l’indomani del giorno in cui era stata prevista l’ultimascadenza, veniva notificata al debitore la cedola con il quale lo siavvertiva della prossima vendita dei beni pignorati che sarebbestata tenuta sette giorni dopo. La vendita « hoc modo facta ha-beat valoris firmitatem. Et haec habeant locum in bonis que nonsint obligata pro pignore mobili, in quibus bonis obligatis pro pi-gnore mobili servetur mos consuetum ab antiquo » (50). Se i beninon fossero stati acquistati da nessun compratore alla prima oc-casione, la seconda volta sarebbero stati venduti ad un prezzo in-feriore, che comunque non doveva danneggiare il creditore (51).Nel caso in cui il creditore non avesse venduto nel giorno previ-sto i beni pignorati al debitore, decidendo di venderli in un’altraoccasione a prezzo diverso, la cinquantasettesima norma delleConstitutiones stabiliva che egli dovesse pagare una multa di unamarca di denari alla quale si aggiungeva una detenzione di otto
(47) Ibid., c. 13r.(48) Sugli Strassoldo il lavoro più ampio è S. PETRUZZI, La famiglia Strassoldo sino al sec.
XIV. Introduzione storica e documenti, tesi di laurea, Univ. Di Trieste, a.a. 1972-1973 (rel. P.Cammarosano); sulla loro attività nel campo del credito: M. DAVIDE, Ricerche sui rapporti dicredito nel Friuli del Trecento, tesi di laurea, Univ. Di Trieste, a.a. 1999-2000 (rel. P. Camma-rosano); un cenno sulla famiglia anche in CAMMAROSANO, DE VITT, DEGRASSI, Il Medioevo cit.,pp. 124-125.
(49) Constitutiones Patriae Foriiulii, LIII.(50) Ibid., LIV.(51) Ibid., LVI.
IL CREDITO IN FRIULI NEL TRECENTO 657
giorni. Nel caso in cui i debitori, alla luce di una valida ragione,avessero ottenuto una proroga per la vendita all’incanto dei lorobeni, l’eventuale persona che avesse comprato nonostante la con-cessione di tale proroga era tenuta al versamento di una pena-le (52).
Furono stabilite delle leggi che vietavano di vendere il pegnoal di fuori dei confini della città o del distretto. I notai friulaniusavano sovente questa formula:
preterito ipso termino et debito non soluto pateretur vendere seu vendifacere possit pro pignore mobili ad incantum in Utino, in Civitate Au-stria, in Aquileia seu alibi ubi melius ei placuerit et fuerit usum superforis Aquiliensis ecclesie absque aliqua protestacione non obstantibusaliquibus guerris, feriis, statutis, constitucionibus, ordinamentis et inhi-bicionibus quibuscumque in contrarium loquentibus, quibus omnibusper pactum expressum ibidem illico renunciavit.
La vendita dei pegni era stata organizzata in maniera precisa.I giuristi avevano deciso che se qualcuno avesse designato ani-mali o beni immobili come pegno « ab eo petito pro executionealicuius sententie aut designaverit alicui de dictis bonis mobili-bus pro pignore conventionali, tunc teneatur dictus designansdicta animalia vel alia bona mobilia pro pignore mobili consi-gnata tradere in manibus preconis, vel eius cui promisit, taliterquod dictum pignus possit vendi rationabiliter illa die, qua dic-tum vel conventum fuerit de pignore vendendo vel die ad quamfuerit profertum ». Quando venivano venduti del vino o dei graniera sempre specificata la misura. Se il debitore non consegnavail pegno nel modo accordato pagava una penale di una marca« cuius medietas curie, alia parti applicetur ». Se invece il pegnoera stato consegnato e non era sufficiente « ad solutionem eiuspropter quod vendentur » il debitore era tenuto a designare unamalleveria integrativa (53).
Nel caso in cui fossero stati venduti dei beni immobili era le-cito a coloro che fossero contrari alla cessione avere un periododi dieci giorni per recuperarli pagando il compratore, qualoraavesse già saldato l’acquisto, per le spese sostenute (54).
(52) Ibid., LX.(53) Ibid., LXI.(54) Ibid., LXII.
MIRIAM DAVIDE658
La trentacinquesima norma aggiunta alle Constitutiones Pa-triae Foriiulii regolava la vendita all’asta dei beni mobili e immo-bili di persone che risiedevano al di fuori dei confini del Patriar-cato. In questo caso la vendita si teneva dopo una proclamazionein piazza, nel luogo dove era possibile svolgerla, secondo il dirit-to, trascorsi dieci giorni dal momento in cui era stato avvisato ildebitore che si dichiarava « esse extra patriam, qui non est velnon residet sub dominio et iurisdictione ecclesie Aquileiensis etdomini patriarche ».
Fu aggiunta un’ulteriore norma che specificava il comporta-mento che dovevano tenere gli acquirenti dei beni all’incantochiamati a rispondere per la risoluzione del prezzo. Il comprato-re dei beni era tenuto a pagare il denaro fissato entro dieci gior-ni nel caso di beni immobili ed entro cinque giorni se avesse ac-quistato beni mobili. Se l’acquirente non effettuava il pagamentodel pegno era costretto a pagare venticinque lire (55).
Ogni comune friulano, inoltre, regolava l’istituto del pegnocon leggi proprie, contenute negli statuti, in aggiunta a quelledelle Constitutiones. Negli statuti udinesi si stabiliva che qualsia-si “vicinus Utini” potesse impunemente pignorare i beni di pro-prietà di un forestiero per il suo pane, il vino, la carne e altrevettovaglie, pagando lo stesso giorno in cui le aveva prese (56). Ilcomune ordinava che qualunque residente nella città di Udine,acquirente di beni venduti all’incanto, fosse tenuto a dare il de-naro tre giorni dopo. Se il compratore non saldava l’acquisto ilCapitano della città lo invitava a pagare una penale di una marcada effettuarsi presso la “domum conscilii”. Nell’eventualità di unrifiuto il Capitano ordinava la detenzione in carcere, la requisi-zione del pegno comprato e la commutazione di una multa diquaranta denari, metà della quale andava al Comune e l’altra me-tà allo stesso Capitano (57).
La vendita all’asta dei pegni pignorati era stata regolamentatadal Capitano e dal Consiglio della città di Udine. La regolamenta-zione era valida per compratori udinesi e forestieri (« quod pi-
(55) Ibid., additio XXXVI.(56) Rubrica 83 degli Statuta e ordinamenti del Comune di Udine cit.(57) Rubrica 29 degli Statuta e ordinamenti del Comune di Udine cit. La legge era l’elabo-
razione di una disposizione del comune e del Capitano cittadino del 24 gennaio del 1390 (Bi-blioteca Civica di Udine, Annales civitatis Utini, IX).
IL CREDITO IN FRIULI NEL TRECENTO 659
gnus sit infra confines terre Utini vel extra confines terre Utini »)mantenendo norme diverse per i cittadini rispetto ai forestieri se-condo la trentaquattresima rubrica degli Statuti.
Un consiglio cittadino tenutosi il 15 giugno del 1391 condan-nò la pratica definita come “pestifera et damnosa” di alcune per-sone che obbiettavano alla vendita delle cose da loro impegnatecreando risse e discordie tra i cittadini accorsi per le vendite.L’allora Capitano, Nicolussio di Castellerio, il Consiglio e il co-mune udinese decisero di debellare questo cattivo costume stabi-lendo che la persona che fosse contraria alla vendita “prius pre-stet sacramentum” in modo che non “contradicat per maliciam”e presentasse un fideiussore in grado di pagare “quinquaginta li-bras Veronensium” o di obbligare tutti i suoi beni per la causa.Colui che obbiettava aveva tre giorni di tempo per appellarsi, in-cluso il giorno in cui gli era stata recapitata la cedola di avviso.Il compratore era tenuto a pagare solamente nel momento in cuifosse stata risolta la causa (58).
La scelta di garantire le promesse di pagamento avveniva fre-quentemente attraverso la costituzione di un pegno che in alcunicasi era definito come mobile e non era specificato. In molti casi,essendo la società friulana una società prevalentemente agricola,i debitori sceglievano di proporre come garanzia dei terreni (59).Questi pegni talora non erano definiti solamente come campi macon articolate descrizioni delle colture. Ad esempio Giovanni fi-glio del fu Candido presentò come pegno a garanzia di un presti-to di 4 marche di denaro fattogli da Pietro Barbironsci figlio diAgostino di Flagogna « unum suum campum, pastinatum vitibuset arboribus » di cui erano dati, come di norma, i confini (60). Inaltri casi il pegno scelto poteva essere una vigna (61) oppure uncampo su cui gravava il pagamento di un livello che doveva esse-re saldato una volta all’anno, in genere a Natale o otto giorni do-po (62). Altre volte una braida (terreno cintato e composto da più
(58) Ibid., legge 35.(59) Alcuni interessanti esempi di pegni costituiti da terreni agricoli si trovano nel notari-
le dell’Archivio di Stato di Udine: b. 5125, Nicolussio q. Cignotti, XII, cc. 9r-10r; ibid., III, c.6r.
(60) Archivio di Stato di Udine, b. 5125, Nicolussio q. Cignotti, cc. 9r-10r; b. 5127, Leo-nardo Theoldi q. Pietro, IX, cc. 29r-30r; b. 5134, Quarino q. Odorico Cerdone, VII, cc. 71r-72r; b. 681, X, c. 65r.
(61) Archivio di Stato di Udine, b. 687, Odorlico, X, c. 64r.(62) Archivio di Stato di Udine, b. 5122, Nicolussio q. Tomasino, I, cc. 13r-14r.
MIRIAM DAVIDE660
campi) poteva essere una guarentigia assai valida per un prestito,come si verificò nel caso di Lucia vedova di Pietro Mani che, do-po aver presentato come fideiussore la propria figlia Beatrice,vincolava una sua braida retta dal toscano Tobia, pagante un af-fitto di tre staia di frumento, tre staia di segale e tre galline (63).Come sui terreni così anche sugli animali cadeva la scelta dellapignorazione da parte dei debitori, i quali accettavano che i pro-pri animali fossero messi all’incanto nel caso in cui non fosserostati in grado di restituire il prestito ottenuto. Gli animali utiliz-zati come pegni potevano essere buoi, mucche o giovenche (64), ocavalli dei quali era specificato sovente il colore del pelo. Taloraquando i debitori sceglievano di proporre come pegno un equinolo fornivano del fieno con cui alimentarlo o della sella, comescelse di fare Anichinus Daus figlio del fu Lolardo Daus che co-me garanzia in cambio della somma di otto marche di denaro ot-tenuta in prestito da Guntardo, figlio del fu Renalduccio di Fi-renze, apothecarius in Udine, cedette « unum suum equum ba-yum brunum cum sella et feno » (65). Questo esempio dimostracome spesso si scegliesse una forma di pegno che implicava unapercezione di interesse non monetizzabile, offerta dall’uso dell’a-nimale dato in garanzia. Lo stesso meccanismo si realizzava conla concessione in pegno di livelli, pratica assai diffusa.
Un tipo di livello al quale si faceva spesso ricorso nella costi-tuzione pignoratizia erano le case concesse in affitto. L’oreficeJacopo di Montegnacco, ad esempio, ebbe come garanzia sulprestito un « livellum duorum statiorum frumenti sibi omniumdebendorum et solvendorum et super quandam domum mura-tam, soleratam cupisque copertam, sitam Utini in burgo superio-ri » (66). Le malleverie più frequenti furono, particolarmente neicasi in cui la somma prestata fosse elevata, canipe, sorta di ma-
(63) Archivio di Stato di Udine, b. 5134, Quarino q. Odorico Cerdone, VII, cc. 203r-204r.(64) Alcuni esempi si riscontrano negli atti contenuti nel Notarile dell’Archivio di Stato di
Udine: b. 5125, Nicolussio q. Cignotti, XII, c. 15r; b. 5131, Nicolò Manin, XIX, c. 38r; ibid.,cc. 36r-37v; ibid., XIX, cc. 36r-37v; b. 5134, Quarino q. Odorico Cerdone, X, c. 16r; ibid.,XXVI, c. 18r; ibid., XXVII, cc. 22r-23r.
(65) Archivio di Stato di Udine, b. 5122, Nicolussio q. Tomasino, I, c. 40r. Altri esempi incui i debitori propongono come malleverie dei cavalli si trovano sempre nel Notarile dell’Ar-chivio di Stato di Udine: b. 5131, Nicolò Manin, IX, c. 39v; ibid., XIX, cc. 36r-37v; b. 67,Maffeo, II, c. 47r.
(66) Archivio di Stato di Udine, b. 5127,Leonardo Theoldi q. Pietro, XIV, cc. 29v-31r. Unaltro esempio di livello come malleveria si trova nella busta 687 del notaio Odorlico, nel deci-mo registro, nelle carte 98r-99v.
IL CREDITO IN FRIULI NEL TRECENTO 661
gazzini che potevano essere murati (67), o case che potevano es-sere costruite « de parandana » o di muratura (68). Di norma inotai specificavano con accuratezza i materiali con cui erano co-struiti gli edifici in modo da fornire così una valutazione econo-mica, come ad esempio fece il notaio Nicolò figlio del fu Giovan-ni che rogò un atto in cui un altro notaio Nicola figlio di Nicolaaveva deciso di offrire come guarentigie al creditore due case didiverso valore economico, specificando i materiali con cui questeerano costruite e se i tetti erano o meno ricoperti da tegole, non-ché ricordando che sulle case gravava un livello di sedici denariche doveva essere pagato al signore del castello di Marano, paesein cui erano situati i beni di proprietà del debitore (69).
A livello economico i pegni più interessanti sono rappresenta-ti dai mansi, beni o sedimina composti da un numero elevato dicampi lavorati, vigne e boschi. Molte volte di questi mansi è se-gnalato il nome del conduttore e l’affitto che costui pagava, comeera il caso di Blasio detto Iulio che versava « de affictu congia vi-ni sex, starium frumenti unum, denarios XII et galinas duas cumovis » a Giovanni figlio del fu Candido di Rainerotto di Udineche aveva scelto di impegnare il proprio manso come guarentigiaper il prestito di tredici marche di denaro su cui aveva accettatodi sottoscrivere anche una penale di quaranta denari (70). I credi-tori chiedevano spesso ai debitori in garanzia dei mansi quandoprestavano delle grosse cifre di denaro. A questo proposito Nico-lussio Bevilacqua di Udine per ottenere da Giovanni figlio di serCandido il prestito richiesto, « quattordecim ducatos boni aureiet iusti ponderis nomine mutui », obbligò « pro pignore mobilidicto creditori unum mansum sive bonum situm in Basaldella,
(67) Archivio di Stato di Udine, Nicolussio q, Cignotti, III, c. 24r. Segnalo inoltre altri attiin cui sono usate come pegni delle canipe: b. 687, Odorlico, IV, cc. 18v-19r.
(68) Il termine parandana (anche paradani), ancora vitale in alcune aree del Friuli, desi-gna delle strutture di magazzino e talora anche abitative costruite con canne o graticci.
(69) Archivio di Stato di Udine, Nicolò q. Giovanni, VI, cc. 27r-28r.Tra i molti contrattinei quali sono assunte come guarentigie delle case segnalo alcuni esempi contenuti nel nota-rile dell’Archivio di Stato di Udine: b. 5130, Cristoforo q, Agostino, III, cc. 2r-3r; ibid., III, cc.9r-10v; III, cc. 12r-13r; ibid., III, c. 28r; b. 5134, Quarino q. Odorico Cerdone, X, cc. 8r-9r;ibid., XXXI, c. 18r; b. 687, Odorlico, IV, c. 37r; ibid., X, c. 44v-45r. In un atto del notaio Qua-rino q. Odorico Cerdone, (b. 5134, III, c. 8) fu presentata come guarentigia una canipa su cuigravava un livello che doveva essere pagato al pievano di Cividale. Un altro esempio di malle-veria riguardante una canipa può essere rilevato nella busta 687 del notaio Odorlico, IV, c.21r.
(70) Archivio di Stato di Udine, b. 5134, Quarino q. Odorico Cerdone , X, c. 20r.
MIRIAM DAVIDE662
rectum per Zulianum molitorem de dicta villa pro quo solvit deaffictu duos starios frumenti, duos avene, duos surgi et unummilei et galinas VI cum ovis » (71).
Il semplice prestito di denaro, definito nei documenti comepurum mutuum e non foenus, era divenuto una necessità per lapopolazione friulana ed era perciò largamente utilizzato in tuttala regione. Gli atti che registravano dei prestiti semplici eranoparticolarmente frequenti e talora si trattava della pratica crediti-zia più diffusa soprattutto nelle zone a minore sviluppo economi-co. In questi mutui sovente non era espresso chiaramente l’inte-resse che sarebbe stato percepito ad operazione conclusa, anchese si può pensare che la somma indicata negli atti fosse statamaggiorata rispetto a quella effettivamente ricevuta dal richie-dente. In molti casi le guarentigie richieste nei contratti si limita-vano all’obbligazione generica dei propri beni, all’accettazione diuna penale e all’istituzione di fideiussori. Era meno frequente lascelta di istituire un pegno. I nobili sceglievano con una certafrequenza di stipulare, sia come creditori che come debitori, deisemplici mutui accettando anche di garantire con le loro proprie-tà somme richieste da altre persone. Il notaio Giovanni figlio delfu Moretto Antoni di Aquileia, ad esempio, aveva registrato ilprestito concesso da Chichino del fu Rubeus a Asquino figlio diser Francesco di Manzano che si era dichiarato contentus et con-fessus habuisse et recepisse quattro marche di denari garantite,oltre che dalla consueta generica obbligazione dei beni e da unapenale, da un mallevadore, il nobile Odorico della famiglia Stras-soldo (72). In molti degli atti aquileiesi i creditori sono dei cittadi-ni di origine lombarda giunti a seguito della famiglia della Torre.Tra questi Corrado detto Cuio, originario di Milano ma ormai re-sidente in città, decise di prestare a Domenico detto Perche delpaese vicino di Fiumicello quaranta fortoni e uno staio di fru-mento. Era una pratica comune quella di prestare oltre che de-naro anche una quantità di cereali dal momento che la maggiorparte dei prestiti era strettamente legata al calendario delle attivi-
(71) Archivio di Stato di Udine, b. 5130, Nicolò q. Giovanni, II, c. 3r.Altri esempi di mansiscelti come pegni si trovano in b. 5134, Quarino q. Odorico Cerdone, VII, cc. 150v-151r; b.687, Odorlico, X, c. 143r; ivi, X, c. 146rv; b. 5127, Leonardo q. Theoldi q. Pietro, IX, cc.31v.-32r.
(72) Archivio di Stato, b. 67, Giovanni q. Moretti q. Antonio, IV, c. 26v.
IL CREDITO IN FRIULI NEL TRECENTO 663
tà agricole (73). Negli atti registrati dai notai aquileiesi Giovannidel fu Moretto sopracitato e Maffeo la pratica di istituire un pe-gno rappresentava una scelta piuttosto rara. Nell’aquileiese sonoinoltre registrati molti mutui richiesti da donne, in taluni casi as-sociate tra loro (74). Anche nella zona del cividalese la scelta distipulare dei contratti di semplice mutuo era largamente diffusamentre la forma di guarentigia più usata era ancora una volta lafideiussione, mancando talora anche la semplice generica obbli-gazione di tutti i beni. La colonia toscana presente a Cividale,impegnata in diverse attività da quelle amministrative alla con-duzione di attività legate al campo della lana (75), era spesso inte-ressata nei contratti di prestito, come ad esempio lo fu Gugliel-mo quondam Nigi de Florencia, abitante a Cividale, prestatore ditre marche di denari a Giovanni detto Pirich, figlio di Tommasodi Gagliano che presentò un proprio fideiussore (76). Anche lacomponente lombarda residente in città spesso faceva uso deiprestiti semplici, come Stefanello figlio del fu Lancelmo di Mila-no creditore di una marca di denaro nei confronti di Federico fi-glio del decano e massaro di un monastero Martino (77). Anche aCividale era comunque usata, anche se in misura minore che inaltre località, la pratica di istituire una malleveria a garanzia, co-me scelse di fare Çancianus quondam Francisci de Craoreto cheper ottenere un prestito di due marche di denari da parte di Be-nedetto figlio di Domenico decise di pignorare una sua canipa sucui era tenuto a pagare un censo annuale di un denaro. Il con-tratto prevedeva la vendita all’incanto del pegno in caso di man-cata restituzione del denaro (78). In altri casi la scelta di istituireun pegno cadeva su una propria casa sulla quale sovente gravavail pagamento di un livello come nel caso del pellicciaio cividaleseGiacomo figlio di Domenico che pignorò una sua casa per laquale ogni anno nella ricorrenza di San Biagio doveva pagare unlivello di tre denari al Capitolo di Cividale (79).
(73) Archivio di Stato di Udine, Maffeo, I, c. 13rv.(74) Ibid., cc. 29 e 43; donne in associazione: ibid., c. 30v.(75) BATTISTELLA, I Toscani in Friuli cit.(76) Archivio di Stato di Udine, b. 681, Enrico, III, c. 11r.(77) Ibid., II, c. 99v. In un atto lo stesso prestatore risiedeva a Milano pur continuando
quindi ad avere degli interessi in Friuli (ibid., II, c. 114rv.)(78) Archivio di Stato di Udine, b. 687, Odorlico, IV, c. 18v-19r.(79) Ibid., IV, c. 37rv.
MIRIAM DAVIDE664
La pratica di chiedere prestiti semplici era diffusa anche nellospilimberghese, zona in cui operavano come prestatori molti to-scani che erano legati a piccoli prestiti al consumo e che richie-devano in genere come garanzia la sola fideiussione. Negli attidel notaio Supertino di Tommaso è registrato un solo caso diistituzione di malleveria in cui Zanino del fu Enrico detto Mu-schitta promise di restituire al toscano ser Tano, residente a Spi-limbergo e più volte citato come creditore negli atti del notaio, 6marche di denari frisacensi obbligando una sua braida nelle vici-nanze di Spilimbergo (80). Si può supporre che in generale esi-stessero due circuiti di prestito, di cui uno riguardava i prestiti alconsumo mentre l’altro si riferiva a prestiti condotti tra nobili.Le somme dei primi erano in genere basse e di gran lunga infe-riori a quelle che si incontrano nei secondi. Mentre nelle campa-gne i prestiti di consumo avevano sovente per oggetto sementi ederrate, nei circuiti cittadini anche prestiti di lieve entità eranoin denaro (81).
La tipologia creditizia più diffusa nel Trecento friulano insie-me ai prestiti semplici era quella delle vendite a credito, di cerea-li, di animali o di panni. Le vendite a credito di cereali e di vinoerano frequentemente legate al calendario agricolo ed è lecitosupporre che in molti casi avessero un carattere speculativo. Unesempio di questa pratica speculativa è riscontrabile in un attorogato dal notaio Nicolussio q. Cignotti in cui il creditore, il to-scano Sinibaldo appartenente alla famiglia dei Bardi, ottennel’ultimo giorno di novembre la promessa di pagamento di duemarche di denari e ventotto fortoni da effettuarsi il giorno di SanMichele dell’anno successivo « pro rata quantitate bladi » che idebitori, i fratelli Enrico e Canciano figli del fu Andrea, avevanoottenuto. La scelta di dilatare il pagamento in un tempo così lun-go può essere spiegata con una volontà speculativa da parte delcreditore che voleva così assicurarsi un ragguardevole guada-gno (82). Ampiamente attestata nell’area udinese, la pratica dellavendita con dilazione di pagamento era peraltro corrente in tutta
(80) BORTOLAMI, Spilimbergo Medioevale cit., pp. 172-173.(81) P. SPUFFORD, Money and its use in medieval Europe, Cambridge, 1988, pp. 382-384; D.
DEGRASSI, Il registro del notaio Giacomo di Faedis: una ricerca sulla vita rurale in Friuli nel se-colo XIV, in Studi medievali, Ser. 3a, XXII/I, 1981, pp. 183-223, a pp. 212-213.
(82) Archivio di Stato di Udine, b. 5125, Nicolussio q. Cignotti, XII, c. 14r. Altri esempi divendite a credito di cereali si possono trovare in Archivio di Stato di Udine, b. 5127, Leonar-
IL CREDITO IN FRIULI NEL TRECENTO 665
la regione. A Faedis, dove la gran parte delle transazioni docu-mentate concerne vendite con pagamento differito di una generi-ca quantità di vino e di grani, la scadenza usuale era stabilita peril giorno di San Michele successivo alla stipulazione del contrat-to; in genere l’estinzione del debito si realizzava entro un an-no (83). Una situazione analoga si presenta a Venzone, dove oltreche nelle compravendite di vino il differimento di pagamento ècontemplato nel caso dei panni e di altre merci (84). A Cividale lamaggior parte delle compravendite dilazionate comprendeva ven-dite di generiche quantità di cereali e di animali che dovevanoessere risolte entro un anno dalla stipulazione del contratto nellaconsueta giornata di San Michele.
Tutte le vendite a credito erano garantite attraverso l’accetta-zione di una penale, l’obbligazione generica dei beni e soprattut-to l’istituzione di un pegno sovente di valore, quale un genericobonum o un manso (85). Tra gli atti registrati dal notaio NicolòManin sono molte le vendite a credito di vino (86) eseguite dalnotaio Nicola figlio di Venuto di Udine che, una volta proposti itermini di scadenza che andavano dai tre ai sei mesi, garantivala dilazione del pagamento attraverso la richiesta di guarentigieche spesso erano costituite da animali e non solo, come si leggein un atto (87) in cui l’acquirente di otto conzi di vino rosso Mar-tino, figlio di Andrea di Flambro, decise di presentare come pe-gno, oltre a tre buoi dal pelo rosso, un mulino retto da un mu-gnaio. Un’altra malleveria che compare spesso tra le scelte degliacquirenti di vino a titolo di garanzia è la casa, pegno propostoad esempio da Giovanni q. Romani di Talmassons che, avute adisposizione poche settimane per pagare le cinque marche di de-nari necessarie per comprare il vino, « designavit eidem creditoriquandam suam domum cum omnibus suis iuribus et pertinen-
do Theoldi q. Pietro, II, c. 15r; ivi, III, c. 45-46r; b. 5134, Quarino q. Odorico Cerdone,XXVII, c. 22-23; b. 67, Giovanni Moretti q. Antonio, II, c. 13v; ibid., II, c. 43v.
(83) D.DEGRASSI, Il registro del notaio Giacomo di Faedis: una ricerca sulla vita rurale inFriuli nel secolo XIV cit. p. 209.
(84) Se ne trovano esempi nei regesti in I. ZENAROLA PASTORE, Appunti di vita economico-so-ciale nella Venzone del Trecento cit.
(85) Alcuni esempi di vendite a credito di vino si trovano in Archivio di Stato di Udine, b.5122, Nicolussio q. Tomasino, I, cc. 25r-26v; b. 5125, Nicolussio q. Cignotti, XII, cc. 24r-25r;b. 5127, Leonardo Theoldi q. Pietro, XIV, cc. 31r-32r.
(86) Archivio di Stato di Udine, b. 5131, Nicolò Manin, XIX, c. 8r; ibid., XIX, cc. 36r-37v;ibid., XIX, c. 38r.
(87) Archivio di Stato di Udine, b. 5131, Nicolò Manin, XIX, c. 7r.
MIRIAM DAVIDE666
ciis, de muro soleratam, cupisque copertam, sitam in Utino incontrada Sancti Francisci » che sarebbe stata venduta all’incantonel caso in cui non fosse stata risolta la transazione (88).
In molti atti notarili sono gli animali ad essere venduti a cre-dito (89), in molti casi si tratta di cavalli, assicurati sovente attra-verso l’istituzione di pegni costituiti da case o prati, proprietàche presuppongono un elevato valore economico degli animaliche erano acquistati attraverso una dilazione del pagamento, oda altri animali di proprietà su cui cadeva la possibilità di vendi-ta all’incanto in caso di mancato pagamento. Un esempio di que-sto tipo di documenti è riportato negli atti del notaio LeonardoTheoldi q. Pietro in cui il conciatore di pelli Jacopo Chodul diGrazzano per l’acquisto di un cavallo bruno « pro pignore mobilidesignavit eidem creditori quasdam suas domos sue solite habi-tacionis muratas cupisque copertas cum omnibus eorum iuribuset pertinenciis iure livelli perpetualis, sitas in burgo Graza-ni » (90). Un altro esempio di questa pratica è registrato tra gli at-ti del notaio spilimberghese Supertino di Tommaso in cui Stefa-no da Tesis e il figlio Martino promettono di pagare 6 lire comepagamento per una puledra rossa a Ser Giovanni da Ronchis cir-ca nove mesi dopo la stipulazione dell’atto il giorno di SanMichele (91).
Una categoria che faceva un largo uso delle vendite a creditoera costituita dai lavoratori della lana e dai mercanti di stoffe,che riuscivano così a vendere più facilmente i loro prodotti difrequente assai costosi. Venivano rogati dei semplici contratti neiquali i compratori dei tessuti accettavano di garantire l’acquistodelle stoffe solamente con generiche promesse di obbligazionedei propri beni come nel caso di Giovanni figlio del fu ser Candi-do Rainerotti di Udine che, dopo aver obbligato tutti i suoi beni,« promisit dare stetit ac solvere provido Sandro drapperio q. serRaynerii de Utini stipulanti per se et suos hinc ad festum SanctiMartini proximum futurum ducatos boni aurei et iusti ponderis
(88) Archivio di Stato di Udine, b. 5127, Leonardo Theoldi q. Pietro, V, cc. 23r-24r.(89) Alcuni esempi di vendita a credito di animali si trovano in Archivio di Stato di Udine,
b. 5125, Nicolussio q. Cignotti, III, c. 18r; ibid., III, cc. 19r-20r; ibid., III, c. 24r; ibid., III, c.25; b. 5127, Leonardo Theoldi q. Pietro, XIV, cc. 33v-34r; b. 5134, Quarino q. Odorico Cerdo-ne, VII, cc. 71r-72r; ibid., X, c. 16r; b. 67, Giovanni Moretti q. Antonio, II, c. 19v.
(90) Archivio di Stato di Udine, b. 5127, Leonardo Theoldi q. Pietro, VIII, cc. 55v-56r.(91) BORTOLAMI, Spilimbergo Medioevale cit., pp. 181.
IL CREDITO IN FRIULI NEL TRECENTO 667
octo et denarios monete aquilegensis quadraginta et hoc vocavitpro drappo empto, habito et recepto » (92); in altre circostanze ivenditori garantivano la vendita con garanzie più precise e sicu-re. Un esempio di questo secondo caso può essere esemplificatoda un atto rogato dal notaio Leonardo Theoldi q. Pietro in cuil’udinese Odorico figlio del fu ser Giovanni di Castello dopo averpromesso di pagare i sei ducati d’oro e i dodici soldi dovuti peruna certa quantità di panni al sarto Francesco figlio del fu Stefa-no della Burghulina « obligavit et specialiter pro pignore mobilidesignavit suos pratos sitos in pratis de Chastelli » (93). L’elevatoprezzo dei tessuti, genericamente definiti come colorati in moltiatti e di cui solamente in pochi casi era data la misura esatta (94),giustificava sicuramente la necessità per i venditori di ottenereguarentigie sicure, quali terreni agricoli o case (95).
Infine ci si obbligava per residui di pagamento di censi o difitti, di diritti dotali, di compere di immobili e di salari.
La situazione creditizia friulana trecentesca era quindi carat-terizzata dalla diffusione, in buona parte, di un prestito di consu-mo legato strettamente ai bisogni e alle necessità di una popola-zione soprattutto contadina che cercava un supporto economiconei momenti di difficoltà dovuti a produzioni agricole non sem-pre sufficienti (96). La maggior parte dei prestiti era decisamentelegata al calendario delle attività agricole con pagamenti in dena-ro di una certa quantità, non meglio specificata in molti casi, digeneri alimentari definiti genericamente “quantitate bladi”, e conuna scadenza di pagamento inferiore ad un anno. Si può suppor-
(92) Archivio di Stato di Udine, b. 5134, Quarino q. Odorico Cerdone, VII, cc. 203r-204r.(93) Archivio di Stato di Udine, b. 5127, Leonardo Theoldi q. Pietro, IX, cc. 29r-30r.(94) Il notaio Cristoforo q. Agostino rogò un atto (Archivio di Stato di Udine, b. 5130, V,
c. 9r) in cui Tommaso figlio di Lazzaro da Remanzacco acquistò a credito un panno coloratodi 34 braccia e 5 quarte dopo aver accettato di impegnare tutti i suoi beni con la promessa direndere entro i dieci giorni successivi alla stesura del contratto dieci drappi a Gurono Bon-ben che rappresentava gli interessi di Culussa, appartenente alla famiglia toscana dei Bon-ben, e del cavaliere Federico Savorgnan. Anche in questo caso il debitore scelse come gua-rentigia una casa. Secondo Vincenzo Joppi un braccio di panno a Udine nel XIV secolo equi-valeva a 0,6810 metri (in Statuti e ordinamenti del Comune di Udine cit., p. XXI).
(95) Alcuni esempi di vendite a credito di panni si trovano in Archivio di Stato di Udine,b. 5122, Nicolussio q. Tomasino, I, cc. 6r-7r; ibid., I, c. 27r; ibid., I, c. 50r; b. 5125, Nicolus-sio q. Cignotti, III, cc. 10v-11r; b. 5127, Leonardo Theoldi q. Pietro, VIII, cc. 34r-35r; b. 5134,Quarino q. Odorico Cerdone, VII, cc. 53r-54r; ibid., VII, cc. 203r-204r; ibid., X, cc. 8r-9r;ibid., VII, cc. 150v-151r.
(96) Sulla situazione di endemico indebitamento dei contadini cfr. Le campagne friulanedel tardo medioevo. Un’analisi dei registri di censi dei grandi proprietari fondiari, a c. di P. CAM-MAROSANO, Udine, 1985, pp. 103-108.
MIRIAM DAVIDE668
re che in molte vendite a credito di cereali vi fosse una volontàspeculativa con interessi simulati. In questo tessuto creditizio,ancora embrionale, si impiantarono i banchi di prestito dei to-scani che, oltre ad occuparsi di un credito che si rivolgeva al pa-triarcato e alla gestione delle risorse economiche dello stesso, en-trarono nei circuiti economici cittadini friulani con una presenzacostante sia dal punto di vista della finanza pubblica, con prestitie depositi in Comune o con l’acquisto di appalti di dazi, come te-stimoniano i Camerari di Udine, sia come singoli cittadini inte-ressati a prestare denaro o a vendere in maniera dilazionata unavasta gamma di prodotti su cui spiccano i panni, produzione tes-sile in larga parte curata da artigiani di origine toscana residentiin Friuli. Altre componenti esterne furono quella dei lombardiche, pur essendo maggiormente interessati alla gestione di ga-staldie e all’acquisizione di appalti, operarono frequentementecome prestatori ad interesse, e, in maniera più marginale, quelladei feneratori ebrei, che durante il XIV secolo scelsero di non fa-re prestiti ad enti pubblici preferendo occuparsi di mutui di pic-cola entità legati alle necessità di ogni giorno. Oltre a questecomponenti esogene rispetto alla società friulana molti furono igruppi sociali interessati ai circuiti creditizi attivi in Friuli, tra iquali emersero le figure emergenti degli artigiani le cui attività siandavano sviluppando in concomitanza con la crescita generaledelle cittadine friulane, con una preponderanza di fabbri, beccaie lavoratori del settore laniero e tessile, ed ancora i notai e i no-bili delle famiglie friulane, tra le quali si faceva sempre più po-tente la casata dei Savorgnan.
MIRIAM DAVIDE