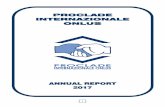Benedetti Ezio, SVILUPPI RECENTI NEL SISTEMA EUROPEO DEI VISTI: PROFILI CRITICI E ANALISI NORMATIVA
La Internet governance nel sistema internazionale
Transcript of La Internet governance nel sistema internazionale
di Tommaso Natoli Dottore di ricerca in Ordine internazionale e diritti umani
Sapienza – Università di Roma
La Internet governance nel sistema internazionale
F O C U S T M T – 1 9 S E T T E M B R E 2 0 1 4
2 | federalismi.it – focus TMT |n. 2/2014
La Internet governance nel sistema internazionale *
di Tommaso Natoli
Dottore di ricerca in Ordine internazionale e diritti umani
Sommario: 1. Introduzione: la Rete come risorsa strategica globale; 2. Profili descrittivi
dell’attuale regime di Internet governance; 3. Aspetti critici dell’attuale sistema di Internet governance;
4. Il dibattito in seno alla Comunità internazionale e principali proposte di riforma; 4.1. La World
Conference on International Telecommunication del 2012; 4.1.1. La Risoluzione numero 3; 5. Conclusioni:
l’inizio della Digital Cold War.
1. Introduzione: la Rete come risorsa strategica globale. La rivoluzione digitale avvenuta nel corso degli ultimi vent’anni è uno degli elementi principali del
processo di integrazione globale di cui oggi siamo, assieme, attori e spettatori. Tale fenomeno ha
riverberato i suoi effetti sulle dinamiche internazionali ad un ritmo crescente fino a costituirne,
oggi, un fattore strutturale. Superata una prima fase nella quale le tecnologie digitali hanno svolto
un ruolo prettamente comunicativo, infatti, attorno ad esse sorgono oggi numerose questioni di
natura etica, sociale, politica ed economica. L’incidenza di tali questioni sulla dimensione statuale
ed inter-statuale è ormai talmente dirompente da mettere in discussione i presupposti tradizionali
della sovranità e dell’esercizio dei poteri pubblici, andando ad incidere sul quadro dei diritti
individuali1. È infatti difficile negare come l’enorme flusso di dati e informazioni in transito ogni * Articolo sottoposto a referaggio. 1 Cfr. gen. J. KULESZA, Internet Governance and the Jurisdiction of States: Justification of the Need for an International Regulation of Cyberspace, in ‘III Global Internet Governance Academic Network Symposium Working Paper’, 2008, disponibile su http://papers.ssrn.com; D. FIDLER, Introduction: The Internet and the Sovereign State: The Role and Impact of Cyberspace on National and Global Governance Symposium, in ‘Indiana Journal of Global Legal Studies’, 5/2, 1998, secondo cui: «Developments in technology have long had effects on states and international relations. […] Technological changes have had impact as well on fundamental aspects of international intercourse, such as trade and war. The growing debates about the impact of the revolution in new information technologies, especially the Internet, belong to this older phenomenon of technology affecting the dynamics of international relations.»; H.H. PERRITT JR, The Internet as a Threat to Sovereignty? Thoughts on the Internet's Role in Strengthening National and
3 | federalismi.it – focus TMT |n. 2/2014
secondo sulle reti digitali costituisca un elemento che caratterizza le relazioni internazionali
contemporanee tanto da far ritenere il cyberspazio la loro “quinta dimensione” – dopo terra,
mare, aria e spazio extra-atmosferico2.
Da un punto di vista strutturale ciò che oggi chiamiamo “Internet” può essere considerato come
un unicum tecnologico, una rete telematica globale composta a sua volta da una miriade di reti
autonome ma interconnesse, le quali operano in assenza di un organo centrale di controllo.
Questa “intelaiatura” virtuale non solo ha reso possibile la creazione di mercati globali per ogni
tipo di merci e servizi, ma ha permesso anche la nascita di innumerevoli fora all’interno dei quali
vengono condotte e proiettate a livello internazionale attività pubbliche di qualsivoglia natura,
con tempi e modalità prima impensabili. In particolare, negli ultimi anni il web ha permesso
l’avanzamento di istanze di natura “endogena” – si pensi agli scenari in cui i social media hanno
giocato un ruolo rilevante (seppur non decisivo) nell’organizzazione dei movimenti di protesta e
di insurrezione popolare nel mondo arabo3 - ed “esogena”, attraverso nuove forme di advocacy
digitale che permettono di condurre ogni tipo di campagna di informazione, denuncia e
sensibilizzazione su temi ritenuti di rilevanza globale4.
La Rete costituisce inoltre il veicolo attraverso il quale sempre è ormai possibile minacciare la
sicurezza degli Stati, sia attraverso la diffusione on-line di documenti riservati5, che attraverso la
realizzazione di veri e propri attacchi digitali6. Sempre per asserite ragioni di sicurezza, alcuni Stati
hanno avviato attività segrete di controllo dei dati e di sorveglianza delle comunicazioni digitali, Global Governance, ivi, p. 423, 436-37; J.L. GOLDSMITH, The Internet and the Abiding Significance of Territorial Sovereignty, ivi, p. 475 e ss.; G. M. RUOTOLO, Internet-ional Law. Profili di diritto internazionale pubblico della rete, Bari, 2012, passim; S. RODOTÀ, Una Costituzione per Internet, in notizie di POLITEIA, XXII, 82, 2006, pp. 177-182. 2 Come emerso nel corso dei lavori preparatori del Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, tenutosi in Brasile nel 2010. Si veda, in proposito, il documento reperibile all’indirizzo: http://www.cybercrimelaw.net/documents/UN_12th_Crime_Congress.pdf 3 Cfr. Gen. M. CASTELLS, Communication, Power and Counter-power in the Network Society, in ‘International Journal of Communication’, 1(1), 2007, pp. 238–266; P. N. HOWARD, The Digital Origins of Dictatorship and Democracy: Information Technology and Political Islam, New York, 2010; I. ALLAGUI, J. KUEBLER, The Arab Spring and the Role of ICTs: Editorial Introduction, in ‘International Journal of Communication’, 5/2011, pp. 1435–1442.; B. SELWAN EL KHOURY, Le rivoluzioni arabe non sono figlie dei social network, in ‘Limes’ (quaderni speciali), n.1/4, pp. 97 – 104. 4 Si pensi, ad esempio, alla comunità virtuale “Avaaz” (avaaz.org), che conta oggi più di venti milioni di membri impegnati in campagne di sensibilizzazione e pressione nei confronti dei governi su questioni internazionali ritenute urgenti. 5 Il cui caso più eclatante è sicuramente quello di Wikileaks (wikileaks.org); per un approfondimento sul tema si veda: M. L. SIFRY, WikiLeaks and the Age of Transparency, 2011. 6 Tanto da aver comportato la nascita di nuove categorie di esercizio della violenza come cyber-war e cyber-terrorism. Per un’interessante analisi teorica dell’argomento, si veda: C. DEMCHAK, P. DOMBROWSKI, Rise of a Cybered Westphalian Age, in ‘Strategic Studies Quarterly’, primavera 2011; RUOTOLO G. M., op. cit., p. 93.
4 | federalismi.it – focus TMT |n. 2/2014
come dimostrato dallo scandalo scoppiato nel giugno del 2013 a seguito delle rivelazioni fornite
dall’ex tecnico della CIA Edward Snowden.7
Non da ultimo la gestione della Rete interessa in misura sempre maggiore numerosi aspetti legati
alla tutela giuridica di alcuni diritti fondamentali dell’individuo, come quello all’informazione, alla
libertà di espressione, alla partecipazione al progresso culturale e scientifico,8 allo sviluppo,9 e alla
privacy10.
Alla luce di tali evoluzioni, il controllo gestionale del cyberspazio ha gradualmente assunto per gli
Stati una valenza strategica primaria, in ragione degli effetti che i fenomeni di natura digitale
dispiegano sulla loro capacità di garantire la stabilità interna ed affermare il pieno esercizio della
sovranità esterna11. Tuttavia, l’avvento di Internet è stato un fenomeno così pervasivo e repentino
da aver generato, in un lasso di tempo relativamente breve, un notevole divario tra i meccanismi
amministrativi tipici delle forme governative o intergovernative e le logiche gestionali ed
operative di Internet, elaborate in base a linguaggi e dinamiche in continua evoluzione, e
contrassegnati sin dalla loro nascita da una forte alterità – se non da una vera e propria 7 Per un interessante approfondimento in merito si veda: M. MILANOVIC, Human Rights Treaties and Foreing Surveillance: Privacy in the Digital Age, in ‘Harvard International Law Journal’ (in uscita), disponibile su: papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2418485. 8 Si fa riferimento, in particolare, all’art. 19 del Patto sui diritti civili e politici del 1966 e all’art. 15 del Patto sui diritti economici, sociali e culturali. Il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha inoltre affermato per la prima volta il diritto alla libertà di espressione su Internet in una risoluzione del 5 luglio 2012, nella quale ha chiaramente stabilito come «the same rights that people have offline must also be protected online [...] regardless of frontiers and through any media.», e ha invitato gli Stati a «promote and facilitate access to the Internet and international cooperation aimed at the development of media and information and communications facilities in all countries.». Documento consultabile su: www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-2_en.pdf, p. 23. Gli aspetti inerenti il rapporto tra Internet e i diritti fondamentali sono stati approfonditi anche nel Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue, presentato al Consiglio il 16 maggio del 2011. Il testo del rapporto è reperibile alla pagina: www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/a.hrc.17.27_en.pdf. 9 Come sostenuto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella risoluzione 66/184 Informations and communications technologies for development, del 22 dicembre 2011: «information and communications technologies have the potential to provide new solutions to development challenges, particularly in the context of globalization, and can foster sustained, inclusive and equitable economic growth and sustainable development, competitiveness, access to information and knowledge, poverty eradication and social inclusion that will help to expedite the integration of all countries, especially developing countries, in particular the least developed countries, into the global economy.». 10 Si consultino in merito i documenti prodotti nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, tra cui la UNGA Ris. The Right to Privacy in the Digital Age, del 21 gennaio 2014, e i due Opening Remarks by Ms. Navy Pillay, United Nations High Commissioner for Human Rights to the Expert Seminar: The right to privacy in the digital age, del 24 febbraio 2014, e to the Side-event at the 24th session of the Human Rights Council, del 20 settembre 2013, entrambi consultabili alla pagina www.ohchr.org /EN/Issues/DigitalAge/Pages/DigitalAgeIndex.aspx. 11 Sul concetto di “sovranità esterna”, cfr. S. MARCHISIO, Corso di diritto internazionale, Torino, 2013, p. 34 ss.
5 | federalismi.it – focus TMT |n. 2/2014
opposizione - rispetto alle concezioni “classiche” di controllo, autorità e legittimo esercizio del
potere pubblico12. Le ragioni di ciò sono riconducibili alla matrice valoriale che ispirò l’attività dei
pionieri - informatici e tecnici – impegnati a suo tempo nella creazione di Internet, intenzionati a
minimizzare il coinvolgimento governativo, considerato limitativo della libertà e portatore di
procedure inefficienti e costose, che avrebbero rallentato lo slancio innovativo della nuova
tecnologia13.
Sebbene Internet sia nato per volontà, sotto la supervisione e grazie finanziamenti
dell’amministrazione statunitense, inizialmente interessata ad elaborare soluzioni tecnologiche ad
esigenze di sicurezza legate al rischio di guerra nucleare, già nella sua genesi sono rinvenibili i
tratti di quella che è stata definita una “libertà autarchica”, o una “benevola anarchia”14, frutto di
un’impostazione originaria costruita attorno ai concetti di governance without government, self-regulation,
private sector leadership, e bottom-up policy development15. In base a tali presupposti è stata sviluppata
l’infrastruttura che ne permette ancora oggi il funzionamento, realizzata e messa a disposizione
nella sua interezza da organismi di natura tecnica, secondo una logica funzionale basata sul
contemperamento degli interessi di tutti gli attori coinvolti (c.d. modello multi-stakeholder).
Da un punto di vista amministrativo, con l’importante eccezione degli Stati Uniti d’America, il
potere dei governi nazionali sulla Internet governance è quindi da sempre fortemente limitato. Il
traffico tra le diverse reti viene infatti regolato secondo codici e standards determinati da
procedure di autoregolazione tecnica e di consultazione orizzontale, la cui operatività è garantita
da accordi di natura contrattuale. Le capacità di controllo degli Stati sono quindi circoscritte al
proprio ordinamento, con riferimento alla regolazione normativa di determinate fattispecie
criminose localizzabili nel proprio territorio (si pensi alle normative anti-pirateria o anti- 12 Cfr. gen., J. GOLDSMITH e T. WU, Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World, Oxford, 2006; J. KULESZA, International Internet Law, New York, 2012; J. GOLDSMITH, Against Cyberanarchy, in ‘University of Chicago Law Review’, 65/1199, 1998; D. G. POST, Against ‘Against Cyberanarchy’, in ‘Berkeley Technology Law Journal’, 17/1365, 2002. 13 In questo senso, oltre alla ben nota Declaration of the Independence of Cyberspace di John Perry Barlow’ del 1996, si fa riferimento anche al discorso A Cloudy Cristal Ball – Visions of the future tenuto da Dave Clark nel 1992 nel quale si legge: «We do not believe in kings, presidents and voting. We believe in rough consensus, factual approach and running code». 14 H. KLEIN, ICANN and Internet Governance: Leveraging Technical Coordination to Realize Global Public Policy, in ‘The Information Society’, 18/2002, pp. 193 - 207. É interessante a questo proposito sottolineare come molti dei giovani ricercatori coinvolti nei primi progetti di costruzione di reti telematiche, provenissero dalle università della costa Ovest degli Stati Uniti, e fossero quindi fortemente influenzati dalla rivoluzione culturale anti-establishment nata in opposizione alla Guerra del Vietnam, che caratterizzò gli anni sessanta. Il frutto delle loro ricerche fu anche un tentativo di elaborare forme alternative di organizzazione sociale, politica e comunicativa. 15 W. KLEINWATCHER, The History of Internet Governance, 2009, p. 2.
6 | federalismi.it – focus TMT |n. 2/2014
pedopornografia). L’impossibilità si stabilire un controllo effettivo sul cyberspazio ha poi spinto
una serie di Paesi, in particolare quelli sottoposti a regimi autocratici e illiberali, ad attuare
politiche di restrizione all’accesso attraverso l’appropriazione statale di servizi e infrastrutture
comunicative, il filtraggio dei contenuti digitali e la sorveglianza delle comunicazioni16.
Gli aspetti appena illustrati descrivono a grandi linee il quadro che vede la Rete come un
elemento strategico nelle relazioni globali, la cui rilevanza è destinata a crescere nel prossimo
futuro. La volontà di far rientrare la sua gestione nel quadro dell’ordinamento pubblico
internazionale, evitando un sistema di gestione ripartito tra le diverse legislazioni statali - per
molti aspetti incompatibile con la natura stessa del mezzo - ha spinto parte della Comunità
internazionale a promuovere la creazione di meccanismi ed organi gestionali di natura inter-
governativa, al fine di favorire una effettiva compartecipazione internazionale di natura
“pubblica” 17.
Come si vedrà, la difficile governabilità di Internet, dovuta alla sua struttura capillare e
multicentrica, rende tale tentativo prima di tutto una sfida all’idea stessa di Internet governance,
intesa come la capacità di stabilire e rendere effettive norme di condotta e di indirizzo degli attori
(utenti e fornitori dei servizi) operanti in un determinato contesto di riferimento18.
2. Profili descrittivi dell’attuale regime di Internet governance. La natura dei meccanismi di Internet governance attualmente operanti è strettamente collegata alle
peculiarità strutturali del mezzo, a loro volta riconducibili alle dinamiche storico-evolutive che le
hanno determinate. Il funzionamento generale di un sistema in cui il dato tecnico e quello
“politico-amministrativo” sono strettamente interrelati è quindi legato in primo luogo alla sua
natura decentralizzata. Il trasferimento di dati, infatti, non avviene attraverso un unico canale di
riferimento, ma si avvale al contrario di una moltitudine di reti interconnesse attraverso le quali i
dati non viaggiano in maniera ordinata, ma vengono suddivisi in “pacchetti”. Tale sistema è 16 Si veda il rapport Enemies of the Internet 2014 di Reporters Without Borders, presentato il 12 marzo 2014, disponibile alla pagina 12mars.rsf.org/2014-en/. Vedi anche il rapporto Freedom on the net 2013 di Freedom House, reperibile alla pagina freedomhouse.org. 17 Ad oggi, l’unico strumento giuridico multilaterale riguardante aspetti generali del web è la Convention on Cybercrime, adottata a Budapest nel novembre 2001 su iniziativa del Consiglio d’Europa. 18 La dicitura “Internet governance” è stata introdotta negli anni ottanta per indicare una serie di aspetti gestionali di natura prevalentemente tecnica. Tale definizione si è poi evoluta significativamente, al punto che, ai fini del presente lavoro, si farà riferimento a quanto stabilito nel Report del Working Group on Internet Governance (WGIG) del giugno del 2005, secondo cui per Internet governance si intende: «the development and application by Governments, the private sector and civil society, in their respective roles, of shared principles, norms, rules, decision-making procedures, and programmes that shape the evolution and use of the Internet.». Documento consultabile alla pagina http://www.wgig.org/docs/WGIGREPORT.pdf.
7 | federalismi.it – focus TMT |n. 2/2014
quindi formato da fonti molteplici e indipendenti, che inviano frammenti di dati attraverso canali
a loro volta molteplici e indipendenti19.
Una simile architettura rende quindi impossibile l’istituzione di un unico centro di imputazione
decisionale in grado di esercitare funzioni “normative” in maniera univoca e generalizzata
(government), e ostacola l’elaborazione policies di sistema volte ad indirizzare uniformemente i
comportamenti di tutti gli attori in esso operanti (governance). Da qui la complessità che
caratterizza gli aspetti regolativi di Internet, frutto di una discrasia venutasi a creare tra un sistema
capillare, de-spazializzato e multicentrico e i meccanismi regolativi fondati sui presupposti
giuridici tipici dell’organizzazione statuale20.
In tale direzione, per migliorare il funzionamento del sistema, al suo interno sono stati elaborati
degli strumenti regolativi propri, tra cui ad esempio la procedura che viene ancora oggi utilizzata
per l’elaborazione di alcuni dei principali standard tecnici di Internet, individuati a seguito di una
forma spontanea di consultazione orizzontale per mezzo di documenti denominati Request for
Comments (RFC). Questi documenti, messi a disposizione dell’intera comunità di utenti e poi
raccolti dalla Internet Engineering Task Force (IETF)21, una volta fatti circolare ed “ottimizzati”,
contribuiscono a definire importanti aspetti inerenti la vita e l’evoluzione di Internet22.
A partire dagli anni ottanta, la gestione delle infrastrutture “esterne” è stata affidata su impulso e
controllo dell’amministrazione statunitense, ad una serie di entità amministrative più o meno
strutturate 23 . Verso la fine degli anni novanta, intuite le potenzialità commerciali derivanti 19 I pacchetti di dati, sebbene abbiano il medesimo punto di partenza e di destinazione, seguono itinerari diversi e il loro contenuto non può essere controllato se non una volta giunto a destinazione (in base al così detto processo end-to-end). 20 In termini generali, si può sostenere che la natura “de-spazializzata” di Internet faccia vacillare i presupposti dell’esercizio di politiche decisionali effettive da parte dei governi nazionali, la cui autorità è necessariamente collegata al concetto di “territorialità”. 21 Organizzazione non governativa formata da esperti del settore, nata su impulso dell’amministrazione statunitense al fine di promuovere e favorire il funzionamento della nuova tecnologia. La IETF si definisce come “a large open international community of network designers, operators, vendors, and researchers concerned with the evolution of the Internet architecture and the smooth operation of the Internet. It is open to any interested individual.” About the IETF, www.ietf.org/about/. L’attività dell’IETF, e di altre organizzazioni ad essa affini come la World Wide Web Consortium (W3C) del Massachussets Institute of Technology, la International Organization for Standardization (ISO), la International Electrotechnical Commission (IEC), contribuisce a definire il funzionamento e l’evoluzione di Internet. Si veda, in proposito, RUOTOLO G. M., op. cit., p. 29. 22 I RFC, benché privi del requisito della giuridicità, hanno gradualmente acquisito un valore para-normativo in quanto la loro mancata osservazione è suscettibile di comportare l’esclusione dalla comunità di utenti. V. www.ietf.org/rfc.html. 23 La prima di queste, la Internet Assigned Numbers Autority (IANA), fu creata nel 1988 e la sua attività fu in un primo momento “incarnata” nella figura dello scienziato informatico Jon Postel, ai tempi direttore della Computer Networks Division dell’Istituto di scienze informatiche dell’Università della California. Nel corso di
8 | federalismi.it – focus TMT |n. 2/2014
dall’impressionante espansione di Internet, il governo di Washington ha ritenuto necessario
trasferire tale gestione ad un organismo più complesso: la Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers (ICANN), presentata nel 1998 dall’amministrazione Clinton come l’organismo che
avrebbe garantito una gestione della Rete indipendente e “democratica”. Ancora oggi
l’interoperabilità tra tutte le componenti strutturali e operative del web è garantita da questa
organizzazione privata no-profit, con sede in California, incaricata di gestire il funzionamento del
Domain Name System (DNS)24 e il name space, ovvero l’elenco all’interno del quale occorre figurare
per poter “esistere” su Internet ed essere raggiungibili dagli altri apparecchi connessi, la cui
unicità è un requisito necessario per garantire l’affidabilità delle comunicazioni via web25.
In linea generale è quindi possibile affermare che il corretto funzionamento del DNS garantisca
l’esistenza stessa della Rete nelle forme in cui la conosciamo oggi,26 e che l’unicità della lista di questa prima fase si può ritenere che la principale autorità di riferimento di Internet, benché incaricata di una gestione puramente tecnica, coincidesse con la persona di Postel, e in via indiretta con il Governo americano, essendo egli sotto contratto del Dipartimento della difesa per tale attività. Per avere un’idea dell’importanza di tale funzione, basti pensare che fu Jon Postel, insieme alla sua collega Joyce Reynolds a definire - con un documento conosciuto come RFC920 - i primi sei ‘domini generici’ (.gov, .edu, .com, .org, .mil, e .net) e gli oltre 200 ‘domini nazionali’ (.it, .fr, .us, .jp ecc). 24 Il Domain Name System (DNS) consiste in un database dinamico contenente i nomi di dominio registrati dagli utenti (ad es. nomequalsiasi.com) accoppiati ad un determinato numero identificativo unico, o Internet Protocol – IP (es. 12.34.56.78). Alcuni computer, chiamati server, svolgono il lavoro di collegamento tra il nome di dominio e il numero di protocollo, e permettono, una volta che una richiesta viene riconosciuta e autorizzata, di mettere in comunicazione i due “PC – utenti”. 25 Si tratta di un modello descrittivo volutamente semplificato, riferibile in realtà alla prima versione di Internet ovvero quella esistente fino al 1983. A partire da quell’anno, l’aumento di utenti e connessioni impose ai ricercatori di suddividere il name space in una serie di sottoliste tra loro comunicanti e distribuite su vari computer, sui quali viene ripartito il carico di lavoro altrimenti insostenibile (le migliaia di richieste di indirizzamento che vengono effettuate ogni secondo). Ognuna di queste parti di database è definita zone file o zone, e contiene a sua volta una sottolista di accoppiamenti nome di dominio – numero di protocollo, ad ognuna delle quali è assegnato un name server, ovvero un programma di indirizzamento e un host computer, ovvero l’hardware che ospita il zone file e il name server. Ogni zone è collegata ad un'altra secondo una gerarchia piramidale all’apice della quale c’è la root zone, in maniera tale da garantire il requisito dell’unicità. Ogni livello ha il suo nome/dominio di riferimento. I top-level domains generici (gTLDs) sono i domini come .com, .org, o .net, mentre i domini di primo livello nazionali (ccTLDs), come .it o .fr, sono relativi ad organizzazioni localizzabili in un determinato Stato. Gli altri nomi di dominio riguardano i livelli inferiori e sono separati da un punto: dominio2.dominio1.com sono i tre livelli di domini sotto i quali può essere registrato un sito. In questo sistema ogni dominio ha il suo amministratore, che esercita in maniera esclusiva il proprio controllo e la propria autorità sugli amministratori ad esso sottoposti ed è a sua volta soggetto alle entità amministrative ad esso superiori (così detta ‘distributed administration’). All’apice vi è sempre e comunque il root administrator (l’ICANN), le cui policies possono essere trasmesse a cascata ed arrivare a tutti gli amministratori di rete del DNS tramite rapporti contrattuali contenenti le norme e le condizioni relative all’inserimento nel name space, come ad esempio la fornitura di informazioni sui contatti, il pagamento delle tasse annuali, il riconoscimento del ruolo dell’amministratore DNS e così via. Di conseguenza, ognuna delle reti che compone Internet ha un contratto con l’entità incaricata di gestire il DNS, ovvero l’ICANN. 26 G. M. RUOTOLO, op. cit., p. 48.
9 | federalismi.it – focus TMT |n. 2/2014
nomi, benché dovuta a necessità di natura tecnica, consente all’entità incaricata di gestirla, ovvero
l’ICANN, di autorizzare - e quindi potenzialmente di negare - la registrazione di un dominio su
Internet27.
La posizione di monopolio nella quale si trova l’ICANN, in merito all’operatività dei computer
che si connettono alla Rete, potrebbe quindi farla ritenere come la sua principale “entità
regolatrice”28. Sebbene questa abbia mantenuto fino ad oggi il controllo su aspetti di natura
prevalentemente tecnica, il dibattito sulla sua capacità di attuare veri e propri meccanismi di
governance è tutt’ora aperto, ed è stato da più parti sostenuto come il suo campo decisionale
potrebbe potenzialmente espandersi ad altre questioni di rilevanza internazionale29.
Ad ogni modo, è generalmente riconosciuto che l’organizzazione e il funzionamento
dell’ICANN, nonché il rapporto tra questa e il governo statunitense, costituiscono i due nodi
centrali della gestione futura e dell’evoluzione delle tecnologie di Rete. Gli Stati Uniti, di fatto,
hanno sempre esercitato una supervisione unilaterale sui meccanismi appena descritti e non
hanno mai nascosto l’intenzione di voler mantenere un controllo esclusivo sul root zone file,
adducendo come motivazione principale il fatto che il server dedicato alla sua gestione (definito
per questo “autoritativo”), si trovi fisicamente sul loro territorio30.
3. Profili critici dell’attuale sistema di Internet governance . 27 Come sottolineato dalla Internet Achitecture Board (IAB) nel 2000: «Both the design and the implementation of the DNS protocol are heavily based on the assumption that there is a single owner or maintainer». Più in particolare le prerogative gestionali dell’ICANN riguardano la supervisione del root server, le regole generali che permettono il passaggio da un nome di dominio ad un altro, la scelta dei nomi di dominio disponibili, i costi di registrazione degli stessi, e le restrizioni sull’aggiunta o la cancellazione di nuovi domini. I singoli operatori (registrars) sarebbero quindi vincolati alle norme stabilite tra l’ICANN e i vari amministratori di rete attraverso un sistema di contratti “a cascata”, il cui mancato rispetto potrebbe comportare la sospensione dell’operatività di un determinato dominio. Cfr. H. KLEIN, op. cit., p. 203, secondo cui «Internet users could only enjoy access to the name space if they obeyed ICANN’s rules; if they broke the rules, they could see their domain name suspended, canceled, or transferred.». All’interno dei contratti sarebbe poi prevista una sorta di “clausola in bianco” secondo cui il «Registrar shall comply […] with all ICANN adopted Policies». 28 B. CAROTTI, L’ICAAN e la governance di Internet, p. 2, 2006, contributo reperibile alla pagina: http://www.irpa.eu/wp-content/uploads/2011/10/Icann_Rtdp_bc.pdf. 29 Secondo H. KLEIN, op. cit., p. 197, senza andare incontro a particolari ostacoli tecnici, l’ICANN si trasformerebbe così in un general-purpose regolator, in grado di esercitare poteri decisionali su materie come la proprietà intellettuale, il controllo dei contenuti trasmessi, o l’accesso a determinate aree virtuali. Mentre per i domini nazionali le autorità preposte al controllo potrebbero sempre rivendicare una propria autorità nella gestione del registro, ciò è vero soprattutto per i TLDs generici, nei quali è concentrata la maggior parte delle registrazioni, e il cui controllo influenza in maniera decisiva qualsiasi utente Internet. 30 Ancora oggi la National Telecommunications and Information Administration (NTIA), agenzia del Dipartimento del commercio americano (Departement of Commerce – DoC), detiene il potere di approvare qualsiasi modifica al root zone file e quindi di influenzare il funzionamento dell’intera Rete.
10 | federalismi.it – focus TMT |n. 2/2014
La struttura interna dell’ICANN è in realtà piuttosto complessa31. Essa consiste in un sistema di
enti semi-autonomi che comprende, oltre all’ICANN come società a sé stante, anche altri
organismi di supporto ad essa collegati, tra i quali un comitato aperto alla rappresentanza dei vari
governi nazionali (Government Advisory Committee – GAC) 32. Essendo la sua attività ispirata al
principio della mediazione tra tutti i portatori di interesse coinvolti, il vertice decisionale
dell’organizzazione (Board of Directors) è composto da figure esperte provenienti dal mondo
tecnico, accademico e commerciale, e da personalità indicate direttamente dalla comunità degli
utenti. Tuttavia, nei primi anni di vita dell’ICANN il criterio multi-stakeholder è stato applicato in
maniera parziale e le decisioni del Board sono state oggetto di forti critiche in relazione alla poca
trasparenza sulle decisioni prese e agli squilibri di potere che si sono venuti a creare al suo
interno.
Nondimeno, è il rapporto con il Dipartimento del commercio americano (DoC), ad aver
costituito il punto critico principale, in virtù del fatto che - almeno sulla carta - l’ICANN avrebbe
dovuto agire in maniera indipendente e nell’interesse della comunità globale di utenti33. Nel corso
dei suoi primi dieci anni di vita, i vari accordi stabiliti con il DoC sono stati oggetto di numerosi
emendamenti, elaborati al fine di conferire a tale organizzazione maggiori margini di autonomia e
indipendenza34.
31 «In the ICANN community, you’ll find registries, registrars, Internet Service Providers (ISPs), intellectual property advocates, commercial and business interests, non-commercial and non-profit interests, representation from more than 100 governments, and a global array of individual Internet users. […] ICANN’s fundamental belief is that all users of the Internet deserve a say in how it is run.» Welcome to ICANN, http://www.icann.org/en/about/welcome. Per una rappresentazione grafica dell’attuale struttura dell’ICANN si veda il grafico alla pagina: http://www.icann.org/en/groups/chart. 32 Si tratta di un organo consultivo nel quale i governi nazionali possono incontrarsi, discutere e coordinare le proprie azioni. Individualmente ogni governo nazionale può esercitare la propria autorità e applicare le proprie policies solamente sul file zone relativo al proprio codice nazione (ad es. .it per l’Italia). Fanno parte del GAC, con il ruolo di osservatori, anche alcune organizzazioni internazionali. Si veda in proposito: https://gacweb.icann.org/display/gacweb/Governmental+Advisory+Committee. 33 Fino al 2009, la base giuridica della relazione tra l’ICANN e il DoC poteva essere ricostruita in base a tre differenti accordi: il Memorandum of Understanding del 1998 (MoU), sostituito nel 2006 da un Joint Project Agreement (JPA), l’ICANN’s Cooperative Research and Development Agreement (“CRADA”), e il contratto relativo alle funzioni dello IANA inerenti alla gestione operativa del root zone file e l’assegnazione dei numeri di protocollo Si vedano in proposito,www.ntia.doc.gov/page/docicann-agreements,www.ntia.doc.gov/page/iana-functions-purchase-ordere www.icann.org/en/about/agreements. 34 Cfr. A. M. FROOMKIN, Almost Free: An Analysis of ICANN’s ‘Affirmation of Commitments’, in ‘Journal of Telecommunications and High Technology Law’, Vol. 9, 2011, p.192.
11 | federalismi.it – focus TMT |n. 2/2014
Sebbene in uno statement of policy del 1998 relativo ai principi fondativi dell’ICANN, conosciuto
come White Paper35, il Dipartimento del commercio americano avesse fatto riferimento ad una
private, bottom-up coordination nell’attività della nuova organizzazione, impegnata nella
«rappresentazione degli impulsi proveniente dalla vasta e crescente comunità di utenti di
Internet», di fatto l’autorità esercitata dal governo degli Stati Uniti sulle decisioni relative al root
zone file è rimasta negli anni intatta36. Sebbene alcuni di questi principi fossero stati in effetti
contemplati nei regolamenti interni dell’ICANN (Bylaws), specialmente in relazione ai meccanismi
rappresentativi dei suoi organi, in una serie di altre circostanze questi vennero sostanzialmente
disattesi. Il primo Consiglio direttivo, ad esempio, fu costituito da 9 persone scelte ad interim
senza alcuna consultazione o partecipazione pubblica, a seguito di un processo descritto dallo
stesso Jon Postel come poco democratico e trasparente37.
In risposta alle critiche provenienti dal fronte internazionale nei primi anni duemila, l’ICANN ha
aperto due uffici di collegamento – uno presso la Commissione europea di Bruxelles nel 2003 e
l’altro a Sidney tre anni più tardi38, mentre da un punto di vista tecnico vennero semplificate e
migliorate alcune delle operazioni relative alla gestione dei domini nazionali (ccTLD), sulle quali i
governi di alcuni Stati avevano espresso forti riserve39.
Dal punto di vista della partecipazione internazionale, sono state poi compiute alcune modifiche
relative ai poteri del Government Advisory Committee (GAC), originariamente concepito come un
organo a funzione consultiva, con la facoltà di fornire pareri solo su questioni sostanziali, di cui il
Board avrebbe dovuto tenere conto nell’elaborazione delle decisioni definitive40. Il GAC aveva da
subito cercato di ritagliare per sé un ruolo più incisivo, approvando nel 2000 un atto nel quale
rivendicava una maggiore capacità politico-gestionale sul funzionamento del DNS, definito come
una «public resource in the sense that its functions must be administered in the public or common interest» e il
Domain Name System come un bene comune, paragonabile allo spettro elettromagnetico41.
35 Management of Internet Domain Names and Addresses, giugno 1998, consultabile alla pagina: www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/6_5_98dns.pdf 36 Cfr. W. KLEINWATCHER, op. cit., secondo cui lo stesso Postel riconobbe, nel corso di un’audizione dinnanzi ad un comitato di Rappresentanti del Congresso USA, come “This new organization will be unique in the world – a non-governmental organization with significant responsibilites for administering what is becoming an important global resource”. 37 H. KLEIN, op. cit, p. 204. 38 Si veda in merito la pagina http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-22nov06.htm 39 A.M. FROOMKIN. op. cit., p. 195. 40 ICANN, Bylaws, art. VII § 3(a) e art. III § 3 (b) (Nov. 6, 1998), http://www.icann.org/en/general/archive-bylaws/bylaws-06nov98.htm. 41 http://archive.icann.org/en/committees/gac/gac-cctldprinciples-23feb00.htm
12 | federalismi.it – focus TMT |n. 2/2014
Nel 2002, una riforma dei regolamenti interni ha dunque stabilito che gli eventuali conflitti tra i
pareri del GAC e le decisioni del Board avrebbero dovuto essere risolti in base ad un negoziato
volto al raggiungimento di un’equa soddisfazione42, e che i rappresentanti dei governi nazionali
avrebbero avuto il potere di raccomandare direttamente al Board determinate iniziative43.
Tuttavia, il rapporto di subordinazione al DoC che, come previsto nel White Paper, avrebbe
dovuto terminare nel 2000 dando piena indipendenza all’ICANN, è stato invece rinnovato per
via contrattuale fino al settembre 2009, quando le parti hanno sottoscritto la Affirmation of
Commitments by the United States Departement of Commerce and the Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers (d’ora in avanti “Affirmation”)44. Il documento, che regola ancora oggi il rapporto tra
il DOC e l’ICANN, sembrerebbe ad una prima lettura aver segnato un notevole passo in avanti
verso un’effettiva autonomia dell’ICANN nella gestione del funzionamento del DNS, e verso il
passaggio dal controllo pubblico ad un modello di gestione effettivamente indipendente.
Una sua analisi accurata, però, da un punto di vista sia formale che sostanziale, permette di
evidenziare una serie di ambiguità sul piano normativo. Si tratta, infatti, di una dichiarazione di
impegni difforme rispetto alle forme contrattualistiche utilizzate in precedenza e nella quale non
vengono previsti meccanismi concreti di attuazione. Tale svolta sarebbe quindi configurabile non
tanto da un punto di vista giuridico, quanto più in senso politico, se non addirittura simbolico. Le
numerose promesse sottoscritte tra le parti, perlopiù ripetizioni di quanto già previsto negli
accordi precedenti, non vengono formulati in maniera esecutiva (enforceable), lasciando aperta la
questione della loro efficacia45.
Da un punto di vista legale, inoltre, l’Affirmation non affronta alcuni aspetti sostanziali, di fatto
lasciati immutati, a dimostrazione di un implicito mantenimento dello status quo ante. Certo, il
governo statunitense ha accettato l’estinzione degli accordi precedenti, in particolare del JPA, che
costituiva l’elemento più lampante del controllo da questo esercitato. In cambio, l’ICANN ha
promesso di rimanere stanziato negli Stati Uniti, e quindi soggetto alla giurisdizione americana, e 42 ICANN, Bylaws, art. XI §§ 2(1)(i)-(j) (Dec. 15, 2002), http://www.icann.org/en/general/archive-bylaws/bylaws-15dec02.htm. Tuttavia il Board ha mantenuto il potere di agire indipendentemente dall’esistenza di un conflitto pendente, nella misura in cui le ragioni del conflitto vengono inserite nella decisione finale. Id. art. XI § 2(1)(k). 43 Id. art. XI § 2(1)(i). 44 Consultabile alla pagina www.icann.org/en/about/agreements/aoc. 45 Cfr. A. M. FROOMKIN, op.cit., p. 203, secondo cui: «Yet, from a legal standpoint, the Affirmation of Commitments is, on the whole, quite vacuous. Indeed, the Affirmation’s greatest significance may lie in what it is not. […] Symbolism may indeed be the strongest affirmative characteristic of the Affirmation: nothing in the Affirmation, nor anything else ICANN has said on the subject, suggests that any of these promises are enforceable by the U.S. Government, much less by an interested third party».
13 | federalismi.it – focus TMT |n. 2/2014
aumentato ulteriormente i poteri del GAC, al quale è stato concesso un accesso diretto alle
riunioni del Board e maggiori poteri nell’individuazione delle questioni da affrontare.
Quello che però non viene in alcun modo affrontato nel documento del 2009 è la questione del
necessario consenso del governo statunitense a qualsiasi modifica, aggiunta o cancellazione dei
dati registrati nel root zone file, fisicamente collocato in un computer della Verisign/Network Solutions
Inc. (NSI), una società controllata in base ad un contratto d’appalto pubblico, e che di fatto agisce
su indicazione dell’ICANN solo in presenza di una controfirma di un funzionario governativo.
La maggior parte dei poteri dell’ICANN sul controllo del DNS, come la possibilità di riallocare
determinati domini o bloccare l’accesso agli IP, sono infatti stabiliti nel contratto relativo alla
IANA function, ancora in vigore46. È stato inoltre sottolineato come l’apparente riduzione del
controllo esercitato dal Governo statunitense non abbia in alcun modo influito sul potere
esercitato dai grandi gruppi di interesse economico di influenzare il funzionamento interno
dell’ICANN47.
La riforma del 2009 non è riuscita a placare le voci, sempre più insistenti sul piano internazionale,
relative al fatto che l’ICANN avrebbe potuto estendere i propri poteri di governance oltre le
questioni di natura puramente tecnica, eventualità che si era già rivelata più concreta del previsto
nell’agosto del 1999, quando questo diffuse la “Uniform Dispute Resolution Policy” (UDRP). Pur
trattandosi di una regolamentazione “funzionale”, nel quale venivano definite le procedure
operative da seguire per risolvere le controversie relative ai diritti di proprietà intellettuale nei
nomi dei domini, si trattò in quel caso di un vero e proprio esempio di private governance, attuata
dall’ICANN attraverso una clausola condizionale nei contratti relativi al name space48.
Quanto detto fin’ora ha comportato il sorgere di una serie di interrogativi legati ai criteri di
legittimazione, responsabilità, equità e trasparenza nella gestione di una risorsa dal valore
strategico fondamentale per la vita “pubblica” internazionale. Il controllo esercitato dal governo 46 Si veda, in proposito, la pagina www.ntia.doc.gov/page/iana -functions-purchase-order. 47 Cfr. A. KOVACS, The ICANN-US DOC 'Affirmation of Commitments' - A Step Forward?, 2009, consultabile alla pagina: http://cis-india.org/internet-governance/blog/the-icann-us-doc-affirmation-of-commitments-a-step-forward, secondo cui «While ICANN may be a public interest organisation on paper, in practice it is heavily dominated by large businesses, in particular those US-based, who seem to be willing to go to considerable lengths to defend their interests. The [Affirmation] has done nothing to check these tendencies.». 48 Arrivando ad interessare gli utenti in base ad un processo di flow-down contrattuale, le dispute sarebbero state risolte da procedure private di arbitrato nelle quali si sarebbero definiti i diritti rispettivi in base a criteri definiti dall’ICANN. Le decisioni arbitrali avrebbero potuto essere rese effettive attraverso la rimozione o il trasferimento del nome di dominio ad oggetto della controversia. Si tratta ovviamente di procedure volontarie, che in caso di insoddisfazione di una delle parti avrebbero potuto portare ad un giudizio dinnanzi ai fori giudiziari precostituiti.
14 | federalismi.it – focus TMT |n. 2/2014
degli Stati Uniti sugli organi di gestione della Rete ha, infatti, suscitato crescenti reazioni da parte
degli Stati sostenitori di una gestione maggiormente inclusiva. Ciò anche alla luce del fatto che
l’ICANN potrebbe potenzialmente essere spinta a favorire gli interessi di sicurezza nazionale
statunitensi, ad esempio rispetto alle attività di cyber terrorismo, o a rispondere a determinate
esigenze di natura politica49.
Fino ad oggi i vertici decisionali dell’ICANN hanno fatto appello alla loro “neutralità”,
asseritamente giustificata dalle competenze tecniche e dalla capacità di contemperare i diversi
interessi in gioco. Tuttavia, l’ente continua ad esercitare poteri regolativi in posizione di
monopolio, senza che questi siano bilanciati da un adeguato processo di legittimazione che tenga
conto delle ricadute globali delle decisioni prese50. Negli ultimi anni la questione è stata inserita
nell’agenda internazionale da un numero crescente di Stati, intenzionati a sostenere la
realizzazione di un sistema multilaterale in grado di tener conto dell’interesse pubblico globale.
4. Il dibattito in seno alla Comunità internazionale e le principali proposte di riforma. L’eventualità di trasferire le funzioni svolte dall’ICANN ad organismi di natura intergovernativa è
stata oggetto di discussione già a partire dalla fine degli anni novanta. Avviato in ambito europeo,
il dibattito si è poi trasferito su impulso delle potenze emergenti in seno ad una delle più antiche
organizzazioni intergovernative: la International Telecommunication Union (ITU)51. Nel quadro di tale
organizzazione era stato concluso nel 1988 l’ultimo importante strumento giuridico a vocazione
universale in materia di telecomunicazioni internazionali: le International Telecommunication
49 Come emerso in merito alla creazione del dominio “.ps” per la Palestina, in ragione delle ricadute politiche che tale decisione avrebbe potuto generare. Cfr. O.S. CISNEROS, Dot-PS: Domain Without a Country, Wired News, 2001. Disponibile alla pagina http://www.wired.com/politics/law/news/2001/01/41135. 50 Mentre alcuni autori, come Lawrence Lessig, sostengono che dietro alla gestione “tecnica” vi sia la legittimazione di un accentramento del potere nelle mani di elite politico-economiche, intenzionate a prendere determinate scelte in totale assenza di trasparenza e democraticità, altri (KLEIN, op. cit., pp. 204-205) hanno sostenuto come il controllo sul DNS potrebbe essere utilizzato per promuovere iniziative di giustizia sociale internazionale. Gli amministratori dei domini, potrebbero dedicare una parte degli introiti ottenuti per la creazione di un fondo universale volto a ridurre il digital divide, e permettere così ai Paesi più arretrati economicamente condizioni più vantaggiose di accesso alle reti digitali. 51 Fondata a Parigi nel 1865 ed entrata a far parte del sistema delle Nazioni Unite nel 1947. In base al proprio mandato l’ITU ha il compito di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri al fine di migliorare l’utilizzo razionale delle telecomunicazioni, offrire assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo, nonché favorire l’armonizzazione delle politiche nazionali in tale settore.
15 | federalismi.it – focus TMT |n. 2/2014
Regulations (ITRs)52, regolamenti di cui Internet non fu chiaramente oggetto, non avendo ancora il
ruolo e l’importanza di oggi53.
A partire dagli anni 2000 l’ITU ha quindi rappresentato lo scenario di un serrato confronto
internazionale in merito alle eventuali modifiche da apportare ad un modello di web-governance
sempre più percepito come unilateralmente imposto ed esclusivo. Il primo importante momento
di discussione si è avuto a Ginevra nel dicembre del 2003, in occasione della prima fase del World
Summit on the Information Society (WSIS)54 . L’evento, voluto dalle Nazioni Unite e organizzato
dall’ITU, era stato ideato con l’obiettivo di develop and foster a clear statement of political will and take
concrete steps to establish the foundations for an Information Society for all, reflecting all the different interests at
stake, nonché di discutere le possibili strategie finalizzate alla riduzione del divario tra Paesi ricchi
e Paesi in via di sviluppo nelle possibilità di accesso alle tecnologie dell’informazione55. I due
documenti presentati alla fine dei lavori stabilivano per la prima volta una serie di principi
programmatici finalizzati alla costruzione di una visione comune della futura “società
dell’informazione” globale56. Sebbene la questione della governance non fosse stata affrontata in
maniera diretta, per alcuni Stati l’evento ha rappresentato l’occasione per convogliare l’attenzione
internazionale sulla necessità di pervenire a forme alternative di gestione delle telecomunicazioni
digitali. La questione dello status di ente privato dell’ICANN, e del suo diretto collegamento con
le agenzie governative statunitensi, venne chiaramente indicato come uno dei nodi più 52 Nel corso della World Administrative Telegraph and Telephone Conference (WATTC) di Melbourne del 1988. Il trattato è stato sottoscritto da 178 Paesi ed è entrato in vigore nel 1990. Il testo è consultabile alla pagina: http://www.itu.int/osg/spu/stratpol/ITRs/mel-88-e.pdf 53 Le ITRs riguardarono quindi le sole comunicazioni radiotelegrafiche e telefoniche, già a quel tempo sottoposte ad un regime regolamentare stabilito nel 1973, cui evidentemente era necessario operare alcune revision. Nonostante le ITRs definiscano le “telecomunicazioni” come «transmission, emission or reception of signs, signals, writing, images and sounds or intelligence of any nature by wire, radio, optical or other electromagnetic systems.», è comunemente stabilito che queste non siano applicabili ai servizi di protocollo Internet. Cfr. J. GOLDSMITH, WCIT – 12: An Opinionated Primer and Hysteria-Debunker, consultabile alla pagina newsle.com/article/0/49381929. 54 Indetto dall’Assemblea Generale dell’ONU con la Risoluzione 56/183 del 21 dicembre 2001. Cfr. H. KLEIN, Understanding WSIS: An Institutional Analysis of the UN World Summit on the Information Society, in ‘Information Technologies and International Development’, 1/3–4, 2004. Tutte le informazioni e i documenti relativi al WSIS sono reperibili alla pagina: http://www.itu.int/wsis/index.html. 55 Il così detto digital divide rispetto al quale le 175 delegazioni presenti a Ginevra riuscirono ad adottare una Dichiarazione di principi che stabiliva l’obiettivo comune di creare una ‘Società dell’informazione’ accessibile a tutti e fondata sulla condivisione delle conoscenze. Un Piano d’azione più specifico stabiliva che il 50 per cento della popolazione mondiale avrebbe dovuto avere accesso alla rete entro il 2015, senza tuttavia specificare nel dettaglio quali strumenti sarebbero stati utilizzati per raggiungere tale obiettivo. I delegati delle Ong produssero inoltre un documento dal titolo Shaping Information Societies for Human Needs, nel quale vennero riassunte una serie di questioni legate alla tutela dei diritti umani. 56 Si tratta del “Piano d’azione” e della “Dichiarazione di Principi”, i cui testi sono consultabili alla pagina: http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=en&id=1161|1160
16 | federalismi.it – focus TMT |n. 2/2014
controversi, in particolare da parte di Brasile, Cina, Sud Africa, e di alcuni Stati arabi. Il governo
cinese, nelle vesti di “capofila” di una schiera di Paesi in via di sviluppo, propose di intavolare un
negoziato volto a redigere una convenzione multilaterale di regolamentazione del web, alla quale
collegare un’organizzazione intergovernativa appositamente creata.
Il motivo principale che impediva il raggiungimento di un accordo su tali questioni era che non
esisteva ancora una definizione univoca e condivisa di Internet governance57. Fu per questo motivo
che, nel corso del summit, l’allora Segretario delle Nazioni Unite Kofi Annan venne incaricato di
promuovere la creazione di un organo di studio, il Working Group on Internet Governance (WGIG)58,
al fine di chiarire alcuni aspetti fondamentali e di riferire i risultati del proprio lavoro nel corso
della seconda fase del WSIS, prevista per l’anno successivo a Tunisi. Nonostante l’elaborazione di
una definizione condivisa di Internet governance59, i lavori del WGIG si sono ritrovati presto ad un
punto di stallo, in quanto i delegati statunitensi, pur accettando un’impostazione basata sulla
necessità di innalzare il livello di coordinamento e di comunicazione tra gli stakeholders, si sono
opposti strenuamente a qualsiasi proposta che comportasse la pur minima rinuncia al controllo
esclusivo del root zone file, così come al ruolo di supervisore delle attività svolte dall’ICANN. In un
documento del Dipartimento del commercio americano del giugno 2005 il punto di vista degli
USA è stato presentato in maniera perentoria:
«Given the Internet’s importance to the world’s economy, it is essential that the underlying DNS of the Internet
remains stable and secure. As such, the Unites States is committed to taking no action that would have the
potential to adversely impact the effective and efficient operation of the DNS and will therefore
maintain its historic role in authorizing changes or modifications to the authoritative root zone file»60.
Nello stesso documento veniva tuttavia riconosciuta, seppure in maniera puramente formale,
l’autorità sovrana degli Stati in relazione alla gestione dei rispettivi domini nazionali, aspetto
particolarmente rilevante in relazione ai timori espressi dalla Repubblica popolare cinese e da
alcuni governi di Paesi in via di sviluppo, rispetto alle possibili interferenze degli USA nella
gestione dei zone files nazionali.
57 La presenza di due diverse concezioni in merito, una “ristretta” agli aspetti tecnici, ed una allargata invece a tutte le questioni “politiche” (come ad esempio il commercio digitale, i reati telematici o la libertà d’espressione) portavano inevitabilmente a differenti conclusioni, vanificando i tentativi di dialogo. 58 Formato da 40 membri, di cui più della metà rappresentavano l’interesse del settore privato, della società civile e delle comunità tecniche e accademiche. 59 V. nota 16. 60 US Principles on the Internet’s Domain Name and Addressing System, Dipartimento del Commercio USA, Washington, 30 giugno 2005, Consultabile alla pagina: http://www.ntia.doc.gov/other-publication/2005/us-principles-internets-domain-name-and-addressing-system.
17 | federalismi.it – focus TMT |n. 2/2014
Nel corso della seconda fase del Summit (Tunisi 2005), sono state quindi presentate una serie di
proposte finalizzate all’istituzionalizzazione di un sistema di governance internazionale di Internet,
in linea con il contenuto e le raccomandazioni contenute nel rapporto finale del WGIG 61 .
Dinanzi alle perduranti difficoltà di giungere ad un accordo in merito alla creazione di un
organismo intergovernativo ad hoc, si optò per la stesura di un primo accordo che, seppur privo di
uno specifico contenuto programmatico, sanciva una serie di principi chiave (Agenda di Tunisi)62.
Questi stabilivano, tra le altre cose, la sovranità nazionale nella gestione dei domini nazionali, la
necessità di un coinvolgimento di tutti gli stakeholders - settore privato, società civile e governi -
ognuno con un proprio ruolo specifico, ma soprattutto per la prima volta venne affermato il
principio secondo cui tutti i governi avrebbero dovuto avere la medesima responsabilità
nell’assicurare la stabilità, la sicurezza e la continuità di Internet63. Nel documento veniva poi
decisa la creazione di un forum globale di dibattito e confronto permanente che avrebbe preso il
nome di Internet Governance Forum (IGF), la cui attività avrebbe dovuto mantenere aperto un canale
di confronto sui possibili meccanismi di “cooperazione rafforzata” volti a garantire la stabilità, la
funzionalità e l’indivisibilità della Rete, nell’interesse di tutti gli attori coinvolti, Stati compresi64.
Tali meccanismi sarebbero stati elaborati nel corso di sessioni annuali tenute sotto gli auspici del
Segretariato generale dell’ONU, al fine di favorire ed orientare le scelte che le organizzazioni del
settore (ICANN, IETF, ITU) avrebbero potuto prendere in futuro.65
Gli esiti del WSIS sono stati recepiti negli anni successivi da alcune risoluzioni del Consiglio
Economico e Sociale delle Nazioni Unite, incaricato a Tunisi di continuare ad occuparsi della
61 Consultabile alla pagina http://www.wgig.org/docs/WGIGREPORT.pdf. 62 Consultabile alla pagina: http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/6rev1.html. 63 Agenda di Tunisi, § 68. 64 Ivi, § 72. Tra i compiti previsti dal mandato dell’IGF vi sono, tra le altre cose: «Discuss public policy issues related to key elements of Internet governance in order to foster the sustainability, robustness, security, stability and development of the Internet; Facilitate discourse between bodies dealing with different cross-cutting international public policies regarding the Internet and discuss issues that do not fall within the scope of any existing body». Si veda in proposito la pagina: www.intgovforum.org/cms/aboutigf. 65 La nona edizione dell’Internet Governance Forum, dedicata al tema “Connecting Continents for Enhanced Multistakeholder Internet Governance”, si è tenuta a Istanbul dal 2 al 5 settembre 2014 e ha ospitato circa 3 mila addetti ai lavori provenienti da più di 100 nazioni, inviati da governi, organizzazioni internazionali, settore privato e società civile. L’intenzione iniziale di giungere decisioni condivise su temi di grande rilevanza come ad esempio il delicato passaggio post-ICANN, la Net Neutrality, lo scandalo Snowden-NSA, e il rapporto tra Web e diritti umani (non a caso passato in secondo piano in un Paese in cui 29 utenti di Twitter sono ancora perseguiti per aver criticato il governo nel corso dei moti di protesta in difesa del Parco Gezi iniziati nel maggio 2013), si è tuttavia dimostrata vana. Di fatto, pur considerando l’importanza di aver mantenuto aperti i canali di dialogo tra i vari portatori di interesse, il raggiungimento di accordi di natura sostanziale è stato rinviato all’edizione successiva, prevista per il 2015 in Brasile.
18 | federalismi.it – focus TMT |n. 2/2014
questione66, e dell’Assemblea generale ONU che, in una risoluzione del 2010 volta a sottolineare
le potenzialità che le tecnologie dell’informazione possono avere nel favorire i processi di
sviluppo nei Paesi economicamente più arretrati, ha affermato come «all Governments, on an
equal footing, should carry out their roles and responsibilities for international Internet
governance and for ensuring the stability, security and continuity of the Internet» stabilendo però
poi come ciò non dovesse valere «with regard to the day-to-day technical and operational matters
that do not impact on international public policy issues»67.
Nel frattempo, con una risoluzione del 2006 68 , la Conferenza degli Stati membri dell’ITU,
riunitasi ad Antalya, si accordava sulla necessità di avviare un’opera di revisione generale dei
trattati ITRs, rese obsolete dal declino dei mezzi di comunicazione tradizionali e dalle significative
evoluzioni in atto nel settore da un punto di vista sia tecnico che di policy69. Le disposizioni di
dettaglio di questo processo di revisione sarebbero state definite a seguito di indagini settoriali
portate avanti dagli organi interni specializzati dell’ITU, per poi essere presentate e discusse nel
corso di una conferenza internazionale degli Stati membri, appositamente convocata.
4.1. La World Conference on International Telecommunication del 2012. L’avvio della revisione degli ITR è stata da subito considerata da alcuni Paesi come un’occasione
unica per tentare di “gettare le fondamenta giuridiche” di un nuovo modello di web-governance. Nel
corso di un summit tenutosi nell’ottobre del 2011, India, Brasile, e Sud Africa, avevano
sottolineato la necessità di subordinare gli organi tecnici di controllo di Internet ad un ente di
natura politica operante sotto gli auspici delle Nazioni Unite, e dichiarato di voler dare effettiva
66 ECOSOC Ris. 2006/46, Follow-up to the World Summit on the Information Society and the review of the Commission on Science and Technology for Development del 28 luglio 2006; ECOSOC Ris. 2010/2 e 2011/16, Assessment of the progress made in the implementation of and follow-up to the outcomes of the World Summit on the Information Society rispettivamente del 19 luglio 2010 e del 26 luglio 2011. 67 UNGA Ris. 64/187, Information and communication technologies for Development, del 9 febbraio 2010 (preambolo). 68 ITU Res. 146 (Antalya, 2006), Review of the International Telecommunication Regulation, Consultabile alla pagina: http://www.itu.int/ITU-T/itr-eg/files/resolution146.pdf. 69 Come stabilito nei punti ‘e’ ‘f’ e ‘g’ della Risoluzione secondo cui: «advances in technology have resulted in an increased use of IP-enabled infrastructure and relevant applications presenting both opportunities and challenges for ITU Member States and Sector Members;» e che «Member States are evaluating their policy and regulatory approaches to ensure an enabling environment that fosters supportive, transparent, pro-competitive, and predictable policies, as well as legal and regulatory frameworks that provide appropriate incentives for investment in, and development of, the information society;».
19 | federalismi.it – focus TMT |n. 2/2014
applicazione ai principi generali contenuti nell’Agenda di Tunisi, asseritamente rimasti senza
applicazione70.
L’intera fase preliminare della World Conference on International Telecommunication (WCIT-2012),
organizzata dall’ITU con l’obiettivo di rinegoziare il contenuto delle ITRs, è quindi stata
contrassegnata da un clima di grande agitazione71. A pochi mesi dall’inizio dei lavori, infatti, una
serie di segnali d’allarme sono stati lanciati da parte di organi istituzionali internazionali72, da
alcune delle principali web – corporations 73 , nonché da autorevoli figure legate al mondo di
Internet74, i quali esprimevano profonda preoccupazione per i possibili esiti dell’incontro. La
tensione è stata poi accentuata dalla diffusione di alcune delle disposizioni contenute nelle
proposte presentate in fase di negoziati preliminari, che rivelarono l’effettiva volontà di
promuovere, in seno alla Conferenza, nuove norme internazionali in grado di influire sul sistema
gestionale di Internet. Inoltre, la mancanza di trasparenza che caratterizzò l’intero processo
negoziale contribuì ad acuire il timore che il nuovo accordo internazionale, qualora approvato,
70 «The Leaders highlighted the importance of building a wide political coalition at the international level for making the global internet governance regime as multilateral, democratic and transparent as provided by the WSIS.»; India-Brazil-South Africa (IBSA) Dialogue Forum Fifth Summit of Heads of State and Government Tshwane Declaration, §54, consultabile alla pagina: http://www.ibsa-trilateral.org/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=92. 71 La Conferenza, convocata dall’ITU al fine di rinegoziare i trattati ITRs del 1988, si è tenuta dal 3 al 14 dicembre a Dubai (Emirati Arabi Uniti). Le delegazioni partecipanti con diritto di voto sono state 144, alle quali si sono aggiunti anche numerosi osservatori provenienti dalle associazioni e organizzazioni del settore. Per ulteriori informazioni si consulti la pagina: http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/default.aspx. 72 Si veda, ad esempio, la ‘Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 (“Relativa alla WCIT-12 […]”), 2012/2881(RSP), nella quale, esprimendo preoccupazione per la mancanza di trasparenza nelle negoziazioni antecedenti all’evento, si dichiarava che «the ITU, or any other single, centralised international institution, is not the appropriate body to assert regulatory authority over either internet governance or internet traffic flows; […] some of the ITR reform proposals would negatively impact the internet, its architecture, operations, content and security, business relations and governance, as well as the free flow of information online;” e che “as a consequence of some of the proposals presented, the ITU itself could become the ruling power over aspects of the internet, which could end the present bottom-up, multi-stakeholder model; expresses concern that, if adopted, these proposals may seriously affect the development of, and access to, online services for end users, as well as the digital economy as a whole; believes that internet governance and related regulatory issues should continue to be defined at a comprehensive and multi-stakeholder level;». 73 Si veda, ad esempio, la campagna organizzata da Google con il video virale “Take Action: Add Your Voice to Keep the Internet #freeandopen”, e l’invito a firmare la petizione su www.google.com/takeaction/. 74 Tra cui, ad esempio, Vinton Cerf, l’informatico statunitense conosciuto assieme a Bob Kahn come uno dei “padri di Internet” per aver condotto insieme la ricerca che sviluppò e collaudò i protocolli di comunicazione TCP/IP e la stessa rete Internet come la conosciamo noi oggi, il quale ha dichiarato: «The decisions taken in Dubai in December have the potential to put government handcuffs on the Net. To prevent that – and keep the Internet open and free for the next generations – we need to prevent a fundamental shift in how the Internet is governed. I encourage you to take action now: insist that the debate about Internet governance be transparent and open to all stakeholders.», in ‘Keep the Internet Open’, The New York Times, 24 maggio 2012.
20 | federalismi.it – focus TMT |n. 2/2014
potesse conferire ai singoli Stati un ruolo molto più incisivo nelle politiche di gestione della
Rete75.
Di fatto, nonostante l’obiettivo principale fosse quello di rinegoziare le ormai desuete ITRs,
aggiornandole ad un mondo profondamente diverso da quello del 1988, la preoccupazione che
tale processo di aggiornamento potesse estenderne il campo di applicazione anche alle questione
legate alla web-governance ha catalizzato l’attenzione mediatica globale e condizionato il
comportamento delle delegazioni nel corso dei lavori. A poco sono servite le dichiarazioni del
Segretario generale dell’Organizzazione Hamadoun Touré, il quale aveva più volte affermato
come la WCIT – 12 non si sarebbe occupata né di “regolare” Internet né di stabilire norme
relative alla sua governance76. A contraddire tali affermazioni contribuì il fatto che molte delle
proposte di riforma presentate dagli Stati prima dell’inizio dei lavori includevano disposizioni che
avrebbero potuto interessare, in maniera più o meno esplicita, la Rete e i principi generali
secondo i quali questa avrebbe dovuto essere governata77.
Sulla base di tali premesse, nel corso degli incontri le posizioni dei delegati si sono
progressivamente orientate attorno due modelli principali di riferimento, uno prevalentemente
“conservatore” e l’altro marcatamente “riformista”. I primi, difensori dell’approccio multi-
stakeholder, hanno da subito affermato la loro netta opposizione a qualsiasi tentativo di
“imbrigliare” la Rete in un nuovo sistema di controllo intergovernativo, visto non solo come
ostacolo all’innovazione e allo sviluppo tecnologico, ma anche come elemento limitativo del
grado di libertà e di diffusione del mezzo, nonché del ruolo da questo svolto per l’integrazione
culturale, la diffusione su scala mondiale dei principi democratici, e la tutela del diritto alla libertà
di espressione, di informazione e alla privacy. Sull’altro fronte, le delegazioni “riformiste”
presentarono al Segretario generale una serie di proposte incentrate sulla rivendicazione del
principio di uguaglianza sovrana degli Stati nella gestione di una risorsa divenuta fondamentale
per l’intera Comunità internazionale. Tra queste, quella presentata dalla Federazione Russa,
espressamente indirizzata a scardinare il modello esistente, prevedeva in maniera chiara e
perentoria di inserire nel nuovo trattato la seguente disposizione: 75 Tale mancanza di trasparenza ha portato alla nascita di pagine web e blog finalizzati a far “filtrare” documenti e indiscrezioni sulle trattative in corso, come ad esempio wcitleaks.org. 76 Si veda, in proposito, il discorso tenuto dal Segretario generale nel corso del First Plenary of World Conference on International Telecommunications (WCIT-12), 3 December 2012, http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/speech-toure2.aspx. 77 D. FIDLER, Internet Governance and International Law: The Controversy Concerning Revision of the International Telecommunication Regulations, in ASIL Insight, Vol. 17/6, 7 febbraio 2013. Reperibile alla pagina: http://www.asil.org/pdfs/insights/insight130207.pdf.
21 | federalismi.it – focus TMT |n. 2/2014
«Member States shall have equal rights to manage the Internet, including in regard to the allotment, assignment
and reclamation of Internet numbering, naming, addressing and identification resources and to support for the
operation and development of the basic Internet infrastructure.»
Altre proposte hanno poi riguardato l’adozione di norme relative alle “comunicazioni elettroniche
indesiderate”, alla sicurezza delle reti di comunicazione, e ai costi delle comunicazioni digitali78.
Di fatto, a Dubai, le questioni relative alla web governance sono state affrontante in maniera
tutt’altro che incidentale e hanno costituito l’oggetto dei dibattiti più spinosi condizionando
l’intero processo di riforma. La proposta di inserire nel nuovo preambolo un semplice
riferimento agli obblighi da rispettare in materia di diritti umani, ad esempio, è stata da subito
considerata come un tentativo di consolidare le posizioni degli Stati intenzionati a difendere una
visione libera e aperta di Internet, e a contrastare i tentativi di censura da parte di alcuni regimi
dittatoriali o autocratici refrattari all’alto tasso di permeabilità delle frontiere consentito dalle
tecnologie digitali79.
Un’ulteriore disposizione fortemente discussa nel corso della Conferenza, poi inserita nel
Preambolo, faceva riferimento ad un generico “diritto di accesso” degli Stati ai servizi di
telecomunicazione internazionale80. Tale enunciazione, sicuramente innovativa rispetto a quanto 78 In questa direzione quella relativa, ad esempio, all’applicazione alle comunicazioni digitali del controverso principio del sending-party-pays, improntato al modello della telefonia tradizionale. Tale principio, “consacrato” dalle ITRs nel 1988, prevede che il gestore della rete che invia ad un’altra rete dei dati relativi alle comunicazioni internazionali è tenuto a pagare una tassa. Fino ad oggi questo non ha trovato applicazione in relazione ad Internet, anche in virtù del forte incremento dei costi di connessione e traffico che questo apporterebbe. Secondo tale proposta un aumento dei costi delle comunicazioni via Internet avrebbe permesso di reinvestire le risorse così ottenute nella riduzione del digital divide con quei Paesi non ancora dotati di infrastrutture sufficientemente avanzate. Cfr. J. GOLDSMITH, WCIT – 12: An Opinionated Primer and Hysteria-Debunker, consultabile alla pagina newsle.com/article/0/49381929, secondo cui «The basic issue, much simplified, is that the enormous revenues that nations and their telecoms used to derive from international telephony pricing structures diminished with the shift to cheaper Internet-based alternatives such as email, Internet telephony, instant messaging, and the like. Under current contractual and other arrangements, telecoms and ISPs in one nation transmit internet packets from abroad (and pay for the bandwidth needed to transmit those packets) without collecting the type of revenues they used to collect for traditional telephony transmission. Some nations at WCIT-12 propose to introduce language in the ITRs that would make acceptable the application of some version of telephony pricing model to the Internet in order to charge for carriage for Internet services in their countries.» 79 «Member States affirm their commitment to implement these Regulations in a manner that respects and upholds their human rights obligations.», Atto finale WCIT-12, Preambolo. Interessante richiamare a questo proposito la formulazione profondamente progressista prevista all’art 19 della ‘Dichiarazione universale dei diritti umani’ del 1948, ripresa poi dall’art. 19.2 del Patto sui diritti civili e politici, secondo cui «Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice». 80 «These Regulations recognize the right of access of Member States to international telecommunication services.», Atto finale WCIT-12, Preambolo.
22 | federalismi.it – focus TMT |n. 2/2014
previsto dal diritto internazionale delle telecomunicazioni preesistente, ha sollevato in alcune
delegazioni non pochi interrogativi in merito all’esatto contenuto di tale diritto. Mentre il
linguaggio utilizzato è sembrato riferirsi all’affermazione di un diritto di accesso universale ai
servizi di telecomunicazione, che in quel caso sarebbe stato più appropriato attribuire agli
individui piuttosto che agli Stati, la preoccupazione fu che tale disposizione potesse costituire la
base giuridica per eventuali “intromissioni” governative nella gestione tecnica dei servizi Internet.
Nondimeno, a lavori già avviati, fu in merito all’emendamento del primo articolo, dedicato come
di consueto all’oggetto e allo scopo del trattato, che si verificarono le maggiori contrapposizioni.
In base alla lettura di una delle disposizioni proposte, infatti, il campo di applicazione delle nuove
ITRs sarebbe stata estesa anche alle “agenzie operative autorizzate” attive nel settore dei servizi di
telecomunicazione internazionale81. La mancanza di una definizione esaustiva di tali “agenzie”, ha
suscitato il timore che il futuro trattato avrebbe potuto vincolare anche organismi privati come i
providers, ma soprattutto gli enti tecnici gestionali come l’ICANN e la IETF82.
Ulteriori divisioni si sono poi create in relazione ad alcuni aspetti particolari, come la sicurezza
delle reti di telecomunicazione e le unsolicited bulk electronic communications, oggetto di due nuovi
articoli, il 5a83 e il 5b84, il cui inserimento nelle ITRs è stato proposto in sede di negoziato. Le
delegazioni intenzionate a difendere lo status quo, sostenendo che l’ITU non costituiva il contesto
adatto all’interno del quale affrontare la problematica della cyber and information security85, hanno 81 Art. 1.1 (a bis): «These Regulations also contain provisions applicable to those operating agencies, authorized or recognized by a Member States, to establish, operate and engage in international telecommunications services to the public, hereinafter referred to as “authorized operating agencies.». 82 L’opposizione da parte degli Stati Uniti rispetto a qualsiasi tentativo di espandere gli ITRs oltre il loro “oggetto” tradizionale è stato uno dei motivi alla base della loro rifiuto di sottoscrivere i nuovi trattati. Si vedano in proposito le dichiarazioni dell’Ambasciatore statunitense Terry Kramer, capo della delegazione USA a Dubai, alla pagina http://www.state.gov/e/eb/rls/rm/2012/202040.htm. 83 Art. 5a, Security and robustness of networks: «Member States shall individually and collectively endeavour to ensure the security and robustness of international telecommunication networks in order to achieve effective use thereof and avoidance of technical harm thereto, as well as the harmonious development of international telecommunication services offered to the public». 84 Art. 5b, Unsolicited bulk electronic communications: «Member States should endeavour to take necessary measures to prevent the propagation of unsolicited bulk electronic communications and minimize its impact on international telecommunication services. Member States are encouraged to cooperate in that sense». 85 Si veda, in merito, il Report del Center for Democracy and Technology – CDT, Security Proposals to the ITU could create more problems, not solutions, del settembre 2012, disponibile alla pagina: www.cdt.org/files/pdfs/Cybersecurity_ITU_WCIT_Proposals.pdf. Secondo GOLDSMITH J., op. cit., 2012: «There are a number of cybersecurity proposals for WCIT-12, They basically come in two stripes: proposals that would enhance national control over cybersecurity, and proposals that would require international cooperation. As for national control, Art. 34(2) of ITU Constitution, to which the ITRs must conform, already acknowledges national control over “private telecommunications which may appear dangerous to the security of the State or contrary to its laws, to public order or to decency.” Nations already have sovereignty, recognized by the ITU, to impose their cybersecurity vision
23 | federalismi.it – focus TMT |n. 2/2014
considerato la proposta come un tentativo parte di alcuni Paesi - in particolare Russia e Cina –di
garantirsi una maggiore capacità di controllo sui contenuti delle comunicazioni internazionali al
fine di contenere possibili minacce alla sicurezza nazionale, senza che venissero al contempo
previste relative limitazioni e garanzie.
Il termine elettronic contenuto del nuovo articolo 5b, relativo alla necessità di misure che gli Stati
avrebbero dovuto intraprendere per prevenire e minimizzare l’impatto di comunicazioni
indesiderate (spam), è stato considerato come un implicito riferimento ai sistemi di pubblicità
trasmessi on-line. Ciò ha rafforzato la posizione degli Stati “conservatori”, secondo i quali i termini
bulk, unsolicited e necessary measures avrebbero permesso interpretazioni estremamente vaghe e
soggettive, potenzialmente in grado di giustificare eventuali attività di sorveglianza e filtraggio dei
dati trasmessi86. Nemmeno l’introduzione di una clausola di esclusione rationae materiae, volta a
specificare come le ITRs non avrebbero riguardato le questioni legate al contenuto delle
telecomunicazioni, è riuscita ad attenuare i contrasti sorti in merito ai confini applicativi del
nuovo strumento87.
4.1.1. La Risoluzione numero 3. Dopo dieci giorni di alternanza tra accese discussioni e fasi di stallo, il Segretario generale Touré è
intervenuto in prima persona per tentare una soluzione di compromesso tra i due “schieramenti”.
La sua proposta ha riguardato l’adozione di una risoluzione non vincolante – allegata e quindi
non parte delle nuove ITRs – volta a chiarire il ruolo dell’ITU, e degli Stati membri, rispetto ai
temi legati alla Internet governance. Nella tarda notte del 12 dicembre, è stata quindi adottata la
“Risoluzione n.3 - To foster the enabling environment for the greater growth of the Internet”, dal contenuto
sostanzialmente in linea con la posizione assunta in passato dall’ITU, volto a favorire il confronto
e la condivisione su questi temi senza prevedere alcun intervento diretto dal punto di vista
within their borders […] As for the international cooperation proposals, the nations of the world cannot not even agree on very basic cooperation requirements for 1990s-style cybercrimes. The Cybercrime Convention ( http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm) is full of vague definitions and sovereignty exceptions, and even with these weaknesses, it has been ratified by only 37 nations.» 86 Secondo alcuni esperti, le preoccupazioni relative alle possibili interpretazioni degli articoli 5a e 5b sarebbero state in realtà frutto di un’esagerazione, motivata da una poco giustificata “ITU-phobia” , intesa come «a feverish, diseased way of thinking about the ITU’s role in Internet governance.» Cfr. M. MUELLER, ITU Phobia: Why the WCIT was Derailed, Internet Governance Project, dicembre 2013, http://www.internetgovernance.org/2012/12/18/itu-phobia-why-wcit-wasderailed/# comment-4224. 87 «These Regulations establish general principles which relate to the provision and operation of international telecommunication services offered to the public as well as to the underlying international telecommunication transport means used to provide such services. These Regulations do not address the content-related aspects of telecommunications.» Art. 1.1 a.
24 | federalismi.it – focus TMT |n. 2/2014
operativo 88 . Nonostante ciò, la sua approvazione ha comunque incontrato forti resistenze,
soprattutto da parte dei Paesi occidentali, motivate sulla base delle analogie esistenti tra
determinati passaggi della Risoluzione ed alcune delle proposte presentate in precedenza, come
ad esempio quella della delegazione russa, nella quale si affermava l’uguaglianza di tutti gli Stati
nel ruolo e nella responsabilità nella Internet governance89. In particolare, il riferimento al solo
paragrafo 35.a dell’Agenda di Tunisi, secondo il quale the policy authority for Internet-related public
policy issues in the sovereign right of the States, è stato visto come il tentativo di sostenere una
concezione dell’Internet governance parziale e “Stato-centrica”, priva degli aspetti complementari e
inclusivi contenuti in altri due paragrafi della stessa Agenda, relativi al ruolo del settore privato e
della società civile nel mantenimento di una Rete stabile e dinamica90.
In maniera analoga, la parte dispositiva della Risoluzione n. 3 è sembrata voler favorire un
rafforzamento dell’ITU, non facendo questa alcun riferimento ai meccanismi di gestione esistenti
al di fuori di tale organizzazione, quale ad esempio il coordinamento con l’ICANN attraverso il
‘Governmental Advisory Committee’, e con gli altri enti non governativi (IEFT, RIRs, W3C). Le
proposte indirizzate ad equilibrare in questo senso il contenuto della Risoluzione, al fine di
affermare una concezione più articolata e obiettiva del sistema attualmente in vigore, furono
fermamente respinte dalla delegazione saudita e da quella russa, tanto che si ipotizzò la volontà di
dar vita ad una hidden agenda, condivisa da un certo numero di Stati, da elaborare e costruire nel
corso di successivi incontri91.
In breve, quello che era nato come un tentativo di compromesso costruttivo ha finito per
costituire un nuovo fronte di scontro diplomatico, inasprito da ulteriori polemiche sorte in merito
alle anomalie procedurali che ne hanno caratterizzato l’approvazione 92 . Il timore era che la 88 Consultabile alla pagina http://www.itu.int/en/wcit-12/Documents/final-acts-wcit-12.pdf. 89 FIDLER D., op. cit., v. nota 77. 90 Cfr. W. KLEINWÄTCHER, WCIT and Internet Governance: Harmless Resolution or Trojan Horse?, 17 dicembre 2012, consultabile su: http://www.circleid.com. Il riferimento è ai paragrafi: «34. A working definition of Internet governance is the development and application by governments, the private sector and civil society, in their respective roles, of shared principles, norms, rules, decision-making procedures, and programmes that shape the evolution and use of the Internet.» e «55. We recognize that the existing arrangements for Internet governance have worked effectively to make the Internet the highly robust, dynamic and geographically diverse medium that it is today, with the private sector taking the lead in day-to-day operations, and with innovation and value creation at the edges». 91 Ivi. 92 Per sbloccare la situazione di stallo durata fino all’una e mezza di notte, mentre alcune delegazioni avevano già abbandonato i lavori, il Chairman della seduta Mohammed Nasser Al Ghanim decise di “misurare la temperatura della sala”. Circa cinquanta delegazioni si espressero a favore dell’adozione della Risoluzione n. 3, mentre altre 30-40 espressero parere contrario. Questo bastò al Chair per dichiarare il testo approvato così com’era. Il giorno seguente, su richiesta della delegazione spagnola, il Chair dichiarò
25 | federalismi.it – focus TMT |n. 2/2014
Risoluzione n. 3 rappresentasse una sorta di “Cavallo di Troia” all’interno delle nuove ITRs, la
cui eventuale futura applicazione avrebbe giustificato l’adozione di approcci evolutivi sul tema
delle Internet policies all’interno dell’ITU, di fatto incaricata di continuare ad occuparsi della
questione, nonostante la sua limitata capacità di incidere sui reali meccanismi di governance.
Sostenere che tale documento avrebbe permesso di per sé alla Federazione Russa e alla
Repubblica Popolare Cinese di “prendere il sopravvento” su Internet e di metterne in pericolo la
libertà è chiaramente una esagerazione. Di certo, tale Risoluzione, e la sua controversa
approvazione, hanno apposto il sigillo finale sulla frattura venutasi a creare nel corso dei lavori93.
5. Conclusioni: l’inizio della “Digital Cold War”. La Conferenza di Dubai ha rappresentato lo scenario all’interno del quale si sono definitivamente
palesati i caratteri di un confronto internazionale di cui già da qualche anno si potevano intuire le
premesse, ma che era rimasto latente fino a quel momento94. Il processo di aggiornamento dei
vecchi regolamenti relativi alle telecomunicazioni internazionali ha contribuito a palesare
l’esistenza di un nuovo “assetto bipolare”, affermatosi nella membership dell’ITU, e quindi – di
riflesso - nella Comunità internazionale. Delle 144 delegazioni partecipanti, 89 tra cui l’Arabia
Saudita, il Brasile, la Cina, l’Indonesia, l’Iran, la Russia, e la quasi totalità degli Stati africani
presenti, hanno accettato di firmare il nuovo trattato95. La gran parte dei 55 Paesi rimanenti, tra
cui i membri dell’Unione Europea, il Canada, il Giappone e gli Stati Uniti, ha invece motivato il
suo rifiuto con riferimento alle disposizioni che avrebbero potuto giustificare un approccio
maggiormente inter-governativo in materia gestione delle reti telematiche, e questo nonostante il
testo del nuovo accordo non menzioni mai le parole “Internet”, “Rete” o “Dominio”. Gli Stati che “la misurazione di temperatura” della notte precedente non costituiva un voto formale ma che il testo della Risoluzione sarebbe rimasto comunque invariato. Si tratta del primo caso di “votazione” simile in tutta la storia dell’Organizzazione. Si veda in proposito: www.accessnow.org/blog/2012/12/12/wcit-watch-just-taking-the-temperature-a-late-night-resolution-on-the-inter. 93 M. MUELLER, ITU Phobia: Why the WCIT was Derailed, 18 dicembre 2012, disponibile su www.internetgovernance.org/2012/12/18/itu-phobia-why-wcit-was-derailed/#comment-4224. 94 Cfr. J. GOLDSMITH, WCIT – 12: An Opinionated Primer and Hysteria-Debunker, consultabile alla pagina newsle.com/article/0/49381929, secondo cui: «The fight for control of the Internet – over its governance, its content, its delivery mechanisms, its protocols, its economics, and its security – has been going on for a while now in various places. […] Usually these skirmishes between nations take place on discrete topics with discrete audiences and interests. What is interesting and important about WCIT-12 is that it is a platform for discussion of all of these issues at once. A body once tasked with the relatively uncontroversial role of promoting technical standards for international telephony and radio has become a forum for nations to discuss competing visions for speech, security, economics, and governance.». 95 Per un elenco riassuntivo dei Paesi firmatari, consultare la pagina: http://www.itu.int/osg/wcit-12/highlights/signatories.html.
26 | federalismi.it – focus TMT |n. 2/2014
Uniti, alla guida di un gruppo numericamente inferiore di Paesi, ma rappresentativo dei due terzi
circa degli utenti di Internet - e dell’attività economica a questi riconducibile - già prima dell’inizio
dei lavori avevano dichiarato la loro netta opposizione al presunto tentativo di estendere il campo
di applicazione delle ITRs alla Rete, e ribadito l’intenzione di voler preservare il ruolo di
supervisori dei meccanismi operativi e degli organi gestionali, in quanto unici garanti della
stabilità e della capacità di adattamento del sistema alle continue spinte evolutive proprie delle
tecnologie dell’informazione digitale96.
Complessivamente si può ritenere che, da un punto di vista tecnico, la World Conference International
Telecommunication del 2012 abbia costituito una significativa battuta d’arresto per un settore, come
quello delle telecomunicazioni internazionali, nel quale più di altri è necessario mantenere un alto
livello di omogeneità normativa. Il fatto che nel corso dei lavori le decisioni più importanti siano
state prese a maggioranza, e non per consensus come normalmente previsto dalla prassi
procedurale dell’ITU, costituisce in questo senso un dato significativo97. Il pericolo è che gli
effetti della divisione venutasi a creare si possano ripercuotere anche su altri aspetti delle
telecomunicazioni internazionali di competenza dell’ITU: i nuovi accordi, infatti, per gli Stati che
li hanno sottoscritti, entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 201598, mentre coloro che non
dovessero accedervi entro quella data resterebbero vincolati alle ITRs originali, indirizzando il
settore verso un’inopportuna frammentazione normativa.
I risvolti applicativi delle nuove ITRs e della Risoluzione n. 3 ad esse allegata, i cui contenuti
rimangono indefiniti sotto molti aspetti, saranno passibili di valutazione solo in futuro. Al
momento è possibile osservare, come evidenziato altrove99, che è la natura stessa della Rete ad
aver reso superflua l’esistenza di un trattato dalle finalità analoghe a quelle delle “vecchie” ITRs,
in quanto il problema della connettività tra le reti nazionali è venuta meno con la creazione di
codici universali che ne hanno consentito una unitarietà strutturale de facto100. L’esistenza di un
96 Si veda, in proposito, House approves resolution to keep Internet control out of UN hands, 5 dicembre 2012, alla pagina http://thehill.com/blogs/floor-action/house/271153-house-approves-resolution-to-keep-internet-control-out-of-un-hands. 97 Come affermato dallo stesso Segretario Generale Touré nel corso di un Working Group della WCIT del 20 giugno 2012: «We all know that, in the true tradition of the ITU, we will not vote on any issues […] but came to consensus on every issue.». Testo reperibile alla pagina: http://news.dot-nxt.com/2012/06/20/toure-speech-wcit-wg. 98 Art. 10.1 dei nuovi ITRs. 99 G.M. RUOTOLO, op. cit., p.109. 100 Alcuni studiosi sostengono, infatti, che queste potrebbero essere pienamente sostituibili con accordi presi in ambito WTO, che regolerebbero i rapporti tra le grandi imprese private di telecomunicazione. Cfr. M. MUELLER, Threat Analysis of WCIT part 2: Telecommunications Vs. Internet, 7 giugno 2012, disponibile alla
27 | federalismi.it – focus TMT |n. 2/2014
trattato finalizzato a regolare le telecomunicazioni internazionali concluso sotto gli auspici di
un’organizzazione intergovernativa avrebbe ben’altro significato se questo settore fosse ancora
regolato in base a regimi di monopolio statale e non da un regime transnazionale basato perlopiù
su contratti di natura privatistica e servizi elaborati in base a un sistema globale di codici e
protocolli.
Allo stesso tempo è stato notato come l’ITU, organizzazione dal peso decisionale
sostanzialmente limitato, costruita su un settore industriale in declino, e di fatto priva di
meccanismi di enforcement e di risoluzione delle controversie101, ad oggi non costituirebbe più un
istituzione in grado di assumere una posizione rilevante nel settore delle comunicazioni digitali e
sarebbe pertanto destinata ad una graduale marginalizzazione a meno di una profonda opera di
rinnovamento interno.
Tuttavia, l’esito della WCIT-12 può essere considerato come un importante momento di
passaggio verso una nuova fase, nel corso della quale è lecito presupporre che la disputa
internazionale per l’affermazione di nuovi modelli di gestione del web acquisterà un’importanza
crescente. In tale direzione, due diverse concezioni del ruolo degli Stati nazionali sono
definitivamente venute alla luce in tutta la loro eterogeneità102. Nondimeno una lettura dell’evento
in senso puramente dicotomico costituirebbe una semplificazione eccessiva in quanto molte
delegazioni, in particolare quelle dei Paesi in via di sviluppo, si sono recate a Dubai con
l’obiettivo principale di favorire il raggiungimento di un accordo che permettesse loro di ottenere
migliori condizioni di accesso alle tecnologie di comunicazione digitale e hanno assunto di
conseguenza posizioni strumentali al raggiungimento di tale obiettivo103.
Appare tuttavia indiscutibile il fatto che nel corso della Conferenza si sia venuta a delineare una
vera e propria “faglia geopolitica”, che vede da una parte gli Stati favorevoli al mantenimento di
una Rete aperta, decentralizzata e autonoma, gestita con meccanismi partecipativi che
garantiscano l’attuale livello di libertà e una forte spinta all’innovazione, e dall’altra gli Stati
interessati a realizzare una gestione del web conforme ai propri interessi nazionali, rendendo
Internet uno strumento subordinato alle prerogative di sovranità, anche attraverso una maggiore pagina http://www.internetgovernance.org/2012/06/07/threat-analysis-of-wcit-part-2-telecommunications-vs-internet/ 101 Ibid., «The realist view of the ITU is that it is a weak and declining intergovernmental organization (IGO). The industry on which it is based, circuit-switched telephony, is everywhere in decline.» 102 P. ROSENZWEIG, WCIT Treaty Breakdown — A Summary and Some Analysis, disponibile alla pagina: www.lawfareblog.com/2012/12/wcit-treaty-breakdown-a-summary-and-some-analysis/. 103 ACCESS, Brief on Outcome of the World Conference on International Telecommunications, 4 febbraio 2013, consultabile alla pagina: https://s3.amazonaws.com/access.3cdn.net/7bf90377bf58715c0a_j8m6iv2rt.pdf.
28 | federalismi.it – focus TMT |n. 2/2014
capacità di controllo dei contenuti trasmessi. A sostegno di questa seconda posizione vi è l’idea
che una risorsa dal valore strategico globale non possa più essere vincolata da enti ed organismi
strettamente collegati con uno solo dei Paesi della Comunità internazionale, gli Stati Uniti
d’America, i quali hanno permesso il consolidamento di posizioni di potere economico dei grandi
gruppi di interesse privato, traendone indubbio vantaggio. Inoltre, un sistema maggiormente
egalitario da un punto di vista sostanziale permetterebbe, almeno in linea teorica, una maggiore
capacità di utilizzare le nuove tecnologie in funzione delle esigenze di sviluppo nei Paesi
economicamente più arretrati, attraverso la riduzione del digital divide, così come previsto nei
documenti elaborati in seno alle Nazioni Unite nel corso degli ultimi anni.
A giudizio di chi scrive permangono forti dubbi sull’attuabilità di un modello verticale di
controllo dipendente unicamente dalle rispettive sensibilità politiche degli Stati. L’affermarsi di
una visione “statalista” comporterebbe un mutamento dell’attuale fisionomia del cyberspazio dagli
esiti imprevedibili, nonché una sostanziale alterazione delle capacità di interazione e fruizione da
parte degli utenti. È presumibile che, nel corso dei prossimi incontri previsti al livello
internazionale, gli Stati continueranno a servirsi degli strumenti intergovernativi per tentare di
estendere la propria sfera di influenza, plasmare l’architettura di Internet in funzione dei propri
obiettivi strategici, o semplicemente affermare una propria idea di web – governance. Così è
avvenuto ad esempio nel corso della conferenza NETmundial, tenutasi a San Paolo del Brasile
nell’aprile del 2014, in apertura della quale è stata la stessa Presidente Dilma Rousseff, tra le più
indignate a seguito dello scandalo Snowden-NSA, a lanciare un chiaro appello a favore di un
Internet inteso come “spazio democratico e risorsa condivisa di tutta l’umanità”, da gestire in
maniera “multipolare, trasparente e aperta a tutti”. 104 In tale occasione il Brasile, Paese
all’avanguardia in materia di gestione delle risorse digitali,105 ha presentato il “Marco civil”, una
sorta di Carta dei diritti e doveri dei cittadini brasiliani in materia di utilizzo delle risorse web,
104 NETmundial, Dilma Rousseff’s Opening Speech, 23 aprile 2014, disponibile alla pagina http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETMundial-23April2014-Dilma-Rousseff-Opening-Speech-en.pdf. 105 Come dimostrato dall’amministrazione collegiale e partecipativa di tutti gli aspetti relativi a connettività e infrastrutture collegate, da parte del Comitato Brasiliano di Gestione di Internet e del suo braccio operativo, il Nucleo di Informazione e Coordinamento. Vedi F. GUERRINI, Il futuro della governance di Internet post Datagate: il Brasile dà l’esempio, disponibile alla pagina www.lastampa.it/2014/02/21/tecnologia/il-futuro-della-governance-di-internet-post-datagate-il-brasile-d-lesempio-ErEm79auOLdCIXps70PdJL/pagina.html.
29 | federalismi.it – focus TMT |n. 2/2014
entrata in vigore proprio a ridosso della conferenza e nato con l’intento di delineare i caratteri di
un modello alternativo di gestione della Rete.106
È chiaro che il modello attualmente in vigore necessiterà di modifiche gestionali nella direzione di
incrementare la rappresentatività di tutti gli attori coinvolti e contemperare le rispettive esigenze,
in primo luogo quelle degli utenti. Rispetto agli organismi esistenti, con particolare riferimento
all’ICANN, occorrerà portare a termine il processo di transizione iniziato nel 2006, in base al
quale le sue funzioni sono destinate ad essere trasferite ad una nuova entità, la cui struttura e il cui
funzionamento rimangono però ancora da definire 107 . Solamente a seguito di una chiara
definizione del ruolo riservato agli Stati nazionali, della creazione di un sistema di check and
balances volto a contenere il potere delle grandi web-corporations, anche attraverso un effettivo
controllo giurisdizionale di natura internazionale sulle decisioni prese108, nonché di un maggiore
coinvolgimento della società civile internazionale, si potrà parlare di un sistema di governance
realmente democratico e rispettoso dei diritti individuali, adatto a compiere in maniera legittima le
scelte che disegneranno il futuro di Internet109.
Dal punto di vista amministrativo, quindi, sarebbe auspicabile una maggiore decentralizzazione,
che riduca allo stesso tempo il pericolo di possibili ingerenze dei governi e il ricorso ad atti di
censura e controllo dei contenuti. 110 Un nuovo assetto decentrato sarebbe, non da ultimo,
fondamentale per realizzare un livellamento universale dei costi di connessione, nella direzione di 106 Il cui testo in inglese è disponibile alla pagina https://www.publicknowledge.org/documents/marco-civil-english-version. Tra i contenuti più innovativi del documento vi è ad esempio la “Net neutrality”, principio in base al quale l’accesso ai contenuti web non può essere in alcun modo discriminatorio, le norme a tutela della privacy e della libertà di espressione. 107 In questo senso, una prima apertura sembra essere stata fatta con la dichiarazione presentata il 14 marzo 2014 dalla National Telecommunications & Information Administration (NTIA) del Dipartimento del Commercio statunitense, dove si legge che: «To support and enhance the multistakeholder model of Internet policymaking and governance, the U.S. Commerce Department’s National Telecommunications and Information Administration (NTIA) today announces its intent to transition key Internet domain name functions to the global multistakeholder community. As the first step, NTIA is asking the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) to convene global stakeholders to develop a proposal to transition the current role played by NTIA in the coordination of the Internet’s domain name system (DNS).». Tale passaggio di consegne a questa nuova entità dovrebbe avvenire, secondo quanto affermato dall’amministrazione statunitense, entro settembre 2015. Documento disponibile alla pagina:http://www.ntia.doc.gov/press-release/2014/ntia-announces-intent-transition-key-internet-domain-name-functions. 108 Cfr. B. CAROTTI, op. cit., pp. 20 e 21. 109 Così come osservato dallo Special Rapporteur delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti di libertà di opinione e di espressione, Frank La Rue, a conclusione dei lavori della Conferenza di Dubai, 19 dicembre 2012. Si veda la pagina www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12903&LangID=E. 110 È noto come lo stesso presidente dell’ICANN Fadi Chehadé abbia definito il modello attuale di web-governance della Rete come “troppo USA-centrico”.
30 | federalismi.it – focus TMT |n. 2/2014
favorire maggiori possibilità di accesso per le popolazioni dei Paesi meno avanzati. Una pressione
diplomatica costante e decisa in questa direzione, anche da parte dell’Unione europea, all’interno
dei principali organismi internazionali - primi tra tutti l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e
l’ECOSOC - nella direzione di favorire la nascita di una “visione comune” e di piattaforme di
confronto potrebbe scongiurare l’acuirsi di tensioni future.111
Un’interessante prospettiva in questo senso può essere fornita da alcuni modelli organizzativi
esistenti, come quelli relativi alle telecomunicazioni internazionali via satellite (INMARSAT,
INTELSAT, EUTELSAT), la cui natura di organizzazioni intergovernative “classiche” è stata
modificata a seguito di un processo di semi-privatizzazione avvenuto negli anni 1999-2001112.
Tale processo, che andrebbe in tal caso concepito in senso inverso (dal privato al pubblico), ha
dato vita ad un’inedita forma di gestione “ibrida” dei servizi forniti, frutto della coesistenza tra
un’organizzazione internazionale pubblica, titolare di alcuni poteri di controllo e di indirizzo, e
più società private costituite sulla base del diritto interno degli Stati d’appartenenza, responsabili
della gestione tecnica e commerciale113. In via ipotetica, qualora applicato alla gestione della Rete,
la rilevanza di tale modello deriverebbe dal fatto che l’organizzazione internazionale sarebbe
espressione della volontà generale e delle necessità della Comunità internazionale tutta, stabilendo
finalità e principi di interesse generale come ad esempio quelli di uguaglianza e di non
discriminazione all’accesso e all’utilizzo del mezzo. 114 Allo stesso tempo questa non avrebbe 111 Rileva in proposito la recente Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Governance e politica di Internet, il ruolo dell’Europa nel forgiare il futuro della governance di Internet, COM (2014), 72, del 12 febbraio 2014, nella quale si ribadisce che “Dal 2009 l'ICANN ha fatto passi avanti […], in particolare con l'apertura di centri operativi a Istanbul e Singapore nel 2013. Sebbene ciò rappresenti un segnale positivo, l'ICANN continua ad essere un organismo soggetto alla legislazione californiana e vincolato da un legame contrattuale con un unico paese. Il rapporto esclusivo dell'ICANN con un unico governo, come spiegato nella Dichiarazione d'impegno, deriva dalla storia di internet; è necessario tuttavia che l'organismo acquisisca una dimensione più globale in un'epoca in cui internet è diventata in tutto il mondo uno strumento fondamentale di supporto per la società e l'economia.” (p. 5). 112 Cfr. L. PANELLA, La privatizzazione delle organizzazioni internazionali di telecomunicazioni via satellite, Milano, 2003, pp. 6-7. 113 Ivi. In tal caso i “due livelli” rispondono ognuno ad un determinato strumento giuridico: una convenzione istitutiva garantisce la partecipazione paritaria degli Stati sovrani, definendone il ruolo in termini di politiche gestionali e garanzie generali, mentre un accordo operativo di natura contrattuale sottoscritto con i gestori privati del servizio riguarda le competenze tecniche, e le questioni legate allo sfruttamento commerciale del mezzo. Gli enti privati possono essere rappresentati negli organi creati dallo strumento convenzionale, in maniera tale da garantire la dovuta partecipazione di entrambi le componenti (pubblica e privata) al processo formativo della volontà dell’organizzazione. Allo stesso tempo l’attività di gestione tecnico-commerciale è oggetto di rapporti periodici, in maniera tale da permettere lo svolgimento della funzione di controllo e di indirizzo da parte della componente pubblica. 114 Id., p. 30. così come previsto negli accordi istitutivi di INTELSAT (art. III), INMARSAT (art. III), EUTELSAT (art III).
31 | federalismi.it – focus TMT |n. 2/2014
alcuna capacità di gestione diretta delle infrastrutture comunicative, garantendone la neutralità e
allontanando il rischio di frammentazioni o gestioni improprie.
Nell’attuale impossibilità di giungere all’elaborazione di un modello gestionale che incontri il
favore dell’intera Comunità internazionale, le questioni principali da affrontare da un punto di
vista giuridico dovrebbero riguardare prima di tutto l’individuazione di un quadro di principi
generali, e di diritti individuali ad essi correlati, da garantire e rispettare sia “all’interno” della
dimensione virtuale che “attraverso” di essa (libertà di accesso e di utilizzo, diritto alla
conoscenza, rispetto della privacy, riconoscimento della Rete come bene comune) 115 . Un
passaggio di natura “para-costituzionale” del cyberspazio vincolerebbe i futuri modelli di web-
governance, indipendentemente dalla loro natura, al rispetto di garanzie e diritti - individuali e
collettivi - non più comprimibili in base ad esigenze di efficienza e sicurezza, o ignorabili su
pressione di gruppi di interesse privati116.
In questo senso, l’elaborazione di una Carta fondamentale di Internet, qualora universalmente
accettata, porrebbe le basi per il consolidamento dell’idea di uno “spazio pubblico universale” di
confronto e condivisione, da tutelare come risorsa comune a tutta l’umanità. Tale sarebbe infatti
un luogo in cui chiunque possa avere la possibilità di esprimersi autonomamente, di reperire e
fornire informazioni, contribuendo così alla creazione di un flusso di conoscenza in costante
evoluzione. All’interno di tale spazio, qualora debitamente inquadrato in una prospettiva di diritti
e doveri, la partecipazione ad una “vita digitale” si articolerebbe in nuove forme di interazione e
di “organizzazione sociale e politica, qualitativamente diverse da quelle attuali, ridando senso
adeguato anche ai riferimenti di eguaglianza e cittadinanza” 117.
115 Si veda, in proposito, la proposta presentata dal Brasile nell’ambito del Council Working Group on International Internet-Related Public Policy Issues, “Principles for the Governance and Use of the Internet”, consultabile alla pagina http://files.wcitleaks.org/public/S12-RINTPOL1-C-0002!!MSW-E.pdf ; Si veda anche S. RODOTÀ, op. cit., pp. 177-182. 116 J. KULESZA, International Protection of Human Rights On-Line; Key Problems, in Collection of Papers from the International Scholastic Conference “Law as a Unifying Factor in Europe – Jurisprudence and Practice”, 2011, pp. 387-394; 117 S. RODOTÀ, Una costituzione per Internet, p. 180, consultabile alla pagina: http://www.repubblica.it/2006/06/sezioni/scienza_e_tecnologia/regole-internet/regole-internet/regole-internet.html.