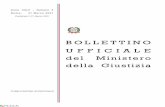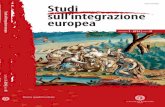La giustizia dei privati nel sistema dell'autodisciplina pubblicitaria
Transcript of La giustizia dei privati nel sistema dell'autodisciplina pubblicitaria
LA GIUSTIZIA DEI PRIVATI NEL SISTEMA DELL’AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA
1. Introduzione. 2. L’autodisciplina pubblicitaria nella crisidel legicentrismo e dello statalismo. 3. L’autodisciplinapubblicitaria come ordinamento giuridico. 4. Soggetti e oggettodel sistema; 5. La risoluzione delle controversie: il procedimentoordinario e i poteri del giurì; 6. Il procedimento monitorio e ipoteri del Comitato di controllo; 7. Il procedimentoautodisciplinare è un arbitrato?; 8. Il controllo dell’autoritàgiudiziaria sulle pronunce del Giurì; 9. Giurì di autodisciplinapubblicitaria e Autorità garante della Concorrenza e del Mercato;10. Il Cross Border Complaints System e il futurodell’autodisciplina pubblicitaria.
1. Introduzione. Nel quadro di una ricostruzionesistematica dell’arbitrato e degli strumenti disoluzione delle controversie alternativi oconcorrenti con la giurisdizione statale èopportuno volgere l’attenzione al modello digiustizia interno al sistema italianodell’autodisciplina pubblicitaria.
Questa indagine, ad un primissimo esame,potrebbe apparire, dal punto di vistametodologico, di estrema semplicità: dal 2005,infatti, è stata istituita la Camera diConciliazione ed Arbitrato presso l’Istitutodell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) al finedi rendere possibile la gestione edamministrazione di procedimenti arbitrali e diconciliazione, in base ad appositi regolamenti,per la soluzione delle controversie in materia
1
pubblicitaria. L’indagine in oggetto sembrerebbe,quindi, presentarsi anzitutto come unaricostruzione della disciplina sull’arbitratoamministrato dalla Camera arbitrale dell’IAP.
Una simile impostazione sarebbe, però,vanificata dal fatto che, a dispetto di ogniragionevole previsione, trascorsi diversi annidall’entrata in vigore del relativo regolamento,il ricorso a tale tipologia di arbitratoamministrato è stato praticamente nullo: le partiinteressate a far valere la pretesa illiceità diuna comunicazione commerciale, infatti, ove nonabbiano fatto ricorso all’autorità giudiziaria oa quella amministrativa (in specie l’AutoritàGarante della Concorrenza e del Mercato), hannocontinuato a sottoporre le controversie al Giurìistituito presso l’Istituto per l’autodisciplinapubblicitaria, un organo molto accreditato nelsettore in virtù dell’attività svolta nell’arcodi quasi mezzo secolo. Di che tipo diprocedimento si tratta? Dottrina e giurisprudenzaquasi unanimi hanno negato si tratti di vero eproprio arbitrato, a dispetto delle indubbiesomiglianze con tale istituto. Comeclassificarlo, dunque?1. E perché le aziende del1 Emblematico della difficoltà di qualificare taleprocedimento è il fatto che nel Quarto rapporto sulla diffusionedella giustizia alternativa in Italia, si faccia riferimento aglistrumenti autodisciplinari di soluzione del contenziosopubblicitario, premettendo però che tale esperienza “purnon rientrando nelle tipologie di strumenti alternativioggetto della presente ricerca, arbitrato, conciliazione,rassegnazione di nomi a dominio, svolge un’importante
2
settore continuano ad utilizzarlo come strumentodi risoluzione alternativa delle controversie,invece di ricorrere all’arbitrato propriamentedetto?
2 - L’autodisciplina pubblicitaria nella crisi del legicentrismoe dello statalismo. Il procedimento che si svolge difronte al Giurì istituito presso l’Istituto perl’autodisciplina pubblicitaria (IAP) al fine dirisolvere le controversie in materia dipubblicità commerciale produce effetti neiconfronti di aziende, mezzi ed operatoripubblicitari che, a diverso titolo, hannoriconosciuto le norme sostanziali e processualicontenute nel Codice di autodisciplinapubblicitaria. Questo Codice costituisce unostrumento di regolamentazione privatistica delfenomeno della pubblicità commerciale fondato sul
funzione di prevenzione e di controllo sulle problematicheinerenti alla correttezza della comunicazione commerciale,che ha ridotto drasticamente il contenzioso in questematerie e ha sopperito alle lacune e alle inadeguatezzaprocedurali della normativa statuale in materia”. Ciòpremesso, è davvero singolare come, nel medesimo Rapporto,al Giurì pubblicitario venga attribuita una “funzionegiurisdizionale” nella quale “l’organo giudicante” “adottauno schema processuale quanto mai rapido ed essenziale”inteso comunque a garantire il rispetto “dellalegittimazione attiva e passiva, della conoscenza del themadisputandum, del contraddittorio, della difesa delle parti edella comunicazione della decisione” (V. BONSIGNORE, Ladiffusione della giustizia alternativa in Italia, in Istituto per l’arbitrato, lamediazione e il diritto commerciale. Quarto rapporto sulla diffusione dellagiustizia alternativa in Italia, Milano, 2011, p. 98).
3
principio della volontaria soggezione al sistemanormativo e alle procedure in esso previste perla soluzione delle controversie.
Nel contesto sistematico di cui ai presentivolumi, peraltro, il procedimento istituito aisensi di tale Codice autodisciplinare assumerilievo non solo come specifica tipologia digiustizia dei privati, ma anche come indicatoredella trasformazione in atto nella gerarchiadelle fonti, a livello nazionale esovranazionale, ed in specie della diffusione siadi regole non riconducibili a una disposizioneautoritativa dello Stato che di procedimenti perla soluzione delle relative controversie almenoin parte indipendenti rispetto alla giurisdizionepubblica2.
Invero la gestione del contenzioso inmateria di pubblicità commerciale presenta unanotevole articolazione e complessità essendoaffidata, oltre che alla competenza del giudiceordinario – penale civile e amministrativo - aquella del Giurì di autodisciplina istituito sindal 1966 nonché, a partire dal D. Lgs. 25 gennaio1992 n. 74, all’Autorità Garante dellaConcorrenza e del Mercato e, in misura minore,all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Negli ultimi anni, peraltro, la normativa inmateria pubblicitaria si è notevolmentesviluppata, attraverso strumenti di regolazionediversi e talora privi del necessario2 P. GROSSI, Globalizzazione, diritto, scienza giuridica, in Società dirittostato. Un recupero per il diritto, Milano, 2006, p. 279 ss.
4
coordinamento. Della disciplina in materia dipubblicità commerciale fanno parte leggi delloStato, regolamenti autodisciplinari e, lato sensu,orientamenti della giurisprudenza e delleautorità amministrative. Il diritto dellapubblicità di provenienza statale è collocato intesti di legge diversi, sia di carattere generale(come il Codice del consumo), sia relativi aspecifici settori merceologici (per i prodottisanitari, alimentari, ecc.). Alla pubblicitàcommerciale sono altresì applicabili numerosenorme collocate in aree diverse del nostroordinamento, come norme penali (si pensi allefattispecie di abuso della credulità popolare odi diffusione di immagini oscene)3, civili (adesempio in materia di tutela dei segni distintividell’impresa o del diritto d’autore) eamministrative (come in materia di pubblicità diprodotti dannosi)4. La frammentarietà delladisciplina in materia pubblicitaria ed il suosviluppo tardivo e talora disorganico costituisceuna delle ragioni dell’attenzione importanzaassunta in Italia dal Codice di autodisciplinapubblicitaria, dell’autorevolezza acquisita nel
3 F. BRICOLA, Profili penali della pubblicità commerciale, in Riv. it. dir.proc. pen., 1965, I, p. 722 ss. Sui diversi profili dirilevanza giuridica della pubblicità commerciale, v. S.GATTI, Pubblicità commerciale, in Enc. dir., Milano, 1988, p. 1058ss.4 Sulle diverse tipologie di disciplina del fenomenopubblicitario, già G. GHIDINI, Introduzione allo studio dellapubblicità commerciale, Milano, 1968, 17 ss., 151 ss., 209 ss..
5
tempo dal Giurì e della diffusione deiprocedimenti instaurati al suo cospetto.
In un simile quadro non è sempre facileindividuare, soprattutto in assenza di precisenorme di raccordo, l’organo che ha titolo pergiudicare il preteso illecito pubblicitario, ladisciplina sostanziale applicabile ed il relativoprocedimento5. Se nessun dubbio sorge nelleipotesi in cui la condotta pubblicitaria realizzila violazione di una norma penale (come la frodein commercio prevista dall’art. 515 c.p.) o diuna norma civile (come il divieto di concorrenzasleale di cui all’art. 2598 c.c.), piùproblematico appare il caso in cui la condottacostituisca un illecito ai sensi tanto del Codicedel consumo quanto del Codice di autodisciplinapubblicitaria. Si pensi alla diffusione di unospot pretesamente ingannevole: può seguirneun’azione civile da parte del soggettodanneggiato, l’apertura di un procedimento penaleo di un procedimento di fronte al giudiceamministrativo o ancora un’azione davantiall’Autorità garante della concorrenza e delmercato o allo stesso Giurì di autodisciplina.Diversi possibili procedimenti possono dar luogo,evidentemente, a pronunce non solo diverse matalora contraddittorie. Si può configurare uncontrasto di giudicati? O invece deve pensarsi ad
5 Su ciò, v. A. FRIGNANI, La pubblicità: controllo amministrativo egiurisdizionale; rimedi e sanzioni, in A. FRIGNANI, W. CARRARO, G.D’AMICO (a cura di), La comunicazione pubblicitaria d’impresa,Milano, 2009, p. 217 ss.
6
un dialogo tra corti dotate di poteri ecompetenze diverse? Un dialogo organizzatosecondo quali norme di raccordo?
3 - L’autodisciplina pubblicitaria come ordinamentogiuridico. Fino all’entrata in vigore del D. Lgs. 25gennaio 1992 n. 74, emanato in attuazione dellaDirettiva 84/450/CE come modificata dallaDirettiva 97/55/CE, il nostro ordinamentogiuridico registrava una grave lacuna normativain materia di pubblicità commerciale, poiché sioccupava del settore solo sotto il profilo dellaconcorrenza tra le imprese ai sensi del Codicecivile. Al fine di ovviare a tale lacuna glioperatori del settore adottarono nel 1966 unCodice6 che formalizzava alcune regole di
6 Il Codice entrò in vigore il 12 maggio 1966 ma ladecisione di redigerlo – sulla scia del Code international dePratiques Loyales en matière de publicité adottato dalla ICC nel 1937e dopo un primo esperimento di un Codice morale dellapubblicità elaborato dall’UPA (Utenti Associati dellaPubblicità) nel 1951 - era stata assunta dalle agenzie edagli operatori della pubblicità tre anni prima, durante il7° Congresso nazionale della pubblicità. Da allora ilCodice è stato oggetto di numerosi aggiornamenti (dal 6giugno 2011 è in vigore la 52° edizione) volti non solo “adadeguare le norme del Codice alla realtà pubblicitaria inevoluzione, ma anche, e forse soprattutto, a rafforzaresempre più il controllo della pubblicità ed a tutelarel'interesse del consumatore”, considerato che, fino aglianni Cinquanta, la difesa del consumatore era limitata allafattispecie penalistica della frode in commercio e allediscipline speciali sulla vendita di prodotti alimentari eagrari (A. VANZETTI, L’autodisciplina pubblicitaria oggi, in Corr. giur.,
7
correttezza nello svolgimento dell’attivitàpubblicitaria, prevedendo forme di controllo siapreventivo che repressivo-sanzionatorio neiconfronti dei responsabili di messaggi nonleciti. Il Codice di lealtà pubblicitaria, poiribattezzato Codice di autodisciplinapubblicitaria (CAP), fu così adottatodall’Istituto di Autodisciplina pubblicitaria(IAP) un’associazione cui aderiscono organismirappresentativi delle diverse categorie di
11, 1998, p. 1191 ss. nonché A. PEDRIALI, Introduzione al codice didisciplina pubblicitaria, in Giur. pubbl., 1996, VII, p. 13). Laprima edizione del Codice, denominata “Codice di lealtàpubblicitaria”, invero, era ispirata essenzialmente allatutela delle aziende da atti di concorrenza sleale più chealla protezione dei consumatori. Non a caso nella premessaal Codice del 1966 si legge che il suo scopo “è di far sìche ogni e qualsiasi forma di manifestazione pubblicitarianon danneggi la pubblicità che ha un ruolo essenziale perlo sviluppo dell’economia e per la creazione di maggiorebenessere ed è insieme un servizio socialmente utile”. Unamaggiore attenzione nei confronti della posizione deiconsumatori si segnala già nella versione del 1971, nellacui premessa si precisa che il Codice è altresì un“servizio socialmente utile per l’informazione delconsumatore”. Più significativa e radicale fu la riformaapprovata nel 1975 per effetto della quale il Codice mutòdenominazione (da “Codice di lealtà pubblicitaria” a“Codice di autodisciplina pubblicitaria”) e indicò come suoscopo fondamentale “di assicurare che la pubblicità nellosvolgimento del suo ruolo particolarmente utile nelprocesso economico, venga realizzata soprattutto comeservizio per l’informazione del pubblico, con specialeriguardo alla sua influenza sul consumatore”. In generalesulla definizione di consumatore, v. G. ALPA, Ancora sulladefinizione di consumatore, in Contratti, 2001, p. 205 ss. Sulle
8
aziende ed operatori pubblicitari7.Alcuni interpreti, nel periodo
immediatamente successivo all’emanazione delCodice, qualificarono l’autodisciplinapubblicitaria come un fenomeno di tipopregiuridico, esclusivamente attinente alla sferadella deontologia professionale8. In una simileprospettiva la disciplina pubblicitaria sipresentava come un ordinamento del tutto autonomo
origini del CAP, v. anche M. MAMMONE, L’autodisciplina pubblicitaria.La pubblicità comparativa, in G. CORASANITI-L. VASSELLI (a curadi), Diritto della comunicazione pubblicitaria, Torino, 1999, p. 115ss. Per un bilancio del primo ventennio di lavoro delsistema, v. M. FUSI, I vent’anni dell’autodisciplina pubblicitaria, inRiv. dir. ind., 1986, I, p. 168 ss. e A. VANZETTI, L’autodisciplinapubblicitaria oggi, cit. V. anche R. CORTOPASSI, L’esperienzadell’autodisciplina pubblicitaria, in Dir. Inf., 1991, 2, p. 469 ss. 7 “Fanno parte dell’Istituto le più importanti equalificate associazioni ed enti del mondo pubblicitarioche operano su tutto il territorio nazionale, i qualirappresentano sostanzialmente il 90-95% dell’investimentototale del settore. Sono infatti presenti le imprese cheinvestono in pubblicità, le organizzazioni professionali ei mezzi di diffusione della pubblicità con le loroconcessionarie degli spazi pubblicitari” (G. DEODATO,L’autodisciplina pubblicitaria e il suo giurì, in Impr. St., 2008, pp. 17-18). Tra gli enti che hanno riconosciuto il Codice bastisegnalare le agenzie Assocomunicazione e UNICOM, nelsettore televisivo Rai, Mediaset, Sky e la FederazioneRadio Televisioni, nella stampa la FIEG (Federazioneitaliana editori giornali), nonché l’Associazione aziendepubblicitarie italiane e la Federazione concessionarie dipubblicità e soprattutto UPA (Utenti Pubblicità Associati).8 La tesi fu ad esempio sostenuta da R. FRANCESCHELLI che fuvicepresidente del Giurì nella sua prima composizione.
9
rispetto a quello statale, senza possibilità diconflitto con questo, ma non certo come unordinamento giuridico. Un simile orientamento9
rifletteva, evidentemente, il pregiudiziopositivistico e statualistico secondo cui puòparlarsi di norme giuridiche solo in presenza diuna manifestazione imperativa di volontà da partedel legislatore statale.
Gli ordinamenti dell’ultimo cinquantennio,per converso, prima che la crisi del monopolio
Cfr,. ad es. Il nuovo Codice di lealtà pubblicitaria, in Riv. dir. ind.,1971, I, p. 1. Ma sul punto v. anche L. SORDELLI, Pubblicità(Disciplina della), in Enc. Giur. Trecc.. Il medesimo orientamento sicoglie nelle prime decisioni assunte dallo stesso Giurì:l’Autodisciplina “si svolge sul piano di quella deontologiaetica che con il Codice di Lealtà si è voluto instaurare etutelare, e che però non coincide con quello sul qualeoperano le norme del diritto positivo” E ancora: “Ladecisione del Giurì non può valicare i limiti nei qualideve essere contenuta e che sono costituiti da prescrizionid’indole esclusivamente etica nell’ambito della validitàche esse hanno per le parti, le quali le hanno accettateaccettando il Codice di Lealtà pubblicitaria” (Giur. Aut.n. 1/1966). Invero un qualche dubbio sulla giuridicità diquegli “ordinamenti minori “che tengono uniti i loro membriper scopi parziali” e “la cui vita si svolge all’interno diquella dello stato e s’intreccia in vario modo con questa”è espresso pure, negli stessi anni, da N. BOBBIO, in Teoriadell’ordinamento giuridico, Torino, 1960, p. 196 ss..9 Ancora nella sentenza del 9 gennaio 1981 della Corted’appello di Milano (in causa Hélène Curtis c. WellaItaliana) si ribadiva che “l’efficacia delle decisioni delGiurì resta limitata all’ambito dei rapporti etico-professionali, senza invadere il campo della tutelagiurisdizionale dei diritti”.
10
statale della giurisdizione, hanno evidenziato ilsuperamento dell’esclusività della potestànormativa dello Stato. Quello che si ritenevafosse un confine netto tra diritto formalmentevalido e non-diritto, tra norme imposteautoritativamente e fattuale dinamismo dellaprassi, si è ormai significativamente sfumato. Èla stessa logica dello stato moderno, fondatosulle coppie concettuali autorità/obbedienza eeteronomia/autonomia a non esprimere in modoesaustivo le modalità di produzione del dirittocontemporaneo: nelle società contemporanee,complesse ed aperte alle dinamiche infra- esovra-statuali, infatti, i processi diregolazione si svolgono in buona parte fuoridalle aule dei Parlamenti e vi partecipano, conmodalità e competenze diverse, i Tribunali delloStato come i Collegi arbitrali, le Autoritàgaranti come i Giurì di autodisciplina10.
In questo quadro il fenomenodell’autoregolazione presenta caratteristichepeculiari e particolarmente consonanti con lospirito della società contemporanea. In esso si
10 Sul crescente ruolo svolto da privati, associazioni ecorporazioni non solo nel processo di formazione delleregole, ma anche nella individuazione e gestione deglistrumenti per la risoluzione dei conflitti, v. M. R.FERRARESE, Il diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale,Roma-Bari, 2006, p. 32 ss. Sul Codice di autodisciplinapubblicitaria come paradigma della attuale ridefinizionedei rapporti tra il singolo e le istituzioni, puntualiconsiderazioni in L. FRANZESE, Ordine economico e ordinamentogiuridico. La sussidiarietà delle istituzioni, Padova, 2004, p. 48 ss.
11
stempera, fino a scomparire, la separazione traautore e destinatario della regola: il processodi regolazione non esprime più la pretesaordinatrice avanzata da un potere gerarchicamentecostituito bensì nasce dalle esigenze dellaprassi, dalle necessità delle diverse sferedell’esperienza. All’astratta razionalitàuniformatrice del moderno paradigma normativo sisostituisce la concreta ragionevolezza di unaregola che il privato, al contempo, contribuiscea formare e si impegna a rispettare11.
La genesi del Codice di autodisciplinapubblicitaria, in tal senso, sembra riprodurre lemodalità tipiche della lex mercatoria12, se è veroche a generarlo, in assenza di un intervento daparte del legislatore statale, sono stati glistessi operatori e professionisti attraversol’adozione e la diffusione, anzitutto in formaconsuetudinaria, di pratiche di condottacommerciale che col tempo si sono consolidatefino ad assurgere a regole di (auto)disciplina
11 Come efficacemente è stato scritto: “La ragionevolezzadel precetto diventa garanzia di implementazione dellostesso, perché il privato nel decidere di autolimitarsidichiara implicitamente la sua disponibilità a osservare illimite” (G. DE MINICO, Regole comando e consenso, Torino, 2004,p. 130).12 Per l’attualità della nozione v. M.R. FERRARESE, Le istituzionidella globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, Bologna,2000, p. 60. In chiave critica, però, v. N. IRTI, Norma eluoghi, Roma-Bari, 2001, p. 57 ss. Sui rapporti tra lexmercatoria e diritto statale, v. L.C. UBERTAZZI, Numerus claususdei diritti di proprietà intellettuale?, in Aida, 2009, p. 282 ss.
12
del settore13.In questo scenario la qualificazione
dell’autodisciplina pubblicitaria in terministricto sensu giuridici è ormai largamente condivisasia in dottrina che in giurisprudenza14. IlC.A.P., in tal senso, sembra costituire unordinamento giuridico al tempo stesso autonomo ederivato. In dottrina si è da tempo rilevato comela natura ordinamentale dell’autodisciplina
13 Sul punto v. G. MAIFREDA, Autodisciplina mercantile e culturaoccidentale, in Impr. St., 2008, p. 5 ss. Sulla crescenteelaborazione e diffusione di nuovi tipi contrattualiprodotti della capacità normativa dei privati più che dellapotestà sovrana, v. G. BENEDETTI, Tutela del consumatore edautonomia contrattuale, in G. VETTORI (a cura di), Materiali ecommenti sul nuovo diritto dei contratti, Padova, 1999, p. 810.14 Assai significativo, peraltro, è il fatto che lagiurisprudenza abbia riconosciuto la rilevanzadell’autodisciplina pubblicitaria per il diritto statale,in specie enunciando il “principio di diritto secondo cui,nell’apprezzamento delle situazioni concrete rientranti neldivieto degli atti di concorrenza posto dall'art. 2598 n. 3c.c., costituiscono parametri di valutazione dellacorrettezza professionale le regole contenute nel Codice diautodisciplina pubblicitaria, quali espressione dell'eticaprofessionale e commerciale, alla cui tutela la normacivilistica è finalizzata” (Cass. Civ., sez. I, 15 febbraio1999, n. 1259, RCS Editori s.p.a. c. Il Giornale di SiciliaEditoriale Poligrafica s.p.a.). Sul punto v. anche G.GHIDINI, Slealtà della concorrenza e costituzione economica, Padova,1978, p. 79 ss. M. LAMANDINI, Il giudice in soccorso del Giurì(commento a Giurì di Autodisciplina pubblicitaria 22 settembre 1998, n. 281 -Trib. Torino 16 ottobre 1998, decr. - Trib. Torino 30 ottobre 1998, ord.), inDir. ind., 1998, 4, p. 358 nonché S. GIUDICI, Autodisciplinapubblicitaria e concorrenza sleale, in Riv. dir. ind., 1999, 2, p. 79.
13
pubblicitaria, e la sua possibile coesistenza conla legislazione statale sulla stessa materia, inparticolare, possano trovare adeguatagiustificazione nella cornice della teoria dellapluralità degli ordinamenti di Santi Romano15 edin specie della sua finissima riflessione sullanozione di autonomia16. L’ordinamentoautodisciplinare, in questa cornice, si presentacertamente come ordinamento autonomo nel senso
15 P. GROSSI, Santi Romano: un messaggio da ripensare nell’odierna crisidelle fonti, in Società, diritto, stato, cit., p. 143 ss.16 Scrive il costituzionalista siciliano: “Un ordinamentoche si costituisce in base ad un ordinamento superiore nonsi confonde e si amalgama, almeno sempre e necessariamente,con quest’ultimo, ma può restare ben distinto da esso.Senza dubbio i due ordinamenti staranno in connessionel’uno con l’altro e questa connessione sarà, secondo icasi, più o meno stretta” (S. ROMANO, Autonomia, in Frammentidi un dizionario giuridico, Milano, 1947, p. 16). Lo stessoRomano, peraltro, proprio muovendo da Cesarini Sforza,distingue ed anzi stabilisce un’antitesi tra il “dirittodei privati”, individuato in ordinamenti originari,costituiti da privati “al di fuori di ogni attacco con unordinamento superiore” ed il “diritto privato” riferito adordinamenti autonomi benché privi del connotatodell’originarietà. Interessante, sotto tale profilo, èrilevare che già nella sentenza Trib. Milano del 22 gennaio1976 (Riv. dir. ind., 1977, 2, p. 91 ss.) le disposizioni delCAP sono qualificate come “un ordinamento derivato, la cuigiuridicità si desume agevolmente secondo i criteri postidall’ordinamento superiore”. Interessanti rilievi vengonoformulati dallo stesso relatore di tale sentenza, G.FLORIDIA, nel saggio Autodisciplina e funzione arbitrale, in Riv. dir.ind., 1991, I, pp. 8-9. V. anche G. ALPA, Il diritto dei consumatori,Bari, 2002, p. 127.
14
che gli schemi di qualificazione in essoformulati, benché molto simili a talunefattispecie rinvenibili nella disciplina inmateria di pratiche commerciali scorrette, oggirinvenibili nel Codice del consumo, sono distinterispetto a queste e talora non coincidenti conesse. Una pratica pubblicitaria può dunquerisultare illecita ai sensi del C.A.P. e deltutto lecita per la legge dello Stato eviceversa17. Ed in ogni caso, come si avrà modo divedere in seguito, anche nell’ipotesi disostanziale coincidenza tra le rispettivediscipline, “il ricorso all’uno o all’altro degliorgani giudicanti dei due sistemi non preclude nécondiziona la possibilità di ricorrere all’altroné vincola le rispettive decisioni”18.
L’ordinamento pubblicitario si presentaaltresì come ordinamento non originario maderivato, perché, in quanto “ordinamento deiprivati”, nasce all’interno dell’ordinamentostatale ed essendo espressione dell’autonomiaprivata è pur sempre vincolato al perseguimento
17 Significativamente alla lettera a) delle Normepreliminari e generali si legge: “Il Codice definisce leattività in contrasto con le finalità suddette, ancorchéconformi alle vigenti disposizioni legislative; l’insiemedelle sue regole, esprimendo il costume cui deveuniformarsi l’attività pubblicitaria, costituisce la basenormativa per l’autodisciplina pubblicitari”.18 Così D. ARCHIUTTI, I rapporti tra l’autodisciplina pubblicitaria e lanormativa statale in materia di pubblicità ingannevole e comparativa illecita,in U. RUFFOLO (a cura di), Commentario al codice dell’autodisciplinapubblicitaria, Milano, 2003, p. 482.
15
di un interesse meritevole di tutela ed alrispetto dei principi fondamentalidell’ordinamento19. In sintesi: l’autodisciplinapubblicitaria rappresenta un ordinamentogiuridico autonomo e derivato di originecontrattuale20, la cui efficacia è anzituttovincolata al rispetto dei limiti di cui all’art.1343 c.c. (liceità della causa), 1346 c.c.(possibilità, liceità e determinabilitàdell’oggetto) e 1418 c.c. (non contrarietà anorme imperative).
4 - Soggetti e oggetto del sistema. Meritevole diattenzione è in primo luogo l’ambito soggettivoin cui l’autodisciplina pubblicitaria spiega isuoi effetti21. Le due principali modalità di
19 V. ad es. Giur. Aut. n. 57/2002.20 Scrive ancora Romano: “talora si dimentica che rapporti,diritti e doveri non possono sorgere che sulla base dinorme e che quando queste non si trovano nelle leggi delloStato, cioè quando questo non fa che attribuire efficaciaall’autonomia dei privati, esse non possono trovarsi chenel singolo negozio, il quale così prima di essere fontedel diritto soggettivo, è fonte di norme; norme subordinatea quelle statali e perciò secondarie e complementari;;norme non autoritarie, ma poste da coloro che si vincolanoad esse (…) o almeno con l’accettazione di coloro cui sonorivolte (…); ma sempre norme e, quindi, leggi; leggi, però,private e non pubbliche” (S. ROMANO, Autonomia, cit., p.27).21 Sul punto v. ad es. V. DI CATALDO, Natura giuridicadell’autodisciplina pubblicitaria e ambito soggettivo di applicazione del Codicedi autodisciplina, in Contr. impr., 1991, p. 114 ss. A. PEDRIALI,Profili soggettivi dell’autodisciplina pubblicitaria, in Riv. dir. ind., 1992,
16
adesione al Codice sono l’accettazione (diretta omediata dall’associazione di appartenenza) e lasottoscrizione di un contratto contenente laclausola di accettazione.
Il Codice vincola anzitutto imprese eoperatori pubblicitari che hanno costituito ilCodice o si sono successivamente associati ohanno aderito alla IAP. Tale adesione può esserediretta oppure mediata dall’appartenenza adun’associazione professionale che preveda perstatuto l’adesione dei suoi iscritti al Codice.Si legge alla lettera b) delle Norme preliminari egenerali del CAP che il Codice “è vincolante perutenti, agenzie, consulenti di pubblicità,gestori di veicoli pubblicitari di ogni tipo eper tutti coloro che lo abbiano accettatodirettamente o tramite la propria associazioneovvero mediante sottoscrizione di un contrattopubblicitario di cui al punto d)”. Il Codice èdunque vincolante anche per tutti i soggetti chefanno parte di tali organismi, in ragione di taleappartenenza e degli effetti obbligatoriderivanti nei loro confronti dalle delibereassunte dall’ente. La lettera c) delle medesimeNorme preliminari e generali, in tal senso, prevedeche: “gli enti firmatari si impegnano a osservareed a far accettare dai loro associati le normedel Codice stesso e dei Regolamentiautodisciplinari, a dare opportuna diffusionealle decisioni dell’organo giudicante, nonché adadottare adeguati provvedimenti nei confronti deiI, p. 138 ss.
17
soci che non si attengano al giudizio dell’organostesso o siano recidivi”.
Le precedenti disposizioni sonoulteriormente rafforzate dall’impegno, di cuialla lettera d), assunto dagli enti firmatari afar inserire un’esplicita accettazione del Codicenei contratti sottoscritti dai propri associati:“Per meglio assicurare l’osservanza delledecisioni dell’organo giudicante, gli organismiaderenti si impegnano a far sì che ciascunsoggetto ad essi associato inserisca nei propricontratti una speciale clausola di accettazionedel Codice, dei Regolamenti autodisciplinari edelle decisioni assunte dal Giurì, anche inordine alla loro pubblicazione, nonché delleingiunzioni del Comitato di Controllo divenutedefinitive”. La diffusione della clausola diaccettazione è stata così massiccia chel’autodisciplina si applica oggi quasi all’interosistema pubblicitario italiano22.
Il Codice vincola così anche imprese esoggetti i quali, pur non avendo aderito al (oaltrimenti riconosciuto il) Codice, abbiano
22 L’intento esplicito di garantire la diffusa osservanzadelle decisioni dell’organo giudicante sembra essere statoraggiunto. La clausola di accettazione “negli ultimi anni èstata infatti recepita dai contratti standard dipubblicità, con una significativa conseguenza. Per questavia il codice ha trovato applicazione anche nei confrontidelle campagne pubblicitarie realizzate dagli utenti, dalleagenzie o dai professionisti non firmatari del codice” (M.BONINI, Controllare le idee. Profili costituzionali della pubblicità commerciale,Milano, 2007, p. 113).
18
stipulato un contratto contenente la clausola diaccettazione23. Nei confronti di tali soggetti,evidentemente, il sistema produrrà effetti soloin modo occasionale e limitatamente al messaggiopubblicitario in relazione al quale è statosottoscritto il contratto contenentel’accettazione.
Un’altra categoria di soggetti vincolati alrispetto del Codice è stata infine individuatadalla giurisprudenza autodisciplinare in coerenza23 Così Giur. Aut. n. 4/1977. La dottrina si è a lungointerrogata sulla qualificazione da dare a tale clausola.Se, come sopra segnalato, quello autodisciplinare èordinamento non originario, ma derivato da quello statalein virtù delle prerogative da questo riconosciuteall’autonomia privata, deve preliminarmente ritenersi cheogni valutazione circa la validità della clausola (nonché,più in generale, la liceità delle norme e del procedimentoprevisti dal Codice) spetti al Giudice dello Stato. Propriola già citata sentenza del Tribunale di Milano del 1976(Riv. dir. ind., 1977, 2, p. 91 ss.) e ben nota nel settorepubblicitario, ha fornito una qualificazione della clausoladi accettazione nei termini di un contratto a favore diterzi: nel sottoscrivere un contratto avente ad oggetto laprestazione di un servizio pubblicitario da partedell’operatore o mezzo, infatti, l’utente prometterebbe diassoggettare ad un ordinamento privato ogni decisione inordine alla liceità di uno o più messaggi della propriaimpresa, così facendo sorgere in capo ai terzi chedovessero ritenersi danneggiati dal messaggio la facoltà diattivare il relativo procedimento. Dottrina minoritaria hainvece intravisto nella clausola di accettazione non uncontratto a favore di terzi bensì una fonte di rinvio,mediante la quale la disciplina sostanziale e processualedel CAP verrebbe integrata nel regolamento espressamentevoluto dalle parti, così determinando un’occasionale
19
con i principi generali dell’ordinamento: sitratta di quei soggetti che con il propriocomportamento concludente abbiano manifestato lavolontà di riconoscere l’operatività del Codicein relazione ad un singolo caso. Si pensi allacondotta di chi abbia formulato istanza al Giurìaffinché si pronunci in ordine alla pretesailliceità di un messaggio pubblicitario o,viceversa, di chi abbia accettato ilcontraddittorio a fronte di istanza con la quale
inclusione nel sistema autodisciplinare di un’utenteestraneo a tale sistema. Altra questione affrontata dadottrina e giurisprudenza concerne l’applicabilità aicontratti pubblicitari della disciplina sulle condizionigenerali di contratto ex art. 1341 c.c.. Sul punto si èritenuto che, considerata la notorietà del sistemaautodisciplinare per gli operatori del settore, sialegittimo presumere, in capo al soggetto estraneo alsistema che abbia stipulato un contratto seriale contenenteuna clausola di accettazione, la conoscibilità di taleclausola mediante l’uso dell’ordinaria diligenza. Sul puntosi legge nella pronuncia Giur. Aut. n. 1/1987: “Lanotorietà ormai diffusa e consolidata del sistemaautodisciplinare, e l’obbligo che grava su tutti i mezziaderenti all’istituzione (…) di inserire la clausola diaccettazione del Codice tra le condizioni del contrattod’inserzione, generano una presunzione di conoscenza dellaclausola stessa da parte di tutti gli utenti dellapubblicità che si avvalgono di tali mezzi, sicché, inmancanza di una specifica prova di rifiuto, non sembralecito sottrarsi alla soggezione all’autodisciplina” (V.anche Giur. Aut. n. 124/1977. Per alcune, limitateeccezioni a questo principio, v. ad es. Giur. Aut. nn.5/1977 e 121/1994). Peraltro non può del tutto escludersi,anche in relazione ad un rapporto pubblicitario derivanteda un contratto nel quale non sia prevista tale clausola,
20
sia stato convenuto di fronte al Giurì. Quanto alprimo profilo, il riferimento è anzituttoall’art. 36 che conferisce a “chiunque ritenga disubire pregiudizio da attività pubblicitariecontrarie al Codice di autodisciplina” la facoltàdi “richiedere l’intervento del Giurì” neiconfronti di soggetti che, avendo accettato ilCodice nelle forme in esso indicate, “abbiacommesso le attività ritenute pregiudizievoli”.L’esercizio di tale facoltà da parte del soggettoestraneo al sistema autodisciplinare ècondizionata alla presentazione di “un’istanzascritta”, contenente gli estremi del messaggiopretesamente illecito, l’esposizione delle“proprie ragioni”, la produzione della necessaria“documentazione” nonché la corresponsione dil’applicabilità della disciplina volontaria. È stato lostesso Giurì ad affermare che l’autodisciplinapubblicitaria ha ormai una diffusione tale che l’adesionead essa sia divenuta una vera e propria prassi del settoree che quindi l’accettazione del sistema debba presumersi inogni contratto pubblicitario, salvo prova di una esplicitacontraria volontà delle parti. In assenza di tale prova,per converso, in ogni rapporto pubblicitario, persino traquello intercorrente tra soggetti entrambi estranei alsistema autodisciplinare, la clausola di accettazionedovrebbe ritenersi automaticamente inserita nel contratto.Si legge, a tal proposito, nella pronuncia Giur. Aut. n.50/1988: “La clausola di accettazione del Codice diAutodisciplina costituisce una clausola d’uso che, ai sensidell’art. 1340 c.c., si intende inserita nel contratto diinserzione pubblicitaria, se non risulta che non sia statavoluta dalle parti: incombendo a chi contesta la competenzadel Giurì l’onere di provare tale volontà di escludere laclausola di accettazione”.
21
“previsti diritti d’istanza”: la giurisprudenzaha ragionevolmente rinvenuto nella condotta dichi presenti l’istanza ed assolva ai relativioneri procedimentali la volontà di riconoscere ilCodice, così altresì esponendo lo stesso soggettoad una possibile azione riconvenzionale da partedel convenuto. Alle stesse conclusioni devegiungersi in relazione alla seconda ipotesi, incui un soggetto estraneo al sistema, chiamato arispondere della pretesa illiceità di unmessaggio di fronte agli organidell’autodisciplina pubblicitaria, abbiaaccettato il contraddittorio, così di fattoriconoscendo la competenza del Giurì24.
Quanto al sopra richiamato principio secondocui è legittimato ad adire il Giurì per far sìche si pronunci sulla pretesa violazione diregole del CAP “chiunque ritenga di subirepregiudizio da attività pubblicitarie contrarieal Codice” è opportuna una precisazione. Ladottrina ha avuto modo di rilevare come ilpregiudizio in oggetto non possa esserecircoscritto al profilo commerciale e ciò anchein coerenza con l’enunciato di apertura delCodice che indica come finalitàdell’autodisciplina che “la pubblicità, nellosvolgimento del suo ruolo particolarmente utilenel processo economico, venga realizzata comeservizio per il pubblico, con speciale riguardo
24 V. A. PEDRIALI, Profili soggettivi dell’autodisciplina pubblicitaria,cit., p. 150.
22
alla sua influenza sul consumatore”25.Naturalmente la posizione dell’attore(consumatore o eventualmente imprenditore nonconcorrente) e la tipologia di interesse di cuisi lamenta la lesione incideranno sulpronunciamento del Giurì adito che, ad esempio,non potrà valutare l’ eventuale incidenza dellacondotta contestata sul piano concorrenziale26.
Una conferma del fatto che la competenza del
25 Su ciò v. V. GUGGINO, Relazione introduttiva, in La correttezza dellapubblicità tra Autodisciplina e controllo pubblico. Apertura Anno Iap 2011, inhttp://www.iap.it. Lo stesso Giurì nella decisione n. 97/1988 haavuto modo di precisare che “con certezza è da escludereche l’istanza al Giurì sia riservata a coloro che temono disubire un pregiudizio commerciale. Anche un singoloconsumatore è abilitato ad attivare l’intervento del Giurìed a maggior ragione lo è un’Associazione esponenzialedegli interessi di un’intera categoria di soggetti. Neppureperaltro sussiste il limite che il pregiudizio paventatosia direttamente riconducibile alla sfera dell’inganno opiù in generale dell’interferenza nell’attività di consumodel prodotto reclamizzato, ben potendo il pregiudizioriguardare altri interessi essi pure meritevoli di tutela esuscettibili di essere pregiudicati da una pubblicitàcontrastante con le norme del Codice”. Alle tradizionalifinalità in materia perseguite dall’autodisciplina inmateria di concorrenza, dunque, se ne sarebbe aggiuntaun’altra: “Gli organismi volontari, di controllo egiudicanti, esercitano infatti anche una più estesafunzione di garanzia e pedagogica, fondata sulla tutela divalori coessenziali all’ordinamento a fini generali”.26 In tal senso la pronuncia Giur. Aut. n. 1/1990 (“Iltermine “pubblicità” usato dal codice di autodisciplina nonva inteso in senso restrittivo, bensì come comprensivo diogni comunicazione, anche di tipo istituzionale, idonea a
23
Giurì travalica i confini della concorrenzacommerciale si desume dalla stessa esegesi delleNorme preliminari e generali del Codice, con specificoriferimento alla nozione di “comunicazionecommerciale”, sintagma che ha sostituito dal 2008la più ristretta nozione di “pubblicità”. Iltermine “comunicazione commerciale”, si leggealla lettera e), comprende “la pubblicità e ognialtra forma di comunicazione, ancheistituzionale, diretta a promuovere la vendita di
valorizzare e quindi anche a difendere, l’immagine di uno opiù imprenditori e dei loro prodotti”. Sul punto v. ancheGiur. Aut. n. 54/1997. Una conferma del fatto che lacompetenza del Giurì travalica i confini della concorrenzacommerciale si desume dalla stessa esegesi del codice diautodisciplina, con specifico riferimento alla nozione di“comunicazione commerciale”. “Agli effetti del Codice”, silegge, infatti, alla lettera e) delle Norme preliminari eGenerali, “il termine ‘comunicazione commerciale’ comprendela pubblicità e ogni altra forma di comunicazione, ancheistituzionale, diretta a promuovere la vendita di beni oservizi quali che siano le modalità utilizzate, nonché leforme di comunicazione disciplinate dal titolo VI”. L’art.46 precisa, in tal senso che “è soggetto alle norme delpresente codice qualunque messaggio volto a sensibilizzareil pubblico su temi di interesse sociale, anche specifici,o che sollecita, direttamente o indirettamente, ilvolontario apporto di contribuzioni di qualsiasi natura,finalizzate al raggiungimento di obiettivi di caratteresociale”. Dietro alla scelta terminologica, risalente al2008, di sostituire, nella titolazione del codice, lanozione di “comunicazione commerciale” alla piùcircoscritta nozione di “pubblicità” si è letta la“risposta dello IAP all’invito da parte del legislatorecomunitario alle autodiscipline europee ad ampliare la lorosfera di applicazione” “al di là della tradizionale
24
beni o servizi quali che siano le modalitàutilizzate, nonché le forme di comunicazionedisciplinate dal titolo VI” 27. Tale modificadella denominazione del Codice, peraltro,recepisce un consolidato orientamentogiurisprudenziale secondo cui il terminepubblicità va inteso come “comprensivo di ognicomunicazione, anche di tipo istituzionale,idonea a valorizzare e quindi anche a difendere,l’immagine di uno o più imprenditori e dei loroprodotti”28.
5 - La risoluzione delle controversie: il procedimentoordinario e i poteri del giurì. Il sistemadell’autodisciplina pubblicitaria svolge le suefunzioni di controllo sul settore di riferimentoattraverso due organi, il Giurì ed il Comitato dicontrollo. Mentre al Giurì sono attribuitefunzioni istruttorie e di decisione della
pubblicità commerciale” e dunque ad includere anche leforme di comunicazione e marketing che travalicanol’advertising tradizionale e vengono veicolate dai nuovimedia (Sul punto G. D’AMICO, L’autoregolamentazione in materiapubblicitaria, in A. FRIGNANI, W. CARRARO, G. D’AMICO (a cura di),La comunicazione pubblicitaria d’impresa, cit., p. 224).27 L’art. 46 precisa, in tal senso che “è soggetto allenorme del presente Codice qualunque messaggio volto asensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale,anche specifici, o che sollecita, direttamente oindirettamente, il volontario apporto di contribuzioni diqualsiasi natura, finalizzate al raggiungimento diobiettivi di carattere sociale”.28 Su ciò v. Giur. Aut. nn. 1/1990 e 54/1997.
25
controversia, il Comitato ha competenzediversificate, tra le quali vi è quella diattivare il procedimento di fronte al Giurì,anche su impulso dei consumatori, in relazione acomunicazioni commerciali la cui non difformitàrispetto al Codice debba essere accertata.
Le controversie in materia pubblicitaria,dunque, vengono sottoposte al Giurì a seguito diricorso presentato da un soggetto o su istanzapresentata dal Comitato di controllo. Se, da unlato, ai sensi dell’art. 36 co. I del CAP,“chiunque ritenga di subire pregiudizio daattività di comunicazione commerciale contrarieal Codice di Autodisciplina” può richiederedirettamente l’intervento del Giurì, dall’altroil co. III dello stesso articolo prevede, inossequio al principio per cui il Codice proteggenon solo gli interessi delle imprese concorrentima anche quelli dei consumatori, singoli oassociati, e dello stesso sistema pubblicitarioper quanto concerne la tutela della sua dignità ecredibilità29, che “i singoli consumatori, come le
29 Il che non significa, evidentemente, che si possarigidamente distinguere tra norme che riguardano la tuteladegli interessi dei concorrenti e norme intese a garantirela libera scelta dei consumatori. L’art. 8, ad esempio, aisensi del quale “la comunicazione commerciale deve evitareogni forma di sfruttamento della superstizione, dellacredulità o, salvo ragioni specifiche, della paura”,proprio perché finalizzato a proteggere una sceltacommerciale da parte del consumatore libera da indebiticondizionamenti, tutela altresì l’interesse del concorrentead un funzionamento del mercato ispirato ad una
26
loro associazioni, possono gratuitamentesegnalare al Comitato di Controllo lacomunicazione commerciale ritenuta non conformealle norme del Codice di Autodisciplina chetutelano gli interessi generali del pubblico”.
Quanto alle forme prescritte per larichiesta di intervento, l’interessato deve, aisensi dell’art. 36 co., II produrre “un’istanzascritta” indicando la comunicazione commercialeda sottoporre all’esame del Giurì, esponendo leproprie “ragioni” e allegando la relativa“documentazione”. In diverse pronunce, peraltro,il Giurì ha sottolineato come, il procedimento inoggetto essendo alieno da ogni formalismo,l’istanza debba considerarsi comunque valida ovein essa siano rinvenibili gli elementi essenzialial raggiungimento del suo scopo: a tal fine, adesempio, l’indicazione della pubblicitàdenunciata e l’esibizione delle ragioni sonostate ritenute sufficienti anche ove l’istanzasia priva di uno specifico richiamo alle normedel Codice pretesamente violate30. La
competizione corretta. D’altronde il divieto di compierequalunque “denigrazione delle attività, imprese o prodottialtrui, anche se non nominati”, di cui all’art. 14, nelproteggere l’impresa concorrente, svolge altresì unafunzione di garanzia della libera scelta del consumatore.30 Giur. Aut. n. 1984/33. Il criterio antiformalistico èespressamente enunciato dall’art. 31 co. IV che recita“Salvo quanto disposto nel presente Codice, il Giurì e ilComitato di Controllo esplicano le loro funzioni senzaformalità”. Lo stesso Giurì, peraltro, ha avuto modo dirilevare come “non ogni formalismo sia fine a se stesso” e
27
giurisprudenza, in ossequio allo stesso criterionon formalistico, ha altresì ritenuta validal’istanza pur in assenza di sottoscrizione deldifensore nella copia del ricorso trasmesso allaresistente e ciò in relazione ad ipotesi in cuila provenienza dell’atto dal difensore munito dimandato fosse altrimenti desumibile e lasottoscrizione fosse presente nell’esemplaredepositato presso la segreteria dell’Istituto31.Parimenti l’assenza di puntuale indicazionedell’impresa inserzionista è ritenuta sanabileove gli elementi forniti nell’istanza sianocomunque idonei alla sua individuazione32.
Requisito essenziale dell’istanza è,evidentemente, la precisa indicazione dellapubblicità denunciata e ciò anzitutto al fine didelimitare il thema decidendum della controversia:il Giurì, ad esempio, non potrà pronunciarsi suannunci la cui pretesa contrarietà al Codice siastata denunciata per la prima volta nel corsodella discussione orale. Benché, infatti, ilGiurì detenga, ai sensi dell’art. 37 VI comma, ilpotere di accertare e dichiarare d’ufficioviolazioni del Codice non previste nell’istanza,tale potere la giurisprudenza ritiene siaesercitabile, sempre fatta salva la necessità di
che “in taluni casi il rispetto della procedura è posto apresidio di valori fondamentali del due process”intrinsecamente connessi all’“esercizio di ogni poteredecisorio” (Giur. Aut. n. 39/2004).31 Giur. Aut. n. 1997/339-351.32 Giur. Aut. n. 1988/97.
28
disporre una relativa istruttoria, solo inrelazione a violazioni diverse da quelle indicatenell’istanza, ma commesse con lo stesso annunciopubblicitario sottoposto all’attenzione del Giurìe non anche in relazione a violazionipretesamente rinvenibili in annunci diversi daquello denunciato33. Una competenza del Giurì inordine a messaggi non espressamente denunciatinell’istanza sembra doversi ammettere solonell’ipotesi di una campagna pubblicitariacostituita da una pluralità di comunicazionifunzionalmente collegate tra loro e non tutteritualmente contestate34. La giurisprudenza,invero, ha ritenuto che anche la parte possasollevare durante l’udienza di discussione “altree diverse contestazioni” relativamente ad unmessaggio già oggetto di denuncia, ma che ciò nonpossa comunque ledere il principio delcontraddittorio e il diritto di difesa35 e dunquerenda necessaria la concessione di un termine perla relativa predisposizione delle difese.
Una volta presentata l’istanza, il Giurìassume i necessari provvedimenti, ai sensidell’art. 37, ai fini dello svolgimentodell’istruttoria e della convocazione delladiscussione orale. Il Presidente nomina infattiun “relatore”, scelto tra i membri del Giurìnonché, ove la materia del contendere lo
33 Giur. Aut. n. 1989/55.34 Giur. Aut. n. 1997/27035 Giur. Aut. n. 1998/191bis
29
richieda, un “consulente tecnico”36. Viene altresìdisposta la “comunicazione degli atti alleparti”, assegnando un termine “per il depositodelle relative deduzioni e di eventualidocumenti” e convocandole per la discussioneorale.
Al procedimento in oggetto possonopartecipare i difensori, i consulenti e unrappresentante del Comitato di controllo. Laparte può, infatti, farsi assistere erappresentare da legali37 nonché avvalersi di un
36 A partire dalla XLIII edizione del Codice, entrata invigore il 5 settembre 2007, è stato introdotto un articolo32 bis che prevede l’istituzione di un albo contenente inominativi di consulenti tecnici che possano assistere ilGiurì nella sua attività decisionale. Mentre nelladisciplina previgente, in caso di contrasto tra leproduzioni istruttorie delle parti o comunque dicontestazione in ordine all’interpretazione di documentiallegati, la consulenza tecnica d’ufficio poteva esseredisposta solo a seguito di sospensione del procedimento.Ciò rendeva necessario il rinvio della discussione inrelazione alla consulenza fornita dall’esperto, coninevitabile danno per il principio di celerità del giudizioautodisciplinare. Nella disciplina vigente, per converso,il Presidente del Giurì provvederà alla nomina di unconsulente tra gli esperti inseriti nell’elenco di cuiall’art. 32 bis, il quale potrà partecipare alladiscussione, accedere agli atti del procedimento e fornirei necessari chiarimenti. Sul punto v. L.C. UBERTAZZI (a curadi), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza,appendice aggiornata dedicata specificamente allacomunicazione commerciale, Padova, 2008.37 A tal proposito il Giurì ha ritenuto che il CAP, nelprevedere che “avanti il Giurì le parti possono farsi
30
consulente tecnico che eventualmente prende partealla discussione. Quanto poi al contributo delComitato di controllo, esso non si limita allapresenza del rappresentante: nei procedimenti adistanza di parte, infatti, il Presidente delGiurì può richiedere al Comitato un “parereconsultivo scritto”, comunque non vincolante siaper il Giurì che per le parti38. Il comma VIIIdello stesso art. 37, peraltro, prevede che“pareri” possano essere richiesti dal Giurì alComitato di controllo “senza formalità”, inqualsiasi fase del procedimento e su qualsiasiquestione.
Il procedimento è dunque scandito in duefasi nettamente distinte, nella prima ilcontraddittorio si sviluppa in forma scritta,nella seconda attraverso la discussione orale. Ildettato del Codice sembrerebbe distinguererigidamente le due fasi, stabilendo che ladiscussione orale debba vertere “soprattuttosugli aspetti della controversia che non siastato possibile trattare per iscritto”. Taledistinzione, peraltro, è stata decisamenteattenuata dalla giurisprudenza che pur ricordandocome la ratio di tale regola procedurale risiedanella garanzia del contraddittorio, ha comunque
assistere o rappresentare dai loro legali”, abbia concessouna mera facoltà, configurando una situazione ben diversarispetto all’obbligatorietà dell’assistenza del difensoretassativamente prevista per il giudizio civile o ilprocedimento penale (Giur. Aut. n. 8/1972). 38 Giur. Aut. n. 1993/63.
31
ribadito, in nome del carattere tendenzialmentenon formalistico del procedimento, come essa nondebba comportare alcun tipo di preclusione. Sedunque ciascuna parte è tenuta a svolgere in modocompleto per iscritto le proprie difese permettere in condizione la controparte dipredisporre adeguatamente la linea difensiva,d’altronde, considerati anche i tempi brevi delprocedimento e la conseguente difficoltà, inspecie per la parte convenuta, di raccogliere edepositare la documentazione, dovrà considerarsiammissibile la produzione di nuovi documentianche al momento della discussione, fatto salvoil potere discrezionale del Giurì di decidere sedisporre un rinvio della discussione con relativaconcessione di termini per eventuale produzionidocumentali di parte avversaria39.
Il procedimento in oggetto è connotato dauna significativa eccezione rispetto al principiogenerale, enunciato dall’art. 2697 c.c., secondocui “chi vuol far valere un diritto in giudiziodeve provare i fatti che ne costituiscono ilfondamento”. Nel procedimento autodisciplinarevige infatti il principio dell’inversionedell’onere della prova40. Con la singolare
39 Giur. Aut. n. 1989/151.40 Tale inversione, invero, trova una precisagiustificazione nelle caratteristiche del settore diriferimento nei termini efficacemente riassunti dal dettatodell’art. 6: “Chiunque si vale della comunicazionecommerciale deve essere in grado di dimostrare, a richiestadel Giurì o del Comitato di controllo, la veridicità dei
32
conseguenza che mentre l’impresa che denuncial’ingannevolezza di un messaggio proponendo difronte all’autorità giudiziaria un’azione perconcorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3c.c. deve dimostrare l’ingannevolezza delmessaggio, la stessa denuncia ai sensi del Codiceautodisciplinare impone al soggetto che si èvalso della comunicazione commerciale di provarela sua non contrarietà rispetto al Codice.Dell’eventuale silenzio della parte provocata apronunciarsi su un punto di fatto o comunque delrifiuto a produrre il supporto probatorionecessario a dimostrare la conformità al vero delmessaggio il Giurì potrà naturalmente tenereconto in sede di decisione41.dati, delle descrizioni, affermazioni, illustrazioni e laconsistenza delle testimonianze usate”. D’altronde lostesso art. 32 co,. III prevede che “in qualsiasi momentoil Giurì e il Comitato di Controllo possono richiedere chechi si vale della comunicazione commerciale forniscadocumentazioni idonee a consentire l'accertamento dellaveridicità dei dati, delle descrizioni, affermazioni,illustrazioni o testimonianze usate“. Sulla pretesaanomalia di tale inversione, v. F. CORSINI, Arbitratiamministrati, proprietà intellettuale e questioni processuali, in Aida,2006, p. 192. Individua la ratio dell’inversione in un favorper il consumatore P. TESTA, L’onere della prova, in Dir. inf.,1991, 2, p. 543 ss. Più in generale sull’importante temadella verità nelle informazioni diffuse tramite i media, v.V. CUFFARO, Il problema della verità/falsità, ivi, p. 474 ss. 41 A tal proposito il Giurì ha più volte affermato che ovel’inserzionista non abbia fornito la prova della verità diun’affermazione pubblicitaria contestata, tale affermazionedebba ritenersi mendace (Giur. Aut. nn. 1998/28 e 1993/09).Ma v. anche Giur. Aut. n. 2007/33 in riferimento a prova
33
Una volta esaurita la discussione si apronodiverse possibilità: il Giurì, ove ritenga chiusal’istruttoria, può rimettere in decisione lacontroversia42. In alternativa può rinviare gliatti al relatore per un supplemento diistruttoria senza formalità, con successivaritrasmissione al Giurì per la prosecuzione delprocedimento.
Quando il Giurì ritenga di poter emettere lasua pronuncia, si ritira in camera di consiglioeventualmente invitando il consulente tecnico apartecipare senza diritto di voto. Emessa ladecisione, il dispositivo, munito “quandoopportuno” di precisazioni sugli elementiriprovati, viene comunicato alle parti. In casodi accertata violazione del Codice, il Giurìdispone che le parti desistano dallacomunicazione commerciale in oggetto43.
della verità fornita in modo non rigoroso.42 Nell’ipotesi in cui durante l’istruttoria siano emersecircostanze diverse da quelle segnalate dall’istante, ilGiurì può sempre, ai sensi dell’art. 37 comme VI lett. c)del CAP, accertare d’ufficio le relative violazioni, benchénon espressamente denunciate.43 Le parti interessate dovranno desistere “nei terminiindicati dall’apposito Regolamento autodisciplinare”. Inparticolare il “Regolamento sui tempi tecnici di attuazionedelle decisioni autodisciplinari” prevede che lacomunicazione commerciale debba terminare entro 7 giorni(ridoti a 5 per talune violazioni), che l’ordine dicessazione debba essere eseguito entro 120 giorni quandoriguardi le confezioni del prodotto. Si tratta, comunque,di termini di cessazione che dovranno essere valutati “inconsiderazione delle peculiari caratteristiche dei mezzi
34
Diversamente dalla decisione del Giurì in ordinealla pretesa illiceità della comunicazionecommerciale – decisione che deve essere comunqueassunta, anche quando la comunicazione in oggettosia stata ritirata o modificata, e ciò anzituttoal fine di incidere sull’erroneo convincimentoingenerato nel consumatore - il provvedimentoinibitorio, consistente nell’ordine di cessare ladiffusione del messaggio, ha senso che vengaassunto solo nei confronti di messaggiattualmente diffusi al pubblico, salvo il caso dimessaggi non diffusi ma rispetto ai qualisussista un pericolo di ripetizione.
Le decisioni vengono quindi pubblicate on linesul sito dell’Istituto di AutodisciplinaPubblicitaria. In alcuni casi il Giurì potràdisporre che “di singole decisioni sia datanotizia” sui mezzi d’informazione ritenuti piùidonei, anche in relazione alle finalità che taleprovvedimento sarà inteso a perseguire44. In ognidiversi”. L’utente pubblicitario dovrà comunque, entro ilgiorno successivo alla decisione definitiva, comunicare diessersi attivato per sospendere il messaggio nei terminiprevisti.44 La sanzione della pubblicazione è definita in alcunepronunce “afflittiva” per distinguerla da quella“repressiva” consistente nell’inibitoria conseguente allapronuncia medesima (Giur. Aut. n. 1978/40). La funzioneinformativa del pubblico circa “gli errori indotti” da unmessaggio di cui si sia accertato “il carattere ingannevolee denigratorio”, richiamata per contro nella pronuncia n.1997/339-351, sembra svolgere al contempo una funzionerisarcitoria del concorrente denigrato. In linea generalela pubblicazione della pronuncia sarà giustificata in
35
caso, ai sensi dell’art. 40 IV comma, nessunadelle parti coinvolte potrà utilizzare ladecisione “per fini commerciali”. Si tratta, haprecisato la giurisprudenza, di un “divietoformale” che colpisce il fatto in sédell’utilizzo della pronuncia, non il modo in cuitale utilizzo sia effettivamente realizzato45.
Considerato che il sistema autodisciplinareè per sua natura privo di strumenti sanzionatori
ipotesi di messaggi importanti e diffusi nel tempo (Giur.Aut. n. 1998/229) e potrà per converso essere evitata incaso di violazioni di lieve entità. L’opportunità dellapubblicazione potrà peraltro essere valutata anche graziead un bilanciamento tra la gravità e durata delleviolazioni e l’eventuale cessazione della pubblicitàcontesa e dichiarazione di non voler reiterare la condotta(Giur. Aut. n. 1994/84). Nega che il provvedimento chedispone la pubblicazione della pronuncia possa averefinalità sanzionatorie D. ARCHIUTTI, I rapporti tra l’autodisciplinapubblicitaria e la normativa statale, cit., p. 503. A giudizio diM.S. SPOLIDORO (Le sanzioni del Codice di autodisciplina pubblicitaria, inRiv. dir. ind., 1989, I, p. 58 ss.), per converso, l’inibitoria,la pubblicazione della decisione e la stessa pubblicazionedell’accertamento, da parte del Giurì, dell’avvenutainosservanza delle sue decisioni, devono esserequalificate, appunto, come sanzioni. Sul punto v. anche R.ROSSOTTO, L'inottemperanza autodisciplinare (commento a Giurì diAutodisciplina pubblicitaria 11 luglio 1995, n. 174 - Giurì di Autodisciplinapubblicitaria 26 settembre 1995, n. 196 - Giurì di Autodisciplina pubblicitaria 10ottobre 1995, n. 213), in Dir. ind., 1996, 5, p. 404.45 Così Giur. Aut. n. 1987/94. Dovrà peraltro ritenersiillecito anche un utilizzo indiretto delle decisioni delGiurì, come nel caso di un articolo che dia notizia dellapronuncia “con rilievo, tono e contenuto che trascendonoqualsiasi esigenza di informazione” del lettore (Giur. Aut.
36
in senso stretto46, in specie di quel potere diapplicare sanzioni pecuniarie oggi inveceattribuito all’Autorità garante, assumeparticolare rilievo la disciplina codicisticadell’inosservanza delle decisioni emesse dalGiurì o dal Comitato di controllo47. Mentrel’ordinario provvedimento che dispone lapubblicazione della pronuncia di cui all’art. 40è del tutto facoltativo, per conversonell’ipotesi di inosservanza il Codice prevedeche il Giurì o il suo Presidente, reiterato senzasuccesso l’ordine di cessazione dellacomunicazione commerciale ritenuta illecita,“dispongono che sia data notizia al pubblicodell’inosservanza attraverso gli organi diinformazione indicati”. Si tratta peraltro,secondo il convincimento del Giurì, di una
n. 1989/155).46 In senso lato può invece ascriversi una portatasanzionatoria al provvedimento che dispone l’immediatacessazione del messaggio pubblicitario considerato che essodetermina un danno conseguente alla mancata utilizzazionedella campagna pubblicitaria, un danno di caratterepatrimoniale e soprattutto un danno per l’immagineaziendale.47 Il sistema autodisciplinare in materia pubblicitaria,peraltro, si caratterizza per la notevole effettività dellesue decisioni. Basti considerare il dato statistico secondocui nell’anno 2010 “il 98,8% delle decisioni che vengonoassunte sono ottemperate da parte dei destinatari, e quelresiduo 1,2% a sua volta viene condannato in secondabattuta dal Giurì“ dal che deriva la conclusione che “latotalità dei provvedimenti va a buon fine“. Così V. GUGGINO,Relazione introduttiva, cit., pp. 4-5.
37
sanzione in linea di principio applicabile ancheai casi di inosservanza di ingiunzionipresidenziali avverso le quali non sia statapresentata opposizione48.
Una volta emessa la pronuncia, ove la partesoccombente non si sia uniformata ad essa neitempi previsti dall’apposito regolamento si apre,su istanza di “chiunque vi abbia interesse”, unasorta di controversia nella controversia, aventead oggetto l’accertamento della sussistenza diuna condotta inottemperante. Tale controversiapuò seguire il procedimento ordinario o quellod’urgenza a seconda che l’inottemperanza appaia omeno manifesta. La procedura ordinaria, perinottemperanza non manifesta, ripete le modalitàe i termini previsti dall’art. 37 per il giudiziorelativo alla pretesa illiceità dellacomunicazione pubblicitaria49.48 Così Giur. Aut. 1998/66 e 1986/6.49 Deve ritenersi non manifesta l’eventuale inottemperanzaper il cui accertamento sia necessaria un’attivitàinterpretativa diretta a stabilire, tra l’altro, se le duepubblicità siano effettivamente recepite nell’identico mododai destinatari (Giur. Aut. n. 1988/79). Sul punto varilevata l’attenzione rivolta dalla giurisprudenzaautodisciplinare alla decisiva distinzione tra lequalificazioni adoperate nel messaggio ed il contenutocomunicazionale di questo. Mentre la ricorrenza dellemedesime qualificazioni del prodotto reclamizzato, giàritenute illecite, può essere oggetto di sempliceaccertamento giacché la qualificazione rientra nell‘ambitooggettivo del giudicato, per converso l’indagine in ordineall’equivalenza dei due messaggi quanto agli effettipragmatico- comunicativi sul consumatore richiede una più
38
Ove invece la pronuncia venga disattesa inmodo manifesto - si pensi alla reiterazione diuna comunicazione identica a quella giudicataillecita50 - il Presidente del Giurì “condecisione succintamente motivata” accertal’inottemperanza e dispone che di tale condottasia data notizia al pubblico. Tale provvedimentoresterà sospeso per un breve termine al fine diconsentire alle parti “di presentare motivataopposizione”. La decisione diverrà esecutiva nelcaso in cui non venga ritualmente presentataopposizione o questa risulti manifestamenteinfondata. Ove invece le ragioni addotte dallaparte interessata a sostegno dell’opposizioneappaiano non manifestamente infondate, ilPresidente disporrà la revoca del provvedimentod’urgenza e la convocazione delle parti dinanzial Giurì per la discussione: la controversiaseguirà così l’iter del procedimento ordinario.
6 - Il procedimento monitorio e i poteri del Comitato dicontrollo. Nel sistema dell’autodisciplina
approfondita indagine ermeneutica. In tal senso v. ad es.Giur. Aut. nn. 1990/127, 1995/196, 2007/49.50 In questi termini v. Giur. Aut. n. 1986/39 - riferitoall’ipotesi in cui il messaggio riprovato venga, nonostantee dopo la condanna, letteralmente ripetuto, sicchél’identità assoluta sia suscettibile di sempliceconstatazione senza necessità di indagine critica - nonchéGiur. Aut. n. 1988/32. Ricorrerà l’inottemperanza manifestaanche nelle ipotesi in cui le modificazioni siano diportata così modesta da non lasciare adito a dubbi sullasostanziale identità del contenuto (Giur. Aut. n. 1991/98).
39
pubblicitaria il Comitato di controllo svolge unruolo di notevole importanza. Tale ruolo puòessere compreso appieno se si considera chel’autodisciplina svolge una funzione deflattivadel contenzioso pubblicitario rispetto allagiurisdizione ordinaria e all’attivitàdell’Autorità garante non solo mettendo adisposizione un efficacissimo strumento disoluzione alternativa delle controversie, maanche prevenendo conflitti attraverso unacomplessa attività – svolta proprio dal Comitatodi controllo - di consulenza preventiva delcontenuto dei messaggi pubblicitari non ancoradiffusi nonché di negoziazione finalizzata ad unasollecita modificazione del messaggio già oggettodi contestazione. È d’altronde coerente con lalogica di un sistema autodisciplinare, costituitoda regole spontaneamente formulate dagli stessisoggetti destinati a rispettarle, il fatto dioperare in funzione preventiva ben prima e piùche con strumenti repressivi e sanzionatori51.
Più nel dettaglio, l’art. 32 del CAPattribuisce al Comitato di controllo il potere
51 Risulta infatti dai dati ufficiali riportatidall’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria(http://www.iap.it) che Basti pensare che dei casi definiti anorma del Codice autodisciplinare nel corso dell’anno 2010(in totale 1020) il 65% sono stati risolti dal Comitato dicontrollo in via breve, cioè o definiti grazie allacollaborazione dell’inserzionista o archiviati per noncontrarietà al Codice; un altro 18% dei casi, poi, è statodefinito sulla base dei pareri preventivi forniti dallostesso Comitato.
40
di: i) esprimere pareri preventivi su comunicazionicommerciali non ancora diffuse;ii) esaminare, su segnalazione di consumatori oper iniziativa propria, le comunicazionicommerciali ritenute non conformi alle norme delCodice che tutelano i consumatori e i cittadiniin generale;iii) invitare in via preventiva a modificare lecomunicazioni ritenute non conformi;iv) disporre l’archiviazione del procedimento;emettere ingiunzioni di desistenza nei confrontidi comunicazioni commerciali manifestamentecontrarie al Codice; formulare istanza al Giurìaffinché provveda all’esame e alla decisione delcaso.
Il Comitato interviene anzitutto sui casiche possono essere definiti o composti in modopiù spedito. Già nella fase iniziale delprocedimento, infatti, il Presidente delComitato, ove non rilevi una significativadifformità del messaggio contestato rispetto alCodice, può, anche senza istruttoria e senzaconvocazione delle parti per la discussione,disporre l’archiviazione del caso52.
52 Tale provvedimento, a giudizio di C. CONSOLO (Natura del giurìdi autodisciplina pubblicitaria, in Aida, 1993, p. 176), potrebbeessere avvicinato “alla figura dei provvedimenti di tutelasommaria anticipatoria, a cognizione in fatto e in dirittorapida ma tendenzialmente piena, salva la possibilità diuna sua integrazione alla luce degli argomenti dicontroparte”.
41
L’archiviazione può essere altresì decisa quandola parte, su richiesta del Comitato, si attiviper interrompere la diffusione del messaggio ocomunque per modificarne il contenuto. Ove perconverso tale condotta operosa della parte non simanifesti, o comunque gli elementi forniti dallaparte in sede di indagine sulla veridicità delmessaggio non siano risultati convincenti, ilComitato può attivare il procedimento dinanzi alGiurì nelle forme abbreviata o ordinaria.
L’art. 39 disciplina anzitutto ilprocedimento monitorio, stabilendo che se lacomunicazione commerciale risulta “manifestamentecontraria” a una o più norme del Codice, ilPresidente del Comitato può, ancora prima diavviare la fase istruttoria e senza discussione,emettere l’ingiunzione di desistenza, munita disintetica motivazione. Contro tale provvedimentola parte può proporre “motivata opposizione” alComitato entro 10 giorni. Nell’ipotesi di“mancata presentazione dell’opposizione”, diinosservanza del termine prescritto o di “assenzadi motivazione”, “l’ingiunzione acquistaefficacia di decisione”.
Ove invece siano stati rispettati i terminie motivata l’opposizione al provvedimento,l’ingiunzione si intende sospesa e si avviaun’ulteriore fase cognitiva che prenderà inspecifica considerazione “le circostanze e leragioni opposte dalle parti”. Tale fase potràconcludersi, nuovamente, a) con un provvedimentopresidenziale di revoca dell’ingiunzione e di
42
archiviazione del caso, sentito comunque ilComitato; b) “ove il Comitato ritenga non convincenti leragioni dell’opposizione”, con la trasmissionedegli atti al Presidente del Giurì con relativamotivazione e, ove questi, condiviso il giudizionegativo circa le ragioni dell’opposizione,ritrasmetta gli atti al Presidente del Comitatodi controllo, il Comitato emette un’ingiunzionedi desistenza; c) con la trasmissione degli atti al Giurì - oveil Comitato ritenga “opportuna” una decisione sulcaso da parte di tale organo – e conseguentementecon la convocazione delle parti per ladiscussione della vertenza: “con ciòl’ingiunzione si considera revocata”.
Per quanto concerne i poteri istruttori, ilComitato può avvalersi del parere di esperti e,ove necessario, chiedere alla parte la produzionedocumentale necessaria alla verifica dellaconformità al vero del contenuto del messaggio53.All’art. 32 co. III si legge infatti che “inqualsiasi momento il Giurì e il Comitato dicontrollo possono richiedere che chi si valedella comunicazione commerciale forniscadocumentazioni idonee a consentire l’accertamento
53 L’art. 6 stabilisce infatti che “chiunque si vale dellacomunicazione commerciale deve essere in grado didimostrare, a richiesta del Giurì o del Comitato dicontrollo, la veridicità dei dati, delle descrizioni,affermazioni, illustrazioni e la consistenza delletestimonianze usate”.
43
della veridicità dei dati, delle descrizioni,affermazioni, illustrazioni o testimonianzeusate”. Sembra logico ritenere, sulla scia di unconsolidato orientamento della giurisprudenza,che, benché non previsto dal dettato codicistico,il Comitato possa dedurre elementi di giudiziodalla condotta della parte che rifiuti o omettadi produrre la richiesta documentazione ocomunque tale documentazione risultiinsufficiente a provare la veridicità delmessaggio.
7 - Il procedimento autodisciplinare è un arbitrato? Inapertura del presente contributo si è rilevata ladifficoltà di classificare correttamente ilprocedimento che si svolge di fronte al Giurìdell’autodisciplina pubblicitaria nel quadrodegli strumenti alternativi di risoluzione dellecontroversie. Sulla questione si sono registrate,nel tempo, le valutazioni più diverse, accomunateforse solo nel convincimento, della dottrinalargamente maggioritaria come di una costantegiurisprudenza, che i procedimenti in oggetto nonpossano essere assimilati ai giudizi arbitrali54.54 È interessante rilevare come tale convincimento si fondisu una qualificazione della struttura e della funzione delgiudizio arbitrale connotata da una tendenza, al contempo,a ‘giurisdizionalizzare’ l’arbitrato rituale e a svalutarel’arbitrato libero, circoscrivendone oggetto e funzioni.Tale duplice qualificazione dell’arbitrato, peraltro, è ilpresupposto da cui muovono anche quegli interpreti che,all’opposto, ritengono di poter qualificare il procedimentoin sede autodisciplinare in termini di arbitrato rituale.
44
In tale sforzo di qualificazionesistematica, in primo luogo, un punto sul qualela dottrina non sembra aver avuto dubbi riguardal’impossibilità di assimilare il procedimentoautodisciplinare all’istituto dell’arbitraggioprevisto dall’art. 1349 c.c.. Meritanoattenzione, se non altro per individuare il nododella questione, gli argomenti addotti a sostegnodi tale tesi: l’arbitratore, si è detto, nonrisolve conflitti, ma contribuisce alladeterminazione del contenuto negoziale di unrapporto giuridico non ancora perfetto; mentre intale istituto i contraenti conferiscono al terzoun mandato affinché precisi l’oggettodell’obbligazione o comunque integri un elementodel negozio, il Giurì della pubblicità intervienea dirimere un contenzioso insorto in relazione adun rapporto già perfetto55. Il rilievo non è privodi significato: alla cognizione del Giurì vienedevoluta una vera e propria controversia cheviene definita grazie al giudizio di un soggettoterzo ai sensi della disciplina sostanziale eprocessuale prescelta o comunque richiamata dalleparti56.55 B. GRAZZINI, Autodisciplina pubblicitaria e ordinamento statuale, cit.,p. 40 ss.; L. SORDELLI, Pubblicità (disciplina della), cit., p. 48.“Le decisioni del Giurì non possono riguardarsi” – scriveC. CONSOLO (Natura del Giurì di autodisciplina pubblicitaria e fenomeni insenso lato arbitrale, cit., p. 180 ss.) – “come determinazionecontenutistica delle obbligazioni assunte” dalle parti delcontratto associativo “che sono ab initio precisate e verrannodal Giurì solo accertate e munite di sanzione e tutela”.56 Va peraltro segnalato il tentativo esperito dall’attuale
45
Dalla lettura del contenziosoautodisciplinare in termini di controversia hapreso le mosse certa dottrina, come si è dettominoritaria, per qualificare il procedimento inoggetto come vero e proprio arbitrato rituale57. Atal fine si è posto anzitutto l’accento sullastruttura del procedimento e sulla terminologiautilizzata nel Codice: si pensi al prescrittodeposito di un’“istanza scritta”, motivata eintegrata dalla necessaria documentazione, allaconcessione di termini per “deduzioni” e“produzioni documentali”, alla convocazione perla “discussione orale”, alla valutazione degli“elementi di prova”, all’“assunzione degli attiistruttori” ritenuti necessari, alla garanzia del
Presidente dell’IAP, Antonio Gambaro, di leggere il Giurìpubblicitario come “antesignano dei sistemi di ADR”anzitutto sotto il profilo della “totale terzietàdell’organo decidente e la legalità delle sue decisioni” edi avvicinarlo alla “mediazione aggiudicativa che siconclude con l’indicazione da parte del giudicante di chiabbia ragione o torto in una singola disputa e in chemisura” (A. GAMBARO, Relazione introduttiva, in La correttezza dellapubblicità tra Autodisciplina e controllo pubblico, cit., pp. 3 e 5).57 “Non sembra che possa essere messo in dubbio che, conl’accettazione dell’Autodisciplina, le parti si impegnano asottoporre le controversie tra di esse insorte, nell’ambitodella loro attività pubblicitaria e quindi con riferimentoalla interpretazione e applicazione del contratto diAutodisciplina, ad una forma di arbitrato, consistente in unmandato conferito a soggetti terzi per la soluzione di unacontroversia nascente da un rapporto giuridico giàperfetto” (G. SENA, Il sistema dell’autodisciplina pubblicitaria, in Riv.dir. ind., 1988, pp. 195-196).
46
contraddittorio, alla comunicazione del“dispositivo” alle parti, al deposito della“pronuncia” presso la segreteria58.
In dottrina si è altresì sottolineata lacompatibilità tra il procedimentoautodisciplinare e le disposizioni di cui alTitolo VIII del Libri IV del c.p.c. Si èrilevato, in tal senso, come non costituisca unostacolo la disciplina relativa alla nomina degliarbitri ex art. 810 ss. c.p.c.: il fatto chenell’autodisciplina pubblicitaria le controversiesiano deferite non ad arbitri nominati perciascuna controversia, ma ad un organo interno dicarattere stabile nominato interamente dallo IAP,ad esempio, avviene anche negli arbitrati delleassociazioni commerciali59. Nelle controversie neipartiti politici o nelle società cooperative,poi, la definizione delle controversie vienespesso affidata ad organi interni di naturapermanente e comunque la nomina degli arbitriviene attribuita ad un organo della strutturaaggregativa60.
Per quanto riguarda invece la naturapermanente dell’organo giudicante nel sistemaautodisciplinare, il dettato dell’art. 809 c.p.c.prescrive non che l’arbitro o il collegioarbitrale vengano nominati per la singola58 G. SENA, Il sistema dell’autodisciplina pubblicitaria, cit., p. 199.59 L.C. UBERTAZZI, La giurisprudenza del Giurì di autodisciplinapubblicitaria: alcune osservazioni, in Foro it., 1986, p. 2951.60 B. GRAZZINI, Autodisciplina pubblicitaria e ordinamento statuale, cit.,p. 51;
47
controversia, bensì che gli arbitri siano “uno opiù, purché in numero dispari” e che ilcompromesso o la clausola compromissoriacontengano “la nomina degli arbitri oppure ilnumero di essi e il modo di nominarli”. Si trattadi requisiti indubbiamente presenti nel giudizioautodisciplinare, considerato che il CAP fissaall’art. 34 il numero dispari dei membri delcollegio (“il Giurì è validamente costituito conla presenza di almeno tre membri”) e all’art. 29indica le modalità di designazione (“ad operadello IAP”) e la composizione del Giurì61.
Quanto poi al fondamentale principio chesancisce la nullità della clausola compromissoriache attribuisca ad uno solo dei contendenti lascelta degli arbitri, esso non sembra intaccatodal fatto che nel procedimento autodisciplinarela nomina degli arbitri avvenga ad opera di unorgano dello IAP, considerato che questo puòconsiderarsi terzo rispetto ai singoli aderential Codice che si trovano in conflitto. Lo stessorequisito dell’imparzialità dell’organogiudicante sembra rispettato, se è vero che ilCAP garantisce l’indipendenza del Giurìstabilendo che i membri dello stesso e delComitato di controllo svolgano le loro funzionisecondo il proprio libero convincimento e non inrappresentanza di interessi di categoria (art.31). In ordine alla composizione del Giurì, quale61 G. SENA, Il sistema dell’autodisciplina pubblicitaria, cit., p. 199;B. GRAZZINI, Autodisciplina pubblicitaria e ordinamento statuale, cit., p.52.
48
risulta dall’art. 29, va rilevato come essa siacomunque improntata ad esigenze di imparzialità edi equa valutazione degli interessi in gioco62.
Si è da ultimo sottolineato come noncostituisca un ostacolo alla qualificazione delprocedimento autodisciplinare come arbitrato ilruolo attribuito dal Codice al Comitato dicontrollo ed in specie la sua legittimazione adagire davanti al Giurì in relazione a messaggiche contrastino con le finalità chel’Autodisciplina persegue o comunque a tutela
62 B. GRAZZINI, Autodisciplina pubblicitaria e ordinamento statuale, cit.,p. 52. In dottrina si è invece affermato che l’art. 38comma III lett. C) del CAP, che consente al Giurì,nell’ambito di un procedimento iniziato ad istanza diparte, di rilevare violazioni non indicate in tale istanza,istituisce una sorta di “pronuncia d’ufficio” “della cuilegittimità è lecito dubitare dopo la riforma dell’art. 111Cost. e comunque incongruente anche con un modelloprivatistico di giustizia quale l’arbitrato libero” (F.CORSINI, Arbitrati amministrati, proprietà intellettuale e questioniprocessuali, cit., p. 192). Tale argomento, però, non appareconvincente. Una mancata corrispondenza tra chiesto epronunciato, infatti, potrebbe configurarsi solo quando gliarbitri si siano pronunciati al di fuori di quantoespressamente o implicitamente loro devoluto. Nel caso dispecie, invero, le parti hanno preventivamente deciso didevolvere ogni controversia al Giurì con richiamo ad unregolamento che espressamente prevede che il Giurì “qualoradurante il procedimento siano emersi elementi tali da fareritenere la sussistenza di violazioni non previstenell'istanza in esame, le accerta, le contesta, e dichiarad'ufficio“. Il tutto, peraltro, “salva la necessità didisporre la relativa istruttoria”, dunque garantendo ildiritto di difesa e il necessario contraddittorio.
49
degli interessi dei consumatori. Tale ruolo,infatti, sembrerebbe rientrare nel principiogenerale per cui, nell’esercizio dei poteri dicui all’art. 1322 c.c., le parti possonoattribuire ad un terzo il potere di provocarel’accertamento di inadempimenti delleobbligazioni inter partes63.
A dispetto degli argomenti appenarichiamati, la qualificazione in termini diarbitrato rituale del procedimento in oggetto haincontrato, come si è detto, pochi consensi indottrina e una fiera opposizione da parte dellostesso Giurì, il quale non ha esitato adaffermare che “la clausola di accettazione non èné una clausola compromissoria né una clausolache produce deroghe alla competenza dell’Autoritàgiudiziaria ordinaria. Con essa, infatti,l’inserzionista si obbliga ad osservare iprecetti del Codice di autodisciplinapubblicitaria secondo l’interpretazione el’applicazione che ne fa il Giurì, unico organoabilitato nell’ordinamento autodisciplinare agarantirne l’osservanza”64.
In dottrina si è poi sostenuto che traarbitrato e autodisciplina pubblicitaria visarebbero affinità per lo più superficiali e talida non intaccare una fondamentale differenza:mentre nell’arbitrato rituale le parti si63 L.C. UBERTAZZI, La giurisprudenza del Giurì di autodisciplinapubblicitaria, cit., p. 2952. Contra F. CORSINI, Arbitratiamministrati, proprietà intellettuale e questioni processuali, cit.. 64 Giur. Aut. n. 54/96.
50
limiterebbero a sostituire un giudice privatoalla giurisdizione statuale in vista di unarisoluzione della controversia ai sensi dellenorme dettate dallo stesso ordinamento delloStato, nell’autodisciplina il negozio istitutivoavrebbe come scopo precipuo “di attuare unosganciamento completo del sistema istituitorispetto a quello anche solo indirettamentericonducibile alle norme processualidell’ordinamento dello Stato”65. La causacomplessiva del negozio autodisciplinare, in talsenso, non si esaurirebbe nella scelta di arbitriprivati in luogo dei giudici dello stato, maconsisterebbe in una più ampia sostituzione delpotere privato di autonomia al potere statuale dieteroregolazione della materia. In coerenza conla sua vocazione propria ed in specie alla sua“volontà di autonomia” rispetto all’ordinamentostatuale66, l’autodisciplina si presenterebbe,quindi, come sistema alternativo e nonconcorrente all’ordinamento statuale,caratterizzato da proprie norme sostanziali eprocedimentali67.65 Da tali premesse Floridia desume la discutibileconseguenza che “l’arbitro o gli arbitri si collocanoaccanto ai giudici ordinari come destinatari di un poteregiurisdizionale che si distingue solo per ragioni dicompetenza da quello che è proprio di questi ultimi” (G.FLORIDIA, Autodisciplina e funzione arbitrale, cit., p. 6)66 B. GRAZZINI, Autodisciplina pubblicitaria e ordinamento statuale, cit.,p. 61.67 L’irriducibilità dei giudizi autodisciplinari a rango diarbitrati rituali, invero, è indirettamente affermata nelle
51
L’argomento, benché non del tuttoconvincente, merita un’adeguata considerazioneproprio in considerazione dell’importanza, per ilsistema autodisciplinare, dell’autonomia rispettoall’ordinamento statale. Proprio perchéautodisciplinare, infatti, tale sistema mira arisolvere le controversie al proprio interno,grazie all’immediata desistenza dalla diffusionedi comunicazioni non ammesse o alla modificadelle parti del messaggio oggetto dicontestazione o comunque mediante una pronunciache verrà verosimilmente ottemperata dalla partesoccombente e che dunque non fonda la suaefficacia sul potere sanzionatorio dello Stato.Per dispiegare i suoi effetti, in altri termini,l’ordinamento autodisciplinare non ha bisogno nédella definitività della cosa giudicata né dellaforza pubblica che garantisca l’effettività di
interpretazioni, pur elogiative, che del fenomenoautodisciplina pubblicitaria sono state proposte a livellocomunitario. Nel comma 2 dell’art. 10 della Direttiva05/29/CE, infatti, accanto al riconoscimento del ruolo chel’autodisciplina svolge in sede di promozione dellacorretta funzionalità del mercato e della difesa deiconsumatori e di alleggerimento del contenzioso di fronteai Tribunali dello stato, ha comunque precisato che “ilricorso a tali organismi di controllo non è mai consideratoequivalente alla rinunzia agli strumenti di ricorsogiudiziario e amministrativo”. Sull’impossibilità diqualificare il sistema autodisciplinare in termini diarbitrato rituale, v. anche C. CONSOLO (Natura del Giurì diautodisciplina pubblicitaria e fenomeni in senso lato arbitrale, cit., p.180 ss.).
52
quanto statuito dall’organo giudicante68.Tale sintetico richiamo all’intenzionalità
propria del sistema autodisciplinare èsufficiente solo ad escludere che il procedimentodi fronte al Giurì sia un arbitrato rituale, manon incide in alcun modo sulla sua qualificazionein termini di arbitrato irrituale69. Se è vero,infatti, in ossequio al criterio della
68 Le principali fonti del diritto contemporaneo, per lopiù transnazionale, scrive v. M. R. FERRARESE (Il dirittosconfinato, cit., p. 69 ss.), ovvero “contratto egiurisdizione, quest’ultima intesa sia come cortiinternazionali che come sedi para-giudiziarie di tipoarbitrale) hanno una forza ben diversa da quella di cuidisponeva la legislazione, anche se possono raggiungerelivelli di efficacia persino superiori a quelli propridella legge”.69 Si è ipotizzato, all’opposto, che “la ragione per laquale si continua a fare riferimento all’arbitratoirrituale dipenda proprio da ciò: che le parti non voglionocorrere il rischio che la decisione degli arbitri possaessere statalizzata”. Non a caso “la pratica dell’arbitratolibero è coessenziale alle organizzazioni che tendono adarsi, nell’ambito dei singoli ordinamenti, una propriaautonomia” e nelle quali “la forza delle decisioni èstrettamente legata alle sanzioni collegate al mancatospontaneo adempimento delle stesse”. Tale ordinamento delgruppo ha quindi bisogno di “norme di chiusura in base allequali le sue regole sono imposte da soggetti presceltidallo stesso e senza possibilità di intervento da partedello Stato”. Il ricorso all’arbitrato irrituale, in talsenso, “non è più frutto di una scelta episodica deicompromittenti”, essendo piuttosto “la maniera con la qualele organizzazioni intermedie si danno e si possono dare una
53
“differenza degli effetti”70, che l’elementodifferenziale dell’arbitrato rituale è la volontàdelle parti di giungere alla definizione dellacontroversia mediante un lodo che possa produrreeffetti nell’ordinamento dello Stato, devericonoscersi che proprio questa volontà delleparti è assente nel procedimentoautodisciplinare.
Non è un caso che proprio quella dottrina,minoritaria benché autorevole, che ha sostenutola natura arbitrale del giudizio di fronte alGiurì, abbia ritenuto di dover accostare taleprocedimento all’arbitrato rituale piuttosto chea quello irrituale. Il presupposto da cui taledottrina muove, infatti, è la contrapposizione -nei presenti volumi ripetutamente contestata -tra un arbitrato rituale inteso come giudizio incui le parti conferiscono agli arbitri un mandatoa risolvere una o più controversie“essenzialmente con gli stessi obblighi e con glistessi effetti della funzione giurisdizionale” eun arbitrato irrituale nel quale il mandatoavrebbe ad oggetto la definizione in vianegoziale di contrasti insorti tra le parti inrelazione a determinati rapporti giuridici“mediante una composizione amichevole,conciliativa o transattiva, o mediante un negoziodi mero accertamento, l’una o l’altra
giustizia privata” (G. VERDE, Ancora sull’arbitrato irrituale, in Riv.arb.,1992, 3, pp. 431-432).70 S. SATTA, Contributo alla dottrina dell’arbitrato, ristampa, Milano,1969, p. 179 ss.
54
direttamente riconducibili alla volontà deimandanti e da valere come contratto da questiconcluso”71. Tale riduzionistica letturadell’arbitrato irrituale, peraltro, si ritrovaanche presso autori che negano la somiglianza tragiudizio autodisciplinare e arbitrato, i qualiribadiscono il convincimento secondo cui lemodalità eliminatrici della lite nell’arbitratolibero si realizzerebbero esclusivamente “nelleforme del negozio di accertamento ovvero instrumenti conciliativi o transattivi”72.
71 G. SENA, Il sistema dell’autodisciplina pubblicitaria, cit., p. 197.72 Da tale discutibile premessa si desume l’irriducibilitàdel giudizio autodisciplinare all’arbitrato libero con iseguenti argomenti. Quanto alla transazione si afferma che,mentre il giudizio autodisciplinare ha la funzione diaccertare chi ha torto e chi ha ragione in ordine allaviolazione del Codice di autodisciplina, eventualmentedando luogo ad una pronuncia di condanna, la composizionetransattiva si raggiunge mediante reciproche concessioni,indipendentemente da un accertamento dei dirittieffettivamente spettanti alle parti. Quanto allacomposizione conciliativa, poi, si sottolinea come essa,pur tendendo non a una composizione qualsiasi ma allagiusta composizione della vertenza, non sia ancora attivitàdi decisione e dunque si differenzi dall’attività digiudizio in senso proprio. Quanto infine al negozio diaccertamento si ribadisce che in esso prevale l’elementodel vero e proprio giudizio rispetto a quello transattivo,solo che le parti mirano ad eliminare l’incertezza relativaa situazioni giuridiche tra loro intercorrenti e sivincolano ad attribuire al fatto o all’atto preesistentegli effetti che risultano dall’accertamento contrattuale.Nel sistema autodisciplinare, per converso, l’incertezzache deve essere eliminata concerne l’esistenza di una
55
In sintesi: sia i sostenitori che idetrattori della tesi circa la natura arbitraledel procedimento autodisciplinare, tranne pocheeccezioni, contrappongono l’arbitrato rituale, incui verrebbe svolta un’attività di giudiziosostanzialmente giurisdizionale, all’arbitratoirrituale, in cui gli arbitri non definirebberouna controversia né svolgerebbero in sensoproprio attività di giudizio. Una correttasoluzione del problema circa la supposta naturaarbitrale del procedimento di soluzione dellecontroversie ai sensi dell’autodisciplinapubblicitaria, per converso, deve prendere lemosse proprio da una messa in discussione diquesta rigida e discutibile differenziazionedelle due tipologie di arbitrato73.
A ben vedere, infatti, nell’arbitrato liberola parte non vuol concedere qualcosa né intendetransigere. Si pensi all’ipotesi in cui l’arbitrolibero, dovendo giudicare secondo diritto,
violazione e comunque il Giurì non si limita ad effettuareun semplice accertamento, arrivando ad emanare unapronuncia inibitoria. Su ciò v. B. GRAZZINI, Autodisciplinapubblicitaria e ordinamento statuale, cit., p. 61. Tali argomenti,intesi a dimostrare l‘irriducibilità del giudizioautodisciplinare all‘arbitrato irrituale, sarebberoinoppugnabili solo se l’arbitrato libero fosse davveroriducibile a strumento di definizione di un contrastomediante una composizione amichevole, o mediante un negoziodi mero accertamento.73 In tal senso, C. PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, I ed.,Padova, 2000, tomo I, p. 68; ID., Arbitrato, in Enc. Giur. Trecc.,IV aggiornamento, Roma, 1995, p. 3 ss.
56
rigetti in toto le richieste di una delle parti:come potrebbe definirsi una transazione? Il veroè che anche nell’arbitrato libero le partichiedono che venga individuata, ‘secondo diritto’o ‘secondo equità’, una soluzione che diverràvincolante per entrambe. Ecco perché variaffermata l’identità di funzione tra arbitrirituali ed arbitri liberi: in entrambi lacontroversia viene decisa secondo il criterio digiudizio voluto dalle parti, con una decisioneche queste, sottoscrivendo il compromesso, sisono impegnate ad eseguire. Anche gli arbitriirrituali, dunque, possono risolvere lacontroversia, accertando i fatti, giudicandosulle contrapposte pretese delle parti,applicando norme di diritto74. Se ne deveconcludere che non ha ragion d’essere l’argomentosecondo cui il giudizio autodisciplinare nonsarebbe riconducibile all’arbitrato libero per ilsolo fatto che il Giurì non si limita a compiereuna mera attività di accertamento o dicomposizione amichevole, ma risolve una
74 Ivi, pp. 88-89. In tal senso già Cass. Civ. 12/9/1984, n.4794, causa Turrini c. Mignani, in Mass. Giur. it., 1984,secondo cui: “non è incompatibile con l’irritualitàdell’arbitrato il conferimento ad arbitri del potere didefinire le controversie con il pieno riconoscimento delfondamento della pretesa dell’una o dell’altra parte,mediante l’applicazione di norme, principio equitativi edaltri criteri”. Dunque “la necessità di applicare edinterpretare norme giuridiche per pervenire alladeterminazione conclusiva non contrasta col carattereirrituale dell’arbitrato”.
57
controversia75.Va peraltro dato conto di un’autorevole
dottrina secondo cui, pur non rinvenendosiostacoli di principio alla qualificazione delprocedimento autodisciplinare in termini diarbitrato irrituale, tale qualificazionerisulterebbe del tutto riduttiva e ciò inconsiderazione del fatto che nel contrattoautodisciplinare il potere di autonomia è direttonon solo a regolare i rapporti intercorrenti “frasoggetti determinati in relazione a singoliaffari” bensì a regolare in modo generale ecostante “una serie indefinita di rapportointercorrenti nell’ambito di categorieprofessionali in base a regole che promanano
75 “Se pure il risultato è un contratto il modo, l’iter èun arbitrato, cioè un processo innanzi a terzo e deciso daterzo: infatti, le parti non chiedono al terzo unadeterminazione purchessia del contenuto del loro contratto,sibbene una determinazione che, previa ricognizione ediscussione delle ragioni hic et hinde, risolva unacontroversia su posizioni giuridiche sostanziali, fra loroinsorta”. Così E. FAZZALARI, Arbitrato (teoria generale e dirittoprocessuale civile), in Dig. Disc. Priv. Sez. civ., Torino, 1987, p. 405.Del giudizio autodisciplinare come “arbitrato astatuale,istituito dal consenso degli aderenti ed animatodall’affectio societatis” scrive F. ROSI, Risoluzione delle controversie inmateria di pubblicità commerciale e nuova disciplina comunitaria, in Riv.arb., 1991, 2, p, 448. Non esclude che in certi casi “ilfenomeno del deferimento di una questione al Giurì diautodisciplina possa assumere forme riconducibili allafigura dell’arbitrato” A. CERRI, La pubblicità commerciale tralibertà di manifestazione del pensiero, diritto di informazione, disciplina dellaconcorrenza, in Dir. inf., 1995, 3, pp. 539-540.
58
dalle stesse categorie interessate”76.Invero non vi sono difficoltà ad ammettere
che il complessivo fenomeno dell’autodisciplinapubblicitaria non è interamente coperto dalmodello dell’arbitrato irrituale giacché esso noncostituisce solo uno strumento di soluzione nongiurisdizionale di controversie, bensì un piùampio sistema di regole sostanziali eprocedurali77. D’altronde non c’è motivo di
76 In particolare, si è detto che l’arbitrato irrituale “siconfigura tipicamente come proiezione contenziosa di unrapporto contrattuale specifico nel quale rilevanounicamente gli interessi individuali delle parti che dannovita al regolamento del singolo affare o dei singoli affariche formano oggetto del contratto tra loro intercorso. Percontro l’autodisciplina si configura tipicamente come unsistema nel quale rileva, accanto agli interessiindividuali dei singoli aderenti, un loro interessecollettivo all’osservanza delle regole poste, e nel qualequesto interesse collettivo è stato istituzionalizzato, siapure sempre e soltanto in forme privatistiche” In talsenso, dunque, “la proiezione contenziosa dell’osservanzadelle regole suddette assume una connotazione diversarispetto a quella propria dell’arbitrato irrituale” e ciòsia perché “nell’autodisciplina il contenzioso si svolgedavanti ad un organo inserito stabilmente nella strutturaorganizzativa del sistema (e non davanti ad un arbitro o adun collegio arbitrale nominato dalle parti perl’occasione), ma questo organo assume il compito principale digarantire l’effettività del sistema creato per il soddisfacimento dell’interessecollettivo degli aderenti all’osservanza delle regole e solo di riflesso quello digarantire l’interesse individuale del singolo aderente all’osservanza di taliregole” (G. FLORIDIA, Autodisciplina e funzione arbitrale, cit., p. 7). 77 Proprio perché il sistema autodisciplinare non si riduceal solo procedimento di fronte al Giurì e alle sue
59
ricondurre forzosamente l’intero ordinamentodell’autodisciplina pubblicitaria all’arbitratoirrituale78. Altro è il nodo del problema: vi sonoconvincenti ragioni per negare l’assimilabilitàall’arbitrato irrituale del procedimento inteso arisolvere le controversie in ordine al rispettodelle norme di condotta in materia dicomunicazione commerciale?79.
Il fuoco dell’indagine deve spostarsi dalla
pronunce, non può condividersi quella tesi che rinvieneun’assoluta incompatibilità tra il procedimentoautodisciplinare e l’arbitrato libero in relazione al fattoche gli effetti di questo sono solo negoziali, mentrel’art. 41 del CAP prevede che “i mezzi pubblicitari chedirettamente o tramite le proprie Associazioni hannoaccettato il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria,ancorché non siano stati parte nel procedimento avanti alGiurì, sono tenuti a osservarne le decisioni” (F. CORSINI,Arbitrati amministrati, proprietà intellettuale e questioni processuali, cit.,p. 192 ss.). L’ovvio rilievo che il lodo produce effettitra le parti e non nei confronti di terzi estranei allacontroversia, non esclude affatto che, proprio nella logicadel più ampio sistema autodisciplinare, i terzi possanospontaneamente impegnarsi, a rispettare ogni pronuncia delGiurì che possa riguardarla.78 Anche perché, come è stato ricordato, “ogni settoremercantile usa elaborare tecniche e prassi proprie. Alleregole e consuetudini di settore – alla lex mercatoria –corrisponde molto frequentemente un modello d’arbitrato”(G. POLVANI, Arbitrato amministrato e camere arbitrali, in N. IRTI (acura di), Dizionario dell’arbitrato, Torino, 1997, p. 15)79 Un’efficace decostruzione degli argomenti cheimpedirebbero di qualificare il giudizio autodisciplinarecome arbitrato libero può trovarsi in F. CRISCUOLO, Modelloarbitrale e strumenti alternativi di giustizia, in Riv. arb., 2000, 1, p. 42
60
struttura del giudizio autodisciplinare aglieffetti delle sue pronunce, in specie per quantoconcerne i rapporti con l‘autorità giudiziariaordinaria.
8 - Il controllo dell’autorità giudiziaria sulle pronunce delGiurì. La tematica dei rapporti tra autodisciplinapubblicitaria ed Autorità giudiziaria ordinariaha da sempre attirato l’attenzione di quanti, indottrina come in giurisprudenza, abbiano compiutouno sforzo di classificazione del procedimento difronte al Giurì.
L’indagine sul tema deve muovere dallacomplessiva qualificazione del sistemadell’autodisciplina pubblicitaria: se è vero,infatti, che tale sistema costituisce unordinamento autonomo ma pur sempre aventeun’origine contrattuale, si pone un problema dicompetenza del Giudice ordinario non solo sulnegozio autodisciplinare, ma sullo stessapronuncia emessa dal Giurì.
È innegabile, in primo luogo, che sussistala competenza del giudice ordinario quanto allavalidità, sotto il profilo della causa edell’oggetto, del negozio che è alla basedell’obbligatorietà del sistema autodisciplinare:la causa dev’essere lecita80 ai sensi dell’art.
ss. il quale tralaltro rileva come “proprio l’arbitratolibero si presta particolarmente a soddisfare l’esigenza diorganizzazioni che rifuggono il formalismo della disciplinastatale” (ivi, pp. 43-44).80 Per quanto concerne il profilo della liceità della
61
1343 c.c. e, ove venga considerata atipica, deveperseguire un interesse meritevole di tutela exart. 1322 co. 2; l’oggetto dev’essere possibile edeterminabile come prescritto dall’art. 1346 c.c.e comunque non contrario a norme imperative aisensi dell’art. 1418 c.c..
Il principio generale, in tema di raccordotra autodisciplina pubblicitaria e giurisdizioneordinaria, è individuabile nell’impossibilità disupplenza del Giudice statale nell’esercizio
causa, la già citata sentenza 22 gennaio 1976 del Tribunaledi Milano (Riv. dir. ind., 1977, 2, p. 91 ss.) si è posta ilproblema se l’apposizione di limiti convenzionaliall’esercizio della libertà d’impresa sia intesa a impedirerestringere o falsare il gioco della concorrenzaall’interno del mercato. Le regole del Codice diautodisciplina pubblicitaria, infatti, prescrivendocondotte alle quali devono attenersi gli aderenti neldiffondere una comunicazione commerciale, costituisce unvincolo per l’attività imprenditoriale in cui potrebbe inipotesi ravvisarsi un effetto anticoncorrenziale. Ma lapreoccupazione non ha ragion d’essere: il sistemaautodisciplinare, infatti, si fonda sull’impegno assuntodai suoi aderenti ad evitare condotte per lo più illecitein quanto anticoncorrenziali. In tal caso, dunque, non solonon sussiste una causa anticoncorrenziale ma si ha unoscopo meritevole di tutela perché diretto a fare luogo aduna tipizzazione dell’illecito pubblicitario che “non sisovrappone alla disciplina statuale, ma si inscrive in essaal fine di riempire di contenuto e di specificare ilgenerale dettato normativo dei principi della correttezzaprofessionale” (G. FLORIDIA, Autodisciplina e funzione arbitrale,cit., p. 10; B. GRAZZINI, Autodisciplina pubblicitaria e ordinamentostatuale, cit., p. 126 ss.). La liceità della causa delcontratto di autodisciplina pubblicitaria, d’altronde, nonpuò essere messa in dubbio se solo si considera la
62
delle funzioni spettanti al Giurì. Se è vero,d’altronde, che il sistema dell’autodisciplinapubblicitaria si fonda su una regolamentazioneautosufficiente, vincolante solo i suoi aderentie quanti vi si assoggettano mediante la clausoladi accettazione, non può ritenersi che taliregole possano essere fatte valere davanti aigiudici dello Stato né che in esso le relativepronunce possano ottenere un qualchericonoscimento o comunque essere suscettibili diimpugnazione. Nessun controllo sul rispetto dellenorme del CAP da parte di aderenti esottoscrittori potrà essere effettuato dalGiudice: il giudice ordinario non può esserealternativo al Giurì per quanto concernel’attuazione del Codice autodisciplinare81.
Direttiva 05/29/CE che esplicitamente attribuisce alsistema una funzione utile, sul piano sia preventivo deiconflitti che deflattivo del contenzioso, rispetto alcontrollo esercitato dallo Stato sulle condotte lesive deiconsumatori e della concorrenza. Si legge, infatti, alconsiderando n. 20 della Direttiva: “è opportuno prevedere unruolo per i codici di condotta che consenta aiprofessionisti di applicare in modo efficace i principidella presente direttiva in specifici settori economici”.L’apprezzamento nei confronti del sistema autodisciplinaresi giustifica anche in considerazione degli effettideflattivi nei confronti delle procedure giudiziarie eamministrative: “il controllo esercitato dai titolari deicodici a livello nazionale o comunitario per l’eliminazionedelle pratiche commerciali sleali può evitare la necessitàdi esperire azioni giudiziarie o amministrative e dovrebbeessere pertanto incoraggiato”.81 Sul punto, v. P. TESTA, Pronunzia del Giurì e diritti dei terzi, in
63
Sull’inammissibilità di un controllogiurisdizionale sul merito delle pronunceautodisciplinari sembra incontestatol’orientamento giurisprudenziale, inauguratodalla pluricitata sentenza del Tribunale diMilano del 1976 e in più occasioni ribadito,secondo cui “nessuna disposizione normativa,generale o speciale, prevede che il provvedimentodel Giurì sia direttamente impugnabile avantiall’autorità giudiziaria” o comunque suscettibile“di un sindacato di merito da parte del giudiceordinario” e ciò in considerazione del fatto chetale provvedimento si pone “su un piano privato,espressione dell’autonomia delle parti”. Ildettato dell’art. 39 del Codice autodisciplinare,d’altronde, è chiaro: “Le decisioni del Giurìsono definitive”. Alla definitività deveaggiungersi l’incontestabilità di tali pronunce eciò per effetto di una lettura dell’art. 42 incui non è previsto alcun riesame di merito delledecisioni.
L’insindacabilità delle decisioni del Giurìda parte del Giudice statale, evidentemente, nonva interpretata nel senso della sottrazione dellefattispecie rilevanti per l’ordinamentoautodisciplinare alla cognizione delle autoritàamministrative e giurisdizionali dello Stato,“ove i medesimi fatti siano rilevanti ai finidell’applicazione delle leggi dello Stato”82. Tale
Dir. inf., 1993, 3, p. 734 ss.82 Così non è stata escluso il concorso di un’azione diconcorrenza sleale o di contraffazione del marchio e dei
64
concorso dei poteri del Giurì con quellidell’autorità giudiziaria ordinaria, peraltro,sembra costituire un’ulteriore confermadell’impossibilità di assimilare il giudizioautodisciplinare all’arbitrato rituale. In casocontrario, infatti, dovrebbe propendersi per lamancanza di giurisdizione del giudice ordinario,in virtù della clausola compromissoria, aconoscere dei medesimi fatti e comunque dovrebbeammettersi la possibilità di un controllo delgiudice statale in sede di impugnazione delladecisione autodisciplinare, cosa che si è esclusaper le ragioni sopraindicate83.
Il fatto che il giudice ordinario non possariesaminare il merito del giudizioautodisciplinare, e dunque esercitare quel potere
relativi profili inibitori e risarcitori con l’eserciziodel potere d’istanza davanti al Giurì per i medesimi fatti,visti sotto il profilo della contrarietà alle normeautodisciplinari” (A. RAPISARDI, Decisioni del Giurì e controllodell’autorità giudiziaria ordinaria, in Dir. ind., 1996, 3, p. 223). Sulpunto v. anche S. ALVANINI, La non sindacabilità in sede di giurisdizioneordinaria delle decisioni dello IAP, in Dir. ind., 2010, 5, p. 478.83 A. RAPISARDI, Decisioni del Giurì e controllo dell’autorità giudiziariaordinaria, cit., p. 223. Quegli autori, come Ubertazzi eSena, che propendono per la qualificazione delprocedimento avanti al Giurì in termini di arbitratorituale, infatti, coerentemente assimilano la clausola diaccettazione ad una clausola compromissoria, conconseguente difetto di giurisdizione del giudice dellostato ed attribuiscono all’autorità giudiziaria il solopotere di decidere in ordine alle impugnazioni dellepronunce autodisciplinari, come di qualsiasi altro lodorituale, ex artt. 827 ss. c.p.c..
65
di valutare la corretta applicazione del Codiceche allo stesso Giurì è stato conferito in viaesclusiva dalle parti con l’adesione al sistema ocon la sottoscrizione della clausola diaccettazione, non esclude, peraltro, che ledecisioni del Giurì possano essere sindacatedall’autorità giudiziaria nelle ipotesi in cui lapronuncia sia emessa o nei confronti di soggettonon vincolato al sistema o su materie non oggettodel contratto di adesione. L’intervento delGiudice dello Stato è proprio inteso ad evitareche simili pronunce, esorbitando dal sistemaautodisciplinare, possano spiegare effettinell’ordinamento statale.
La dottrina ha altresì ritenuto ammissibilel’intervento dell’autorità giudiziaria ordinariain altri casi eccezionali in cui si siaverificata una violazione di principifondamentali dell’ordinamento giuridico, comenell’ipotesi di violazione del contraddittorio ocomunque del diritto alla difesa o condottafraudolenta dell’organo giudicante nei confrontidi una delle parti84.
Che la pronuncia del Giurì sia definitiva einsindacabile nel merito, dunque, non esclude cheessa possa essere annullata in ipotesieccezionali in cui siano venute meno lecondizioni minime del giusto processo arbitrale85.84 V. ad es. M.S. SPOLIDORO, Le sanzioni del Codice di autodisciplinapubblicitaria, cit., pp. 73-7485 Per lo stesso lodo rituale, invero, la conseguenza dellanon impugnabilità del lodo è la preclusione della
66
Torniamo al dilemma della qualificazione delgiudizio autodisciplinare come arbitratoirrituale. È significativo il fatto che leipotesi eccezionali in cui la dottrina haritenuto impugnabile la pronuncia del Giurìautodisciplinare siano in buona parte coincidenticon le ipotesi di impugnabilità del c.d. “lodocontrattuale” ai sensi della vigente disciplina.L’art. 808-ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. ,n.40 del 2 febbraio 2006, infatti, prevede che ilodi contrattuali siano annullabili nelleipotesi:
“possibilità di proporre l’impugnazione per nullità perinosservanza delle regole di diritto, ma lascia comunqueferma la impugnabilità del lodo per i motivi di nullità”(C. PUNZI, Disegno sistematico dell’arbitrato, I, cit., p. 90). “Illodo arbitrale irrituale - si legge in Cass. Civ. 6/2/2009n. 2988, Comune di Napoli c. Saimer srl, in Guida dir., 2009,12, p. 50 - è impugnabile solo per i vizi che possonovulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, comel’errore, la violenza, il dolo o l’incapacità delle partiche hanno conferito l’incarico o dell’arbitro stesso. Alriguardo l’errore rilevante è solo quello attinente allaformazione della volontà degli arbitri, che si configuraquando questi abbiano avuto una falsa rappresentazionedella realtà per non avere preso visione degli elementidella controversia o per averne supposti altri inesistenti,ovvero per non avere dato come contestati fatti pacifici oviceversa, mentre è preclusa ogni impugnativa per errori didiritto, sia in ordine alla valutazione delle prove”. Tinquesta ottica, dunque, deve ritenersi che il sindacato delgiudice ordinario non si sovrapponga a quello dell’organoautodisciplinare, così salvando il principiodell’insindacabilità nel merito (v. G. FLORIDIA, Autodisciplinae funzione arbitrale, cit., p. 17).
67
i) di invalidità della convenzione di arbitrato ocomunque di pronuncia su conclusioniesorbitanti dai limiti di quella;
ii) di nomina degli arbitri in modo difforme daquanto previsto dalla convenzione;
iii) di pronuncia da parte di chi non potevaessere nominato arbitro perché privo dicapacità legale di agire;
iv) di mancato rispetto da parte degli arbitridelle regole imposte dalle parti comecondizioni di validità del lodo;
v) di violazione del principio delcontraddittorio.È opportuno verificare se l’applicazione di
tale disciplina alle pronunce del Giurì porti aconseguenze inaccettabili per l’autodisciplinapubblicitaria. Applicando l’art. 808-ter c.p.c.alla fattispecie in oggetto, dovrà concludersiche la pronuncia del Giurì sia annullabile dalgiudice ordinario quando:- sia stata emessa in violazione della lettera
b) delle Norme preliminari e generali del CAP, cioènei confronti di soggetto non vincolato alsistema o comunque verta su materia estraneaal Codice di autodisciplina (ad esempiogiudizio di illiceità su una condotta nonavente natura di comunicazione commerciale aisensi del CAP);
- il Giurì sia stato nominato in modo difformeda quanto previsto agli artt. 29 e 34 del CAP(nomina come componente del Giurì di soggettoesercente attività professionale nel settore);
68
- la pronuncia sia stato emessa in dispregio diregole essenziali per la sua validità (come ades. l’art. 32 co. 1, si pensi all’ipotesi dipronuncia del Giurì emessa in applicazione dinorme del Codice del Consumo non coincidenticon le fattispecie del Codiceautodisciplinare);
- sia stato violato il principio delcontraddittorio.Sotto il decisivo profilo dei rapporti con
la giurisdizione ordinaria, dunque, l’eventualequalificazione del procedimento di fronte alGiurì come arbitrato irrituale non contraddice iprincipi che connotano l’autodisciplina86.
Né va dimenticato l’insegnamento di quelladottrina che nel segnalare che l’arbitrato liberoè spesso “organizzato da gruppi (associazioni,società e così via) che prevedono regolamentiuniformi”, ha riaffermato che in tale forma digiustizia non statuale - la si chiami pure
86 “Sarebbe incompatibile con i limiti inderogabilidell’ordinamento superiore – rileva G. FLORIDIA (Autodisciplinae funzione arbitrale, cit., p. 12) – un sistema diautodisciplina nel quale non fosse garantita nei modiopportuni la difesa dell’incolpato nel procedimento che dàluogo all’applicazione della misura repressiva” o nel qualecomunque l’organo giudicante applicasse “una disposizioneautodisciplinare incompatibile con l’ordinamento superiore”o comunque “facesse un’applicazione distorta o erroneadelle disposizioni sostanziali o strumentali contenutenell’ordinamento derivato oppure se applicasse principi ivinon espressamente previsti”.
69
endoassociativa87 - va rinvenuto il caratteredell’arbitrato tutte le volte che “la volontànegoziale delle parti esige dal terzo il rispettodel contraddittorio, dunque lo svolgimento di unprocesso, breve o lungo non importa. Le partivogliono essere messe in grado di far sentire leloro ragioni, di allegare fatti e addurreprove”88. Non sono, quelli appena citati, elementiche si ritrovano appieno nel procedimento difronte al Giurì?
Si dirà: l’arbitrato irrituale in materiapubblicitaria è quello previsto dal Regolamentodi Arbitrato predisposto dalla Camera diConciliazione ed Arbitrato presso l’Istitutodell’Autodisciplina Pubblicitaria. È peròsingolare che le parti non abbiano mai utilizzatotale istituto. Può davvero escludersi chel’insuccesso di tale forma di arbitratoamministrato dall’IAP sia una conseguenza delfatto che uno strumento di soluzione alternativadelle controversie, tutto sommato assimilabileall’arbitrato irrituale, nonché caratterizzato datempi di definizione (e costi) decisamenteridotti, era già operativo ed efficace?
9 - Giurì di autodisciplina pubblicitaria e Autorità garantedella Concorrenza e del Mercato. Se il sistemaautodisciplinare ha svolto un importante ruolo87 Definita altresì “giurisdizione domestica” in Giur. Aut.n. 57/2002.88 E. FAZZALARI, Arbitrato (teoria generale e diritto processuale civile),cit., p. 405.
70
sul piano sia della regolazione che dellasoluzione delle controversie nel settorepubblicitario - secondo alcuni un monopolio difatto del controllo sulla correttezza e liceitàdei messaggi pubblicitari - ciò è anzitutto pereffetto della carenza e frammentarietà dellanormativa statale in materia. Nel corso deglianni, peraltro, il sistema autodisciplinare nonsolo ha acquisito credibilità e autorevolezza, maha ottenuto importanti riconoscimenti a livellocomunitario, di cui vi è traccia, ad esempio,nella Direttiva 84/450/CE89.
È stata proprio la legge nazionale attuativadi tale Direttiva a colmare l’assenza di unadisciplina di settore. Il D.L. n. 74 del 25gennaio 1992, com’è noto, ha attribuitoall’Autorità Garante della concorrenza e delMercato, già istituita con legge n. 287 del 10Ottobre 1990, la competenza in materia di89 Al cui Considerando n. 16 si legge: “i controllivolontari esercitati da organismi autonomi per eliminare lapubblicità ingannevole servono ad evitare azionigiudiziarie o ricorsi amministrativi e devono quindi essereincoraggiati”. All’art. 5 della stessa Direttiva 84/450/CE,come modificata dalla Direttiva 97/55/CE, si legge chel’attribuzione all’autorità giudiziaria e/o amministrativadei poteri di controllo in materia di pubblicitàingannevole e comparativa non esclude che “gli Statimembri” possano “incoraggiare” “il controllo volontario”“esercitato da organismi autonomi”. La Direttiva 05/29/CEgiunge fino a dichiarare che “è opportuno prevedere unruolo per i codici di condotta che consenta aiprofessionisti di applicare in modo efficace i principidella presente direttiva”.
71
pubblicità ingannevole. I poteri della stessaAutorità, com’è noto, sono stati successivamenteprecisati dalla legge n. 67 del 25 febbraio 2000,attuativa della Direttiva 97/55/CE, che ne haesteso la competenza alla materia dellapubblicità comparativa.
La legge 74/1992 si è trovata a doveraffrontare il delicato problema del coordinamentotra controllo pubblico e interventoautodisciplinare in materia pubblicitaria edunque a fare una scelta politica tra diversipossibili modelli90. Il legislatore potevaanzitutto, sulla falsariga di quanto avviene inaltri ordinamenti europei, scegliere di ometterequalunque riferimento al sistemaautodisciplinare, in ossequio ad una visioneseparatistica dei rapporti tra normazionepubblica e autonomia negoziale. Un’opzione disignificato opposto sarebbe stata quella divalorizzare le pronunce autodisciplinari fino arenderle idonee a produrre effettinell’ordinamento dello stato, così equiparandolequoad effectum alle sentenze dei tribunali eriservando agli organi statali solo un controllodi seconda istanza, fino a mettere in discussionela stessa consolidata autonomia dell’ordinamentoautodisciplinare91.
Il legislatore, poi, avrebbe potuto adottare90 Su ciò v. V. MELI, Autodisciplina statale e legislazione statale, inDir. ind., 1996, 3, p. 227.91 G. MANFREDI, Giurì di autodisciplina, autorità indipendenti e autoritàgiudiziaria, in Dir. Ind., 2011, 1, pp. 66-67.
72
soluzioni intermedie, prevedendo forme diintegrazione più o meno strette econseguentemente organizzando il controllopubblico in modo da preservare comunque unospazio per il giudizio disciplinare. Ragionandoin un’ottica di economia dei giudizi ed in speciedi sussidiarietà del sistema autodisciplinarerispetto al controllo pubblicistico, ad esempio,si sarebbe potuto precludere il ricorsoall’Autorità ove le esigenze indicate dallaDirettiva 84/450/CE fossero state adeguatamentesoddisfatte dal procedimento avanti al Giurì. Nelregolare l’ipotesi di contemporanea pendenza deidue procedimenti, poi, si sarebbe potuto siaprevedere la sospensione di uno dei due(verosimilmente quello a carattere pubblicistico)in attesa della conclusione dell’altro siaregolare gli effetti che la pronunciaautodisciplinare avrebbe dovuto produrre neiconfronti del giudizio avanti all’Autorità.
La soluzione scelta dal legislatore costituìun compromesso tra un esplicito riconoscimentodel ruolo da tempo giocato dal sistemaautodisciplinare nel settore pubblicitario e lapretesa statalistica di controllo sul settore.Recitava il primo comma dell’articolo 8 delD.Lgs. n. 74/92: “Le parti interessate possonorichiedere che sia inibita la continuazione degliatti di pubblicità ingannevole ricorrendo adorganismi volontari e autonomi diautodisciplina”. Si trattava, invero, di unriconoscimento debole, considerato che la libertà
73
di risolvere in via privata controversie sudiritti disponibili non aveva certo bisogno diuna solenne enunciazione.
Il tipo di coordinamento prescelto dallegislatore negli anni ’90, invero, sembravapiuttosto debole, affidato all’iniziativa delleparti e ad una valutazione discrezionaledell’Autorità e, soprattutto, non determinatoquanto agli effetti della decisioneautodisciplinare sul procedimento pubblico92.L’art. 8, infatti, prevedeva che il coordinamentosi realizzasse in due modalità: prima che fosseavviato il procedimento dinanzi all’Autorità,quando le parti avessero sottoscritto un accordocon cui si impegnavano a non promuovere l’azionedi fronte alla stessa Autorità fino allaconclusione del procedimento autodisciplinare;pendente il procedimento amministrativo, nonrilevando che fosse stato avviato prima o doporispetto a quello autodisciplinare, quandol’Autorità, su richiesta della parte interessata,avesse disposto la sospensione del procedimento
92 Si legge ai commi 2 e 3: “Iniziata la procedura davantiad un organismo di autodisciplina, le parti possonoconvenire di astenersi dall’adire l’Autorità Garante sinoalla pronuncia definitiva. Nel caso in cui il ricorsoall’Autorità sia già stato proposto o venga propostosuccessivamente da altro soggetto legittimato, ogniinteressato può richiedere all‘Autorità la sospensione delprocedimento in attesa della pronuncia dell’organismo diautodisciplina. L‘Autorità, valutate tutte le circostanze,può disporre la sospensione del procedimento per un periodonon superiore a 30 giorni”.
74
per un periodo non superiore a 30 giorni.La scelta fatta con la l. 74/92 suscitò
perplessità e delusione tra i conoscitori edesperti dell’autodisciplina pubblicitaria. Ancheperché il tipo di coordinamento presceltolasciava irrisolto un quesito fondamentale: qualera la ratio della sospensione del procedimentoamministrativo? Si poteva pensare, anzitutto, aduna finalità di economia procedimentale,considerato che l’Autorità poteva avere interessea non ripetere l’attività istruttoria già svoltain sede autodisciplinare. Ma non sembrava questol’interesse prevalente, se è vero che nelladisciplina in oggetto era assente la previsionedi una sospensione del procedimento su impulsodell’Autorità. Né è credibile che il legislatore,coordinando i due procedimenti, pensasse ad unavincolatività del giudizio autodisciplinare suquello amministrativo. L’autorità amministrativa,infatti, era pur sempre tenuta a fornire unadecisione motivata nel merito e non potevaastenersi dal provvedere, come, ad esempio,nell’ipotesi in cui si fosse limitata a rinviaread una decisione autodisciplinare che avessedichiarato l’ingannevolezza della pubblicitàinibendone l’ulteriore diffusione93.
93 V. MELI, Autodisciplina statale e legislazione statale, cit., p. 230.Secondo Floridia sarebbe proprio “la necessariaautoreferenzialità sostanziale e procedimentale del sistemadi autodisciplina” ad indurre il legislatore sia nazionaleche comunitario, che pure riconoscono l’utile funzione didecongestionamento che tale sistema può svolgere nei
75
Alla pronuncia autodisciplinare dovevadunque attribuirsi un’efficacia per lo piùpersuasiva: l’Autorità poteva tenerne conto,eventualmente richiamando accertamenti emersidurante la fase istruttoria o anche valutazioniformulate dal Giurì; il tutto, però, nel quadrodell’attività istruttoria che l’Autorità garanteera pur sempre tenuta a svolgere. E se l’Autoritàavesse ignorato la pronuncia del Giurì? Se essaavesse omesso in modo ingiustificato ogniriferimento all’esito e alle motivazionicontenute nella pronuncia autodisciplinare sullastessa materia e in un contenzioso cheriguardasse le stesse parti? Nessuno avrebberisposto che il procedimento amministrativosarebbe stato per ciò solo viziato per eccessodi potere, a meno che l’omissione del riferimentoal giudizio autodisciplinare non si fosse
confronti delle procedure giudiziarie e amministrative, adescludere che le pronunce del Giurì possano avere uneffetto vincolante nell’ordinamento dello Stato (G.FLORIDIA, Il coordinamento tra controllo autodisciplinare e controlloamministrativo delle pratiche sleali, in Dir. ind., 2009, 2, pp. 175-176). Sul significato della scelta operata dal legislatorecon il D. Lgs. 74/1992, v. anche M. MAMMONE, L’autodisciplinapubblicitaria, cit., p. 113 ss. Nega che la “aspirazionedell’Autorità Garante a trasformarsi in Grande Fratello(non in senso televisivo)” corrisponda ad una consapevolescelta ideologica “in senso autoritario-paternalista” A.VANZETTI, Legislazione e diritto industriale, in Riv. dir. ind., 2011, 1, p.15. Per un’interessante rassegna degli orientamentidell’Autorità Garante in materia di pubblicità ingannevolee comparativa, A.M. GAMBINO, V. FALCE, L. STAZI, Pubblicitàingannevole e comparativa, in Conc. merc., 2010, p. 193 ss.
76
tradotta in un grave errore di valutazione inordine a elementi di fatto e di diritto rilevantiai fini del procedimento o comunque in errori oincongruità nella motivazione94.
In un simile quadro, dunque, non potevaescludersi l’eventualità di pronunce difformisulla stessa controversia. Non si sarebbetrattato, d’altronde, di conflitto tra giudicatistricto sensu, se è vero che una pronuncia sarebbestata emessa da un’autorità privata e avrebbequindi vincolato solo gli aderenti all’IAP,mentre l’altra sarebbe provenuta da un’autoritàamministrativa in virtù dei poteri conferitidalla legge autorizzata ad emanare provvedimentidirettamente esecutivi95.
Il delicato equilibrio tra autodisciplinapubblicitaria e controllo amministrativorealizzato tramite la l. 74/92, invero, si èdecisamente alterato negli ultimi anni ed inparticolare a partire dal D.Lgs. 49/2005 con cuiil Legislatore nazionale, non sempre inconsonanza con le Direttive comunitarie, hanotevolmente accresciuto le competenze94 V. MELI, Autodisciplina statale e legislazione statale, cit., p. 23195 Su ciò G. MANFREDI, Giurì di autodisciplina, autorità indipendenti eautorità giudiziaria, cit., p. 64. Va peraltro rilevato come ilsistema autodisciplinare possa comunque svolgere una certafunzione deflattiva anche in assenza di formalevincolatività delle sue decisioni e ciò in considerazionedel fatto che la pronuncia di illiceità e la conseguenteinibitoria potrebbero, in caso di condotta ottemperantedella parte soccombente, rendere superfluo il ricorsoall’Autorità garante.
77
dell’Autorità, estendendole dalla comunicazionepubblicitaria alle pratiche commerciali in sensoampio e conferendo all’Autorità il potere diinfliggere sanzioni pecuniarie96.
Che in tale nuovo scenario, espressione diuna precisa scelta politica del nostrolegislatore, l’Autodisciplina pubblicitaria possadavvero svolgere un’efficace funzione deflattivaè assai dubbio. E ciò in parziale contrasto conla Direttiva 05/29/CE che demandava a ciascunoStato membro ogni decisione “se sia opportuno chel’organo giurisdizionale o amministrativo possaesigere che si ricorra in via preliminare ad altri mezziprevisti per risolvere la controversia”97, inclusi96 Il legislatore avrebbe così introdotto “elementi tali datrasformare un controllo di natura civilistica in unmeccanismo inquisitorio attivabile d’ufficio, gestito con ipoteri d’indagine degli ispettori e della Guardia diFinanza e finalizzato ad incrementare le entratepatrimoniali dello Stato”, così realizzando di fatto inchiave “dirigistica” un “vero e proprio governodell’economia e del mercato” (G. FLORIDIA, Il coordinamento tracontrollo autodisciplinare e controllo amministrativo delle pratiche sleali,cit., p. 177). Sull’ulteriore rafforzamento dei poteridell’AGCM nella nuova versione del Codice del consumo, v.A. LEONE, Pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette fra tuteladel consumatore e delle imprese, in Dir. ind. , 2008, 3, pp. 263-264.Sui poteri dell’autorità in materia di pratiche commercialiscorrette, A. GAGLIARDI, Pratiche commerciali scorrette, Torino,2009, p. 33 ss. Sul recente esaurimento della spintapropulsiva delle Autorità indipendenti e sull’opportunitàdi un riordino a carattere non generale ma settoriale, v.M. CLARICH, Le autorità indipendenti. Dopo l’ascesa il declino?, in IlMulino, 2005, 2, p. 271 ss.97 Corsivo mio.
78
quelli derivanti dall’applicazione dei codici dicondotta: se la valutazione circa l’opportunitàdi prevedere un ricorso preliminare ad organismiassimilabili al nostro Giurì autodisciplinareveniva demandata dalla Direttiva europea aisingoli stati, infatti, era per far sì che neidiversi ordinamenti venisse valutatal’autorevolezza di tali organismi e la diffusionedei relativi strumenti di soluzione dellecontroversie. Il nostro legislatore, perconverso, pur a fronte di un sistemaautodisciplinare efficace, prestigioso e in gradodi coprire praticamente l’intero settore, haritenuto di non doversi avvalere di tale sistema,ripiegando su meccanismi di coordinamento debolie tutto sommato inefficaci98.
La vigente disciplina di raccordo tra
98 Una scelta politica nella quale è stata intravista una“volontà di istituire una vera e propria polizia delmercato gestita con metodi autoritari e con il potere diimporre sanzioni pecuniarie che nulla hanno a che vederecon una tutela appropriata di interessi essenzialmenteprivatistici come sono non solo quelli dei concorrenti maanche quelli dei consumatori” (G. FLORIDIA, Il coordinamento tracontrollo autodisciplinare e controllo amministrativo delle pratiche sleali,cit., p. 178). Per un’interessante ed autorevoleautocritica allo strapotere dell’Autorità in materia dicontenzioso pubblicitario, in specie all’eccessivapropensione a sanzionare le condotte scorrette, v. A.CATRICALÀ, Intervento, in La correttezza della pubblicità tra Autodisciplina econtrollo pubblico, cit., p. 2-3. Sull’attrito tra logicadell’autoregolazione ed attribuzione di poteri diregolazione e vigilanza alle Autorità Garanti, v. L.FRANZESE, Ordine economico e ordinamento giuridico, cit., p. 50 ss.
79
procedimenti autodisciplinari e procedimentiamministrativi, oggi allocata nel Codice delconsumo, è coerente espressione di unatteggiamento del legislatore formalmenteorientato a valorizzare i dispositivi diautoregolazione e controllo interni alleorganizzazioni professionali99, ma sostanzialmenterestio a realizzare una reale economia deigiudizi ed in specie a rendere obbligatorio ilricorso preventivo al controlloautodisciplinare100. Il meccanismo di raccordo,infatti, non è molto dissimile da quello giàprevisto dalla L. 74/1992: le parti possonoaccordarsi per avviare il procedimento
99 L’art. 27 bis stabilisce infatti che “Le associazioni ole organizzazioni professionali possono adottare, inrelazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o piùsettori imprenditoriali specifici, appositi codici dicondotta che definiscono il comportamento deiprofessionisti che si impegnano a rispettare tali codicicon l’indicazione del soggetto responsabile odell’organismo incaricato del controllo della loroapplicazione”. A tal proposito si è rilevato che unafunzione deflattiva possa essere efficacemente svolta solo“qualora gli stessi consumatori fossero coinvolti nellaformulazione di codici”, come suggerito dal Considerando n.20 della Direttiva 05/29/CE, e “adeguatamente informatidella loro esistenza” (G. TADDEI ELMI, sub art 27-27quater, inG. VETTORI (a cura di), Codice del consumo. Aggiornamento, Padova,2009, p. 136). 100 Per una critica dell’equilibrio scelto dal legislatoretra autorità amministrativa e sistema autodisciplinare, v.F. GHEZZI, Codici di condotta, autodisciplina, pratiche commerciali scorrette.Un rapporto difficile, in Riv. società, 2011, 4, p. 682 ss.
80
autodisciplinare prima di adire l’autoritàamministrativa o giudiziaria; ove il procedimentoautodisciplinare sia già in corso, possonoaccordarsi per attenderne la conclusione prima diadire l’autorità amministrativa101; ove invece siain corso il procedimento amministrativo, possonochiederne la sospensione in attesa che vengaemessa la pronuncia in sede autodisciplinare102.
La scelta del legislatore di non esigere
101 Si è notato in dottrina che la nuova formulazione delprimo comma dell’art. 27 ter ammetterebbe che le partipossano accordarsi in via preventiva ad intraprendere ilgiudizio autodisciplinare prima di ricorrere all’autoritàamministrativa; ciò non sarebbe stato possibile nellaprecedente disciplina, in cui l’art. 8 co. 2 del D.Lgs.74/1992 prevedeva che le parti potessero accordarsi in talsenso solo una volta “iniziata la procedura davanti ad unorganismo autodisciplinare”. 102 Recita infatti l’art. 27 ter: “I consumatori, iconcorrenti, anche tramite le loro associazioni oorganizzazioni, prima di avviare la procedura di cuiall’art. 27, possono convenire con il professionista diadire preventivamente il soggetto responsabile ol’organismo incaricato del controllo del Codice di condottarelativo ad uno specifico settore la risoluzione concordatadella controversia volta a vietare o a far cessare lacontinuazione della pratica commerciale scorretta. In ognicaso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunquesia l’esito della procedura, non pregiudica il diritto delconsumatore di adire l’Autorità, ai sensi dell’art. 27, oil giudice competente. Iniziata la procedura davanti ad unorganismo di autodisciplina, le parti possono convenire diastenersi dall’adire l’Autorità fino alla pronunciadefinitiva, ovvero possono chiedere la sospensione delprocedimento innanzi all’Autorità, ove lo stesso sia stato
81
l’attivazione del procedimento autodisciplinarecome condizione di procedibilità del ricorsogiurisdizionale o di quello amministrativo hareso di fatto inutile il meccanismo di raccordo,tanto che non risulta che l’Autorità garanteabbia sospeso un procedimento in attesa delladefinizione del caso in sede autodisciplinare.D’altronde un simile meccanismo, giàinsufficiente nella disciplina prevista dalla L.74/1992, si è rivelato tanto più inadeguato avalorizzare la funzione deflattiva dell’organismoautodisciplinare, pur richiamata dalle direttivecomunitarie, in un quadro normativo, quale quellodelineato dal D.Lgs. 49/2005, che prevedel’attribuzione all’Autorità garante non più solodi poteri inibitori attivabili su iniziativa diparte, ma più ampi poteri di controllo delmercato esercitabili d’ufficio e rafforzati damezzi inquisitori e sanzionatori103.
Una rinnovata collaborazione tra sistemaautodisciplinare e Autorità garante, perconverso, come segnalato da autorevole dottrina,potrebbe essere riattivata prevedendo, neiprocedimenti ad istanza di parte, la pronunciadel Giurì come una sorta di parere - obbligatorio
attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesadella pronuncia”. 103 “Una funzione autenticamente deflattiva e autogestitadel controllo autodisciplinare, ove non si ripristini lalegittimità comunitaria della disciplina delle pratichesleali, è irrimediabilmente pregiudicata dalla sostituzionedel rimedio inibitorio con quello delle misure pecuniarie”.
82
benché non vincolante - di cui l’Autorità debbacomunque tenere conto, salvo l’onere di motivareeventuali difformità104.
10. Il Cross Border Complaints System e il futurodell’autodisciplina pubblicitaria. Lo sviluppo del mercato alivello sovranazionale unitamente allaprogressiva ed inarrestabile migrazione di partedelle comunicazioni dai media tradizionali allarete telematica deterritorializzata segnala comela funzione dell’autodisciplina pubblicitaria,messa a rischio a livello nazionale da normativecome quella italiana, intese ad accentrare ipoteri di controllo in capo ad organidell’amministrazione, possa trovare adeguatavalorizzazione a livello sovranazionale105.
104 Così G. FLORIDIA, Il coordinamento tra controllo autodisciplinare econtrollo amministrativo delle pratiche sleali, cit., p. 179. Menocondivisivile, forse, è una soluzione più radicale in cui,sulla falsariga del meccanismo di raccordo previsto dalCodice delle comunicazioni, si preveda che l’Autoritàdichiari la propria incompetenza quando entrambe la partivi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezziper la soluzione della controversia (G. MANFREDI, Giurì diautodisciplina, autorità indipendenti e autorità giudiziaria, cit., p. 65).Sulle prospettive dell’autodisciplina pubblicitaria, v.altresì L.C. UBERTAZZI, Le PCS ed il futuro dell’autodisciplina, inDir.ind., 2010, 4, p. 377 ss.105 E ciò tanto più in considerazione del fatto che mentrele regolamentazioni autodisciplinari convergono almeno suiprincipi fondamentali, le legislazioni degli Stati europeiin materia di pratiche commerciali scorrette presentanorilevanti differenze. A queste, com’è noto, ha cercato difar fronte la Direttiva 05/29/CE. Su ciò v. F. BENATTI, La
83
Uno sforzo in tal senso sembra essere statogià dispiegato dagli organismi autodisciplinaridei principali paesi europei i quali nel 1989 -trasformando la preesistente European AdvertisingTripartite - si sono associati nella EuropeanAdvertising Standard Alliance (EASA). All’EASA,associazione internazionale di diritto belgariconosciuta dal 1994, hanno poi aderito iprincipali rappresentanti dell’industrypubblicitaria. L’obiettivo dell’Alleanza è nonsolo di promuovere la diffusione dei sistemiautodisciplinari in Europa e la condivisione dispirito nei criteri di controllo adottati daisistemi autodisciplinari106, ma per quanto
recente evoluzione in materia di pubblicità, in Giur. It., 2007, p. 1684ss. V. anche G. DEODATO, L’autodisciplina pubblicitaria e il suo giurì, inImpr. St., 2008, p. 17 ss. Sulle nuove dimensionidell’autodisciplina pubblicitaria, v. F. UNNIA, Autodisciplinapubblicitaria, via europea al controllo, in Impr. St.., 2008, p. 20 ss.;S. GAMBUTO, La pubblicità oltre i confini nazionali, in A. FRIGNANI, W.CARRARO, G. D’AMICO (a cura di), La comunicazione pubblicitariad’impresa, cit., p. 51 ss. Che tale sia la prospettiva, nonsolo a livello europeo, è confermato dal fatto che il 15settembre del 2011 la Camera di Commercio Internazionale hapubblicato la nuova edizione del Code of Advertising and MarketingCommunications (avente ad oggetto per la prima volta anchel’importante fenomeno dell’Online Behavioural Advertising) chedovrebbe essere progressivamente recepito dai codici dicondotta nazionali e comunque diventare un paradigma diriferimento per le best practices a livello mondiale inmateria di comunicazione.106 Sulle peculiarità del sistema autodisciplinare italianorispetto ai principi fatti propri dall’EASA, v. R.CORTOPASSI, L’autodisciplina nella realtà pubblicitaria, in Impr. St., 1997,http://impresa-stato.mi.camcom.it/im_40/cortopassi.htm). Sui caratteri
84
possibile di garantire l’eguaglianza ditrattamento dei casi denunciati.
Pur essendo diffusa la consapevolezza dellosviluppo globale del fenomeno pubblicitario,un’armonizzazione delle diverse normative stataliin materia pubblicitaria è al momentoimpensabile. Una soluzione efficace, e forse nonsolo sul breve periodo, è stata individuataproprio dall’EASA, che ha adottato dal 1992 ilCross Border Complaints System, un sistema in virtù delquale il consumatore del paese nel quale vienediffuso il messaggio pubblicitario puòbeneficiare delle stesse tutele previstedall’ordinamento del paese dal quale il messaggioviene diffuso. Grazie a tale sistema dicollegamento in rete tra ordinamentiautodisciplinari, infatti, viene garantita tutelaal consumatore senza gravare sui Tribunali né suibilanci degli Stati. La procedura prevede,infatti, che il consumatore presenti un’istanzadi fronte agli organismi autodisciplinari delproprio paese affinché prendano in esame il casoe provvedano in ordine all’archiviazione oall’avvio della fase successiva della proceduracon l’inoltro della pratica all’organismoautodisciplinare competente nel paese da cui ilmessaggio è stato diffuso.
Il sistema ora tratteggiato rispetta ilprincipio di territorialità, in quanto demanda il
del sistema autodisciplinare inglese e sulla suapropensione al dialogo con la società civile, v. F. UNNIA,Autodisciplina pubblicitaria, cit., pp. 21-22.
85
giudizio agli istituti nazionali diautodisciplina, ma in realtà si fonda sul mutuoriconoscimento tra ordinamenti autodisciplinari.Il modello di integrazione sembra essere quellodi una rete di coordinamento tra le normativesostanziali e processuali nel quadro di alcuniprincipi comuni. A tal fine i membri dell’EASAhanno sottoscritto nel 2002 un documentocontenente common principles contenenti standard dicorrettezza da rispettare per operare secondo bestpractices. Un efficace sistema europeo di controlloautodisciplinare, d’altronde, come si legge inuna sorta di considerando di tale dichiarazione,“dipende dall’applicazione di un insieme diprincipi che fondano il sistema e che sianocomuni a tutti”.
È auspicabile che, nella prospettiva di unconsolidamento di tale rete europea dei sistemiautodisciplinari, tale importante dichiarazione,generata dal comune sforzo dei componentidell’EASA, possa trasformarsi in vera e propriacarta europea dei principi autodisciplinari inmateria di pubblicità commerciale e chesull’effettivo rispetto di tali principi nellepronunce dei Giurì nazionali possa esserechiamato a decidere un Giurì europeo che assurgaa giudice di legittimità.
Una simile ipotesi non contraddice ma portaa coerente compimento sia la costruzione ‘a rete’del Cross Border Complaints System europeo sia ilprincipio dell’insindacabilità delle pronunceautodisciplinari ai sensi del CAP italiano. La
86
decisione del Giurì istituito presso l’IAP,infatti, rimarrebbe definitiva salvo lapossibilità di un’impugnazione per nullità nelleipotesi previste dall’art. 808-ter c.p.c. (adesempio per violazione del contraddittorio)nonché di impugnazione di fronte al Giurìistituito presso l’EASA per violazione deiprincipi europei in materia di comunicazionicommerciali (ad esempio per errata applicazionedel principio). Se c’è un profilo, peraltro,sotto il quale il pur autorevolissimo sistemaautodisciplinare italiano meriterebbeun’implementazione questo riguarda proprio ilpieno rispetto della parametro di cui al n.25.4.4 dei common principles, secondo cui neisistemi autodisciplinari nazionali “dovrebberoessere previste adeguate procedure di appello odi revisione”.
Il corretto orientamento per un edificandosistema autodisciplinare europeo, invero, sembraproprio quello suggerito dal n. 28.1 dei commonprinciples: aprirsi sempre più verso “una convergenzatra i sistemi di autodisciplina, la loro amministrazione e leprocedure, sulla base di riconosciuti standard dicorrettezza”.
87