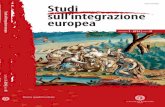FORME DI GIUSTIZIA TRA MUTAMENTO E CONFLITTO SOCIALE
Transcript of FORME DI GIUSTIZIA TRA MUTAMENTO E CONFLITTO SOCIALE
5
Le ideologie
sono i cosmetici del potere, ma perché mai il potere ha bisogno di truccarsi?
Friedrich Dürrenmatt
6
SOMMARIO
Presentazione della Seconda Edizione pag. 7 Presentazione pag. 9 Introduzione pag. 11 Studio n° 1: Dal pluralismo delle istanze al pluralismo degli interessi pag. 18 Studio n°2 : Appartenenza ed estraneità: la giustizia degli altri pag. 51 Studio n°3: Maometto, il Naufrago e il Lupo: per una giustizia da teatro pag. 91 Studio n°4: Lo Straniero e la Giustizia pag. 126 Studio n°5: In nome del popolo italiano pag. 178
7
PRESENTAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE
Un aggiornamento sotto forma di ampliamento perché il volume continui a vivere e non ingiallisca. A distanza di quattro anni dalla sua prima edizione questo volume doveva mantenere un impegno ed una promessa, l’uno e l’altra manifestati già dalle sue prime battute, riprendere un percorso ed una riflessione che nelle nostre intenzioni non doveva arrestarsi a quel punto ma che proprio da quel punto partiva per uno sviluppo ulteriore. E questa ulteriore riflessione ha riguardato uno dei tempi più scottanti dell’intero panorama della giustizia, quello della discrezionalità giudiziaria che da molti anni costituisce per noi una spina nella mente, ma che al di là delle nostre modeste considerazioni costituisce il tema dei temi per chi, più autorevolmente di noi, si è occupato e si occupa di questa specifica problematica. Problematica che a dire il vero mai come in questi ultimissimi anni si è fatta sempre più sanguinante e sempre più ha assunto un rilievo parossistico quanto meno nelle considerazioni più comuni, quelle della “gente”, per così dire, informata e attenta ad osservare un fenomeno che per molti versi si colora di tratti quasi cabalistici: essere giudicati a latitudini giudiziarie nazionali differenti significa soprattutto avere la certezza dell’incertezza del proprio destino. Come mai, ci si potrà chiedere, questa e queste problematiche hanno visto e vedono un’attenzione più spasmodica da parte della “gente” che da parte dello studioso professionale? La risposta è tutta contenuta nell’analisi dell’ultimo decennio e particolarmente dell’ultimo quinquennio della nostra storia
8
nazionale attraversata da una crisi socio-economica che per molti versi ne ha mutato l’identità e la dimensione, e attraversata da uno scontro politico di inaudita violenza in mezzo a cui il tema della giustizia ha costituito l’occasione e l’agone politico del confronto prima ancora, e più ancora, che quello più tecnicamente giudiziario con cui gli schieramenti si sono fronteggiati. Se è vero che il saggio scientifico, o almeno una gran parte di questi, ha una vita breve e talora brevissima abbiamo una presunzione che non vogliamo tenere nascosta, che il nostro è ancora di sicura attualità. Merito certamente non nostro, null’affatto, né merito delle nostre considerazioni, il merito è solo e soltanto di una felice coincidenza in una infelice coincidenza: il tema della giustizia è straordinariamente all’attenzione con una quotidianità che inquieta più che rassicurare, che fa riflettere più che tranquillizzare. Per parte nostra che abbiamo negli occhi e nella mente questa quotidiana realtà intendiamo semplicemente avanzare delle modeste considerazioni e, come dicevamo nella presentazione dell’altra edizione, intendiamo parlare, a voce bassa, solamente di “forme” di giustizia, piccole sfere di un universo e in un universo, i cui confini non sono soltanto indistinguibili ma mai neppure tracciati.
9
PRESENTAZIONE
Cinque studi, parte di un percorso e di una riflessione che data ormai da anni e che negli anni si sviluppa e che al momento della seconda edizione del volume non si è ancora conclusa ma che anzi da questa trae nuova linfa e nuovo vigore per ispezionare un universo che si fa sempre più oscuro e sconosciuto Un percorso ed una riflessione che nelle intenzioni non si arresta a questo punto, ma che, anzi, proprio da questo punto parte per uno sviluppo ulteriore. Al tema ed ai temi della giustizia fanno da sfondo costante i temi del mutamento sociale e del conflitto sociale, perché l’uno e l’altro di queste grandi problematiche sono l’elemento ineliminabile di ogni considerazione al riguardo, la strettoia obbligata attraverso cui qualsiasi riflessione sul tema deve passare, e in secondo luogo perché, mi sia consentito, questo è il nostro gusto scientifico preponderante e l’insegnamento dei nostri maestri. Mutamento sociale e conflitto sociale che, ancor più che lo sfondo, costituiscono la sfida alle norme e alla giustizia; come ho già notato in una precedente occasione il conflitto e la complessità sociale, e, aggiungiamo ora, il riflesso del mutamento sociale, non sono lì a bella posta per essere risolti da alcuno né da alcunché, anzi tra queste situazioni sociali c’è un’osmosi talmente forte che l’una condiziona l’altra in una rincorsa irrefrenabile, in cui le norme non
10
sono neanche sassolini di disturbo sull’asfalto della complessità e del conflitto. Della giustizia, del suo tema, e dei suoi temi, intendiamo parlare con voce assai sommessa, quasi sottovoce, convinti come siamo che forse al di là della nostra modesta voce anche altri voci, più forti e più autorevoli della nostra si smarriscono. A voce bassa intendiamo parlare solamente di “forme” di giustizia, piccole sfere in un universo, e di un universo, i cui confini non sono soltanto indistinguibili ma mai neppure tracciati.
11
INTRODUZIONE
Una considerazione organica e unitaria innestata su un progetto organico e unitario, una riflessione sull’universo della giustizia, e sul suo quotidiano estrinsecarsi. Una riflessione che per il momento e solo in parte preferisco affidare a questo agile volume, perché solo in parte e fin qui è compiuta. L’intenzione è più ampia, parte da lontano e vuole arrivare, se sarà possibile e ce ne saranno le capacità, un po' più lontano: una riflessione a tutto campo sul mondo della giustizia. Ma sfiorando appena l’idea di giustizia perché, ed è forse opportuno uscire immediatamente allo scoperto, non crediamo che esista o possa esistere un’idea di giustizia. Un’idea di giustizia, si intende, unica e universale, o quantomeno unitaria e largamente condivisibile. In questo senso l’idea di giustizia è, a nostro avviso, puramente e semplicemente emozionale, ancor più che un sentimento, una voglia repressa, o anche espressa, insopprimibile e irrefrenabile. Un’emozione, nient’altro che questo, e, come tutte le emozioni,
12
razionale ma assai spesso anche irrazionale, un voler che sia piuttosto che un sia da volere. Sotto questo punto di vista l’idea di giustizia, questa idea di giustizia, non ci appartiene perché non afferisce ai nostri gusti scientifici né ai nostri gusti umani. In linea con la tradizione culturale cui ci sentiamo legati ed a cui esprimiamo la nostra propensione, la cultura e la tradizione conflittualista, un’idea, unitaria, e per ciò solo dogmatica, è da rifuggire come il peggior pensiero che possa attraversare la mente umana. Specie quando questa idea investe in pieno i princî pi primari dell’uomo e della società, e quello della giustizia fra questi, e tra i primi fra questi. Eppure, e proprio in questa logica, non siamo sfuggiti, volutamente, alla tentazione di discutere di questa idea, proprio con l’intenzione di evidenziarne i punti scientificamente più deboli e i pericoli più macroscopicamente reali. Perché non abbiamo mai smesso di dimenticare, neppure per un attimo, che dietro l’idea e il concetto di giustizia si muovono figure umane “in carne ed ossa”, con i loro drammi, le loro debolezze, le loro protervie, le loro acquiescenze. In una parola, con tutto il loro essere. Sul tavolo della giustizia c’è e si spende la pelle dell’uomo. Non un’idea, non un’emozione, non un pacchetto di teorie filosofiche, sociologiche o giuridiche. Solo e soltanto la pelle dell’uomo. Il suo destino, il suo passato e il suo futuro. Il destino di tutti quegli uomini che in qualche misura sono coinvolti sul tavolo della giustizia, da attori, da comprimari o da semplici comparse. Ma soprattutto il destino dei più deboli. Perché, senza volersi nascondere dietro un dito, la giustizia incide più sui deboli che sui forti e ai deboli incute timore più che ai forti, più ai poveri che ai ricchi. Proprio perché la giustizia non è un’idea, non è un’emozione, non è una sensazione da condividere o da combattere ma è qualcosa di reale, terribilmente reale e concreta, è un’impronta lasciata sulla
13
pelle di chi l’ha provata e la prova, è un marchio indelebile che si imprime più incisivamente su chi ad essa non può o non sa sfuggire. Quindi la giustizia da voglia di tutti, voglia che sia “giusta”, “perfetta”, “efficace”, “equanime” diventa una realtà concreta per pochi o per molti, ma non per tutti indistintamente, ma solo per coloro che della giustizia partecipano direttamente. Da un’invocazione indeterminata e generica diventa, allora, un grido distinguibile e qualificato da un nome e da un cognome, un grido personalizzato; una voce specifica e inconfondibile, da riferire a questo o a quell’uomo singolarmente. Ma oltre questo non potevamo trascurare temi a noi più sentitamente cari, quali il rapporto tra giustizia e potere, e quello, intimamente connesso, della rappresentatività sociale della giustizia; chiedendoci, cioè, che grado di riferibilità può avere, e in concreto ha, una decisione giudiziaria, e più in generale la giustizia, in riferimento all’applicazione di una norma giuridica (“legge”, se si vuole) che ha sì, sotto il profilo strettamente formale, una valenza generale ed astratta (come negarlo?) ma sotto quello più strettamente sociologico ha una valenza più ristretta, che lascia trasparire in controluce, e chiaramente, la riferibilità sociale ad un determinato gruppo o a determinati gruppi sociali. Non crediamo possa esserci chi voglia negare che la norma giuridica al di là che essere una previsione generale ed astratta è una previsione specifica e concreta per la regolazione sociale ed economica di fattispecie sociali specifiche e individuabili. Se così è il punto focale non è per noi quello di puntualizzare il ruolo politico della magistratura, che pure non disconosciamo, quanto quello di verificare e discutere il rapporto tra la norma (meglio “la legge”), il giudice e il soggetto che in concreto è investito dalla decisione e dalla norma.
14
Il vero punto di domanda é per noi che tipo di decisione può scaturire e in concreto scaturisce dall’applicazione e dall’interpretazione di una norma che è il prodotto più visibile di una contrattazione socio-politica inegualitaria, condotta fra gruppi socio-politici che misurano rapporti di potere assai differenti fra di loro, e condotta all’interno di gruppi che gettano sul piano della contrattazione capacità di contrattazione, di resistenza e di forza profondamente squilibrate e disequilibrate rispetto alle altre? Il problema, ed è uno dei problemi più assillanti della nostra società, e in genere di tutte le società altamente complesse, è, allora, quello di verificare che validità reale, e soprattutto nei confronti di chi, può avere, e in concreto ha, una norma che è frutto di una contrattazione approvata in un luogo, il parlamento, in cui predominano le rappresentanze di interessi o che comunque abbia perduto di rappresentatività politica in senso stretto e si trasforma in un organo ratificatore di decisioni prese altrove. Tutto questo genera una considerazione: se la norma giuridica, in un numero rilevante di casi, ed anzi in un numero sempre più rilevante di casi “aderisce” ad un gruppo sociale più che ad un altro, come un abito tagliato e confezionato su misura, la decisione giudiziaria, che da questa norma scaturisce, “aderisce” anch’essa ad un gruppo sociale più che ad un altro? Che grado di rappresentatività, e nei confronti di chi, possiede una decisione giudiziaria che si fonda su una norma così costruita? Un tema questo ed una domanda a cui è dedicato quasi interamente il secondo degli studi contenuti in questo volume, ed a cui abbiamo tentato di dare una qualche risposta, analizzando anche dall’interno il meccanismo del passaggio dalle istanze sociali alle istanze giuridiche, un tema quest’ultimo sviluppato nel primo dei quattro studi. Il terzo dei studi presentati in questo volume è tutto dedicato al rapporto tra giustizia e potere.
15
Se il giudice interprete della legge, del conflitto sociale e del fatto è stato oggetto di attenzione negli studi precedenti in questo emerge unicamente la figura del giudice osservatore: “il profeta Maometto è in cima a un colle in un luogo solitario”. La giustizia giudica dall’alto! Perché il potere, di cui la giustizia è parte in quanto braccio armato, osserva e giudica dall’alto! Ma qui non abbiamo fatto muovere personaggi “reali”, abbiamo fatto muovere personaggi di teatro e da teatro. Due grandissimi creatori di situazione teatrali Dürrenmatt e Mrozek, e i loro personaggi. Personaggi “reali” ma di teatro, protagonisti “veri” ma da palcoscenico, situazioni “tangibili” ma di cartapesta. Perché se la giustizia è dramma anche il teatro è dramma. Anche iconograficamente e scenograficamente sia la giustizia che il teatro si manifestano allo stesso modo, con rappresentazioni e con celebrazioni. Da questo punto di vista l’accostamento è perfetto: si celebra il processo come si celebra la commedia, si rappresenta una realtà giudiziale come si rappresenta una realtà teatrale. Come ha ricordato un grande maestro «il processo è una rappresentazione drammatica: ruoli, personaggi, battute, risposte, sono elementi talora così plastici ed evidenti da costituire le parti di un dramma non scritto né immaginato ma reale. Non può quindi sorprendere che il processo e la principale figura che vi inerisce, il giudice, siano divenuti non poche volte argomenti di opere letterarie. Spesso anzi la sostanza drammatica del processo e del suo principale personaggio è lo spunto e la materia di opere altamente espressive di una condizione sociale o addirittura della condizione umana». Dramma e giustizia, giustizia e dramma: l’accostamento è perfetto! E soprattutto, reale!
16
Il quarto studio accosta alla tematica del dramma e della giustizia quella dello psico-dramma vissuto attraverso la narrazione di Albert Camus: lo straniero e la giustizia, che diventa lo Straniero e la Giustizia nella personalizzazione dell’autore. Anche qui personaggi “veri” ma da scrittura romanzesca, situazioni “reali” ma costruite ai fini di un racconto. Questo è, nelle nostre intenzioni l’epilogo logico e immancabile delle nostre considerazioni fin qui spese: la consapevolezza dell’ineluttabilità della giustizia di fronte alla certezza della “estraneità” da questa ed a questa, la voglia di sentirsi e di essere straniero di fronte alla giustizia, senza aggettivazione alcuna; senza mai porsi la domanda se questa sia giusta o ingiusta, se ci appartenga o no. L’estraneità è anche e soprattutto in questo, nel non porsi domande né darsi risposte, nel non sentirsi partecipi di un rito a cui necessariamente si presenzia, nel non contestare nulla perché nulla ci appartiene direttamente. Una accettazione totale, non rassegnata, solamente distaccata, lontana, estranea. Il quinto studio “In nome del popolo italiano” è evocativo sin dal titolo del suo sviluppo, intende indagare il mondo, drammaticamente oscuro, della sentenza, sotto il profilo specifico della sua rappresentatività. Tema questo che solo apparentemente è popolato di un bagaglio rilevante di analisi e ricerche ma che in realtà in molti, ed anzi moltissimi, suoi aspetti rivela una straordinaria esiguità di riflessioni. Certo, il panorama nazionale e internazionale, specie di matrice anglo-sassone, presenta alcuni, e non pochi a dire il vero, pregevolissimi studi sulla sentenza ma pare a noi che talora sia stato trascurato un tema che ci pare essenziale, quello della rappresentatività della sentenza stessa. Ci si chiede, cioè, che grado di rappresentatività possegga nel nostro ordinamento la decisione giudiziaria, e, più in specifico, quale sia il rapporto tra la decisione del caso che ha originato la
17
decisione e i generici casi che possono rientrare nella fattispecie decisa, e, in sostanza, se la fattispecie specifica oggetto della decisione sia genericamente riferibile alla fattispecie generale ed astratta di cui alla previsione normativa o se piuttosto non costituisca una fattispecie così singolare da non essere in tutto o in parte riferibile ad una previsione generica che valga per tutti i soggetti sociali o non piuttosto ad alcuni di questi Se uno dei problemi più assillanti della nostra società, e in genere di tutte le società altamente complesse, è quello di verificare che validità reale, e soprattutto nei confronti di chi, può avere, e in concreto ha, una norma che è frutto di una contrattazione approvata in un luogo in cui, per usare le parole di un prestigioso studioso italiano, predominano le rappresentanze di interessi o che comunque abbia perduto di rappresentatività politica in senso stretto e si trasforma in un organo ratificatore di decisioni prese altrove non può che conseguirne che il problema a questo connesso è quello di chiedersi che grado di rappresentatività possiede una decisione giudiziaria che si fonda su una norma così costruita, e che rispetto a questa presenta, anzi, un’ulteriore variabile, che ne fa un unicum rispetto alla norma stessa, la discrezionalità della decisione e nella decisione. Nel nostro percorso di riflessione ci hanno confortato e supportato voci altissime di studiosi e coscienze critiche di impareggiabile statura, alle une e alle altre ci siamo riferiti nei nostri scritti e abbiamo preferito citarle direttamente perché non si perdesse il gusto diretto ed immediato delle loro parole.
18
Studio n.1
DAL PLURALISMO DELLE ISTANZE AL PLURALISMO DEGLI INTERESSI
.1 Un'idea. Un'emozione Com'è noto il concetto di giustizia è uno dei temi più universali e più controversi nell'intero panorama dei fenomeni sociali, e più ancora che il campo dei fenomeni sociali il concetto di giustizia investe direttamente la sfera ontologica, l'essenza stessa dell'uomo nelle sue manifestazioni sociali e nelle sue costruzioni sociali, in una parola nei suoi insediamenti sociali, al punto che il concetto di giustizia da sempre finisce per essere un concetto per diventare invece un'idea. In questo senso e in questo significato linguistico l'espressione «giustizia» è universalmente più usata e più diffusa dell'altra, quello di concetto di giustizia.
19
Com'è evidente questa determinazione linguistica non è né casuale né ininfluente, al contrario è densa di significati e decisiva per poter cogliere, immediatamente e a prima vista, il senso del termine giustizia. E' altrettanto evidente che questa attribuzione diretta e immediata del termine al significato, e direi più propriamente al senso, del termine giustizia è rimessa al singolo individuo, a colui, cioè, che singolarmente medita e mediti sul significato del termine e sulle sue implicazioni. Il passaggio dal concetto all'idea di giustizia ha quindi un suo primo significato e una sua prima motivazione proprio nella maggiore comprensibilità che l'espressione incontra a livello individuale. L'idea di giustizia è prima di tutto un sentimento, intimo e personale come ogni altro sentimento, e come tale profondo, radicato, legato alle più diverse sfumature del carattere e delle esperienze proprie e familiari. In altri termini, l'idea di giustizia ha una valenza più immediata dell'altra, quella di concetto, proprio perché l'espressione concetto è di per se stessa spersonalizzata e anonima; l'espressione idea è, al contrario, carica di una valenza che la riporta al sentimento, ossia al modo di sentire e di intendere. Friedrich Dürrenmatt, il grande drammaturgo svizzero, che al tema della «giustizia» ha dedicato quasi interamente la sua vasta pro-duzione letteraria, nell'unico saggio scientifico, non scenografico, da lui espressamente dedicato a questo tema scrive che «la giustizia è un'idea che presuppone una società di persone. Un uomo solo su un'isola può trattare le sue capre in modo giusto e basta. Un'idea, ribadisce l'autore, la si può pensare, il problema è se si possa realizzarla, se si possa costruire un ordinamento sociale giusto come, ad esempio, si può costruire una macchina1. L'uomo -
1L'occasione di questo scritto di Dürrenmatt è l'invito rivoltogli dall'Università di Magonza nel 1968 a tenere una conferenza sul tema della giustizia e del diritto.
20
prosegue l'Autore- può costruire ciò di cui arriva a farsi un concetto esatto partendo da concetti esatti. Dai concetti esatti egli sviluppa sistemi e strutture esatte per gli ambiti del suo pensiero e del suo mondo, vale a dire i numeri, il secondo, il metro, il denaro, gli strumenti scientifici, le macchine ecc. ecc., solo lui stesso non si lascia trasformare in un concetto esatto»2. Da questa osservazione scaturiscono, per l'Autore, conseguenze differenti e inconciliabili per gli uomini. Seguiamo compiutamente il suo discorso, pur se in maniera sintetica. Il fatto che l'uomo, osserva Dürrenmatt, sia l'unico concetto "non esatto" implica che egli esprime un concetto duplice, che cioè definisce allo stesso tempo qualcosa di particolare e qualcosa di generale; tramite il concetto particolare che ha di se stesso l'uomo si isola, tramite il concetto generale egli si associa ad altri uomini, con il concetto particolare egli si attiene alla sua libertà mentre con il concetto generale egli rinuncia alla sua identità per diventare una funzione del concetto generale. L'uno, il concetto particolare, è un concetto esistenziale, l'altro, il concetto generale, è un concetto logico. Questa doppiezza di concetti genera due diversi modi di intendere la socialità in generale: «nel momento in cui con il suo pensiero elabora due concetti di se, l'uomo diventa paradossale. Il concetto generale che egli si fa di sé non comprende il concetto particolare che egli pure si fa di se stesso. Nel concetto generale l'uomo esclude se stesso come individualità».
Da questa circostanza scaturisce un libro magistrale che comprende sia il discorso tenuto dinanzi agli studenti sia una elaborazione ampliata succes-sivamente in base alla discussione scaturita nel corso dell'incontro. Si veda F. Dürrenmatt, I dinosauri e la legge, trad. it. a cura di Eugenio Bernardi, Einaudi, Torino 1995. La citazione è contenuta a pag.20. 2Ibidem.
21
Tutto questo rileva, per Dürrenmatt, direttamente nella costruzione di un ordinamento sociale giusto in quanto esistono due possibilità di costruirlo partendo dal materiale uomo di cui disponiamo, partendo, cioè, o dal concetto particolare di uomo, ossia dall'individuo, o dal concetto generale di uomo, ossia dalla società. Nell'uno o nell'altro caso il tipo di giustizia che ne deriva sarà differente («se l'uomo stabilisce due concetti di sé, egli ha anche due idee di giustizia»). Il diritto del singolo consiste nel fatto di essere se stessi, e questo diritto è il diritto di libertà, il diritto della società consiste, invece, nel garantire la libertà di ciascuno e questo diritto è la giustizia. Il rapporto della libertà con la giustizia, conclude sul punto l'autore, è problematico: «l'idea esistenziale di libertà si trova su un piano diverso rispetto all'idea logica di giustizia. Un'idea esistenziale è data dall'emozione, un'idea logica è una concezione intellettuale». La conclusione cui perviene l'autore rispondendo all'interrogativo su cosa sia un ordinamento sociale giusto è nel senso che «gli ordinamenti sociali, a causa delle emozioni su cui si basano, sono di per sé strutture fallite non solo per quanto riguarda la giustizia ma anche la libertà», e che, quindi, gli ordinamenti sociali sono ordinamenti ingiusti e non liberi. «Peggio ancora - afferma l’Autore- non esiste un ordinamento sociale giusto perché l'uomo, se cerca la giustizia, ha ragione a trovare ogni ordinamento sociale ingiusto, e se cerca la libertà, ha ragione a trovarlo privo di libertà»3. Un'idea personale, quindi, quella di giustizia e forse meglio, per dirla con Dürrenmatt, un'emozione. In questo senso e con questa valenza l'idea di giustizia ha sfidato i secoli e i millenni ed è diventata, come si diceva prima, non più un
3Ivi, pp.20-48.
22
concetto e neanche un'idea ma un interrogativo universale e ontologico. Un interrogativo, si badi bene, che investe non solo l'ambito più specifico e più marcatamente professionale della giustizia, in senso stretto, ma qualsiasi ambito sociale e relazionale in cui rientri una qualche idea di giustizia, foss'anche larvata o indiretta. E' il caso, per esempio della scienza, della religione, di una qualsiasi istituzione sociale, di un qualsiasi comportamento sociale o di un qualsiasi atteggiamento sociale e persino di una qualsiasi attività ricreativa.4 E l'interrogativo finisce per diventare un aggettivo quando ci si domanda se sia «giusto o giusta» un'azione, un comportamento o più genericamente una cosa, quindi un interrogativo aggettivato. E' questo un problema dei problemi che da sempre agitano l'intero ambito sociale, ivi compreso quello giuridico ovviamente. Quando l'idea di giustizia si aggettiva con il termine «giusta» l'ambito delle analisi teoriche e delle applicazioni pratiche si complica a dismisura, si apre una voragine interpretativa che non si riesce, né si riuscirà mai, a colmare. I tentativi in questo senso non sono mancati da parte degli studiosi delle più diverse discipline, specie di quelle filosofiche e logiche, ma l'orizzonte pur arricchendosi sempre più di pregevoli e pregevolissimi apporti si è sempre più articolato e perturbato. Ed ancor più hanno contribuito a disarticolare il quadro quelle analisi che si sono prefisse l'impresa, e direi la pretesa, di qualificare con i più diversi significati l'aggettivazione del termine «giusta» riferito all'idea di giustizia.
4Per una trattazione assai approfondita dell'idea di giustizia si veda Enrico Opocher, Analisi dell'idea della giustizia, Giuffrè, Milano 1977.
23
Pensiamo, per esempio, al tentativo, assai noto, e a nostro modesto avviso un pò ingenuo, di Perelman5 il quale finisce per elencare e, a dire il vero, per criticare i diversi e più comuni, nel senso di linguaggio più corrente, significati che il termine «giustizia giusta» ha storicamente assunto o può logicamente assumere. La difficoltà che questi tentativi, e anche gli altri scientificamente più articolati e più sostanziati6, è quella insita in un'osservazione che dal punto di vista sociologico e sociologico giuridico in particolare, non trova via di scampo, e cioè che tanto il concetto o l'idea di giustizia, tanto la sua aggettivazione - «giusta» - fanno riferimento a «valori» che sono direttamente legati a un solo concetto, a una sola idea, a un determinato contesto storico, a uno specifico contesto istituzionale, a una determinata composizione sociale: in una parola a valori che sono, e devono essere necessariamente relativi e non assoluti.7 E' sottinteso e evidente che dietro queste parole si agita, e neanche larvatamente, la contrapposizione tra assolutismo e relativismo dei
5C.H. Perelman, De la justice, Institut de Sociologie Solvay, Bruxelles 1945, trad. it. di Liliana Ribet, La Giustizia, Giappichelli, Torino 1959. 6Ci riferiamo, tra le tante, all'analisi, notissima, di John Rawls, A Theory of Justice, Harward University Press, Cambridge (Mass.) 1971, ed. it. Una teoria della giustizia, traduzione di Ugo Santini, a cura di Sebastiano Maffettone, Feltrinelli, Milano 1982. Più di recente nuove proposte di qualificazione del termine giustizia provengono dal saggio di Michael Walzer, "L'uguaglianza complessa", in Spheres of Justice: a Defense of Pluralism and Equality, Basic Books, New York 1983, ed.it. Sfere di Giustizia, trad. di Gianni Rigamonti, Feltrinelli, Milano 1987. Sul punto si veda anche l'antologia introdotta e curata da Salvatore Veca, Giustizia e liberalismo politico, Feltrinelli, Milano 1996. 7John Rawls, com'è noto, definisce la giustizia come la prima «virtù» delle istituzioni sociali. V. Rawls,Una teoria della giustizia, cit. pag.21.
24
valori, quali che questi siano, e «come» che questi siano8, ed è altrettanto evidente che per noi l'unica prospettiva possibile è proprio la più «prospettica», ma ci preme precisare che, in questo contesto, l'idea stessa di «valore» è un'idea talmente parcellizzata e polverizzata nei suoi significati che finisce per aderire a ciascuno di noi come una seconda pelle, qualcosa da cui è difficile distaccarsi e condividere, o dividere, con altri; diventa, insomma, un'idea di valore, relativa e pluralistica. Mario Cattaneo, nel ricordare la celebre affermazione che Platone attribuisce a Socrate «della giustizia e della saggezza, e di tutte quante le altre cose pregevoli alle anime, non c'è niente del loro splendore nelle copie di quaggiù», nota che questa frase indica in modo chiaro e preciso qual è il compito e insieme qual è la difficoltà della indagine filosofico-giuridica: si tratta infatti, prosegue l'autore, di ricercare e di mettere in luce il divario esistente tra questa idea e le «copie di quaggiù», ovvero gli ordinamenti giuridici esistenti, le leggi e le istituzioni positive con le quali abbiamo a che fare nella vita sociale e civile, leggi e istituzioni le quali, anche se talora vengono esaltate dalla retorica politica, in realtà non hanno nulla dello «splendore» dell'idea di giustizia. Il compito della riflessione filosofica sul diritto consiste,
8Decisamente propendiamo per un superamento della problematica sull'esistenza e la scelta di "valori", se mai questo fosse possibile e attuabile. In questo senso, e sotto questo specifico aspetto, mi accosto decisamente all'osservazione di Adorno che «l'intero problema del valore, che la sociologia e altre discipline, si trascinano dietro come una zavorra, è mal posto. Una coscienza scientifica della società che si compiace della propria avalutatività manca la cosa allo stesso modo di quella che si richiama a valori più o meno imposti e arbitrari». Si veda Theodor W. Adorno, "Sulla logica delle scienze sociali" in Adorno, Popper, Dahrendorf, Habermas, Albert, Pilot, Dialettica e positivismo in sociologia, trad. ital. di Anna Marietti Solmi, Einaudi, Torino 1972, pp.138-139.
25
per questo autore, proprio nella continua analisi del divario esistente tra l'idea della giustizia e la sua attuazione concreta 9. Tutto questo per noi vale decisamente non solo sotto l'aspetto filosofico-giuridico ma ancor più sotto quello sociologico e so-ciologico giuridico in particolare. Giulio M. Chiodi, in un'ampia riflessione sui diversi concetti del potere e le sue implicazioni, assegna alla giustizia la caratteristica di «luogo comune ideale», di natura puramente e semplicemente «simbolica»10. Ben pochi vocaboli, osserva l'autore, sono serviti a designare e a motivare le più contrastanti posizioni quanto quello di «giustizia» e del suo contrario «ingiusto»11, ma, nota più oltre Chiodi, al di fuori dei significati di giustizia connessi con le prassi giuridiche, il concetto di giustizia è oggi più che mai indefinito e gravato di suggestioni più psicologiche che sociali. In ogni caso conserva tuttora, circa la sua rilevanza politica, il valore di un generico sentimento limite, in cui confluiscono luoghi comuni non espressi. Quanto meno ad essa si fa esplicitamente appello, tanto più sono carenti nella società simboli etico-sentimentali, che si configurano in un insieme ideologico sufficientemente condiviso per essere vissuto e definito come giusto. E’ in questo senso che l'autore parla di «situazione allegorica», di «luogo comune ideale», e tanto più questo è vero tanto più il concetto di «giustizia» si svuota di contenuti collettivi (Chiodi usa propriamente l'espressione «contenuti simbolici») aggregativi del consenso. Infatti, per Chiodi è frequentemente impiegata dagli esponenti politici come appello aggregativo di carattere emozionale
9M.A. Cattaneo, Critica della giustizia, Lanfranchi, Milano 1996, pag. 11. Il riferimento a Platone è contenuto nel Dialogo Fedro, 250 a b, trad. it. di G. Galli, Firenze 1971, pag. 55. 10Giulio M. Chiodi, La menzogna del potere, Giuffrè, Milano 1979, pp.206-226. 11Ivi, pag.208.
26
e retorico, che rivela due aspetti significativi: è sostitutiva di argomenti o valori decisivi, di sicura capacità persuasiva, e si situa nella posizioni limite di extrema ratio simbolica, di ultimo richiamo simbolico12 E, conclude, sul punto l'autore, in assenza di valori condivisi dalla collettività in maniera indiscussa, questo richiamo retorico si ripromette ovviamente effetti d'indole emotiva, per indurre i cittadini all'ordine, all'autodisciplina, all'adeguamento, sostanziale, passivo; vuole, quindi, riferirsi in maniera generica e al tempo stesso risolutiva (a volte accorata), ad un impegno civile fondato su un impegno morale, ad un contegno i cui concreti contenuti comportamentali non possono essere specificati, ma rimangono allusi e lasciati per così dire all'intuito del cittadino stesso, che viene tuttavia sollecitato ad una sorta di stare decisis13. L'idea di giustizia finisce, quindi, per coincidere con un'idea di valore, o meglio con un'idea di una pluralità di valori, che non può in alcun modo essere condotta ad unità senza determinare forzature socio-politiche di tipo autoritario, se non proprio dittatoriali. .2 Pluralismo sociale e giustizia Ora, se questa idea di valore si presenta con una valenza unica (con riferimento, ovviamente, a un valore unitario) l'idea di giustizia è un'idea che incombe pesante sul capo di ciascuno di noi, tanto in qualità di soggetti sottoposti alla giustizia in maniera diretta, cioè in qualità di utenti specifici di giustizia, tanto in qualità di cittadini, cioè di utenti generici o potenziali di giustizia.
12Ivi, pag.224. 13Ivi, pag.225.
27
Solo l'individuazione e la scelta di una pluralità di valori e il trasferimento di questi in un'idea pluralista di giustizia può garantire ciascuno di noi da qualsiasi tentazione, reale o anche solo ipotetica, di gestione della giustizia separata e svincolata dalla molteplicità, dalla diversità e dalla pluralità delle istanze che ad essa pervengono e che da questa pretendono e attendono soluzione. Quindi l'idea di giustizia non ha un rapporto unitario, monovalente con se stessa, né può averlo, pena, lo ripetiamo, tentazioni reali o potenziali di assolutizzazione teorica e pratica, ma ha, e deve avere, un rapporto polivalente con se stessa e con i valori, la pluralità di valori, che le sono demandati da tutelare e da proteggere. In altri termini, non esiste la giustizia della giustizia perché il confronto non può (e non deve, per noi) avvenire con se stessa, non può, cioè, rimanere nel proprio ambito ma deve espandersi ben oltre questo e investire il rapporto, e i rapporti, con quei contenuti che le sono sì propri ma non in quanto tali ma in quanto demandati dalla collettività e per essa dalle più diverse componenti della comunità (pluralismo delle istanze sociali). D'altra parte una prova significativa di ciò può essere rappresentata dalla stessa distinzione tra giustizia, legge e diritto14; distinzione questa assai marcata e impegnativa che fa riferimento alla legge come ad uno, ed uno solo, dei possibili elementi che compongono il diritto: facciamo ricorso, per profondità e acutezza d'analisi, alle parole di Giulio M. Chiodi, il quale sostiene che «diversamente dal diritto la legge non ha per fine la giustizia, ma il controllo sociale (fine squisitamente politico). E il controllo sociale è appunto uno degli elementi che il diritto non può assolutamente trascurare, pur non essendo di per sé il suo obiettivo. Non va comunque trascurato
14Non è certo casuale che in questa circostanza e in questa fase dell'analisi stiamo parlando di pluralismo sociale e giustizia e non già di pluralismo sociale e legge nè tantomeno di pluralismo sociale e diritto.
28
che nella legge è sempre presente, se così ci si può colloquialmente esprimere, una forte dose di diritto. La legge -conclude l’Autore- sostanzialmente si presenta di necessità come un ibrido del diritto, di morale, di doveri e di comandi, di opportunità e anche di interessi "politici" dominanti. Con una forte semplificazione [...] si può anche dire che le legge è un misto di diritto e di scelte utili-taristiche o in senso lato politiche»15. Tutto questo non si può affermare neanche in minima parte per la giustizia né sotto il profilo tecnico, non è essa stessa diritto né legge ma servizio e apparato, né sotto quello sostanziale, non contiene né dispensa legge, e questa comunque (richiamiamo le parole di Chiodi) non ha per fine la giustizia, né si può assumere che il giudizio giuridico, cioè "di diritto" possa in qualche modo coincidere con l'idea di giustizia, non foss'altro perché i rispettivi piani operativi divergono in maniera assoluta, l'uno riguarda un profilo tecnico e strumentale, il diritto, l'altro un profilo simbolico e di apparato, la giustizia. Così espressa l'idea di giustizia muta decisamente ottica e e-spressione: non un rapporto con sé stessa, né con il valore ideale che questa rappresenta e che le è demandato di rappresentare (ovviamente da chi il valore sceglie e riassume, definisce e tra-smette, omologa e trasferisce in una sintesi di decisione in cui il valore è, per dirla con Parsons, condiviso o condivisibile) ma un rapporto con una pluralità di valori che non le appartengono direttamente ma che sono i riferimenti e i referenti diretti in quanto ad essa aderiscono ed afferiscono. Riferimenti e referenti che, ovviamente, sono e devono essere e-spressione di un mondo diverso e separato da quello della giustizia,
15G.M. Chiodi, "Giurisdizione ed equità regolativa" in Governo dei giudici, a cura di Edmondo Bruti Liberati, Adolfo Ceretti, Alberto Giasanti, Feltrinelli, Milano 1996, pag.43.
29
e precisamente espressione primaria della società16, del contesto sociale, in una parola dei cittadini. E' evidente che spingendoci oltre questa analisi si travalica a piè pari l'ambito della giustizia e si entra in quello, ancor più vasto e, per molti versi più minato, della "legittimazione" (sociale, politica o giuridica che sia) e questo, pur se la tentazione è forte preferiamo evitarlo in questo contesto; e tuttavia non vogliamo dimenticare sul punto l'indirizzo di Vincenzo Tomeo il quale nota che «quando si dice che il diritto statuito, cioè la legge, diviene la forma dominante del diritto si dice sostanzialmente che la decisione collettiva, organizzata attraverso procedure stabilite, è il fondamento di ogni obbedienza: lo stesso diritto è tale «in forza di una decisione». In particolare -nota più oltre Tomeo- «non c'è altro criterio per preferire una decisione all'altra se non la sua adeguatezza agli interessi che intende regolare. Di qui quella sorta di «rincorsa» delle decisioni collettive, in cui la prossima è sempre ritenuta la più adeguata e la più «giusta» [...]17. Un analogo ragionamento (l'adeguatezza, cioè, agli interessi che intende regolare) mi sento pienamente di estendere all'ambito della giustizia, anche se il ragionamento in quest'ambito per certi versi si complica perché si innesta un ulteriore elemento, oltre quello dell'adeguatezza agli interessi da tutelare, quello dei «valori» da tutelare, o meglio la scelta dei valori da tutelare e l'adeguatezza della scelta di questi valori18. La giustizia, intesa tanto come idea tanto come istituzione (struttura e funzione, insieme) è, quindi, in quest'ottica un sistema di servizio,
16Meglio ancora, della comunità. 17V. Tomeo, "Legittimazione e scambio politico", Sociologia del Diritto, 1984 n.1, pag.99. 18Tutto questo, sia ben chiaro, con la precisazione circa i «valori» di cui ho detto sopra.
30
un apparato strumentale posta alle dipendenze, e quindi a garanzia, della pluralità delle espressioni sociali e dei valori che di questi ne sono il portato; in questo senso si è detto che la giustizia è apparato di servizio e non già apparato primario. Da questo punto di vista condividiamo in pieno la collocazione sub-sistematica che al mondo della giustizia, globalmente intesa, è assegnata dai teorici dell'integrazione sociale, tanto dai capiscuola tanto dagli esponenti attuali più prestigiosi, Luhmann e Friedman in primo luogo. Proprio questa collocazione in un mondo che è un satellite di un universo più generale e che a questo continuamente si riferisce e si riporta (è questo, ovviamente, per noi, il senso più autentico della collocazione sub-sistematica rispetto al sistema sociale) è la garanzia migliore che questo frammento di mondo, per dirla con Luhmann, questo sotto-sistema, non prenderà mai il sopravvento sul sistema sociale globale, anzi a questo continuamente dovrà adeguarsi e dovrà conformarsi. Ma detto ciò il nostro gradimento per questa teoria e per questa costruzione socio-giuridica si arresta esattamente a questo punto e solo a questo; riconosciamo che una simile costruzione, teorica e pratica, presenta il vantaggio, decisivo a nostro avviso, di vincolare l'ambito della giustizia al più generale ambito sociale, cioè all'ambito di cui i cittadini sono gli unici titolari e gli unici referenti, ma oltre questo una simile teoria non può produrre. E ciò perché, in definitiva, il problema si sostanzia, per noi, in quello del rapporto tra pluralismo e giustizia, rapporto che nessuna teoria integrazionista, in qualsiasi forma espressa, pur in quella più morbida e conciliante, riesce a inquadrare e collocare in una dimensione per noi soddisfacente e realistica. Il problema è, espresso in altri termini, quello di capire come dal pluralismo degli interessi sociali si passi al pluralismo delle istanze sociali e da queste ad una sintesi rimessa, sì, in buona parte al
31
legislatore ma per la parte residuale, ma non minore né meno importante, al giudice. E quindi, per dirla in termini ancora differenti ma coincidenti, il problema è quello di cogliere e vedere il problema della diversità e della pluralità dei valori sociali con l'interpretazione che di questi ne dà la giustizia, in quanto istituzionalmente investita di questo compito, nel momento in cui e laddove questi interessi si contrappongono e fra loro nasce ostilità e conflitto. .3 Pluralismo giuridico e conflitto sociale Né si può dimenticare né omettere di sottolineare che questa plu-ralità di interessi sociali e di istanze sociali è, in definitiva, espressione di gruppi sociali, cioè di posizioni differenti e diversificate, di posizioni sociali contrapposte, in una parola di posizioni sociali di conflitto e in conflitto. Né, altrettanto, si può dimenticare né omettere di sottolineare che questa pluralità di interessi, questa pluralità di istanze, questa pluralità di gruppi sociali si traduce in una pluralità di proposte legislative, la cui forza di definizione, cioè di approvazione, è data precisamente dal grado e dalla quantità di potere che ciascun gruppo sociale è capace di far valere sulla scena socio-politica. Questa per noi è la vera essenza del pluralismo, giuridico, sociale o politico che sia, cioè producibilità, e di fatto produzione, di istanze normative da parte di gruppi sociali differenti e tra loro disomogenei, tra loro in conflitto o in contrasto o in una situazione di tregua e perfino di pace sociale, ma pur sempre una molteplicità
32
di proposte e di istanze che hanno una origine socialmente diversificata19. Come insegna Vincenzo Tomeo «la discontinuità e la diversità delle situazioni, l'eventuale conflitto tra situazioni diverse procede da realtà concrete: è la pluralità dei gruppi sociali che sta alla base delle situazioni» 20. E' compito del diritto ridurre, per quanto possibile e attraverso tecniche e meccanismi differenti, la complessità delle istanze e delle proposte pluralistiche, omogeneizzare le istanze in una sintesi
19Come acutamente nota Massimo Corsale il pluralismo giuridico può ben risiedere anche in situazioni di rilevante squilibrio sociale dove accanto a interessi capaci di aggregare soggetti sociali in grado di esercitare una pressione efficace sugli equilibri esistenti e sui centri di poteri relativi, e quindi di ottenere soddisfazione in misura rilevante, convivono interessi diffusi, ossia riguardanti larghissimi settori sociali o addirittura la generalità dei membri dellla società, ma deboli perchè incapaci di aggregare soggetti sociali per esercitare una pressione adeguata in vista della loro soddisfazione. Ma questa incapacità di aggregazione -nota ancora Corsale- è anche da mettere in relazione col fatto che generalmente (anche se non sempre) gli stessi individui e gruppi sociali che ne sono portatori sono anche portatori di qualcuno degli interessi «forti» in contrasto con essi. E pertanto il contrasto sorge non solo tra minoranze sociali titolari di interessi forti e maggioranze sociali portatrici di interessi deboli ma persino tra gli stessi soggetti titolari ora di interessi forti ora di interessi deboli in contrasto coi primi a seconda delle differenti circostanze sociali. Da tutto questo -conclude Corsale- non dovrebbe essere difficile dedurre che il pluralismo giuridico, lungi dall'occultare la dimensione conflittuale nella società (come nota Giovanni Tarello, Il diritto come ordinamento. Informazioni e verità nello stato contemporaneo, a cura di R. Orecchia, Giuffrè, Milano 1976 pag.49), riesce a spiegare meglio di altri modelli tanto il conflitto in atto quanto le contraddizioni che non riescono a dar luogo a un vero e proprio conflitto ma generano sordo disagio sociale, solo potenzialmente esplosivo. Si veda M. Corsale, "Pluralismo giuridico" in Enciclopedia del diritto, vol.XXXIII, Giuffrè, Milano 1985, pp.1021-1023. 20V. Tomeo,Il diritto come struttura del conflitto, Angeli, Milano 1981, pag.73.
33
che tenga conto delle diverse posizioni, situazioni e interessi. Ma questo è compito solo ideale, una vocazione, di fatto, più che un compito; una vocazione dettata dal realismo di garantire il più a lungo possibile la condizione favorevole che ha originato la norma stessa e, per uscire fuor di metafora, in definitiva il consenso su cui la norma si regge. Ma il diritto come insegna Vincenzo Tomeo non sempre è composizione di interessi anzi talora, e assai spesso, «è pretesa e una pretesa significa affermare contro altri interessi la propria a-spirazione a godere di uno spazio sociale che viene conteso agli altri soggetti: qui la «composizione» se c'è, è subalterna all'affermazione di una pretesa e comunque essa avviene dopo che la pretesa sia stata riconosciuta. In ogni caso, qui il diritto si presenta come suscitatore di conflitto o quanto meno come tu-telatore di un interesse in conflitto con altri, non certo come integratore»21. «Sul piano dell'esperienza sociale totale -nota ancora Tomeo- i soggetti (individuali o gruppi) non sono collocati in situazioni omogenee, tali da ricondurre ogni manifestazione del sociale (soggetti e situazioni) ad una misura comune. La discontinuità di struttura e di cultura esistenti producono, se mai, situazioni diversificate e, non di rado, in opposizione tra loro. La diversa collocazione dei soggetti non è prodotto soltanto da diversità di ruoli e di funzioni, ma soprattutto da diverse situazioni di potere in cui i soggetti stessi si trovano reciprocamente»22. Si diceva poco sopra che il compito di ridurre la complessità delle istanze in una sintesi che tenga conto delle diverse posizioni,
21V. Tomeo, "Funzione e struttura nelle teorie sociologiche del diritto" in Società Norme Valori. Studi in onore di Renato Treves, a cura di U. Scarpelli e V. Tomeo, Giuffrè, Milano 1984, pp.266-267. 22V. Tomeo, Il diritto come struttura del conflitto, cit., pag.38.
34
situazioni e interessi è compito solo ideale della giustizia, una vocazione più che un compito, perché in realtà non è infrequente che l'intervento giudiziario determini esso stesso conflitti, o creandone di nuovi o trasformando quelli già esistenti in nuove situazioni conflittuali. Chiarissime al riguardo le parole di Eligio Resta per il quale «la natura del conflitto si trasforma dal momento sociale a quello giudiziario a causa dell'intermediazione della giustizia, con le sue regole di funzionamento, di «politica» del servizio sociale e con una logica più raffinata di legame col potere»23. Pur senza pervenire al paradosso verbale (meno, molto meno quello sostanziale) di Luhmann il quale si spinge ad affermare che i conflitti sociali sono straordinariamente stabili fintantoché non interviene un «terzo» a portare al loro interno l'incertezza della aspettativa 24 (e col termine «terzo» possiamo ben intendere anche l'apparato della giustizia), siamo decisamente convinti che i conflitti innestano meccanismi a catena di difficile controllo (sotto il profilo reale non sotto quello formale); al riguardo Vincenzo Ferrari osserva che «anche da posizioni integrazionistiche si è felicemente notato che il procedimento giudiziario può condurre, anziché alla soluzione, alla reiterazione dei conflitti: che potranno eventualmente allargarsi a macchia d'olio ad altre parti in posizione
23E. Resta, Conflitti sociali e giustizia, De Donato, Bari 1977, pag.53. 24N. Luhmann, "Conflitto e diritto", Laboratorio Politico 1982 n.1 pag.9. Paradosso verbale dicevo e non sostanziale perchè, a mio modesto avviso, i conflitti sociali sono "straordinariamente" stabili nel senso che sono costantemente presenti e vivi sulla scena sociale, non già nel senso che sono "straordinariamente" immobili fintantochè non interviene «un terzo» a portare al loro interno l'incertezza dell'aspettativa. Sotto il profilo sostanziale aderisco pienamente all'affermazione di Luhmann se questa si riferisce, realmente, ad una situazione di costante presenza di conflitti sulla scena sociale.
35
omologa». Dunque -è la conclusione dell’Autore- «il diritto può essere utilizzato per aprire conflitti, oltre che per risolverli [...] ed inoltre il conflitto continua malgrado le contingenti decisioni con cui si condiziona, a mano a mano, il suo svolgimento fra gli stessi ed altri contendenti. Dunque ciò che importa è riscontrare che attraverso il diritto, semplicemente, si propongono o si impongono modelli comportamentali cui i contendenti si troveranno più o meno costretti, de facto, a rapportarsi caso per caso nello svolgimento del rapporto conflittuale»25 La nascita del diritto, ossia la produzione normativa, tiene, ov-viamente conto di questa situazione, anzi ne riflette fedelmente la struttura e la composizione: è questa, in sostanza, ciò che poc'anzi abbiamo definito come pluralismo delle istanze normative, cioè come la nascita pluralistica della norma. Ma, c'è da tener conto -ed è un'ulteriore osservazione di Tomeo su cui concordiamo anche in questo caso pienamente, che «la feno-menologia del conflitto (su cui, ovviamente, si fonda la produzione pluralistica del diritto) penetra in tutti gli ambiti, anche quelli più riservati, dell'organizzazione pubblico-istituzionale; si manifestano modalità conflittuali non solo sul terreno più strettamente politico (il legislativo, l'esecutivo) ma anche nella magistratura, nell'amministrazione, nei servizi; ogni ambito della vita pubblica ne viene contrassegnato»26. Di tutto questo deve tener conto non solo il sistema politico ma anche quello dell'amministrazione e della magistratura. Ciascuno, ovviamente, secondo le rispettive competenze e con specifici strumenti; quali siano le une e gli altri è quanto di più controverso e di più tenacemente contrastato si dibatte sulla scena istituzionale ed extra-istituzionale del nostro paese, costantemente ma con picchi di
25V. Ferrari, Funzioni del diritto, Laterza, Roma-Bari 1987, pp.95-96. 26V. Tomeo, Il diritto come struttura del conflitto, cit. pag.83.
36
particolare accanimento in momenti particolari della vita pubblica, come quello attuale. Un'osservazione ci sembra pacifica, che uno dei compiti, uno tra i tanti (certamente non il più importante), attribuiti al sistema politico, e in parte anche a quello amministrativo, è quello della riduzione della complessità delle proposte e delle istanze, tal che le proposizioni normative risultino largamente e indifferenziatamente fruibili, al di là della loro specifica provenienza. Questo non vale, neanche in minima parte, per la magistratura, anzi, al contrario, anche la magistratura è investita in pieno da quella folata costante di complessità che è l'anima stessa del sistema sociale nella sua interezza e in tutte le sue componenti. Mai come in questo momento ciò è profondamente vero! .4 Decisione e Conflitto Il problema si riassume sinteticamente nella domanda: qual è il ruolo della magistratura di fronte alle istanze pluralistiche? In tutta sincerità non ci sentiamo in animo di rispondere, non perché crediamo di non essere in grado di rispondere ma semplicemente perché crediamo che una risposta totale, la risposta delle risposte, non possa essere fornita a livello individuale ma solamente a livello istituzionale. Al di fuori di quest'ambito una qualsiasi risposta ci sembra un latrare al cielo, dispersivo quantomeno e anche del tutto inutile. Ma al di là di questo ambito specifico e di questa domanda speci-fica a cui abbiamo volutamente omesso di dare una risposta alcune osservazioni si impongono.
37
Un problema si ripropone attualmente all'attenzione con sempre maggiore evidenza e incisività e questo, sì, ci sentiamo di af-frontarlo con una qualche cognizione di causa: il problema se il giudice debba interpretare la legge o interpretare il conflitto; problema, non a caso, continuamente riproposto nel volume «Governo dei Giudici». Il problema prende le mosse da un notissimo saggio di Vincenzo Tomeo, apparso oltre vent'anni fa su Critica Liberale27 e che già all'epoca è stato fonte di ampie discussioni e ampi approfondimenti, e che si è proposto da subito come anticipatore di tematiche e problematiche che sarebbero state all'attenzione dei teorici e degli operatori del diritto sino ai nostri giorni, anzi più che mai ai nostri giorni. Il senso della questione -facendo ricorso alla sintesi di Gherardo Colombo -contenuta nel volume Governo dei giudici28- può essere così riassunto: ai giudici viene domandato ciò che essi, in quanto membri di un apparato istituzionale che è parte essenziale del sistema politico, difficilmente possono dare, cioè a dire "la giustizia". Eppure la richiesta di giustizia è costante. Ma costante è pure la riflessione sul ruolo del giudice, sulla sua funzione, sulla sua autonomia; continua è, in altre parole, l'esigenza di circondare la sua azione con gli strumenti e le procedure necessarie perché essa sia imparziale e senza ostacoli. [...] Ora il problema dei giudici è quello di dare un significato al proprio "ruolo d'autorità" che lo distingua rispetto a quello dei titolari degli altri "ruoli politici". La difficoltà di questa operazione risiede nel fatto che essi subiscono 27V. Tomeo, "Interpretare il conflitto", Critica Liberale n.144/1973. Lo stesso tema era stato proposto nel volume Il giudice sullo schermo, Laterza, Roma-Bari 1973; in particolare nel capitolo V dal titolo "Il giudice come interprete del conflitto", pp.137-142. 28G. Colombo, "Dal giudice interprete del conflitto al giudice interprete della legge" in Governo dei giudici, cit., pag.85.
38
più di altri la naturale contraddizione dei "ruoli d'autorità", esercitando funzioni con tratti di un tipico rapporto di potere (i magistrati sono soggetti di un rapporto inegualitario e asimmetrico in cui la funzione svolta è quella di costringere o condizionare gli altri) e con tratti che si richiamano a principi super partes di imparzialità e di rispetto dell'eguaglianza. «La riscoperta di un ruolo tecnicamente politico per il giudice -nota Tomeo- è un fatto abbastanza recente ed è in fondo connesso all'affermarsi della magistratura come uno dei protagonisti del sistema politico italiano. Ma la riconquista dell'indipendenza e-sterna ed interna da parte della magistratura e la riscoperta della sua funzione politica ha posto immediatamente i giudici di fronte al problema di dare un significato al proprio ruolo di autorità, che lo distinguesse rispetto a quello dei titolari degli altri ruoli politici»29. «Per spiegare questa contraddizione -sostiene Tomeo- ma non per risolverla appare difficile il ricorso a strumenti concettuali di tipo sociologico30, in termini politici la spiegazione può essere formulata con risultati più soddisfacenti. E' chiaro infatti -sottolinea l’Autore- che la discussione sul giudice e la sua funzione rientra nel quadro di ciò che va sotto il nome di crisi dei ruoli sociali, e questo induce facilmente l'osservatore a chiedersi se la crisi attuale non comporti la crisi del sistema sociale nel suo complesso, in quanto sistema di fini e mezzi collettivi; in particolare una simile domanda non può non ricorrere quando il ruolo del giudice è posto in questione; quando, cioè, ci si chiede se la composizione dei conflitti abbia senso e, nel caso, quale sia il titolo di legittimità
29V. Tomeo, "Interpretare il conflitto", cit. 30L'autore ricorda che nella sociologia classica vi è solo Max Weber che, «richiamandosi alla giustizia del cadì», affermi l'esistenza di un giudizio e di un giudice equitativo, la cui decisione, cioè, non si basa su princìpi preesistenti. Si veda V. Tomeo, Il giudice sullo schermo, cit. pp.139-140.
39
sociale, ancor prima che politico e giuridico, che dia al giudice l'attitudine a svolgere la propria funzione»31. Ma a fronte di questa contraddizione di ruolo rimane nel cittadino, e si rinnova quotidianamente, un'aspettativa di giustizia. Una cosa è certa: il ruolo del giudice non può avere carattere risolutivo, per la semplice ragione che la giustizia, intesa sia come apparato sia come servizio, non risolve i conflitti, anzi, se mai, come si è già detto li determina, li amplifica, li trasforma. Su questo punto esiste unanimità di giudizio perlomeno da parte di chi, in qualche misura, aderisce ad una posizione conflittuale della società o comunque ad una posizione non totalmente integrazionistica. Un'analisi assai acuta sul punto è quella di Mirian Damaska: «è importante riconoscere -afferma l'Autore- che l'associazione dell'attività giudiziaria con la risoluzione dei conflitti esercita una forte presa sull'immaginazione giuridica, specialmente in quelle culture in cui l'atteggiamento dello Stato (effettivo o proclamato a livello ideologico) tende ad essere di tipo più reattivo che attivo. [...] Se il comparatista, nel suo vagare da una cultura all'altra, utilizzasse lo stretto concetto analitico di giurisdizione, gli sfuggirebbero molte funzioni largamente percepite come ipotesi di attività giurisdizionale. Egli deve dunque adeguare i suoi concetti ed ampliare l'idea di giurisdizione: per lui la giustizia deve diventare un Giano bifronte. Nella sua visione gli obiettivi del processo devono ricomprendere non solo la risoluzione dei conflitti ma anche l'applicazione della legge o in definitiva l'attuazione delle scelte politiche dello Stato»32. Da queste poche parole emerge chiara la posizione di Damaska: l'autore intravede due distinte
31Ibidem. 32M.R. Damaska, The faces of Justice and State Authority, New Haven, Yale University Press 1986, trad. it. I volti della giustizia e del potere, Il Mulino, Bologna 1991, pag.161.
40
organizzazioni dello stato e di conseguenza due differenti modi di intendere l'apparato della giustizia: «quando lo Stato è visto come manager, l'amministrazione della giustizia appare rivolta alla realizzazione di programmi di governo ed alla attuazione di scelte politiche dello Stato. Al contrario, dove lo Stato si limita a mantenere l'equilibrio sociale, l'amministrazione della giustizia tende ad essere assimilata alla risoluzione dei conflitti »33. Questa sintesi coglie esattamente i termini della questione, am-mettiamo senza riserve che entrambi i modelli sono teoricamente ammissibili e compatibili socialmente ma come ammette lo stesso Damaska tutto questo è possibile quando si è di fronte a modelli ideali (o nella loro forma pura, come afferma l'autore) e questi, fortunatamente, non esistono in nessun angolo di mondo e forse mai esisteranno; bisogna far i conti, quindi, con la realtà vera e attuale. E questa, a nostro avviso, è tutta rivolta a modelli misti in cui a gradi crescenti di complessità sociale corrispondono gradi crescenti di conflittualità sociale. In quest'ottica la giustizia, intesa sia come apparato, sia come servizio, sia come componente umana, non costituisce né può co-stituire eccezione. Come osserva Tomeo il giudice «non può risol-vere come un demiurgo il conflitto sociale che lo sovrasta e lo coinvolge al punto che egli stesso è un segno di contraddizione»34. Precisamente quella contraddizione di ruoli di cui si è detto poco sopra, cioè la scelta tra l'esercizio di una funzione «tecnica» e quello di una funzione per così dire «politica». Questa doppiezza nell'esercizio delle funzioni induce, secondo Tomeo, il giudice a schierarsi con uno dei due ruoli, a optare per uno di questi: taluni sono indotti anche inconsapevolmente a schierarsi con un ruolo tecnico, coscienti o meno che la situazione
33Ivi, pag.42. 34V. Tomeo, Il giudice sullo schermo, cit., pag.141.
41
in cui sono collocati è una delle tante espressioni del conflitto che coinvolge tutto il sistema dei rapporti sociali; altri si orientano decisamente verso il ruolo di interprete del conflitto. Ma a ben guardare questa contraddizione è più fittizia che reale perché la doppiezza nell'esercizio delle funzioni e la scelta a questa conseguente (scelta del ruolo) è essa stessa fittizia: «l'inizio della crisi -osserva al riguardo Tomeo- è più apparente che reale, come, d'altra parte, è più apparente che reale l'assunzione attuale di aspetti politici in un ruolo che in passato sembrava definito da caratteri tecnici. Apparentemente, il giudice interprete della legge non ha contraddizioni né crisi (anzi la legge può apparire perfino strumento di innovazione sociale [...] peraltro una siffatta valutazione della legge va intesa in senso relativo; in situazioni di arretratezza, lo Stato di diritto è una situazione innovatrice rispetto all'ordine antico). Nella realtà, caratteri politici ed elementi contraddittori sono latenti in ogni caso nel ruolo del giudice. Se infatti pensiamo al giudice come a un ruolo dotato di potere formale, cioè di autorità, esso fa parte per sua natura di un sistema di rapporti che chiamiamo politico. Come tale il giudice gode di poteri e svolge funzioni che sono sostanzialmente omogenee a quelle svolte in sedi diverse, ma contigue ai luoghi dove si esercita la funzione giudiziaria»35. Ma c'è un'ulteriore osservazione che vale, a nostro avviso, ad avvicinare e a qualificare la funzione del giudice come funzione, almeno genericamente, «politica» o a questa quantomeno assai vi-cina e si riferisce alla natura della norma di legge che il giudice è chiamato a «trattare». Se questa è realmente frutto di un procedimento pluralistico, cioè contiene in sé tutti quegli elementi di mediazione sociale, economica e politica che servono a salvaguardare tutte le più diversi componenti sociali, se, cioè, è il 35Ibidem.
42
portato autentico di istanze sociali contrapposte, anche di quelle che non sono riuscite a dar voce o a farsi ascoltare perché troppo deboli o marginali, ma comunque istanze sociali, allora, realmente, questo ruolo «politico» della giustizia scolora sin quasi a scomparire del tutto, non foss'altro perché sarebbe un inutile doppione di altri apparati più rappresentativamente politici e dotati di strumenti per esercitare questa funzione in maniera più diretta e più immediata. Se, in definitiva, la norma di legge fosse realmente rappresentativa della pluralità degli interessi e delle istanze sociali di cui lo Stato, attraverso il meccanismo della produzione legislativa, si fa istituzionalmente carico, tal che sia un riferimento reale di tutte le più diverse componenti sociali, o perlomeno di un'ampia quota di queste, la più estesa possibile, allora la funzione giudiziaria diventa una mera funzione dichiarativa: il compito del giudice non sarebbe altro che quello di adeguare la fattispecie concreta alla previsione normativa, riequilibrando la situazione automaticamente, in quanto è la norma stessa che possiede in sé i meccanismi di riequilibrio e di riallineamento della fattispecie reale alla norma. In questo caso, e solo in questo caso, il giudice avrebbe una funzione meramente dichiarativa o, più genericamente, «amministrativa». Certo, condivido in pieno quelle posizioni che invocano al giudice la funzione di «interprete della legge»36, nessun altra funzione e
36Tra le tante, particolarmente apprezzabile e misurata appare quella recentemente espressa da Gherardo Colombo, il quale confuta in maniera decisa la tesi di Tomeo del «giudice interprete del conflitto», con un ragionamento assai articolato che si sostanzia nell'osservazione che oggi siamo lontani da una situazione in cui il giudice in condizioni cariche di tensioni e di contraddizioni sociali, manifesta il desiderio di esercitare un "ruolo" politico sotto la protezione di una motivazione tecnica (come sostenuto da Tomeo). Il percorso -afferma Colombo- è di segno opposto, e va nella direzione della conquista di spazi autonomi all'interno dei quali il magistrato cerca di svolgere un "ruolo" di
43
nessun altro ruolo può essergli assegnato se le cose stessero effettivamente così: sarebbe la norma stessa (con le sue previsioni di legge) ad operare preventivamente la scelta di interpretare il conflitto e di trasmettere questa scelta al suo interprete naturale, il giudice, perché questi ne curi l'esecuzione, laddove questa sia stata disattesa o violata o ignorata; sarebbe la norma stessa a contenere quel reale bilanciamento degli interessi che sta alla base del «gioco» sociale, il giudice dovrebbe solo prenderne atto e trasferire tutto questo in una decisione. Ma sarebbe oltremodo azzardato oltreché risibile e decisamente pericoloso affermare e ritenere che questo sia il quadro reale nel nostro o in qualsiasi altro paese del mondo. Senza, peraltro, voler aprire qui alcun problema relativo alla crisi di legittimazione e di rappresentatività, che ci porterebbe assai lontano dal nostro tema, pur se le connessioni tra questi temi sono scontate oltre che doverose, alcune osservazioni e alcuni passaggi ci sembrano ineludibili. Il primo -per usare le parole di Giulio Chiodi- «che un parlamento in cui predominano le rappresentanze di interessi o che comunque abbia perduto di rappresentatività politica in senso stretto, si trasforma immancabilmente in organo ratificatore di decisioni prese altrove: l'«altrove» è la sede effettiva delle contrattazioni della legge.
semplice "interprete della legge". [...] Il discorso, dunque, deve essere rinviato alle norme. Se la norma va verso l'emancipazione, allora anche il giudice che la applica è un giudice che consente o che, addirittura, promuove l'emancipazione. Se invece la norma contrasta l'emancipazione, il giudice, che è e deve assolutamente essere terzo, imbocca un'altra strada, pur restando fermo che non è suo compito intervenire nelle dinamiche sociali, se non applicando la legge nel suo significato. Si veda G. Colombo, "Dal giudice interprete del conflitto al giudice interprete della legge", in Governo dei giudici, cit. pp.91-92.
44
Il secondo aspetto concerne il fatto che essendo la contrattazione di per sé procedura di legittimazione delle decisioni legislative, il parlamento si trasforma in una sorta di teatro, dove si rappresentano le decisioni e se ne recitano variamente le argomentazioni. La rappresentanza, persa la rappresentatività, si converte ovviamente in rappresentazione. In sostanza, per la legge contrattata l'unica legittimazione richiesta è che si effettui realmente una procedura di negoziazione da parte di chi abbia una consistente influenza sociale o ne sia il rappresentante; il fatto solo che si negozi, si ritiene, giustifica legittimamente la decisione e garantisce -o lo si vuol far credere pubblicamente- che non vi siano arbitrî e soprusi di parte»37. E un'altra osservazione si impone sul punto ed è tratta da un altro magistrale insegnamento di Vincenzo Tomeo: «si è soggetti sol-tanto in quanto (e nei limiti in cui) si dispone di potere. Nel ruolo di cittadino, come titolare di attività politica, chiunque è soggetto, dispone, cioè fittiziamente di una quota di potere, che gli consente la partecipazione ad un sistema, quello politico, in cui le parti sociali si annullano in ruoli istituzionali di pari dignità e potere. Lo schermo protettivo costituito dal pubblico-istituzionale si presenta a questo livello, come un soggetto primario, «altro» dalle parti sociali, nel quale, in un certo senso, tendono ad annullarsi i soggetti empirici e a rappresentarsi come ruoli egualmente necessari»38. E -osserva poco oltre l'autore- «l'ordinamento è stato costretto ad ammettere l'origine extra-legislativa e anzi extra-istituzionale di alcune composizione di interessi e di contrattazioni tra le parti sociali; è stato costretto a riconoscere la presenza di ruoli conflittuali anche nel momento giurisdizionale e rappresentanze di interessi anche all'interno dell'amministrazione; è stato infine
37G.M. Chiodi, "Giurisdizione ed equità regolativa", cit., pag.38. 38V. Tomeo, Il diritto come struttura del conflitto, cit. pag.82.
45
costretto a riconoscere l'ingresso degli interessi conflittuali anche nel momento legislativo, nel momento stesso della redazione della legge (spesso con una delega -sostanziale se non formale- ai fiduciari delle parti, di proporre un testo conclusivo che il «legislatore» adotterà dopo una fittizia discussione parlamentare anche molto animata, con deliberazioni a maggioranza, votazioni conclusive e ferrei accordi di governo intesi a far votare il testo nella forma e solo nella forma voluta dalle parti)»39. Non mi pare di dover spendere ulteriori parole oltre queste il-luminanti citazioni per dimostrare una realtà che è inequivocabile: la legge non è di per sé la sintesi e la composizione della pluralità delle situazioni sociali diffuse, ma è l'atto definitivo e finale di una contrattazione ineguale, in cui le posizioni di maggior forza e potere riescono ad ottenere una maggior quota di «legge»40. E' proprio questa la considerazione, per noi ineludibile e insu-perabile, che deve indurre ad escludere in capo al giudice una 39Ivi, pp.84-85. 40Giulio Chiodi rappresenta questa situazione in maniera assai efficace: primo: non v'è dubbio che influisca di più nelle negoziazioni chi disponga di maggior potere contrattuale; non solo ma questi è sicuramente anche in grado di determinare più di qualsiasi altro contraente le regole della contrattazione stessa e di condizionare altresì l'entità della materia che ne è oggetto. Secondo: vengono automaticamente esclusi dalla contrattazione tutti i soggetti che non vi sono rappresentati, mentre ne debbono subire tutte le conseguenze che ne discendono. Terzo: non è previsto un effettivo sistema di garanzie nelle negoziazioni, perché sostanzialmente prive di garanzie; infatti chi negozia è al tempo stesso, il garante della negoziazione e del rispetto delle sue regole. Quarto: si ha instabilità normativa, dal momento che chi negozia può sempre rinegoziare il negoziato. Quinto: è il punto più delicato sotto il profilo degli interessi [...]: l'effetto legislativo deciso dalle sole parti contraenti ha effetto vincolante generale, anche per chi non è stato rappresentato nella contrattazione; come può essere garantito il terzo da una normativa che viene stabilita solo da una contrattazione tra parti, di cui non fa parte? G.M. Chiodi, "Giurisdizione ed equità regolativa", cit., pag.39.
46
funzione meramente dichiarativa: se così fosse il giudice si li-miterebbe a tradurre in una decisione quel contenuto e quel tasso di squilibrio e di «ingiustizia» insito in una norma di legge così determinata. In questo caso il giudice sarebbe null'altro che l'esecutore fedele di una situazione, «normativa» fin che si vuole e quindi formalmente «legale», di evidente disparità sociale, giuridica, economica e politica, senz'altro limite alla sua attività di decisione che la mera e pedissequa osservanza della norma stessa; una funzione, in sostanza, meramente ratificatoria della diseguaglianza sociale. Non crediamo possa essere questo il senso più autentico dell'attività giudiziaria e del ruolo del giudice! Tutto questo è, a nostro avviso, non solo aberrante socialmente ma anche giuridicamente iniquo e politicamente pericoloso, se non di più. Per meditare una volta di più su questo pericolo e tentare di e-sorcizzarlo ricorriamo a un'ampia citazione di Friedrich Dürren-matt: «il tentativo di costruire un ordinamento sociale giusto partendo dal concetto individuale lo possiamo paragonare al gioco del lupo, e quello che parte dal generale al gioco del buon pastore. Se considero giusto il gioco del lupo, la sua giustizia per me consiste nel fatto che esso garantisce ogni giocatore e il suo bottino purché il giocatore si attenga alle regole del gioco. La libertà di ogni singolo è assicurata dal fatto che le regole del gioco permettono un gioco abile ma non truffaldino. La giustizia e la libertà del gioco del lupo coincidono quindi solo per i giocatori con molte pedine o per quelli che giocando abilmente possono sperare di entrare in possesso di molte pedine. Invece, per i giocatori con poche pedine e che non hanno più nes-suna speranza di entrare in possesso di molte pedine o per coloro che non sanno giocare abilmente, la libertà e la giustizia del gioco del lupo non coincidono: essi sono sì liberi, ma non in condizione
47
di sfruttare la loro libertà, dimodochè a loro la libertà sembra una schiavitù e la giustizia del gioco un'ingiustizia. Essi tendono a riporre le loro speranze nel gioco del buon pastore oppure cominciano a giocare non rispettando più le regole. Il giocatore esperto chiede quindi all'arbitro di guidare il gioco in modo più giusto o di renderlo più giusto per la maggior parte dei giocatori [...] in quanto si deve fare in modo che i giocatori con molte pedine e coloro che possono sperare di entrare in possesso di molte pedine siano la maggioranza. Quando questo non è possibile, i giocatori con molte pedine costituiscono una minoranza. Per fare sì che il gioco del lupo possa continuare, costoro decidono di essere loro a nominare l'arbitro. Con ciò la libertà e la giustizia del lupo diventano illusorie: i giocatori con poche pedine dipendono dai giocatori con molte pedine. La giustizia e la libertà sono utili solo per quelli che ne approfittano e la morale diventa un privilegio dei giocatori con molte pedine. Ma se l'arbitro diventa onnipotente [...] al punto che tutti i giocatori dipendano da lui, anche il gioco del lupo diventa illusorio e si trasforma subdolamente nel gioco del buon pastore. Queste difficoltà che il gioco del lupo incontra di continuo, fanno sì che quell'idea di un ordinamento sociale libero e giusto, che in origine si voleva realizzare e che ha portato a un ordinamento non libero e ingiusto, venga ora utilizzata come argo-mento per mantenere un ordinamento sociale ingiusto. Il gioco del lupo diventa ideologico. Un ordinamento sociale -è la conclusione di Dürrenmatt- ha biso-gno di un'ideologia nel momento in cui non funziona più»41. E' indispensabile, è la nostra riflessione, che i «giocatori» dotati di «molte pedine» o quelli più «abili» non dettino essi stessi le regole del gioco e bisogna evitare che questi stessi nominino un «arbitro» o, peggio, si facciano essi stessi «arbitri» del gioco: ma bisogna 41F. Dürrenmatt, I dinosauri e la legge, cit., pp.23-24.
48
rifuggire anche un'altra pericolosissima tentazione, che cioè siano i giocatori dotati di «molte pedine» o i più «abili» a interpretare le regole del gioco o che nomino un arbitro che per loro le interpreti. E' la riproposizione dell'interrogativo su cui ruota la nostra analisi: sotto altre forme -afferma Tomeo- risorge l'antica domanda: al giudice non si chiede soltanto l'applicazione della legge, ma anche ciò che egli difficilmente può dare, cioè «la giustizia»42. Il suo ruolo, a nostro avviso, non può essere solo quello di in-terprete della legge. La strada da percorrere per definire ruolo e attività del giudice è, a nostro avviso, ben altra e va nel senso che quella contraddizione di ruolo nel giudice, di cui si è detto sopra, deve svanire e svanisce totalmente: l'unico modo di sopravvivere alla contraddizione -o, come oggi si dice, di gestirla- è quello di modificare alcuni tratti del ruolo: il giudice interprete della legge può e deve far luogo al giudice interprete del conflitto43 E interpretare il conflitto significa per Tomeo pareggiare, in qualche misura le posizioni, o tentare quantomeno di farlo; si-gnifica, cioè, rendersi conto che le situazioni sociali sono so-stanzialmente e decisamente squilibrate e rendere giustizia significa anche e soprattutto tentare di riequilibrarle, ossia tentare di porre su piani simili o quanto più simili possibili (in riferimento alle rispettive posizioni di equilibrio) situazioni inizialmente impari. Senza una simile consapevolezza del ruolo e senza una simile ope-ratività del ruolo si rischia ulteriormente di divaricare, a nostro avviso, le situazioni su posizioni di squilibrio ancora maggiori rispetto a quelle iniziali. E d'altra parte il problema e il dilemma, a nostro avviso, si ri-compone, se pure è mai esistito: interpretando il conflitto si
42V. Tomeo, Il giudice sullo schermo, cit. pag.142. 43Ibidem.
49
interpreta, in fatto e in diritto, la legge. Nessuna contraddizione esiste e può esistere tra queste due posizioni e tra queste due espressioni: se è vero, come è vero, che la legge è uguale per tutti non può esistere mai né in nessun luogo una legge più uguale per alcuni piuttosto che per altri né alcun giudice che fornisca più giustizia a taluni piuttosto che ad altri. Interpretare la legge significa certamente rendere il cittadino uguale dinanzi alle legge ma significa anche (ed è l'aspetto operativo) rimuovere gli ostacoli ad una eguaglianza reale e non fittizia dinanzi alla legge. Significa, anzi, rendere il cittadino uguale dinanzi alla legge rimuovendo qualsiasi ostacolo che gli impedisca di esserlo. Non si tratta di due operazione diverse e tra loro alternative o in contraddizione, bensì di un'unica operazione, doverosa e dovuta, quella di rendere giustizia rimuovendo gli ostacoli che impediscono di renderla. Significa, come afferma Tomeo, tentare di svolgere una funzione riequilibratrice: e in questo senso «dare giustizia» vuol dire considerare come primarie, in un rapporto antagonistico, le posi-zioni subalterne proprio perché subalterne44. Se una funzione come quella del giudice è essenzialmente riequilibratrice, la tendenza all'equilibrio non può che alimentarsi di una costante ricerca e rivalutazione delle posizioni subalterne45 Al di fuori di questo, oggi che la complessità sociale aumenta quotidianamente a vista d'occhio e che le situazioni sociali si divaricano e si disarticolano si rischia di interpretare la legge come una mera operazione matematica o logica, rischiando in questo modo di contribuire ad accrescere ancora di più il livello di diversificazione sociale, fino a scadere in quella forma di ri-
44
Ibidem. 45V. Tomeo, "Interpretare il conflitto", cit.
50
tualismo burocratico assai noto ai sociologi del diritto e denunciato da grandi sociologi del passato come Weber e Merton. In conclusione crediamo fermamente e ribadiamo che il problema sia assolutamente unitario, che non contenga in sé alcuna con-traddizione e che non costituisca, in definitiva, neppure un pro-blema ma sia il risvolto unico di una operazione giudiziaria do-verosa e indispensabile (come il diritto e il rovescio della stessa medaglia): solo interpretando il conflitto si interpreta la legge.
51
Studio n.2
APPARTENENZA ED ESTRANEITA’:
LA GIUSTIZIA DEGLI ALTRI
.1 Premessa Di analisi sociali sulla giustizia il panorama scientifico si è via via arricchito solo a partire dalla metà degli anni settanta, non solo in Italia ma anche in campo internazionale; e non si può certo negare che il tema non risenta decisamente di questa sua giovinezza, anzi per la verità il tema presenta tutte quelle lacune e quelle imperfezioni tipiche della novità. Perché paradossalmente il tema della giustizia è davvero ancor oggi una novità; bene ha detto Bobbio nella lontana, ma non lontanissima, fine degli anni cinquanta affermando «che una nozione fondamentale come quella di giustizia sia stata in tutti i tempi, così poco analizzata, tanto che se si volesse raccogliere in
52
antologia (e ne varrebbe la pena) le analisi più celebri da Platone in poi, non ci sarebbe certamente bisogno di un ponderoso volume. Soprattutto i contemporanei che hanno dedicato così grande spazio, nei loro trattati di filosofia del diritto e di teoria generale del diritto, all’analisi di nozioni come “diritto”, “legge”, “norma”, “ordinamento” e via dicendo, hanno rivolto ben scarsa attenzione al problema della giustizia»46. Da allora, come nota Vincenzo Ferrari, «il panorama degli studi filosofico-giuridici sulla giustizia, nel senso “alto” della parola, si è cospicuamente arricchito. Soprattutto la comparsa, nel 1971, del notissimo libro di John Rawls ha dato vita ad una grande discussione, che ha impegnato un’intera generazione di studiosi di ogni parte del mondo, toccando tematiche non soltanto generali, ma anche specifiche, di interesse immediato. Di questa rinascita ha risentito anche la letteratura sociologica, che presenta sull’argomento un campo pressoché sterminato di indagine: le opinioni del pubblico, la loro formazione, i loro effetti, i loro rapporti con le strutture normative esistenti o progettate, legislative, regolamentari e professionali. Anch’essa in passato era stata abbastanza avara di contributi in materia di giustizia».47 Questo cospicuo fiorire di studi e di analisi ha indotto più di uno studioso a parlare di un autentico paradigma delle teorie della giustizia; Sebastiano Maffettone e Salvatore Veca nell’introdurre una recentissima e prestigiosa antologia “sull’idea di giustizia” hanno affermato che «negli ultimi decenni, è venuto progressivamente consolidandosi nel tempo un vero e proprio paradigma nell’ambito della filosofia politica, intesa come teoria
46N. Bobbio, Prefazione al volume di Ch. Perelman, La Giustizia (1945), trad. it.di L. Ribet, Giappichelli, Torino 1959, pag.5. 47V. Ferrari, Giustizia e diritti umani, F. Angeli, Milano 1995, pp.15-16.
53
politica normativa. Si tratta del paradigma delle teorie della giustizia».48 Questo è certamente vero, il panorama nazionale e internazionale degli studi e delle analisi sulla “giustizia” è progressivamente cresciuto, specie nell’ultimo decennio in coincidenza coi nuovi scenari politici che hanno investito gran parte delle nazioni, tanto all’est quanto all’ovest, tanto al nord che al sud del mondo; un universo in cui la complessità sociale si è fatta galoppante e inarrestabile e nei confronti della quale qualsiasi scenario, interno e internazionale, economico, politico, sociale, si è rivelato fortemente inadeguato. A fronte di questa accresciuta complessità sociale e di questa polverizzazione delle problematiche ad essa connessa è aumentata a dismisura per un verso la richiesta di “giustizia” e per altro verso l’esigenza di controllare questa domanda, di esorcizzarla, di inquadrarla e di incanalarla entro binari precostituiti e programmati. E’ il tema della giustizia politica, è il tema dei rapporti tra giustizia e politica, è il tema del rapporto tra magistratura e classe politica. Tutti temi questi che a far data da circa un ventennio, e oltre, si sono imposti sempre più all’attenzione degli esperti e della gente comune; ma non per questo sono temi che paiono esauriti o esaurienti, al contrario sono queste tematiche e problematiche sempre più lacunose e impalpabili. Questo perché impalpabile è il concetto stesso di giustizia ed anzi, come ho già scritto in una precedente occasione il concetto di giustizia non è neanche un concetto ma è un sentimento, un’emozione, individuale, personale, intima, un sentimento che nulla ha, e nulla può avere di collettivo e
48L’idea di giustizia da Platone a Rawls, a cura di S. Maffettone e S. Veca, Laterza, Roma-Bari 1997, pag.VII.
54
di sociale, proprio perché come ogni altro sentimento è prima di tutto intimo e personale.49 Eppure questa affermazione che qui ribadisco e ripropongo, altrettanto convinto come allora, non è del tutto vera sotto taluni specifici aspetti, anzi credo fortemente che esiste “un’idea” di giustizia e un “concetto” di giustizia che si differenzia da quell’idea di giustizia come emozione e come sentimento di cui ho detto, che da questa se ne distacca e se ne discosta in modo netto. Esiste, a mio avviso, accanto a un concetto emozionale di giustizia, un concetto e un’idea di giustizia che lo sovrasta e che è oggettiva, anzi direi che è fortemente oggettiva, che esula del tutto dal sentimento e dall’emozione, un’idea e un concetto talmente oggettivi da condizionare la vita stessa, intesa in tutte le sue manifestazioni, degli uomini. Un’idea talmente forte che finisce per essere un concetto e un concetto talmente forte che finisce per essere un paradigma: ed è, l’idea, il concetto, il paradigma della giustizia “degli altri”.
49B.M. Bilotta, «Dal pluralismo delle istanze al pluralismo degli interessi» in La Giustizia e le Giustizie, a cura di B.M. Bilotta e A. Scerbo, Rubbettino, Soveria Mannelli 1998, pp.63-64. Giulio Chiodi ha al riguardo adoperato un’espressione molto efficace: «al di fuori dei significati di giustizia connessi con le prassi giuridiche, il concetto di giustizia è oggi più che nai indefinito e gravato di suggestioni più psicologiche che sociali. In ogni caso conserva tuttora, circa la sua rilevanza politica, il valore di un generico sentimento limite, in cui confluiscono luoghi comuni non espressi. Quanto meno ad essa si fa esplicitamente appello, tanto più sono carenti nella società simboli etico-sentimentali, che si configurano in un insieme ideologico sufficientemente condiviso per essere vissuto e definito come giusto», cfr. G.M. Chiodi , La menzogna del potere, Giuffrè, Milano 1979, pag.224.
55
.2 La giustizia del sé e la giustizia degli altri A ben guardare tutte le analisi sulla giustizia che nel tempo si sono succedute e più in particolare, per quel che più specificatamente ci interessa, le analisi sociali sulla giustizia o quelle sulla “giustizia sociale” hanno avuto tutte, indistintamente tutte, come oggetto di attenzione e di indagine un concetto di giustizia e, più in generale un universo di giustizia, che promana dalla società, intesa nella sua generalità e nella sua globalità50, ossia un concetto e un universo di giustizia da cui il cittadino rimane investito e ne risulta più l’oggetto di riferimento che non il soggetto di riferimento. Questo vale, a nostro parere, tanto per le forme di giustizia distributiva, che sono decisamente le più numerose, tanto per quelle di giustizia commutativa, talché anche la richiesta, individuale o collettiva che sia, di giustizia finisce per essere o per diventare anch’essa un fenomeno sociale. Questo concetto è stato espresso assai bene da Friedrich von Hayek quando ha affermato che «la richiesta di “giustizia sociale” è indirizzata non all’individuo ma alla società -ma la società in senso stretto, cioè come distinta dall’apparato governativo, è incapace di agire per uno scopo specifico, e la richiesta di “giustizia sociale” diventa quindi una richiesta ai membri della società affinché si organizzino in modo da poter assegnare particolari quote della produzione sociale ai vari individui o gruppi».51 Esistono, sostanzialmente, due modi differenti di “vedere” la giustizia e precisamente un modo che potrebbe definirsi, seppure
50Quindi tanto nei singoli appartati che nelle loro specifiche funzioni. 51F. A. von Hayek, Law, Legislation and Liberty, Routledge, London 1982, ed. it. Legge, Legislazione e Libertà, trad. it. di P.G. Monateri , Il Saggiatore, Milano 1990, pag.V. L’idea di giustizia da Platone a Rawls pag.306.
56
limitativamente, personale o come preferisco dire in questo contesto “la giustizia del sé” ed un altro che potrebbe definirsi sociale, o, come preferisco dire, “la giustizia degli altri”. Il modo di “vedere” la giustizia del sé è decisamente la parte meno studiata e meno analizzata del pianeta giustizia, forse perché generalmente si crede che sia la parte meno interessante di questo pianeta in quanto quella che meno coinvolge la collettività, e questo, a mio avviso è, almeno in parte, un grosso errore. Sicuramente questo tipo di “visione” è più vicina a quell’idea di giustizia emozionale di cui ho detto e si accosta o si ingloba del tutto in quel sentimento della giustizia che si differenzia da individuo a individuo. Ma non si può negare che esiste un denominatore comune che unisce tutti questi modi di sentire e di intendere individuali, proprio questo denominatore comune è a mio avviso non meno importante dell’altro ai fini di una analisi della giustizia e sulla giustizia ed è questo che è stato quasi del tutto trascurato dalle analisi. Vincenzo Tomeo ha magistralmente espresso questo concetto quando, in una conversazione privata, ebbe a dire che i politici possono provocare infelicità diffusa, ma i giudici provocano dolore concreto e immediato a singoli uomini in carne e ossa52, un concetto forte questo che si integra con un altro, di altrettanto vigore, espresso in un saggio assai noto agli addetti ai lavori -Interpretare il conflitto-, «quando si chiede giustizia si chiede qualche cosa che vuol sottrarsi ai condizionamenti sociali: è un persistente atteggiamento giusnaturalistico, di cui si deve tener conto. E’ forse un errore credere che i giudici e la “giustizia” da
52L’episodio è riportato da V. Ferrari ne «Il giudice come interprete del conflitto: permanente vitalità di una formula icastica», in Giustizia e Conflitto Sociale, a cura di Alberto Giasanti, Giuffrè, Milano 1992, pag.446.
57
essi amministrata possano sottrarsi a quei condizionamenti, ma è un errore che si ripresenta ad ogni momento».53 Questo richiamo giusnaturalistico riferito all’idea di giustizia e alla richiesta di giustizia è precisamente quel che noi intendiamo con l’espressione “giustizia del sé”, che può assumere contorni e valenze differenti a seconda che il soggetto sia direttamente investito dal pianeta giustizia oppure che al pianeta giustizia si accosti e pensi in maniera astratta e indiretta: questi due punti di vista sono sostanzialmente differenti se pure non necessariamente divergenti né men che meno necessariamente opposti. Ma è innegabile che l’idea di giustizia più diretta e più immediata è proprio quella di colui che sia direttamente interessato a questa, specialmente come soggetto passivo, e che quindi questa idea finisce per accostarsi a quella “richiesta di giustizia” di cui ha parlato Tomeo. Certo il mondo della giustizia non è la somma, né la sommatoria delle “richieste di giustizia”, seppure concettualmente e logicamente pare a noi che così dovrebbe essere, così come, d’altra parte, e proprio per questo, il diritto non è la somma, né la sommatoria, delle istanze di regolamentazione sociale. Tutt’altro! Questo concetto è stato espresso mirabilmente da Laurence M. Friedman nella sua notissima formula secondo cui il diritto è allocazione di beni e risorse, in cui il tema della allocazione rappresenta esattamente il processo di accumulazione di risorse, genericamente intese come tali, e più precisamente, per quel che maggiormente ci interessa in questa fase dell’analisi, di concentrazione di diritto e osiamo dire di giustizia, se con questo non distorciamo il pensiero di Friedman. Ma sul punto lo stesso
53V. Tomeo, «Interpretare il conflitto», Critica Liberale anno VI n.144, agosto 1973, ora anche in La Giustizia e le Giustizie, cit. pag.196.
58
autore, al di là della sua celeberrima formula, si è espresso in maniera molto incisiva; seguiamo da vicino il suo ragionamento: «le teorie del diritto come fenomeno sociale -afferma l’Autore- assumono che il sistema giuridico scaturisce da attività simili a quelle del mercato. Secondo questa teoria, la gente commercia i propri interessi così come commercia i beni; i codici giuridici che vigono nella società sarebbero, più o meno come, delle liste di contrattazioni e di preferenze sensibili alle trattative e all’esercizio di pretese come lo è il listino quotidiano delle quotazioni di borsa. Alcuni soggetti incominciano il gioco avendo a disposizione più gettoni e giocano con regole diverse dagli altri. La teoria per cui il diritto è un mercato non richiede che si neghi che il diritto esprime valori profondi o alte aspirazioni; tale teoria non implica affatto che tutti facciano solo calcoli razionali e che nessuno faccia sacrifici, che nessuno differisca le proprie gratificazioni a momenti futuri, che nessuno agisca nell’interesse pubblico e in maniera altruistica. Quella teoria riconosce il fatto che alcune persone o gruppi possono decidere di lottare per la giustizia sociale così come altre persone o altri gruppi possono decidere di riservare il proprio prezioso potere per una battaglia volta ad ottenere un maggior prezzo delle proprie prestazioni (omissis). Non vi è alcuna ragione per credere che tutte le società siano egualmente egoiste o altruiste. Ovunque gli ideali confliggono con gli interessi più bassi e più sporchi. In un certo senso il processo politico è cieco; esso non vede se una battaglia è egoistica o non lo è. Una persona che lotta per migliorare la propria nicchia produce sul diritto lo stesso impatto di una persona che lotta, impiegando la stessa quantità di forza, per nutrire le masse affamate o per salvare le foreste dall’ingordigia dei baroni del
59
legname, o per migliorare l’insegnamento scientifico nelle scuole».54 Se il mondo della politica e massimamente quello del diritto, che di quell’altro è l’espressione più diretta, è, come da più parti si afferma, e come noi assumiamo, il mondo della contrattazione ineguale, altrettanto lo è quello della giustizia. In quest’ottica l’idea di giustizia finisce per diversificarsi su due fronti opposti e contrapposti, da un lato l’idea di giustizia, come valore, un’idea del tutto personale, quella che abbiamo definito “la giustizia del sé”, l’altra un’idea concreta ed oggettiva di giustizia, quella che abbiamo definito “la giustizia degli altri”. La giustizia del sé finisce per coincidere con un’idea di valore, o meglio con un’idea di una pluralità di valori, che non può in alcun modo essere condotta ad unità senza determinare forzature socio-politiche di tipo autoritario, se non proprio dittatoriali. E sarebbe, d’altra parte, oltremodo irrazionale, oltreché pretestuoso, pretendere che vi sia, o che si crei artificiosamente, una sorta di finzione di unità spendibile verso tutti e che racchiuda la pluralità di valori di cui ciascuno é, in proprio, portatore e per certi versi l’unico portatore, perché sostanzialmente a fronte di una pluralità di valori, che sono sempre per definizione impalpabili e sociologicamente di difficile rilevazione e collocazione, questa nasconde e racchiude una pluralità di aspirazioni verso beni materiali, e questi sì rilevabili e quantificabili con precisione assoluta; bene ha detto sul punto Michael Walzer affermando che «i princî pi stessi della giustizia hanno una forma pluralistica; beni sociali diversi devono essere distribuiti per ragioni diverse, secondo
54L.M. Friedman, The Legal System. A social science perspective, Russel Sae Foundation, New York 1975, trad. it. Il sistema giuridico nella prospettiva della scienza sociale, traduzione di Giovanni Tarello, Il Mulino, Bologna 1978, pp.303-304.
60
procedure diverse, e tutte queste differenze derivano da concezioni diverse dei beni sociali stessi, risultato inevitabilmente del particolarismo storico e culturale».55 Ma pur rimanendo tutto questo incontestato e incontestabile, non si può nascondere che la giustizia è un fenomeno essenzialmente personale e mirato a “quella” specifica persona, identificabile con nome e cognome, e non genericamente a “tutte” le altre persone, e ciò per svariati motivi, in primo luogo perché non é detto che tutti si trovino o si debbano o si possano trovare nelle medesime circostanze nel medesimo momento di vita o non è detto che debbano trovarsi nelle stesse circostanze in qualche altro momento di vita, è assolutamente probabile, anzi che la gran parte delle persone non si troverà mai in certe circostanze, in secondo luogo perché, a prescindere dal fatto che ci si potrà o ci si potrebbe trovare in circostanze comuni, in un preciso contesto storico, realmente ci si trova o non ci si trova in quelle specifiche circostanze e quindi la circostanza di fatto attiene a chi effettivamente in quella circostanza si trova56. In breve, la giustizia ha di fronte uomini in carne ed ossa, come ha detto Tomeo, e circostanze di fatto specifiche e non previsioni normative genericamente e astrattamente rivolte a tutti gli uomini. Questo é incontestabile.
55M. Walzer, «L’uguaglianza complessa», in Giustizia e liberalismo politico, a cura di Salvatore Veca, Feltrinelli, Milano 1996, pag.147. 56E come non riconoscere, poi, che due situazioni giudiziarie e quindi due “casi” non sono mai del tutto identici se non per mera finzione processuale, anche se convenzionalmente si finisce per doverli assimilare in virtù della considerazione che, come ammette Hare, «il fatto che due casi reali non siano mai identici non ha alcuna importanza per il problema. Tutto ciò che dobbiamo fare, infatti, è immaginare un caso identico nel quale i ruoli siano invertiti». Cfr. R.M. Hare, Libertà e ragione, trad. it., Il Saggiatore, Milano 1971, pag. 154.
61
Ma non é solo un richiamo a un persistente atteggiamento giusnaturalistico quello che invade e pervade il sentimento individuale di giustizia, il senso della giustizia del sé, è anche un’esigenza oggettiva e obiettiva di pretendere e richiedere, da parte di ciascuno, cioè proprio da parte di coloro che in una precisa circostanza di vita si trovano in una precisa circostanza giudiziaria, che si renda giustizia. In questa specifica circostanza non emerge solo uno scontro tra parti o fra interessi contrapposti. come insegnano i teorici del diritto processuale, ma vi è uno scontro tra valori differenti: in gioco non è soltanto la privazione della libertà personale o la privazione di un bene materiale o la pretesa di un comportamento, ma vi è anche qualcosa d’altro che questo per certi versi sormonta e per altri versi presuppone, ed é proprio lo scontro fisico fra sé e gli altri, l’eliminazione diretta dell’altro prima ancora che l’eliminazione della pretesa dell’avversario. E’ l’espressione più alta del conflitto sociale quella che viene in gioco! Solo che a livello processuale il conflitto, questo tipo di conflitto, si complica enormemente rispetto ad altri tipi di conflitti sociali, perché le parti si moltiplicano e gli interessi si diversificano a dismisura: ciascuna parte finisce per essere portatrice di istanze personali, o comunque sue proprie, comunque “di parte”, anche quando istituzionalmente sono, o dovrebbero essere, portatrici di istanze terze, e ciò perché a prescindere del tutto dall’esito del conflitto, anche la parte istituzionalmente terza è percepita dalle parti contendenti non solo e non tanto come estranea ma addirittura come parte in conflitto, cioè come parte del conflitto; e nel caso del giudice come parte “forte” del conflitto stesso. E’ questo il motivo più vero per il quale i conflittualisti più autentici negano che vi possa essere una qualche risoluzione giudiziaria al conflitto, anzi apertamente riconoscono che una qualsiasi decisione giudiziaria,
62
favorevole o contraria che sia, genera ulteriore conflitto di per sé e ulteriormente ne genera perché da questa decisione sorge una “nuova” situazione di conflitto. Come osserva Ferrari «qui risiede il maggior distacco fra la concezione giuridica e la concezione sociologica del rapporto tra diritto e conflitti. Secondo la visione giuridica, il diritto, trattando i conflitti li dirime, li risolve. Non soltanto la conciliazione fra due litiganti ma anche la più tranchant fra le sentenze giudiziali elimina la disputa, la rende irrilevante agli occhi del mondo. Ciò che ne scaturirà sul piano sociale potrà essere rilevante agli occhi del diritto, ma sarà comunque altro rispetto alla disputa chiusa. Secondo la visione sociologica, ogni decisione parziale o finale, che venga assunta nel corso dell’interazione non è altro che un evento che contribuisce a produrre altri eventi e dunque non è, neppure teoricamente, un fatto risolutivo: é semplicemente un “mutamento della situazione” per usare le parole di Eckhoff”»57. Nella vicenda giudiziaria si innesta un elemento ulteriore di conflitto, oltre quello iniziale, un elemento che aumenta a dismisura la complessità sociale e quindi anche la complessità stessa del conflitto: il giudice. Il giudice, in quest’ottica, diventa un elemento di accelerazione straordinaria della complessità sociale e quindi necessariamente, e di conseguenza, del conflitto. Per la ragione che il giudice é “altro” rispetto alla situazione conflittuale iniziale, e quindi il risultato del suo giudizio, la “giustizia”, è “altro” rispetto
57V. Ferrari, Funzioni del diritto, Roma-Bari, Laterza 1987, pag. 187. Il richiamo a T. Eckhoff é tratto da «Il mediatore, il giudice e l’amministratore nella soluzione dei conflitti» in A. Giasanti- V. Pocar (a cura di), La teoria funzionale del diritto, Milano, Unicopli 1983, pag.159. E non solo i conflittualisti più autentici ma anche gli avversari più convinti riconoscono che il diritto non risolve soltanto i conflitti, ma li rende possibili e addirittura li produce, come afferma N. Luhmann, «Conflitto e diritto» in Laboratorio Politico 1982 n.1, pag.17.
63
alla situazione di conflitto iniziale. Questa connessione fra aumento della complessità e l’intervento del giudice é stata ben evidenziata, fra gli altri, da Luhmann quando ha affermato che «il diritto aumenta in primo luogo l’incertezza dell'aspettativa, aggiungendo un terzo, che si inserisce nel conflitto e lo può risolvere. Non é certo in favore di chi lo deciderà: Il terzo fattore può essere un testo (ancora sconosciuto o da interpretare) o un ufficio informazioni, un arbitro, un intermediario o un giudice, che ha la possibilità di emettere decisioni vincolanti; in ogni caso esso aumenta l’incertezza dell’aspettativa di entrambi le parti, poiché ognuna, oltre che con il comportamento dell’avversario, deve fare i conti anche con qualcos’altro, e pertanto non può sapere con sicurezza neanche come l’avversario si atteggerà rispetto a questo terzo fattore». Seguiamo compiutamente il suo pensiero: «le condizioni che ne derivano -afferma ancora l’Autore- imposte dalla partecipazione di un Terzo, servono altre funzioni e tendono a stabilire un ordine che si presenta agli interessati con una certa obiettività. L’incertezza dell’aspettativa che compare di nuovo corrisponde a questa struttura di ordine. In relazione al nuovo rapporto tra complessità e instabilità, un sistema che motiva e limita il comportamento con decisioni non ancora fisse. Il pendolo tra certezza e incertezza dell’aspettativa, tra apertura e chiusura del sistema a possibilità ulteriori, tra aumento e riduzione della complessità, non é un pulsare senza senso, ma é piuttosto -nella misura in cui si espone a diversi condizionamenti- conseguenza e fattore produttivo di storia. L’incertezza introdotta da un Terzo si dispone in certo qual modo trasversalmente rispetto all’apertura tematica e strategica del conflitto. Anche se il conflitto permette tutto ciò che ha successo, il Terzo discrimina.....Una esternazione del conflitto in direzione di terzi fattori o di un Terzo che si inserisce mette in gioco possibilità
64
supplementari. Il gioco stesso, o il Terzo, non sarà da parte sua tematicamente neutrale».58 Dunque il giudice, come ammettono anche i più convinti interpreti dell’integrazione sociale, non potrà mai essere considerato realmente terzo estraneo, ossia terzo neutrale, ma nelle parti in conflitto egli tende, per sua natura, ad assumere la veste di parte, anzi di parte forte, forse per certi versi della parte più forte. Tra i contendenti di un conflitto giudiziale si innesta una parte ulteriore: lo stato, che quindi, agli occhi degli “interessati”, finisce per assumere le vesti di avversario o quantomeno di contendente. E’ la situazione descritta in modo assai eloquente da Vincenzo Tomeo, nel suo volume Il giudice sullo schermo, in cui nell’attribuire al cittadino un atteggiamento di diffidenza verso il giudice e la giustizia si interroga sul significato di un atteggiamento così palese di sfiducia. «Essa può essere -é la risposta dell’Autore- il risultato di una realistica consapevolezza che ogni “giustizia”
58N. Luhmann, Conflitto e diritto, cit, pp.16-19. E’ appena il caso di notare che sotto il profilo dell’esito dell’analisi ci permettiamo di dissentire profondamente dalle conclusioni di Luhmann in quanto l’Autore si serve di queste premesse per riconoscere il valore positivo e sostanzialmente pacificante, o quantomeno stabilizzante, del diritto, e dell’intervento del Terzo, cioè della decisione giudiziaria, perché come egli stesso afferma «una situazione così preparata, che combina la certezza del conflitto con l’incertezza relativa al Terzo, rappresenta un terreno fertile per la genesi dell’ordine. Soluzione del conflitto -conclude sul punto l’Autore- è perciò una definizione forse troppo esagerata, ma si potrebbe parlare di formazione di aspettative abbastanza generalizzate, alle quali la situazione di conflitto serve come una prima verifica». (Ibidem, pag.18). Rispetto all’incertezza dell’aspettativa, osserva ancora l’Autore, il conflitto ha dalla sua almeno un vantaggio: fornire la possibilità di giungere ad una decisione, e quindi al ristabilimento delle aspettative. Per noi invece, lo ripetiamo, il conflitto sia quello sociale in generale che quello giudiziale non perviene mai a una conclusione né a soluzione ma genera una spirale di conflitto in cui la situazione iniziale di conflitto è solo il volano di altre situazioni conflittuali a catena.
65
dipende da una struttura sociale determinata e che ogni diversa richiesta di “giustizia” ripropone pour cause un tentativo di cambiare la società. Un atteggiamento di sfiducia può essere però il risultato di una situazione del tutto diversa: la fatalistica convinzione che, in ogni caso e in ogni modo, la separazione tra chi detiene il potere e chi lo subisce riproduce e rispecchia una situazione costante, necessaria, praticamente immodificabile. Non è sempre vero che accanto alla convinzione che vede nella legge la regola comune, non vi può essere che la convinzione simmetricamente opposta che vede nella legge lo strumento del controllo da parte della classe dominante di cui é l’emanazione. Vi può essere posto anche per una terza soluzione, che non é intermedia ma totalmente diversa, quella che vede nella legge una pura e semplice emanazione del potere, considerato come essenza immutabile e paretianamente tendente all’equilibrio: possono mutare le componenti, non muta il rapporto di dominazione».59 Questo “terzo” é il soggetto e il luogo del diritto e della giustizia, necessariamente indipendente dai contendenti ma anche svincolato, in parte o del tutto, da questi, potrà essere il soggetto e lo strumento del controllo sociale, come ammettono apertamente i funzionalisti più dichiarati, potrà essere il soggetto e lo strumento della soluzione autoritaria e formale del conflitto ma non potrà mai essere il soggetto o l’elemento della soluzione sociale del conflitto, perché in sostanza questo terzo incarna in sé il ruolo del potere e questo ruolo lo gestisce autonomamente ed in proprio rispetto alle richieste che provengono dalle parti in conflitto: potrà decidere di assegnare una “quota” di giustizia all’una o all’altra parte o a nessuna delle due o ad entrambe le parti, ma non muta in nessun modo il rapporto di potere rispetto alle parti stesse, anzi questo rapporto viene sempre più ribadito e rivendicato. 59V.Tomeo, Il giudice sullo schermo, Roma-Bari, Laterza, 1973, pag.29.
66
E’ questo il motivo per cui definiamo questo tipo di giustizia “la giustizia degli altri”. Come acutamente osserva Mario Cattaneo «é possibile affermare e sostenere che esistono due diverse definizioni del concetto di diritto, su due piani o livelli diversi. Da un lato è possibile definire il diritto come uno strumento, o se si vuole, come una “funzione sociale”, come un ordinamento normativo coattivo, avente lo scopo di regolare la convivenza sociale. Dall’altro lato é possibile assumere un’altra definizione del concetto di diritto, a un diverso livello. Tale definizione intende il diritto essenzialmente come valore, come il tentativo di attuare -per quanto é possibile in una società imperfetta e difficile come quella umana- la giustizia; secondo tale definizione, il diritto ha il compito di difendere e proteggere i diritti individuali e la libertà di ciascuno. In sostanza, se é vero che in questa prospettiva il diritto é un “valore”, si può e si deve precisare tale espressione dicendo che si tratta di “un valore strumentale”, vale a dire non tanto un valore in sé quanto un valore finalizzato ad un altro valore di grado superiore: il valore cui il diritto deve servire è la libertà e dignità dell’uomo».60 Ma come riconosce Domenico Corradini «del diritto non ci si può fidare o non ci si può fidare ciecamente e che non si può aver cieca fede che il diritto non violi ciò che non é ontoassiologicamente inviolabile: la soggettività o la suitas dell’altro nella differenza, o nella spazio della differenza».61 E dunque questo “sentimento” che ciascuno ha della giustizia “degli altri” é un complesso variegato di sensazioni, di percezioni e di convinzioni da cui emerge sostanzialmente diffidenza, sfiducia,
60M Cattaneo, Critica della giustizia, Milano, Lanfranchi 1996, pag.44. 61D. Corradini, Filosofia del conflitto, in Atti del XVIII Congresso nazionale della Società italiana di filosofia giuridica e politica, Milano, Giuffrè 1995, pag.37.
67
timore, rancore, senso di impotenza, o anche solo la sensazione di estraneità, che é, forse, il sentimento e la sensazione più autenticamente vera che si prova dinanzi alla giustizia, sensazione accompagnata e motivata, come abbiamo detto, dalla convinzione e dalla constatazione che il terzo non é realmente terzo né realmente estraneo alla situazione ma gestisce, certo non in proprio, un ruolo di potere e quindi indiscutibilmente un ruolo di parte. Se, poi, questa stessa sensazione, la si vuole ulteriormente dilatare fino ad includere in questa anche il profilo della considerazione dell’uguaglianza di ciascuno di fronte alla legge, sicuramente si innesta un ulteriore elemento che rafforza definitivamente questa convinzione. Il diritto, e quindi anche la giustizia, é certamente il luogo istituzionale dell’ineguaglianza, su questo sono stati scritti fiumi di inchiostro e tutti di segno concorde e su questo si può, dunque, convenire senza molti sforzi; il luogo istituzionale dell’ineguaglianza si é detto, non fosse altro perché il concetto di eguaglianza è quanto di più oscuro e di più labile possa esservi al mondo ma anche solo per la considerazione lapalissiana che trattare in modo formalmente “uguale” tutti i casi significa di fatto trattarli in maniera ineguale. Questo punto è stato evidenziato con molta acutezza da Eligio Resta quando ha affermato che «sono proprio le politiche dell’uguaglianza a mostrare un volto sempre più contraddittorio dei sistemi giuridici contemporanei. Da una parte essi, per rimanere cognitivamente aperti, devono chiudersi sempre di più dal punto di vista organizzativo. Questo significa che la possibilità di rispondere a problemi di natura diversa, a soggetti e condizioni differenti, può essere salvata soltanto da un arricchimento della «riflessività» interna. La legalità non può derivare da altro se non dalla stessa legalità indicata dal diritto, i principi che regolano l’attività del
68
diritto non possono che essere “giuridici”, é il diritto stesso a definire quello che é diritto e quello che non é diritto. Ma da un altro punto di vista specularmente opposto, il diritto moderno nasce come un sistema del tutto secolarizzato, sradicato, “errante radice”, sottoposto alla variabilità decisionale del politico, che costituisce un anello importante di quel programma condizionale. Gli spazi della cittadinanza, la vita dei diritti, sono dispersi in una lunga catena decisionale (molto spesso di non decision making) in cui il principio giuridico é soltanto un punto di riferimento. Per quanto «sostanziale» sia la sua previsione (come nel caso dell’uguaglianza sostanziale) la sua attuazione «dipende» da tante altre possibilità. E’ questo uno dei motivi più classici di contrasto tra stato di diritto e stato sociale. La storia dell’uguaglianza é fino in fondo dentro un modello individualistico in cui tutto sembra animato da una struttura “mimetica”, animata da una antropologia dell’invidia e dalle relative richieste di “inclusione” da una parte, e da elargizioni sotto forma di riconoscimento o da etnocentriche omologazioni dall’altra. E i diritti dovrebbero essere qualcosa di differente da pretese da una parte e da prestazioni supererogatorie dall’altra. Del resto “il soggetto di diritto” é un’invenzione dello stesso codice dell’uguaglianza e si sa che la storia é una complessità già ridotta. L’aspetto perverso della giustizia procedurale pura che sancisce l’eguaglianza formale dei cittadini di fronte alla legge doveva essere ben presente ai costituenti italiani se, pur in una dimensione spesso non chiara di “politeismo ecumenico” che recepisce le più diverse stratificazioni ideologiche, essi hanno scelto di mettere insieme la dimensione dell’uguaglianza formale e quella dell’uguaglianza sostanziale...... Non é consentito dedurre dall’interpretazione della norma costituzionale che, dal momento che esiste la previsione normativa dell’uguaglianza sostanziale, le
69
disuguaglianze in Italia sono cancellate. Ma non si può nemmeno inferire che, dal momento che le disuguaglianze esistono e in qualche caso si rafforzano, la norma costituzionale sia ormai abolita».62 E con altrettanto vigore Raffaele De Giorgi evidenzia che «la distinzione uguaglianza-disuguaglianza, in quanto operazione interna al sistema giuridico rende manifesto il fatto che le condizioni dell’uguaglianza sono contemporaneamente condizioni della disuguaglianza, cioè che nel diritto c’é uguaglianza perché c’é disuguaglianza. La società moderna al suo attuale livello di evoluzione, si confronta con problemi rispetto ai quali lo schema uguaglianza-disuguaglianza non ha alcuna rilevanza risolutiva. D’altra parte non si può certo pensare che una volta svelato il paradosso dell’uguaglianza e dell’equità nel sistema giuridico, sia possibile tornare indietro rispetto all’acquisizione del principio giuridico dell’uguaglianza. Né, tantomeno, si può pensare che lo schema possa evolvere o comunque trasformarsi fino a realizzare condizioni di presunta uguaglianza materiale. La società di uguali si realizzerà solo dopo il giudizio universale».63 Ma proprio questo senso e questa percezione dell’ineguaglianza, seppure razionalmente motivata dall’oggettività più palese e macroscopica e dalla consapevolezza della sua ineliminabilità, fa accrescere sempre più quella spirale di sfiducia e di estraneità di cui é circondato il mondo del diritto e della giustizia: certezza dell’ineguaglianza di fronte alla legge, certezza di un trattamento diseguale di fronte alla legge, certezza dell’estraneità.
62E. Resta, «Il diritto fraterno. Uguaglianza e differenza nel sistema del diritto», in Sociologia del Diritto 1991/3, pp.22-25. 63R De Giorgi, «Modelli giuridici dell’uguaglianza e dell’equità», in Sociologia del diritto 1991/1, pag.33.
70
Ma v’é di più, manca nelle parti in conflitto, più ancora che altro, la sicurezza dell’ eguaglianza nella diversità, cioè quella sorta di par condicio, di possibilità di uguali opportunità di fronte alla ineguaglianza che dovrebbe costituire l’essenza della giustizia, cioè quella condizione per cui il cittadino verrebbe posto nella possibilità di avere, e poter spendere, eguali chances sul tavolo del conflitto giudiziale64. Questo aspetto é stato evidenziato assai bene da Vincenzo Tomeo quando ha affermato che «l’uguaglianza delle chances politiche é un mito, ma ciò non é che un altro e potente motivo di conflitto. D’altra parte che una decisione giuridica trovi in fondamento di razionalità nei principi del sistema non é del tutto una menzogna ideologica; ma non é nemmeno la realtà delle cose. Nella realtà é la ricerca dello scopo che conta, e l’interpretazione degli scopi comporta inevitabilmente una interpretazione delle situazioni di conflitto. Il decisore può operare, a questo punto, anche una scelta tra i principi del sistema, adottandone alcuni a scapito di altri: in sostanza può operare una scelta politica».65 .3 Pluralismo sociale e giustizia Si ritorna alla celeberrima formula di L.M. Friedman, che forse meglio di altri fotografa in maniera lapidaria la situazione. 64E’ questa la giustizia in senso formale che presuppone, per usare le parole di Giulio Chiodi, «un’uguaglianza formale dei cittadini di fronte alla legge alle istituzioni, cioè allo stato: rimangono, invece, impregiudicate le differenze che si generano in seno allo sviluppo economico e sociale», e queste, aggiungiamo noi, si riflettono, e anche in maniera determinante sull’esito del conflitto giudiziale. Cfr. G.M. Chiodi, La menzogna del potere, cit., pag.221. 65V. Tomeo, Il diritto come struttura del conflitto, Milano, Angeli 1981, pag.95.
71
«Il potere, afferma ancora Friedman, è disegualmente distribuito e disegualmente esercitato e il diritto non può che rispecchiare siffatta distribuzione66. Il potere discrimina, o per meglio dirla con terminologia priva di connotazioni emotive, riflette la struttura sociale esistente, in due diversi modi. In primo luogo, le norme stesse, l’aspetto ufficiale del diritto, non sono affatto del tutto imparziali anche quando sono applicate con imparzialità. Esse sono il prodotto di lotte per il potere e sono forgiate dall’opinione dei dominanti». In secondo luogo «ancora più importante è, sotto questo aspetto, la struttura di base del diritto: i regolamenti, le norme tributarie, e in generale la disciplina dell’economia, sono plasmati sulle esigenze e sugli interessi dei proprietari. Peraltro molte norme sembrano essere, sotto il profilo dei valori, fuori dal tempo e neutrali, sembrano essere espressione di fede e di valori aerei, non storicamente situati. Quale sia poi il modo in cui queste norme vengono applicate è un’altra questione. L’amministrazione della giustizia è sottoposta a delle forme di controllo sociale, sia impercettibili sia vistose, che non sono riconosciute dal diritto ufficiale»67 E’ la mancanza di eguaglianza nella diseguaglianza di cui si diceva prima! Michael Walzer ha puntualizzato molto acutamente questa situazione definendola di uguaglianza complessa. «La giustizia -afferma l’Autore- é una costruzione umana e non é detto che ci sia un modo per realizzarla. Non si tratta soltanto di realizzare un 66L.M. Friedman, Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali, cit., pag. 304-305. 67Ibidem, pp.306-307.«Ad esempio, conclude l’Autore, chi è povero semplicemente non è in grado di sostenere le spese per l’avvocato di cui ha bisogno per realizzare il suo diritto nei confronti del padrone di casa, del venditore, e dell’amministrazione pubblica nelle relazioni di diritto privato o nel diritto penale».
72
singolo principio o un insieme di principi in contesti storici diversi; nessuno potrebbe negare l’esistenza di una varietà di realizzazioni moralmente ammissibili. La mia tesi va oltre: principi stessi della giustizia hanno una forma pluralistica; beni sociali diversi devono essere distribuiti per ragioni diverse, secondo procedure diverse, e tutte queste differenze derivano da concezioni diverse dei beni sociali stessi, risultato inevitabile del particolarismo storico e culturale»68 I soggetti partecipi di un conflitto giudiziale sono perfettamente consci di tutto questo, da qui nasce quella diffidenza e quella sfiducia di cui é circondata la funzione giudiziaria, é questo anche uno dei motivi più frequenti per cui si preferisce ricorrere alla figura dell’arbitro, il quale, volontariamente scelto dalle parti in conflitto, e proprio perché scelto volontariamente dalle parti in conflitto, é portatore di un ruolo di potere che non gli attribuisce un terzo soggetto, normalmente lo stato come nel caso del giudice, bensì le parti stesse; questo se non é proprio garanzia di estraneità è quantomeno garanzia di terzietà reale rispetto alle parti che lo hanno scelto, perché tra lui e le parti corre un rapporto di fiducia, dovuto ad una scelta libera e volontaria. E tanto maggiori sono gli interessi in gioco ed in conflitto tanto più frequente é la scelta di un arbitro, a riprova della considerazione che proprio la funzione di terzietà su base volontaria é garanzia di fiducia, o di maggior fiducia, e di accettazione della decisione. Ed é anche, sostanzialmente, la ragione per cui la giustizia “alternativa”, nelle sue varie forme, é destinata sempre più a sovrapporsi e a soppiantare la giustizia “normale”. Nella giustizia “alternativa” ad una terzietà imposta, e fortemente sospetta, si viene a sostituire una terzietà volontaria e accettata
68M Walzer, «L’uguaglianza complessa», cit., pag.147.
73
dalle parti; così il rapporto di fiducia fra parti e terzo si accresce, seppure sarebbe azzardato sostenere che possa definirsi totale. 69 Finora abbiamo esaminato la giustizia dalla parte di chi questa la “subisce”, ma la giustizia non é solo questo, anzi per molti versi non é affatto questo, ma é una realtà complessa e polivalente, che presenta volti diversi a seconda del punto di vista dell’osservatore, e aspetti differenti a seconda di chi la sperimenta; sotto questo punto di vista la giustizia é, per riportarci ancora una volta alla formula di Friedman, allocazione di beni e servizi scarsi, cioè un vero e proprio «sistema di razionamento».70 Bisogna quindi porsi da entrambe le ottiche. Quella di chi é il beneficiario di questo sistema di allocazione e quella di chi ne é escluso. Seguiamo compiutamente il pensiero dell’Autore: «ciò che il sistema giuridico fa, e ciò che esso é, riflette la distribuzione del potere nella società: chi sta al vertice, chi sta alla base; inoltre, il diritto provvede a che questa struttura sociale resti stabile, o cambi soltanto nei modi approvati e previsti. Il sistema emette comandi, attribuisce benefici, e dice alla gente ciò che si può e ciò che non si può fare; in ogni caso, la norma del diritto, se eseguito, ha compiuto qualche scelta in ordine a chi deve avere, o ottenere, o mantenere, qualche bene».71
69Per Pizzorno il principio di imparzialità, senza il quale l’attività giudicatrice non ha senso, é realizzato in maniera ideale quando sono le parti stesse ad accordarsi per scegliere il giudice. Ma in una società moderna tale pratica é possibile solo raramente (nel caso di arbitrati e simili) Cfr. A. Pizzorno, Il potere dei giudici. Stato democratico e controllo della virtù, Roma-Bari, Laterza 1998, pag.16. 70L.M. Friedman, Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali, cit. pag.62. 71Ibidem, pp.62-63.
74
Dunque, per Friedman, e noi condividiamo in pieno questa analisi, la giustizia funziona come un meccanismo di razionamento, e di attribuzione, di decisioni e di risorse, e dunque, aggiungiamo noi, é, in definitiva, un meccanismo selettivo di scelte. E pertanto se la norma giuridica é una decisione e quindi una scelta, un’opzione fra diverse possibili opzioni, e in sostanza una decisione e una scelta politica, l’applicazione della norma conseguentemente non può, e per molti versi non deve, discostarsi da questa scelta politica. Il giudice, volente o nolente, non può che essere parte di questo meccanismo e in ultima analisi di questa scelta, cioè non può, in definitiva non essere parte in questa scelta politica, se proprio non vogliamo azzardarci a dire che non può non essere anche parte di questa scelta politica. In questa affermazione ci confortano i giudizi di illustri autori. Alessandro Pizzorno nel sottolineare che sin dagli anni settanta in Italia si é acceso il dibattito sulla natura ed i limiti del potere giudiziario e sui rapporti di questo con la politica rileva che «sin da allora, prima che l’opinione pubblica se ne accorgesse, la classe politica cominciò a veder la magistratura, o certi settori di essa, come possibile attore politico, potenziale alleato in certi casi, pericoloso nemico in altri». Due le possibili ipotesi che l’Autore assegna a questo fenomeno, la prima é che «l’emergere di una sfera pubblica, e quasi, a contraccolpo, di partiti politici organizzati su base popolare e tendenzialmente ideologici, dà origine alla politica programmatica, volta a riformare o riorganizzare la società, e a quella che ne è l’espressione più coerente, lo stato sociale. Questo porta con sé una produzione normativa di natura assai differente da quella dei regimi rappresentativi classici. La funzione giudiziaria dilata allora le sue funzioni e la sua creatività normativa in modi che non erano previsti dalla posizione che le era stata assegnata originariamente nella divisione dei poteri». La seconda è che «ci
75
sono trasformazioni sociali in senso proprio, che non passano unicamente attraverso le modifiche del sistema politico e dell’attività dello Stato ma che convergono con queste nell’orientare un accresciuto flusso di domanda verso la funzione giurisdizionale. La più rilevante di queste trasformazione è quella che gli americani chiamano “due process revolution”, e che potremmo definire la resa delle autorità sociali alla legge. A lungo, nelle società occidentali sono convissute con lo stato di diritto e con il sistema economico di mercato -e sono state essenziali per mantenere l’ordine sociale- autorità sociali capaci di emanare norme e farle rispettare.... La società era (e in parte è ancora, ma in misura che decresce rapidamente) formata da innumerevoli ordinamenti giuridici minimi, regolati da norme proprie e retti da autorità capaci di sanzionare le inosservanze e le trasgressioni, quindi, almeno parzialmente chiusi nei confronti dell’ordinamento giuridico dello Stato. Solo in casi patologici il giudice era chiamato a intervenire, normalmente per le piccole controversie se ne faceva a meno. L’attività giudicante vera e propria, quella organizzata dallo Stato, poteva così limitarsi a prendere in considerazione non più che un’area ridottissima di eventi trasgressivi dell’ordine sociale sul totale di quelli che accadevano nella società nel suo insieme. Negli ultimi decenni quest’area è in continua espansione».72 E, conseguentemente, aggiungiamo noi, è in continua espansione il ruolo politico del giudice, seppure in questo momento si assiste a ripetuti tentativi, politici e anche legislativi, volti a ridurre, o quantomeno a contenere questo ruolo politico del giudice. Ruolo politico che si manifesta anche attraverso l’esercizio, latente o manifesto, di supplenza di funzioni, più che giudiziarie, propriamente o contiguamente politiche da parte del giudice, come 72A. Pizzorno, Il potere dei giudici, cit, pp.39-40.
76
riconosce pur tra mille cautele e con infinita circospezione anche Massimo Morisi, il quale fonda la sua analisi su questo punto partendo dalla considerazione che «l’interpretazione della legge e del suo significato, cioè la funzione primaria del giudice, si compie ad opera del magistrato ponendo a confronto la voluntas del potere sovrano con la specifica ratio del caso da dirimere. La ricerca e la ponderazione giudiziaria del significato della specifica questione da risolvere avviene sulla base di norme, di valori e di principi, che possono far ritenere, agli occhi di quel singolo giudice, le prescrizioni legislative da applicare più o meno consone al senso e al valore più profondi che egli attribuisce al singolo caso per cui egli può ritenerle più o meno utili e pertinenti all’interpretazione del conflitto tra ruoli, pretese e asimmetrie di posizioni e risorse sociali che il caso stesso sottende e che il giudice, a differenza dell’attore politico, deve -se non dirimere- almeno trattare. Proprio questa valenza complessa e molteplice dell’azione interpretativa -è la conclusione dell’Autore- rende capace la funzione giurisdizionale di integrare o, secondo le circostanze, di surrogare la rappresentazione di diritti e interessi cui sarebbero deputate le “arene” propriamente politiche e amministrative».73 Anche Stefano Rodotà, più apertamente, riconosce un mutamento e un aumento, avvenuto negli ultimi anni, del ruolo politico della funzione giurisdizionale attribuendolo alla sua collocazione nel sistema politico, «che ne fa la prima istituzione incontrata da soggetti e interessi nuovi alla ricerca di legittimazione».74 Secondo 73M. Morisi, Anatomia della magistratura italiana, Il Mulino, Bologna 1999, pag.17. 74S. Rodotà,«Magistratura e politica in Italia.», in Governo dei giudici. La magistratura tra diritto e politica, a cura di E. Bruti Liberati, A. Ceretti, A. Giasanti, Feltrinelli, Milano 1996, pag.27. Corre l’obbligo di precisare che Rodotà rifugge, quasi con sdegno, l’idea che questo ruolo giurisdizionale possa in qualche modo essere qualificato come ruolo di «supplenza giudiziaria»; siamo
77
l’Autore «sono sempre più spesso i giudici a essere i primi destinatari di tutta una serie di domande sociali. Quanto più il legislatore è lento, o quanto più il suo intervento è frenato dalla forza di interessi particolari o dalla mancanza di un consistente consenso sociale, tanto più forte diviene la ricerca di un altro varco istituzionale, che la magistratura può fornire per la sua natura di potere “diffuso”. Accanto alle tradizionali funzioni di controllo sociale, di risoluzione delle controversie e di legittimazione dell’autorità costituita emergono con nettezza momenti dell’attività dei magistrati che si risolvono nell’articolazione della domanda politica e nell’attuazione delle politiche pubbliche».75 Il discorso di Rodotà è decisamente interessante anche per l’ottica che propone e le premesse da cui parte, un’ottica sicuramente iper-garantista o quantomeno iper-statalista in cui il soggetto al centro dell’attenzione non è il giudice bensì il fruitore dell’apparato della giustizia. Una voce, questa, solo apparentemente dissonante rispetto a quelle fin qui evidenziate, in realtà l’Autore amplifica più di altri il ruolo politico del giudice, seppure legittimandolo attraverso la richiesta e la sollecitazione del cittadino e rendendolo un ruolo strumentale all’interesse del cittadino stesso (che diversamente sarebbe privo di una sua propria visibilità). Seguiamo da vicino il suo ragionamento, «l’arena giudiziaria diventa anche un luogo dove soggetti, altrimenti esclusi dai tradizionali luoghi
di fronte a intrecci (tra giustizia e politica), precisa l’Autore, sempre più complessi, che non possono essere spiegati adoperando categorie rozze come quella della “supplenza giudiziaria” o risolvendo tutto in una volontà di potenza dei magistrati, o nella brama di apparire nel «circo mediatico-giudiziario». Cfr. Ivi, pag.28. 75Ibidem. E’ evidente da quanto abbiamo detto sopra che dissentiamo in maniera netta dalla considerazione che la funzione giudiziaria sia risolutiva di controversie e di legittimazione dell’autorità, ma comprendiamo appieno e rispetttiamo il parere del giurista positivo.
78
istituzionali, riescono a far sentire la loro voce. Dunque un canale per la rappresentanza politica, con un innegabile arricchimento del processo democratico nel suo insieme. Se, infatti, uno dei caratteri di tale processo è la sua capacità d’essere veicolo d’inclusione di nuove identità collettive, è innegabile che questo sia già avvenuto per molti soggetti grazie alla disponibilità del canale giudiziario. La via giudiziaria, inoltre, assicura visibilità ai conflitti, contribuendo a quella generale trasparenza che, di nuovo, si presenta come una delle caratteristiche del processo democratico»76. La conclusione cui perviene l’Autore è che è in atto un grande processo di ridefinizione del ruolo della magistratura nell’ambito dei sistemi politico-istituzionali e che questo comporta continui attraversamenti dei confini tra giustizia e politica in una logica in cui vi sia un rinnovata considerazione della legittimazione democratica della istituzione giudiziaria e di singoli magistrati.77 Sembra a noi che comunque e ovunque si voglia cercare e trovare la legittimazione all’attività giudiziaria il ruolo politico in capo al giudice sia incontestabile, e ciò per entrambe le ragioni su cui un’asserzione di questo genere può reggersi: sia per i rapporti istituzionali in cui è inserito il giudice (meglio dovrebbe dirsi, più genericamente, il magistrato) e di cui egli è circondato e di cui egli si circonda, sia per il profilo più specificatamente normativo che la funzione richiede e di cui egli si serve nell’esercizio delle sue funzioni Per quanto riguarda il primo aspetto, proprio per il fatto di essere inserito in un ruolo di potere che gli deriva dall’appartenenza ad un ordine, che è sostanzialmente un potere, all’interno dello Stato il giudice riveste e gestisce un ruolo politico; su questa affermazione, che potrebbe sembrare a prima vista un sillogismo, pochi, credo
76Ivi, pag.27. 77Ivi, pp.28-30
79
siano in grado di dissentire. Il punto non è, però, quello di dissentire o di assentire sul contenuto di questa affermazione quanto, piuttosto, quello di intendersi su che significato si debba attribuire a questo ruolo politico del giudice e di come questo ruolo in concreto è esercitato. Le voci contrastanti, a ben guardare, non riguardano la veridicità o meno di questa asserzione quanto invece il significato stesso del termine “ruolo politico” e soprattutto le motivazioni che le supportano, sono queste tutte questioni che possono portare a esiti assai differenti pur rimanendo invariata l’affermazione iniziale. Renato Treves data «il carattere politico del potere giudiziario» dopo la fine della guerra, quando, a suo giudizio, si è creata una discrepanza sempre più profonda tra le strutture normative vigenti e la realtà sociale in continua trasformazione. «Discrepanza che ha reso più evidente il fatto che la funzione del giudice non può essere semplicemente quella di chi applica o interpreta la legge, ma è quella di chi decide e risolve il conflitto: ha reso più evidente il fatto che la funzione del giudice è una funzione sostanzialmente politica anche se più sfumata e meno immediata di quella esercitata da altri operatori più specificamente impegnati in questo settore».78 Ma, a giudizio dell’Autore, quel che maggiormente interessa «non è tanto il problema della scelta politica, quanto la constatazione del fatto che si debba fare una scelta politica e che sulla base di questa scelta il magistrato esercita un potere molto ampio, dato che l’apparato tecnico dottrinale a cui fa ricorso può giustificare le scelte più diverse».79 Più sottile e molto raffinato il ragionamento di Vincenzo Tomeo, al riguardo «E’ facile osservare -nota l’Autore che, per quanto
78R. Treves, Giustizia e giudici nella società italiana, Roma-Bari, Laterza 1972, pag.188. 79Ivi, pag.194.
80
riguarda il giudice, la crisi del suo ruolo formale è iniziata non appena i giudici come corpo e come ceto hanno assunto un ruolo tecnicamente e apertamente politico. Ma l’inizio della crisi è più apparente che reale, come, d’altra parte, è più apparente che reale l’assunzione attuale di aspetti politici in un ruolo che in passato sembrava definito da caratteri tecnici. Apparentemente, il giudice interprete della legge non ha contraddizioni né crisi (anzi, la legge può apparire perfino strumento di innovazione sociale). Nella realtà, caratteri politici ed elementi contraddittori sono latenti in ogni caso nel ruolo del giudice. Se, infatti pensiamo al giudice come a un ruolo dotato di potere formale, cioè di autorità, esso fa parte per sua natura di un sistema di rapporti che chiamiamo politico. Come tale, il giudice gode di poteri e svolge funzioni che sono sostanzialmente omogenee a quelle svolte in sedi diverse, ma contigue ai luoghi dove si esercita la funzione giudiziaria. Può darsi che il ruolo del giudice sia contraddistinto da aspetti più sfumati e meno immediati rispetto ad altri ruoli tecnicamente politici; ma nei momenti che veramente contano nel processo sociale tali sfumature e tali mediazioni tendono inevitabilmente a scomparire. In questi momenti i giudici sono posti drammaticamente di fronte alla contraddizione di svolgere una funzione che si appella a princìpi super partes, ma che, non diversamente da altri ruoli di potere, formale o non formale, è per sua natura connessa e incardinata nel contesto di un rapporto inegualitario, asimmetrico e antagonistico. I princìpi di imparzialità e di rispetto dell’uguaglianza si scontrano allora senza alcuna mediazione con il contenuto reale di una funzione il cui obiettivo è quello di costringere e di condizionare gli altri».80 Massimo Morisi inquadra e riveste questo ruolo politico del giudice osservandolo non tanto sotto il profilo dei soggetti che da questo 80V. Tomeo, Il giudice sullo schermo, cit., pp.140-141.
81
ruolo sono investiti quanto piuttosto sotto quello degli oggetti della sua competenza e dell’interpretazione che di questi ne compie: «proprio questa valenza complessa e molteplice dell’azione interpretativa del giudice rende capace la funzione giurisdizionale di integrare o, secondo le circostanze, di surrogare la rappresentazione di diritti e di interessi cui sarebbero deputate le “arene” propriamente politiche o amministrative..... E’ chiaro allora che questo ruolo politico della magistratura diventa un presupposto della funzionalizzazione della legalità alla regolazione sociale. E in un duplice senso. Da un lato, per il concorso del giudice, appunto alla regolazione sociale di cui si avvale il sistema politico amministrativo per la sua stabilità. Dall’altro, per il fatto che questo suo contributo regolativo si sviluppa proprio attraverso l’analisi e l’intermediazione -”dall’interno”- delle dinamiche dialettiche tra interessi della società civile. Cioè innestando la propria azione di magistrato nella costante confluenza delle regole dello Stato e delle funzioni selettive del mercato; delle logiche e dei processi che costituiscono la politica e delle modalità di interazione e negoziato proprie del far politiche. Il giudice è così chiamato a condividere con il ceto politico una generale funzione di distribuzione dei valori e delle risorse che alimentano il conflitto, la convivenza e la frammentazione di una collettività storicamente data. Il magistrato, in una parola, è parte attiva del coordinamento politico della società civile».81 Per quanto riguarda l’altro aspetto, il profilo normativo, cioè l’applicazione in concreto della legge questo è l’elemento che, forse più dell’altro, sancisce e rafforza ulteriormente il carattere politico del ruolo del giudice. Se la norma è una scelta politica, l’attività di chi questa scelta applica, ed è istituzionalmente chiamato ad applicare, non è forse un riflesso di questa stessa scelta politica? 81M. Morisi, Anatomia della magistratura italiana, cit., pp.17-18.
82
Crediamo fermamente che il giudice non possa sottrarsi in alcun modo a questo interrogativo, che in realtà per noi è del tutto pleonastico: volutamente o non volutamente, intenzionalmente o non intenzionalmente, con più o meno grado di consapevolezza e di determinazione il giudice non si può sottrarre a questa logica. .4 Giustizia e gruppi di appartenenza Quindi, inevitabilmente, l’equazione si specifica: scelta politica equivale a scelta applicativa82, e scelta applicativa equivale a scelta politica, perché l’una non potrebbe esistere senza l’altra e viceversa. Ma affermare che la norma giuridica, e alla fin fine, senza voler per forza spaccare il capello in quattro anche il diritto in generale83, è una scelta politica non è solo un dato di fatto, ma è un dato di fatto che si connota dei significati e delle conseguenze più emblematiche e determinanti. Certo, ci rendiamo conto dell’obiezione, peraltro molto forte, che proviene da Habermas quando afferma che «ridurre le norme giuridiche a semplici comandi del legislatore politico equivale a sostenere che, nella modernità, il diritto si risolve integralmente in politica. Sennonché anche il nostro concetto di politica deve
82Pur attraverso passaggi logico-interpretativi assai complessi che non è qui il caso, nè l’occasione, di riproporre e a cui si rimanda in toto. Da ultimo sul punto si veda A. Barak, Judicial discretion, Yale University Press 1989, trad. it. di I. Mattei, La discrezionalità del giudice, Milano, Giuffrè 1995. 83E’ il caso di sottolineare che, per usare le parole di Giulio Chiodi, non va trascurato che nella legge è sempre presente una forte dose di diritto. Cfr. G.M. Chiodi, “Giurisdizione ed equità regolativa”, in Governo dei giudici, cit. pag.43.
83
disgregarsi».84 E ciò perché, secondo l’Autore, in questo modo il potere politico non potrà più essere inteso come autorità giuridicamente legittima, in quanto «un diritto interamente assorbito dalla politica verrebbe a perdere ogni forza legittimante»85; e verrebbe a cadere anche la concezione su cui si fonda il diritto positivo per il quale questo «sarebbe in grado di conservare la propria normatività poggiando sulle sue sole forze, cioè con l’esercizio di una politica giurisprudenziale che è sì sottoposta alla legge, ma che si è nello stesso tempo autonomizzata rispetto alla politica e alla morale »86. Non ci sentiamo di condividere questo tipo di obiezioni perché comunque la norma giuridica, secondo noi, ha una sua propria legittimazione nel momento in cui la norma stessa è stata validamente emanata e quindi è giuridicamente perfetta; è, in sostanza, il procedimento e il sistema stesso che legittima la norma giuridica, e quindi si determina quel meccanismo di autorefenzialità di cui Luhmann è stato l’interprete più prestigioso. Ma la scelta politica si manifesta non solo come scelta applicativa della normazione, per certi versi, e forse anche più vistosamente, si manifesta anche come scelta interpretativa di questa; Carlo Guarnieri ha precisato molto bene questo punto affermando che «il riconoscimento che un certo grado di creatività è connaturato al processo di interpretazione di norme apre la via a riconoscere la discrezionalità dell’attività giudiziaria. Anche se discrezionalità non significa necessariamente arbitrio, resta che il giudice si trova a dover operare scelte fra alternative interpretative. Ma se il giudice può scegliere fra alternative, la sua decisione diviene fonte di
84J. Habermas, Recht und Moral. (Tanner Lectures), 1988, trad.it. di L. Ceppa, Morale, Diritto, Politica, Einaudi Torino 1992, pag.63. 85Ibidem. 86Ibidem.
84
incertezza per chi viene a contatto con lui. Così facendo, il giudice acquista potere, che è potere politico vista la sua posizione e gli effetti delle sue decisioni e che assume particolare rilevanza nel caso di giudici di tribunali, come le corti supreme, in grado, attraverso l’influenza che esercitano su quelli inferiori, di elaborare vere e proprie norme a carattere generale».87 Il punto focale per noi non è certo quello di puntualizzare il ruolo politico della magistratura né mostrare alcun tipo di sentimento, ostile o favorevole, a questo; il punto è molto più increscioso e problematico, ed è quello di verificare il rapporto tra la norma, così qualificata, il giudice e il soggetto che in concreto è investito dalla decisione e dalla norma. Il vero punto di domanda è per noi: che tipo di decisione può scaturire, e in concreto scaturisce, dall’applicazione e dall’interpretazione di una norma che è il prodotto più visibile e palese di una contrattazione socio-politica inegualitaria, condotta fra gruppi socio-politici che misurano rapporti di potere assai differente fra loro, e condotta all’interno di gruppi di potere che gettano sul piano della contrattazione capacità di contrattazione, di resistenza e di forza profondamente squilibrate e disequilibrate rispetto alle altre? In altri termini, che validità reale, e soprattutto nei confronti di chi, può avere, e in concreto ha, una norma, che è frutto di una contrattazione approvata in un luogo, il parlamento, in cui, per usare le parole di Chiodi, «predominano le rappresentanze di interessi o che comunque abbia perduto di rappresentatività politica in senso stretto» e «si trasforma in un organo ratificatore di decisioni prese altrove: l’altrove è la sede effettiva delle contrattazioni della legge»?88
87C. Guarnieri, Magistratura e politica in Italia, cit. pag. 25. 88G. M. Chiodi, “Giurisdizione ed equità regolativa”, cit., pag.38.
85
E ciò per il motivo, chiarito assai bene dallo stesso Autore, che «la norma medesima, proprio laddove regnano la contrattazione e il patteggiamento, si presta a farsi strumento di contrattazione e addirittura di pretesto negoziatorio. Il giudice come voce della legge, allora non è certo più quello immaginato dai suoi sostenitori. Detto in altri termini la politicizzazione (e per molti versi la privatizzazione, che in questo caso tendono a identificarsi) conduce a sollevare delle legittime riserve sul principio veteropositivista, per molti assolutamente e comunque incontrastabile, dell’infallibilità della legge. Il giudice rigorosamente formalistico, anziché organo super partes, diverrebbe indirettamente strumento di parti politiche».89 Se queste sono le premesse, si può ragionevolmente sostenere che le norme di legge, e quindi la giustizia siano effettivamente eguali per tutti, o piuttosto che siano un po' più uguali per taluno e un po’ meno uguali per talaltro? Lo stesso Friedman, pur da posizioni integrazioniste, ammette senza alcun ritegno che «una delle cose che più colpiscono, riguardo ai sistemi giuridici moderni, è lo stacco tra ciò che essi dicono, tra gli ideali che essi professano, e il modo in cui di fatto agiscono. Molte sono le ragioni di questo stacco. Una ragione è che è funzionale agli interessi dei ceti dominanti che il sistema appaia non avere connotati di classe, e appaia giusto e imparziale. Una certa quantità d’ipocrisia è duplicemente utile: il doppio metro di giudizio va a vantaggio di chi occupa le posizioni di vertice, e -allo stesso tempo- occupa la realtà agli occhi del resto della società90» Edgar Friedenberg ha fotografato in maniera esemplare questa situazione affermando che «il diritto è essenzialmente inteso ad
89Ivi, pag.39. 90L.M.Friedman, Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali, cit., pag.314.
86
imporre distorsioni della giustizia alla gente comune, ma senza mai ammetterlo; ai membri più deboli della società non è vietato l’accesso al diritto -ciò potrebbe distruggere il potere di integrazione sociale che ha il mito dell’eguaglianza di fronte alla legge- ma i deboli scoprono che il diritto è molto meno produttivo a loro favore di quanto non lo sia nelle mani dei loro aggressori».91 Ritorna la domanda da cui siamo partiti e che anima per intero questo lavoro: si può forse, allora, sostenere che le norme giuridiche abbiano di fatto una “appartenenza” sociale?, che tutte o, più probabilmente una certa quantità di queste92, “aderiscano” a qualche gruppo sociale più di quanto non “aderiscano” a qualche altro gruppo sociale o a tutti gli altri gruppi sociali? E, in ultima istanza, si può sostenere che esiste una giustizia “per gruppi sociali di appartenenza”? Gli indizi, per rispondere positivamente a queste domande, sono davvero moltissimi e tutti convergenti. A partire già dalla considerazione, più volte sviluppata nel corso di questo lavoro, che la norma giuridica porta in sé impressa l’impronta originaria di un gruppo sociale di appartenenza, ed è, pertanto, essa stessa la prova provata che tra l’uno e l’altra corre un legame profondissimo e vistoso. Vincenzo Tomeo ha descritto molto bene questa situazione affermando che «l’ordinamento è stato costretto ad ammettere questa realtà e a riconoscerne, per aspetti non secondari, la rilevanza giuridica; è stato costretto ad ammettere l’origine extra-legislativa e anzi extra-istituzionale di alcune composizioni di interessi e di contrattazioni tra le parti sociali; è stato costretto a
91E. Z. Friedenberg, “The side effects of the legal process” in The rule of law, a cura di R.P.Wolff, 1971, pag.37. 92Certamente le più “qualificanti” e le più “significative” sotto il profilo economico e sotto quello sociale.
87
riconoscere la presenza di ruoli conflittuali anche nel momento giurisdizionale e rappresentanze di interessi anche all’interno dell’amministrazione; è stato infine costretto a riconoscere l’ingresso degli interessi conflittuali anche nel momento legislativo, nel momento stesso della redazione della legge».93 Ma gli indizi sono davvero tantissimi e non crediamo di doverli esaminare tutti, indizi nascosti non necessariamente in norme di legge, ma assai più di frequente in prassi giudiziarie e in interpretazioni giudiziarie; d’altra parte non sarà molto fine ma sicuramente d’effetto citare il vecchio adagio, non sappiamo quanto in disuso per il quale la legge per gli amici si interpreta, per gli altri si applica. Valga, per tutti, un esempio di queste prassi riferito da Gherardo Colombo, «a Milano prima che la dirigenza della Procura della Repubblica fosse assunta da Francesco Saverio Borrelli, c’è stata per anni una prassi costante, una cultura dominante in tema di reati contro la pubblica amministrazione: in breve il Procuratore della Repubblica, quando veniva a conoscenza di una notizia che poteva in qualche modo configurare un reato, finiva quasi sempre con il chiedere spiegazioni al vertice della gerarchia nell’ambito della quale era stata presentata la notizia, l’esposto, la denuncia. Va da sé che la risposta era sempre una risposta di difesa della struttura, se non di autodifesa».94 L’ultima questione aperta è che cosa debba intendersi per “gruppo sociale di appartenenza” riferito al mondo della giustizia, con questa espressione intendiamo un gruppo sociale omogeneo, o perlomeno quanto più omogeneo possibile, sotto il profilo dello
93V. Tomeo, Il diritto come struttura del conflitto, cit., pag. 84. 94G. Colombo, “Dal giudice interprete del conflitto al giudice interprete della legge”, in Governo dei giudici, cit., pag.89.
88
status sociale e degli interessi a questo connessi, e quindi usiamo il termine non connotandolo di una sua eccessiva tecnicità95. La nostra convinzione più profonda è che il rapporto tra giustizia e gruppi di appartenenza è strettissimo, e che nell’ambito di questo rapporto il concetto di giustizia è elastico: ciò che è reato per talun gruppo non lo è per altri, o ciò che è reato per talun gruppo lo è meno per un altro gruppo, e, più in generale, ciò che è lecito per un gruppo sociale non lo è altrettanto, o in eguale misura, per un altro. E d’altra parte non è certo una novità constatare che si è sempre più disposti a tollerare in capo a noi comportamenti e atteggiamenti giuridici, oltreché sociali, che non siamo disposti a tollerare in capo agli altri, così come si è maggiormente propensi a tollerare questi stessi comportamenti e atteggiamenti in capo al nostro gruppo sociale di appartenenza e meno, molto meno, in capo agli altri gruppi. E’ questa la logica del gruppo di appartenenza anche per quanto riguarda l’applicazione delle norme giuridiche e per quanto riguarda la giustizia in generale: una maggiore indulgenza verso i propri comportamenti, o verso i comportamenti di un determinato gruppo di appartenenza sociale, e un atteggiamento di intolleranza o di intransigenza verso analoghi comportamenti in capo ad altri soggetti o ad altri gruppi di appartenenza. Perché la norma giuridica, cioè la scelta politica per definizione, volente o nolente condiziona il giudice e lo costringe, ove non si voglia affermare che lo induce, a schierarsi pro o contro quel determinato comportamento, e quindi, di fatto, anche pro o contro
95Per questa rimandiamo alle magistrali pagine di W.G. Runcinam, in Relative deprivation and social justice, Routledge & Kegan Paul Ltd, London 1966, trad it. di A. Pichierri, Ineguaglianza e coscienza sociale, Einaudi, Torino 1972. In particolare si veda il Cap.II, “La privazione relativa ed il concetto di gruppo di riferimento”.
89
quel determinato gruppo sociale che di quel comportamento è il referente e l’attore. Indulgenza e intolleranza, si badi, intesi non solo come atteggiamento di pura osservazione sociologica ma come comportamento giudiziario in senso stretto, cioè come decisione giudiziaria vera e propria. Oggi, ma si può affermare che si tratta di un oggi ormai remoto, la giustizia riguarda prevalentemente “fenomeni” più che “fatti”, cioè “fatti collettivi” piuttosto che “fatti singoli”, perché si crede, e non senza ragione a nostro avviso, che sono i primi che destano maggiore allarme sociale che è la vera molla giudiziaria delle società complesse, sia per quanto riguarda il campo penale che quello civile, e i “fenomeni” e i “fatti collettivi” riguardano ovviamente gruppi sociali. Ed è altresì evidente che a maggiore omogeneità di comportamenti corrisponde maggiore omogeneità nel gruppo sociale cui questo tipo di comportamento è riferibile o imputabile. Colui che è chiamato a decidere questi comportamenti deve operare ancora una volta una scelta, e questa volta una scelta più ancora politica dell’altra, se possibile, deve, cioè schierarsi, o verso la soluzione della tolleranza o verso quella dell’intransigenza: in ogni caso deve compiere e operare una scelta di campo, oltreché una scelta interpretativa e applicativa. D’altra parte non è il caso di ripetere che la norma giuridica, cioè la norma contrattata, è lo specchio fedele degli interessi economici e sociali che sono stati all’origine della norma stessa, attraverso quel procedimento conflittuale di selezione, decisione e ratificazione che è il meccanismo parlamentare, e che quindi la norma stessa aderisce a questi gruppi sociali, che di questi interessi sono espressione, come un abito. Per il passato si è assistito in taluni casi, anche assai diffusi, a una scelta di campo verso la tolleranza e questo ha contribuito a
90
ingenerare un forte senso di impunità in determinati gruppi sociali e politici e solo in taluni di questi, con gli esiti che sono stati sotto gli occhi di tutti. Si è, in sostanza, ribadita oltre ogni limite, l’idea ma anche la prassi di una giustizia non solo inegualitaria ma anche “ingiusta”96, o quantomeno di una giustizia più giusta per taluni e meno giusta per talaltri. Ma lo spartiacque tra la tolleranza e l’intransigenza è assai sottile e così anche lo spartiacque tra diverse forme di inegualitarismo giudiziario: optare per l’intransigenza o la tolleranza verso tutti e per forme più universali di egualitarismo giudiziario è una delle sfide, tra le più difficili, che ci propongono gli anni a venire.
96Senza con questo voler entrare in alcun modo all’interno del noto e travagliato
91
Studio n. 3
Maometto, il Naufrago e il Lupo:
per una giustizia da teatro
.1 Una premessa La giustizia è una cosa reale! Una cosa terribilmente reale. Perché allora titolare questo studio “Maometto, il Naufrago e il Lupo: per una giustizia da teatro”?. Che, forse, il teatro non è una cosa reale? Che forse il teatro è pura
dibattito filosofico-giuridico sulla “giustezza” della giustizia.
92
fantasia, accostabile alla realtà, e quindi verosimile, ma rappresentazione della realtà filtrata attraverso le parole, a più voci, di un unico soggetto, lo scrittore? Nient’affatto! Tra il teatro e la giustizia corre un nesso strettissimo. Anche iconograficamente e scenograficamente sia la giustizia che il teatro si manifestano allo stesso modo, con rappresentazioni e con celebrazioni. Da questo punto di vista l’accostamento è perfetto: si celebra il processo come si celebra la commedia, si rappresenta una realtà giudiziale come si rappresenta una realtà teatrale. Ma non solo iconograficamente il rapporto tra giustizia e teatro è strettissimo, anche sotto quello degli interpreti il rapporto è assolutamente assimilabile e più ancora sotto quello delle situazioni: la ricostruzione della realtà, in tutte le sue innumerevoli forme -ricostruzione vera e propria, esperimento, ricognizione, ecc.- è del tutto simile sulla scena giudiziaria e su quella teatrale: l’azione, in fondo, non è nient’altro che lo sviluppo della realtà che si rappresenta -giudizialmente o teatralmente-; è, in sostanza, l’intreccio, o meglio l’estrinsecazione dell’intreccio, o, come afferma Aristotele, l’intreccio è «imitazione dell’azione», dove per intreccio l’Autore intende la «composizione dei fatti». Soprattutto importante è -dichiara Aristotele- la composizione dei fatti. Perché la tragedia -afferma ancora l’Autore- non è imitazione di uomini, bensì di azione e di vita, e la vita si risolve in azione e il suo fine è una specie di azione, non una qualità. .... L’unità dell’intreccio non consiste come alcuni credono nel fatto che essa si aggiri intorno ad un unico personaggio. Molti, anzi innumerevoli, casi possono capitare a una persona senza che tuttavia alcuno di essi sia tale da costituire unità.97
97Aristotele, Sulla poetica, trad it. di F. Albeggiani, Nuova Italia, Firenze 1934.
93
Se “l’intreccio”98 è composizione o sintesi di fatti, così come afferma Aristotele, in cosa differisce la rappresentazione teatrale dalla rappresentazione giudiziaria? Entrambe presentano indiscutibilmente le medesime caratteristiche di rappresentazione, composizione e sintesi di fatti, ma non solo, presentano anche l’osservazione di fatti, la ricostruzione di fatti e il giudizio di fatti e su fatti. E nei fatti si stagliano in primo piano gli uomini, singoli uomini in carne ed ossa, come ha affermato Vincenzo Tomeo. Uomini veri, in “carne ed ossa” compaiono sul palcoscenico giudiziario, uomini concreti con i loro drammi e le loro realtà specifiche, imparagonabili e incomparabili, singole ed uniche, non semplici situazioni ricorrenti e generiche sovrapponibili le une alle altre per un mero gioco di norme giuridiche: l’universalità e la genericità del diritto. Sul palcoscenico giudiziario scendono in campo uomini e situazioni ineguagliabili. E uomini veri, anche in “carne ed ossa”, compaiono sul palcoscenico teatrale. Il dramma, come afferma Peter Szondi, «non è scritto è “posto”. Le parole dette nel dramma sono tutte “decisioni”; sono sviluppi della situazione e rimangono in essa; in nessun caso devono essere concepite come emananti direttamente dall’autore. ... Lo stesso carattere di assolutezza dimostra il dramma nel suo rapporto allo spettatore. Come la battuta drammatica non è espressione diretta dell’autore, così essa non è allocuzione al pubblico. ... L’assolutezza del dramma si può formulare anche sotto un altro aspetto: il dramma è primario. Non è la rappresentazione (secondaria) di qualcosa (di primario); ma rappresenta se stesso, è
98Sul punto si veda diffusamente Francis Fergusson, The idea of theatre, Princeton University Press, Princeton 1949, trad.it. di Raul Soderini, Idea di un teatro, Feltrinelli, Milano 1962.
94
se stesso. L’azione drammatica, come ognuna delle battute che la compongono, è “originaria”; si realizza nell’atto stesso in cui si manifesta. .... Dal carattere di assolutezza del dramma deriva anche l’esigenza di non lasciare alcun posto al caso e di dare sempre una motivazione. L’elemento casuale penetra nel dramma dall’esterno; ma in quanto viene motivato acquista un fondamento, affonda, cioè, le sue radici nel terreno del dramma stesso»99. Il dramma, è dunque realtà assoluta in tutte le sue manifestazioni. Teatrali, giudiziarie ed umane in generale. «E dunque cos’è questo dialogo che chiamiamo dramma? si chiede Silvio D’Amico. Anche la parola dramma vien dal greco (drao, opero, agisco) -risponde l’Autore- e continua tutt’ora, come presso gli antichi, ad adoperarsi per designare, in senso ampio, qualunque forma letteraria destinata, in pratica o nell’intenzione, alla rappresentazione scenica: sono drammi genericamente parlando la tragedia e la commedia, la sacra rappresentazione e la farsa, la parade e il suinete, la moralitè e il vaudeville. Ma conviene aggiungere che, nell’infinita varietà di queste forme drammatiche, un carattere comune permane al fondo di tutte: quello di rappresentare, comunque, un conflitto. ... Sarà un conflitto spirituale fra più eroi che s’urtano perché viventi ciascuno nella propria, irriducibile, legge (è stato detto che il vero dramma è quello in cui “tutti hanno ragione”; o si tratterà di un eroe combattuto da forze che lo avversano dall’esterno. Oppure sarà un urto tutto “esteriore”, materiale e grossolano. ... Ma un conflitto, un contrasto, è sempre al centro dell’opera. ... L’idea del dramma e quella del conflitto, sono di regola, così associate che noi parliamo di “drammaticità” anche per opere letterarie non destinate alla
99P. Szondi, Theorie des modernen dramas, Suhrkam Verlag, Frankfurt am Main 1956, trad. it. Teoria del dramma moderno, Einaudi, Torino 1962, 3 ̂ed. P.B.E. 1979, pp. 10-13.
95
scena o addirittura per opere d’altre arti. Ma, in senso tecnico, chiamiamo dramma quello in cui la rappresentazione letteraria del conflitto è fatta in una vera e propria forma scenica: in quella forma, cioè, da cui il poeta materialmente sparisce, per lasciare soli, col solo mezzo dell’espressione dialogica, i suoi personaggi a parlare e ad agire. ... Sicché il dramma si potrebbe definire: la rappresentazione scenica di un conflitto».100 Noi, da posizioni scientifiche conflittualistiche, non possiamo che condividere le parole di D’Amico: il dramma, in tutte le sue espressioni, è conflitto, e conflitto per eccellenza è la rappresentazione della giustizia, cioè la sua celebrazione processuale. Nulla più della giustizia è conflitto! Come nulla più del dramma è conflitto. Sotto questo specifico aspetto, ancor più che sotto tutti gli altri aspetti, il nesso tra la giustizia e il teatro è strettissimo. Vincenzo Tomeo ha ricordato in maniera incisiva questo concetto nel suo celebre volume Il giudice sullo schermo: «il processo è una rappresentazione drammatica: ruoli, personaggi, battute, risposte, sono elementi talora così plastici ed evidenti da costituire le parti di un dramma non scritto né immaginato ma reale. Non può quindi sorprendere che il processo e le principale figura che vi inerisce, il giudice, siano divenuti non poche volte argomenti di opere letterarie. Spesso anzi la sostanza drammatica del processo e del suo principale personaggio è lo spunto e la materia di opere altamente espressive di una condizione sociale o addirittura della condizione umana: si pensi al Processo di Kafka, dove non a caso la tecnica e la vicenda del processo indiziario sono assunti a
100S. D’Amico, Storia del teatro drammatico, 2 voll., Garzanti, Milano 1960, pp.10-12.
96
rappresentazione dello stato e della situazione dell’uomo contemporaneo»101. Ferruccio Pergolesi, autore di uno splendido e suggestivo volume su Diritto e Giustizia nella letteratura moderna narrativa e teatrale del 1949 ma ancor oggi di grande attualità e godibilissimo alla lettura, ha affermato che «ogni processo include un dramma, rifrangendosi su tutti coloro che in qualche modo, ne sono parti. Ciò appare ovvio quando si tratta di un processo penale, ma è esatto pure per il processo civile, salvo le proporzioni, a seconda dei diritti che sono sub judice. Quando si tratta di una controversia civile, il dramma è tutto chiuso nel fascicolo di causa pronto a rivelarsi nella sala di udienza. Le famose caratteristiche che si sono da gran tempo invocate pel processo civile, e che in parte sono attuate col nuovo codice di rito, la concentrazione e l’oralità, sembrano fatte apposta per dare al processo l’innervatura e la pubblicità del dramma. Il processo civile quando ha per obbietto il diritto di famiglia, non è che la riproduzione di una tragedia d’anime, sia che il figlio cerchi il suo genitore o che questi disconosca il nato della sua donna. Ma anche quando si tratta di una contesa patrimoniale, quante volte questa rappresenta la catastrofe morale o materiale di intere famiglie e intorno al fatto materiale si osserva un’incrostazione di sentimenti di odio, di pietà, di vendetta e un’ansia di anime e un dolorare di spiriti».102 Dramma e giustizia, giustizia e dramma: l’accostamento è perfetto! Talmente perfetto che in letteratura la rappresentazione della giustizia è tra tutte le rappresentazioni certamente tra le più diffuse. Noi non vogliamo occuparci in questo saggio delle rappresentazioni apportate dalla letteratura romanzesca né da altre forme
101V. Tomeo, Il giudice sullo schermo, Laterza, Roma-Bari 1973, pag.3. 102F. Pergolesi, Diritto e Giustizia nella letteratura moderna narrativa e teatrale, Zuffi Editore, Bologna 1949, pag.111.
97
rappresentative quali la musica o la filmologia, desideriamo occuparci esclusivamente di rappresentazione teatrale, in primo luogo per un deciso gusto personale e in secondo luogo perché crediamo fermamente che di tutte le rappresentazioni possibili quella teatrale sia la più “vera”, la più diretta proprio perché, per quanto abbiamo detto fin’ora, giustizia e dramma si equivalgono sulla scena dell’azione, del sentimento, della rappresentazione, della suggestione, delle emozioni. Della vastissima letteratura teatrale che si è occupata di rappresentazione della giustizia abbiamo creduto opportuno selezionare due voci altissime: Friedrich Dürrenmatt e Slawomir Mrozek. Due voci apparentemente molto distanti tra loro, assai noto, per quanto in una nicchia intellettuale di lettori, il drammaturgo svizzero-tedesco, assai meno noto, almeno nel nostro paese, l’autore polacco103. Voci, dicevo, apparentemente distanti fra loro e forse anche realmente distanti, certamente diverse e diversissime fra loro. Due modi diversi di vedere” il dramma e soprattutto due modi diversi di “costruire” il dramma. Dürrenmatt è un grande costruttore di situazioni, Mrozek un grande costrutttore di sensazioni ma corre tra questi due autori un filo rosso che li collega intimamente, pur nella evidente e totale diversità: è questo filo rosso che ci ha indotto ad accostarli e farne oggetto del presente studio.
103Più noto è Mrozek in Inghilterra e soprattutto in Francia. In Francia è stata pubblicata l’opera completa dell’Autore presso le Éditions Albin Michel (2 voll.), Paris 1969. In Italia sono stati tradotti parecchi lavori di Mrozek, prevalentemente per i tipi delle Edizioni Lerici.
98
Un filo rosso che non vogliamo anticipare ma che intendiamo dipanare mano a mano che ci addentriamo nell’analisi e nelle osservazioni. .2 Il giudice e i giudici I mondi di Dürrenmatt e di Mrozek sono popolati di giustizia e di giudici, più di giustizia, in realtà, che di giudici. Molto di più il mondo di Dürrenmatt che quello di Mrozek, ma di questo Autore una pièce in particolare, In alto mare, è tutta incentrata sul rapporto tra giustizia, giudici e “vittime”, ed è questa che abbiamo scelto per la nostra analisi. Giustizia e giudici che, come vedremo, in Mrozek sono “particolari”, apparentemente meno “professionisti” di quelli di Dürrenmatt ma non per questo meno professionali, anzi assolutamente professionali, e per molti versi anzi più “professionali” che in Dürrenmatt. Giustizia e giudici, per l’Autore polacco, che si sarebbe tentati di definire allegorici e metaforici, ma è un pensiero da allontanare immediatamente perché lo stesso Autore sgombra il campo da qualsiasi tentazione: «queste pièces non contengono nient’altro all’infuori di quello che contengono, nel senso che non sono un’allusione a qualcosa di particolare e neanche una metafora, per cui non bisogna cercare di decifrarle. Il ruolo principale deve esservi sostenuto dal testo spoglio, presentando nel modo più preciso possibile, e col senso logico delle battute e delle scene posto in maniera ben chiara. [ .....] L’affermazione che queste pièces non sono una metafora, ma solo ciò che sono, nella loro durata scenica limitata nello spazio e nel tempo, porta con sé alcune
99
conseguenze. Non si può aggiungere alcuna “trovata” scenografica, né per gusto umoristico né per decorazione scenica. Non occorre “sottolineare” nulla, e con eguale cautela bisognerà procedere nei confronti dell’ “atmosfera”. Bisogna anche evitare di aggiungere anche delle azioni sceniche eccessivamente ampliate. In una parola, non bisogna fare nulla che si allontani da una rappresentazione estremamente “trasparente”, un po' rigida e statica, pulita e “sotto sotto”.. Una triste esperienza ci insegna che ogni tentativo di “sottolineare” e di “interpretare” e di caricare esageratamente i testi dell’autore di queste piccole pièces sono risultati dei fiaschi dal punto di vista artistico. Non si tratta neppure, Dio ce ne guardi, di commedie, nel senso che non bisogna accentuarne i lati comici. Se vi sono delle battute umoristiche, esse lo sono nel senso che non vanno pronunciate col tono di chi premetta “attenzione, adesso dico una spiritosaggine”. In caso contrario, ne verrebbe fuori qualcosa di mancato, di poco elegante, se non addirittura di cattivo gusto. Non sono neanche, e non lo sono affatto, delle pièces “moderne” o “sperimentali”. Mi pare che non occorra dilungarsi ulteriormente su ciò che si intende con tali definizioni. Mi rendo conto che questi postulati possono attrarmi l’obiezione di non sapere che cosa sia la teatralità. Non è di questo che si tratta, e può anche darsi che io non sappia che cosa sia la teatralità, o che addirittura non la senta affatto. Sono invece convinto, e so con certezza, che certi elementi della cosiddetta “teatralità”, del pensiero teatrale, si sono banalizzati, appiattiti, diventando dei feticci fine a se stessi ed entrando in un certo senso a far parte dell’arsenale del pensiero senza pensiero, del pensiero automatico. Tra l’altro anche l’interpretazione delle pièces come “metafore” creatrici e nuove, può trasformarsi a sua volta in uno schema mentale (tanto più che queste pièces sembrano addirittura invitare o, come suol dirsi, facilitarsi le cose proprio mediante
100
l’applicazione di schemi, quali “metafora”, “commedia”, “modernità” e via dicendo). Pur sapendo, dunque, ciò che queste pièces non sono, non so che cosa esse siano, ma questo non fa parte dei miei doveri. Questo, ormai, è il teatro che deve saperlo. Supporre che i postulati da me esposti possano limitare il regista e non lasciargli più niente, significherebbe non avere un vero rispetto per il teatro, accusarlo di povertà e ristrettezza».104 Nulla di allegorico e nulla di metaforico dunque, come nulla di allegorico e di metaforico è presente in Dürrenmatt, come nota uno dei suoi critici italiani più attenti, Italo Alighiero Chiusano, «si ricordi, poi, la tendenza, così spesso manifestata, di “far grande”. Non che Dürrenmatt tenda al gigantismo e meno che mai all’eroico: chi conosce la sua costante vena eroica e spesso demolitoria, il suo connaturato sgonfiamento di ogni retorica non potrà intendere la nostra espressione in questo senso. Quello che voglio dire è che Dürrenmatt, come giustamente osserva una sua ottima studiosa, Elisabeth Brock-Sulzer, è quanto di più lontano ci sia da un autore “privato”: e anche il più lontano, aggiungiamo noi, da uno scrittore pubblico, nel senso di comiziante, ideologico, massificato e massificante. Il “far grande” di Dürrenmatt consiste nella sua tendenza alla parabola esemplare nè questa parabola, come fa ad esempio Pirandello, parte per il regno delle grandi verità etico-metafisiche, allargandosi a imbuto da una esemplificazione ultraprivata il cui luogo di sperimentazione può essere un salotto, un tinello un’aia, al massimo il palcoscenico di un teatro.
104S. Mrozek, Na pelnym morzu. Karol. Strip-tease, trad. it. di A.M. Raffo, In alto mare. Karol. Strip-tease, Lerici, Milano 1962, Osservazioni per un’evetuale messa in scena.
101
Dürrenmatt arriva alla vasta scala, ma già partendo dalla vasta scala».105 E lo stesso Dürrenmatt in un suo splendido volume di riflessione sulla letteratura, teatro e cinema, spiega come egli dà vita al suo mondo al di fuori di ogni costruzione “immaginifica”: «ma in che modo può lo scrittore dar forma al mondo, in che modo dargli un volto? Impegnandosi risolutamente in qualcosa che non sia una filosofia, d’altronde oramai probabilmente impossibile. Buttando al vento, risolutamente “la profondità di pensiero”, facendo del mondo la sua materia prima. Il mondo è la cava dove lo scrittore ritaglia i blocchi per il suo edificio. Egli non riproduce, ma ricrea il mondo, costruisce mondi propri che daranno un’immagine del mondo attuale, dal momento che i materiali di costruzione provengono dal presente. E che cos’è questo mondo proprio? Un caso limite è costituito dai viaggi di Gulliver, in cui tutto è inventato, tutto contribuisce a formare, per così dire, un mondo a dimensioni fino a quel momento sconosciute. Ma la logica intrinseca, immanente, che anima il tutto ne fa un’immagine del nostro mondo. Un mondo originale che sia logico non può staccarsi dal nostro mondo. Il segreto è questo: la concordanza tra arte e mondo. Non possiamo che lavorare sul soggetto: non ci vuole altro. Se è coerente il soggetto, lo sarà anche l’opera. [ ...] Lo scrittore deve diventare un lavoratore. Chi scrive non deve ingabbiare i suoi soggetti in una drammaturgia: deve dare a ogni soggetto la drammaturgia di cui ha bisogno. In tedesco si dice sich ein Bild machen (lett. farsi un’immagine) e im Bilde sein (lett. essere informato, sapere di che si tratta). Non riusciremo a capire mai niente del mondo se non ce ne facciamo un’immagine. E questo farsi un’immagine è un atto creativo che si può compiere in
105F. Dürrenmatt, Radiodrammi, Einaudi, Torino 1981, Introduzione di Italo Alighiero Chiusano pp. VII-VIII.
102
due modi: riflettendo -e in tal caso sarà giocoforza imboccare le vie della scienza- o ricreando, vedendo, cioè, il mondo attraverso l’immaginazione. Che senso abbiano questi due atteggiamenti -o meglio queste due attività- non sta a me giudicare. Al pensiero si rivela la causalità, alla visione la libertà che muove tutte le cose. Nella scienza si manifesta l’unità, nell’arte la molteplicità dell’enigma che chiamiamo mondo. Tra vedere e pensare corre una strana linea di demarcazione, oggigiorno. Il solo modo di superare il conflitto è viverlo. L’arte, la letteratura, sono come qualunque altra cosa, un confronto col mondo. Una volta afferrato questo, ne potremo intravedere anche il senso».106 E lo stesso Autore precisa in maniera incisiva più volte questo concetto affermando che «non sarebbe, quindi, una filosofia a produrre un’opera teatrale, ma un’opera teatrale a produrre una filosofia. Da una filosofia partorita in modo tanto insolito ci sarebbe da aspettarsi tutte le magagne di un aborto del pensiero. Sarebbe una filosofia soggettiva, addirittura contraddittoria, mentre persino da una tesi di laurea si pretende, non dico la verità oggettiva, ma almeno una certa coerenza interna, l’assenza cioè di incongruenze. Che un filosofo scriva una commedia per spiegare la sua filosofia, passi, ma che si scriva una commedia per ricavarne una filosofia, e per di più una filosofia che giova unicamente all’autore del misfatto, è follia pura: se a imbarcarsi in una simile avventura è un commediografo, la cosa è forse meno imperdonabile, ma non più comprensibile. [ ...] In altre parole: fuori dalla dimensione temporale, l’io diventa una finzione. L’io autore di un testo e l’io che ha riflettuto a partire da quel testo è uno, eppure diviso: non per una questione di tempi, come sarebbe
106F. Dürrenmatt, Theater-Schirften und Reden, Drammaturgisches und Kritisches, Der Mitmacher, 1966-1972-1976, trad. it. Lo scrittore nel tempo, Einaudi, Torino 1982, pp.14-15.
103
facile pensare, ma a causa della necessità mentale di sdoppiarsi: in un io che scrive e un io che riflette su quello che ha scritto. Lo stesso vale per l’individuo; tratto fuori dal tempo, è una finzione. Certo, io e individuo esistono solo nell’istante; ma se si rappresenta quest’istante come un punto sulla linea del tempo, si espelle l’io dal tempo facendone una finzione: in tutto idonea alla letteratura. Se l’io è concepibile solo come finzione, esso è senza dubbio una nostra invenzione, e delle più straordinarie; ma a questo punto vien da chiedersi giustamente chi diavolo sia dopotutto a scrivere. Per essere sincero, posso rispondere soltanto che questa domanda è il mio masso di Sisifo. Appena mi accingo a dare una risposta, appena sento di avere in mano, e sulle labbra, la verità, essa mi sfugge, proprio come il masso a quel disgraziato, risprofondando nell’abisso. Perché l’io non fittizio, non immaginario, non letterario, l’io vero, quello appunto che sta scrivendo -anche se chiamarlo vero è privo di senso, non essendoci una verità da descrivere- questo io esiste nella durata, immerso nel tempo (ma anche questo evidentemente è una finzione), al di là di ogni concetto, di ogni pensiero, non pensabile, poiché da esso emana il pensiero, non rappresentabile, poiché da esso ha origine ogni rappresentazione, di conseguenza insondabile».107 E in un’altro passo dello stesso volume di Dürrenmatt, in una nota alla Visita della vecchia signora, l’Autore ribadisce in modo netto questo suo pensiero: «io descrivo uomini, non marionette; un’azione non un’allegoria; costruisco un mondo, non una morale, come qualcuno ha insinuato»108 Nessuna “finzione, dunque nelle rappresentazioni di Dürrenmatt e di Mrozek se non proprio la finzione della rappresentazione stessa, pura fantasia ma costruita con i “blocchi” della realtà più autentica.
107Ibidem, pp.154-156. 108Ibidem, pag.71.
104
E in questa “fantasia della realtà”, e, ci permettiamo di aggiungere, in questa realtà della fantasia i giudici di Dürrenmatt e di Mrozek si somigliano in maniera impressionante, così come pure si assomigliano le vittime, così come pure si somigliano (certo non in modo fisico) i luoghi della decisione. Si somigliano in modo impressionante anche se in un caso, quello di Dürrenmatt, si tratta di giudici “quasi” veri nell’altro di giudici che le circostanze fanno diventare “veri”. Anche le situazioni sono straordinariamente, impressionantemente, identiche una panne in un caso un naufragio nell’altro: due circostanze sfortunatamente fortuite, comunque non volute, non cercate, non desiderate. Casuali! Casuali ma possibili, al punto che Dürrenmatt sente la necessità di giustificarle in una lunga premessa. «Ci sono ancora delle storie possibili -si chiede l’Autore- storie per scrittori? [ ...] Dentro questo mondo della panne ci porta la nostra strada, al cui margine polveroso, accanto ai cartelloni pubblicitari di scarpe Bally, di Studebaker, di gelati, accanto alle lapidi in memoria delle vittime del traffico, s’intravedono ancora delle storie possibili, nel senso che il volto di un uomo qualunque sembra il volto di tutta l’umanità, una semplice sfortuna diventa involontariamente un fatto universale, si scorgono dei giudici, una giustizia, forse anche la grazia, che fa la sua apparizione per caso, riflessa nel monologo di un ubriaco».109 Una panne, un guasto meccanico, in un caso, un naufragio nell’altro: situazioni certamente possibili e sicuramente “ancora” possibili.
109F. Dürrenmatt, Die Panne. Eine noch mögliche Geschichte 1956, trad. it. di Eugenio Bernardi, La Panne, Einaudi Torino 1972, pp.9-12.
105
E in queste situazioni certamente possibili e certamente “ancora” possibili si muovono personaggi certamente possibili e certamente “ancora” possibili: quasi sempre giudici professionisti (seppure in pensione, com’è nel caso de La panne, giudici che si improvvisano tali, com’è nel caso di In alto mare). Raccontiamo, seppur succintamente, le due storie. La prima è proposta da Dürrenmatt Un incidente di automobile, anche se di lieve entità, costringe Alfredo Traps, rappresentante di articoli tessili a fermarsi ed essendo sera inoltrata a cercare un alloggio per la notte, intravede una grande villa illuminata e si avvia chiedendo ospitalità al padrone, che gliela accorda molto volentieri, e lo informa che tra poco arriveranno degli amici per una serata fra uomini. Ad uno ad uno arrivano gli amici, tutti avanti negli anni, e la cena, sontuosa, ha inizio. Il padrone di casa informa il signor Traps che se gradisce potrà partecipare al loro “gioco”, forse un po' strano lo avverte l’ospite, che consiste nel tornare ad esercitare per giuoco le rispettive professioni di un tempo. «Ebbene, precisò il padrone di casa, io un tempo ero giudice, il signor Zorn pubblico ministero ed il signor Kummer avvocato, e così giochiamo al tribunale. [ ...] Generalmente, spiegò, in tono bonario, si rifacevano i famosi processi storici, il processo di Socrate, il processo di Gesù, il processo di Giovanna d’Arco, il processo Dreyfus, recentemente l’incendio del Reichstag e una volta avevano dichiarato irresponsabile Federico di Prussia. Ma naturalmente, spiegò poi, il giuoco diventa più bello se si giocava con del materiale vivente, il che aveva portato molto spesso a situazioni particolarmente interessanti; proprio due giorni prima un parlamentare che aveva tenuto in paese un discorso elettorale ed aveva perduto l’ultimo treno, era stato condannato a quattordici anni di carcere per ricatto e
106
corruzione»110. Il “giuoco” del suo processo consiste nell’accusarlo di omicidio del suo capo per subentrargli nell’incarico di rappresentante, nonostante che Traps si profonda in ripetute confessioni di innocenza. Ma il suo stesso avvocato difensore lo incalza immediatamente: «si metta bene in testa, giovanotto, innocente o no, è una questione di tattica! E’ da pazzi, a dir poco, voler essere innocenti davanti al nostro tribunale, è molto più intelligente incolparsi subito di un reato, per esempio di un reato particolarmente vantaggioso per i commercianti: di frode. Già durante l’interrogatorio poi può risultare che l’imputato esagera, che non ha commesso una vera e propria frode, ma ha ritoccato soltanto alcuni dati, a scopo di propaganda, come succede spesso in commercio. La via dalla colpa all’innocenza è sì difficile, ma non impossibile, mentre è un’impresa addirittura disperata voler conservare la propria innocenza ed il risultato non può che essere disastroso. Lei vuole perdere dove invece potrebbe averla vinta. Più tardi sarà costretto non a scegliersi una colpa ma a lasciarsela attribuire»111. E Traps aveva finito per attribuirselo quel delitto, seppure per “gioco”. Finalmente, dopo le requisitorie e le arringhe di rito si arriva alla sentenza, che è una sentenza di morte, fondata solo sul fatto che l’imputato si fosse dichiarato colpevole. Il giudice ne era pienamente soddisfatto, «era per lui un piacere aver emesso una sentenza che l’imputato riconosceva totalmente, la dignità dell’uomo non tollerava grazia alcuna, perciò l’egregio commensale gradiva il coronamento del suo omicidio che, come sperava, era avvenuto in circostanze non meno piacevoli del delitto stesso. Ciò che nell’uomo borghese, nell’uomo medio appariva come un caso, in seguito a un incidente, o come semplice necessità di natura, come una malattia, come un’occlusione di un vaso
110Ibidem, pag.19. 111Ibidem, pag.23.
107
sanguigno a causa di un embolo, come un’escrescenza maligna, si presentava qui come un necessario risultato di natura morale, qui finalmente la vita si compiva in tutta la sua perfezione e la coerenza di un’opera d’arte, qui si vedeva la tragedia dell’uomo, qui essa splendeva in tutta la sua luce, prendeva una forma immacolata, giungeva alla perfezione, anzi si poteva tranquillamente dire: solo all’atto dell’emissione della sentenza che faceva dell’imputato un condannato, la giustizia celebra il suo trionfo, perché non vi era nulla di più alto, di più nobile, di più grande del momento in cui un uomo viene condannato a morte». Una sentenza emessa in nome di «una giustizia grottesca e strampalata, una giustizia in pensione, ma anche così era pur sempre la Giustizia»112. Traps era entusiasta e nello stesso tempo stanco, chiese di essere portato nella sua stanza, gli altri pigolando e gracchiando avevano riempito di scarabocchi una pergamena e con la condanna a morte e si diressero a depositarla sul letto del rappresentante generale. Finalmente tutti furono dietro la porta di Traps. «Il giudice aprì e tutto il solenne gruppo si fermò allibito sulla soglia: nel vano della finestra era appeso Traps, una silhouette nera contro l’argento opaco del cielo, in un forte odore di rose, tanto definitivamente e irrimediabilmente che il pubblico ministero, nel cui monocolo si specchiava sempre più splendente il mattino, dovette pigliar fiato prima di esclamare addolorato e rattristato per la perdita dell’amico: Alfredo, mio caro Alfredo! Ma che cosa ti sei messo in testa, santo cielo? Ci rovini la più bella serata della nostra vita!»113. Giustizia è fatta! La sentenza è stata eseguita! La seconda storia è proposta da Mrozek. La scena si svolge su una zattera in alto mare, i personaggi sono rappresentati da tre naufraghi vestiti con un elegante abito scuro e
112Ibidem, pp.66-67. 113Ibidem, pp.69-70.
108
camicia bianca; cravatte annodate con gusto, fazzoletti bianchi nei taschini delle giacche. Tre naufraghi con diverse dimensioni, uno grosso, uno medio, uno piccolo. I tre naufraghi sono ridotti alla fame essendosi esaurite le provviste. Il naufrago grosso propone che non potendo mangiare qualcosa bisogna mangiare qualcuno, qualcuno di loro. Il problema consiste solamente, si fa per dire, nell’individuare chi dei tre mangiare. Le proposte fioccano e provengono tutte dal naufrago grosso, si procederà con un sorteggio, ma la proposta viene respinta. Il grosso propone, allora, una regolare elezione, con dei regolari comizi. Si appronta un palchetto e ciascuno dei naufraghi procede ad illustrare le proprie ragioni, per le quali non è opportuno che sia proprio lui ad essere sacrificato. Si capisce immediatamente che tra il naufrago grosso e quello medio corre un’intesa sotterranea ma forte. Si procede quindi alla votazione, ma questa deve essere annullata perché nel cappello che funge da urna sono stati trovati quattro biglietti anziché tre. E d’altra parte, nota il piccolo, il parlamentarismo è un sistema antiquato. La proposta del medio è quella di ricorrere alla nomina diretta del candidato, di cui, ovviamente il grosso, si incarica volentieri, ottenendo l’opposizione del piccolo. A questo punto la situazione è a un punto morto, il naufrago grosso e quello medio si dichiarano molto delusi dal piccolo che non vuole accettare una soluzione di questo genere e gli chiedono di proporne un’altra. « Piccolo Una soluzione? Ma si figuri! Fin da bambino ho sempre sognato la giustizia universale. Io non chiedo altro che la giustizia! Grosso Come può essere certo che la giustizia non si rivolga contro di lei, cioè, volevo dire, per lei, che non decida la sua candidatura?
109
Piccolo E’ semplicissimo. Fin da piccolo sono stato sfortunato, non mi è andato mai nulla per il verso giusto. Le circostanze sono sempre state contro di me, dunque ... Grosso E’ strano che siano soprattutto gli insoddisfatti a lamentare la mancanza di una giustizia totale e universale. Non sarà per il fatto che reclamando giustizia cercano una giustificazione per il proprio insuccesso? Piccolo Io non mi tiro indietro. Accetto qualunque risoluzione purché sia giusta. Grosso Ovverosia a condizione che non sia lei ad essere mangiato. Piccolo Queste sono insinuazioni. Facciamo prima le cose con giustizia. Il naufrago grosso e quello medio fanno presente di essere orfani, mentre il piccolo non lo è. Grosso Mi sembra che la questione sia molto semplice dal punto di vista della giustizia. Potrebbe lei a cuor leggero far del male ad un orfano? Persino tra i selvaggi l’essere orfano viene considerata la più grave delle disgrazie. No, caro signore. Se uno qualunque di noi due, che siamo orfani, venisse mangiato, sarebbe un insulto fatto alla giustizia più elementare. Come se non bastasse che siamo orfani, lei vorrebbe anche mangiarci. Il naufrago piccolo tenta di giustificarsi sostenendo che non è detto che orfano non lo sia lui stesso. Ad un tratto dalle onde emerge un postino in divisa e berretto che recapita un telegramma al naufrago piccolo in cui gli viene annunciata la morte della madre. La situazione torna allo stallo. Ma il naufrago grosso non s’arrende : «lei dimentica che esiste un’altra giustizia. La giustizia storica» E il solo fatto di essere tutti orfani non è significativo, resta un’altra questione da esaminare: chi erano i rispettivi genitori.
110
Il padre del naufrago piccolo era cancelliere di tribunale, mentre, a suo dire, il padre del grosso era un analfabeta taglialegna, mentre il padre del medio era addirittura sconosciuto; quindi anche su questo il naufrago piccolo ha poco da dire se non che gli dispiaceva ma che comunque non aveva alcuna colpa di ciò. Mentre sono intenti in questa discussione ai bordi della zattera si avvicina un vecchio maggiordomo che rivolto al naufrago grosso così lo apostrofa: «non mi riconosce signor conte? Il signor conte non riconosce il suo vecchio Giovanni. E sì che ero io che insegnavo al signor conte a cavalcare sul poney, quando il signor conte era ancora signorino». Il naufrago grosso ordina al maggiordomo di sparire e di affogare. Riprende la discussione, il piccolo tenta di giustificarsi ma gli altri due lo mettono a tacere. Dopo un’ulteriore resistenza il piccolo si convince che deve essere proprio lui la vittima: sono stato io a prendere per primo la grande decisione, io per primo mi sono offerto per sacrificarmi per gli altri.[ ...] Signori, grazie di cuore. Mi sento finalmente un uomo nel vero senso della parola. Ho concepito degli ideali che prima mi erano estranei. [ ...] Vorrei ancora una cosa che mi sia concesso di pronunciare un breve discorso sulla libertà. [ ...] La libertà non significa niente. Soltanto la vera libertà significa qualcosa. Perché è vera, e quindi migliore. Tenendo presente questo fatto, dove dobbiamo cercare la vera libertà? Pensiamoci con un grano di logica. Se la vera libertà non è la stessa cosa della libertà comune, allora dov’è la vera libertà. E’ chiaro. La vera libertà possiamo trovarla solo là, dove non c’è la libertà morale». Finalmente il naufrago medio trova le vettovaglie, carne con piselli, che il grosso ordina di nascondere immediatamente:
111
Medio Ma ad essere sincero io preferisco i piselli. Lei lo sapeva che non erano finiti? Grosso A me invece non piacciono, e del resto ... Medio Cosa? Grosso (additando il Piccolo) Non vede, del resto, che ormai, è felice così».114 Anche qui giustizia è fatta! Anche qui la sentenza è stata eseguita! Come anche giustizia è stata fatta e la sentenza è stata eseguita in un altro capolavoro di Dürrenmatt Il giudice e il suo boia115, in cui un ispettore di polizia, Bärlach, alle soglie della pensione e gravemente malato, indaga sull’omicidio del tenente della polizia di Berna, Schmied. La scena si svolge nella villa di un avventuriero altolocato, Gastmann, che si avvale di amicizie politiche influenti, tanto da indurre un consigliere nazionale e un giudice istruttore a sviare Bärlach dai suoi propositi di giustizia. Ma questi si manifestano terribili. Tra Bärlach e Gastmann corrono antichi legami fin da quando Gastmann ad Istambul ha commesso un delitto sotto gli occhi dell’ispettore e lo ha sfidato a duello per tutta la vita. Bärlach ha deciso che l’avventuriero dovrà pagare per quell’antico delitto in ogni modo. L’ispettore di polizia si trasforma di colpo in giudice ed emette la sua condanna a morte, «tu non mi ammazzerai. Io sono l’unico che ti conosca, e quindi sono anche l’unico che ti possa giudicare.Ti ho già giudicato Gastmann, ti ho condannato a morte. Tu non vivrai oltre questa sera. Il boia che ho scelto per te, verrà oggi a cercarti. E ti ucciderà perché, in nome di Dio, bisogna pure che qualcuno lo faccia»116. Una sentenza che l’anziano ispettore farà eseguire da un suo giovane collega, il quale
114S. Mrozek, Na pelnym morzu, In alto mare, Lerici, Milano 1962, pp.11-38. 115F. Dürrenmatt, Der richter und sein henker, 1952, trad. it. Il giudice e il suo boia, Feltrinelli, Milano 1960, prima edizione in Feltrinelli/Impronte 1986. 116Ibidem, pag.93.
112
fa irruzione nella villa e in un conflitto a fuoco uccide l’avventuriero e i suoi due servi. Uno dei picchi più elevati della maestria di Dürrenmatt è raggiunto da un piccolissimo racconto, La salsiccia, in cui l’acume narrativo dell’Autore, il senso del concreto ed insieme dell’ironico, la percezione della tangibilità ed insieme dell’abissalità della vita è concreto, si tocca con mano. Val la pena di riferirne compiutamente, con le stesse parole dell’Autore. La scena si svolge in un’aula di un tribunale, è in corso un processo. «Un tale ammazzò la moglie e ne fece salsicce. Il fattaccio si riseppe. Il tale fu arrestato. Fu rinvenuta un’ultima salsiccia. L’indignazione fu grande. Il giudice supremo avocò il caso a sé. L’aula del tribunale è luminosa. Il sole irrompe dalle finestre. Le pareti sono specchi abbaglianti. La gente è una massa in ebollizione. ... Sulla destra luccica la testa pelata del pubblico accusatore. ... Il difensore è a sinistra. Porta occhiali dalle lenti finte. L’accusato siede tra due poliziotti. Ha grandi mani. Le dita orlate di blu. Su tutti troneggia il giudice supremo. La sua toga è nera. La barba una bandiera bianca ... La sua espressione è umanità. Davanti a lui, la salsiccia. Poggiata su un piatto. Sopra il giudice supremo troneggia la giustizia. Ha gli occhi bendati. Nella mano destra regge una spada. Nella sinistra una bilancia. E’ di pietra. Il giudice supremo alza la mano. ... il pubblico ministero si alza ... le labbra una ghigliottina ... la lingua una mannaia. L’imputato trasale. Il giudice ascolta... I suoi occhi sono due soli. I loro raggi colpiscono l’accusato. Le mani pregano. Gli pende la lingua. Le sue orecchie si sporgono. La salsiccia davanti al giudice supremo è rossa. Sta quieta. Gonfia. Le estremità sono tonde. Lo spago in cima è giallo. Riposa. ... La salsiccia ha un odore gradevole. Si fa
113
più vicina. La pelle è ruvida. La salsiccia è morbida. E’ dura. L’unghia lascia la sua impronta a forma di mezzaluna. La salsiccia è calda. La sua forma è soffice. Il pubblico ministero tace. L’accusato alza il capo, il suo sguardo è un bimbo torturato. Il giudice supremo alza la mano. Il difensore balza in piedi. Gli occhiali danzano. Parole saltellano nell’aula. La salsiccia sprizza. Il difensore tace. Il giudice supremo guarda l’accusato. ... Il giudice supremo scuote il capo. Il suo sguardo è disprezzo. Il giudice supremo comincia a parlare. Le sue parole sono spade della giustizia. Cadono come montagne sull’accusato. ... L’accusato è condannato. La morte spalanca le fauci. ... Il giudice supremo tace. L’aula è morta. L’aria pesante. I polmoni pieni di piombo. La gente trema. L’accusato è incollato alla sedia. E’ condannato. Può fare un’ultima richiesta. ... La richiesta gli sguscia dal cervello. E’ piccola. Cresce. Si fa gigantesca. Si addensa. Si plasma. Disserra le labbra. Irrompe nell’aula giudiziaria. Risuona. Il perverso maniaco omicida vorrebbe mangiare quello che avanza della povera moglie: la salsiccia. L’orrore è un grido. Il giudice supremo è un dio. La sua voce è la tromba del giudizio. Acconsente alla richiesta. Il condannato può mangiare la salsiccia. Il giudice supremo guarda il piatto. La salsiccia è sparita. Tace. Il silenzio è cupo. La gente guarda il giudice supremo. Gli occhi del condannato sono spalancati. Dentro c’è una domanda. La domanda è terribile. Fluisce nella sala. Cala sul pavimento. S’affigge alle pareti. Si rannicchia alta sul soffitto. S’impadronisce d’ognuno. La sala si dilata. Il mondo diventa un immenso punto interrogativo»117. E saremmo tentati, e fortemente, di attribuire un ruolo di giustizia a Claire Zachanassian, la Signora della Visita della vecchia signora, se lo stesso Dürrenmatt non provvedesse lui stesso a smentire
117F. Dürrenmatt, La salsiccia (1943), racconto , trad.it.di Umberto Gandini, in Racconti, Feltrinelli 1996, pp.11-12.
114
questo sospetto: «Claire Zachanassian non impersona né la giustizia né il piano Marshall e tantomemo l’apocalisse; che sia semplicemente quello che è : la donna più ricca del mondo, cioè, che grazie al denaro può agire come un’eroina della tragedia greca, assoluta, crudele. Medea, mettiamo»118, se appena dopo lo scrittore non cadesse anch’egli nella tentazione di non negare: «se l’impassibile Claire Zachanassian ha statura eroica fin dall’inizio, il suo anziano amante la deve acquistare. Lurido bottegaio, egli cade nelle grinfie di lei, ignaro. Colpevole com’é, da principio egli crede che la vita abbia da sola cancellato tutte le sue colpe: un bruto insensibile, un semplicione nella cui mente, a poco a poco, si fa strada un barlume di coscienza, attraverso la paura, il terrore, qualcosa che lo riguarda da vicino; egli sperimenta la giustizia sulla propria pelle, perché riconosce la sua colpa, diventando grande nella morte. ... La sua morte è sensata e insensata al tempo stesso. Se accadesse nel regno mitico di un’antica polis, potrebbe essere solo sensata: la vicenda però si svolge a Güllen, nel presente. ... Accanto ai protagonisti ci sono gli abitanti di Güllen, gente comune come tutti noi. ... Il disastro è ormai ineluttabile. Da questo momento gli abitanti di Güllen cominciano a prepararsi all’omicidio. ... E’ il processo attraverso cui una comunità cede a poco a poco alla tentazione.... La tentazione è troppo grande. La povertà è troppo dura»119. L’omicidio è commesso. Giustizia è fatta! La sentenza è stata eseguita! Anche stavolta, come sempre! .3 Il giudice osservatore
118F. Dürrenmatt, Theater-Schirften und Reden, Drammaturgisches und Kritisches, Der Mitmacher, 1966-1972-1976, trad. it. Lo scrittore nel tempo, Einaudi, Torino 1982, pag.72. 119Ibidem, pag.73.
115
«Il profeta Maometto è in cima a un colle in un luogo solitario. Ai piedi del colle c’è una fonte. Arriva un cavaliere. Mentre il cavaliere abbevera il suo cavallo, dalla sella gli cade una borsa di monete. Il cavaliere se ne va senza accorgersi che ha perso la borsa. Arriva un secondo cavaliere, trova la borsa, la prende e si allontana a cavallo. Arriva un terzo cavaliere abbevera il suo cavallo alla fonte. Nel frattempo il primo cavaliere si accorge di aver perso la borsa di monete e torna indietro. Crede che sia stato il terzo cavaliere a rubargli il denaro: ne nasce una lite. Il primo cavaliere uccide il terzo cavaliere, poi, non trovando la borsa, rimane sorpreso e taglia la corda. Il profeta in cima al colle si dispera: “Allah, -grida- il mondo è ingiusto. Un ladro si allontana impunito e un innocente viene ucciso!”. Allah, che in genere non parla, risponde “Stolto! Che cosa vuoi mai capire della mia giustizia! Il denaro che il primo cavaliere ha perso lo aveva rubato al padre del secondo cavaliere. Il secondo cavaliere si è ripreso quello che già gli apparteneva. Il terzo cavaliere aveva violentato la moglie del primo cavaliere. Uccidendo il terzo cavaliere, il primo ha vendicato sua moglie”. Quindi Allah si chiude nuovamente nel silenzio. Da quando ha udito la voce di Allah, il profeta loda la sua giustizia».120 Da questa piccola storia, tratta liberamente da Le Mille e una notte, Dürrenmatt trae una grande conclusione, che «naturalmente non è indifferente chi sia l’osservatore» perché un osservatore «in sé non esiste, un osservatore osserva, interpreta o agisce secondo la sua natura»121.
120F. Dürrenmatt, I dinosauri e la legge (1988, 1990, 1992), trad.it. di Eugenio Bernardi, Einaudi, Torino 1995, pag.5. 121Ibidem, pag.6.
116
Dunque, tre sono i possibili atteggiamenti di chi “osserva”, l’atteggiamento di chi osserva, l’atteggiamento di chi interpreta, l’atteggiamento di chi agisce. Ma naturalmente è del tutto ininfluente, per lo meno per la maggior parte degli uomini se non proprio per tutti, che chi osserva o interpreta o agisce sia un “osservatore” generico e, per così dire, neutrale; un osservatore generico, neutrale e disinteressato non è rilevante per nessuno ed anzi rischia di passare del tutto inosservato, come in realtà passa inosservato. Il problema, e non è certo una sottigliezza ma è il distinguo che funge da crinale di spartizione tra una situazione neutra e una situazione significativa e carica di conseguenze, sta tutto nell’individuazione della partecipazione dell’osservatore e del grado di partecipazione di questo cioè proprio nella qualità dell’atteggiamento di chi osserva. Il punto centrale del problema sta tutto nell’interesse dell’osservatore. E ribadiamo un osservatore neutrale non esiste, non può esistere, come rileva Dürrenmatt (“l’osservatore in sé”). Si deve avere interesse ad osservare, o perché proprio l’operazione dell’osservazione non è fine a se stessa ma è finalizzata a ..., oppure perché l’osservazione è uno strumento, professionale, per “interpretare” e per “agire”: nella piccola storia raccontata dal nostro Autore manca del tutto il gusto dell’osservazione per l’osservazione, com’è ovvio che sia. Certo, nota l’Autore «ci vuole una certa disumana durezza a non voler essere nient’altro che un osservatore: anche solo un minimo slancio di umanità avrebbe indotto il profeta ad avvisare il primo cavaliere della perdita del suo denaro, per cui il secondo cavaliere non avrebbe rubato e il terzo cavaliere sarebbe rimasto in vita, ma con ciò anche l’ingranaggio della giustizia universale per un
117
momento si sarebbe confuso e, inceppato, la dimostrazione di essa per bocca di Allah sarebbe stata impedita da un piccolo gesto umano comprensibile per noi tutti, e un pizzico di umanità ci avrebbe fatto perdere tonnellate di sublimità divina».122 qual’è dunque la conclusione di tutto questo: che è l’ottica di osservazione a “creare” la visione e non viceversa; l’avvenimento che si osserva è di per sé neutro, è l’osservatore che gli attribuisce una valenza, anzi meglio che gli attribuisce visibilità. Dürrenmatt lo ha spiegato magistralmente: «vediamo che se un osservatore s’intromette in qualche modo nell’avvenimento che osserva, l’avvenimento si modifica, e con ciò il risultato dell’avvenimento stesso. Il risultato che si ottiene è diverso, anzi si possono immaginare molti risultati diversi, non soltanto per quanto riguarda i cavalieri, ma anche per quanto riguarda la giustizia e l’ingiustizia di questo mondo e quindi per quanto riguarda la struttura universale»123. E non è forse sempre l’ottica dell’osservatore a modificare l’avvenimento, o addirittura a crearlo anche nel caso dei tre naufraghi di Mrozek? Già il fatto di per sé di vedere “piccolo” il naufrago piccolo crea negli altri due la consapevolezza della giustezza della loro scelta, e non è trascurabile, poi, la considerazione che il non gradimento gastronomico di uno di loro (il disgusto per i piselli) è anch’esso elemento sufficiente per favorire un’ottica di osservazione piuttosto che un’altra. Se, poi, spostiamo la riflessione dall’ottica dell’osservazione, cioè dall’osservatore al punto di osservazione, cioè al luogo dell’osservazione dobbiamo concludere che la giustizia osserva dall’alto.
122Ibidem. 123Ibidem, pag.8.
118
Che vuol dire anche che non solo osserva, ma anche interpreta ed agisce, cioè giudica, dall’alto. E questo perché il potere osserva, interpreta, giudica dall’alto. “Il profeta Maometto è in cima a un colle”, ma sopra di lui sta Allah che lo osserva, lo interpreta, ed agisce, solo a lui appartiene il mondo della verità, perché sta più in alto del profeta: per questo solo fatto Maometto, il profeta, è fallibile. Un altro osservatore lo sovrasta. Mirjan Damaska in un suo celebre volume, I volti della giustizia e del potere, ha puntualizzato assai bene il punto: «separata dalla risoluzione delle controversie, la giustizia attiva è anche libera dall’immaginazione dominante della lite come scontro simbolico: nella classica relazione triadica, quella di due parti che avanzano pretese confliggenti di fronte ad un organo che decide. Il processo può consistere in una situazione bipolare tra un funzionario dello Stato e un singolo individuo, o coinvolgere un gran numero di protagonisti che propongono una varietà di punti di vista diversi: uno schema poligonale. Naturalmente si può anche mantenere in via provvisoria la forma triadica della lite. Ma il processo attivo, sia esso bipolare, triadico o poligonale, va strutturato in modo da consentire la ricerca della risposta migliore in termini di politica del diritto alla situazione occasionale».124 Certo come non chiedersi, a questo punto, se abbia ragione Maometto o Allah. La domanda è meno banale e meno ingenua di quanto possa apparire, e si potrà obiettare che bisogna intendersi che cosa significhi aver ragione, una delle cose più complicate del mondo, per l’intanto nascondiamoci dietro un dito e ricorriamo al senso più comune e più corrente dell’espressione; ebbene
124Mirjan R. Damaska, The faces of Justice and State Authority,Yale University Press, New Haven 1986, trad. it. I volti della giustizia e del potere, Il Mulino, Bologna 1991, pag.157.
119
chiediamoci se abbia ragione Maometto e Allah. Il problema è di quelli che dai primordi del mondo agita l’uomo, è lo scontro tra la verità processuale e la verità sostanziale, tra una verità provabile, e provata, e una verità posseduta seppure non provata o non provabile. Maometto osserva i fatti attraverso i suoi occhi e attraverso questi li giudica; il torto della giustizia è patente: un ladro si allontana impunito e un innocente viene ucciso. Questa è la situazione che realmente “accade”, che veramente è processualmente provabile. L’altra verità quella di cui è in possesso Allah appartiene solo a lui e se anche si potesse dire che appartiene al mondo sarebbe di così ardua, per non dire, impossibile composizione, dovendo mettere insieme circostanze avvenute in luoghi, tempi e modalità diverse, da divenire impossibile per il mondo; è infatti una verità della divinità, Allah ne è in possesso perché dall’alto, dal più in alto di tutti, riesce ad “osservare” meglio di chiunque altro. Ma anche così i dubbi permangono, anzi paradossalmente si amplificano: se, per esempio, l’osservatore in cima al colle fosse stato un criminale ed avesse egli stesso rubato la borsa delle monete persa dal primo cavaliere la situazione si presenterebbe in maniera assai diversa da quella descritta prima: «per quanto riguarda infatti la morte del terzo cavaliere, la punizione infertagli per aver violentato la moglie del primo cavaliere tutt’a un tratto può diventare discutibile, nel senso che potrebbe verificarsi uno spostamento di tempo: visto che il secondo cavaliere alla fonte non aveva trovato niente da rubare, non avrebbe neanche avuto motivo di andarsene via così in fretta. In questo caso, tornando alla fonte, il primo cavaliere avrebbe trovato due cavalieri, il secondo che vi si tratteneva ancora e il terzo appena sopraggiunto. Di conseguenza il primo cavaliere avrebbe accusato di furto o gli altri due o uno degli altri due. Se avesse accusato uno degli altri due avrebbe accusato il secondo cavaliere, dato che il secondo era arrivato alla fonte prima
120
del terzo. A seconda delle accuse il primo cavaliere avrebbe lottato contro gli altri due o contro il secondo cavaliere. Nella prima variante la morte del primo cavaliere si dà come probabile (uno contro due), nella seconda variante o il primo cavaliere ammazza il secondo o il secondo il primo. In ogni caso la violenza rimane impunita, e in ogni variante la giustizia è imperfetta. O il primo cavaliere viene punito con la morte per il furto commesso a danno del padre del secondo cavaliere, ma con ciò il secondo cavaliere non ottiene i suoi averi, oppure il secondo cavaliere insieme ai suoi averi perde anche la vita, sicché dal punto di vista statistico, per primo le probabilità di sopravvivenza sono minime. Anche in questo caso si tratta di una recrudescenza notevole dell’ingiustizia universale e di un’ulteriore impossibilità per Allah di provare la giustizia universale. Questa volta le tonnellate di sublimità divina sono andate in fumo a causa del miserabile furto di un osservatore»125. Ma non è forse la giustizia ad esser posta sul gradino più alto anche nella rappresentazione quotidiana della giustizia stessa? Non è forse il giudice ad essere assiso sul seggio più alto nel luogo della rappresentazione e della celebrazione del processo? Anche solo dal punto di vista iconografico il giudice decide più in alto degli altri. Allah è più in alto anche del suo profeta, e non potrebbe che essere così, ed anche il naufrago grosso di Mrozek quando pronuncia la sua “sentenza” sale sul seggio posto più alto, una cassetta posta al centro della zattera. Perché, senza usare infingimenti né giri di parole, giustizia è potere e potere è giustizia. Su questo sono stati scritti fiumi di inchiostro da che esiste l’uomo e non vogliamo qui ripercorrere questo lunghissimo fiume di inchiostro, ma non possiamo sottrarci a qualche considerazione, 125F. Dürrenmatt, I dinosauri e la legge, cit., pp.6-7-
121
sempre con particolare riferimento alle nostre situazioni teatrali e ai nostri Autori teatrali. E’, in breve, il problema della giustizia politica su cui oggi tanto si dibatte126. Al rapporto tra potere e diritto Lawrence M. Friedman ha dedicato alcune magistrali pagine: «il potere è disegualmente distribuito e disegualmente esercitato; e il diritto non può che rispecchiare e sostenere siffatta distribuzione. L’ideologia e la cultura intervengono nel processo che conduce dal potere potenziale al suo effettivo esercizio. [ ...] Il diritto discrimina, o -per dirla con terminologia priva di connotazioni emotive- riflette la struttura sociale esistente in due modi. In primo luogo, le norme stesse, l’aspetto ufficiale del diritto, non sono affatto del tutto imparziali anche quando sono applicate con imparzialità. Esse sono il prodotto di lotte per il potere e sono forgiate dall’opinione dei dominanti. [ ...] Una delle cose che più colpiscono, riguardo ai sistemi giuridici moderni, è lo stacco tra ciò che essi dicono, tra gli ideali che essi professano, e il modo in cui agiscono. Molte sono le ragioni di questo stacco. Una ragione è che è funzionale agli interessi di ceti dominanti che il sistema appaia non avere connotati di classe, e appaia giusto e imparziale. Una certa quantità di ipocrisia è duplicemente utile: il doppio metro di giudizio va a vantaggio di chi occupa le posizioni di vertice, e -allo stesso tempo- occupa la realtà agli occhi del resto della società. Il diritto -scrive Edgar Z. Friedenberg- è essenzialmente inteso ad imporre
126Fra le tante intrepretazioni si veda il volume di Otfried Höffe, Politische Gerechtigkeit. Grundlegung einer kritischen Philosophie von Recht und Staat, Frankfurt am Main, 1987, trad.it., Giustizia Politica. Fondamenti di una filosofia critica del diritto e dello Stato, Il Mulino, Bologna 1995. Si veda anche il volume di Agnes Heller, Beyond Justice, Basil Blackwell, Oxford and New York 1987, trad. it. Oltre la giustizia, Il Mulino, Bologna 1990.
122
“distorsioni della giustizia” alla gente comune, ma senza mai ammetterlo; “ai membri più deboli della società non è vietato l’accesso [ al diritto] -ciò potrebbe distruggere il potere di integrazione sociale che ha il mito dell’eguaglianza di fronte alla legge- ma i deboli scoprono che il diritto è molto meno produttivo a loro favore di quanto non lo sia nelle mani dei loro aggressori”. [ ...] La giustizia, dunque, è classista è l’idea che non lo sia è solo un mito».127 Dürrenmatt ha espresso questo principio con una plasticità esemplare, facendo ricorso alla parabola del lupo e del buon pastore. «Che l’uno si avventi sull’altro, che tra gli esseri umani domini la guerra, che ognuno cerchi di imporsi e di accrescere i suoi beni e il suo potere a spese degli altri, il borghese classico, essendo un realista, lo accetta come un fatto naturale. Homo homini lupus. Tuttavia affinché gli egoismi degli uomini non portino a una guerra di tutti contro tutti, ogni lupo si è impegnato a osservare determinate regole del gioco nei confronti degli altri lupi, o più esattamente: i lupi hanno stabilito un gioco tra di loro. Ma per poter giocare un gioco tra lupi, devono essere garantiti anzitutto due elementi del gioco: il giocatore e il bottino che il gioco gli frutta. Se il giocatore non è garantito, in qualsiasi momento può essere sopraffatto da un altro lupo che non sta più al gioco, e se non è garantito il bottino, il lupo, dal momento che il gioco non gli procura alcun bottino, si dedica di nuovo alla caccia
127Lawrence M. Friedman, The legal system. A social science perspecitive, 1975, ed. it. a cura di Giovanni Tarello, Il sistema giuridico nelle prospettive delle scienze sociali, Il Mulino, Bologna 1978, pp. 306-314. La citazione di E.Z. Friedenberg si riferisce al suo saggio “The side effects of the legal process” in The rule of law, a cura di Paul Wolff, 1971.
123
naturale»128[ ...] Il guadagno che il borghese ricava usando le sue pedine è il bottino che guadagna con il gioco e che grazie alle regole del gioco può mettere al sicuro. Ma quanto più le regole del gioco, in origine semplici, si differenziano tanto più il gioco si complica, tanto più si allarga, e quanto più si allarga, tanto più entrano in azione coloro che grazie alla loro abilità nel gioco possiedono, rispetto agli altri, un numero maggiore di pedine utilizzabili, e quanto più le pedine sono distribuite in modo diseguale tra i giocatori, tanto più si pone il problema di chi in realtà controlli il gioco. Anche se rispettare le regole del gioco è nell’interesse di tutti, le complicazioni del gioco inducono da una parte i giocatori esperti a barare -cosa di cui i giocatori meno esperti si accorgono troppo tardi-, dall’altra fanno sì che i giocatori con meno pedine ridiventino lupi in libertà e aggrediscano i giocatori con più pedine per poter entrare meglio nel gioco in un mondo contrario alle regole. E’ il gioco stesso quindi a esigere un arbitro, non solo perché sorvegli il gioco, ma anche perché immetta nel gioco le pedine. Infatti le pedine significano le cose, e le cose si possono produrre, quindi anche le pedine si devono poter produrre. [ ...] Un arbitro però deve essere pagato. Quindi ogni giocatore deve versare all’arbitro un certo numero di pedine, sicché capita che ben presto anche l’arbitro, il quale è stato pagato, entri nel gioco, e che essendo pagato da tutti diventi il giocatore più potente. A questo punto non si può più stabilire se l’arbitro sia lì per i giocatori o i giocatori per l’arbitro. Questo arbitro è lo Stato borghese».129 A questo punto, per chiudere il cerchio, due domande si impongono, la prima: chi è “l’arbitro” di cui parla Dürenmatt, e che
128F. Dürrenmatt, I dinosauri e la legge, cit., pag.11. 129Ibidem, pp.7-12.
124
più tecnicamente dovremmo qualificare come giudice?; la seconda : quale parte, e quindi quale giustizia rappresenta?, o meglio: quale parte maggiormente rappresenta e quindi quale giustizia maggiormente rappresenta.? Se le regole del gioco sono il frutto del compromesso dei diversi giocatori che hanno partecipato al gioco con un numero diverso, e fra loro squilibrato, di pedine, la regola non potrà non risentire di questa contrattazione condotta da posizioni e con posizioni diseguali. Il compromesso, e quindi la regola finale, non potrà che essere espressione di questo compromesso e registrare in sé la diseguaglianza attraverso la quale è stata prodotta. Anzi la regola del gioco concretamente registra la diversità delle diverse posizioni dei giocatori che hanno partecipato alla sua creazione e fotografa esattamente la quantità di potere che ciascuno di questi ha investito nella creazione della regola stessa. E’ mai credibile che la regola del gioco segni un andamento diverso da quello che ha condotto alla sua creazione? E’ mai credibile, cioè, che la regola del gioco riveli nella sua formulazione finale un aspetto diverso da quello che i giocatori stessi hanno voluto imprimere durante la fase della creazione stessa? Vincenzo Tomeo ha fornito delle magistrali risposte a questi quesiti: «sono situazioni che riproducono un quadro non dissimile da quello tracciato da Gumplowicz: un assetto di gruppi minoritari dominanti di fronte a gruppi complessivamente maggioritari, ma singolarmente subordinati e nell’insieme dominati. Se si aggiunge la circostanza attuale di un diritto, in cui la formazione extra-legislativa ed extra-statuale non è infrequente, il quadro appare nella sua interezza: i gruppi confliggono e si contrappongono ai fini
125
di una distribuzione del potere sociale»130 il cui scopo ultimo è la conquista degli apparati dello stato: «si parla abitualmente di “possesso”, di “occupazione” dello stato, proprio per indicare il controllo materiale degli strumenti istituzionali del controllo sociale. [ ...] Il possesso dello stato assume quindi un’importanza critica poiché costituisce il momento sanzionatorio e formale con cui si definisce la distribuzione del potere».131 Ed allora, non è forse logico, ed anche corretto, supporre che il giudice in quanto esercita una funzione, e svolge un ruolo, di potere, o meglio dotato di potere formale, sia più vicino, e in qualche modo debba essere più vicino, al gruppo che, in qualche modo, ha partecipato a compilare le regole del gioco? Non crediamo di essere assai distanti dal vero se riteniamo che anche questa, certo non solo questa, è una possibile ragione per cui anche visivamente e rappresentativamente la giustizia sta in alto, più in alto degli altri, e dall’alto osserva, interpreta, giudica. «Il profeta Maometto è in cima a un colle in un luogo solitario» ma più in alto di lui sta Allah, anche i naufraghi di Mrozek pronunciano le loro sentenze dall’alto. Anche l’iconografia è potere, così come il potere è iconografia!
130V. Tomeo, Il diritto come struttura del conflittto, Angeli, Milano 1981, pag.78. 131Ibidem, pag.84.
126
Studio n°4
Lo Straniero e la Giustizia
Partito lui, ho ritrovato la calma. Ero esausto e mi sono gettato
sulla branda. Devo aver dormito perché mi sono svegliato con
delle stelle sul viso. Rumori di campagna giungevano fino a me.
Odori di notte, di terra, e di sale rinfrescavano le mie tempie. La
pace meravigliosa di quell’estate assopita entrava in me come una
127
marea. In quel momento e al limite della notte, si è udito un sibilo
di sirene. Annunciavano partenze per un mondo che mi era ormai
indifferente per sempre. Per la prima volta da molto tempo, ho
pensato alla mamma. Mi è parso di comprendere perché, alla fine
di una vita, si era preso un “fidanzato”, perché aveva giocato a
ricominciare. Laggiù, anche laggiù, intorno a quell’ospizio dove
vite si stavano spegnendo, la sera era come una tregua
melanconica. Così vicina alla morte, la mamma doveva sentirsi
liberata e pronta a rivivere tutto. Nessuno, nessuno aveva il diritto
di piangere su di lei. E anch’io mi sentivo pronto a rivivere tutto.
Come se quella grande ira mi avesse purgato dal male, liberato
dalla speranza, davanti a quella notte carica di segni e di stelle, mi
aprivo per la prima volta alla dolce indifferenza del mondo.
Nel trovarlo così simile a me, finalmente così fraterno, ho sentito
che ero stato felice, e che lo ero ancora. Perché tutto sia
consumato, perché io sia meno solo, mi resta da augurarmi che ci
siano molti spettatori il giorno della mia esecuzione e che mi
accolgano con grida di odio. 132
132 A. Camus, L’Etranger, 1942, Edition Gallimard, Paris 1942, trad. it. di Alberto Zevi, Bompiani, XVI^ ed., Milano 2000, pp.149-150.
128
E’ questa la chiusa de Lo Straniero di Albert Camus ed è, forse,
anche un modo insolito, o comunque non del tutto consueto, di
cominciare a citare questo romanzo; di solito si comincia col citare
la prima frase “oggi la mamma è morta. O forse ieri, non so” e si
prosegue con il citare quelle frasi in cui emerge un distacco
psicologico di Meursault, quasi una sua freddezza psicologica,
dagli avvenimenti immediati.
Mi sono sempre immaginato Meursault, afferma René Girard, come
un essere estraneo ai sentimenti degli altri esseri umani. Amore,
odio, ambizione, invidia, cupidigia, gelosia: tutto ciò gli è
sconosciuto. Assiste alle esequie della madre con la stessa
impassibilità con cui, il giorno dopo, guarda un film di Fernandel.
Meursault finisce per uccidere un uomo, ma come si potrebbe
vedere in lui un vero criminale? Come potrebbe avere quest’uomo
un movente qualsiasi? ... Il personaggio di Meursault incarna
l’individualismo nichilista esposto nel mito di Sisifo e
generalmente denominato “assurdo”. Meursault è posseduto
dall’assurdo come certuni, in tutt’altro contesto spirituale, sono
posseduti dalla grazia. Ma il termine “assurdo” non è assolutamente
indispensabile: l’Autore stesso –nella sua prefazione all’edizione
americana dello Straniero- definisce il suo eroe come qualcuno che
129
“non sta al gioco”; Meursault si rifiuta di mascherare i suoi
sentimenti , e immediatamente “la società si sente minacciata”.
L’eroe riveste, dunque, un significato positivo: non è “un relitto”,
un essere alla deriva; “é un uomo povero e nudo, innamorato del
sole”133.
Sono proprio queste parole dello stesso Camus, insieme alla scelta
del titolo del romanzo, a dare il senso all’intera opera “la società si
sente minacciata” perché Meursault è uno “straniero”, anzi è “lo
straniero”.
E’ proprio da questa motivazione sociale, anzi decisamente
sociologica”, fornitaci dallo stesso Autore, che desideriamo avviare
le nostre considerazioni.
Perché Meursault è e resta sempre uno straniero, anzi lo
Straniero”, e questo nonostante alcuni suoi sforzi, o forse solo,
tentativi, di “omologarsi”, di non “stranierizzarsi”, di voler
costruire una vita cosiddetta “normale”.
La sera Maria è venuta a prendermi e mi ha domandato se volevo
sposarla. Le ho detto che la cosa mi era indifferente, e che
avremmo potuto farlo se lei voleva. Allora ha voluto sapere se
133 R. Girard, Pour un nouveau procès de l’étranger. Système du délire, Grasset, Paris 1976, ed. it. Il risentimento. Lo scacco del desiderio nell’uomo contemporaneo, Cortina, Milano 1999, pp. 29-30.
130
l’amavo. Le ho risposto, come già avevo fatto un’altra volta, che
ciò non voleva dir nulla, ma che ero certo di non amarla. Perché
sposarmi, allora? mi ha detto. Le ho spiegato che questo non aveva
alcuna importanza e che se lei ci teneva potevamo sposarci. Del
resto era lei che me lo aveva chiesto e io non avevo fatto che dirle
di sì. Allora lei ha osservato che il matrimonio è una cosa seria. Io
ho risposto: no. E’ rimasta zitta un momento e mi ha guardato in
silenzio. Poi ha parlato: voleva soltanto sapere se avrei accettato
la stessa proposta se mi fosse venuta da un’altra donna cui fossi
legato nello stesso modo. Io ho detto: naturalmente. Allora si è
domandata se lei mi amava, e io, su questo punto, non potevo
saperne nulla. Dopo un altro istante di silenzio, ha mormorato che
ero molto strambo, che certo lei mi amava a causa di questo, ma
che forse un giorno le avrei fatto schifo per la stessa ragione.
Siccome io tacevo, non avendo nulla da dirle, mi ha preso il
braccio sorridendo e ha detto che voleva sposarmi. Io ho risposto
che l’avremmo fatto non appena lei avesse voluto.134
Ed è il pensiero di Maria, la scelta fatta e non mantenuta per
l’avversità degli eventi, che tormentano Meursault in prigione:
134 A. Camus, L’Etranger, cit, pp.55-56.
131
il prete ha girato lo sguardo tutt’intorno e ha risposto con una voce
che d’improvviso ho trovato molto stanca: tutte queste pietre
sudano il dolore, lo so. Non l’ho mai guardate senza angoscia. Ma
dal fondo del mio cuore so che i più miserabili di voi hanno visto
sorgere un volto divino. E’ questo volto che vi si chiede di vedere.
Mi sono animato un pò. Ho detto che erano mesi che guardavo
quei muri. Non c’era nulla né alcuna persona al mondo che
conoscessi meglio. Forse già molto tempo prima vi avevo cercato
un volto. Ma quel volto aveva il colore del sole e la fiamma del
desiderio: era quello di Maria135.
Meursault è un uomo qualunque, un piccolo borghese francese, per
usare le parole di Girard, non ha responsabilità né famiglia, né
problemi personali, né alcuna simpatia per le cause impopolari. A
quanto pare beve solo caffelatte, conduce davvero la vita prudente
di qualunque piccolo burocrate.136 Meursault è davvero un uomo
comune e dell’uomo comune ha tutti i desideri, filtrati certo da un
carattere privo di passionalità o anche solo di fervore, ma desideri a
tutti gli effetti.
135 Ibidem, pp.145-146. 136 R. Girard, cit., pp 38-39.
132
Come osserva Alfredo Verde Meursault parla francamente, non
nega, anzi afferma e confessa i suoi desideri omicidi nei confronti
della madre. Questi desideri, l’ambivalenza nei confronti
dell’oggetto d’amore, sono effettivamente presenti in tutti. Ma in
Meursault sono razionalizzati in modo eccessivo137.
Gli istruttori avevano sentito che avevo dato prova di insensibilità
il giorno dei funerali. Lei capisce, mi ha detto l’avvocato, è un pò
imbarazzante per me domandarle questo. Ma è molto importante.
Sarà un argomento molto forte per l’accusa, se io non trovo niente
da ribattere. Voleva che lo aiutassi. Mi ha chiesto se quel giorno
avevo sofferto. Questa domanda mi ha molto stupito e mi è parso
che sarei stato molto imbarazzato se avessi dovuto farla io a un
altro. Comunque gli ho risposto che avevo un pò perduto
l’abitudine di interrogare me stesso, che mi era difficile
informarlo. Naturalmente volevo bene alla mamma, ma questo non
significava nulla. Tutte le persone normali, gli ho detto, hanno una
volta o l’altra desiderato la morte di coloro che amano.
137 A. Verde, “L’assassino innocente. Delitto, processo e pena ne Lo Straniero di A. Camus” in Marginalità e Società 18/1991, pag.102. Per una analisi completa del saggio di questo autore si rinvia anche alla prima parte contenuta nella medesima Rivista, nel numero 17-91, pp.107-125.
133
Non è affatto vero che Meursault ha dato prova di insensibilità,
vive emozioni forti, sente ostilità verso qualcuno, come sottolinea
Alberto Giasanti138. Reagisce anche violentemente agli insulti:
No figlio mio, mi ha detto mettendomi la mano sulla spalla, io sono
con te. Ma tu non puoi saperlo perché hai un cuore cieco. Io
pregherò per te.
Allora non so per quale ragione, c’è qualcosa che si è spezzata in
me. Mi sono messo a urlare con tutta la mia forza e l’ho insultato e
gli ho detto di non pregare per me e che è meglio ardere che
scomparire. Riversavo su di lui tutto il fondo dei mio cuore con dei
sussulti misti di collera e di gioia. Aveva l’aria così sicura, vero?
Eppure nessuna delle sue certezze valeva un capello di donna. Non
era nemmeno sicuro di essere in vita dato che viveva come un
morto. Io, pareva che avessi le mani vuote. Ma ero sicuro di me,
sicuro di tutto, più sicuro di lui, sicuro della mia vita e di questa
morte che stava per venire139.
No, non è l’insensibilità ad averlo perso, non è quella “mancanza di
anima” che gli rimprovera il pubblico ministero ad averlo condotto
alla condanna:
138 A. Giasanti, Introduzione al volume Giustizia e Conflitto Sociale, pag.17. 139 A. Camus, L’Etranger, cit. pag. 147.
134
Il p.m. si è messo a parlare della mia anima. Diceva che si era
chinato su di essa e non vi aveva trovato nulla, signori giurati.
Diceva che in verità io non ne avevo affatto, di anima, e che nulla
di umano mi era accessibile, nessuno dei principi morali che
presiedono al cuore degli uomini. Naturalmente –aggiungeva- non
è questo che vogliamo rimproverargli. Non abbiamo il diritto di
lamentarci che sia privo di ciò che egli non potrà mai possedere.
Ma quando si tratta di questa Corte la virtù tutta negativa della
tolleranza deve cedere il passo a quella meno facile ma più elevata
della giustizia. Soprattutto quando il vuoto dell’animo quale si
ritrova in quest’uomo diventa un abisso dove la società può perire
È la paura che la società sia toccata, e intaccata, da questo straniero,
dallo straniero, che la società “perisca” per questo straniero, ad aver
perso Meursault.
E’, insomma, per noi e dal nostro punto di vista, un risvolto tutto
sociologico a condurre Meursault in prigione e sulla ghigliottina.
Del resto proprio questa è l’interpretazione dello stesso Camus, per
lui la morte del suo eroe è “il risultato odioso di una collettività
indegna” e la prova che “nella nostra società, chiunque non pianga
al funerale di sua madre rischia di essere condannato a morte”140.
140 A. Camus, Prefazione all’edizione americana de L’Etranger del 1955.
135
In questa situazione, come afferma Girard, l’omicidio sarà forse un
pretesto, ma è l’unico di cui i giudici dispongano.
Un’occasione hanno affermato parecchi critici, l’accidente come si
direbbe con stretto linguaggio sociologico, persino un tragico errore
giudiziario, un giudizio di colpevolezza qualificato come omicidio
premeditato e non già involontario, come ha affermato taluno.
Tutto questo non ci convince, non è così né può essere così; perché
se così fosse sposterebbe il piano dell’analisi dal profilo sociale a
quello psicologico ed evenemenziale, e questo farebbe, a mio
avviso, un torto non solo al romanzo ma addirittura alle intenzioni
ed alle parole del suo stesso Autore: “la società si sente minacciata”
dallo Straniero perché questo “non sta al gioco”.
E la società “si sente minacciata” dallo Straniero che “non sta al
gioco” proprio perché lo Straniero è uno straniero.
Come ha notato con molta acutezza René Girard adottare la teoria
dell’incidente significa necessariamente minimizzare, se non
eludere, il conflitto tragico tra Meursault e la società; ecco perché, a
giudizio dell’autore, questa teoria non concorda con il giudizio del
lettore. Affinché i significati intenzionali dell’Autore siano
presenti, è necessario che il rapporto tra Meursault e il suo delitto
non possa ridursi, come avviene per i criminali comuni, a un
136
semplice movente; bisogna invece che questo rapporto risulti
essenziale e non accidentale. Fin dall’inizio del romanzo si sente
che si sta preparando una catastrofe e che Meursault non può far
nulla per difendersi: l’eroe è innocente, non c’è alcun dubbio, ed è
proprio questa innocenza a causare la sua rovina.141
Non concordo affatto sull’innocenza di Meursault, questi è
colpevole, anzi la mancanza di un qualsiasi movente nell’omicidio
ne aggrava la posizione (il presidente sarebbe stato lieto, prima di
sentire il mio avvocato, che io precisassi i motivi che avevano
ispirato il mio gesto. Ho detto molto in fretta, rendendomi conto di
quanto ero ridicolo, che era stato a causa del sole); né vale per noi
invocare il Fato o il Destino come taluno ha ipotizzato, fra gli altri
Carl Viggiani, perché questa categoria non è una categoria
sociologica.
Il problema per noi è e rimane quello di un rapporto diretto tra
Meursault e la società filtrato attraverso l’azione e il giudizio degli
inquirenti e dei giudici .
Meursault è, anche sotto questo aspetto, uno straniero e questo
determina una reazione sociale, come acutamente ha notato Charles
Debuyst quando ha affermato che una reazione di questo tipo ha per
141 R. Girard, Il risentimento, cit., pp.40-41.
137
conseguenza di trasformare l’autore della trasgressione in
“straniero”, in “impuro”, in “rinnegato”, vale a dire in un essere per
cui qualsiasi idea di partecipazione al gruppo ha perso il suo senso,
dimodochè una sanzione di esclusione o di rifiuto deriva in modo
del tutto naturale da tale stato di fatto.142
Perché, in definitiva, lo straniero è l’altro, il diverso da noi,
l’estraneo a noi; in una parola, è tutto ciò di quel che noi non siamo
come individui e come gruppi sociali.
E’ la situazione descritta con assoluta precisione da Luciano
Gallino quando afferma che la condizione di estraneità è la
configurazione della coscienza di un individuo formata dalla
interiorizzazione del complesso organizzato de a) gli atteggiamenti
che la comunità in cui è vissuto, o alcuni settori di essa, hanno
manifestato sia nei suoi confronti sia nei confronti di altri soggetti,
interni o esterni alla comunità, insieme con le situazioni più o meno
critiche che essa ha dovuto affrontare; b) le norme di condotta che
la comunità prescriveva, e che l’individuo ha appreso a
generalizzare svolgendo diversi ruoli e interpretando i ruoli di altri,
sotto l’influenza di una serie di altri significativi.
142 Ch. Debuyst, Modèle éthologique et criminologie, Mardaga Editeur, Bruxelles 1985.
138
In sintesi, conclude Gallino, l’altro generalizzato potrebbe definirsi
come la personificazione interiore di aspetti della società penetrati
in un individuo tramite la socializzazione, cioè la realtà oggettiva di
altrui divenuta soggettiva per sé.143
Si tratta, evidentemente, della situazione opposta all’identità e
all’identificazione, anzi più precisamente l’altra faccia della
medaglia; se identità, come sottolinea, Gallino significa capacità di
stabilire una differenza osservabile tra sé e l’altro, di differenziarsi
dal mondo, e di mantenere nel tempo il senso di tale differenza e se
l’identificazione è il risultato della disposizione a co-fondersi, ad
essere incluso, del senso d’una affinità o d’una parentela con altri in
forza del quale l’individuo avverte di essere inglobato in una entità
più grande, che gli ingiunge di usare come parlante “noi” in luogo
di “io” 144, l’altruità, e maggiormente l’estraneità, è la situazione del
distacco dalla società, o integralmente o parzialmente; cioè o come
estraneità totale alla società, è la situazione dello straniero e dello
Straniero, oppure come estraneità parziale a un certo tipo di società
o a certi tipi di gruppi sociali.
143 L. Gallino, voce “Altro generalizzato” in Dizionario di Sociologia, Utet, Torino 1983, pag.17 144 L. Gallino, “Identità, identificazione” in Laboratorio Politico 1982 nn.5-6, pag.145.
139
In effetti, ammette Gallino, non si ha identità, né soggettiva né
oggettiva (ossia non si dà né il senso né l’appartenenza di essa),
senza riferimento a qualche forma di identificazione; né esiste
identificazione che sia scindibile da un’identità. L’identità è
rilevabile unicamente contro uno sfondo di affini con i quali in
quanto affini, è possibile in un altro momento identificarsi, così
come l’identificazione è soltanto possibile se agli altri si reca il
senso di una differenza che si va elidendo. Ma sia l’identità sia
l’identificazione sono internamente stratificate, ciascuno strato
corrispondendo a inclusioni di sé in altri, e oggettivazioni dell’altro
che permette al sé di differenziarsi, delimitate da cerchie
concentriche di riferimenti biologici e culturali via via più ampie.145
Per Gallino, dunque, la definizione dell’altro passa attraverso due
parametri, gli atteggiamenti della comunità e le norme di condotta
della società stessa in riferimento alla coscienza di un individuo
inserito in questa comunità, tutto quello che sta al di fuori di questi
due parametri è estraneo al singolo individuo o al singolo gruppo
sociale: è straniero.
Gli uni e gli altri finiscono per diventare, o lo sono originariamente,
elementi connaturati al concetto stesso di società; il richiamo alla
145 Ibidem, pp.146-147
140
posizione di Durkheim è d’obbligo. Come è noto questo autore
definisce la sociologia come scienza dei fatti sociali e questi sono
coercitivi e indipendenti rispetto alle espressioni individuali, e in
quanto tali l’individuo non può sfuggire a questi indipendentemente
dalle sue azioni e dalle sue volontà particolari. I sentimenti “vivi
nella generalità delle coscienze” costituiscono la “normalità”.
«L’uniformità delle coscienze dà origine a certe regole giuridiche
che determinano la natura e i rapporti delle funzioni divise, la cui
violazione produce soltanto misure riparatrici, prive del carattere di
espiazione.
Ognuno di questi corpi di regole è d’altra parte accompagnato da un
corpo di regole puramente morali. Dove il diritto penale è molto
voluminoso, la morale comune è molto estesa: c’è quindi una
molteplicità di pratiche collettive poste sotto la custodia
dell’opinione pubblica. Dove il diritto restrittivo è molto
sviluppato, per ogni professione c’è una morale professionale.
Ogni società è una società morale. Sotto certi aspetti questo
carattere è perfino più pronunciato nelle società organizzate. Dal
momento che l’individuo non è autosufficiente, egli riceve dalla
società tutto ciò che gli è necessario in quanto lavora per essa. Si
forma così in lui un sentimento vivissimo dello stato di dipendenza
141
in cui si trova, ed egli si abitua a stimarsi per quello che vale, cioè a
non considerarsi che la parte di un tutto, l’organo di un organismo.
»146
Meursault, da questo punto di vista, è un tipico soggetto
“durkheimiano”, anzi forse il più tipico soggetto durkheimiano, è il
piccolo impiegato inserito in un meccanismo sociale rigido e
regolato, è un piccolo burocrate senza sogni e senza eccessi di
aspirazione (rifiuta il trasferimento a Parigi).
Come nota Girard una delle ragioni per cui si accoglie senza
protestare lo sbalorditivo messaggio dello Straniero è la modesta
condizione sociale dell’eroe. I piccoli impiegati sono davvero le
vittime più indicate della società moderna e, come tutti quelli della
sua classe, Meursault è esposto a una serie di flagelli sociali che
vanno dalla guerra all’oppressione economica. Se però si guarda
più attentamente, nella tragedia di Camus questo non è preso in
considerazione: nello Straniero, infatti, i modi di oppressione reali
non svolgono ruolo alcuno.
Benché lo scrittore giochi sull’ambiguità, prosegue Girard, o
quantomeno si guardi bene dal dissiparla, il romanzo parla di una
146 E. Durkheim, De la division du travail sociale, F. Alcan, Paris 1983, trad. it. di Fulvia Airoldi Namer,Torino 1971.
142
rivolta individuale non sociale. Ci si chiede di credere che
Meursault è un essere eccezionale, niente affatto il rappresentante
di una classe sociale. Quel che si presume i giudici esecrino in lui è
proprio ciò che lo distingue dagli altri. Disgraziatamente, però,
questa presunta originalità non si manifesta affatto nei suoi atti.
In fin dei conti, Meursault è un piccolo burocrate senza ambizioni
e, in quanto tale, niente lo destina ad essere perseguitato. Le uniche
autentiche minacce che possono incombere su di lui sono le stesse
che incombono su tutti i piccoli burocrati e sulla specie umana in
genere.147
Non possiamo che condividere questa posizione: è la società che
“estranizza” lo Straniero e lo straniero.
Meursault è un uomo qualunque, che vive in maniera qualunque
una vita qualunque con aspirazioni qualunque e con emozioni
qualunque. Le sue preoccupazioni sociali sono quelle tipiche di chi
sente di dover essere sempre all’altezza del suo ruolo perché
costantemente sotto esame, di chi cerca una approvazione sociale
costante e perfino ossessiva:
svegliandomi ho capito perché il principale aveva l’aria scontenta
quando gli ho chiesto i due giorni di libertà: oggi è sabato.
147 R. Girard, cit., pp.44-45.
143
L’avevo per così dire dimenticato, ma nell’alzarmi mi è venuto in
mente. Il mio principale, si capisce, ha pensato che così avrei avuto
quattro giorni di vacanza con la domenica, e questo non poteva
fargli piacere. Ma in fondo non è colpa mia se hanno sotterrato la
mamma ieri invece di oggi, e del resto avrei avuto in ogni modo
vacanza il sabato e la domenica. Naturalmente questo non mi
impedisce di comprendere benissimo il mio principale.148
Oggi ho avuto molto da fare in ufficio. Il principale è stato gentile:
mi ha domandato se non ero troppo stanco e ha voluto anche
sapere che età aveva la mamma. Ho detto: una sessantina d’anni,
per non sbagliarmi e lui, non so perché, ha avuto l’aria di provare
un certo sollievo, e di considerare che era una faccenda
esaurita.149
Meursault è decisamente un uomo qualunque, che scruta negli
occhi degli altri, e principalmente in quelli di chi sta al di sopra di
lui, una approvazione continua: vive le emozioni costanti di chi
cerca apprezzamento negli altri e di chi fa di tutto per non destare
negli altri pensieri o sentimenti negativi che lo possano riguardare:
il principale ha l’aria di provare un certo sollievo e di considerare
148 A. Camus, L’Etranger, cit., pag.25. 149 Ibidem, pag.33.
144
esaurita la “faccenda”, questo lo tranquillizza ed è, in fondo, quel
che maggiormente gli preme in questa situazione.
Meursaul è solo e sempre preoccupato di non infrangere le regole
sociali, nessuna, anche quando questo atteggiamento potrebbe
comportare qualche forzatura giuridica come nel caso della
protezione fornita al macrò suo vicino di casa nella testimonianza
di fronte alla polizia.
Meursaul è comunque solidale perché sa che esserlo è la prima
regola sociale e infrangerla significherebbe chiamarsi fuori dal suo
piccolo mondo, lavorativo, affettivo, sociale, e ambientale.
Durkheim spiega in maniera magistrale questo rapporto osmotico:
dal momento che un corpo di regole è la forma definita che
assumono col tempo i rapporti che si stabiliscono spontaneamente
tra le funzioni sociali, si può dire a priori che lo stato di anomia è
impossibile ovunque gli organi solidali sono sufficientemente ed
abbastanza a lungo in contatto. Infatti essendo contigui essi sono
facilmente avvertiti in ogni circostanza del bisogno che hanno gli
uni degli altri, ed hanno perciò la consapevolezza viva e continua
della loro mutua dipendenza. Per la stessa ragione gli scambi tra
di essi avvengono facilmente; essendo regolari, sono anche
frequenti; si regolarizzano da soli ed il tempo completa a poco a
145
poco l’opera di consolidamento. Infine, dal momento che le minime
reazioni possono venir risentite da ogni parte, le regole che così si
formano ne recano l’impronta; esse prevedono e stabiliscono nei
minimi particolari le condizioni dell’equilibrio. Se invece tra le
parti si interpone un mezzo opaco, soltanto le eccitazioni dotate di
una certa intensità possono comunicarsi da un organo a un
altro.150
Le regole sociali sono per Meursault doveri cui conformarsi senza
discutere e forse senza nemmeno accorgersi di doversi conformare.
Infatti egli non viola mai alcuna regola sociale ma viola
semplicemente una ed una volta soltanto la regola giuridica.
Lo scrittore sa bene questa differenza, è attentissimo a dimostrare
che il suo eroe si conforma pienamente alle regole sociali seppure
“non sta al gioco” perché tende a mascherare, o forse solo a
dissimulare, i suoi sentimenti e mostra un ostentato distacco anche
di fronte alle situazioni estreme, quali la morte della madre, questa
è sì una colpa sociale tanto che lo stesso scrittore nella prefazione
all’edizione americana afferma che “nella nostra società chiunque
non pianga al funerale di sua madre rischia di essere condannato,
ma aggiunge, ben conscio, che questo è un paradosso.
150 E. Durkeim, De la division du travail social, cit.
146
Lo stesso scrittore sa bene che deve trovare una colpa giuridica
verso cui possa incanalarsi il biasimo sociale e legittimare la
condanna.
E’ vero, molti testimoni, al processo, concordavano nel trovare
biasimevole la sua “freddezza” nella circostanza della morte della
madre: gli è stato chiesto se la mamma si lamentava di me. Lui ha
detto di sì, ma che era un pò la mania di tutti i suoi ospiti quella di
lagnarsi dei loro familiari. ... A un’altra domanda ha risposto che
era rimasto stupito della mia calma il giorno dei funerali. Gli è
stato chiesto che cosa intendesse per calma. Allora si è guardato le
punte della scarpe e ha detto che io non avevo voluto vedere la
mamma, non avevo pianto neppure una volta e me ne ero andato
immediatamente dopo i funerali senza raccogliermi sulla tomba.
.... Arrivando il portiere mi ha guardato e ha girato gli occhi
dall’altra parte. Ha detto che non avevo voluto vedere la mamma,
che avevo fumato, che avevo dormito e bevuto caffelatte. Allora ho
sentito che qualcosa sollevava la sala e per la prima volta ho
compreso che ero colpevole. Hanno fatto ripetere al portiere la
storia del caffelatte e quella delle sigarette. Il P.M. mi ha guardato
con una luce ironica negli occhi. A questo punto il mio avvocato ha
chiesto al portiere se non aveva fumato anche lui con me. Ma il
147
P.M. si è opposto con violenza a questa domanda. ... Malgrado ciò
il presidente ha chiesto al portiere di rispondere alla domanda. Il
vecchio ha detto con grande imbarazzo: so bene che ho sbagliato.
Ma non ho osato rifiutare la sigaretta che mi ha offerto il
signore.151
Meursault riconosce, dunque, di essere “colpevole” di non aver
pianto, di aver fumato, di aver bevuto caffelatte e persino di aver
dormito; anche il portiere riconosce di aver “sbagliato” ad aver
fumato, ma solo perché indotto da Meursault.
Entrambi hanno infranto delle regole sociali? Non crediamo di
poterci spingerci al punto di poterlo affermare, eppure l’uno si
dichiara “colpevole, e l’altro riconosce di “aver sbagliato”.
La società si difende e prende le distanze nel caso di Meursault, il
quale riconosce peraltro spontaneamente le sue colpe, in quello del
portiere egli stesso ammette il suo errore; forse è vero, come
afferma Camus, che chiunque non pianga al funerale di sua madre
rischia di essere condannato a morte, ma non crediamo alle sue
parole come non crediamo a questo tipo di colpe di Meursault.
La colpa di Meursault, se di colpa si tratta, è decisamente veniale, e
la sua auto-attribuzione –per la prima volta ho compreso che sono
151 A. Camus, L’Etranger, cit., pp.110-111.
148
colpevole- è volutamente paradossale come paradossali sono, e
dichiaratamente, le parole di Camus che attribuiscono al suo eroe
questo tipo di colpe, e questa ammissione è successiva, quando è
ristretto in prigione e si è ormai estraniato dal tipo di vita
precedente.
Come paradossale, oltre che singolare, è la notazione del direttore
dell’ospizio il quale attribuisce al protagonista la colpa di aver
mantenuto la calma in una situazione avversa quale la morte della
madre; una colpa il mantenere la calma, non una virtù!
Tutto ciò è certamente paradossale! E non è convincente né la
ricerca della colpa in questo ambito né l’auto-attribuzione della
colpa. Semplicemente perché non vi è colpa, perché non vi è stata
violazione di una regola sociale: fumare, bere caffellatte, non
piangere, dormire, non è colpevole e neppure riprovevole, perché,
come direbbe Durkheim, tutto questo non “urta contro gli strati
forti e definiti della coscienza collettiva”, o anche non è un “fatto”
sociologicamente rilevante.
La verità, la colpa, il biasimo vanno cercati altrove.
Come nota Alfredo Verde a questo punto il giudice istruttore passa
dall’indagine sul reo a quella sul fatto senza logica apparente. Ma
la logica, come afferma l’autore, c’è e si potrebbe esprimerla così:
149
se questa canaglia non amava sua madre allora può aver ucciso a
sangue freddo, e a sangue freddo aver finito la sua vittima, dopo
essersi accertato di averla colpita.152 Il giudice allora si smaschera e
ricorre alla religione,:
con una voce tutta mutata, quasi tremante, ha gridato: e questo lei
lo conosce. Ho detto: sì, naturalmente. Allora mi ha detto in modo
rapido e concitato che lui credeva in Dio; era convinto che nessun
uomo fosse tanto colpevole che Dio non lo perdonasse, ma
occorreva, per questo, che l’uomo attraverso il pentimento
diventasse come un bambino la cui anima è vuota e pronta a tutto
accogliere. .... Ha ricominciato a parlarmi ancora una volta, eretto
in tutta la sua persona, e mi ha chiesto se credevo in Dio. Io gli ho
risposto di no. Si è seduto indignato. Mi ha detto che era
impossibile, che tutti gli uomini credono in Dio, anche quelli che se
ne allontanano. Era convinto di questo e se mai avesse dovuto
dubitarne, la sua vita non avrebbe avuto più alcun senso. Vuole, ha
esclamato, che la mia vita non abbia senso? A me questo non
riguardava e gliel’ho detto. .... Come faccio sempre quando voglio
liberarmi di qualcuno che mi secca ascoltare, l’ho guardato con
l’aria di essere d’accordo. Con mio grande stupore il giudice si è
152 A. Verde, “L’assassino innocente”, cit., pag.103.
150
entusiasmato. Lo vedi, lo vedi, si è messo a dire, non è vero che
credi e ti confiderai a Lui?. Naturalmente ho detto ancora una
volta no. Il giudice è rimasto nella sua poltrona153.
Ecco finalmente emergere una colpa sociale; come nota acutamente
Verde se qualcuno non crede, se così facendo si pone come
estraneo alla comunità, ai devoti a Dio e allo stato, come straniero,
il giudice non può capirlo, può soltanto annientarlo, di fronte alla
minaccia del “non senso”, dell’ignoto, della psicosi. Qui si vede,
conclude l’autore, come la società utilizzi i meccanismi punitivi al
fine di rinsaldare il senso di identità e di appartenenza dei suoi
membri legittimi. Il desiderio del giudice è la difesa in virtù della
quale, ed attraverso la quale, la società si permette di punire.154
L’orizzonte dal nostro punto di vista si rischiara sempre di più: è un
problema tutto sociologico quello che perde Meursault, è una colpa
sociale quello che lo conduce verso la condanna.
Meursault è un uomo normale, persino troppo normale per poter
aspirare a difendersi in qualche modo di fronte alla reazione
dell’intera società; Meursault lo capisce perfettamente e non tenta
in alcun modo alcuna difesa, reagisce isolandosi dal contesto
153 Ibidem, pag.104. 154 A. Verde, “L’Assassino innocente”, cit., pp.104-105-.
151
sociale, pure da quello affettivo, con la forza dell’indifferenza, ed
anche il contesto sociale reagisce allo stesso modo: mi ha chiesto
soltanto [il giudice], sempre con quell’aria un pò strana, se mi
dispiaceva quel che avevo fatto. Ho riflettuto un pò e ho detto che
piuttosto che dispiacere provavo una certa noia. Ho avuto
l’impressione che non mi capisse. Ma quel giorno le cose si sono
fermate lì.155
C’era tuttavia una cosa che mi metteva a disagio. A volte,
nonostante le mie preoccupazioni, ero tentato di intervenire, e
allora l’avvocato mi diceva: stia zitto, che è meglio per lei. In un
certo qual modo avevano l’aria di trattare la cosa al di fuori di me.
Tutto si svolgeva senza il mio intervento. Si decideva la mia sorte
senza chiedere il mio parere. Di tanto in tanto avevo voglia di
interrompere tutti quanti e dire: ma insomma chi è l’accusato qui.
E’ una cosa importante, essere accusato. E io ho qualcosa di dire.
Ma dopo averci riflettuto un pò, non avevo nulla da dire.156
E tutto questo perché Meursault è uno straniero, anzi è lo Straniero.
E’ l’altro da cui la società, un certo tipo di società, deve difendersi
attraverso il suo braccio armato, la giustizia e i suoi giudici.
155 A. Camus, L’Etranger, cit., pag.87. 156 Ibidem, pag.121.
152
Certo, lo ribadiamo, un certo tipo di società, cioè quel tipo di
società di cui i giudici sono i garanti principali.
Girard precisa assai bene questa situazione quando afferma che è
vero che Meursault non piange al funerale di sua madre, ed è
appunto questo tipo di comportamento che i suoi vicini non
mancheranno di criticare, ma fra queste critiche e il patibolo c’è un
abisso che non sarebbe mai varcato se Meursault non commettesse
un delitto. Nemmeno il giudice più feroce potrebbe nulla contro di
lui se questi non avesse ucciso un uomo.157
La trama narrativa è costruita da Camus in modo tale non da
raccontare una storia ma da creare emozioni, schieramenti,
partigianerie, e tutte a favore del suo eroe; l’Autore vuole, alla fine,
indurre il lettore ad assolvere il reo e a condannare i giudici.
E’ questa l’opinione di Girard, che si spinge ad affermare che l’eroe
è condannato a morte non per il delitto di cui è accusato e di cui è
realmente colpevole, ma a causa della sua innocenza, che il delitto
non ha intaccato e che deve restare visibile agli occhi di tutti come
se fosse l’attributo di una divinità.158 Secondo questo autore Camus
ha voluto, in sostanza, dimostrare che l’eroe che segue il proprio
157 R. Girard, Il risentimento, cit, pag.39. 158 Ibidem, pag.47.
153
cuore viene necessariamente perseguitato dalla società. In altre
parole, conclude l’autore, ha voluto dimostrare che i giudici hanno
sempre torto.
Non crediamo di poter condividere fino in fondo questa opinione,
anzi per molti versi dissentiamo da questa, seppure riconosciamo
trattarsi di una tesi largamente condivisa; comunque a noi questa
interpretazione pare “sociologicamente” debole. Intanto perché
Meursault è sicuramente colpevole del delitto commesso, e questo
è incontestabile: il giudice di fronte all’evidenza non può che
condannare. Si potrà obiettare che ciò non è sempre vero, e che il
suo libero convincimento può indurlo anche di fronte all’evidenza
più plateale, come in questo caso, a dare al fatto una qualificazione
giuridica differente, a decidere in maniera differente da questa e
persino assolvere.
Sicuramente, questo è indiscutibile. Il libero convincimento del
giudice è la regola prima di ogni giudizio.
Ma, allora, la domanda si fa più specifica e più capziosa: perché la
corte ha deciso per la colpa più grave ed ha comminato la pena di
morte?
Le risposte, a nostro avviso, sono molteplici.
154
Una prima risposta riguarda proprio la struttura stessa dell’opera:
Camus ha scelto piani descrittivi differenti, ha combinato il piano
del reale con quello dell’irreale, del fantastico con quello del
concreto, della speranza con quello della certezza, dell’essere con
quello del dover essere e persino quello dell’essere con quello del
voler essere. Meursault ha commesso un delitto, in piena
coscienza, volontariamente, quasi programmandolo pur nella
brevità temporale dell’intenzione, eppure Camus tende a
giustificarlo.
Certo, ci rendiamo conto, che tutta la vicenda si gioca sul “quasi”, e
Camus proprio su questo costruisce l’induzione del lettore alla
benevolenza verso il suo eroe, l’induzione alla tolleranza,
l’induzione al perdono. Si percepisce in ogni attimo dell’opera la
simpatia dell’Autore per il suo personaggio: è l’insensibilità dei
giudici e del pubblico ministero a volerlo condannare alla pena
capitale.
I piani descrittivi, in questo modo, si invertono: il mondo del
desiderio e della convinzione personale diventano il mondo reale, o
perlomeno quello che l’Autore intende trasmettere al suo lettore; il
mondo reale diventa l’occasione per poter esprimere un giudizio
155
negativo sui giudici e sull’apparato repressivo che segue alla
sentenza.
E alla fine i due piani finiscono per confluire in un grande sogno,
anche questo in bilico tra realtà e immaginario, quello della libertà,
e della speranza di libertà e della morte; un grande sogno in cui il
protagonista diventa il padre di Meursault, finora del tutto estraneo
all’azione, e anch’egli diventa il protagonista di un sogno del
sogno:
in quei momenti mi sono ricordato di una storia che la mamma mi
raccontava a proposito di mio padre. Io non avevo mai conosciuto
mio padre. L’unica cosa precisa che sapevo di quest’uomo è forse
ciò che mi raccontava allora la mamma: era andato un giorno a
vedere l’esecuzione di un assassino. Era stato male solo al
pensiero di andarci, ma c’era andato ugualmente e, al ritorno,
aveva vomitato a lungo. A quel tempo mio padre mi faceva un pò
schifo. Adesso comprendevo, era una cosa così naturale, Come
facevo a non comprendere che nulla è più importante di
un’esecuzione capitale e che, da un certo punto di vista è
addirittura l’unica cosa che sia veramente interessante per un
uomo.159
159 A. Camus, L’Etranger, cit, pag.135.
156
Questa sovrapposizione di piani descrittivi giustifica e legittima
una sovrapposizione e una inversione di piani di giudizio: i giudici
comminano la pena capitale ma l’eroe rimane tale anche dopo la
sentenza perché sul piano ideale è e rimane comunque l’eroe: è
questa la scelta di Camus.
Una seconda risposta è tutta giocata sul piano del reale: i giudici
giudicano un soggetto che per una larga parte della sua vita ha
incarnato il ruolo del piccolissimo borghese, tutto casa, lavoro,
amore e piccola quotidianità e che ad un tratto le circostanze
rendono assassino. Né vale, come taluno ha fatto, invocare il
Destino; l’evento è una scelta personale del protagonista, anche
solo sotto il profilo del dolo eventuale, come direbbero i penalisti; è
una libera scelta del protagonista tornare là proprio dove sa essere
l’arabo, è una scelta deliberata quella di infilare il coltello in tasca,
è una sua scelta personale accanirsi sulla vittima con colpi ripetuti.
Si potrà forse dire che è un delitto d’impeto, che non merita la
condanna capitale, ma comunque una condanna severa certamente
sì, perché è di fatto un delitto senza movente.
In questo caso, com’è logico che sia, i giudici si erigono ad arbitri
del reo e più ancora della società, questo è quanto lascia intendere
continuamente Camus; i giudici nel giudicare Meursault tutelano la
157
società da un soggetto che non ha rispettato le regole giuridiche e
che non “sta al gioco” sociale, come ha affermato lo stesso Autore.
Anche questa seconda interpretazione è, a nostro avviso, plausibile
e persino ineccepibile.
Una terza risposta è forse più banale ma forse la più concreta:
Meursault non è quel solipsista incallito che la scienza
psicoanalitica ha cercato di tramandarci e neppure un soggetto
privo di cuore e di sentimenti come i giudici e i testimoni lo hanno
dipinto. Niente di tutto questo. Egli è, al contrario, un uomo
qualunque, capace di provare le gioie di tutti gli uomini qualunque,
con la stessa intensità di tutti gli altri uomini qualunque; è, infatti,
così che si descrive lui stesso:
infine mi ricordo soltanto che dalla strada, attraverso tutte le sale e
le aule, mentre il mio avvocato continuava a parlare, ha risuonato
fino a me la trombetta di un venditore di panna. Mi hanno assalito
i ricordi di una vita che non mi apparteneva più, ma in cui avevo
trovato le gioie più povere e più tenaci: odori d’estate, il quartiere
che amavo, un certo cielo di sera, il riso e gli abiti di Maria.160
Come non credere alle sue stesse parole? Meursault è un uomo
dalle gioie “povere” e “tenaci”; è il prototipo dell’uomo qualunque,
160 Ibidem, pag.129.
158
del borghesuccio che conduce una vita modesta e che aspira a gioie
modeste ma “tenaci”, è un uomo che rispetta le amicizie anche se
queste sono talora un pò equivoche e ingombranti, è un uomo che
cerca di compiacere gli altri per ricevere consenso sociale, il capo-
ufficio, gli amici, la fidanzata. E’ in una parola un uomo che cerca
negli altri la ragione della sua vita.
E’ da qui che nasce il suo delitto: l’aver scelto di difendere una
situazione oggettivamente indifendibile, quella di un piccole lenone
di periferia che per aver picchiato la sua protetta si è attirato le ire
dei familiari di questa; ma il lenone è pur sempre un suo amico e
Meursault cerca la solidarietà dei suoi amici, ne cerca
l’approvazione, sa che deve dare per poter ricevere, anche se il dare
in qualche caso può essergli pregiudizievole; ma si tratta pur
sempre di suoi amici e rappresentano il suo mondo, piccolo, brutto
e quotidiano, ma il suo mondo.
Anche in questo Meursault è uno straniero, anzi lo Straniero.
Condividiamo in questo l’opinione di Alfredo Verde secondo cui la
reazione sociale ha per conseguenza di trasformare l’autore della
trasgressione in “straniero”, in “impuro”, in “rinnegato”, vale a dire
in un essere per cui qualsiasi idea di partecipazione al gruppo ha
159
perso il suo senso, dimodochè una sanzione di esclusione o di
rifiuto deriva in modo del tutto naturale da tale stato di fatto.161
Sul concetto di esclusione buona parte della sociologia della
devianza americana, quella di matrice funzionalistica ovviamente,
ha costruito i suoi paradigmi, che in questo caso crediamo si
adattino alla perfezione.
Per riferirci alla sintesi proposta da Tamar Pitch la teoria della
devianza ha un ruolo centrale nella teoria del sistema sociale, in
quanto la dimensione della conformità e delle deviazione è inerente
all’intera concezione dell’azione sociale, la complementarietà delle
aspettative di ruolo, in base a cui l’azione acquista significato e
viene compresa, implica l’esistenza di criteri comuni di definizione
di quello che è il comportamento accettabile e in qualche senso
approvato. Il problema classico dell’ordine, prosegue l’autrice, è
risolto da Parsons mediante un complesso schema categoriale,
presunto valido per ogni sistema sociale. La struttura della società
consiste, infatti, per questo autore, di modelli di cultura normativi,
istituzionalizzati al livello del sistema sociale e interiorizzati nella
161 A. Verde, “L’assassino innocente”, cit. pag.122.
160
personalità mediante i processi di educazione e di
socializzazione.162
In questa logica, che a nostro avviso Meursault condivide in pieno,
il meccanismo dell’interazione sociale è vincolato alle aspettative
degli altri e alla gratificazione che questa aspettative sia soddisfatta.
Come nota la Pitch in questo caso il problema hobbesiano
dell’ordine si risolve in una interpretazione di personalità e sistema
sociale mediante il valore, criterio di definizione del ruolo ed
insieme alla base della struttura motivazionale della personalità. E
pertanto in un sistema di azione in cui la motivazione è la ricerca
della gratificazione e in cui questa è assicurata nella misura in cui si
seguono certi modelli di comportamento definiti da certi valori
condivisi dall’alter o dagli alii, i quali sono, in ultima analisi i
dispensatori di sanzioni positive o negative, l’uniformità di
comportamento sembra assicurata “naturalmente” come afferma lo
stesso Parsons in quanto “l’aderenza ad un qualsiasi criterio di
valore interiorizzato dall’ego rappresenta una gratificazione di suoi
162 T. Pitch, La devianza, La Nuova Italia, Firenze 1975 1ˆ ed. , pag. 97. Il riferimento è al notissimo volume di Talcott Parsons, The Social System, Glencoe 1951, trad. it. di A. Cottino, Ed. di Comunità, Milano 1965.
161
bisogni e il mezzo per sollecitare le reazioni favorevoli di altri
membri del sistema”.163
Come specifica l’autore americano “le norme che determinano
l’azione sono delle aspettative collettive di comportamento” e
pertanto “l’agire sociale è dato soltanto in rapporto al sistema di
modelli culturali trasmessi, in cui si articola l’autocomprensione
sociale”164
Questo rapporto tra azione e aspettativa sociale è visto in maniera
totale anche da un autore assai distante dal modello funzionalistico,
Jurghen Habermas, il quale afferma che “il senso orientante ha la
forma di un’aspettativa obbligatoria di gruppo relativa ai modi di
comportamento in situazioni specifiche”165
Per questa linea, e pur tra le numerose e sostanziali differenze che
intercorrono tra le posizioni di Parsons e di Merton, e che non è qui
il caso di riproporre, il notissimo schema mertoniano dell’anomia si
muove anch’esso nell’ambito del rapporto tra mezzi e fini166, e
163 Ibidem, pp.97-98. 164 T. Parsons, The Social System, cit 165 J. Habermas, La logica delle scienze sociali, trad. it. di G. Bonazzi, Il Mulino, Bologna 1970, pag.24. 166 R. K. Merton, Social Theory and Social Structure, Glencoe, The Free Press, 1957, ed. it. a cura di Filippo Barbano Teoria e struttura sociale, Il Mulino, Bologna 1966, pag.224.
162
come nota Tamar Pitch nell’approccio strutturale-funzionale il
deviante è il disadattato, l’origine del suo disadattamento è
psicologica, da ritrovarsi in un difetto di socializzazione che ne ha
strutturato la personalità sulla base di bisogni-disposizioni aventi
tendenze negative verso il sistema di aspettative condivise.167
Devianza significa, dunque, esclusione sociale e quindi estraneità.
Precisiamo subito che, da posizioni conflittualistiche, non
condividiamo assolutamente questa proposta e questa
interpretazione, anzi decisamente la contrastiamo, ma siamo
altrettanto convinti che al di là dei nostri gusti scientifici non
possiamo non convenire che l’intero costrutto mentale e descrittivo
proposto da Camus rientra perfettamente in questo ambito teorico,
in questa situazione e in questa logica sociale.
Tutto, d’altra parte, conduce e induce a questa conclusione.
In primo luogo l’atteggiamento stesso di Meursault che fino ad un
buon tratto di cammino della sua vita è attento alle aspettative
dagli altri e su queste modula il proprio comportamento: si presenta
alla veglia funebre, com’è convenzione, con la cravatta nera e la
Per una analisi più approfondita del mio intendimento sul punto mi permetto di rimandare al mio saggio “Il conflitto nella diversità. Un’analisi sociologica”, in AA.VV. Diritto, Lavoro, Alterità Figure della diversità e modelli culturali, a cura di F.A. Cappelletti e L. Gaeta, E.S.I., Napoli 1998, pp.179-204.
163
fascia al braccio, accetta di sposare Maria perché lei lo voleva,
anche se questo poi non avverrà, è pieno di comprensione verso il
piccolo sfruttatore di prostitute suo vicino di casa, perché, in fondo,
è un suo amico, lo ascolta nella descrizione della rissa in cui questi
è stato coinvolto e solidarizza con lui al punto da scrivere una
lettera alla “ragazza” di lui piena di insulti e di minacce (adesso, tu
sei un vero amico. Ha ripetuto la frase e io ho detto: sì), solidarizza
anche con il vecchio Salamano, anche se si percepisce che non lo
apprezza affatto, ma tant’è anche lui è un suo “amico”.
Sì certo rifiuta un buon trasferimento di lavoro a Parigi ma solo
perché non vede la ragione di un cambiamento di vita così radicale
dal momento che questo tipo di vita non gli dispiace (a pensarci
bene non ero infelice), anzi dopo essere stato costretto ad
abbandonare gli studi molto presto ed essere stato costretto a
ridimensionare le proprie ambizioni quel tipo di vita non lo
scontentava affatto.
Meursault fino all’episodio dell’omicidio rientra perfettamente in
questo schema, da questo episodio in avanti egli diventa altro.
Altro agli altri.
167 T. Pitch, La devianza, cit., pag.101.
164
Da questo momento in avanti non vuol più compiacere nessuno,
diventa estraneo al sistema, non ne condivide più i “valori”, il suo
agire si diversifica dalle aspettative del sistema stesso, e quindi
dalle aspettative degli “altri”.
I giudici diventano ai suoi occhi i custodi del sistema, dell’apparato
che fino ad allora gli è appartenuto e che adesso gli è estraneo, anzi
“straniero”, ed anche il prete è il custode di questo stesso apparato
che egli rifiuta. Giudici e sacerdoti, ciascuno nel proprio ruolo,
rappresentano le garanzie più visibili di questo meccanismo da cui
egli si allontana. Volontariamente, con fermezza, consapevole delle
conseguenze cui va incontro.
Giudici e sacerdoti che tentano di riportarlo all’interno del sistema,
del loro sistema, di un medesimo, identico sistema.
Il giudice istruttore fa appello alla sua fede per trasmettergli un
messaggio di clemenza: purchè creda in Dio, è in questo preciso
istante che scatta in Meursault la reazione più violenta trovando il
coraggio di negare di credere in Dio anche se sa che questo gli sarà
pregiudizievole perché questa è l’ultima chance di clemenza che il
giudice gli offre: ma a quel momento lui ha l’esatta percezione di
essere lo Straniero:
165
ha cominciato: io non ho mai visto un’anima altrettanto incallita
come la sua. I criminali che sono venuti dinanzi a me hanno
sempre pianto di fronte a questo simbolo del dolore [ il
crocefisso]. Stavo per rispondere che era precisamente perché si
trattava di criminali. Ma poi ho pensato che anch’io ero come loro.
Dopo questo interrogatorio il giudice istruttore ha mutato
comportamento, Meursault ai suoi occhi è diventato un estraneo e
come tale lo ha abbandonato al suo destino:
in seguito ho rivisto spesso il giudice istruttore. Solo che, tutte le
volte, l’avvocato mi accompagnava. Si limitavano a farmi
precisare certi punti delle mie precedenti dichiarazioni, oppure il
giudice discuteva con l’avvocato i capi d’accusa. Ma in realtà in
quei momenti non si occupavano affatto di me. A poco a poco,
comunque, il tono degli interrogatori è mutato. Pareva che il
giudice non avesse più interesse per me e avesse in un certo qual
modo archiviato il mio caso.
Meursault è stato “archiviato” dal giudice istruttore quando si è
reso estraneo al sistema, così come è stato archiviato dal prete:
aveva gli occhi pieni di lacrime; si è voltato ed è scomparso.
E’ lo stesso Meursault che spiega la sua metamorfosi, con una
lucidità stupefacente:
166
...ero sicuro di me, sicuro di tutto, più sicuro di lui [del prete],
sicuro della mia vita e di questa morte che stava per venire. Sì, non
avevo che questo. Ma perlomeno avevo in mano questa verità così
come essa aveva in mano me. Avevo avuto ragione, avevo ancora
ragione, avevo sempre ragione. Avevo vissuto in quel modo e avrei
potuto vivere in quest’altro. Avevo fatto questo e non avevo fatto
quello. Non avevo fatto una tal cosa mentre ne avevo fatto una tal
altra. E poi era come se avessi atteso sempre quel minuto ... e
quell’alba in cui sarei stato giustiziato. Nulla, nulla aveva
importanza e sapevo bene il perché. E anche lui [il prete] sapeva
perché. Dal fondo del mio avvenire, durante tutta questa vita
assurda che avevo vissuta, un soffio oscuro risaliva verso di me
attraverso annate che non erano ancora venute e quel soffio
uguagliava, al suo passaggio, ogni cosa che mi fosse stata
proposta allora nelle annate non meno irreali che stavo vivendo.
Cosa mi importavano la morte degli altri, l’amore di una madre,
cosa mi importavano il suo Dio, le vite che ognuno si sceglie, i
destini che un uomo si elegge, quando un solo destino doveva
eleggere me e con me miliardi di privilegiati che, come lui [il
prete], si dicevano miei fratelli? Capiva, capiva [il prete] dunque?
Tutti sono privilegiati. Non ci sono che privilegiati. Anche gli altri
167
saranno condannati un giorno. Anche lui [il prete] sarà
condannato. Che importa se un uomo accusato di assassinio è
condannato a morte per non aver pianto ai funerali di sua
madre?168
Meursault capisce di essere “estraneo” al suo stesso mondo di poco
tempo prima, al “sistema” cui ha aderito con soddisfazione, è
estraneo a se stesso. Anche Maria, l’ultimo pensiero, quello più
forte e più bello che lo ha legato alla sua vita di prima, fugge e
cambia:
per la prima volta da molto tempo ho pensato a Maria. Erano lungi
giorni che non mi scriveva più: quella sera ho riflettuto e mi sono
detto che forse si era stancata di essere l’amante di un condannato
a morte. Mi è venuta anche l’idea che forse era malata o morta.
Era nell’ordine delle cose. Certo non l’avrei saputo perché al di
fuori dei nostri corpi ormai divisi nulla ci legava o ci ricordava
l’un l’altro, e del resto a partire da quel momento, il ricordo di
Maria mi sarebbe stato indifferente. Morta, non mi interessava più.
Questo, lo trovavo normale, così come il fatto che gli altri mi
dimenticheranno dopo che sarò morto. Non avranno più nulla a
che fare con me. Non posso nemmeno dire che fosse duro a
168 A. Camus, L’Etranger, cit, pp.147-148.
168
pensarci. In fondo non c’è idea cui non si finisca per fare
l’abitudine169.
Meursault a partire da quel momento è diventato definitivamente
estraneo agli altri, e più ancora a se stesso!
Da questo momento non si attribuisce più alcuna colpa se non
quella di essere stato condannato a morte per non aver pianto ai
funerali di sua madre.
E’ in questo momento che diventa vittima della società!
E’ quel che intende, a nostro avviso, Camus quando afferma che
chiunque si comporti come Meursault rischia di essere condannato
a morte. Ma non dai giudici ma dalla società stessa, di cui i giudici
sono i custodi, o alcuni dei custodi più influenti e rappresentativi.
Meursault è dunque uno straniero, anzi lo Straniero perché non ha
più alcun diritto di cittadinanza in quella società, proprio in quella
società che fino a poco prima ha amato e lo ha reso, a suo modo,
felice e in cui è stato, a suo modo, felice.170
Ci sentiamo di condividere, almeno in parte, l’accostamento
dell’idea dello straniero di Camus con quella di Carl Schmitt
avanzato da Alfredo Verde con particolare riferimento al concetto
169 Ibidem, pag.141. 170 ... ho sentito che ero stato felice. A. Camus, L’Etranger, cit. pag.150.
169
di amico-nemico proposto dall’autore tedesco quando identifica il
“nemico” nello “straniero”171 inquadrando il “nemico” “soltanto in
colui che mi può mettere in questione. Riconoscendolo come
nemico, riconosco che egli mi può mettere in questione. E chi può
mettermi realmente in questione? Solo io stesso. O mio fratello.
Ecco, l’Altro è mio fratello. L’altro si rivela fratello mio, e il
fratello mio nemico. Adamo ed Eva ebbero due figli, Caino e
Abele. Così comincia la storia dell’umanità. Questo è il volto del
padre di tutte le cose. Questa è la tensione dialettica che tiene in
moto la storia del mondo, e la storia del mondo non è ancora alla
fine”172.
Meursault è dunque l’altro! Rispetto al se stesso di prima, rispetto
agli altri, rispetto alla società!
Non ha più alcun diritto di cittadinanza nella “sua” società.
Non è più parte di quel mondo, un “mondo che mi era ormai
indifferente per sempre”
Senza voler entrare, se non tangentalmente, nel vessatissimo
problema della cittadinanza che da sempre agita i sonni degli
171 C. Schmitt, Il concetto di politico (1932), in Le categorie del politico, ed. it. a cura di Gianfranco Miglio e Pierangelo Schiera, Il Mulino, Bologna 1972. 172 C. Schmitt, La sapienza della cella, in Ex captivitate salus (1950), ed. it., Adelphi, Milano 1987.
170
studiosi di diritto, e di quelli dei filosofi e dei sociologi del diritto, e
maggiormente da circa un cinquantennio sulla scia del notissimo
saggio di Thomas H. Marshall173 che ha ridato uno straordinario
vigore agli studi di questo argomento, ai fini della nostra indagine
attuale, ed in linea rispetto a quanto abbiamo fin qui sostenuto, ci
sentiamo in animo di condividere in pieno la proposta di Danilo
Zolo secondo cui la cittadinanza opera nell’ambito della sovranità
dello Stato moderno, e cioè come una forma politica nazionale,
territoriale e burocratica. E’ vero che la teoria giusnaturalistica
concepisce i diritti di cittadinanza come diritti naturali e universali
di cui ogni uomo è titolare in quanto membro di una comunità
politica. Nella realtà, tuttavia -aggiunge l’autore- la prestazione
delle garanzie giuridiche e dei concreti vantaggi collegati alla
titolarità della cittadinanza è regolata dal codice politico dello Stato
sovrano, e cioè da un codice funzionale fortemente differenziato
che ha al proprio centro l’istanza particolaristica della sicurezza,
non quella universalistica dell’uguaglianza degli uomini e della
173 T. H. Marshall, Citizenship and Social Class (1950), in T.H. Marshall, Class, Citizenship and Social Development, The University of Chicago Press, Chicago 1964, trad. it. Cittadinanza e Classe Sociale, Utet, Torino 1976.
171
giustizia. E ciò sottopone l’universalismo dei diritti sia a regole di
esclusione che a regole di subordinazione.174
E’ proprio questo aspetto, quello della sicurezza personale e
collettiva, e non già quello utopistico e onirico della uguaglianza,
su cui si allinea, anche a nostro avviso, il concetto di cittadinanza e
di inclusione sociale e inversamente quello di esclusione e di
estraneità.
Lo stesso Zolo ha precisato ancor più diffusamente questo concetto
affermando che il sistema politico “concentrato” ha la facoltà di
emanare decisioni vincolanti, tutelate in ultima istanza dall’uso
della forza. Esso si pone così al centro di una rete di relazioni
asimmetriche fra soggetti detentori di potere e soggetti subordinati
attraverso la quale vengono allocati i fattori della sicurezza sociale.
Chi detiene il potere –e tanto più quanto maggiore è il suo potere- è
in grado di garantire la propria sicurezza e, nello stesso tempo, di
regolare le aspettative di sicurezza dei soggetti subordinati e
obbedienti, decidendo di volta in volta determinate distribuzioni dei
rischi e delle assicurazioni politiche.
174 D. Zolo, “La strategia della cittadinanza”, in AA.VV., La Cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti, a cura di Danilo Zolo, Laterza, Roma-Bari 1994, pp. 18-19.
172
Da questo punto di vista –prosegue l’autore- il sistema politico
svolge una funzione di protezione simbolica molto al di là delle sue
specifiche prestazioni in quanto apparato di regolamentazione
selettiva dei rischi sociali. Non c’è dubbio che la protezione della
vita fisica, la tutela giuridica della proprietà e dei contratti.........
sono meccanismi specifici di riduzione della paura. Ma è
soprattutto sul piano simbolico che le istituzioni di autorità, con il
loro apparato di procedure, di riti, di rappresentazioni allegoriche,
di mitologie, di codici normativi e persino di galatei e di etichette
soddisfano il bisogno latente di protezione sociale: un bisogno
irrazionale o “residuale”, per usare il lessico della sociologia
paretiana. Nella misura in cui corrispondono all’esigenza
psicologica di affidamento ad una autorità superiore, di adesione a
valori collettivi e di alleggerimento del senso di responsabilità
individuale gli apparati simbolici della politica diffondono una
gratificante sensazione di ordine e di sicurezza.
Nella valutazione dei comportamenti politici –conclude l’autore- è
fuorviante la stessa alternativa moralistica fra egoismo e altruismo,
fra ricerca dell’utile privato e dedizione al bene pubblico, fra
incentivi selettivi e motivazioni solidaristiche. In realtà ciò che
distingue la razionalità funzionale del sistema politico ed è alla
173
base delle motivazioni degli attori politici è essenzialmente il
valore della sicurezza. E la ricerca della sicurezza motivata
dall’impulso soggettivo di avversione al rischio, conduce a risultati
sociali che, pur essendo ben lontani dagli ideali della solidarietà,
dell’equità o dell’eguaglianza possono almeno offrire il beneficio
della stabilità e dell’ordine.175
E’ sulla base di questo principio di sicurezza che la società si
difende
Lo chiede a gran voce il pubblico ministero nel corso della sua
arringa:
... quando si tratta di questa Corte, la virtù tutta negativa della
tolleranza deve ceder il passo a quella meno facile ma più elevata
della giustizia. Soprattutto quando il vuoto dell’animo quale si
ritrova in quest’uomo diventa un abisso dove la società può perire.
E i giudici hanno accolto in pieno questa tesi: la condanna a morte
è la logica conclusione del processo di “stranierizzazione” cui si è
avviato lo Straniero.
E’ a questo punto e solo a questo punto che Meursault riconquista,
o forse conquista per la prima volta nella sua vita, una qualche
175 D. Zolo, Il principato democratico, Feltrinelli, Milano 1992, pp.68-70.
174
forma di considerazione sociale, pur negativa che sia ma pur
sempre una considerazione forte:
... il presidente mi ha detto in una forma strana che mi sarebbe
stata tagliata la testa in una pubblica piazza in nome del popolo
francese. Mi è parso allora di riconoscere il sentimento che
leggevo su tutti i volti: credo proprio che fosse rispetto.
E’ il rispetto della considerazione, come negarlo? Meursualt lo
percepisce appieno: i gendarmi mi guardavano con molta dolcezza.
Meursault non è più un pericolo, per nessuno, verso di lui ci si può
perfino abbandonare a sentimenti di rispetto e di tenerezza perché è
ormai innocuo, è fuori da qualsiasi situazione sociale, è solo un
condannato in attesa di esecuzione.
Non sembri irriverente ma come non provare un forte moto di
simpatia verso il cane di Salamano?
lo spaniel ha una malattia della pelle, la rogna credo, che gli fa
perdere quasi tutto il pelo e lo copre di placche e di croste scure. A
forza di vivere con lui, tutt’e due insieme in una stanzetta, il
vecchio Salamano ha finito per somigliargli. Ha delle croste
rossastre sul viso e pelo giallo e rado. Il cane, da parte sua, ha
preso dal padrone un modo di camminare tutto curvo, col muso in
avanti e il collo teso. Sembrano della stessa razza e tuttavia si
175
detestano. Due volte al giorno alle undici e alle sei, il vecchio
porta il suo cane a passeggio. Si può vederli lungo la rue di Lyon,
il cane che tira l’uomo fino a che Salamano inciampa; allora il
vecchio bastona il cane e lo insulta. Il cane s’accovaccia per il
terrore e si impunta. A questo punto tocca al vecchio tirarlo.
Quando il cane non se ne ricorda più, ricomincia a tirare il
padrone e di nuovo è battuto e insultato. Allora restano tutt’e due
fermi sul marciapiede e si stanno a guardare, il cane pieno di
terrore, l’uomo di odio. E così tutti i giorni..... Sono otto anni che
dura questa storia ....... quando l’ho incontrato per le scale,
Salamano stava insultando il cane. Gli diceva: maledetto, carogna
e il cane gemeva. Io ho detto: buon giorno, ma il vecchio ha
continuato a insultarlo. Allora gli ho chiesto cosa aveva fatto il
cane. Lui non mi ha risposto. Diceva soltanto: maledetto, carogna.
Era chino sul cane e doveva essere occupato a sistemargli
qualcosa nel collare. Ho parlato più forte. Allora, senza voltarsi,
mi ha risposto con una specie di furia repressa: è sempre qui176.
Il cane di Salamano è sempre strato uno “straniero” per il suo
padrone, lo ha preso proprio per poterlo insultare, malmenare e
sfogare su di lui quella rabbia che non ha più potuto sfogare su sua
176 A. Camus, L’Etranger, cit., pp.34-35.
176
moglie, che era morta, e forse è sempre stato uno straniero anche
per se stesso: Ma lo spaniel ha un moto d’orgoglio decide di
riappropriarsi della sua vita, di non essere più lo straniero di
Salamano e decide di sparire ai suoi occhi:
... gli ho chiesto dov’era il suo cane. Mi ha risposto bruscamente
che se n’era andato. E poi di colpo si è messo a parlare con grande
volubilità: l’ho portato in Piazza d’Armi, come il solito. C’era
parecchia gente, là intorno ai baracconi. Io mi sono fermato a
guardare “il re dell’evasione”. E quando ho voluto continuare la
strada, lui non c’era più. Si capisce, era da tanto tempo che volevo
comprargli un collare meno largo, ma non avrei mai creduto che
quella carogna se ne potesse andare così.177
Il cane di Salamano in quel momento ha deciso di smettere d’essere
straniero a se stesso e di riappropriarsi di sé nell’unico modo che gli
è permesso, fuggendo!
Meursault è, invece, e rimane, uno straniero perché ha deciso di
violare volontariamente, senza alcun motivo, la prima regola della
convivenza civile, la più importante, il rispetto fisico dell’altro,
quella la cui violazione fa scattare la reazione sociale più dura:
l’esclusione anche fisica.
177 Ibidem, pag .50
177
Ma di questo non stupiamoci: lo spaniel di Salamano non è un
uomo, è solamente una bestia.
Anche in questo e per questo Meursault è lo Straniero!
178
Studio N. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sommario: 1. Premessa. – 2. Rappresentatività della decisione giudiziaria. – 3. Discrezionalità nel giudizio. Discrezionalità del giudizio. – 4. La prova alla prova. – 5. A mò di conclusione.
1. Premessa Recitano testualmente tutti i codici processuali italiani che “la sentenza è pronunciata «In nome del popolo italiano» e reca l’intestazione «Repubblica italiana»”, e nella pratica del mondo giudiziario è proprio questa la formula con cui l’autorità giudiziaria che la emette licenzia la sentenza stessa. Ebbene, quanto all’indicazione «Repubblica italiana» apposta come intestazione della sentenza non avanziamo alcuna osservazione, è di palese evidenza che indica in via estremamente sintetica e iconografica una serie di situazioni assolutamente, o più prudentemente si potrebbe dire abbastanza, pacifiche: indica innanzitutto un luogo geografico in cui la sentenza è stata pronunciata, la Repubblica italiana appunto, quindi un luogo fisico, poi un luogo simbolico, indicato come il tutto per la parte, che fa riferimento ad un concetto di unitarietà, anch’esso indicato come il tutto per la parte, e quindi l’organo della Repubblica autore della pronuncia inteso, anch’esso con riferimento alla carta fondamentale, ed ancora una situazione simbolica, intesa anche
179
questa retoricamente come il tutto per la parte, ossia la funzione giudiziaria, che prescinde del tutto dal magistrato che materialmente ha emesso la decisione, cioè una pronuncia della magistratura, in sé, e ciò per la considerazione costituzionalmente dichiarata, che la magistratura costituisce un ordine unitario in cui il singolo magistrato è organicamente inserito, e quindi è, o dovrebbe essere178 indifferente, che ad emettere la pronuncia sia questo o quel magistrato di questo o quel luogo fisico. Questo rileva semmai in termini strettamente giuridici ai fini della qualificazione della competenza ma non già ai fini sociologici e sociali in generale, ed indica, infine, la riferibilità alla autorità suprema, politicamente parlando, a cui la pronuncia da ultimo va riportata, la Repubblica italiana appunto. Tutto questo lo diamo per pacifico o quanto meno tendiamo a darlo per pacifico. Il problema, e non possiamo negarlo, sorge, ed in maniera pressante per noi, per l’altra formula, quella che prevede che la sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano; anche in questo caso a voler fare i giuristi formalisti il problema si potrebbe chiudere in pochissime battute, anzi solo facendo riferimento alla Costituzione la quale prevede che la giustizia è amministrata in nome del popolo italiano179,e quindi il frutto di questa attività di amministrazione, la sentenza, non può che essere pronunciata in nome del popolo italiano.
178 Tralasciamo, saltandolo a piè pari, il rilievo, tutto sociologico, che la diversità del luogo in cui avviene la pronuncia riverbera o potrebbe riverberare sostanzialmente in una probabile o comunque possibile diversità di giudizio e quindi di pronuncia. Non è questo il tema del presente lavoro, e se ci soffermassimo anche solo per un attimo su questo punto daremmo la stura ad una tematica talmente diversa da questa e talmente controversa che richiederebbe ben più che un saggio anche solo per la sua enunciazione. 179 Art.101 della Costituzione della Repubblica italiana.
180
Ma noi che giuristi formalisti non siamo, bensì sociologi giuridici, non possiamo accettare come assioma questa equivalenza. Anzi, sorge in noi il problema opposto, quello di capire, prima di tutto, se e in che termini questa equivalenza esista realmente, al di là delle innegabili dichiarazioni dei testi, costituzionale e normativi. In secondo luogo, se questo primo problema dovesse essere risolto in termini, ovviamente per noi, negativi, cioè non aderendo assiomaticamente a questa equivalenza, e volendo considerare questa un puro teorema giuridico, ancorché di altissimo valore in quanto dislocato nella fonte più elevata della nostra normativa, sorge a cascata una serie assai cospicua di problematiche, alcune delle quali non possiamo eludere e che affrontiamo in questo lavoro, pur rendendoci conto, e dichiarando con molta umiltà, che altre, ed altre ancora, se ne potrebbero aprire ed affrontare, ma che se così facessimo non impiegheremmo certo lo spazio di questo lavoro e certamente neppure quello di molti volumi. Il problema, dunque, è, per noi, quello di capire che valore sociologico attribuire alla formula in nome del popolo italiano e quindi che valore sostanziale assegnarle. Il problema, come sempre, si può ben scindere sotto due profili, uno di tipo formale e uno di tipo sostanziale e pur nell’ottica del sociologo che è un’ottica precipuamente, se non esclusivamente, sostanzialista non vogliamo tuttavia trascurare anche un’ottica più propriamente formale, perché anche sotto questo specifico punto di vista si rafforza in noi la convinzione della tesi che andiamo a sostenere. Addirittura se si osservasse la questione dal solo punto di vista formale questa prospettiva sarebbe di per sé redimente rispetto ad ogni altra questione di tipo sostanziale perché si dovrebbe concludere che la formula null’altro esprime se non l’ennesima finzione di cui è pervaso il mondo del diritto, una delle tante fictio, null’altro che una fictio, in base alla quale il popolo, nello
181
specifico, rappresenta o rappresenterebbe un’entità astratta dell’intero processo decisionale, di ogni singolo processo giudiziariamente decisionale, e quindi sostanzialmente dell’archetipo decisionale tout court, cioè un’entità anch’essa astratta, che ha una valenza puramente legittimatoria a tutti i livelli, massimamente a quello politico. E quindi il richiamo al popolo italiano, in quest’ottica, sarebbe in sé e per sé l’elemento legittimante di una operazione, il giudizio appunto, che ha bisogno non d’uno ma di due livelli di legittimazione, il popolo italiano e la repubblica italiana. Senza contare che l’attività giudiziaria ha poi ancora un livello di legittimazione, quello più forte e decisivo, che è dato dalla legge. Quindi gli altri due in questa luce rischiano di apparire come rinvii, dei semplici rinvii, e null’altro che questo. Questo richiamo sarebbe, in ultima analisi, pura forma priva di contenuto, e questo non ci convince affatto! Il richiamo formale non può essere l’elemento legittimatorio di un processo che già di per sé è legittimato. Certo non possiamo negare che in un ordinamento come quello italiano dominato da un eccesso di formalismo giuridico la forma finisce per tener luogo della sostanza assai più spesso di quanto si possa credere; per riferirci alle parole di Natalino Irti la forma mette al sicuro, mentre le volontà lottano senza tregua, irrompono nel tempo e nello spazio, e determinano nuovi e diversi corsi della storia, la forma gode di un’oggettiva insensibilità. Ed anche la forma giuridica è «chiusura di eventi», un’impersonale congegno che ricevendo ed elaborando qualsiasi contenuto, lo de-soggettivizza, lo solleva all’astrattezza del mero producibile, lo riduce alla semplicità del calcolo. I contenuti di volontà, gli «eventi», che irrompono nel tempo e nello spazio, sono immessi
182
entro i canali delle procedure e perciò slegati dagli autori e ridotti a materiale di produzione.180 Ma certamente, nello specifico, percorrendo la sola via della forma dobbiamo concludere che anche in questo caso si tratta, a nostro giudizio, di un richiamo puramente retorico e null’altro. Ecco perché crediamo che insistendo sull’aspetto formale della formula la questione non può essere in alcun modo risolta. Dal punto di vista sostanziale il problema è, invece, molto più spinoso e complesso e investe una moltitudine di aspetti con cui solo in parte dichiariamo di volerci cimentare. Il primo punto che affrontiamo, e quello su cui ruotano gli altri che trattiamo, è il problema della rappresentatività della decisione giudiziaria, che risponde alla domanda se effettivamente, cioè al di là della forma, e in che modo, la decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. 2. Rappresentatività della decisione giudiziaria Michele Taruffo in un passo di uno dei suoi saggi più noti afferma che “l’elemento nuovo che ha ribaltato il tradizionale modo di intendere l’attività del giudice è indubbiamente costituito dall’emergere in termini sempre più chiari e drammatici (ovviamente prima nella realtà politico- sociale e poi tra i giuristi), del problema dei valori nella giurisprudenza: nel momento in cui il giudice cessa di essere visto come pura «funzione» astratta o «macchina» neutrale, ed appare invece come portatore di valori etico-politici e come protagonista di conflitti sociali, sorge l’esigenza di superare le mere affermazioni di principio sul ruolo dei valori nell’interpretazione e nell’applicazione della legge,
180 N. Irti. Il salvagente della forma, Laterza, Roma-Bari 2007, pag. VIII.
183
tipiche dell’approccio strettamente giuridico, per affrontare il tema con strumenti metodologici adeguati; nasce in altri termini l’impulso a studiare l’attività e la funzione del giudice in due nuove direzioni essenziali: quella sociologica e quella politica. Donde l’individuazione di linee di indagine che rifiutano il consueto inquadramento dogmatico astratto, e mettono in evidenza le componenti metagiuridiche che intervengono a determinare la decisione, e le caratteristiche lato sensu ideologiche della decisione stessa. ……A parte ogni valutazione dello scarso pregio degli argomenti con cui si tenta di negare la scientificità e quindi la legittimità degli studi politici sulla giustizia rimane comunque certo che un approccio di questo tipo è in grado di individuare nell’attività del giudice elementi che non a caso sfuggono al filtro giuridico-dogmatico, e che invece svolgono un ruolo essenziale sia nella formazione della decisione che nella sua espressione e giustificazione”181 Proprio questi elementi che Taruffo definisce, con assoluta precisione, metagiuridici sono, a nostro giudizio, essenziali nella formazione della decisione giudiziaria, e in questo senso si sviluppa sul punto la nostra analisi, cioè la ricerca di questi elementi, o almeno di taluni di questi. In quest’ottica occorre, a nostro giudizio, sezionare i vari momenti ed elementi della decisione giudiziaria, facendo nostra una puntualizzazione dello stesso Taruffo, secondo cui il termine “giudizio” usato con riferimento a fenomeni giuridici conosce, nel linguaggio comune come nel linguaggio tipico dei giuristi, una rilevante biforcazione di senso: esso viene infatti usato indifferentemente per indicare due fenomeni che sono forse connessi ma che sono comunque diversi e quindi vanno distinti l’uno dall’altro, processo e decisione. Posta in questi termini,
181 M. Taruffo, La motivazione della sentenza civile, Cedam, Padova 1973, pp. 23-26.
184
precisa l’autore, la distinzione accentua la diversità tra le famiglie di espressioni riconducibili ai due diversi significati di “giudizio”; tuttavia occorre considerare che processo e decisione non sono fenomeni distinti e separati, al contrario non v’è bisogno di sofisticate speculazioni teoriche per intendere che processo e decisione sono connessi da un legame di mezzo a fine, di strumento a risultato, di premessa a conseguenza.182 Seguiamo compiutamente il pensiero dell’autore sul punto, che riteniamo assai utile ai fini della nostra analisi: “ne segue la considerazione che il processo serve soprattutto a produrre decisioni, sicché la sua struttura può essere diversamente modellata a seconda delle decisioni che si vogliono conseguire, può allora sorgere il sospetto che tra giudizio-processo e giudizio-decisione vi sia qualche intrinseca e profonda connessione che viene, benché spesso inconsapevolmente, evocata proprio dall’uso polisemico, ma allora non del tutto casuale, di “giudizio” per indicare alternativamente - ma spesso insieme- il processo e la decisione. Si potrebbe allora pensare, conclude l’autore, che pur essendo diversi i denotata rispettivi, tuttavia qualche corrispondenza o qualche riflesso reciproco, o qualche vicendevole implicazione, vi siano tra giudizio-processo e giudizio-decisione”.183 Ora, pare a noi che questa premessa non sia e non debba essere considerata solo di tipo formale, anzi al contrario, per noi il profilo formale assume una importanza determinante sotto quello sostanziale, né possiamo nascondere che quel che Taruffo denota garbatamente come sospetto, che tra giudizio-processo e giudizio-
182 M. Taruffo, «Giudizio: processo e decisione», in I metodi della giustizia civile, a cura di M. Bessone, E. Silvestri, M. Taruffo, Cedam, Padova 2000, pp.267-268. 183 Ivi, pp.268-269.
185
decisione vi sia una intima connessione, per noi è più che una certezza. Al riguardo non possiamo non richiamare alcune riflessioni di Salvatore Satta, di una chiarezza esemplare: “ha il processo uno scopo? Non si dica, per carità, che lo scopo è l’attuazione della legge, o la difesa del diritto soggettivo, o la punizione del reo, e nemmeno la giustizia o la ricerca della verità, se ciò fosse vero sarebbe assolutamente incomprensibile la sentenza ingiusta, e la stessa forza del giudicato, che copre assi più che la terra, gli errori dei giudici. Tutti questi possono essere e sono gli scopi del legislatore che organizza il processo, della parte o del pubblico ministero che in concreto lo promuove, non lo scopo del processo. Se uno scopo al processo si vuole assegnare questo non può essere che il giudizio; e processus judicii infatti era l’antica formula, contrattasi poi, quasi per antonomasia, in processo. Ma il giudizio non è uno scopo esterno al processo, perché il processo non è altro che il giudizio e formazione di giudizio: esso dunque se ha uno scopo, lo ha in se stesso, il che è come dire che non ne ha alcuno. Veramente processo e giudizio sono atti senza scopo, i soli atti della vita che non hanno uno scopo”184 Un paradosso? -si domanda lo stesso autore- nient’affatto come lui stesso chiarisce. Seguiamo compiutamente il suo pensiero: “no, non è un paradosso, è un mistero, il mistero del processo, il mistero della vita. Se noi contempliamo il corso della nostra esistenza –il breve corso della nostra vita individuale, il lungo corso della vita dell’umanità – esso ci appare come un susseguirsi, un intrecciarsi, un accavallarsi di azioni, belle o brutte, buone o cattive, sante o diaboliche: la vita stessa anzi non è altro che l’immenso fiume dell’azione umana, che sembra procedere e svolgersi senza una sosta. Ed ecco, a un dato punto, questo fiume si arresta, deve
184 S. Satta, Il mistero del processo, Adelphi, Milano 1994, pag. 24.
186
arrestarsi se non vuole diventare un torrente folle che tutto travolga e sommerga: l’azione si ripiega su se stessa, e docilmente, rassegnatamente si sottopone a giudizio. Perché questa battuta di arresto è proprio il giudizio: un atto, dunque, contrario all’economia della vita, che è tutta movimento, tutta volontà e tutta azione, un atto antiumano, inumano, un atto veramente –se lo si considera, bene inteso, nella sua essenza- che non ha scopo”.185 Dopo questa premessa addentriamoci nei termini del problema. Il problema, in sostanza, ruota tutto intorno alla domanda: che grado di rappresentatività ha la decisione, e, in altri termini, la decisione pronunciata in nome del popolo italiano, e che riguarda un caso singolo, è realmente riferibile al nome del popolo italiano tutto? Si potrebbe obiettare, facendo ricorso ancora una volta allo scudo della forma, che la domanda in sé e del tutto inutile ove non sia addirittura impertinente Ma sotto il profilo più sostanziale il problema apparentemente semplice in superficie è di una complessità, e di una gravità assoluta, ed investe un corollario di problematiche da quella del ruolo del giudice a quello della rappresentatività della legge a quello della legittimazione . Sul primo punto se solo volessimo sfiorare l’argomento, e non ne abbiamo intenzione alcuna, dovremmo citare non solo secoli ma millenni di letteratura al riguardo e ai fini del nostro ragionamento sarebbe puro esercizio di conoscenza senza una reale utilità, e solo per completezza d’analisi spendiamo qualche battuta proponendo una estrema sintesi, ed avvertendo che in questa fase della analisi attribuiamo al giudice la funzione pura e semplice di amministratore di giustizia e null’altro che questo. Relativamente ai sistemi di civil law nell’ambito della cultura giuridica dell’Europa continentale per una concettualizzazione del
185 Ivi, pag. 25
187
potere giudiziario ricorriamo alla pregevole sintesi di Massimo La Torre: “si sono individuati due ideal-tipi forniti di particolare forza d’attrazione. Vi è innanzitutto il modello «francese» dominante nel quale il giudice applica la legge e da questa riceve la sua legittimità (là dove la legge è espressione della sovranità popolare). Il giudice qui è una sorta di «commissario», amministra la legge in una situazione specifica (conflitto di interessi in un caso concreto). Vi è poi il modello «tedesco» dominante, nel quale il giudice realizza la volontà dello Stato di cui è un «organo» e come tale risulta sufficiente legittimato. Il giudice è qui «funzionario», Beamter.” 186 Precisa ancora La Torre che i due modelli “sono convergenti. Essi convergono innanzitutto in tanto in quanto il giudice «francese» vede nella legge un evento puramente formale (la norma gerarchicamente suprema) e non si cura delle ragioni materiali di questa né del processo deliberativo che l’ha prodotta. In questo senso anch’esso – come il giudice «tedesco» - si configura essenzialmente come un «organo» dello Stato attento principalmente al rispetto della razionalità interna di questo. I due modelli convergono anche in tanto in quanto lo Stato di cui il giudice «tedesco» è l’organo riveste le proprie decisioni delle forme di una legge generale ed astratta e la legge viene poi riformulata essenzialmente come norma gerarchicamente suprema e/o decisione ultimativa (a prescindere dalle qualità del processo deliberativo in cui si produce la legge medesima”. Deve però dirsi, conclude l’autore, che i due modelli sopra individuati stanno più o meno al centro di uno spettro alle cui estremità troviamo da un lato (nel modello «francese») la visione pre-democratica di un giudice come potere sovrano proprio, indipendente e contrapposto agli altri, e dall’altro (nel modello
186 M. La Torre, Il giudice, l’avvocato e il concetto di diritto, Rubbettino, Soveria Mannelli 2002, pag. 47.
188
«tedesco») la concezione radicalmente democratica dell’attività giudiziale come coniugazione della pratica deliberativa collettiva (che trova nella legge la sua espressione più piena). In quest’ultimo paradigma il giudice non è né funzionario o organo di uno Stato che come tale (come entità ipostatizzata) non esiste, né ovviamente il signore dotato di privilegi e prerogative intoccabili, figura tipica delle istituzioni tardo-feudali. Ma non è nemmeno la mera bocca della legge, l’esecutore della volontà sovrana del popolo. E in conclusione, per l’autore, il giudice deve rendere possibile –sia pure in una situazione eccezionale e d’emergenza com’è quella di un conflitto intersoggettivo di interessi- strutture collettive di argomentazione e deliberazione orientate all’universalizzabilità degli interessi accettati come ragioni di una condotta e di una decisione.187 Altra pregevolissima sintesi sul punto, che riteniamo opportuno citare, è quella di Guido Alpa secondo cui “nel mondo del diritto molteplici sono i modelli dell’attività giudiziale ritagliati sulle disposizioni o costruiti nella prassi. Per introdurre un discorso apparentemente molto complesso, i giuristi procedono per stereotipi semplificanti, e delineano almeno tre figure di giudice: il «giudice mero esecutore», il «giudice scopritore», il «giudice legislatore». Il giudice mero esecutore è il giudice che si dice piacesse a Federico il Grande e a Napoleone: un solerte funzionario dello Stato, ligio alle leggi, portatore di valori ufficiali, cauto esaminatore delle disposizioni, privo di vocazioni creative, solido conservatore, tendenzialmente ottuso. E’ il modello passato alla storia come «bouche de la loi», sul quale si è edificata la Scuola dell’esegesi. I suo compito consiste nell’applicare le disposizioni del monarca-legislatore, sussumendo nel dettato normativo il caso a lui
187 Ivi, pp.47-49.
189
sottoposto. Le sue operazioni debbono essere limitate e meccaniche: accertare i fatti, individuare le disposizioni a cui essi si possono far risalire, trarne le conseguenze. Il compito è più complicato se il giudice – non più mero esecutore, ma scopritore del diritto - deve porsi alla ricerca della disposizione applicabile alla fattispecie: prendere atto che gli stessi fatti possono farsi risalire a più disposizioni, che le disposizioni, per loro natura, sono astratte e generali, che il legislatore non ha prefigurato tutte le circostanze possibili sulle quali esprimere il suo dettato, che spesso le disposizioni sono contraddittorie oppure laconiche oppure riduttive e che quindi la ricerca del diritto ottenuta scavando nel magma del diritto, comporta operazioni dirette a comporre le antinomie, a completare le lacune, ad estendere o a restringere il dettato normativo, e così via. E’ il giudice che piace ai formalisti di cultura tedesca, i quali delineano nella Rechtsfindung il complesso delle operazioni ermeneutiche dirette al «ritrovamento» del diritto e alla sua applicazione. Finalmente il cerchio si chiude con il giudice legislatore, il quale, non avendo ritrovato nel tessuto normativo la disposizione da applicare al caso di specie, e dovendo comunque provvedere, ravvisa la necessità di creare ad hoc la disposizione che fa difetto. E’ il modello confinato ai casi eccezionali ed estremi, prefigurato all’inizio di questo secolo dal legislatore svizzero. Questi stereotipi, emersi in epoche e in culture assai differenti tra loro, oggi sono tutti coevi, sono riflessi nel modo di pensare comune all’attività del giudice, spesso sono confusi o sovrapposti, oppure sono il precipitato di una crasi che tutti li ricomprende. Tuttavia questi modelli stanno tra loro in evidente forte opposizione: in questo senso, il giudice dell’età napoleonica e il giudice svizzero dell’inizio di questo secolo stanno tra loro agli antipodi.
190
In più, si tratta di stereotipi, usati consapevolmente come tali: nessun giurista francese crede, o poteva credere, nella sufficienza di un articolo di codice per poter assolvere al compito di dirimere una controversia, nessun giudice svizzero crede, o poteva credere, di avere il potere di sostituirsi bellamente al legislatore”188 Un ulteriore modello, mi sia consentito di aggiungere, a questi, per così dire, tradizionali189, ed è quello proposto da Vincenzo Tomeo, ossia il giudice come interprete di conflitti. “Per quanto riguarda il nostro paese – sono le parole stesse dell’autore - è facile osservare che il giudice è stato messo in questione non appena i giudici come corpo e come ceto hanno assunto un ruolo anche tecnicamente politico. Via via che la magistratura ha vigorosamente affermato, dal 1945 in poi, la sua presenza come uno degli elementi costitutivi del sistema politico, questo ruolo è andato manifestando aspetti e caratteri «politici» che sono subito apparsi assai più rilevanti che in passato. E tali sono apparsi, ma in realtà la sostanza delle cose non è cambiata: sono semplicemente emersi in piena luce certi tratti del ruolo o della funzione che un tempo erano più sfumati o in qualche modo resi meno evidenti dalla situazione in cui reciprocamente si trovavano i diversi ruoli di autorità. L’ombra discreta in cui si era tenuta la magistratura fino a due decenni or sono nei confronti dell’esecutivo e del legislativo, mentre aveva mantenuto il potere giudiziario in una situazione sostanzialmente subalterna, aveva però contribuito a sfumare i contorni di una funzione essenzialmente politica ieri non meno che oggi. Naturalmente, a questo stato di fatto si può trovare una spiegazione. Un ruolo
188 G. Alpa, L’arte di giudicare, Laterza, Roma-Bari 1996, pp.3-4. 189 Altra pregevolissima analisi al riguardo è quella proposta da Damaska, già citata. Si veda M.R. Damaska, The faces of Justice and State Authority, New Haven, Yale University Press, 1986, trad. it. I volti della giustizia e del potere, Il Mulino, Bologna 1991.
191
divenuto improvvisamente così critico all’interno di un apparato che aveva inteso la propria presenza istituzionale in una prospettiva di decoroso distacco, non esige soltanto una immediata presa di coscienza sul proprio essere sociale, cioè sulla propria posizione e sulle proprie funzioni, ma esige anche, a non lunga scadenza, una valutazione e un orientamento circa il modo con cui agisce. Come dunque interpretare questo ruolo? Si chiede l’autore: è innegabile – è la sua risposta- che i giudici subiscano per primi e con maggiore intensità che per altri ruoli sociali la naturale contraddizione dei ruoli di autorità, non possono non riconoscere nelle funzioni da loro esercitate i tratti di un tipico rapporto di potere - essi, cioè, sono soggetti di un rapporto inegualitario e asimmetrico in cui la funzione da loro svolta è quella di costringere o condizionare gli altri – e nel medesimo tempo alcuni tratti del loro ruolo si richiamano a principi super partes di imparzialità e di rispetto dell’eguaglianza. Ora di fronte ad una contraddizione di questo genere – che assume per il sociologo qualche aspetto di quella situazione che è designata tecnicamente come conflitto di «ruolo» non mi pare che possa darsi vera soluzione, reale superamento se non con la distruzione del ruolo medesimo. Ma poiché non si può dire ai giudici di non essere giudici, bisogna almeno ricercare nella realtà sociale qualche elemento per interpretare tale contraddizione. Anzitutto, è la soluzione proposta da Tomeo, almeno la consapevolezza del conflitto. Ma la consapevolezza del conflitto, avverte l’autore, ha poco senso se non è accompagnata da un atteggiamento coerente. Essere consapevoli di ciò, significa considerare la situazione in cui si è collocati come una delle tante espressioni del conflitto che coinvolge tutto il sistema dei rapporti sociali. Il punto è che, mai come oggi, i giudici tendono a scoprire di essere al centro di un sistema di rapporti per loro natura inegualitari ed antagonistici dei quali essi sono obbligati a tener
192
conto. Ed è poco probabile che i canoni di interpretazione che essi sono abituati ad usare siano gli strumenti più adatti per interpretare e capire questa situazione conflittuale. Essere interpreti della legge significa dichiarare la rispondenza di un rapporto o di una situazione concreta alla pronuncia della legge, cioè ad una statuizione a carattere generale. In tale funzione apparentemente interpretativa-dichiarativa non trova posto quella funzione «riequilibratrice» che è una pretesa costante e forse ingenua dell’uomo comune verso il giudice.190 Come dicevamo non prendiamo al momento sul punto una posizione a favore dell’una o dell’altra figura del ruolo del giudice perché del tutto ininfluente ai fini di questa analisi, per quanto crediamo che la nostra posizione sia chiaramente palesata ed emersa nel corso di questo lavoro. La domanda che ci poniamo investe per intero il ruolo del giudice o meglio l’interpretazione di questo ruolo sia da parte dello stesso giudice sia da parte del “popolo” in nome del quale egli pronuncia le sue decisioni. Immaginiamo per un momento questo ruolo in termini puramente funzionali, cioè di colui che amministra la giustizia, espressione quantomai generica e del tutto anodina, e che tale vuole essere, e poniamoci la domanda: può il giudice nel pronunciare una decisione in nome del popolo italiano comprendere e ricomprendere realmente nella sua decisione l’intero popolo italiano?
190 V. Tomeo, «Il ruolo del giudice e la sua crisi», in Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, IV Serie –XLIX- 1972, pp. 629-630. Sul punto, dello stesso autore si veda anche «Interpretare il conflitto», in Critica Liberale n. 144, 1973 ora anche in B.M. Bilotta, A. Scerbo, La giustizia e le giustizie (a cura di), Rubbettino, Soveria Mannelli 1998, e Il diritto come struttura del conflitto, Angeli, Milano 1981.
193
La risposta prescinde del tutto dall’interpretazione del ruolo, adottare uno degli stereotipi sopra sintetizzati o avvolgere il ruolo stesso in una toga, per così dire, più innovativa attribuendogli un ruolo di interprete del conflitto non muta la sostanza della risposta perché questa coinvolge la norma e in definitiva la legge stessa. E quindi la domanda trasmigra da un aspetto formale ad uno più sostanziale: come può la decisione assunta sulla base di una norma di legge che è espressione, evidente o nascosta, di talune forze sociali più che di altre, e quindi di taluni interessi sociali più che di altri, essere rappresentativa di tutto il popolo italiano, in quanto in nome di questo, indistintamente tutto, pronunciata? In sostanza: può la decisione giudiziaria, che ripropone al suo interno, necessariamente, un contenuto normativo che è l’espressione diretta, spesso visibile, della diversità del peso socio-economico-politico con cui le diverse componenti del popolo italiano hanno contribuito a produrla e a formarla e che riproduce al suo interno questo squilibrio, espressione, a sua volta, di uno squilibrio di posizioni, di decisioni, di potere, e di rappresentazione delle istanze sociali, effettivamente dirsi pronunciata in nome del popolo italiano? O anche: se la norma nient’altro è se non la rappresentazione pro quota191, del popolo italiano nelle sue componenti rappresentative,
191 A dire il vero in democrazie, come quella italiana attuale, a prevalente sistema elettorale maggioritario, anche questo non è poi del tutto vero, anzi per taluni versi è un po’ forzato se non in parte falsato, in quanto com’è noto i meccanismi elettorali proporzionali sono ridotti e vigono quote di maggioranza che privilegiano più che proporzionalmente la componente politica vincente. Natalino Irti esprime con assoluta acutezza questo punto affermando che “se le due pretese [si tratta di pretese che divergono nell’agone parlamentare] stanno alle regole del gioco – e, dunque, né sovvertono il regime democratico né instaurano dittature tecnocratiche o dittature religiose o ecologiche- , allora la quantità di consenso decide il conflitto, e l’ipotesi vittoriosa si fa norma
194
come può una decisone che di questa rappresentazione ne è a sua volta una sotto-rappresentazione investire nella sua interezza il popolo italiano? Domanda che si sostanzia nell’altra, comunque collegata: può l’attività di decisione del giudice unificare contenuti di potere e di rappresentazione di questi per effetto dell’uso di una espressione, in nome del popolo italiano appunto? A ben guardare nessuno si è mai spinto al punto da parlare a proposito del giudice di questo suo presunto (dalla formula) ruolo di “unificatore” di interessi, poteri, pesi sociali e destini sociali. Occorrerebbe presumere che il giudice possieda in sé, e sia ammantato, nel momento della decisione, di talune doti, quasi taumaturgiche, che gli consentano di conciliare interessi tra loro realmente divergenti e contrapposti, quote di potere effettivamente differenti, e in definitiva quote di “norma di legge” concretamente diverse, che nessuno al mondo ha mai presunto di attribuirgli se non una formula, una mera formula, questa sì del tutto retorica e assolutamente taumaturgica, in nome del popolo italiano. Anche nello più spinto stereotipo del giudice innovatore, di cui si è detto, manca del tutto l’attribuzione di questo ruolo unificatore in capo al giudice, anzi dal punto di vista sociologico è esattamente il contrario, il giudice è nel panorama sociale tra i maggiori produttori di conflitto sociale. Magistralmente ha espresso questa posizione Lawrence Friedman, quando ha affermato che “il pluralismo è come una sistema di
giuridica. La pretesa maggioritaria non assume il rango di norma suprema ma è norma tra norme, esposta non diversamente dalle altre, alle inattese oscillazioni della volontà popolare o delle assemblee elettive. I nomodotti, indifferenti ai contenuti che di tempo in tempo li attraversano, sono pronti a registrare il mutevole risultato del conflitto. Qui non c’è alcun fondamento contenutistico ma soltanto un fondamento procedurale”. Si veda N. Irti-E. Severino, Dialogo su diritto e tecnica, Laterza, Roma-Bari 2001, pag. 58.
195
mercato che implica negoziazioni, mercanteggiamenti del voto, compromessi, aggiustamenti dei prezzi e delle pretese. Anch’esso ha un senso, e potrebbe costituire l’ideale ma solo se la distribuzione del potere e della ricchezza fosse in qualche modo «giusta». Le teorie del diritto come fenomeno sociale assumono che il sistema giuridico scaturisce da attività simili a quelle del mercato. Secondo questa teoria, le gente commercia i propri interessi così come nel mercato commercia i beni; i codici giuridici che vigono nella società sarebbero, più o meno come delle liste di contrattazioni e di preferenze, sensibili alle trattative e all’esercizio di pretese come lo è il listino quotidiano della quotazioni di borsa. Alcuni soggetti incominciano il gioco avendo a disposizione più gettoni, e giocano con regole diverse dagli altri”.192 Date queste premesse la conseguenza è inevitabile, e la rimettiamo alle stesse parole dell’autore: “il diritto discrimina o, per dirla con terminologia priva di connotazioni emotive, riflette la struttura sociale esistente in due modi diversi. In primo luogo, le norme stesse, l’aspetto ufficiale del diritto, non sono affatto del tutto imparziali anche quando sono applicate con imparzialità. Esse sono il prodotto di lotte per il potere e sono forgiate di base dall’opinione dei dominanti. Ancor più importante è, sotto questo aspetto, la struttura di base del diritto: i regolamenti, le norme tributarie, e in generale la disciplina dell’economia, sono plasmati sulle esigenze e sugli interessi dei proprietari; le norme sul contratto ed il diritto commerciale hanno, allo sguardo di un osservatore superficiale, un’aria di innocenza e sembrano all’uomo medio essere intessute di
192 L.M. Friedman, The Legal System. A social science perspective, Russel Sage Foundation, New York 1975, trad. it. Il sistema giuridico nella prospettiva della scienza sociale, traduzione di Giovanni Tarello, Il Mulino, Bologna 1978, pag. 303.
196
giustizia e di buon senso, ma si tratta del buon senso e della giustizia delle società occidentali e della loro economia, della parte dominante della popolazione. Peraltro molte norme sembrano essere sotto il profilo dei valori, fuori dal tempo e neutrali, sembrano essere espressione di fede e di valori aerei, non storicamente situati Quale sia poi il modo in cui queste norme vengono applicate è un’altra questione. L’amministrazione della giustizia è sottoposta a delle forme di controllo sociale, sia impercettibili sia vistose, che non sono riconosciute dal diritto ufficiale. Nel complesso, è la conclusione dell’autore, sembra ragionevole supporre che la giustizia non sia così cieca e così priva di elementi classistici come pretende di essere; e che essa penda nella realtà, da un lato”193 Torniamo allora alla domanda: può mai il giudice assurgere al ruolo di unificatore quando lo strumento con cui opera, la norma giuridica, è di per sé inegualitario e discriminatorio? La domanda pare a noi del tutto pleonalistica, la risposta del tutto superflua. Eppure qualche parola sul punto preferiamo spenderla. Massimo La Torre ha molto bene puntualizzato al riguardo quando ha affermato che “se la deliberazione194 è un fatto puramente decisionale, perché opaca rispetto a ragionamenti ed argomenti, ciò significa che decisionale sarà anche la deliberazione affidata al giudice. Ciò però equivarrebbe ad attribuirgli un potere di sovranità: una conseguenza inaccettabile tanto per la monarchia assoluta quanto per la democrazia liberale. Se la deliberazione è espressione di preferenze già formate e per certi versi esistenziali del soggetto investito del potere deliberativo, il giudice –come soggetto distinto dal legislatore- non può essere concepito come un
193 Ibidem, pp. 306-308. 194 Evidentemente legislativa.
197
soggetto deliberativo. La visione d’esso può essere solo quella di una cinghia di trasmissione della volontà generale espressa dal sovrano. Il giudice deve limitarsi ad essere una specie di macchina dell’applicazione della legge. Se la legge, è la conclusione dell’autore, è frutto di mera decisione messa in moto quasi automaticamente – per una specie di riflesso inconscio – da bisogni e preferenze esterne alle deliberazioni e ininfluenzabili da questa, il giudice non può ripercorrere le ragioni della legge, ché queste sono solo interne alla costituzione essenziale del soggetto deputato a prendere la decisione legislativa ultimativa. Il giudice in tal caso può o sovrapporre una propria decisione esistenziale a quella del legislatore oppure prendere atto, in certa misura «descrivere» o «registrare», la decisione legislativa. Il giudice sarebbe così stretto nell’alternativa tra l’arbitraria discrezionalità e la pedissequa ripetizione della legge”. 195 Questa, dunque, l’alternativa rimessa al giudice: applicare la legge o interpretare la legge, ma mai unificare la decisione sotto un unico velo protettivo: il popolo italiano. Lo abbiamo già detto, questi, il popolo italiano, non rappresenta in alcun modo un elemento di legittimazione del giudice, anzi se mai è esattamente il contrario, e sconta un senso di sfiducia unito, forse, e talora, ad un senso di timore. Una sfiducia che Tomeo individua nella fatalistica convinzione che la separazione tra chi detiene il potere e chi lo subisce è un dato sociale importante, altrettanto come quello per il quale la legge, per dirla ancora con le parole dell’autore, è lo strumento del controllo da parte della classe dominante di cui è l’emanazione e sostanzialmente in una convinzione più occulta ma altrettanto forte che vede nella legge una pura e semplice emanazione del potere rispetto alla quale
195 M. La Torre, Il giudice, l’avvocato e il concetto di diritto, cit., pag. 46.
198
possono mutare le componenti ma non il rapporto di dominazione. 196 Una sfiducia e un timore che si accrescono quando si pensa al giudice non solo come applicatore della legge e in definitiva come mero esecutore di questa ma al giudice rivestito di un ruolo “politico”. Questa idea del magistrato “politicizzato”, affermano Paolo Borgna e Marcello Maddalena, sapientemente alimentata da chi ha interesse ad indebolire il sistema dei controlli, si è diffusa in larghi strati dell’opinione pubblica italiana. Si può discutere delle cause di questo luogo comune, assolutamente non corrispondente alla realtà, ma è un fatto che fra i cittadini si è pericolosamente consolidato il convincimento che possa accadere non di rado che il magistrato usi il suo potere discrezionale in funzione delle proprie idee politiche197. Capita spesso, notano i due autori, di sentirsi chiedere da un amico, che magari si trova coinvolto in una banale causa di sfratto, quale sia l’orientamento politico del giudice che ha in carico il suo fascicolo. Per non parlare dei casi in cui vi è un’indagine in materia di reati amministrativi. Noi sappiamo bene che nella stragrande maggioranza dei casi quella domanda non ha alcun senso, ma quasi mai riusciamo a convincere il nostro amico. Se ciò avviene per i normali processi di tutti i giorni, possiamo ben comprendere come a maggior ragione questa idea sia radicata con riferimento a
196 V. Tomeo, Il giudice sullo schermo. Magistratura e polizia nel cinema italiano, Roma-Bari 1973, pag. 27. Sul punto si veda anche, dello stesso autore, «Il ruolo del giudice e la sua crisi», in Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, cit., «Interpretare il conflitto», cit. «L’immagine del giudice nella cultura di massa», in Quaderni di Sociologia n.1/1972. 197 P. Borgna- M. Maddalena, Il giudice e I suoi limiti, Laterza, Roma-Bari 2003, pag. 18.
199
importanti indagini e processi che coinvolgano qualche leader di partito. Insomma l’idea inizialmente espressa ad alta voce da qualche uomo delle istituzioni secondo cui la giustizia è diventata «la prosecuzione della politica», è circondata e si è poi sedimentata sino a far parte del comune sentire del «cittadino medio». E’ evidente che un simile veleno mina in modo irrimediabile la credibilità della magistratura. Ne intacca la legittimazione. La rende assolutamente vulnerabile di fronte ad attacchi diretti a modificarne la collocazione istituzionale.198 Siamo arrivati al cuore del problema! Che è quello della legittimazione, reale si intende, non formale, del giudice e, di conseguenza, della sua decisione. Se solo volessimo sfiorare l’argomento apriremmo, com’è intuibile, un abisso di opinioni, di posizioni e di interpretazioni nella quali, ai fini di questo lavoro, non vogliamo avventurarci; ma certamente non possiamo e non vogliamo liquidare il punto sorvolandolo a piè pari. E parlando di legittimazione in riferimento al potere giudiziario (più appropriatamente, ordine giudiziario) non si può non pensare all’esistenza di una duplice forma di legittimazione, una di tipo formale ed una di tipo materiale, la prima che prevede, sostanzialmente, una forma di auto-legittimazione che è data dal sistema in se e per sé, ossia dal potere stesso inserito in un circuito sistemico luhmannianamente auto-referenziale, l’altra che è prevede il possesso del consenso199.
198 Ibidem pp.18-19. 199 Per una analisi assai attenta ed esaustiva sul tema non si può non rimandare al dibattito, ormai classico per i sociologi giuridici e politici, su Diritto e Legittimazione pubblicato in Sociologia del Diritto, IX/1984/1. Per i brevi riferimenti del nostro testo si veda in particolare S. Castignone, Legittimazione e potere. Elementi per una riflessione analitica e A. Febbrajo, Legittimazione e teoria dei sistemi.
200
Quanto alla prima forma di legittimazione, quella di tipo formale, circuitata com’è in un meccanismo sistemico di questo ne recepisce tutti i vantaggi ma certamente anche gli svantaggi e indubbiamente anche i rischi e le tentazioni. Quanto all’altra, il possesso della legittimazione per così dire materiale non appare affatto scontata né nei fatti realmente lo è. Tutt’altro. E’, probabilmente, questo il senso con cui Borgna e Maddalena intendono il concetto di legittimazione in riferimento al potere giudiziario. Qui la magistratura –affermano testualmente gli autori- tocca con mano la debolezza della sua legittimazione. “In un sistema istituzionale come il nostro – in cui il potere della magistratura è fondato soltanto sulla Costituzione e quello del singolo magistrato soltanto sul concorso – la sistematica messa in discussione della sua imparzialità non poteva non evidenziare, in modo esplosivo, il divario incolmabile fra la legittimazione democratica del potere politico, saldamente ancorata e continuamente confortata dal suffragio universale, e la legittimazione fragile e sempre incerta del potere giudiziario. Questa «carenza di legittimazione democratica» è continuamente rinfacciata ai giudici”. I due autori ricordano come emblematico un episodio avvenuto in Parlamento in cui un ex Presidente della Repubblica, alla vigilia di uno sciopero dei magistrati, ha affermato «loro hanno vinto un concorso, voi siete stati eletti»: questa affermazione, a loro parere, scolpisce in modo icastico questa accusa. 200 Forse una piccola parte di verità, al riguardo, sta proprio nelle nostre parole, scritte poco sopra, quando abbiamo affermato che l’attività giudiziaria è afflitta da un doppio livello di legittimazione, o addirittura da un triplo livello, che ne indebolisce in sé la qualità della legittimazione stessa.
200 P. Borgna- M. Maddalena, Il giudice e i suoi limiti, cit., pp.18-19.
201
Ritorniamo, allora, ancora una volta alla domanda: è proprio vero che la decisione giudiziaria è data effettivamente in nome del popolo italiano, del popolo italiano tutto si intende? Forse la risposta più appropriata, sicuramente la più suggestiva, dall’alto della sua arte di fine giurista e di grande scrittore l’ha fornita Salvatore Satta quando rispondendo alla domanda su che cosa è la giurisprudenza ha affermato che “in mille modi si può rispondere e si è risposto a questa domanda, ma in tutti mi pare che ci sia una nota costante, ed è il riferimento al concreto. Nessuno – prosegue l’autore- mette in dubbio (e come si potrebbe) che qualunque cosa il giudice faccia, lo faccia agendo sul concreto. Ma il concreto si può intendere in due modi: o in relazione a un astratto (la norma) nel quale tutto il concreto sia ipoteticamente contenuto e che quindi esso solo sia il vero concreto; o in assoluto, nel senso che il concreto sia il fatto come oggetto di conoscenza, e quindi la conoscenza del fatto che si raggiunge attraverso il giudizio e solo attraverso il giudizio: in una parola il giudizio stesso”.201 Seguiamo compiutamente il pensiero dell’autore in quanto determinante ai fini della nostra analisi: “il primo è in fondo quella tradizionale nei giuristi; ma è chiaro che esso si risolve in una finzione, perché dire che nella norma c’è tutto equivale a dire che non c’è niente, non potendoci essere altro che quello che il giudizio volta per volta ci mette. Utile finzione, del resto, sotto molti aspetti, ma che diventa pericolosa e perniciosa, quando si pretende di farne una realtà, cioè di scambiare la norma col diritto”. 202 E, aggiungiamo noi, la norma con la decisione. E’ questo un punto focale nella nostra analisi. Nel momento in cui la decisione è presa e definita si “crea” una “realtà”, per usare l’espressione di Satta;
201 S. Satta, Il mistero del processo, cit., pag. 44 202 Ibidem.
202
una realtà nuova, totalmente nuova da quella che fino a quel momento è stata oggetto di decisione, una realtà ontologicamente diversa da tutto quanto l’ha preceduto. Ma che cosa è la conoscenza del fatto –si chiede da ultimo Satta- se non il diritto? “Se ci si pensa un istante, si vede subito che il diritto non è altro che l’essere del rapporto umano, un essere necessitato, assoluto, l’unica terrena forma di conoscenza che a noi è dato avere dell’essere, tanto sicura che tutti in sostanza la possediamo, perché tutti viviamo giuridicamente anche senza aver mai aperto il codice, e vivendo continuamente creiamo diritto e nell’atto stesso del porlo lo conosciamo. La via di questa è il giudizio, lo jus dicere, meravigliosa parola che esprime ad un tempo il conoscere ed il creare, l’atto veramente creativo della conoscenza, il trovare il diritto non fuori di noi ma in noi. Quello scrittore francese che diceva che il diritto è quello che i giudici dicono essere diritto credeva di portare una nota scettica, ed invece esprimeva una profonda verità, anzi l’unica verità che si possa esprimere a definire il diritto”. 203 Meravigliosa verità, certo, ma ci sia consentita una nota scettica, anzi di essere proprio del tutto scettici, proprio come quello scrittore francese di cui ignoriamo il nome! Scettici di fronte alla creazione giudiziaria del nuovo pronunciato in nome del popolo italiano, di “tutto” il popolo italiano. Ma questa creazione non riguarda solo e soltanto la costruzione di una entità nuova pura e semplice, il giudizio appunto, ma anche le modalità con cui a questa si è pervenuti, in specifico la discrezionalità, che è elemento essenziale e determinante nel giudizio stesso.
203 Ibidem, pag. 45
203
3. Discrezionalità nel giudizio. Discrezionalità del giudizio Quando si affronta il tema della discrezionalità giudiziaria un dato su tutti emerge con assoluta certezza, che, come afferma Denis Galligan204, un’analisi del potere discrezionale non è stata tra le principali preoccupazioni della scienza giuridica. E su questo giudizio, che è poi una constatazione di fatto, concordano tutti gli interpreti che si sono cimentati sul tema. Per riprendere le parole di Adrián Rentería Díaz, sarebbe estremamente arduo effettuare una ricognizione esaustiva dell’uso che dell’espressione “discrezionalità del giudice” si fa in letteratura, in quanto tale concetto non è stato oggetto di molto interesse nella letteratura giusfilosofica, e aggiungeremmo noi, anche della letteratura sociogiuridica.205 Vi è in realtà un uso assai diffuso del termine discrezionalità da parte dei giuristi positivi e conseguentemente da parte della dottrina giuridica, ma gran parte delle analisi danno, il più delle volte, per scontato il riferimento al significato dell’espressione, sicché questo tipo di analisi ruota assai più sul contenuto della discrezionalità che non sul significato del termine stesso. Che, diciamo subito, per noi è non solo essenziale ma determinante per poter condurre a termine la nostra analisi: dalla scelta di campo
204 D.J. Galligan, Discretionary power. A legal study of official discretion, Oxford University Press, London 1986, trad.it. La discrezionalità amministrativa, Giuffrè, Milano 1999, pag.5. 205 A. Rentería Díaz, Il labirinto della giustizia, Franco Angeli, Milano 2000, pag. 35.
204
sul significato da attribuire al concetto di discrezionalità dipende in tutto e per tutto l’esito della nostra analisi. Delle svariate nozioni e definizioni che del termine discrezionalità sono state fornite noi preferiamo parlare di discrezionalità come potere di decisione connesso all’attività di decisione del giudice ed alla sua libertà di giudizio, che a prima vista potrebbe, e credo dovrebbe, apparire il significato più diffuso e logicamente più aderente all’attività giudiziaria, così invece non è, anzi questo è il significato in dottrina il meno trattato e praticato. Bene ha detto al riguardo Adrián Rentería Díaz affermando che la ragione di tale atteggiamento era che per assicurare la posizione neutrale del giudice era necessario che egli non fosse consapevole del proprio potere discrezionale, in altre parole che per essere tale il giudice deve essere convinto che egli applica e non crea il diritto.206 Lo stesso Rentería nota che oggi, per fortuna, la situazione sembra essersi modificata, e la nozione di discrezionalità del giudice trova sempre più larghi spazi in letteratura, sebbene sia da sottolineare come persino nelle trattazioni più sistematiche oggi in circolazione manchi del tutto un esame complessivo e approfondito delle fonti da cui questa scaturisce e la questione venga affrontata da una prospettiva connessa ai problemi riguardanti l’interpretazione dei testi legislativi, lasciando relegate in uno spazio residuale le questioni concernenti la determinazione dei fatti, quasi che questi stessero lì, pronti per essere assunti sotto la fattispecie generale. 207 Di fatti, e di fatti concreti, parla diffusamente in una monumentale opera dedicata all’argomento Franco Bricola208, il quale premette che caratteristica essenziale della discrezionalità penale è il rinvio al caso concreto per coglierne un particolare significato,
206 Ibidem, pag. 36 207 Ibidem, pp.36-37. 208F. Bricola, La discrezionalità nel diritto penale, 2 voll., Giuffrè, Milano 1965.
205
inesprimibile in termini astratti o insuscettibile di essere tipicizzato, e che questa nozione si sostanzia nella particolare forma di “giustizia del caso concreto” ed è comune nel suo nucleo essenziale ai vari settori del diritto con differenze che attengono alla maggiore o minore ampiezza dei significati ricavabili dal caso concreto, che dipende, a sua volta dalle peculiari finalità o caratteristiche proprie di ogni branca del diritto.209 Per il diritto penale, in specifico, l’autore precisa che la discrezionalità è fenomeno di rinvio al caso concreto come il più idoneo ad esprimere quella gamma di valori che è suscettibile di condizionare un certo trattamento giuridico-penale. Alla base di questo rinvio, precisa ancora l’autore, sta l’impossibilità del legislatore di fissare in astratto una serie di significati che soltanto il caso concreto, nella sua specifica individualità e quale espressione di una determinata personalità dell’agente può rilevare.210 Seguiamo fino in fondo il pensiero di Bricola perché assai denso di significato ai fini del nostro ragionamento: “si tratta comunque di significati che non esulano da quella cerchia di valori che rappresenta il tessuto connettivo del nostro sistema penale, ogni tendenza all’espansione dell’indagine del caso concreto verso fattori estranei deve essere regolarmente neutralizzata. Per cui la discrezionalità è una forma di applicazione del diritto penale, o meglio di attuazione di esso nelle sue finalità sia di ordine generale che particolare. Il valore positivo o negativo ricavato dal caso concreto non deve, infatti porsi in antitesi con lo scopo per cui è accordato il potere discrezionale ovvero con la natura giuridica dell’istituto strutturato in questa forma. L’osservanza di questo duplice limite (non estraneità dei giudizi di valore, formulati in
209 Ibidem, pp. 225-226. 210 Ibidem, pag.157.
206
relazione al caso concreto, rispetto al sistema penale e conformità dei medesimi allo scopo particolare dell’istituto) impedisce che la discrezionalità scivoli lungo la china pericolosa dell’arbitrio giudiziale. Analogamente il carattere obiettivo dei dati di valore e la loro verificabilità costituiscono un’ulteriore garanzia in tal senso”.211 E’ proprio questo il punto su cui incentrare la maggiore attenzione: questo richiamo ai valori che rappresentano il tessuto connettivo del diritto come modello di applicazione concreta nella decisione da parte del giudice pare a noi per nulla tranquillizzante, anzi non possiamo nascondere che desta in noi più d’una preoccupazione. Innanzitutto la decisione, la scelta e la modalità, dell’interpretazione di questi valori e la traduzione di questi in un provvedimento giudiziario rimessi ad un soggetto che decide soggettivizza, necessariamente, un procedimento che deve essere quanto più oggettivo possibile. In secondo luogo, la ricerca dei valori non può essere rimessa al soggetto che decide perché è agevole dimostrare che questo tipo di operazione potrebbe sconfinare facilmente nell’arbitrio in quanto ciascun decisore potrebbe far riferimento a valori differenti dagli altri e addirittura suoi propri. 211 Ibidem, pp. 158-159. Ci pare opportuno completare il pensiero dell’autore citando la sua conclusione sul punto: “parlare di discrezionalità penale come forma di applicazione e attuazione del diritto non significa ancora identificarla con il puro e semplice procedimento ermeneutico. Il dato che ci consente di tracciare il limite differenziale tra discrezionalità e interpretazione è costituito dai concetti c.d. indeterminati o elastici. Essi rappresentano, pur nella poliedricità delle diverse forme, un elemento caratterizzante comune, si tratta di concetti che, pur essendo destinati ad esprimere, nelle intenzioni del legislatore, una determinata realtà, ossia una certa significazione astratta, non riescono a distendersi in una compiuta e analitica descrizione. L’esigenza di un apprezzamento del giudice ne è, dunque, la matrice comune.”
207
In terzo luogo non si può certo parlare di valori, nel senso di unici e condivisi, laddove si ammetta, e non si vede chi dissenta, che la norma, ossia l’elemento entro cui questi valori dovrebbero, dal giudice, essere cercati, non contiene “valori” unitari e pacifici bensì è l’espressione più evidente della contrapposizione di questi (sotto forma, per chi creda alla teoria conflittualista, di interessi); e ciò ovviamente in un sistema pluralistico di democrazia avanzata come il nostro in cui la contrapposizione degli interessi è la garanzia della democraticità stessa del gioco politico. Sul problema dei valori nella decisione giudiziale si è magistralmente espresso Michele Taruffo: “il problema della razionalità investe specificamente le scelte di valore che il giudice effettua lungo l’iter decisorio, e che riguardano sia la soluzione di problemi, sia la assunzione di direttive destinate alla soluzione di problemi. L’aspetto più rilevante ed autonomo del problema riguarda la scelta dei valori etici, politici, o giuridici, ai quali il giudice uniforma il proprio comportamento, o che egli mira a realizzare mediante le proprie scelte, si tratta, cioè, di definire la razionalità della scelta di valori-guida, intesi come direttive di giudizio o come finalità da conseguire mediante il giudizio. Al riguardo, va rilevato che una scelta di valore non è definibile come razionale o non razionale in sé, ma solo nell’ambito di un determinato sistema di valori, il che equivale a dire che la qualificazione di razionalità della scelta è ideologicamente relativa e condizionata. Sotto questo profilo, il giudizio di valore è razionale se è coerente con i valori su cui si fonda una determinata ideologia, e quindi se è orientato verso le finalità che questa indica come positive.”212 Taruffo percepisce immediatamente la scivolosità che una simile operazione può comportare e ne delimita la portata precisando che questo ricorso ai valori presuppone di aver identificato quale «tavola dei valori» sia sottesa alle norme costituzionali, e specifica che siffatta qualificazione implica l’assunzione di un’ideologia in cui tali valori si configurano come fini da realizzare anche da parte del giudice: data
212 M. Taruffo, La motivazione della sentenza civile, cit, pp. 263-264.
208
questa condizione, la scelta del giudice è razionale in quanto coerente e funzionale rispetto ad un fine che si ritiene indicato come tale dalle norme fondamentali dell’ordinamento”.213 L’autore trae con maestria le conseguenze: “non v’è spazio, dunque, per una qualificazione neutrale ed astratta della razionalità delle scelte di valore. In ogni caso, esse sono razionali se conformi ad un’ideologia determinata, e irrazionali se direttamente o indirettamente contrastanti con essa: il concetto di razionalità dei giudizi di valore è, dunque, essenzialmente, una variabile ideologica, in quanto il metro della razionalità è l’ideologia di chi si pone a sindacare un giudizio di valore sotto il profilo della sua razionalità. In tal senso, ad esempio, una scelta interpretativa intesa ad esaltare la tutela individualistica della proprietà è certamente razionale da punto di vista dell’ideologia liberale, ma non lo è affatto nell’ottica nell’ideologia socialista. Allora, in sostanza, il problema della razionalità delle scelte di valore del giudice non è altro che il problema della presa di posizione ideologica del giudice nei confronti dell’oggetto del giudizio e delle finalità che attraverso il giudizio si realizzano. Analogamente, il problema di sindacare dall’esterno se tali scelte siano o non siano razionali coincide col problema della presa di posizione ideologica dell’interprete o dell’ambiente sociale in genere, nei confronti del giudizio”. 214 E’ questo il punto di snodo del nostro ragionamento: se il contenuto della discrezionalità giudiziaria è, anche e non solo beninteso, la selezione e l’applicazione, da parte del giudice, di valori intorno ai quali costruire la propria decisione, questa può comunque dirsi pronunciata sempre e soltanto in nome del popolo italiano, intendendo, ovviamente, per questo l’intero popolo italiano? Ci sia consentito, anche in questo caso, di manifestare, da parte nostra, più d’una perplessità. Né ci convincono tutte quelle interpretazioni della discrezionalità con riferimento alla situazione che emerge nel momento in cui il giudice nel risolvere il caso che sta trattando non trovi nelle direttive che gli 213 Ibidem, pag. 264. 214 Ibidem, pp. 264-265.
209
provengono dal diritto una risposta univoca215, questo è, se mai, il caso, assai diverso, delle lacune del diritto, che in un ordinamento, come quello italiano, iper-giuridicizzato non sono né frequenti né usuali.216 215 E’ anche questo il senso della definizione di discrezionalità proposta da Aharon Barak, autore di un magistrale volume sull’argomento, il quale nel definirne il concetto afferma: “per me discrezionalità significa il potere conferito ad una persona dotata di autorità di scegliere tra due o più alternative, ciascuna legittima. Il Giudice Sussman alludeva a questa definizione quando diceva «discrezionalità significa la facoltà di optare tra due o più possibili linee di azione, ciascuna pensata come legittima». Il potere discrezionale del giudice rinvia allora alla facoltà, accordatagli dal diritto, di decidere tra parecchie alternative legittime. Tale definizione ipotizza, naturalmente, che il giudice non agisca in modo meccanico, ma valuti la situazione, rifletta, tragga impressioni, verifichi e studi gli elementi del problema. Eppure, quest’uso consapevole della facoltà del pensiero non definisce il nostro concetto, ma suggerisce solamente come il giudice debba agire nell’ambito del proprio margine discrezionale. Anzi, la discrezionalità per definizione, non è un atteggiamento né mentale né emozionale, bensì piuttosto una condizione di diritto in cui il giudice è libero di scegliere tra un certo numero di alternative. Laddove la discrezionalità esiste, è come se il diritto dicesse: ho determinato il contenuto di una norma giuridica fino a questo punto. Da qui innanzi, spetta a te, giudice, stabilirlo, perché io, ordinamento giuridico, non sono in grado di dirti quale soluzione scegliere. E’ come se il cammino del diritto arrivasse ad un crocevia ed il giudice dovesse decidere – senza alcun criterio chiaro e preciso per orientarlo – quale strada prendere”. Cfr. A. Barak, Judicial Discretion, Shikul Daat Shiprety, 1987, trad. it. La discrezionalità del giudice, Giuffrè, Milano 1995. Il passo citato è a pag. 16. 216 Quanto al concetto di discrezionalità come scelta tra due o più alternative possibili fornite dal diritto nota Adrián Rentería Díaz rientra quel senso di discrezionalità che si usa chiamare “intenzionale”, in quanto originato da precise scelte del legislatore, in modo, appunto, intenzionale, ad esempio lasciando al giudice la possibilità di scelta tra un determinato tipo di sanzione oppure tra un margine minimo e uno massimo di pena. Ma rientra anche il senso di discrezionalità, riconosciuto anch’esso in sede teorica, da Kelsen per esempio, dovuto al fatto che la norma non è che una cornice all’interno della quale è il giudice a scegliere uno dei possibili significati. La posizione di Kelsen pare all’autore comprendere sia la discrezionalità di esclusivo carattere tecnico, sia la
210
Discrezionalità è per noi, senza voler dare alcuna definizione né avere la pretesa di darla, ma solo per l’uso del nostro discorso, semplicemente la discrezionalità di decisione nel caso concreto, ossia l’assunzione di una decisione in base al libero convincimento che il giudice riceve dall’esame del caso concreto. In ultima analisi, il fatto si sostanzia nella decisione, e questa determina il fatto. E’ di tutta evidenza che il fatto, giudiziariamente tale, in tutti i campi del diritto, non esisterebbe, come in realtà non esiste, senza un decisione del giudice; è la decisione del giudice che “crea” il caso concreto, giudiziariamente inteso, diversamente non esisterebbe. La verità finale della decisione, comunque la si consideri, è quella fissata dalla statuizione del giudice.217 Certo, non siamo così ingenui dal ritenere che esista una doppia verità, una verità formale o “giuridica” ed un’altra materiale e irraggiungibile, né ci sfuggono, al riguardo i preziosi rilievi di Michele Taruffo, secondo cui questa distinzione, tanto frequente nella letteratura giuridica sulla prova, è una vera e propria distorsione giuridica, e ciò per varie ragioni. Innanzitutto perché – afferma l’autore – accettare questo orientamento significherebbe ammettere che fuori dal processo sia possibile conseguire una verità che per misteriose ragioni il giudice non può raggiungere, sino a una netta e non giustificata sopravvalutazione dell’impatto limitativo che le regole processuali possono avere sulla conoscenza dei fatti da parte del giudice. Tra l’altro, – nota ancora l’autore – l’appiattimento del discorso sull’idea della sola verità «processuale», legata alle norme sulle prove, preclude ogni approccio critico a queste norme perché – eliminando a priori ogni termine di confronto per quanto attiene ai metodi di accertamento dei
discrezionalità concernente questioni connesse anche alle attività di individuazione-interpretazione del materiale normativo e ricostruzione dei fatti. Cfr. A. Rentería Díaz, Il labirinto della giustizia, cit. pag. 41. 217 Per una approfondita analisi, a più voci, sul tema della verità nel processo non possiamo non rimandare all’ integrale lettura del recente volume Processo e verità, a cura di A. Mariani Marini, Plus Edizioni, Pisa 2005, ed alla accurata letteratura cui questo volume rinvia.
211
fatti – impedisce di valutare quali norme siano più adatte, e quali siano invece inadatte, ai fini dell’accertamento giudiziale della verità dei fatti.218 Prima di lui altre autorevoli voci hanno spazzato via questa sorta di equivoco, valga per tutti la posizione di Carnelutti il quale ha affermato che questa distinzione altro non è che una metafora, “nella sostanza è affatto agevole osservare -afferma l’autore- come la verità non possa che essere che una, onde la verità formale o giuridica o non coincide con la verità materiale, e non è verità, o ne diverge, e non è che una non verità” 219, in sostanza la verità è “come l’acqua o è pura o non è verità”. 220 Come ha ben sottolineato Pietro Ruggeri221 il processo civile, come ogni altro processo, non porta ad un giudizio di verità ma semplicemente ad un giudizio di probabilità, ove tuttavia il giudicato crea una situazione di certezza giuridica. Ma come ha magistralmente osservato Chiovenda “i fatti rimangono quelli che furono, né l’ordinamento giuridico prevede che siano considerati veri quelli che il giudice ritenne come base della sua decisione, egli si limita ad osservare che la volontà della legge nel caso concreto è ciò che il giudice afferma essere la volontà della legge”.222 E Calamandrei ribadisce questo concetto affermando che “quando si dice che un fatto è vero, si vuol dire in sostanza che esso ha raggiunto nella coscienza di chi tale lo giudica, quel grado massimo di verosimiglianza che, in relazione ai limitati mezzi di conoscenza di cui il giudicante
218 M. Taruffo, Presentazione al volume di Jordi Ferrer Beltrán, Prova e verità nel diritto, Il Mulino, Bologna 2004, pag. 9. 219 F. Carnelutti, La prova civile, Edizioni dell’Ateneo, Roma 1947, pp.20-30. 220 Ibidem, pag. 34. 221 P. Ruggeri, «Giudizio di verità, Giudizio di probabilità e lealtà nel processo civile», in Processo e verità, a cura di A. Mariani Marini, cit. , pag. 79. 222 G. Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile, Jovene, Napoli 1956, vol. I, pag. 340.
212
dispone, basta a dargli la certezza soggettiva che quel fatto è avvenuto”.223 Ruggeri ha ben precisato questo punto: “l’accertamento della verità dei fatti – afferma - non è requisito assoluto del processo, ma più semplicemente una sua finalità tendenziale. E l’attività del giudice nella ricerca della verità (verosimiglianza) del fatto apparirà più incisiva se sorretta da un robusto potere discrezionale”.224 Una verità, questa, che Gianni Vattimo ha evidenziato con la massima incisività affermando che “ciò che chiamiamo vero è quello che si articola, formula, esprime secondo regole che a loro volta non possono chiamarsi verità in questo senso. In qualche modo, l’idea di verità come corrispondenza si può mantenere, a patto che si sia consapevoli che tale corrispondenza si misura con criteri che a loro volta non sono verificabili o falsificabili, pena il risalimento in infinitum che non ha nulla di diabolico, ma non soddisfa l’esigenza di definitività che sembra essere connessa alla nozione di corrispondenza. L’importanza della nozione di applicazione per l’ermeneutica filosofica sta tutta qui. Il giudice è colui che data una legge chiaramente formulata, scritta nei codici, la applica al caso concreto, riconoscendo in questo una fattispecie del principio contenuto nella legge. Tutto ciò che ha da fare con il riconoscimento della fattispecie è evidentemente legato alla applicazione, al giudizio del giudice. Anche se ci si ferma a questo aspetto dell’applicazione, è chiaro che non si può parlare in termini di vero e falso nel senso metafisico della parola. Ma del fatto come tale, dovunque poi il giudice lo voglia sussumere, si potrà parlare in termini di verità oggettiva?.”225 La risposta del filosofo è di una semplicità e di una logicità disarmante: “sapere e dire esplicitamente tutto questo, articolare una concezione ermeneutica della verità di contro alla visione ingenua, ma in fondo
223 P. Calamandrei, Studi sul processo civile, Cedam, Padova 1950, pag. 111. 224 P. Ruggeri, «Giudizio di verità, Giudizio di probabilità e lealtà nel processo civile», cit. pag. 79. 225 G. Vattimo, «Verità e interpretazione», in Processo e verità, a cura di A. Mariani Marini, cit., pp. 13-14.
213
ideologica del processo come accertamento della verità dei fatti, giova a qualcosa?”. La domanda ci pare pleonastica la risposta scontata. La verità, lo ribadiamo, è quella che emerge dalla decisione, quella che la decisione stessa crea, nessun’ altra che questa. Perché, come afferma Hart, le ambiguità del linguaggio, la diversità delle circostanze, l’indeterminatezza dei fini pubblici sono le ragioni che garantiscono alla discrezionalità un ruolo perenne nell’ordinamento giuridico e fanno della sua eliminazione un sogno impossibile.226 A queste splendide parole se ne accompagnano altre, piene di saggezza e forse anche di speranza di Aharon Barak: “come si deve esercitare la discrezionalità di cui gode il giudice? –si domanda l’autore- Non ho risposte definitive a simili interrogativi –è la sua risposta-. Il mondo del diritto è vasto e grande ed è pieno di bellezza e di saggezza. E’ più che naturale che non esista un solo sentiero che lo attraversi, e che si possano percorrere diverse strade per gustare le sue bellezze o per assaporare il tepore della sua saggezza”.227 Noi men che meno, rispetto a queste prestigiose voci, possediamo ricette o soluzioni, ma siamo supportati soltanto da modeste osservazioni che valgono a confermarci sempre più nella convinzione che la verità nel giudizio è solo la verità del giudizio, la discrezionalità della decisione tutto ammanta e tutto coinvolge. Tutto il resto è puro esercizio di fantasia, di rimpianto, di desiderio, di delusione, ma null’altro che questo. E tutto cio’ in nome del popolo italiano? Di tutto il popolo italiano? 4. La prova alla prova
226 H. L. A. Hart, The concept of law, Oxford University Press, London 1961, trad. it., Il concetto di diritto, a cura di M.A. Cattaneo, Einaudi, Torino 1965. 227 A. Barak, Judicial Discretion, cit. pag. 234.
214
Per completare la nostra analisi sulla discrezionalità nel giudizio manca di parlare di uno degli aspetti in cui la discrezionalità raggiunge il suo massimo livello, la valutazione delle prove. Non vogliamo affatto scendere sul terreno del tecnicismo, appannaggio esclusivo, o quasi, dei processualisti, e che a noi, ai fini della presente analisi interessa, in verità, assai poco; ma qualche collegamento con il tema che stiamo trattando, ai fini del completamento del ragionamento che stiamo sviluppando, ci pare doveroso fare. In un libro assai recente Jordi Ferrer Beltrán228 sviluppa una analisi sul tema di una chiarezza esemplare unita a doti di sintesi davvero apprezzabili, su questa sintesi costruiamo il nostro ragionamento. Due, tralasciando le sfumature teoriche, le tesi che si contrappongono in tema di prova e verità, la prima che sostiene l’esistenza di una relazione concettuale, in base alla quale la verità di una proposizione è una condizione necessaria ma non sufficiente perché possa dirsi che questa condizione è stata provata, e questa deve considerarsi tale se è vera e vi sono elementi di giudizio sufficienti a suo favore. E’ questa la concezione che è stata per gran tempo dominante ma che oggi è nettamente in decadenza. La seconda tesi sostiene che tra prova e verità non esisterebbe altro che un nesso teleologico, cioè non attribuisce alla verità alcun ruolo definitorio di prova ma la considera l’obiettivo ultimo dell’attività probatoria, e che, quindi, la finalità ultima dell’attività probatoria sarebbe quella di raggiungere la verità dei fatti accaduti, la descrizione dei quali si tramuterà nella premessa del ragionamento. La differenza tra le due tesi è davvero abissale: la prima presuppone il legame tra verità e prova come risultato (prende, cioè, posizione sulla possibilità che una proposizione su un fatto sia provata e risulti, al tempo stesso, falsa), la seconda propone, invece, una relazione tra verità e prova come attività probatoria.229 Chi intende adottare una nozione generale di prova al fine di spiegare la nozione di prova giuridica –afferma Ferrer Beltrán- deve necessariamente rendere conto degli aspetti specifici che il diritto e il 228J. Ferrer Beltrán, Prova e verità nel diritto, cit. 229 Ibidem, pp. 62-63
215
processo, come ambito nel quale si sviluppa la prova, impongono a questa nozione, in particolare si può ritenere che questi aspetti specifici provengono principalmente da tre tipi di limiti. Il primo limite riguarda il contesto in cui si sviluppa l’attività probatoria, al termine della quale il giudice o il tribunale devono decidere sui fatti. Il secondo limite processuale che incide in modo rilevante sulla relazione tra prova e verità è l’istituto del giudicato. Il terzo limite alla possibilità di conoscere la verità delle proposizioni sui fatti nell’ambito del processo è dato dall’esistenza, in ogni ordinamento giuridico moderno, di un’apprezzabile quantità di regole giuridiche sulla prova.230 Questi limiti, processuali e non processuali (principalmente l’interesse delle parti), che possono interferire nella determinazione della verità degli enunciati che dichiarano l’accertamento dei fatti, fanno sì che in alcuni casi si possano considerare provati enunciati falsi, da qui sorge la necessità di spiegare, in qualche modo, i casi in cui il normale svolgimento del processo conduce a un accertamento dei fatti che si allontana da quanto realmente accaduto. Dinanzi a questa esigenza sembrano presentarsi due alternative esaustive: o si abbandona la definizione di prova in termini di verità, cioè la relazione concettuale tra le due nozioni, o si sostiene che nei casi in cui si dichiara provato un enunciato sui fatti che risulta falso, esso, in realtà, non è provato. La dottrina tedesca di fine ottocento e successivamente la gran parte della dottrina europea in materia sino ai nostri giorni ha tentato di sottrarsi a questo dilemma proponendo la distinzione tra verità materiale e verità processuale, la prima definita anche oggettiva o reale, la seconda definita formale o processuale. La verità materiale è quella di cui si discute al di fuori del processo, la verità formale è quella che si ottiene nel processo come risultato dell’attività probatoria, questo tipo di verità può coincidere o meno con quella che si ottiene nel processo come risultato dell’attività probatoria e sarebbe auspicabile che coincida ma sarebbe quella che godrebbe di autorità pubblica.. E’ da notare che, secondo questa concezione, indipendentemente dalla coincidenza con i fatti come realmente accaduti, si attribuisce la qualifica di formalmente 230 Ibidem, pp. 65-69.
216
vero all’accertamento dei fatti compiuto dal giudice o dal tribunale nella sentenza; quest’accertamento può essere confermato o revocato e sostituito da una autorità giudiziaria di grado superiore ma una volta che la sentenza sia divenuta immutabile è l’unica verità che interessa il diritto, in tal modo l’accertamento dei fatti compiuto dal giudice diviene vero, in senso formale, per il solo fatto di essere stato emesso dall’organo giudiziale.231 Abbiamo già detto che a partire da Francesco Carnelutti in Italia si è manifestato un forte dissenso verso questa distinzione e della forte avversione manifestata verso di questa da Michele Taruffo che la considera una vera e propria distorsione, sulla base di alcune osservazioni assai pertinenti, la prima delle quali è che seguendo questa distinzione si perviene inevitabilmente ad una netta e ingiustificata sopravvalutazione dell’impatto limitativo che le regole possono avere sulla conoscenza dei fatti da parte del giudice, e più ancora che questa distinzione preclude l’approccio critico alle norme sulle prove perché eliminando a priori ogni termine di confronto per quanto attiene ai metodi di accertamento dei fatti impedisce di valutare quali norme siano più adatte, e quali siano invece inadatte, ai fini dell’accertamento giudiziale della verità dei fatti.232
231 Ibidem, pp. 70-72. J. Ferrer Beltrán avverte che “ciò non vuol dire, tuttavia, che il giudice abbia totale discrezionalità nel determinare i fatti provati, o che possa farlo a suo libero arbitrio. Può anzi accadere che il giudice o il tribunale abbiano l’obbligo giuridico di tentare di scoprire i fatti come realmente accaduti, cioè la verità materiale. In ogni caso, si possono anche avere norme che impongono determinati risultati probatori in presenza di determinati mezzi di prova. La violazione di questi obblighi può dare luogo ai relativi mezzi di impugnazione e alla revocazione della decisione giudiziale da parte di un organo superiore. Ciò nonostante, la distinzione tra verità materiale e verità formale pone l’accento sull’autorità che si attribuisce all’accertamento dei fatti compiuto dal giudice e sulla irrilevanza giuridica della verità materiale una volta risolta la controversia”. 232M. Taruffo, Presentazione al volume di Jordi Ferrer Beltrán, Prova e verità nel diritto,cit., pag. 9.
217
Accanto a queste due concezioni altre si sono negli anni andate sviluppando, due in particolare, l’una secondo cui la prova consiste nel convincimento dei giudice sui fatti, l’altra della prova come certezza del giudice sui fatti, tra l’una e l’altra le sfumature teoriche sono davvero poco più che un dettaglio. La prima di queste due teorie in nulla o poco più differirebbe a parere di Ferrer Beltrán da quella che propugna la distinzione tra verità materiale e verità formale e condurrebbe, sostanzialmente, ad un concezione non razionale della prova, secondo cui è provato quello che il giudice o il tribunale dichiara provato. La seconda patirebbe le stesse critiche della precedente, in quanto anche in questo caso si possono riproporre le stesse critiche, se, infatti, si sostiene che la finalità della prova come attività è quella di raggiungere la convinzione del giudice sui fatti, questa finalità sarà soddisfatta indipendentemente dalla direzione che prende quella convinzione, se è in accordo o meno con i fatti realmente accaduti e anche se è, o meno, la conclusione che si doveva ottenere alla luce degli elementi probatori presenti agli atti di causa.233 La proposta dell’autore si riferisce alla distinzione, nell’ambito del rapporto tra prova e verità, di una proposizione tra «l’essere vera» e «l’essere considerata vera», in sostanza la classica nozione di verità come corrispondenza, in questo modo -afferma l’autore- la verità di un enunciato probatorio non dipende da ciò che il giudice o il tribunale o una giuria risolvono ma dipende esclusivamente dalla sua corrispondenza con la realtà. In questo caso, dipende dal fatto che effettivamente esistano o meno elementi di giudizio sufficienti a favore del fatto sottoposto alla prova che siano stati assunti nel processo. E quindi, in sostanza, l’elemento di novità nella teoria della prova proposta dall’autore sarebbe quello della sufficienza degli elementi di giudizio e per far ciò occorre essere in possesso di una teoria sulla sufficienza degli elementi di giudizio.234 Uno sforzo teorico questo certamente apprezzabile, a nostro avviso, e decisamente suggestivo, che però finisce anch’esso con l’imbattersi 233 J. Ferrer Beltrán, Prova e verità nel diritto, cit, pag. 77. 234 Ibidem, pag. 91.
218
nell’elemento ultimativo di questo processo di corrispondenza, o di sufficienza degli elementi di giudizio, che è dato dalla decisione del giudice; è sempre e soltanto questa decisione a stabilire la corrispondenza o la sufficienza degli elementi di giudizio, e nient’altro che questo. Ritorniamo alla relazione teleologica tra prova e verità, è questo il filone interpretativo prevalente nel cui ambito si sviluppa la migliore dottrina nel nostro paese. Alessandro Giuliani autore di una monumentale opera sulla prova, di natura filosofico-giuridica235, datata ma ancor oggi un monumento per chi voglia informarsi sull’argomento, sostiene che il processo di formazione del convincimento del giudice non è libero, è regolato in forma astratta e preventiva da un complesso meccanismo di restrizioni alla libertà di valutazione, le prove legali; un sistema questo, delle prove legali, che tende a risolversi un una fissazione formale. E dunque il momento probatorio si presenta alla mente del legislatore anziché a quello del giudice ed il legislatore -secondo l’autore- parte da un’idea del normale, che riguarda la media dei casi, ma è evidente altresì che lo scopo politico di un sistema di prove legali può essere perseguito a condizione di trascurare la individualità, la concretezza del fatto storico, che è oggetto dell’accertamento giudiziale. Se il giudice applica criteri di valutazione fissati in anticipo, è implicito un atteggiamento tecnico, formalista, se non addirittura burocratico nella ricerca del fatto. L’aspetto più evidente di questo meccanismo proposto dall’autore è il trasferimento del centro di gravità intorno a cui viene costruito l’edificio della prova, dalla testimonianza al documento236. Ci sia consentito dissentire da questa autorevole voce, sembra a noi che se si oggettivizza l’indagine sulla prova “burocratizzandola” sul piano dell’accertamento si può rischiare di perdere il contatto con il caso concreto e con le sfumature di questo che assai di frequente fanno la differenza con qualsiasi stereotipo normativo e lo rendono unico rispetto a questo e rispetto a qualsiasi altro caso concreto. L’accertamento sulla 235 A. Giuliani, Il concetto di prova, Giuffrè, Milano 1961. 236 Ibidem, pag. 246.
219
“unicità” del caso dipende sempre e soltanto dal giudice che decide il caso. Una posizione assai convincente, ai nostri occhi, esprime Achille Melchionda: “una indiscriminata esaltazione del principio del libero convincimento del giudice rischia di favorire una sorta di anarchia nelle operazioni del giudice, negli ordinamenti moderni, che hanno acquisito consapevolezza delle necessità che il sistema probatorio sia fondato su basi razionali, può servire da cortina per mascherare operazioni autoritarie. E’ proprio dal confronto costante, dal vigile controllo della conformità delle discipline alle situazioni politiche, economiche e sociali che nasce la possibilità di distinguere quanto attenga alla forma, necessaria per la vita di qualsiasi fenomeno processuale, e al formalismo, ossia alle scorie di una disciplina che non ha mai avuto o che non ha più ragione d’esistere”.237 Un’altra autorevole voce che si esprime sui limiti del libero convincimento del giudice è quella di Giulio Ubertis: “al sistema della prova legale, ormai pressoché completamente respinto dal nostro ordinamento processuale penale si contrappongono quelli che lasciano al giudice piena libertà di apprezzamento delle risultanze istruttorie. A questo proposito, infatti, è d’obbligo chiarire come la dottrina più attenta abbia sostituito alla più schematica antitesi prova legale-libero convincimento una più esatta tripartizione per la quale il convincimento giudiziale sembra doversi distinguere in «intimo convincimento» ed in «libero convincimento». Col primo sistema ci si riferisce ad una attività mentale del giudice traducentesi in una scelta intuitiva e, al limite, arbitraria. Col secondo, invece, si intende esprimere soprattutto lo svincolamento del giudice dal «tariffario» previsto per le prove legali restituendogli piena libertà nelle sue decisioni, che però devono essere ragionevolmente fondate e giuridicamente motivate. Che al giudice competa, senza intervento alcuno del legislatore, -è la nota più incisiva dell’autore- di liberamente valutare i fatti secondari così come di pronunciarsi in tema di concludenza probatoria non significa 237 A. Melchionda, voce «Prova», in Enciclopedia del Diritto, vol. XXXVII, Giuffrè, Milano 1988.
220
abbandonarsi ad una immagine del libero convincimento come di una vorace potenza superlogica, che trae il proprio alimento da tutto ciò che anche per un solo istante sia comparso sulla scena del processo.”238 In conclusione, comunque la si voglia considerare la problematica della prova, quale che sia la teoria cui ci si sente scientificamente più affini, quale significato, dal più vasto al più restrittivo, si voglia attribuire all’espressione, ed al concetto, di libero convincimento del giudice, resta comunque un dato ineliminabile, perché connesso all’idea stessa del processo, che tanto l’una quanto l’altro sono così intimamente legati all’idea stessa della decisione da costituire un tutt’uno con questa. Una verità scontata finché si vuole, persino lapalissiana nella sua essenza, ma una ed una soltanto: la decisone è onnivora rispetto all’intero processo e tutto ammanta della sua forza di giudizio. E tutto questo in nome del popolo italiano, dell’intero popolo italiano? 5. A mò di conclusione Giunti a questo punto qualche risposta in più al quesito che ci ha accompagnato lungo tutto il percorso della nostra analisi, rispetto all’inizio, confessiamo di possederla, ma confessiamo anche di aver l’impressione che queste risposte siano molto simili a quelle della nostra premessa, solo più confortate, rafforzate e corroborate dall’esame di molte e molte voci tratte dalla migliore letteratura scientifica, tutte assai autorevoli e prestigiose, cui ci siamo rivolti per affidare la nostra serenità di giudizio, e che spesso abbiamo inteso direttamente citare. Il tema che ci siamo proposti di trattare si è sviluppato, per così dire, “a corolla”, più si è tentato di sfogliarlo più si è ampliato e reso più sottile e più complesso, ma confessiamo che anche questo sapevamo e avevamo immaginato nelle nostre premesse, né poteva essere diversamente. Si tratta, in realtà, del tema dei temi del processo, il punto focale di cui il processo, inteso nella sua interezza, come concezione teorica oltre che 238 G. Ubertis, Voce «Prova», in Enciclopedia Giuridica, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma 1991, vol. XXV, pag. 10.
221
pratica, della logica tutta del processo giudiziario, insomma, si nutre, e non potevamo eludere una serie di quesiti che lungo tutto il cammino ci si sono parati innanzi, e tutti riconducibili a un unico quesito, quello iniziale. Il quesito si è fatto mano a mano sempre più stringente ma, a ben guardare, non è mai mutato né ha cambiato direzione. Il rapporto iniziale giudice-decisione da dicotomico si è fatto tricotomico giudice-discrezionalità-giudizio e più oltre si è arricchito ancora di un elemento che lo ha reso ancor più complesso, giudice-discrezionalità-valutazione della prova-giudizio, in una rincorsa alla complicazione che ricorda da vicino quei giochi matematici in cui l’aggiunta di una variabile aumenta a dismisura il numero delle possibili soluzioni, non proporzionalmente all’aggiunta della variabile stessa, ma con un aumento esponenziale di soluzioni possibili. Il massimo della complicazione, che equivale al massimo delle soluzioni possibili, si raggiunge quando in questa relazione si introduce l’elemento della “norma” ossia l’elemento politico che avvolge l’intera relazione e la coinvolge in un complicato, e, talora complicatissimo gioco di interpretazione, che ne sposta l’ottica da un piano strettamente tecnico ad un più ampio e più scivoloso. La decisione si sposta, allora, da un piano tutto interno al processo per sconfinare, volutamente o meno, comunque, necessariamente, in uno più direttamente “politico”, politico in generale, beninteso, non certo di politica di parte o di schieramento. Questo elemento dell’interpretazione e dell’applicazione dell’elemento politico sposta l’analisi da un piano del caso singolo, del caso concreto su cui e con cui sta operando la decisione, ad uno più generale in cui il caso concreto è valutato, deve essere valutato, in un’ottica più generale e meno contingente. E’ quel succede quotidianamente nei tribunali, in tutti i tribunali di ogni grado e genere, in cui all’effetto decisione, del caso singolo, si innesta quello più generale dell’effetto trascinamento, per effetto di quella relazione di cui abbiamo detto poco sopra e che è stata all’attenzione della nostra analisi lungo tutto il suo percorso, senza mai perderla di vista neanche per un attimo. Si determina così il “precedente” o la “prassi” o
222
il “rito” come un po’ sarcasticamente, e in senso niente affatto tecnico, usano dire gli operatori del diritto per riferirsi agli orientamenti giurisprudenziali vigenti in alcuni tribunali e non in certi altri. E come negare, inoltre, che le sentenze, specie quelle della Suprema Corte, “instaurino” vere e proprie prassi sociali che si consolidano nei comportamenti collettivi fino a quando non ne intervenga una diversa? E come negare, ancora, che i giudici di merito si riferiscono nei loro giudizi proprio a quelle sentenze che sono ormai “consolidate” e che hanno costituito “prassi” giudiziaria? Non si pensi sempre e soltanto al processo penale come al processo tipico del nostro mondo giudiziario e nel nostro mondo giudiziario, il processo penale è, se mai, l’elemento, e il momento, patologico di questo, ma è il processo che meno coinvolge la quantità maggiore di cittadini, proprio perché tratta dell’elemento patologico nella relazione fra questi e lo Stato, ben diversamente del processo civile o di quello amministrativo, e in parte anche tributario, in cui assai di frequente è in gioco l’elemento fisiologico di questo rapporto. Non si pensi sempre e soltanto al processo penale in cui il “fatto” è, nella stragrande maggioranza dei casi un unicum, un dato unico ed irripetibile, anche fenomenologicamente, si pensi piuttosto ai tanti, e numericamente assai più numerosi, procedimenti seriali specie in materia civile o amministrativa in cui la decisione è, di frequente, anch’essa seriale, in cui, per dirla tutta, dalla giustizia del caso singolo si passa alla giustizia del caso collettivo, e questo, ci sia consentito dire, ci pare davvero preoccupante. In sostanza non vediamo chi possa negare che si assiste sempre più nel nostro ordinamento, che è un ordinamento tipico di civil law, all’introduzione di elementi, sempre più diffusi, importati dagli ordinamenti di common law, specie con riferimento ai “precedenti” giudiziari”, per cui sostanzialmente da una giustizia del caso singolo si passa progressivamente, ma inesorabilmente, a decisioni di carattere seriale che riconoscono come precedenti consolidati o prassi dati dai precedenti giurisprudenziali della Corte Suprema o dai tribunali dei diversi gradi in cui la sentenza viene forgiata.
223
Gli stessi tribunali si riferiscono, d’altronde, sempre più a prassi decisorie interne in cui, di frequente ed anzi assai spesso, il precedente è non solo l’elemento guida della decisione ma anche l’unico elemento della decisione stessa. E tutto questo in nome del popolo italiano? Una risposta a questo punto si impone. Eppure, preferiamo non darla, la lasciamo liberamente alla scelta di chi legge seppure crediamo che questi ha già chiaramente più di un sospetto su l’idea che vorremmo proporre e che crediamo emerga con assoluta chiarezza da tutto quanto abbiamo fin qui detto. La risposta la lasciamo a una delle voci che più abbiamo amato e amiamo nel panorama delle scienze letterarie e sociali del secolo scorso Friedrich Dürrenmatt: “il mondo è disordine e poiché si trova in uno stato di disordine, il mondo è ingiusto. Questo principio è così evidente che lo prendiamo per vero senza pensarci su. Ma in verità è un principio problematico perché è problematica la giustizia. Se vogliamo costruire un ordinamento sociale giusto, esistono due possibilità di costruirlo partendo dal materiale uomo di cui disponiamo. Possiamo partire dal concetto particolare di uomo, ossia dall’individuo, o dal concetto generale di uomo, ossia dalla società. Dobbiamo scegliere. Prima di scegliere, però, dobbiamo capire che tipo di giustizia si possa realizzare con un ordinamento sociale. Se l’uomo tuttavia stabilisce due concetti di sé, egli ha anche due idee di giustizia. Il diritto del singolo consiste nel fatto di essere se stesso: chiamiamo questo diritto libertà. La libertà è un concetto particolare che ognuno si fa della giustizia, l’idea essenziale della giustizia. Il diritto della società, invece, consiste nel garantire la libertà di ciascuno, cosa che essa può fare soltanto limitando la libertà di ciascuno. Questo diritto lo chiamiamo giustizia, intesa come il concetto generale di giustizia, come idea logica. La libertà e la giustizia sono le due idee con cui opera la politica, con le quali tiene in pugno l’uomo prendendo in considerazione entrambe le idee. Se la politica lascia cadere una delle due idee diventa sospetta. Senza libertà essa diventa disumana e senza giustizia pure. Si può immaginare un mondo di libertà assoluta e un mondo di giustizia assoluta. Questi due mondi non coinciderebbero ma sarebbero in contraddizione l’uno con l’altro. Essi
224
costituirebbero un inferno, il mondo della libertà assoluta sarebbe una giungla, in cui si dà la caccia all’uomo come si dà la caccia a un animale, mentre il mondo della giustizia assoluta sarebbe una prigione, in cui l’uomo viene torturato a morte. L’arte impossibile della politica consiste nel conciliare l’idea emotiva della libertà con l’idea intellettuale della giustizia, cosa possibile soltanto sul piano della moralità e non sul piano della logica. In altre parole, la politica non può mai essere una scienza pura.”239 E, aggiungiamo noi, neanche la giustizia.
239 F. Dürrenmatt, I dinosauri e la legge, Einaudi, Torino 1995, pp. 21-22.