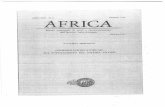USAI A. 2011, Popolamento e organizzazione del Montiferru in età nuragica, in SPANU P. G., ZUCCA R....
-
Upload
archeocaor -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of USAI A. 2011, Popolamento e organizzazione del Montiferru in età nuragica, in SPANU P. G., ZUCCA R....
1
Popolamento e organizzazione del Montiferru in età nuragica
Alessandro Usai*
Testo autografo 1. Premessa
La presente comunicazione trae spunto dalla ricerca che lo scrivente conduce dal 1994 nell’ambito delle attività istituzionali della competente Soprintendenza su tutto il territorio dell’alto Oristanese, con la collaborazione delle amministrazioni comunali e del Corpo forestale e di vigilan-za ambientale, al fine di contribuire alla conservazione e valorizzazione delle aree di interesse ar-cheologico nel quadro di una politica condivisa e coordinata di conoscenza, pianificazione e gestio-ne delle risorse del territorio.
Il lavoro si sviluppa sulla base di tutte le ricerche condotte in precedenza nella regione del Monti-ferru1 (fig. 1), con particolare riguardo alle testimonianze prenuragiche e nuragiche2. All’indagine topografica, mirata alla revisione critica dei dati ricavati dalle varie fonti e alla documentazione del-lo stato attuale dei siti, si accompagnano gli interventi sul terreno: interrotta da tempo l’esplorazione del nuraghe Cobulas di Milis (Santoni et al., 1991), negli ultimi anni sono stati effettuati interventi preliminari nei nuraghi Tunis, Araganzola e Sa Muralla e nell’abitato presso la chiesa di San Pietro di Narbolia3 ed è stato avviato lo scavo del nuraghe Nuracale di Scano Montiferro4. 2. Caratteri generali dell’insediamento nuragico
La documentazione archeologica pertinente alle varie fasi di sviluppo della civiltà nuragica nel Montiferru, dal Bronzo medio al Bronzo finale- Prima Età del Ferro, è straordinariamente abbon-dante e varia. Lo studio approfondito del territorio e della cartografia permette di riconoscere alcuni aspetti fondamentali del popolamento e delle forme di organizzazione; in particolare si possono di-stinguere, in aree geograficamente delimitate, veri e propri sistemi territoriali o cantoni, ciascuno dei quali definito dalle particolari relazioni esistenti tra i nuraghi di diverso tipo (arcaici, semplici e complessi), gli abitati, i centri cerimoniali, le aree funerarie, le risorse diffuse o localizzate, le vie di comunicazione interna ed esterna, i punti di contatto o di scambio, le frontiere naturali e le zone di-sabitate più o meno vaste riservate allo sfruttamento estensivo o alla frequentazione saltuaria. Cia-scun sistema territoriale si articola in un numero variabile di agglomerati insediativi, veri e propri organismi policentrici composti da un numero variabile di siti funzionalmente interdipendenti (Usai, 2006, 2009).
Sulla base di queste premesse, il popolamento nuragico del Montiferru appare articolato in alme-no tre grandi sistemi territoriali (fig. 1): quello settentrionale, corrispondente a parte dei territori di Scano Montiferro e Sennariolo, con appendici pertinenti a Cuglieri e a Santu Lussurgiu; quello oc-cidentale, comprendente la maggior parte del territorio di Cuglieri e una fascia marginale suddivisa amministrativamente tra Santu Lussurgiu e Seneghe; quello orientale e meridionale, che occupa la
* Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Cagliari e Oristano. 1 Il Montiferru è il maggiore edificio vulcanico dell’intera Sardegna, responsabile di buona parte delle colate basalti-
che che coprono vaste aree dell’Oristanese e della Planargia: MELE (1993). 2 TARAMELLI (1935), foglio 205 (Capo Mannu) e foglio 206 (Macomer); PIRAS (1952-53); PES (1953-54); TORE,
STIGLITZ (1987, 1992); MANCA (2002). Dalle tesi di laurea di A. Piras e P. Pes derivano le schede e i disegni riporta-ti in LILLIU (1962). Si ricordano inoltre le ricerche svolte da M. G. Campus nel territorio di Cuglieri, nell’ambito del progetto di censimento archeologico ai sensi della legge 285/1977, nonché le prospezioni e i recuperi effettuati dal signor A. Meridda nei territori di Milis, Narbolia e Seneghe.
3 Lavori condotti dallo scrivente negli anni 2000, 2001 e 2005 con la collaborazione di Alfonso Stiglitz, Ottavio Mura, Marie France Ruf-Usai e Lucilla Campisi: USAI (2005).
4 A. USAI, T. COSSU, F. DETTORI, Primi dati sul contesto tardo-romano e alto-medievale dal nuraghe Nuracale di
Scano di Montiferro, in questi Atti.
2
maggior parte dei territori di Santu Lussurgiu, Bonarcado, Seneghe, Milis e Narbolia. Il sistema o-rientale e meridionale è separato dagli altri due da un’ampia fascia disabitata che segue su entrambi i versanti la principale cresta montuosa orientata da nord-nord-est a sud-sud-ovest; all’estremità sud-occidentale, dove il rilievo si addolcisce fino a svanire, la fascia disabitata si prolunga fino al mare in corrispondenza del deserto sabbioso di Is Arenas e del basso corso del Riu Pischinappiu. Il limite tra il sistema occidentale e quello settentrionale sembra rappresentato in parte dai crinali montani a sud di Cuglieri, in parte dalla profonda vallata dell’asse fluviale Riu Abba Lughida-Marafè-Mannu. Un ruolo altrettanto importante riveste certamente anche l’altra diramazione del Riu Mannu, che scorre profondamente incassata a nord di Scano Montiferro e che con grande verosimi-glianza separa il sistema settentrionale del Montiferru da quello della Planargia occidentale (Tresnu-raghes, Flussio, Sagama). Ugualmente, il limite orientale del Montiferru sembra segnato dalla gola del Riu Cìspiri, che separa i territori di Bonarcado e Milis da quelli di Paulilatino e Bauladu e che prosegue sul lato meridionale del massiccio coi nomi di Riu Canargia e Riu Mare ’e Foghe fino a sfociare nello stagno di Cabras5. Invece sul lato nord-orientale la delimitazione dei sistemi territoria-li nuragici del Montiferru da quelli della Planargia orientale (Sindia) e del Marghine occidentale (Macomer, Borore) appare sfumata e sembra indicata solo da un certo diradamento degli insedia-menti sugli altipiani risalenti verso il Monte Sant’Antonio. All’interno dei sistemi territoriali de-scritti si notano suddivisioni meno marcate e forse meno stabili, indicate da incisioni fluviali secon-darie: il Riu di Sennariolo nel sistema settentrionale, il Riu Fanne Scanu in quello occidentale, il Riu Maistu Impera-Perda ’e Pira, la Roia Narba e il Riu Sos Molinos-Mannu di Milis in quello o-rientale e meridionale.
Naturalmente questa proposta di suddivisione territoriale non deve essere intesa in termini statici e astratti, come una versione adattata e ammorbidita del sistema geometrico dei poligoni di Thies-sen; va invece intesa in senso dinamico e in prospettiva diacronica, come tendenza a superare una situazione iniziale di fluidità territoriale e a delineare progressivamente distinte aree di influenza, forse mai definitivamente cristallizzate.
In ciascuno dei tre sistemi territoriali descritti, i singoli agglomerati si articolano sul terreno coi diversi siti abitativi disposti come maglie di una rete più o meno fitta composta da trame orizzontali e da orditi verticali. Le trame orizzontali si distendono alle varie quote sulle pendici e sui versanti della montagna; schematizzando, potremmo distinguere quattro fasce concentriche, distinte secondo criteri insieme altimetrici e morfologici, che comportano variazioni graduali ma sensibili nei cicli termici e pluviometrici, nell’esposizione alla luce solare e ai venti dominanti, nell’attitudine produt-tiva dei suoli (fascia basale, fascia intermedia, fascia elevata, fascia sommitale)6. Gli orditi verticali sono ben evidenti nel gran numero di direttrici ascendenti e discendenti, che realizzano il collega-mento tra i diversi livelli altimetrici e assicurano l’integrazione delle risorse in essi presenti: sono le strade campestri, talora ben acciottolate e lastricate o rigate da profondi solchi di carri, probabilmen-te di origine nuragica, come indicano i nuraghi e gli abitati dislocati lungo il loro percorso e occupa-ti anche in epoca romana e alto-medievale7.
5 Il legame tra i territori di Narbolia e di San Vero Milis è confermato dal fatto che alcuni nuraghi di San Vero Milis
(tra cui il gigantesco S’Urachi) furono costruiti in zone alluvionali con blocchi basaltici appositamente trasportati dagli affioramenti di Narbolia.
6 La fascia basale (approssimativamente da 0 a 300 m s.l.m.) comprende le aree pianeggianti o leggermente ondulate ad alto potenziale agricolo, eccellenti per un sistema economico integrato (coltivazione di cereali e di leguminose, allevamento permanente di ovini, bovini e suini). La fascia intermedia (approssimativamente da 300 a 600 m s.l.m.) comprende le zone di media e alta collina utilizzate in piccola parte per l’agricoltura e soprattutto per l’allevamento stanziale o itinerante. La fascia elevata (approssimativamente da 600 a 900 m s.l.m.) comprende una serie di rilievi e di altipiani probabilmente in gran parte coperti da boschi, utilizzati per attività permanenti oppure periodiche o sta-gionali (allevamento itinerante, caccia e raccolta). La fascia sommitale (da 900 a 1.050 m s.l.m.) appare come una zona economicamente marginale, occupata da boschi e da affioramenti rocciosi, per lo più controllata a distanza e sfruttata con movimenti stagionali.
7 Sul ruolo delle vie di comunicazione nell’interpretazione dell’organizzazione gerarchica di un territorio nuragico cfr.
3
Il processo di popolamento è testimoniato principalmente dalla diffusione capillare dei monu-menti nuragici nelle loro forme evolutive più arcaiche e in quelle più standardizzate dei nuraghi cu-polati semplici e complessi, e via via anche dalla formazione dei nuclei insediativi più o meno strut-turati associati ai nuraghi o distanti da essi, sempre nell’ambito di agglomerati policentrici esercitan-ti un controllo collettivo su territori piuttosto ampi; ma un aspetto altrettanto significativo di questo processo, seppur meno percepibile, è rappresentato dalla parallela opera di bonifica del suolo, che viene per la prima volta estensivamente liberato dalla foresta mediterranea dominante e reso produt-tivo nelle forme consentite da un’organizzazione economica mista in cui si integrano l’agricoltura (cereali, leguminose, olivo, vite), l’allevamento stanziale e itinerante (ovini, caprini, bovini, suini), la caccia, la pesca e la raccolta di vegetali commestibili spontanei. 3. I sistemi territoriali
Nel cantone orientale e meridionale (fig. 2) il popolamento umano interessa fin dalle prime fasi del Bronzo medio l’ampia fascia basale e la fascia intermedia con nuraghi a corridoio o comunque di tipologia arcaica, isolati o raramente in coppia; la maggior parte dei monumenti sorgono su pen-dii più o meno accentuati, talora in posizioni dominanti sui corsi d’acqua, da una quota minima di 80 m s.l.m. (Tronza-Milis) a una massima di 550 (Perda Ruja-Seneghe), con una maggiore concen-trazione tra 250 e 450 m di quota (Scala ’e Cuaddus A-Narbolia; Narba, Cracheras, Banzos, Umbu-los-Seneghe; Aurras, Temannu, Scovera, Canargia, Cuau, Crastu, Sa Perdera-Bonarcado; Mura Matta-Santu Lussurgiu); ma i nuraghi Gianna Uda di Bonarcado e Riu de Sa Tanca di Milis sorgono addirittura nel fondovalle a diretto contatto col corso d’acqua, a testimonianza di una fase iniziale in cui le vallate fluviali anche più profonde non costituivano frontiere marcate. Nelle fasi successive del Bronzo medio, recente e finale si assiste a un processo prodigioso che comporta l’intensificazione del popolamento nelle fasce basale e intermedia e la colonizzazione della fascia elevata: soprattutto nella fascia basale si formano densi agglomerati caratterizzati da imponenti nu-raghi complessi (spesso trilobati o quadrilobati) e da estesi abitati (Cobulas, Mura ’e Cabonis-Milis; Tradori, Zoddias, Araganzola, Madavò, Procus, Sa Muralla, Terra Craccus, Maganzosa, Tunis-Narbolia; Masu Maiore, Codinas, Zacca, Arburi, Santu Perdu-Seneghe; Cuau, Muschiu, Loriosa-Bonarcado; Piricu-Santu Lussurgiu); lo stesso fenomeno, seppure in misura inferiore, si osserva nel-la fascia intermedia, dove si trova un numero non trascurabile di nuraghi complessi (Erba ’e Cag-gius, Lande-Narbolia; Campu, Sinzimurreddus-Seneghe; Nargius, Bruncu-Bonarcado; Zuanne Ma-dau-Santu Lussurgiu) e dove i fitti gruppi di nuraghi monotorri denotano uno sforzo intenso e forse anche pianificato tendente all’occupazione e alla messa in produzione di aree economicamente rile-vanti. Ancora nelle fasce basale e intermedia si conoscono pochi insediamenti senza nuraghe, sicu-ramente presenti in numero ben maggiore (Predu Ferradu-Santu Lussurgiu; Aidu ’e Muru-Seneghe; Campu Darè, Santu Perdu, Banatou, Mura-Narbolia); nelle stesse fasce più densamente abitate si di-spongono anche le sepolture, spesso accostate ai singoli nuclei insediativi ma talora raccolte in gruppi di due o tre presso gli abitati maggiori o addirittura concentrate in veri e propri complessi fu-nerari come quello di Campu Darè-Caratzu-Procus-Funtana ’e Pira di Narbolia8. Infine, nella fascia
PERRA (2008).
8 USAI (2005, pp. 31-32). Questo complesso funerario, composto da almeno dieci strutture megalitiche (non si esclude l’esistenza di altre tombe distrutte dagli spietramenti o nascoste dalla vegetazione), si distende sulle pendici del colle dove si trovano le due grotticelle prenuragiche di Campu Darè ed è raccolto in un’area di circa mezzo chilometro quadrato all’interno di un quadrilatero che ha ai vertici i nuraghi Niu ’e Crobu, Coronas, Procus e Accas e l’insediamento senza nuraghe di Campu Darè al centro del lato nord-orientale. Alla periferia sud-orientale si trovano il dolmen Caratzu I e le allées couvertes Caratzu II-III (TORE, STIGLITZ, 1992, pp. 93-94, tavv. III.1-2 e IV.42a-c); le sette tombe di giganti si raccordano alle più antiche sepolture megalitiche disponendosi a distanze comprese tra 100 e 200 m e formando due schemi a L simmetrici e contrapposti per i vertici, che difficilmente possono essere immagi-nati casuali. Nonostante scavi abusivi, parziali distruzioni e accumuli di pietrame, e nonostante le dimensioni piutto-sto ridotte, le singole tombe conservano una spiccata monumentalità, accresciuta dalla concentrazione e arricchita da piccole strutture accessorie talora presenti. Nessuna di queste dieci tombe è stata indagata scientificamente, per cui
4
elevata del monte si trovano solo nuraghi semplici piuttosto distanziati, limitati al versante meridio-nale in territorio di Seneghe fino a quota 800, attestati su posizioni dominanti nelle radure della fo-resta.
Nel cantone occidentale (fig. 3) si ripetono molti dei caratteri generali appena esposti, ma si no-tano anche alcune importanti differenze 9. Anzitutto la presenza dei nuraghi a corridoio o comunque di tipologia arcaica è estremamente sporadica: al momento attuale conosco solo il nuraghe Torturi-ga-Alores di Cuglieri, dislocato all’estremità meridionale dell’area sul margine del pianoro di Cam-pu ’e Corra a circa 100 m di quota. La fascia costiera, delimitata da alti costoni strapiombanti, è so-stanzialmente priva di insediamenti: nella parte settentrionale si rileva il solo nuraghe Foghe, posto a guardia dell’unico pur disagevole accesso al mare in corrispondenza della foce del Riu Mannu; nella parte meridionale resta indefinita la natura e la consistenza dell’occupazione nuragica del colle di Corchinas, dominante le insenature di S’Archittu e Santa Caterina di Pittinuri. Nella fascia alti-metrica basale, il popolamento si presenta assai denso nella regione settentrionale di Sessa, costitui-ta da un pianoro appena ondulato da una serie di leggeri solchi vallivi paralleli; si riconoscono alcu-ni agglomerati caratterizzati da un numero limitato di nuraghi complessi, raramente trilobati o qua-drilobati (Nuraghe Longu, Monte ’e Lacana, Oragiana, Nuraghe Maggiore, Oratanda, Su Rosariu-Cuglieri), e da un numero molto maggiore di nuraghi monotorri, non di rado accompagnati da estesi abitati, quasi tutti compresi tra 100 e 150 m di quota; gli insediamenti senza nuraghe sono senza dubbio poco noti. La densità abitativa è molto inferiore al margine settentrionale dell’area, lungo la valle del Riu Marafè (nuraghe Spinalba e probabile insediamento di Matta Tiria10). La regione me-ridionale è caratterizzata da una morfologia movimentata e aspra, sostanzialmente di tipo montano anche a quote assai basse; l’occupazione della fascia basale appare piuttosto episodica (Silbanis, Nurechi, Appara, Crastachesu, Muradissa-Cuglieri). Le fasce intermedia ed elevata si presentano di-sabitate nella parte settentrionale e con scarsi insediamenti nella parte meridionale, per lo più limita-ti al medio e alto versante di Seneghe prospiciente il mare. Coerentemente col quadro insediativo, le sepolture si trovano solo nella fascia basale e soprattutto nella regione di Sessa, generalmente in rapporto coi rispettivi insediamenti; fa eccezione la tomba di Lentiri, isolata al bordo del pianoro sulla valle del Riu Abba Lughida.
Diversamente, il cantone settentrionale (fig. 4) presenta un’evidente attrazione per le fasce inter-medie ed elevate, fino alle soglie del la fascia sommitale. Il pianoro di Sennariolo e Scano Montifer-ro, delimitato a nord dalla gola del Riu Mannu e decisamente in ascesa da ovest verso est, con quote comprese tra 200 e 500 m s.l.m., si presenta fittamente punteggiato di monumenti e insediamenti
restano incerti molti aspetti della loro struttura, cronologia e successione; sembra comunque chiaro che la loro pro-gressiva edificazione in un’area delimitata ribadisse di volta in volta la funzione funeraria in essa riconosciuta già da molto tempo fino a renderla esclusiva: in tal modo una parte determinata del territorio, sottratta al normale processo di insediamento e di sfruttamento produttivo, veniva dedicata unicamente al seppellimento e al culto dei defunti, con un numero di edifici sepolcrali che non ha confronti in tutta l’isola. Come e ancor più che nel caso di monumenti fu-nebri isolati o riuniti in piccoli gruppi, non è chiaro se questa straordinaria concentrazione di sepolture collettive do-vesse accogliere indistintamente l’intera comunità dell’agglomerato o degli agglomerati insediativi circostanti, oppu-re solo gruppi selezionati come le famiglie emergenti della tribù o di uno o più clan appartenenti alla tribù, o addirit-tura singoli individui contraddistinti da un ruolo o da un rango particolari; l’eccezionalità della situazione è tale da non escludere alcuna ipotesi, anche contrastante con l’ostentato collettivismo egualitario del costume funerario do-minante nel mondo nuragico. All’estremità meridionale del complesso, a metà cammino tra le due allées couvertes e a breve distanza anche dal dolmen, si trova il rudere ellissoidale di Caratzu (m 27 × 12 circa), descritto in preceden-za come residuo di un nuraghe arcaico (MANCA DEMURTAS, DEMURTAS, 1991, p. 51, nota 51), ma la cui natura e definizione restano incerte in mancanza di convincenti analogie; possiamo solo ritenere che esso fosse connesso fun-zionalmente e simbolicamente con le strutture funerarie adiacenti. Per la planimetria ellissoidale, le strutture in parte ortostatiche e la presenza di segmenti trasversali interni, il rudere di Caratzu richiama il singolare recinto di Turriga-Milis (m 17 × 11) e l’altrettanto singolare monumento semicircolare di Bonu Caminu-Milis, entrambi di cronologia e funzione imprecisate.
9 Sono particolarmente utili le riflessioni di SANTONI (in corso di stampa). 10 L’insediamento è racchiuso da una spessa muraglia ciclopica di aspetto nuragico; al suo interno, pochissimi ruderi
affiorano appena sul piano roccioso dove si raccoglie solo ceramica alto-medievale.
5
nuragici: nuraghi arcaici a corridoio o con camera rotondeggiante (Baragiones, Murcu, Rodeddu-Sennariolo; Cunculu, Mesu ’e Rios, cfr. Usai, 1990; Altoriu, cfr. Usai, 1989; Santa Barbara, forse anche Orosu e Sa Cola-Scano), nuraghi monotorri (S’Ena ’e Tiana-Sennariolo, Abbauddi-Scano), rari nuraghi complessi (Nuracale, Mazzala-Scano), abitati senza nuraghe (Pedru Muruga-Sennariolo; Luzzanas-Scano). Una certa rarefazione si osserva nella parte più interna dell’altopiano, fino a quota 600, dove sorge isolato il trilobato Nurtaddu-Scano, con piccolo insediamento delimita-to da una poderosa muraglia. Le sepolture sorgono generalmente a breve distanza dagli abitati, tran-ne quella di Pedras Doladas, che è collocata in posizione piuttosto isolata e dominante11. La densità insediativa è abbastanza alta anche nella fascia elevata, caratterizzata in parte da morfologie aspre e in parte da altipiani leggermente ondulati; qui si trovano alcuni nuraghi arcaici (Columbalzos A-B), pochi nuraghi complessi (Urassala-Scano: quota 692; Elighe Onna-Santu Lussurgiu: quota 763) e vari nuraghi monotorri (Leari-Scano: quota 842; Silvanis-Santu Lussurgiu: quota 878).
Da questi ultimi monumenti si accede alla fascia sommitale (fig. 5), che appare invece del tutto separata dagli agglomerati posti sui versanti a est, sud e ovest. Qui si trovano pochissimi monumenti ubicati sulle cime secondarie del massiccio vulcanico in territorio di Santu Lussurgiu, che fanno co-rona alla cima principale di Monte Urtigu o Su Mullone (quota 1050) (Pes, 1988): le muraglie ci-clopiche che sbarrano il versante meridionale del domo andesitico di Punta Badde Urbara (quota 923); la muraglia con andito di accesso che chiude la piccola spianata sommitale di Monte Pertusu-Sa Rocca ’e Su Para (quota 970); il monumento circolare di Punta Alonia (quota 1.002), dall’aspetto di un piccolo nuraghe monotorre in blocchi poliedrici di andesite, con nicchie e stipetti nella camera priva di scala e con conci isodomi di basalto sparsi nella frana; infine il nuraghe Giolzia-Straderis (quota 1.016), addossato agli spuntoni rocciosi e composto da una torretta circolare e da un braccio murario delimitante un piccolo cortile o un semplice riparo. Soprattutto agli ultimi due, collocati su vette isolate e dominanti da un lato sulla vallata di Santu Lussurgiu e dall’altro sul versante di Cu-glieri e sul mare, si potrebbe attribuire un carattere oscillante tra l’affermazione simbolica del domi-nio territoriale e un’ipotetica religiosità legata alle cime montane, in qualche modo accostabile ai culti di sommità noti nella penisola italiana e nel mondo egeo (Peroni, 1994, p. 308; Cultraro, 2001, pp. 284-92). In effetti il Montiferru fa eccezione al quadro generale delle montagne sarde, caratte-rizzate dall’assenza di strutture nuragiche nella fascia sommitale; per quanto mi è noto, ad esso si possono accostare solo la Punta Senalonga di Alà dei Sardi e il Monte Santa Vittoria di Esterzili, dove si trovano complessi di carattere sacro (1.000-1.200 m di quota)12. 4. Osservazioni conclusive
Dal quadro di geografia umana succintamente descritto si ricava un’evidente impressione di di-namismo che caratterizza tutti gli aspetti del sistema culturale nuragico e che si esprime soprattutto nell’intensificazione dello sfruttamento delle aree più produttive e nella colonizzazione di nuove terre attraverso l’espansione degli agglomerati esistenti e la costituzione di nuovi agglomerati. Nel processo di popolamento e di organizzazione territoriale si possono schematicamente distinguere due fasi caratterizzate da tendenze opposte ma forse parzialmente coesistenti nella grande varietà delle situazioni concrete: durante la prima fase, databile al Bronzo medio e almeno in parte al Bron-zo recente, si osserva una tendenza espansiva ed estensiva che comporta la colonizzazione progres-siva del territorio e la diffusione generale dei nuraghi arcaici, semplici e complessi e degli abitati a-diacenti o isolati; durante la seconda fase, databile al Bronzo recente e soprattutto al Bronzo finale, si nota una tendenza selettiva e intensiva che provoca l’abbandono dei luoghi meno favorevoli e la concentrazione del popolamento nelle aree e nei siti più vantaggiosi, con la rapida crescita degli abi-tati adiacenti ai nuraghi più importanti e degli insediamenti produttivi ad essi subordinati. 11 BITTICHESU (2003). La tomba è di tipo isodomo evoluto; l’unico nuraghe nelle vicinanze è l’arcaico Altoriu. 12 MORAVETTI (1993, pp. 167-169 e 205-207). Un semplice ruolo di controllo territoriale può essere assegnato al nura-
ghe monotorre esistente sulla cima del Monte Sant’Antonio di Macomer, in realtà un debole rilievo appena emergen-te sull’altopiano all’estremo limite nord-orientale del Montiferru.
6
Mentre queste due fasi di piena maturità della civiltà nuragica sono abbondantemente documen-tate in tutto il Montiferru, le testimonianze relative alle fasi iniziali e terminali sono ben più lacuno-se e discontinue. A parte il problematico raccordo con la frammentaria documentazione prenuragi-ca13, le manifestazioni nuragiche arcaiche si concentrano sui versanti settentrionale e orientale (terri-tori di Sennariolo, Scano, Bonarcado e Seneghe) e scarseggiano sui versanti meridionale e occiden-tale (territori di Narbolia e Cuglieri). Ma la ricucitura del tessuto lacerato delle linee di sviluppo del-le comunità umane protostoriche è ulteriormente complicata, nelle fasi di trasformazione e dissol-vimento della prima metà del I millennio a.C., da un’estrema carenza di documenti riferibili alla prosecuzione del cammino culturale dei discendenti del popolo costruttore dei nuraghi.
Del resto sono tutt’altro che chiari anche i meccanismi di sviluppo territoriale della piena civiltà nuragica, individuati nei processi di replicazione delle cellule insediative. A questo proposito vorrei attirare l’attenzione sulla diffusa presenza di strutture ciclopiche composte da uno, due o tre filari di blocchi, spesso concluse dall’architrave, certamente impoverite nel corso dei secoli ma con tutta probabilità incompiute o semplicemente abbozzate, che devono essere interpretate come nuraghi non terminati. Alcune strutture di pianta ellissoidale avrebbero potuto diventare nuraghi a corridoio (forse Coa Perdosa-Seneghe); altre di pianta circolare, molto più numerose, erano state indubbia-mente concepite come nuraghi monotorri (Salamattile, Lobos B, S’Arca B, Primidio-Scano; Campu ’e Padre, Pranu Olia A-B, Oragiana B, Pane ’e Perra, S’Attentu, Pulighedda C, Padru Maggiore, Murgu Melis A-B-Cuglieri; Camputzola B-Santu Lussurgiu; Campanile ’e Pranu, Puiolos A-B, Bantine Mura-Bonarcado; Codinazza, Funtana Suerzu, Battazzeri, Pira ’e Marzani-Seneghe, Fua-deddus-Narbolia); infine un’analoga interpretazione si può proporre per alcuni nuraghi complessi14. In effetti queste strutture sono molto povere o del tutto prive di materiali di crollo, sia all’interno che all’esterno, sono prive di insediamento e spesso sorgono in luoghi non occupati successivamen-te, dove non si ha traccia ma nemmeno necessità di recupero di grandi quantità di materiale da co-struzione. Questi nuraghi abbozzati, che potrebbero essere in parte edifici semplici e piuttosto anti-chi, ma forse soprattutto edifici standardizzati e piuttosto tardivi (Usai, 2009), si trovano spesso ac-canto agli insediamenti principali oppure ai margini degli agglomerati, come a testimoniare tentativi non riusciti di intensificazione o di espansione. Poiché ogni insediamento presuppone un progetto di gemmazione, che comporta il trasferimento di un gruppo umano da un luogo già abitato a uno anco-ra disabitato che deve anche essere contemporaneamente bonificato e colonizzato, non trovo strano che una certa percentuale di progetti insediativi potesse fallire per motivi contingenti o per ragioni strutturali connesse alle trasformazioni interne della società nuragica.
Per altro verso si rileva l’abbondanza dei nuraghi complessi, soprattutto quadrilobati e partico-larmente nel quadrante meridionale di Narbolia e Seneghe (cui si aggiungono il pentalobato Cobulas di Milis e l’abnorme mole di S’Urachi di San Vero Milis); questo fenomeno è da porre in relazione con il surplus di risorse umane ed economiche derivante da un’insolita densità abitativa e dall’efficienza del sistema produttivo, nell’ambito di un’organizzazione gerarchica particolarmente sviluppata per effetto dell’interazione e della competizione tra le comunità della pianura, della colli-na e della montagna, della costa e dell’interno15.
13 Sicure attestazioni del Bronzo antico si hanno solo nelle grotticelle artificiali di Fanne Massa-Cuglieri (TARAMELLI,
1918, pp. 312-320; FERRARESE CERUTI, GERMANÀ, 1978, tav. XXI); resta invece alquanto vago l’inquadramento delle tombe dolmeniche come quelle di Caratzu-Narbolia (cfr. supra, nota 10), Mont’e Lacana-Cuglieri (CICILLONI, 1997, p. 45, tavv. III:1 e VI:2) e altre inedite individuate nei territori di Milis e Seneghe.
14 Ad esempio il nuraghe Araganzola di Narbolia, quadrilobato con resti di muraglia recintoria, caratterizzato da un pi-ano di svettamento quasi uniforme e da grande scarsità dei crolli, potrebbe testimoniare un tentativo abbandonato di costituzione di un centro importante all’interno di un agglomerato straordinariamente ricco di nuraghi quadrilobati e trilobati.
15 Interpreto in questo modo la fitta distribuzione di nuraghi complessi nei territori citati, diversamente da Santoni che ha riconosciuto in essa una sorta di “catena” disposta a delimitare e separare il comprensorio nuragico dell’entroterra di Oristano dal Montiferru secondo una linea di demarcazione territoriale parzialmente coincidente coi confini delle curatorie medievali del Campidano di Milis e del Campidano Maggiore (SANTONI, 1990, pp. 32-34); le mie valuta-
7
Tutto ciò doveva esprimersi già nel Bronzo medio e recente con l’esuberante formazione di di-versi centri di coordinamento politico-economico, probabilmente rivolti a ospitare, su diversi livelli gerarchici, attività di accumulazione e redistribuzione dei prodotti primari e secondari del sistema agricolo e industriale, in connessione con le sorti mutevoli di clan, famiglie e anche individui di vol-ta in volta emergenti sul persistente fondo comunitario tribale; ma tutto ciò avrebbe anche condotto nei tempi successivi del Bronzo Finale e della Prima Età del Ferro a ripetuti momenti di crisi e di riorganizzazione dell’assetto insediativo e produttivo, che tendeva a intensificarsi ulteriormente col riutilizzo in varie forme dei nuraghi già esistenti e soprattutto con l’ampliamento e la moltiplicazio-ne degli abitati entro unità politico-economiche più estese. Certo, per avere un’idea più concreta e dinamica dello sviluppo del popolamento sarebbe necessario arricchire il quadro distributivo e de-scrittivo da un lato coi dati cronologici di scavo, dall’altro coi dati quantitativi che possono essere forniti soprattutto dallo studio analitico degli abitati; ma al momento questo obiettivo sembra ancora fuori portata, se non per piccole aree meglio indagate.
A confronto con l’imponente documentazione disponibile sugli aspetti insediativi e funerari, quella concernente i culti è al momento scarsa e controversa. A parte gli edifici sulle cime seconda-rie del Montiferru cui si è sopra fatto cenno, finora non sono noti grandi santuari né tempietti locali annessi ai singoli abitati16; inoltre non si ha notizia di rinvenimenti casuali di figurine votive in bronzo, che sono connesse direttamente o indirettamente coi luoghi del culto e che avrebbero in qualche modo colmato le inevitabili lacune della ricerca sistematica. L’unico aspetto del rituale nu-ragico chiaramente documentato è costituito dai depositi votivi composti da grandi quantità di reci-pienti ceramici, in particolare ollette e anforette di piccole o piccolissime dimensioni, inquadrabili in parte nel Bronzo recente e soprattutto nel Bronzo Finale (Usai, 2005, pp. 37-8) (Cornus
17-Cuglieri?; Campu de Santu Perdu18, Banatou19-Narbolia).
Resta da interpretare adeguatamente nel Montiferru, come nel resto della Sardegna centro-settentrionale, l’apparente (ma probabilmente non effettiva) rarefazione delle testimonianze archeo-logiche nei tempi dell’Età del Ferro. Una scultura in calcare in forma di testa umana recuperata da-gli scavi abusivi nel pozzo di Banatou-Narbolia, che richiama da vicino le teste delle statue di arcie-ri e pugilatori di Mont’e Prama-Cabras, rivela non trascurabili sviluppi artistici e sociali (dunque anche economici e politici) della componente culturale ed etnica di piena tradizione nuragica; resta ancora puramente ipotetica l’eventualità di un rapporto tra indigeni e Phoinikes, che potrebbe essere indiziato da scarsi rinvenimenti di ceramiche fenicie della fine dell’VIII secolo a.C. in aree di prece-dente (forse anche contemporanea) occupazione nuragica, come nei siti di Prei Madau-Riola e Cor-chinas-Cuglieri, proprio sull’acropoli della punica Cornus
20.
zioni coincidono comunque nella sostanza con quelle espresse da Santoni in altra sede (SANTONI, 2003, p. 140).
16 Si ha notizia di un pozzo isodomo d’incerta natura circa 200 m a nord-est del Nuraghe Maggiore di Cuglieri (rela-zione di F. Lo Schiavo agli atti della Soprintendenza archeologica).
17 Il deposito votivo, costituito dai vasetti delle collezioni Lovisato e Gouin riportanti la dicitura Cornus (PINZA, 1901, cc. 224-228, figg. 116-130), è collegato da alcuni autori moderni, sulla scia di TARAMELLI (1918, pp. 320-321, figg. 53-55; 1935, p. 168, nota 32), con una presunta tomba ipogeica presso il Riu Pischinappiu in territorio di Narbolia (TORE, STIGLITZ, 1987, p. 97; 1992, p. 93; SEBIS, 1995, p. 104; USAI L., 1998, pp. 178-179, tav. V.2-6). Come spes-so accade, è impossibile distinguere il contenuto dell’informazione ricevuta da Taramelli dai commenti da lui ag-giunti in un quadro ancora estremamente confuso, in cui non si percepiva alcuna differenza tra tombe ipogeiche neo-eneolitiche, riutilizzi funerari del Bronzo antico (come nelle tombe di Fanne Massa) e depositi votivi del Bronzo Re-cente-Finale.
18 In questo sito si ha notizia di una presunta tomba megalitica (TORE, STIGLITZ, 1992, p. 94, tav. IV.63); ma ritengo improbabile il collegamento tra l’aspetto votivo e quello funerario, come anche a Cornus-Pischinappiu.
19 Il pozzo di Banatou, pur non avendo carattere sacro, poté essere utilizzato come deposito votivo o anche come disca-rica di materiale votivo proveniente da un luogo vicino.
20 Cortese segnalazione verbale di Raimondo Zucca.
8
Riferimenti bibliografici
BITTICHESU C. (2003), Tomba di giganti di Pedras Doladas (Scano Montiferro, Oristano), in AA.VV., Studi in onore di
Ercole Contu, Sassari, pp. 125-145. CICILLONI R. (1997), Note su alcuni monumenti dolmenici in provincia di Oristano, «Quaderni della Soprintendenza
archeologica per le Province di Cagliari e Oristano», 14, pp. 45-61. CULTRARO M. (2001), L’anello di Minosse. Archeologia della regalità nell’Egeo minoico, Milano. FERRARESE CERUTI M. L., GERMANÀ F. (1978), Sisaia. Una deposizione in grotta della cultura di Bonnanaro, «Qua-
derni della Soprintendenza archeologica per le Province di Sassari e Nuoro», 6. LILLIU G. (1962), I nuraghi, torri preistoriche della Sardegna, Cagliari. MANCA G. (2002), Bonarcado antica. Archeologia del territorio, Nuoro. MANCA DEMURTAS L., DEMURTAS S. (1991), Analisi dei protonuraghi nella Sardegna centro-occidentale, in AA.VV.,
Arte militare e architettura nuragica. Nuragic Architecture in its Military, Territorial and Socio-Economic Context.
Proceedings of the First International Colloquium on Nuragic Architecture at the Swedish Institute in Rome, 7-9
december 1989, Stockholm, pp. 41-52. MELE G. (a cura di) (1993), Montiferru, Cagliari. MORAVETTI A. (1993), Gli insediamenti antichi, in I. CAMARDA (a cura di), Montagne di Sardegna, Sassari, pp. 159-
212. PERONI R. (1994), Introduzione alla protostoria italiana, Roma-Bari. PERRA M. (2008), Un sistema territoriale nuragico nella Barbagia-Sarcidano e il nuraghe Nolza di Meana Sardo
(Nuoro), in AA.VV., La civiltà nuragica. Nuove acquisizioni. Atti del Congresso (Senorbì 14-16 dicembre 2000), vol. II, Cagliari, pp. 659-670.
PES P. (1953-54), Saggio di catalogo archeologico sul foglio 206 della carta d’Italia: quadrante IV, tav. SE-SO, tesi di laurea, Università di Cagliari (ora in ID., Archeologia tra Planargia e Montiferru, a cura di A. USAI, T. COSSU, Ca-gliari 2009).
PES P. (1988), Attraverso la storia del territorio di Cornus, in AA.VV., Ampsicora e il territorio di Cornus. Atti del II
Convegno sull’archeologia romana e altomedievale nell’Oristanese (Cuglieri, 22 dicembre 1985), Taranto, pp. 9-11.
PINZA G. (1901), Monumenti primitivi della Sardegna, «Monumenti antichi dei Lincei», XI, coll. 1-280. PIRAS A. (1952-53), Saggio di catalogo archeologico sul foglio 206 della carta d’Italia: quadrante III, tav. NE-NO,
tesi di laurea, Università di Cagliari. SANTONI V. (1990), Il territorio in epoca nuragica, in AA.VV., La Provincia di Oristano. L’orma della storia, Cagliari,
pp. 27-40. SANTONI V. (2003), Sardinia in the Mediterranean from the Middle until the Late Bronze Age, in N. CH. STAMPOLIDIS
(ed.), Sea Routes... From Sidon to Huelva. Interconnections in the Mediterranean, Athens, pp. 140-151. SANTONI V. (in corso di stampa), La ricognizione dei paesaggi archeologici come base fondativa per la gestione del
territorio, in AA.VV., Analisi e sistemi di gestione del territorio. Atti del convegno di Sinnai, 30-31 gennaio 2004. SANTONI V., SERRA P. B., GUIDO F., FONZO O. (1991), Il nuraghe Cobulas di Milis-Oristano: preesistenze e riuso, in
A. MASTINO (a cura di), L’Africa Romana, vol. VIII, Sassari, pp. 941-989. SEBIS S. (1995), La ceramica nuragica del Bronzo Medio (XVI-XIV sec. a.C.) e del Bronzo Recente (XIII-XII sec. a.C.)
nell’Oristanese, in AA.VV., La ceramica artistica, d’uso e da costruzione nell’Oristanese dal neolitico ai giorni no-
stri. Atti del I Convegno di studi “La ceramica racconta la storia”, Oristano, pp. 101-120. TARAMELLI A. (1918), Cuglieri. Ricerche ed esplorazioni nell’antica Cornus, «Notizie degli Scavi», pp. 285-331. TARAMELLI A. (1935), Edizione archeologica della Carta d’Italia. Foglio 205 (Capo Mannu). Foglio 206 (Macomer),
Firenze. TORE G., STIGLITZ A. (1987), L’insediamento preistorico e protostorico nel Sinis settentrionale. Ricerche e acquisizio-
ni, in Atti del II convegno di studi “Un millennio di relazioni fra la Sardegna e i paesi del mediterraneo”. La Sar-
degna nel mediterraneo tra il secondo e il primo millennio a.C. (Selargius-Cagliari, 27-30 novembre 1986), Caglia-ri, pp. 91-105.
TORE G., STIGLITZ A. (1992), Osservazioni di icnografia nuragica nel Sinis e nell’Alto Oristanese (Ricerche 1980-
1987), in AA.VV., La Sardegna nel Mediterraneo tra il bronzo medio e il bronzo recente (XVI-XIII sec. a.C.). Atti
del III Convegno di studi “Un millennio di relazioni tra la Sardegna e i Paesi del Mediterraneo”, Selargius- Ca-
gliari, 19-22 novembre 1987, Cagliari, pp. 89-105. USAI A. (1989), Il nuraghe Altoriu di Scano Montiferro (Oristano), «Quaderni della Soprintendenza archeologica per le
Province di Cagliari e Oristano», 6, pp. 61-72. USAI A. (1990), Il nuraghe Mesu ’e Rios di Scano Montiferro (Oristano), «Quaderni della Soprintendenza archeologica
per le Province di Cagliari e Oristano», 7, pp. 135-147. USAI A. (2003), Sistemi insediativi e organizzazione delle comunità nuragiche nella Sardegna centro-occidentale, in
AA.VV., Atti della XXXV Riunione scientifica dell’Istituto italiano di preistoria e protostoria, Firenze, pp. 215-224. USAI A. (2005), Testimonianze prenuragiche e nuragiche nel territorio di Narbolia, in R. ZUCCA (a cura di), Nurabo-
9
lia-Narbolia. Una villa di frontiera del Giudicato di Arborea, Narbolia, pp. 21-57. USAI A. (2006), Osservazioni sul popolamento e sulle forme di organizzazione comunitaria nella Sardegna nuragica, in
AA.VV., Studi di protostoria in onore di Renato Peroni, Firenze, pp. 557-566. USAI A. (2009), La ricerca archeologica di Pietro Pes: dal 1954 al 2008, in P. PES, Archeologia tra Planargia e Mon-
tiferru, a cura di A. USAI, T. COSSU, Cagliari, pp. XV-XXIII. USAI L. (1998), La produzione vascolare miniaturistica di età nuragica, in C. COSSU, R. MELIS (a cura di), La cerami-
ca nel Sinis dal neolitico ai giorni nostri. Atti del II Convegno di studi “La ceramica racconta la storia”, Oristano-
Cabras, 25-26 ottobre 1996, Cagliari, pp. 175-193.
10
FIGURA 1 Carta fisica del Montiferru con proposta di delimitazione dei diversi sistemi territoriali nuragici e delle principali suddi-visioni interne (elaborazione A. Usai su base I.G.M. 1:100.000).
11
FIGURA 2 Carta dei siti nuragici del versante meridionale del Montiferru (elaborazione A. Usai su base I.G.M. 1:50.000).
12
FIGURA 3 Carta dei siti nuragici del versante occidentale del Montiferru (elaborazione A. Usai su base I.G.M. 1:50.000).
13
FIGURA 4 Carta dei siti nuragici del versante settentrionale del Montiferru (elaborazione A. Usai su base I.G.M. 1:50.000).