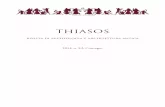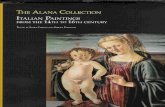16. Maria Serena Rizzo, Laura Danile, Luca Zambito, L'insediamento rurale nel territorio di...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of 16. Maria Serena Rizzo, Laura Danile, Luca Zambito, L'insediamento rurale nel territorio di...
LES DYNAMIQUES DE L’ISLAMISATIONEN MÉDITERRANÉE CENTRALE ET EN SICILE :
NOUVELLES PROPOSITIONS ET DÉCOUVERTES RÉCENTES
LE DINAMICHE DELL’ISLAMIZZAZIONENEL MEDITERRANEO CENTRALE E IN SICILIA:
NUOVE PROPOSTE E SCOPERTE RECENTIédité par a cura diAnnliese Nef, Fabiola Ardizzone
avec la collaboration de con la collaborazione di Lucia Arcifa, Alessandra Bagnera, Elena Pezzini
Roma-Bari 2014
E S T R AT T O - T I R É - A - PA R T
COLLECTION DE L’ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME487
10
© 2014 Edipuglia srl
L’autore ha il diritto di stampare o diffondere copie di questo PDF esclusivamente per uso scientifico o didattico.Edipuglia si riserva di mettere in vendita il PDF, oltre alla versione cartacea. L’autore ha diritto di pubblicare in internetil PDF originale allo scadere di 24 mesi.
L’auteur a le droit d’imprimer ou de distribuer des copies de ce document PDF exclusivement à des fins scientifiquesou pédagogiques. Edipuglia se réserve le droit de vendre le PDF, en plus de la version papier. L’auteur a le droit de publierle PDF d’origine sur internet seulement au bout de 24 mois.
The author has the right to print or distribute copies of this PDF exclusively for scientific or educational purposes.Edipuglia reserves the right to sell the PDF, in addition to the paper version. The author has the right to publish theoriginal PDF on the internet at the end of 24 months.
les dYnamiques de l’islamisation en mÉditerranÉe centrale et en sicileLE DINAMICHE DELL’ISLAMIZZAZIONE NEL MEDITERRANEO CENTRALE E IN SICILIA - isBn 978-88-7228-735-4 - 2014 · École Française de rome / edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
I progetti di ricognizione archeologica, sistematicao specificamente finalizzata all’insediamento medie-vale, piuttosto numerosi, soprattutto nella Sicilia occi-dentale, a partire dagli anni ’80 1, hanno contribuito adelineare un quadro ormai sufficientemente chiaro dellecaratteristiche del popolamento rurale di età medievale,almeno per l’avanzata età islamica e per l’epoca nor-manna: è infatti essenzialmente alle ricerche di super-ficie che dobbiamo quasi tutto quanto oggi sappiamosui momenti essenziali di sviluppo degli insediamentiaperti a carattere agricolo, sulla loro distribuzione nelterritorio, sulle loro caratteristiche topografiche, sullafine di quello che si è soliti definire “popolamento percasali” 2. In pochissimi casi, infatti, si è intervenuti inquesto tipo di siti con scavi archeologici 3, che hannoinvece privilegiato i siti fortificati d’altura 4. L’esitoprincipale, ai fini dell’argomento che ci interessa, di que-ste ricerche è stato quello di poter seguire, dalla metà
circa del X secolo, in coincidenza con la diffusione delleprime invetriate policrome 5, lo strutturarsi, nella Sici-lia occidentale, di un sistema di insediamenti aperti, dimedio e basso pendio, spesso piuttosto estesi, in evi-dente e facile rapporto sia con fonti di approvvigiona-mento idrico sia con i terreni coltivabili; questo sistemainsediativo continua senza modifiche significative nellaprima età normanna, mentre mostra evidenti segni dicrisi a partire dalla metà circa del XII secolo, in con-comitanza con un evidente rafforzamento dei siti d’al-tura.
Già le ricerche degli anni ’90 avevano messo in evi-denza come molti insediamenti aperti si sviluppasserosu siti già sede di villaggi tardoantichi e della prima etàbizantina 6; il recente riconoscimento dei primi indica-tori archeologici sufficientemente attendibili consenteoggi di documentarne archeologicamente in diversi casila continuità nel corso dell’alto medioevo, ma permette
1 BELVEDERE Oscar, BERTINI Adele, BOSChIAN Giovanni, BURGIO
Aurelio, CONTINO Antonio, CUCCO Rosa Maria, LAURO Daniela2002; FENTRESS Elisabeth, KENNETh Derek, VALENTE Ignazio 1986;JOhNS Jeremy 1992; RIZZO Maria Serena 2004; MOLINARI Alessan-dra, NERI Ilaria 2004; CORRETTI Alessandro, MIChELINI Chiara, VAG-GIOLI Adelaide 2010; LAURO Daniela 2009.
2 Sul significato che nei documenti di età normanna sembraassumere il termine casale, da intendere in primo luogo come unapartizione territoriale, eventualmente in grado di generare un abi-tato, ARCIFA Lucia, BAGNERA Alessandra, NEF Annliese 2012,p. 262-263; lo studio di questi documenti ha anche messo in di-scussione l’idea, normalmente accettata, che il termine latino ca-sale traduca esattamente l’arabo raḥal, termine con il quale idocumenti indicherebbero piuttosto una unità fondiaria e fiscale,NEF Annliese 2011a, p. 359-427. Queste osservazioni non modi-ficano ovviamente il quadro tracciato a partire dalla documenta-zione archeologica.
3 Tra i pochi scavi di insediamenti rurali di età medievale due
sono hanno riguardato siti dell’agrigentino, Saraceno, su cui si vedaCASTELLANA Giuseppe, MCCONNELL Brian 1990, e Caliata pressoMontevago, CASTELLANA Giuseppe 1992; a questo brevissimo elencova poi aggiunto lo scavo del sito di Casale Nuovo, presso Mazaradel Vallo, MOLINARI Alessandra, VALENTE Ignazio 1995 MOLINARI
Alessandra in questo volume.4 Su Brucato, la prima delle grandi imprese di scavo medievale
in Sicilia, PESEZ Jean-Marie 1984; su Segesta, MOLINARI Alessan-dra 1997; su Entella, CORRETTI Alessandro 1998; CORRETTI Ales-sandro 2010; CORRETTI Alessandro, MIChELINI Chiara, VAGGIOLI
Maria Adelaide 2010; su Calathamet, PESEZ Jean-Marie 1995; LES-NES Elisabeth, POISSON Michel 2013; su Iato, ISLER hans Peter1995; su Calatamauro CORRETTI Alessandro, DI NOTO Concetta An-tonella, MIChELINI Chiara, VAGGIOLI Maria Adelaide 2004.
5 ARCIFA Lucia, BAGNERA Alessandra, NEF Annliese 2012, p. 266-267.
6 MOLINARI Alessandra 1994, p. 368-370; RIZZO Maria Serena2004, p. 150-151.
L’INSEDIAMENTO RURALE NEL TERRITORIO DI AGRIGENTO: NUOVI DATI DA PROSPEZIONI E SCAVI
Maria Serena Rizzo (Soprintendenza di Agrigento)
Laura Danile, Luca Zambito
les dYnamiques de l’islamisation en mÉditerranÉe centrale et en sicileLE DINAMICHE DELL’ISLAMIZZAZIONE NEL MEDITERRANEO CENTRALE E IN SICILIA - isBn 978-88-7228-735-4 - 2014 · École Française de rome / edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
MARIA SERENA RIZZO - LAURA DANILE - LUCA ZAMBITO
anche di iniziare a riconoscere una situazione piuttostoarticolata e dinamiche insediative di una certa com-plessità 7.
Per il territorio agrigentino, in particolare, progettidi ricognizione archeologica effettuati recentemente enuovi dati da scavo riguardano il settore orientale e nord-orientale dell’attuale territorio provinciale. Ai primi ri-sultati della prospezione archeologica nel comprensoriodi Cignana, in territorio di Palma di Montechiaro, con-dotta dalla cattedra di Topografia Antica dell’Univer-sità di Palermo 8, si possono aggiungere alcuni datiprovenienti invece da una ricerca esplicitamente indi-rizzata al popolamento altomedievale, condotta da LucaZambito nella valle del fiume Naro. Di grande interesse,infine, sono i risultati, sia pure ancora solo preliminari,dello scavo archeologico di emergenza in contrada Col-mitella, in territorio di Racalmuto. Si tratta in gran partedi dati ancora parziali, solo in parte derivanti da ricer-che sistematiche e che necessitano certamente di ulte-riori approfondimenti; essi propongono comunqueinteressanti spunti di riflessione e suggeriscono alcunedelle direzioni nelle quali sarà possibile in futuro indi-rizzare il prosieguo delle indagini.
M.S.R.
La ricognizione nella valle del fiume Naro
Il medio corso del fiume Naro marca il territorio aest di Agrigento ed è caratterizzato da una fitta rete in-sediativa e da un complesso reticolo di assi viari cheintegra perfettamente le possibilità offerte dalla per-vietà della vallata fluviale, mettendo in relazione il maree l’entroterra, i centri urbani e le campagne. In età tar-doantica la documentazione archeologica attesta l’esi-stenza di grandi villaggi, spesso impiantati su struttureresidenziali precedenti, che paiono sopravvivere sino alVII secolo d.C., in alcuni casi con una cesura a metàdel V d.C., all’interno dei quali sono attestate struttureproduttive, depositi e impianti di trasformazione dellederrate agricole. Gli esiti dell’indagine da me condottaconsentono oggi di riconoscere la continuità anche inepoca altomedievale di alcuni di questi ampi villaggi edi individuare alcuni siti di piccole dimensioni, che si
sviluppano soltanto dopo la fine delle importazioni diceramiche ed anfore dall’Africa e dal Mediterraneoorientale. Le ricognizioni nel territorio orientale dellaprovincia di Agrigento, infatti, hanno consentito di in-dividuare un certo numero di siti che presentano alcunecaratteristiche comuni, tanto da un punto di vista topo-grafico, strategico e di collocazione rispetto alle fontidi approvvigionamento idrico e ai rilievi collinari,quanto per gli aspetti della cultura materiale: sono tutti“siti aperti” indifendibili e senza alcuna traccia di operedi fortificazione o di difesa, hanno una limitata esten-sione, una bassa frequenza nell’attestazione del recordarcheologico, spesso sono strategicamente addossati arilievi calcarei e sfruttano porzioni di terreno difficil-mente coltivabili, sono lontani dalle principali direttriciviarie e di comunicazione. Essi inoltre non hanno pree-sistenze né sopravvivono alla fine del X secolo (non sonopresenti infatti merci africane, né prodotti riconducibiliad epoca bizantina, né ceramiche invetriate). A questisiti bisogna aggiungerne altri, Colmitella (Racalmuto,AG), Cangiana (Naro, AG), Cazzola (Canicattì, AG) eVito Soldano che, pur presentando una analoga fase difrequentazione, hanno una lunga continuità di vita, intre casi risalente almeno ad età ellenistica e hanno ca-ratteristiche topografiche diverse rispetto ai precedenti:sono in relazione con le principali direttrici viarie, hannouna grande estensione, fra i cinque e i quindici ettari e,inoltre, da un punto di vista della cultura materiale sem-brano sopravvivere, almeno in tre casi su quattro, alloscorcio del X secolo d.C.; infine sono tutti impiantatisu precedenti strutture abitative o produttive.
Quelli che presentiamo in questa sede sono i primidati per la redazione di una carta delle presenze alto-medievali in questa porzione della provincia di Agri-gento. Future indagini e ricerche potranno contribuiread accrescere le nostre conoscenze sia dal punto di vistadella cultura materiale, con l’individuazione di ulteriorimarkers archeologici per questa fase storica, sia dalpunto di vista numerico implementando le attestazionisul terreno.
I siti
Canicattì, Contrada Giummello
Il sito si sviluppa in prossimità di una imponente dor-sale calcarea che segna il territorio e consente di con-trollare visivamente una ampia porzione di territorio ein particolare l’alta valle del fiume Naro. L’areale di di-spersione dei cocci non supera i 600 m2 e sulla roccia
7 Che sembravano già in parte emergere dai risultati della pro-spezione intensiva in c.da Butermini, RIZZO Maria Serena 2004,p. 151-152.
8 BURGIO Aurelio c.d.s.
352
les dYnamiques de l’islamisation en mÉditerranÉe centrale et en sicileLE DINAMICHE DELL’ISLAMIZZAZIONE NEL MEDITERRANEO CENTRALE E IN SICILIA - isBn 978-88-7228-735-4 - 2014 · École Française de rome / edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
sono visibili tagli regolari e angoli su cui sono appog-giati resti di strutture murarie in pietre calcaree non la-vorate e messe in opera a secco. Non mancano, ai piedidel rilievo roccioso, terreni coltivabili e risorse idriche(sorgenti e i valloni torrentizi).
Campobello di Licata, contrada Ciccobriglio
Anche il sito di contrada Ciccobriglio si sviluppa asud di un rilievo calcareo interessato da alcune esca-vazioni di età preistorica ma che doveva fungere da ri-paro contro i venti di tramontana. Sulla collina non sirileva traccia di frequentazione antropica; l’insedia-mento si sviluppava per una superficie di circa 400 m2
su un piccolo pianoro caratterizzato da un possente de-posito di terreno alluvionale, fertile e con abbondantirisorse idriche.
Naro, contrada Cangiana
A differenza dei primi due il sito di contrada Can-giana si estende per una superficie di almeno venti et-tari su cui si rinviene materiale che da età classicagiunge fino al basso medioevo senza apparenti soluzionidi continuità. All’interno di questa grande superficie peròsi è individuata, a nord di una dorsale calcarea interes-sata da una vasta necropoli tardoantica, un’area di di-spersione di materiale alto medievale ampia circa unettaro (Tav. I). A nord del sito di Cangiana corre unaRegia trazzera, oggi in disuso e in parte ricadente in pro-prietà private, che collegava l’entroterra con la foce delFiume Naro e con il mare. Al sito è associabile unaenorme area sepolcrale che occupa una dorsale roc-ciosa a sud di esso e che ne è separata da uno sterile al-tipiano ampio circa 300 metri.
Canicattì, contrada Cazzola
Il villaggio di contrada Cazzola, ampio circa 4 et-tari, segna con la sua presenza il termine di una lungadorsale gessoso-calcarea che, allungandosi da est versoovest, marca il paesaggio aprendo alla vallata degli af-fluenti del fiume Platani e ai siti dell’entroterra. Un se-condo rilievo si erge poco a sud-est, per cui il sito fungeda nodo viario e sono ben visibili alcuni tracciati stra-dali lastricati e due imponenti silos (profondi oltre 15metri per un diametro di circa 8) in parte ricavati nellaroccia e per più di un terzo fuori terra. Il record ar-
cheologico consente di proporre una cronologia fral’VIII e l’XI secolo d.C.
Siti minori
Due aree di dispersione di frammenti ceramici me-dievali molto piccole (100 m2 ca.) sono state individuatenel sito di Vito Soldano, già sede di un vasto insedia-mento di età romana e tardo-romana, del quale rimanein particolare un imponente edificio termale. Abbando-nato nel V secolo, l’edificio e una delle strade che de-limitano l’isolato che lo comprende vengono occupatida fornaci, la cui destinazione è incerta. Una frequen-tazione della strada, ormai defunzionalizzata, nel corsodell’VIII secolo è documentata dal rinvenimento diun’anfora dipinta e di alcuni frammenti di ceramica dafuoco (due coperchi, un’olla ad orlo verticale, un testello)con impasto scuro per cottura riducente e inclusi calci-tici, e un altro recipiente, forse anch’esso un testello,con anse sormontanti e impasto ricco di inclusi vulca-nici, proveniente forse dall’area etnea 9.
Le due piccole aree in cui è visibile in superficie ce-ramica decorata a stuoia, associata a pochi frammentidi invetriata (due frammenti di catini, alcune pentole aorlo introflesso, tre frammenti di invetriata “iride-scente”, di cui una pertinente forse ad un catino del tipo“pavoncella”) si trovano una lungo le pendici nord diun piccolo rilievo subito a est dell’area archeologica; laseconda, a oltre 300 metri dalla prima e in prossimitàdella Regia Trazzera per Canicattì. Sono visibili anchenumerose scorie di lavorazione del ferro e alcuni ossianimali con segni di macellazione. Le casseruole “tipoRocchicella” sono attestate con due diversi fabrics.
Nelle vicinanze dello stesso sito sono state individuatealtre piccole aree di frequentazione alto medievale, nellequali si sono raccolti pochi frammenti di tegole vacuo-late, di casseruole a bordo rientrante e di pareti di anfo-racei dalla superficie corrugata e nessun esemplareinvetriato. Il dato, se fosse confermato da indagini su uncampione territoriale più ampio, sembrerebbe interpre-tabile con una presenza diffusa sul territorio di piccolisiti, di una estensione non superiore ai 50 m2. Tutti que-sti siti si trovano alla distanza di meno di un km dalgrande sito di Cazzola, al quale è possibile che faces-sero riferimento. È inoltre forse possibile ipotizzare unarelazione tra il declino di Vito Soldano, dove rimangonosolo poche tracce di una ridotta frequentazione dopol’VIII secolo, e lo sviluppo di Cazzola.
I primi due insediamenti (cui sono da aggiungere ledue piccole UT rintracciate in prossimità del sito di VitoSoldano e una con caratteristiche simili presso l’invaso
L’INSEDIAMENTO RURALE NEL TERRITORIO DI AGRIGENTO: NUOVI DATI DA PROSPEZIONI E SCAVI
9 RIZZO Maria Serena, ZAMBITO Luca 2012, fig. 3.
353
les dYnamiques de l’islamisation en mÉditerranÉe centrale et en sicileLE DINAMICHE DELL’ISLAMIZZAZIONE NEL MEDITERRANEO CENTRALE E IN SICILIA - isBn 978-88-7228-735-4 - 2014 · École Française de rome / edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
MARIA SERENA RIZZO - LAURA DANILE - LUCA ZAMBITO
S. Giovanni, in territorio di Naro, la cui estensione nonsupera i 200 m2) documentano l’esigenza di occupareil territorio per nuclei sparsi e prediligendo aree mar-ginali, non coltivabili ma dalle quali erano facilmenteraggiungibili le zone di fondovalle da coltivare, in pros-simità di rilievi rocciosi a volte sfruttati dalle unità abi-tative. Evidente l’assenza di accorgimenti e strutturelegate ad esigenze difensive. Il record ceramico è moltostandardizzato, con nessuna ceramica di importazionee un impoverimento delle forme e dei tipi (Tav. I).
Merita un cenno la questione dei materiali di co-pertura rinvenuti: in tutti i siti minori si tratta di coppicon impasto ricco di vacuoli, cotti a basse temperaturee perciò molto fragili e di scarsa qualità, la superficieesterna è caratterizzata da un motivo inciso a onde chespesso si intrecciano e con forma che si avvicina al qua-drato (Tav. 2). Se non sono presenti, nei primi due siti,le tegole “di tipo bizantino” con striature sulla superfi-cie esterna e impasto senza inclusi vegetali, si trovanoinvece sporadici coppi con impasto vacuolato, più com-patto e meglio cotto, ma senza le striature esterne, untipo che sembra destinato ad avere una grande fortunaalmeno fino al XIII secolo d.C.
I contesti ceramici presentano alcune caratteristicheche ci pare opportuno segnalare. Nei siti di Ciccobri-glio e Giummello così come in quelli “minori” le formeda fuoco sono rappresentate solo da ceramica “tipoRocchicella”, con impasti diversificati che sembrano at-testare l’esistenza di diverse produzioni. Il bordo è rien-trante, senza risega per il coperchio e a sezione più omeno ellittica. Le pareti esterne sono caratterizzate daun trattamento della superficie che determina un carat-teristico motivo a intreccio definito “a stuoia” (Tav.I.12); i confronti tipologici con materiali ben studiatida Lucia Arcifa sono puntuali. Circa l’origine di que-sta particolare forma non possiamo non evidenziarecome nei contesti cartaginesi compaiano alcune casse-ruole, purtroppo non ben databili (si tratta delle forme32.1 e 32.2 prodotte nel fabric 1.9 di Peacock) conl’orlo ingrossato e rientrante e ci chiediamo se questaforma da fuoco non possa essere il riflesso di un so-strato che accomunava le due sponde del canale di Si-cilia in un periodo precedente la conquista islamica.
Al repertorio tipologico, abbastanza limitato, di que-sti contesti alto medievali si può aggiungere una formabassa per la cottura dei cibi (Tav. I.3 e 21), con orlo bi-fido per l’alloggiamento del coperchio e impasto calci-
tico e un catino a orlo indistinto e leggermente estro-flesso (Tav. I.11 e 14).
Fra la ceramica comune si segnala l’abbondanzadelle anse con solcatura mediana pertinenti, ci sembra,tanto a grandi brocche ed anforette quanto a contenitoridi dimensioni maggiori (Tav. I.4-6, 13 e 19). Convivono,fra i materiali di copertura, coppi vacuolati con stria-ture sulla superficie esterna e coppi vacuolati senzaqueste decorazioni. Più complesso e articolato è il re-cord ceramico di c.da Cangiana e di Cazzola, dove, ac-canto alle casseruole carenate, si sono rinvenuti alcuniframmenti di olle ad orlo estroflesso, in qualche casofabbricate con lo stesso impasto, caratterizzato da ab-bondanti inclusi calcitici di medie dimensioni e dal nu-cleo scuro, indizio della cottura in atmosfera riducente(Tav. 3). Recenti scavi e revisioni di dati 10 hanno con-sentito di associare le olle di piccole dimensioni conpareti verticali o leggermente convesse, prodotte in unimpasto facilmente riconoscibile, caratterizzato da ab-bondanti inclusi micacei, calcarei e calcitici, cotto in at-mosfera riducente e con la superficie esterna rifinita astecca, con bordo estroflesso e indistinto ma a volte leg-germente pendulo (Tav. I.20, 22 e 25), da un lato condei coperchi con pesante pomolo per la presa e con pa-reti talvolta perforate da fori-sfiatatoio a circa un terzodella parete, dall’altro con anfore globulari dipinte.
Queste olle non si rinvengono a Ciccobriglio, né aGiummello e nemmeno nei “siti minori” dove sono at-testate invece le casseruole ad orlo rientrante (Tav. I.1,2, 7-10, 17, 23, 24), segnalando quella che ci apparecome una relazione molto stretta tra introduzione deinuovi tipi vascolari e trasformazioni nell’assetto del-l’insediamento.
L. Z.
Lo scavo in contrada Colmitella
Il sito di Colmitella occupava in origine un’alturapoco elevata, che si estendeva longitudinalmente insenso E-W, e le sue pendici; oggi il sito risulta forte-mente modificato nella sua morfologia, non solo dallacostruzione dell’attuale SS640, realizzata negli anni’70, ma anche da diverse opere di sbancamento, fina-lizzate sia ad ottenere terreno coltivabile, sia alla rea-lizzazione di una casa rurale e dei suoi annessi.L’evidenza oggi recuperabile riguarda dunque soltantoalcuni settori di quello che era una volta l’insediamento:una parte dell’abitato, di cui sono stati scavati finora leporzioni superstiti di sette vani e alcune strutture fina-10 RIZZO Maria Serena, ZAMBITO Luca 2012.
354
les dYnamiques de l’islamisation en mÉditerranÉe centrale et en sicileLE DINAMICHE DELL’ISLAMIZZAZIONE NEL MEDITERRANEO CENTRALE E IN SICILIA - isBn 978-88-7228-735-4 - 2014 · École Française de rome / edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
tavola i
Reperti ceramici provenienti dai siti di Giummello (1-5), Ciccobriglio (6-19), Cangiana (20-25).
les dYnamiques de l’islamisation en mÉditerranÉe centrale et en sicileLE DINAMICHE DELL’ISLAMIZZAZIONE NEL MEDITERRANEO CENTRALE E IN SICILIA - isBn 978-88-7228-735-4 - 2014 · École Française de rome / edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
MARIA SERENA RIZZO - LAURA DANILE - LUCA ZAMBITO
lizzate ad attività domestiche, e un settore caratterizzatoda molteplici fosse scavate nella roccia marnosa dellasommità della collinetta e delle sue pendici sud-occi-dentali. In questa occasione saranno presentati i dati pre-liminari relativi al settore B, dove sono stati messi inluce alcuni ambienti destinati sia ad attività domestichesia alla lavorazione di prodotti agricoli. I dati di scavosaranno esposti in ordine cronologico, a partire dalla fasepiù recente e iniziando dall’area orientale, che è quellanella quale sono state rinvenute le testimonianze piùtarde.
1) Al di sotto di un lungo muro con orientamento Est-Ovest, che occupa quasi tutta la lunghezza del set-tore orientale ed è la struttura più recente individuatanell’area di scavo (verosimilmente da ascrivere ad etàmoderna come suggerito dai materiali rinvenuti),sono stati individuati alcuni lembi di strutture con iloro piani d’uso. Ad esse sono pertinenti due coppiedi apprestamenti pressoché circolari (Tav. II.1), deiquali uno è realizzato con frammenti di laterizi rive-stiti da uno strato di argilla, è delimitato da piccolepietre e mostra chiari segni dell’azione del fuoco; l’al-tro, invece, è ottenuto con lastre di pietra molto durae non presenta tracce di combustione. È possibile ipo-tizzare che i due apprestamenti fossero destinati a fun-zioni diverse ma complementari quali la macinazionedei cereali (apprestamenti in pietra) e la cottura delpane (apprestamenti in laterizi). Gli apprestamenti inlaterizi possono infatti essere interpretati come laparte inferiore di quei fornetti adibiti alla cottura delpane che costituiscono la versione stabile di un tipochiamato tannūr o t͎ābūn, diffuso nel Vicino Oriente,nel Maghreb e in Andalusia. Strutture di questo tiposono attestate in Sicilia all’interno di alcuni ambientidel casale di Piazza Armerina. A Colmitella, invece,esse si trovavano in un’area aperta, destinata allo svol-gimento di attività connesse con la preparazione e lacottura dei cibi. Il rinvenimento di due monete di Rug-gero II databili al 1145, poste sui piani associati aqueste strutture, ci induce a proporre una datazioneal XII secolo avanzato per questa fase edilizia del-l’insediamento. Al medesimo periodo sono ascrivi-bili alcune fosse, obliterate dal crollo delle strutturee ricavate nel banco di roccia naturale. Consideratala relazione stratigrafica tra le fosse e gli appresta-
menti per la preparazione e la cottura del pane e iltipo di materiali rinvenuti nel loro riempimento (frr.ossei, resti di pasto, cenere, reperti ceramici), è plau-sibile che esse fossero state utilizzate per scaricare ilmateriale di risulta delle attività connesse con la cot-tura e la preparazione dei cibi. Altre fosse, verosi-milmente coeve, sono state individuate sul versanteNord e Sud dell’area di scavo, tagliate dallo sbanca-mento moderno.
2) Ad una fase precedente, databile tra la fine dell’XI ela prima metà del XII secolo, sono pertinenti diversestrutture verosimilmente connesse anche con attivitàproduttive (vani VI-VIII) (Tav. II.2). All’interno delvano VII, infatti, è stata messa in luce una vaschettaquadrangolare con un piano lastricato adiacente e, nelconsistente strato di crollo che copriva il piano di cal-pestio relativo a queste strutture e riempiva la va-schetta, sono stati rinvenuti frammenti di una grossamacina e di grandi contenitori destinati allo stoccag-gio di derrate alimentari. Tra i reperti attribuibili aquesto periodo si notano alcune casseruole plasmatea mano (Tav. III.1-2), caratterizzate da pareti verti-cali e presa a orecchio 11, una delle quali decorata daun cordone plastico con impressioni digitali. Si se-gnala inoltre il rinvenimento di un piatto con deco-razione in bruno ricoperto da vetrina 12 (Tav. III.3).
3) Ad una fase ancora anteriore, obliterata dagli straticitati, possono essere attribuite alcune costruzioniben distribuite su tutta la superficie finora indagata.All’estremità orientale dell’area di scavo, in partico-lare, è stato messo in luce un ambiente rettangolare(vano IV) il cui limite meridionale non è visibile (Tav.II.3), probabilmente perché danneggiato dallo sban-camento moderno che ha interessato questo versantedella collina. All’interno del vano, all’angolo nord-occidentale, è presente una banchina a spicchio di cer-chio della quale resta da chiarire la funzione. Gli stratidi crollo pertinenti all’ambiente, che si estendevanoin parte a due aree contigue al vano ad Est e adOvest, probabilmente aperte, e che erano costituiti dategole vacuolate miste a pietre, coprivano i piani dicalpestio realizzati direttamente sopra il banco di roc-cia e alcuni reperti che dovevano essere in uso al mo-mento della distruzione delle strutture. Tra essi siannota la presenza di almeno tre esemplari di pen-
11 Sull’introduzione e sulle matrici culturali di queste pentole pla-smate a mano si veda ARDIZZONE Fabiola 2004, p. 200-204.
12 Sulla cronologia dell’invetriata verde con decorazione in bruno,MOLINARI Alessandra 1997, p. 139, prima metà XII secolo.
356
les dYnamiques de l’islamisation en mÉditerranÉe centrale et en sicileLE DINAMICHE DELL’ISLAMIZZAZIONE NEL MEDITERRANEO CENTRALE E IN SICILIA - isBn 978-88-7228-735-4 - 2014 · École Française de rome / edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
L’INSEDIAMENTO RURALE NEL TERRITORIO DI AGRIGENTO: NUOVI DATI DA PROSPEZIONI E SCAVI 357TAVOLA II
Colmitella. Il settore B in corso di scavo.
1
2
3 4
5 6
les dYnamiques de l’islamisation en mÉditerranÉe centrale et en sicileLE DINAMICHE DELL’ISLAMIZZAZIONE NEL MEDITERRANEO CENTRALE E IN SICILIA - isBn 978-88-7228-735-4 - 2014 · École Française de rome / edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
MARIA SERENA RIZZO - LAURA DANILE - LUCA ZAMBITO358 TAVOLA III
Colmitella. Reperti dallo scavo del settore B.
les dYnamiques de l’islamisation en mÉditerranÉe centrale et en sicileLE DINAMICHE DELL’ISLAMIZZAZIONE NEL MEDITERRANEO CENTRALE E IN SICILIA - isBn 978-88-7228-735-4 - 2014 · École Française de rome / edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
tole a bordo ingrossato e rientrante (Tav. III.4). Il fattoche queste siano state rinvenute esclusivamente al-l’esterno del vano (sia a Est che a Ovest di esso), ciinduce ad avanzare l’ipotesi che le attività di prepa-razione e cottura dei cibi si svolgessero in uno spa-zio aperto. Tra i dati utili a fini cronologici si puòmenzionare il fatto che la fossa di fondazione delmuro Nord del vano IV tagliava uno strato che con-teneva metà circa di una lucerna di tipo siciliano eun frammento di un’olla ad orlo estroflesso, repertiche consentono una datazione dello strato tra la finedel VII secolo e gli inizi dell’VIII.
Procedendo verso Ovest, nel quadrato N28, si in-contra parte di un ambiente, incassato nella roccia perun’altezza di circa un metro e circondato da buche dipalo, verosimilmente connesse con il sistema di coper-tura, scavate anch’esse nel banco roccioso; nella paretedi roccia erano ricavate nicchie e alloggiamenti per con-tenitori. In uno di questi era collocata la parte inferioredi un’anfora, con fondo umbonato separato dalla pareteleggermente corrugata da un gradino (Tav. III.8), mor-fologia che richiama le anfore di età islamica, la cui dif-fusione nell’isola ci è nota dal X secolo 13. All’internodi questo spazio si riconoscono una struttura circolarerealizzata in pietre calcaree di medie dimensioni, de-stinata probabilmente all’appoggio di contenitori, e al-meno tre apprestamenti per la cottura. Tra essi, quellopiù occidentale, in uno stato di conservazione migliore,era realizzato con due spallette in pietra addossate allaparete di roccia, aveva il piano di fondo costituito daframmenti fittili ed era rivestito all’interno da uno stratodi argilla concotta con chiari indizi dell’azione delfuoco. Il rinvenimento di un abbondante strato di ce-nere al suo interno ne conferma la destinazione d’uso;lo strato ha infatti restituito numerosi frammenti perti-nenti a due esemplari di vasi da cucina: una casseruoladel tipo a orlo rientrante, con cerchielli impressi in cor-rispondenza delle prese e pareti carenate al di sotto diesse (Tav. III.7), e un “pentolino” caratterizzato da unorlo estroflesso fornito di beccuccio per versare e di unapresa verticale a sezione ovale (Tav. II.5; Tav. III.5-6).Entrambi i reperti hanno un impasto ricco di inclusi cal-citici e di colore scuro a causa di una cottura in am-biente riducente; essi presentano inoltre delle striaturesulla parte inferiore della parete esterna, generalmenteindicate come “decorazione a stuoia”. Insieme a questireperti ceramici è stato ritrovato anche uno scalpello diferro. Alcuni frammenti di tegole vacuolate, invece,sono stati rinvenuti in crollo sul piano di calpestio rea-
lizzato livellando la roccia. Si segnala inoltre la presenzadi una piccola fossa riempita con il materiale di scaricoconnesso alle attività di cottura e preparazione dei cibi(ossa, cenere, carbone, pochi frammenti di laterizi).
Un’altra struttura destinata alla cottura dei cibi, conannessa fossa di scarico, è stata individuata sulla pen-dice occidentale della collina, al di sotto di un consi-stente crollo di tegole. Analogamente a quanto annotatosopra, al suo interno è stato rinvenuto uno strato di ce-nere contenente una casseruola ad orlo rientrante chene suggerisce la pertinenza alla medesima fase crono-logica. A Nord di questa struttura, inoltre, era collocatoun mortaio di pietra verosimilmente utilizzato per la pre-parazione dei cibi. Tali livelli erano obliterati da un pianodi calpestio sul quale sono stati rinvenuti altri frammentidi casseruole con orlo rientrante insieme a frammentidi anse con solcatura mediana. Al di sopra di questo li-vello è stato intercettato uno spesso strato di crollo, co-perto da una nuova sistemazione pavimentale sulla qualesi sono rinvenuti frammenti di ceramica invetriata verde,due frammenti di lucerne a becco canale, anch’esse in-vetriate in verde (Tav. III.9), in associazione a qualcheraro frammento di casseruola del medesimo tipo, pro-babilmente residuale, contesto che è possibile datare,nel suo complesso, al X secolo. L’area sembra dunqueaver subito diverse modifiche in un arco di tempo piut-tosto breve, la cui cronologia sarà comunque da preci-sare con il completamento dei lavori di scavo e di studiodei reperti.
Nell’area di scavo sono stati individuati anche tregrandi contenitori per lo stoccaggio di derrate, allog-giati in tagli eseguiti nel banco di roccia, per i quali, inassenza di relazioni stratigrafiche, non è semplice pro-porre una cronologia. Uno di essi, ancora in situ, po-trebbe fornire, con il prosieguo delle indagini, utilielementi per la costruzione di una cronologia relativa,dal momento che si trova sotto altre strutture.
Nel settore occidentale a valle dell’altura, sono statiportati in luce altri tre ambienti rettangolari ascrivibilialla medesima fase, adiacenti e allineati in senso Nord-Sud (Tav. II.6). Tegole vacuolate, alcune delle quali conla superficie superiore striata, costituivano il crollo deltetto, depositatosi su un piano di calpestio ottenuto conterra battuta e tritume calcareo. La presenza di partico-lari apprestamenti all’interno degli ambienti consentedi ipotizzare che essi fossero adibiti allo svolgimento
L’INSEDIAMENTO RURALE NEL TERRITORIO DI AGRIGENTO: NUOVI DATI DA PROSPEZIONI E SCAVI
13 Vd. infra.
359
les dYnamiques de l’islamisation en mÉditerranÉe centrale et en sicileLE DINAMICHE DELL’ISLAMIZZAZIONE NEL MEDITERRANEO CENTRALE E IN SICILIA - isBn 978-88-7228-735-4 - 2014 · École Française de rome / edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
MARIA SERENA RIZZO - LAURA DANILE - LUCA ZAMBITO
di una attività produttiva che al momento non siamo ingrado di indicare con precisione (verosimilmente con-nessa alla lavorazione di prodotti agricoli). All’internodel vano II, infatti, è stata individuata una struttura diforma pressoché ellittica, ottenuta con pietre dispostein modo irregolare e rinzeppate con tegole, realizzatacon ogni probabilità per ottenere un piano di lavoro odi appoggio. Essa era in connessione con una vaschettaquadrangolare situata a Sud del vano II, all’interno delcontiguo vano I. I due ambienti erano collegati da unacanaletta rivestita da coppi vacuolati (analoghi a quelliutilizzati per la copertura degli ambienti) che conducevaad una buca scavata nel piano di calpestio del vano I.Essa verosimilmente era destinata a contenere un reci-piente funzionale a raccogliere il liquido che scorrevanella canaletta. Nel vano III, inoltre, sono state indivi-duate una banchina semicircolare e una struttura qua-drangolare realizzata con grossi blocchi calcarei per laquale al momento non siamo in grado di proporre unainterpretazione precisa. Per quanto riguarda la crono-logia, un importante elemento post quem è fornito daun sigillo di piombo (Tav. III.10), rinvenuto all’internodello strato di terra battuta che costituiva il piano di cal-pestio del vano II. Il sigillo è relativo ad un Antiochos
notarios e databile, secondo la cronologia gentilmenteindicata dal Prof. Kislinger, tra il 720 e il 780. Dal me-desimo contesto proviene l’impugnatura di una spadain bronzo, confrontabile con un esemplare edito daManganaro e di tipo chiaramente bizantino 14. Tra i re-perti recuperati sopra il piano di calpestio, invece, si di-stinguono alcuni frammenti di casseruola ad orloinspessito e rientrante, analoghi ad altri già individuatinel sito, e associati ad un’ansa di bronzo sormontata daun piccolo melograno (Tav. III.11). Essa è riconduci-bile ad un tipo di versatoio tipico dell’area islamicaorientale al quale viene in genere attribuita una crono-logia compresa tra il IX ed il XII secolo 15. Numerosiframmenti di casseruole ad orlo rientrante, in diversi casicon striature sulla superficie esterna, sono stati rinve-nuti anche sui piani pavimentali dei vani contigui.
I vani I-II poggiano su uno strato caratterizzato dallapresenza di lenti di argilla concotta e contenente unagrande quantità di cereali e legumi abbrustoliti, perti-nente ad una fase precedente ancora da indagare. Sul-
l’interfaccia superiore di questi strati sono stati rinve-nuti alcuni frammenti di sigillata che suggeriscono unadatazione genericamente compresa tra il VI e il VII se-colo per la fase più antica.
Lo scavo condotto nel sito di Colmitella, in sintesi,permette di riconoscere almeno quattro fasi ben distin-guibili la cui cronologia sarà meglio precisata con il pro-sieguo dei lavori. Allo stato attuale della ricercapossiamo proporre per la più recente una datazione nelcorso del XII secolo. Per la fase precedente possiamomettere in evidenza come essa sia connotata in uno deicontesti dalla presenza di pentole a pareti verticali, inun altro dalle lucerne a serbatoio chiuso e dai frammentidi invetriata verde e il fatto che essa obliteri le strutturepertinenti ad una fase anteriore, contraddistinta da cas-seruole con orlo rientrante e “decorazione a stuoia”. L’ul-tima fase infine, ancora da indagare, è connotata dallapresenza di frammenti di terra sigillata.
L. D.
Per completare la descrizione del sito è opportunosottolineare il rapporto dell’insediamento con le risorseidriche, rappresentate da due sorgenti che alimentavanodue diverse vasche, almeno una delle quali rivestita daun cocciopesto apparentemente di età romana e rifor-nita d’acqua grazie ad una canalizzazione in parte con-servata. Infine, si può ricordare che il settore Adell’insediamento, attualmente separato dall’area di abi-tato dall’attuale SS640, è occupato da un gran numerodi fosse (ne sono state individuate e scavate circa 80),probabilmente in origine granarie, successivamente uti-lizzate come immondezzai. Un primo assai parziale stu-dio di alcuni dei riempimenti sembra attestare che lefosse siano state riempite in momenti diversi, forse giàa partire dall’avanzata età bizantina 16, e certamente al-meno fino al XII secolo avanzato. Benché questo datosia da sottoporre alla verifica di un esame esaustivo deimateriali, sembra si debba constatare una notevole con-tinuità d’uso di questo settore del sito per lo stoccag-gio dei cereali. La scelta di concentrare le fosse tuttenella zona caratterizzata dall’affioramento del bancomarnoso è in primo luogo funzionale, e legata alla ne-cessità di utilizzare a questo scopo la roccia; l’esten-sione dell’area di fosse anche alla pendice occidentale
14 MANGANARO Giacomo 2001, p. 169-172, fig. 66-67. Gli esem-plari editi da Manganaro hanno graffiti sull’elsa, che riportano nomee titolo dei possessori.
15 È simile, ad esempio, a tipi di Nishapur, cfr. ALLAN James W.1981, p. 42-43, fig. 100.
16 È il caso ad esempio dell’US 3092, RIZZO Maria Serena, RO-
360
les dYnamiques de l’islamisation en mÉditerranÉe centrale et en sicileLE DINAMICHE DELL’ISLAMIZZAZIONE NEL MEDITERRANEO CENTRALE E IN SICILIA - isBn 978-88-7228-735-4 - 2014 · École Française de rome / edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
della collina, fino a quote decisamente basse, escludonointenti difensivi nella localizzazione delle cavità. Le di-mensioni relativamente piccole di ciascuna buca indu-cono a ritenere che l’ammasso avvenisse su basefamiliare. In epoca successiva nell’area, tagliando al-cune delle fosse ormai abbandonate e colmate, vengonoscavate tre tombe di rito islamico.
Il villaggio di Colmitella, dunque, si sviluppa almenoa partire dal VI/VII secolo e viene abitato fino al-l’avanzato XII; durante questo ampio arco cronologicomantiene le caratteristiche del villaggio rurale, con spazidestinati alle attività domestiche, ed in particolare allapreparazione e cottura dei cibi, spazi destinati proba-bilmente ad attività produttive, forse a disposizione del-l’intero villaggio (vani I-III), aree destinate allostoccaggio dei cereali.
Di notevole interesse, per quanto conservati in modomolto frammentario, gli strati e le strutture connessi conle ceramiche decorate “a stuoia”, che restituiscono unaprima immagine di una realtà ancora poco conosciutadal punto di vista archeologico in Sicilia, quella del-l’insediamento rurale altomedievale. L’analisi dei pochidati di cui disponiamo sembra indicare che anche in que-sta fase l’insediamento fosse stabile, privo di caratteridifensivi e chiaramente finalizzato allo sfruttamentodelle risorse agricole, i cui prodotti venivano trasfor-mati nel sito: il complesso dei vani I-II, per la presenzadella vaschetta quadrangolare nel vano I, che poteva es-sere destinata alla decantazione, era probabilmente unapprestamento per la produzione di olio, forse a dispo-sizione dell’intero villaggio 17. Numerose le tracce dellosvolgimento di attività domestiche, connesse in parti-colare con la preparazione e la cottura dei cibi. Le ban-chine angolari erano forse utilizzate per poggiarvi deicontenitori contenenti acqua o vivande, mentre nel vanodi N28 questa funzione era svolta dagli incassi scavatinella parete di roccia, oltre che da una banchina circo-lare di pietra. Sul piano delle tecniche e delle tipologieedilizie è interessante la coesistenza, fianco a fianco, distrutture quadrangolari costruite in pietra, almeno nello
zoccolo, con l’ambiente parzialmente interrato, circon-dato da buche di palo, che potevano sorreggere sem-plicemente una tettoia oppure sostenere pareti inmateriale stramineo 18; in tutti i casi, comunque, sem-bra che la copertura fosse realizzata con tegole vacuo-late, che, nei vani I-III, hanno in alcuni casi decorazionea striature 19. Non siamo in grado di dire, in questo mo-mento, se anche durante questa fase fosse utilizzato, perla conservazione dei cereali, il sistema del depositonelle fosse, o se siano connessi stratigraficamente conqueste strutture i dolii rinvenuti interrati nell’area.
Per quanto riguarda la cronologia di questi strati equeste strutture, essa è legata essenzialmente alla data-zione delle casseruole con decorazione “a stuoia”, checostituiscono il tipo ceramico nettamente più rappre-sentato in termini quantitativi. È ben noto che i dati re-lativi alla Sicilia orientale, più volte illustrati da LuciaArcifa, ed in particolare i risultati delle ricerche a Roc-chicella di Mineo, dove queste pentole sono state rin-venute in associazione con monete di Michele I, hannocondotto ad ipotizzare che esse si siano diffuse a par-tire dai primi decenni del IX secolo 20. I pochi elementiricavabili ad oggi dalle stratigrafie di Colmitella non con-trastano con questa cronologia: il sigillo allettato nelpiano del vano II, infatti, conferma che esso deve es-sere stato realizzato dopo il pieno VIII secolo, ed è dun-que successivamente a questo momento che possonoessere datati i livelli d’uso dei vani I-II, contenenti di-versi frammenti di casseruole ad orlo rientrante. L’ansadi bronzo con melograno, rinvenuta nel vano II in as-sociazione con le nostre pentole, trova, come si è giàdetto, confronti piuttosto stringenti con oggetti databilia partire dal IX secolo, attribuiti ad ambito culturale isla-mico. L’anfora a fondo umbonato rinvenuta nel vano/ca-panna di N28, per la morfologia generale e le dimensioniridotte, potrebbe essere confrontata genericamente conle piccole anfore da acqua da S͎abra al-Mans͎ūriyya 21,mentre il fondo umbonato, separato dal corpo da un gra-dino, ha numerosi confronti con anfore di X secolo rin-venute in Sicilia, da quelle prodotte dalle fornaci della
L’INSEDIAMENTO RURALE NEL TERRITORIO DI AGRIGENTO: NUOVI DATI DA PROSPEZIONI E SCAVI
MANO Domenico, c.d.s.; RIZZO Maria Serena, ZAMBITO Luca 2012,p. 421.
17 Per la produzione di olio in siti di età islamica in AndalusiaGUTIERREZ LLORET Sonia 1996a.
18 Simili ambienti parzialmente scavati nella roccia, interpretaticome capanne, sono attestati ad Enna in connessione con le pentolecarenate decorate a stuoia, GIANNITRAPANI Enrico, NICOLETTI Ros-sella, VALBRUZZI Francesca c.d.s. L’uso di utilizzare il banco roc-cioso per incavarvi la parte inferiore di alcuni vani può forse spiegarela preferenza, nella fase connotata dalle ceramiche “a stuoia”, per
siti topograficamente caratterizzati dall’affioramento di creste di roc-cia, documentata dalla prospezione di Luca Zambito.
19 I dati provenienti da alcuni contesti catanesi hanno permessodi recente di anticipare all’VIII secolo la diffusione delle tegole va-cuolate, ARCIFA Lucia 2010a, p. 108-109.
20 ARCIFA Lucia 2010a, p. 32-36; ARCIFA Lucia 2010b, p. 120-121.
21 GRAGUEB ChATTI Soundes, TRéGLIA Jean-Christophe, CAPELLI
Claudio, WAKSMAN 2011, fig. 4, tipo S͎abra 3.
361
les dYnamiques de l’islamisation en mÉditerranÉe centrale et en sicileLE DINAMICHE DELL’ISLAMIZZAZIONE NEL MEDITERRANEO CENTRALE E IN SICILIA - isBn 978-88-7228-735-4 - 2014 · École Française de rome / edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
MARIA SERENA RIZZO - LAURA DANILE - LUCA ZAMBITO
Valle dei Templi di Agrigento 22, all’esemplare di Delia,a quello di Casale Nuovo, nella quale però il gradino èmolto più accentuato 23. Sul piano morfologico/funzio-nale, sono già state segnalate le somiglianze tra le cas-seruole del tipo “Rocchicella”, e alcune produzionidiffuse in Africa settentrionale dalla prima età bizan-tina 24: la forma relativamente bassa, l’orlo rientrante, ilfondo convesso 25 trovano infatti corrispondenze in tipiplasmati a mano, attestati a Cartagine (e penso in par-ticolare alla classe V delle Late Wares di hayes 26). Ilrecente rinvenimento a Segesta, in un contesto di tardoVII secolo, di alcuni frammenti di pentole ad orlo in-grossato ed introflesso a cottura riducente ed inclusi cal-citici nell’impasto, di probabile produzione regionale 27,potrebbe rappresentare un indizio di uno sviluppo lo-cale di questa morfologia 28, attestata nell’VIII secolo aMarettimo e Cefalù 29. Nell’agrigentino la tecnologiadella cottura in atmosfera riducente è documentata daalcune produzioni, diffuse forse già anch’esse a partiredalla fine del VII secolo, attestate a Cignana, a Vito Sol-dano e nella stessa Colmitella, caratterizzate però da undiverso repertorio morfologico: le pentole agrigentinedi fine VII/VIII secolo sono infatti essenzialmente ollead orlo subverticale o estroflesso, cui si associano co-perchi con presa a pomello troncoconico, in alcuni casicon fori sfiatatoio, e che sembrano richiamare tipi si-mili diffusi nel mondo bizantino peninsulare ed orien-tale 30.
Interessanti i nuovi dati che vanno emergendo dallericerche più recenti e che disegnano un’area di diffu-sione del tipo della casseruola ad orlo rientrante e trat-tamento “a stuoia” della superficie molto più ampiarispetto a quanto non fosse possibile delineare soltantopochi anni fa: alle aree della Sicilia orientale e centralegià segnalate da Lucia Arcifa e Salvina Fiorilla 31, è pos-sibile oggi aggiungere il settore orientale dell’agrigen-
tino. Mancano in questo momento attestazioni ad Agri-gento e nella parte occidentale del suo territorio: pen-tole di questo tipo non sono state rinvenute, per esempio,nella valle del Platani. Tuttavia, casseruole ad orlo rien-trante ed impasto a cottura riducente sono documentatein alcune aree della Sicilia occidentale, in particolare,ne è stata rilevata la presenza nel territorio di Entella 32,mentre finora ad ovest di Agrigento non sembra atte-stato il trattamento “a stuoia”.
Nell’agrigentino, come nel territorio di Entella e nel-l’area di Gela 33, la distribuzione delle casseruole ad orlorientrante interessa in particolare siti facilmente ac-cessibili a carattere probabilmente agricolo, come èd’altronde confermato dal caso di Colmitella. Nel ter-ritorio di Agrigento, inoltre, come ad Entella, la diffu-sione delle casseruole ad orlo rientrante sembraconnotare un momento di “dinamicità” nell’assetto delpopolamento rurale: alcuni ampi villaggi a lunga con-tinuità di vita continuano ad essere popolati, ma altrivengono abbandonati 34, mentre si sviluppano un certonumero di piccoli insediamenti in siti in precedenza di-sabitati. Difficile, in questo momento, alla luce di datiancora frammentari e di ricerche in continua evoluzione,proporre una interpretazione: tuttavia, se, come a noisembra, la diffusione, nel nostro territorio, delle pen-tole ad orlo rientrante rispecchia una situazione inse-diativa definitasi nel corso del IX secolo, essa dovràessere valutata tenendo conto del fatto che si tratta diun’area di precoce conquista islamica, nonché degli in-dizi che sembrano rivelare, già forse dalla secondametà del IX secolo, l’esistenza di forme di controlloeconomico da parte della nuova entità statale 35. L’esem-pio di Colmitella sembra confermare come un proba-bile ruolo di central place abbia potuto facilitare lasopravvivenza dell’insediamento in questa difficilefase 36: le funzioni fiscali ed amministrative che il sito
22 ARDIZZONE Fabiola 2008, fig. 34.23 MOLINARI Alessandra, in questo volume.24 ARDIZZONE Fabiola 2004a, p. 377-378.25 Sulla diffusione dei contenitori da fuoco a fondo convesso in
epoca altomedievale, in connessione forse con nuovi sistemi di cot-tura e nuove abitudini alimentari, ARThUR Paul 2007a, p. 179.
26 hAyES John W. 1976, p. 97.27 FACELLA Antonino, MINNITI Bernarda, CAPELLI Claudio c.d.s.28 Già ipotizzata da Alessandra Molinari, MOLINARI Alessandra
2009, p. 135.29 ARDIZZONE Fabiola 2004a, p. 377-378.30 RIZZO Maria Serena, ZAMBITO Luca 2012, fig. 2, 10, 13-16;
fig. 3.31 FIORILLA Salvina 2010, p. 98.
32 CORRETTI Alessandro, MIChELINI Chiara, VAGGIOLI Adelaide2010, p. 170-171.
33 BAAS Philipp, BERGEMANN Johannes 2010, p. 207.34 Il fenomeno è evidente ad esempio nel territorio di Palma di
Montechiaro, dove soltanto due siti hanno tracce evidenti di una con-tinuità in età altomedievale, attestata dalle casseruole ad orlo rien-trante, BURGIO Aurelio c.d.s.
35 Su questa lunga fase, che determinò con ogni probabilità si-tuazioni differenziate nelle varie parti dell’isola, con una probabileprecoce attività di controllo fiscale e di installazione di coloni nel-l’agrigentino, ARCIFA Lucia, BAGNERA Alesssandra, NEF Annliese2012, p. 267-268. L’installazione di coloni allo scopo di dissodareterre incolte è in qualche modo attestata dal trattato di al-Da-wūdī,ABDUL WAhAB hasan husni, DAChRAOUI Farhat 1962.
36 BELVEDERE Oscar 2004, p. 9.
362
les dYnamiques de l’islamisation en mÉditerranÉe centrale et en sicileLE DINAMICHE DELL’ISLAMIZZAZIONE NEL MEDITERRANEO CENTRALE E IN SICILIA - isBn 978-88-7228-735-4 - 2014 · École Française de rome / edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it
potrebbe aver svolto in età bizantina e che sono sug-gerite da una parte dal sistema di fosse granarie e didolii, dall’altro dal sigillo del notaio Antiochos garan-tirono forse al villaggio la lunga continuità di popola-mento che emerge dallo scavo. Non vanno poi trascuratialtri aspetti, dalla relazione con le fonti di approvvi-gionamento idrico, garantito da antiche strutture idrau-liche, all’inserimento in un sistema agricolo complesso,che affiancava alla produzione cerealicola e dei legumi(documentati tra i semi tostati nella fase bizantina) pro-duzioni più specializzate, in primo luogo probabilmentequella dell’olivo, alla cui trasformazione erano desti-nate specifiche attrezzature. Queste funzioni dovetterotrovare continuità anche all’interno della nuova orga-nizzazione “per casali”, che, almeno nel territorio dicui stiamo discutendo, sembra associarsi, sul piano delpopolamento rurale, ad un momento in qualche mododi “selezione” e ristrutturazione, che porta a forme diinsediamento meno frammentate e imperniate sul vil-
laggio. Potrebbe, in questa chiave, non essere casualela possibile concomitanza cronologica con il rescrittodi al-Mu‘izz e con la forte spinta alla riorganizzazionedel territorio e del popolamento che esso manifesta,anche a fini di controllo politico-religioso della popo-lazione rurale: se è ben chiaro, alla luce della ricca do-cumentazione archeologica ormai disponibile, almenonella Sicilia occidentale, che esso non comportò né l’ab-bandono degli insediamenti rurali aperti, che anzi si or-ganizzano e si strutturano proprio in questo momento,né l’occupazione generalizzata delle alture, che pureconoscono in diversi casi una nuova fase di occupa-zione 37, potrebbe però aver favorito la concentrazionedella popolazione nei villaggi, a scapito di forme piùdiffuse di popolamento.
L’INSEDIAMENTO RURALE NEL TERRITORIO DI AGRIGENTO: NUOVI DATI DA PROSPEZIONI E SCAVI
37 Venendo forse a costituire dei “capoluoghi di distretto”, MO-LINARI Alessandra 2004, p. 38.
363
Fabiola ardizzone et annliese Nefles dYNamiQUes de l’islamisatiON eN mÉditerraNÉe CeNtrale et
eN siCile : VariatiONs d’ÉCHelle
LA SICILE DANS LA MÉDITERRANÉE ISLAMIQUE
Piero FoisPeUt-ON dÉGaGer UNe stratÉGie militaire islaimiQUe PrOPre aUX
Îles de la mÉditerraNÉe aUX Viie -Viiie sièCles ?david bramoulléla siCile daNs la mÉditerraNÉe Fatimide (Xe-Xie sièCle)Christophe Picardla mÉditerraNÉe CeNtrale, UN territOire de l’islam
LE PROCESSUS D’ISLAMISATION EN MÉDITERRANÉECENTRALE : LE CADRE RÉGIONAL
annliese Nef QUelQUes rÉFleXiONs sUr les CONQUÊtes islamiQUes, le PrOCes-
sUs d’islamisatiON et imPliCatiONs POUr l’HistOire de la si-Cile
adalgisa de simone iN marGiNe alla FisCalitÀ islamiCa iN siCiliamaria amalia de lucal’islamiZZaZiONe del sistema mONetariO iN siCilia Nel PeriOdO
aGHlabita (827-909): l’aPPOrtO del medaGliere del mUseO ar-CHeOlOGiCO a. saliNas di PalermO
Vivien Prigent l’ÉVOlUtiON dU rÉseaU ÉPisCOPal siCilieN (Viiie-Xe sièCle)marie legendreHiÉrarCHie admiNistratiVe et FOrmatiON de l’État islamiQUe
daNs la CamPaGNe ÉGYPtieNNe PrÉ-ṬŪlŪNidemario re, Cristina rognoniCristiaNi e mUsUlmaNi Nella siCilia islamiCa. la testimONiaNZa
delle FONti letterarie italOGreCHe
ÉVOLUTIONS SOCIALES, STRUCTURES URBAINES ETCULTURES MATÉRIELLES : LES VILLES,
UN TERRAIN D’OBSERVATION PRIVILÉGIÉ ?Chokri touihrila traNsitiON UrbaiNe de bYZaNCe À l’islam eN iFrĪQiYa VUe de-PUis l’arCHÉOlOGie. QUelQUes NOtes PrÉlimiNairessobhi bouderbala Les mawāLī À FUsṬāṬ aUX deUX Premiers sièCles de l’islam et leUr
iNtÉGratiON sOCialeroland-pierre Gayraud arabisatiON, islamisatiON et OrieNtalisatiON de l’ÉGYPte À la
lUmière de l’arCHÉOlOGielucia arcifa, alessandra bagnera islamiZZaZiONe e CUltUra materiale a PalermO: UNa riCONside-
raZiONe dei CONtesti CeramiCi di CastellO - saN PietrOrenato Giarrusso, angelo mulone CaratteriZZaZiONe miNeralOGiCO-PetrOGraFiCa di CamPiONi Ce-
ramiCi PrOVeNieNti da CastellO - s. PietrO, dalla CHiesadella GaNCia (PalermO) e da CastellO della Pietra (Castel-VetraNO)
Fabiola ardizzone, elena Pezzini, Viva saccolO sCaVO della CHiesa di saNta maria deGli aNGeli alla GaNCia:
iNdiCatOri arCHeOlOGiCi della Prima etÀ islamiCa a PalermOViva saccol’islamiZZaZiONe a PalermO attraVersO dUe CONtesti di PalaZZO
bONaGia (sCaVi di steFaNO)Francesca spatafora, emanuele Canzonieri al-KHāliṢa: alCUNe CONsideraZiONi alla lUCe delle NUOVe sCO-
Perte arCHeOlOGiCHe Nel QUartiere della KalsaCarla aleo Nero, monica Chiovaro PiaZZa bOlOGNi (PalermO): OsserVaZiONi sU alCUNi CONtesti di etÀ
islamiCa eNtrO il PerimetrO della “madĪNat balarm”Fabiola ardizzone, Francesca agrò l’islamiZZaZiONe a PalermO attraVersO UNa rilettUra della
CeramiCa da FUOCO dei bUtti di Via imeraemanuele Canzonieri, stefano VassalloiNsediameNti eXtraUrbaNi a PalermO: NUOVi dati da maredOlCeFabiola ardizzone, elena Pezzini la PreseNZa dei CristiaNi iN siCilia iN etÀ islamiCa: CONsidera-
ZiONi PrelimiNari relatiVe a PalermO e ad aGriGeNtOletizia arcoleo, luca sineoaNalisi arCHeOZOOlOGiCa di dUe CONtesti della CittÀ aNtiCa di
PalermO: la GaNCia e i “sili” di Via imera (PalermO, iX-X se-COlO d.C.)
ÉVOLUTIONS DES STRUCTURES FONCIÈRES ET DU PEUPLEMENT DANS LES ZONES RURALES :
L’ÉCHELLE MICRO-RÉGIONALE
mohamed Hassen GeNèse et ÉVOlUtiON dU sYstème FONCier eN iFriQĪYa dU Viiie aU
Xe sieCle : les CONCessiONs FONCières (QaṬI‛a), les terres rÉ-serVÉes (ḤIma) et les terres HaBOUs
antonio rotolo, José maría martín CivantossPUNti di riFlessiONe sUll’iNsediameNtO di ePOCa islamiCa Nel
territOriO dei mONti di traPaNialessandra molinari le riCerCHe Nel territOriO di seGesta-CalatHamet-CalataFimi:
riPeNsaNdO ad UN VeNteNNiO di riCerCHe Nella siCilia OCCi-deNtale
alessandro Corretti, antonino Facella, Claudio Filippo mangiaracina CONtessa eNtelliNa (Pa). FOrme di iNsediameNtO tra tarda aN-
tiCHitÀ e etÀ islamiCamaria serena rizzo, laura danile, luca Zambitol’iNsediameNtO rUrale Nel territOriO di aGriGeNtO: NUOVi dati
da PrOsPeZiONi e sCaViOscar belvedere, aurelio burgio, rosa maria CuccoeVideNZe altOmedieVali Nelle Valli dei FiUmi tOrtO e imera set-
teNtriONaleJohannes bergemann FUNde der islamisCHeN PHase im Gebiet VON Gela UNd im HiN-
terlaNd VON aGriGeNtGiuseppe Cacciaguerra l’area meGarese tra il iX e l’Xi seCOlO: UN PaesaGGiO iN traNsi-
ZiONebibliOGraPHie GÉNÉrale
table des matières
Edipuglia srl, via Dalmazia 22/b - 70127 Bari-S. Spiritotel. 0805333056-5333057 (fax) - http://www.edipuglia.it - e-mail: [email protected]