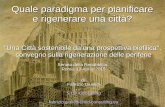"Storia militante": per una nuova Teoria della Conservazione e del Restauro architettonico e...
Transcript of "Storia militante": per una nuova Teoria della Conservazione e del Restauro architettonico e...
PER UNA STORIA MILITANTEStoria dell’Architettura
tra Scienza e Società
ISBN 978-88-89999-49-3
9 788889 999493 > € 25,00
2009-2010
18-19
P
er u
na s
tori
a m
ilita
nte
di Maria Margherita Bulgarini
BOLL
ETTI
NO
SSF
SO
CIE
TÀ D
I STU
DI F
IOR
ENTI
NI
2009-2010
18-19
BOLL
ETTI
NO
DEL
LA S
OC
IETÀ
DI S
TUD
I FIO
REN
TIN
Ia cura diFerruccio Canali e Virgilio Carmine Galati
per una storia ‘militante’storia dell’architettura tra scienza e società
a cura di Ferruccio Canali e Virgilio Carmine Galati
anno 2009-2010 numero 18-19
BollettinoDella soCietÀ Di stuDi Fiorentini
Collana di studi storici
Bollettino della Società di Studi Fiorentini
comitato ScientiFico
Ferruccio Canali, Giorgio Caselli, Giovanna De Lorenzi, Carlo Francini, Virgilio Carmine Galati, Gabriele Morolli, Gastone Petrini, Francesco Quinterio
comitato di lettura e di redazione
Ferruccio Canali, Valerio Cantafio Casamaggi, Giorgio Caselli, Carlo Francini, Virgilio Carmine Galati, Francesco Quinterio, Giuseppe Rizzo
logo: Virgilio Carmine Galati
Soci corriSpondenti
Raffaele Avellino (Umbria), Maria Beatrice Bettazzi (Emilia), Vittoria Capresi (Austria), Tommaso Carrafiello (Campania), Antonella Cesaroni (Marche), Alfredo Cisternino (Liguria), Luigina Galati (Salento), Bombina Anna Godino (Calabria), Motoaki Ishii (Giappone), Enrica Maggiani (Liguria), Olimpia Niglio (Lombardia), Valentina Orioli (Romagna), Andrea Pane (Puglia), Leonardo Scoma (Sicilia), Karin Templin (Inghilterra), Maria Antonietta Uras (Sardegna), Vincenzo Vandelli (Emilia)
Proprietà letteraria e artistica di SSF: divieto di riproduzione e di traduzioni. Gli Organi Direttivi della SSF e la Redazione della rivista non si assumono responsabilità per le opinioni espresse dagli Autori, né per la corresponsione di eventuali Diritti di Riproduzione gravanti sulle singole immagini. Di norma è la Redazione stessa che si prende cura della correzione delle bozze. L’invio di contributi per la pubblicazione non implica né l’edizione degli stessi (per ogni contributo una “Valutazione di accettazione” verrà espresso dal Comitato Scientifico e/o di Redazione), né una loro edizione immediata (i tempi verranno infatti stabiliti di volta in volta sulla base delle priorità o delle esigenze editoriali indicate dagli Organi Direttivi). I materiali grafici inviati verranno comunque soggetti, sia come dimensione di pubblicazione sia come numero, al progetto editoriale approntato per ogni «Bollettino». Non si restituiscono i dattiloscritti, né le immagini, né i disegni pubblicati o non, né i libri recensiti. Il materiale inviato viaggia a rischio mittente. La pubblicazione di foto, disegni e scritti da parte degli Autori implica la loro totale rinuncia alla corresponsione di ogni compenso di Diritto d’Autore, trattandosi di pubblicazione scientifica e senza fini di lucro da parte della Società di Studi Fiorentini.
PER UNA STORIA MILITANTE«Bollettino SSF», 18-19, 2009-2010a cura di Ferruccio Canali e Virgilio Carmine Galati
I disegni presenti in questo numero nella serie “L’‘altra’ Firenze” sono di Ferruccio Canali (pp. 8, 10, 140, 231); di Virgilio C. Galati (pp. 178, 210, 231); di Bombina A. Godino (p. 228); di Domenico Leporini (p. 231)Nella serie “Raccomandazioni per le Energie alternative” i disegni sono di Ferruccio Canali (pp. 191, 194, 207); di Virgilio C. Galati (pp. 189, 195, 198, 204). La fotografia di p. 230 è di Virgilio C. Galati.
cura ScientiFica Ferruccio Canali e Virgilio Carmine Galatiprogetto e cura graFica Ferruccio Canali e Virgilio Carmine GalatireviSione editoriale Maria N. Brigliadori, Luigina Galati e Domenico Leporini traduzioni in ingleSe Karin Templincopertina e FaScetta graFica (p.1) Virgilio C. Galati (Clio polemeia)
Il «Bollettino» è stato registrato presso il Tribunale di Firenze al n.4777 del 2 marzo 1998 fino all’anno 2002. Poi è stato trasforma-to in “Collana editoriale” non potendo garantire regolari uscite periodiche. Il «Bollettino» è registrato nel sistema U-GOV (sistema per la governance degli Atenei universitari italiani del “Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica”) con codice: ISSN 1129-2800. Redazione e Amministrazione: via Boccaccio 44/B, 50133 Firenze
finito di stampare nel 2010 daLitografia I.P. - Firenze
Copyright © 2010 by Emmebi Edizioni FirenzeProprietà letteraria riservata
190
RACCOMANDAZIONI PER L’INSEDIAMENTO E L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER L’ENERGIA ALTERNATIVA
(EOLICA, SOLARE E FOTOVOLTAICA)
di Ferruccio Canali e Virgilio Carmine Galati
Introduzione
La Toscana è stata teatro in questi ultimi anni di un difficile contenzioso che, oltre a contrapporre privati e Autorità (comunali, provinciali e regionali), ha visto consumarsi anche una sonora spaccatura tra le Associazioni ambientaliste: la realizzazione del «parco eolico di Scansano», in provincia di Grosseto, duramente avversato da alcuni abitanti del luogo è stata motivo per porre in evidenza come, al di là dell’esito giudiziario della vicenda (il TAR ha sancito nell’aprile 2010 che i lavori di realizzazione debbano proseguire secondo l’Autorizzazione rilasciata dalla regione Toscana), le energie ‘alternative’ non risultino comunque e sempre a ‘impatto zero’ o, perlomeno come tali non vengano percepite dagli abitanti. Ma la vicenda ha anche dimostrato come le realizzazioni degli impianti legati alla “Green Economy” non godano affatto di quegli automatismi insediativi e realizzativi che la loro caratterizzazione sembrava in origine garantire. Dalla Toscana la polemica si è estesa ad altri casi, aprendo un dibattito e, comunque, richiedendo una presa di coscienza problematica che non può più essere elusa; dalla Toscana, ancora una volta, anche dopo il caso Montichiello, le tematiche paesaggistiche sono venute a sposarsi con un’ottica ambientalista decisamente sui generis, spesso contro corrente e decisamente orientata a problematizzare le convinzioni apparentemente acquisite. I casi di cronaca relativi «al grande buisiness del vento», e agli scandali e alle polemiche relative, hanno fatto intravedere, poi, un mondo di interessi e di incentivi che poco hanno a che fare con la coscienza ecologica e ambientalista, inducendo a porre un’attenzione ancora maggiore all’impatto paesaggistico e alla ‘progettazione’ compatibile di impianti pur nati con la migliore caratterizzazione «green».Ecologia è diventata una sorta di parola d’ordine cui hanno però fatto da corrispettivo, in molti casi, un più corrivo Ecologismo se non veri e propri eco-sprechi.Così, anche nell’ambito della Tutela monumentale, l’affermarsi di nuovi Valori – accanto a quelli tradizionali … - quali “Ambientalismo” ed “Ecologia” nella ricerca di un maggiore equilibrio, cioè, tra la Natura e l’azione dell’Uomo, tra l’Habitat e la Compatibilità dell’intervento umano, è divenuto in breve un Leitmotiv del quale si stenta molto spesso a cogliere i caratteri fondanti e, soprattutto, le concrete finalità. “Green Economy”, “Energie pulite”, “Risparmio energetico”, “Energie rinnovabili”, “Protezione dell’Ambiente e della Natura” concretamente e operativamente espresse nei parametri di “Eco-compatibilità”, “Riuso”, “Riciclo”, “Biodegradabilità”, “Rinnovabililità”, “Ecosostenibilità”, “Biologico”, “Non impattante” o “a impatto zero”, “a risparmio energetico”, “non inquinante”, “differenziato”, “antiallergico” o “non allergenico”, “contro le intolleranze” sono concetti entrati nel linguaggio corrente, tanto da condizionare le scelte non solo di Governi e Amministrazioni, ma anche del singolo cittadino. Il progresso si vorrebbe fosse un ‘progresso verde’ spesso legato, dal punto di vista teorico e filosofico, ad afflati new-age, e a ricerche spirituali. Da tutto ciò è scaturito il desiderio di una tecnologia sicura al 100%, rifiuto di ogni rischio energetico, fiducia nelle nuove tecnologie non tradizionali, contrattazione spinta per salvaguardare il proprio habitat, etc.; tutte lotte, nate da un doveroso e necessario senso di responsabilità ambientale, che a volte si sono venute anche a prefigurare come espressioni di anti-modernismo, specie sul piano infrastruttale. Tali concezioni ecologiste attuali non va dimenticato che non trovavano certamente una diffusione presso la società solo cinquant’anni fa quando il Progresso passava, invece, attraverso la casa moderna costruita presso la fabbrica, l’asfalto sulle strade, la cementificazione delle coste, l’espansione dei nuovi quartieri e l’abbandono del centro storico, o quando si apprezza il “sano olezzo” del petrolio, con un afflato ancora futurista. Che molti comportamenti e convinzioni attuali generino Ecologismo e non vera Ecologia? Dopo almeno dieci anni di richieste e di esperienze ecologiste si può cominciare a svolgere una riflessione più articolata sul fenomeno, cercando di individuare quelle storture o chimere che, almeno a livello di Valori monumentali, hanno dato luogo ad una ‘Spreco-economia’ se non a vere e proprie ‘Eco-speculazioni’, dando luogo ad un nuovo ‘consumismo ecologico’ (fatto di beni ecologici quali lavatrici energetiche, frigoriferi a basso consumo, automobili a benzina verde, architetture ecosostenibili …). Se si affronta il problema da un punto di vista produttivo, si nota come la cosiddetta ‘energia pulita’ venga costituita, in molti casi, da strutture e supporti che senza l’industria pesante tradizionale non esisterebbero. Così, il problema semplicemente si sposta, in modo che alcuni elementi o componenti
APPUNTI, RIFLESSIONI E DIBATTITI 191
vengano realizzati ‘altrove’, fuori dalla cosiddetta “green economy” in un qualche posto remoto (opportunamente privo di leggi di controllo) ma pur sempre sulla Terra. Quindi per produrre energia pulita occorre che da qualche parte si producano le strutture funzionali a tale intento con un energia sporca ed inquinante. Il problema ritorna alla sua radice e induce a compiere riflessioni puntuali, su aspetti singoli che, a partire da considerazioni generali, pur valevoli, vengono troppo spesso orientate anch’esse su parametri unicamente quantitativi. Il caso della produzione delle Energie Alternative risulta particolarmente emblematico per i risvolti insospettati che ha mostrato e per l’alto livello impattante delle realizzazione, che, in molti casi, sembrano contraddire proprio quegli assunti “green” di quali tutta la sensibilità ecologista era partita.
A. IndividuazioneIl ‘sistema’ delle Energie Alternative (E.A.) tra Conservazione e Sviluppo
Territorio, Paesaggio, Città e Architettura costituiscono ambiti imprescindibili, nella concezione diffusa, per valutare la qualità delle condizioni di una società e dei suoi standard qualitativi: territori degradati sono indice di uno scandente livello di vita civile; aree abbandonate costituiscono detrimento di valori collettivi; architetture dismesse o esteticamente deprimenti vanno a discapito della qualità ricercata e diffusa, creando luoghi invivibili. Nella ‘green economy’ è stato individuato un motivo di valorizzazione di questi ambiti: territori ricchi di potenzialità energetiche rinnovabili; zone con impianti a contenuto impatto ambientale; bio-architetture ecosostenibili in grado di elevare gli standard abitativi risparmiando energia se non ‘a consumo zero’. Ritornano, nell’ambito specifico, i concetti di “Energie pulite”, “Risparmio energetico”, “Energie rinnovabili”, “Protezione dell’Ambiente e della Natura” sia a livello di impianti di produzione (territoriale, paesaggistica, architettonica), sia di consumo diretto.Gli impianti fotovoltaici e solari; i parchi eolici; impianti a biomasse; i complessi di fitodepurazione sono venuti a costituire negli ultimi anni nuclei di produzione di ‘energie alternative’, che solo per il fatto della Rinnovabilità energetica e Ecosostenibilità sono stati diffusi sul territorio con grandi agevolazioni economiche e amministrative (spesso una semplice Dichiarazione di Inizio Attività all’Autorità Comunale cui non corrispondeva, se non in casi limitatissimi, un diniego). Un vero e proprio vuoto legislativo, anche per la novità degli impianti e per l’accelerazione della messa a punto delle tecnologie, non prevedeva una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), trovando anzi canali privilegiati di finanziamento per le opere, così da creare dunque una vera e propria impennata nelle richieste e una conseguente difficoltà da parte dei Comuni a prendere una posizione (gli impianti non erano certo previsti nei vecchi Piani Regolatori, né si sapeva se considerali impianti industriali oppure no, proprio per quel carattere di Naturalità che teoricamente li contraddistingueva). La legislazione si aggiorna continuamente, ma provvedimenti ‘quadro’ ancora non sono stati messi a punto: resta il fatto che nel territorio prima agricolo e quindi dismesso, l’originaria destinazione d’uso in genere non cambia, tanto che basta una ‘semplice’ DIA (Dichiarazione di Inizio Attività) per i nuovi impianti industriali; solo alcuni Comuni richiedono una Variante al Piano Regolatore, se non un’Autorizzazione (mentre la cosa si ‘complica’ in caso di vincolo paesaggistico, e diventa complesso solo nel caso di scavi archeologici). Nella maggioranza dei casi, negli strumenti urbanistici comunali il terreno agricolo risulta, dal punto di vista della pianificazione, ‘terra di nessuno’: dopo la realizzazione delle nuove strutture per la produzione delle energie alternative, intere estensioni risultano recintate con filo spinato e riempite di grandi piastre riflettenti, con notevole impatto visivo ad effetto ‘lunare’ fortemente straniante. In aperta campagna, tutto ciò devasta territorio e paesaggio.Così, molte regioni italiane che hanno fatto dello sviluppo energetico alternativo un motore di progresso sociale ed economico hanno visto il loro territorio e i loro paesaggi deturpati in maniera strisciante, fino a quando alcuni Comuni ed alcune Regioni non hanno preso posizioni di attesa, se non di diniego, molto spesso per le proteste delle stesse Associazioni ambientaliste o di privati. Si sono aperti veri e propri contenziosi perché ormai in ogni parte d’Italia e, soprattutto al Centro-Sud, si è diffusa l’idea che si possa incrementare lo sviluppo proprio utilizzando queste fonti cosiddette pulite.
‘Eolico e paesaggio toscano’ (disegno di Ferruccio Canali, 2010)
APPUNTI, RIFLESSIONI E DIBATTITI192
Dal punto di vista paesaggistico spesso si è venuto a creare uno scempio visivo in nome di un ‘progresso verde’ che, in verità, è solo chimerico almeno per gli abitanti che lo vivono, ma non certo per coloro che hanno considerano tutto questo un vero affare (tanto che si è parlato di ‘tetti d’oro’ o di ‘campagne d’oro’), creando la convinzione di uno sviluppo delle campagne abbandonate («la pala frutta anche se non gira»). In verità tutto questo dovrà essere scontato in termini di ulteriore inquinamento spostato solo di venti o venticinque anni (quelli della garanzia degli impianti): le pale eoliche richiedono enormi platee di fondazione in c.a. estremamente invasive, che annullano la produttività dei terreni a meno di costosissime opere di ripristino agricolo; si aggiungono poi gravi problemi di inquinamento acustico, senza parlare dei rischi elettromagnetici; lo smaltimento degli impianti invecchiati (dopo vent’anni), a meno di contratti specifici, spetterà al proprietario e naturalmente si tratta di rifiuti speciali. Analogamente, per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, le schermature e i materiali di cui sono essi costituiti risultano altamente inquinanti e prodotti fuori dalla “green economy”, mentre plinti e platee occupano ampie estensioni trasformando in territorio industriale l’originario territorio agricolo. Inoltre, fortemente soggetti alle intemperie, i pannelli col tempo si rompono e si usurano, se non soggetti a manutenzione, con il rischio di percolamento dei materiali costitutivi. Ritornano questa volta nell’estensione superficiale invece che in altezza come per le pale, i problemi di dismissione finale degli impianti e dei loro materiali speciali, con gravi rischi di abbandono e di inquinamento in qualche decennio. Il tutto a partire dalla iniziale, buona intenzione di «aiutare l’ambiente».
B. Definizioni e indicazioni
1. «Parchi» per l’energia alternativa o impianti industriali: una questione solo lessicale?
La caratterizzazione con la quale gli impianti di produzione di energia alternativa sono stati fino ad oggi considerati risulta, alla luce dell’esperienza, in gran parte da sottoporre ad una rinnovata valutazione: non si tratta infatti di «Parchi» nell’accezione più piena e positiva del termine (omologabile ad esempio al «parco naturale», «parco archeologico», «parco giochi», etc.), ma, semmai, l’espressione va avvicinata a quella di «parco macchine». Si tratta, infatti, di veri e propri impianti industriali di produzione energetica, che dovrebbero essere omologati alle raffinerie o alle centrali elettriche: impianti che hanno senza dubbio un loro valore, spesso anche estetico o storico, ma che, sicuramente, mantengono il loro scopo specificatamente produttivo. Non si parla, infatti di «parco elettrico» o di «parco petrolifero» o di «parco carbonifero» o «idroelettrico», ma l’appartenenza anche dei nuovi impianti a quello stesso gruppo impone una serie di cautele e di attenzioni che forse, una denominazione ottimistica ha voluto in buona parte attutire. 2. Territorio, Paesaggio e Compatibilità. La progettazione degli impianti di Energia Alternativa come opportunità paesaggistica e di monumentalità infrastrutturale
Lo sviluppo delle energie “alternative” risulta decisamente necessario, ma deve imporre, alla base, una precisa progettualità che si esplichi dalla scala del ‘Progetto paesaggistico’ a quella del ‘Progetto infrastrutturale’ a partire dalla diversa natura degli impianti (verticali quelli eolici, orizzontali quelli fotovoltaici); ed è ovvio che solo il Progetto paesaggistico potrà coordinare quello di tipo infrastrutturale. All’interno del Territorio, cioè di quella parte di spazio che non mostra particolari caratteristiche di pregio, l’inserimento di impianti non dovrebbe essere vissuto come un problema di impatto, ma, costituire, piuttosto, un’opportunità. Aree dismesse, zone industriali degradate, aree devastate o abbandonate (discariche, etc) possono rappresentare occasioni di collocazione; nel caso del Paesaggio consolidato, invece, le cautele devono essere maggiori e i casi molto rari (solo qualora il paesaggio possa acquisire ulteriori valori aggiunti, riconosciuti da apposite Commissioni). Il concetto da cui muovere non deve, però, essere unicamente quello della ‘conservazione passiva’ dello status quo (anche se, ovviamente, risulta imprescindibile che ogni nuovo Impianto E.A. necessiti di una Valutazione di Impatto Ambientale opportunamente espressa dagli organi competenti e in primis da quelli di tutela): alla Conservazione deve infatti affiancarsi un concetto che veda nei nuovi impianti infrastrutturali una opportunità di incremento di Valore anche del Paesaggio stesso, cioè non solo un’opportunità di sviluppo economico, ma anche una possibilità di acquisizione di Bellezza, trasformando così il Territorio in Paesaggio.Solo un’opportuna pianificazione condotta a vasta scala dalla Regione, dopo un’accurata analisi dei singoli Valori areali, può dunque coordinare la collocazione dei nuovi impianti in zone in cui non solo non si vengano a deprimere già esistenti Valori estetici, percettivi, storici etc., ma dove, al contrario una nuova collocazione di Impianti E.A. possa costituire una vera e propria ‘attrattiva’ o ‘fulcro di Modernità paesaggistica’: la costruzione del Paesaggio, infatti, non va intesa come storicamente acquisita una volta per tutte, ma, piuttosto, essa deve essere concepita come un processo di trasformazione continua
APPUNTI, RIFLESSIONI E DIBATTITI 193
all’interno della quale una concreta capacità progettuale venga ad inserirsi come incremento (e mai decremento) di Valori acquisiti. Un’occasione in cui la Società contemporanea, con le proprie forme specifiche, può dare il meglio di se stessa vista l’eccezionalità anche dimensionale dei nuovi impianti. Ma soprattutto, con un’opportuna operazione ‘chirurgo-plastica’ la collocazione di Impianti E.A. deve in primo luogo portare valore ad aree già particolarmente devastate o dismesse (zone industriali o similia) attraverso veri e propri risanamenti.Una volta stabilita l’opportuna collocazione, dunque, sarà compito dei progettisti e degli organi di controllo individuare anche la ‘Qualità architettonica’ dei nuovi impianti, visto che non vi è ombra di dubbio che una ‘Moderna monumentalità’ possa essere ricercata anche nelle nuove strutture: i nuovi impianti posso divenire, ad esempio, attrattive per la loro ‘Modernità tecnologica’. La progettazione non può dunque che variare al variare dei siti interessati e non è possibile che siano, perciò, solamente i Tecnici delle Ditte di rivendita che si occupino di fornire impianti prodotti in maniera standard: così mentre gli Impianti Eolici procedono per inserimenti puntuali e con geometrie d’impatti verticali, gli Impianti Fotovoltaici hanno un inserimento disteso sul territorio con impatti di tipo orizzontale. Cambiano dunque le problematiche di inserimento: in una situazione territoriale orizzontale (quali pianure, deserti, linee di costa o di orizzonte piatto etc.), l’inserimento di pale eoliche viene a creare dei punti di attrazione verticale e quindi va considerato sulla base di una percezione puntuale. Invece, i pannelli fotovoltaici, da non inserire mai in aperta campagna per non modificare la vocazione agricola dei territori, possono diventare delle sorti di ‘tatuaggi territoriali’ in aree dismesse (cave, discariche etc.) assumendo specifici disegni, senza alterare la linea dell’orizzonte, ma, semmai, lavorando sulle geometrie delle specchiature e le morfologie naturali (per evitare l’effetto ‘laghetto piatto’ e creare invece delle ‘morfolofie variate’, con dei disegni che seguano le direttrici orografiche).
2.1. Pianificazione regionale, provinciale e comunale: “Piano di Valutazione Energetica” (PVE) e “Piani Attuativi di Valutazione Energetica” (PAVE)
La Pianificazione regionale deve porre tra le proprie priorità ambientali non solo quella della salvaguardia del Paesaggio, ma anche quella della programmazione ecologica di esso (in senso di sviluppo eco-compatibile). Solo la Regione, infatti, può coordinare la collocazione dei vari impianti attraverso una precisa previsione di mappa che non si fondi sul Piano Paesistico (a scala troppo grande), ma che preveda l’istituzione di uno specifico “Piano di Valutazione Energetica” (PVE) da porre come esplicazione del Piano Paesistico stesso. In tale strumento vanno individuate le aree da risanare (zone industriali dimesse, discariche, cave, etc.) riferendo soprattutto ad esse le possibili aree di impianto E.A.; poi si può procedere ulteriormente per le aree territoriali e quindi, solo in ultima analisi, con quelle a caratterizzazione paesaggistica. Il “Piano di Valutazione Energetica”, che sarà solo una previsione quantitativa di ‘risparmio’ ma che avrà anche i Valori qualitativi degli impatti tra i propri cardini istitutivi, dovrà comunque essere opportunamente valutato e approvato da una apposita Conferenza di Servizi composta anche dai rappresentanti delle Soprintendenze competenti; il Piano Paesistici, dunque, dovrà comprendere al suo interno il “Piano di Valutazione Energetica” (strumento ben diverso dagli esistenti Piani Energetici Regionali), che non dovrà essere disgiunto dalla valutazione della qualità territoriale e paesaggistica e non limitarsi alle sole previsioni energetiche.Ciascun Comune dovrà adeguare la propria pianificazione a quella regionale, istituendo in più una Regolamentazione attraverso appositi “Piani Attuativi di Valutazione Energetica” (PAVE) e, soprattutto, ponendo le opere ad impatto territoriale in regime di Autorizzazione e mai di DIA. Compito della Provincia non può essere che quello di coordinare gli impianti intercomunali e di verificare che tutte le disposizioni vengano rispettate.
2.2. Commissioni di Valutazione e Impatto ambientale
Un apposita Conferenza di Servizi, espressa da una Commissione, composta da membri di tutti gli Enti amministrativi oltre che da funzionari della Soprintendenza Regionale e di quelle competenti (di zona e archeologica), dovrà valutare la compatibilità del “Piano di Valutazione Energetica” (PVE) e dei “Piani Attuativi di Valutazione Energetica” (PAVE), oltre che dei singoli nuovi impianti E.A. sulla base di aspetti di ordine percettivo, estetico, storico e ambientale, esprimendo un parere sulla predisposizione delle varie aree interessate. Il parere della Commissione apposita dovrà essere vincolante e di grado superiore anche rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti: in particolare il parere della Commissione, a partire da tali strumenti urbanistici, dovrà riferirsi agli aspetti più di impatto territoriale, paesaggistico e di carattere architettonico, valutando le qualità migliorativa dei nuovi impianti E.A.
APPUNTI, RIFLESSIONI E DIBATTITI194
2.3. Progettazione dei nuovi impianti E.A.
Il notevole rilievo impattante sul Territorio e sul Paesaggio di impianti dal rilevante accento verticale o orizzontale impone che il progetto di insediamento venga coordinato da un tecnico specializzato in questioni paesaggistiche; tecnico che non può che venir individuato in un Architetto specializzato in tali aspetti o in un Paesaggista. Questo affinché la nuova realizzazione abbia in sé caratteri migliorativi o di doveroso ambientamento, senza che l’empiria o peggio la standardizzazione dei prodotti prevalichi la fase della progettazione qualificata. Solo un’adeguata progettazione architettonica potrà infatti trasformare prodotti industrialmente standardizzati in luoghi unici per collocazione, composizione (con accentuazione o particolari ambientamenti, etc) oltre che curare la progettazione delle aree limitrofe (dunque contro l’attuale standardizzazione e serializzazione della tecnica e della forma degli impianti).
2.4. Il Piano di Manutenzione e Durata Energetica Regionale (PMDE.R).
Un problema notevole nel tempo è costituito dall’invecchiamento, dalla obsolescenza e dallo smontaggio e smaltimento di ogni singolo impianto E.A. Ad ogni impianto deve essere associato un “Piano di Manutenzione e Durata Energetica” (PMDE.R) relativo a tutto il territorio regionale e parte integrante del “Piano di Valutazione Energetica” (PVE) e, dunque, del Piano Paesistico regionale. La Regione dovrà essere in possesso, cioè, di un piano regionale di invecchiamento e smaltimento dei parchi eolici e fotovoltaici, in modo da garantire negli anni una pianificazione e una realizzazione coordinata delle sostituzioni o delle revisioni.
3. Città, centri storici e Compatibilità. La progettazione degli impianti di energia alternativa come opportunità di valorizzazione urbana
La città contemporanea si compone di aree funzionalizzate, secondo gli strumenti urbanistici, che per la loro natura consolidata, o programmata, possono più o meno mostrarsi compatibili con i nuovi impianti connessi alla produzione di Energie Alternative. Ogni singola area richiede, dunque, politiche diverse, ma a partire sempre dai medesimi principi non solo di Compatibilità, ma anche di incremento della qualità.Il centro storico si mostra in genere non adatto ad accogliere gli impianti fotovoltaici o solari, sia che si tratti di superfici piane, sia di tetti a terrazze: anche le corti o le aree schermate non possono evitare una percezione riflettente (‘specchiata’ ovvero ‘effetto bagnato’) dall’alto. A meno che non vi siano inserimenti di nuovi edifici, con sostituzioni o integrazioni, che mettano però al centro della propria attenzione il problema della Compatibilità e della Qualità architettonica. Il centro storico, infatti, va letto nella propria possibilità di sviluppo diacronico e dunque, anche ad un linguaggio moderno non può che corrispondere una tecnologia energetica moderna. Anche se su edifici storici monumentalizzati, invece, i nuovi impianti energetici non sembra il caso che trovino posto.Per le aree consolidate, ma prive di valori storico-artistici riconosciuti (quali zona B e C) il problema resta quello di creare specifiche tecnologie che possano adeguarsi agli edifici già esistenti, grazie ad elementi dimensionalmente ridotti, in modo da non stravolgere il linguaggio e l’aspetto della preesistenza, a meno che una adeguata progettazione non contribuisca a porre una nuova qualificazione a tutto il complesso. Ancora una volta, il problema risulta, dunque, di ordine progettuale e l’inserimento diventa una opportunità di qualificazione.Le zone industriali e produttive, in genere poste nelle periferie o in aree specifiche, risultano quelle che meglio di ogni altre si mostrano vocate ad ospitare anche impianti energetici, sia per la dimensione delle coperture dei capannoni, sia per la disponibilità di superfici verticali da vetrare. Insomma, la necessità risulta quella di creare delle ‘superfici tecnologiche’ che possano adeguarsi alle varie caratteristiche delle zone urbane, evitando ancora una volta gli aspetti di serializzazione e standardizzazione.
‘Firenze eolica’ (disegno di Ferruccio Canali, 2010)
APPUNTI, RIFLESSIONI E DIBATTITI 195
3.1. Strumenti urbanistici e Regolamenti edilizi comunali. Il Piano di Manutenzione e Durata Energetica Comunale (PMDE.C).
Gli strumenti urbanistici comunali e il Regolamento Edilizio devono contemplare, per ogni zona ammessa della città (B,C e D), una corrispondente e consona disciplina che regoli collocazioni relative (con indici specifici quali altezze, distanze, percentuali di copertura, etc). Il Comune dovrà comunque procedere alla redazione di uno specifico Piano di Manutenzione e Durata Energetica (PMDE.C).
3.2. Aree industriali e aree periferiche della città: una vocazionalità condivisa
All’interno della zona D di Insediamento Industriale e in particolare delle zone PIP vanno previste delle aree specifiche, dotate di una loro particolare disciplina e destinate a impianti di produzione energetica, sia che ci si trovi in aree libere, sia che si sfruttino ampie superfici di copertura di capannoni industriali. Anche in questo caso l’iniziativa non può essere lasciata al singolo Privato o Imprenditore, ma va coordinata dalle Autorità Comunali, in modo che venga disciplinata la collocazione e la realizzazione sia attraverso uno specifico dettato del Regolamento Edilizio (con indici specifici quali altezze, distanze, percentuali, etc in modo da evitare inquinamenti).
3.3. Progettazione e aspetti architettonici
Il notevole aspetto impattante sulla città di impianti dalla rilevante caratterizzazione orizzontale (come nel caso delle strutture fotovoltaiche) impone che ciascun progetto venga accuratamente coordinato da un Tecnico laureato e specializzato proprio per il complesso rapporto che viene ad instaurarsi tra impianti industriali, anche relativi alle Energie Alternative, e tessuto insediativo. Anche in questo caso, esattamente come per il Territorio e il Paesaggio, la nuova realizzazione infrastrutturale dovrà avere in sé caratteri migliorativi o di doveroso ambientamento, senza che l’empiria o peggio la standardizzazione dei prodotti prevalichino la fase della progettazione qualificata. Anche nel caso di nuove architetture o di riutilizzo di vecchi immobili industriali si mostra necessario che un complessivo progetto preveda fin dall’origine l’impiego delle nuove tecnologie (tegole, pannelli, elementi di orientamento, etc.) in modo da garantire il massimo di qualificazione morfologica ed energetica.
4. Monumenti architettonici, Impianti per l’Energia Alternativa e Compatibilità. Un connubio (im)possibile?
Per quanto riguarda il rapporto tra Monumenti, riconosciuti come tali e soggetti a tutela, e nuovi impianti energetici (pannelli solari o fotovoltaico), alcuni Regolamenti Edilizi si sono orientati nell’ammettere le nuove collocazioni a partire da un minimo di Compatibilità accettabile nel caso di mascheramenti o, comunque, blande o assenti percezioni dall’esterno (con collocamento ad esempio dietro muretti, parapetti o all’interno di corti). In verità, fatto salvo il caso che davvero si possa garantire il massimo di Compatibilità, risulta sostanzialmente sconsigliabile l’uso dei nuovi impianti all’interno degli edifici storici e dei Monumenti, sia che si tratti di complessi isolati (ad esempio ville di campagna), sia di manufatti inseriti all’interno del tessuto urbano. I fattori conflittuali risultano talmente numerosi che risulta assai arduo pensare ad un puntuale dialogo positivo tra forme antiche e infrastrutture moderne. Eppure devono esserci casi eccezionali in cui l’ideazione e la qualità architettonica del Nuovo, ben progettato e calibrato, possano entrare in rapporto dialettico e costruttivo con l’Antico: sarebbe assurdo, e intrinsecamente antistorico, pensare a monumenti ‘ingessati’ che non contemplino in sé l’idea del “Monumenti vivo” con le sue trasformazioni (tra le quali anche l’impiantistica connessa alle nuove esigenza di vita e dunque alle nuove Energie Alternative): solo la Qualità, ancora una volta, potrà garantire tutto ciò, anche se con grandi difficoltà e a prezzo di difficili mediazioni.
‘Siena eolica’ (disegno di Virgilio C. Galati, 2010)