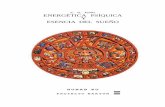Politica energetica e manovra economica per il 2010
Transcript of Politica energetica e manovra economica per il 2010
ii
“La*manovra*finanziaria*per*il**2010” — 2010/5/10 — 10:18 — page V — #1 ii
ii
ii
Indice
PresentazioneGaetana Trupiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Obiettivi e strumenti della manovra finanziaria per il2010Gaetana Trupiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 La situazione della finanza pubblica in Italia . . . . . . . . . . . . . . . 63 La riforma dei documenti di bilancio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 I provvedimenti precedenti alla Legge finanziaria . . . . . . . . . . . . 7
4.1 Il Documento di programmazione economico-finanziaria . 74.2 La manovra anticrisi collegata al DPEF . . . . . . . . . . . . . . . 104.3 La Relazione previsionale e programmatica . . . . . . . . . . . . 13
5 La Legge finanziaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 I provvedimenti successivi alla Legge finanziaria . . . . . . . . . . . . 177 La riforma del sistema fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Addio alla Legge finanziaria in attesa della manovra difinanza pubblicaAntonio Pedone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ii
“La*manovra*finanziaria*per*il**2010” — 2010/5/10 — 10:18 — page VI — #2 ii
ii
ii
VI Indice
2 Lo stravolgimento della Legge finanziaria e della sessione dibilancio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3 Il processo di bilancio tra regole europee e federalismo fiscale . 274 Il controllo quantitativo e qualitativo della spesa pubblica . . . . 295 Ostacoli da superare per il miglioramento della qualita della
spesa pubblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Riferimenti bibliografici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
La Legge finanziaria 2010 tra rigore crescitaGian Cesare Romagnoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 La politica del rigore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 La politica per la crescita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Proposte alternative per la Legge finanziaria 2010 . . . . . . . . . . . 505 Verso una exit strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Riferimenti bibliografici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
La manovra finanziaria e le impreseAntonio Di Majo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 Il valore complessivo della manovra a favore delle imprese . . . . 603 Misure di assestamento della disciplina di imposizione dei
redditi di impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 Gli incentivi agli investimenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Riferimenti bibliografici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Gli incentivi fiscali all’innovazione nella Legge finanziariaper il 2010Bruno Bises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731 I provvedimenti a favore dell’innovazione contenuti nella
Legge finanziaria per il 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 L’evoluzione recente del quadro normativo . . . . . . . . . . . . . . . . 74
2.1 Prima del 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742.2 La Legge finanziaria 2007 e i successivi provvedimenti . . . 75
ii
“La*manovra*finanziaria*per*il**2010” — 2010/5/10 — 10:18 — page VII — #3 ii
ii
ii
Indice VII
2.3 La Legge finanziaria 2008 e il decreto “anti-crisi” . . . . . . . 782.4 La Legge finanziaria 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3 Una prima valutazione del credito d’imposta per Ricerca eSviluppo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
4 Confronti internazionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845 Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84Riferimenti bibliografici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Le politiche di contrasto alla poverta nella manovraeconomicaElena Granaglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872 Una valutazione della manovra economica per il 2010 . . . . . . . 883 Le carenze delle politiche di contrasto alla poverta nel nostro
paese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934 Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100Riferimenti bibliografici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Finanziamento pubblico e federalismo sanitario neltriennio 2010–2012Monica Auteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1071 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1072 La sanita nel triennio 2010–2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
2.1 Accordo Governo–Regioni dell’ottobre 2009 . . . . . . . . . . . . 1112.2 Patto per la Salute e Legge finanziaria 2010 . . . . . . . . . . . . 113
3 Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124Riferimenti bibliografici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
La Legge finanziaria per il 2010 e la legislazione sullavoro pubblico del 2009Gianfranco D’Alessio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1271 Le previsioni in materia di personale nella Legge finanziaria
per il 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1271.1 Determinazione delle risorse per gli incrementi retributivi 1271.2 Disposizioni sul contenimento delle spese per il personale
del SSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
ii
“La*manovra*finanziaria*per*il**2010” — 2010/5/10 — 10:18 — page VIII — #4 ii
ii
ii
VIII Indice
1.3 Nuove modalita per i pagamenti delle retribuzioni . . . . . . 1321.4 Deroghe ai limiti all’assunzione di nuovo personale . . . . . . 133
2 La legislazione in materia di lavoro pubblico del 2009 . . . . . . . . 1332.1 Norme sul personale della L. 69/2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1332.2 La “riforma Brunetta” (L. 15/2009 e D.Lgs. 150/2009) . 135
La Banca per il Mezzogiorno e le precedenti esperienzeGiovanpietro Scotto di Carlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1391 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1392 Le precedenti esperienze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1403 La Legge finanziaria 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1424 Le incertezze sulla definizione della nuova Banca . . . . . . . . . . . . 1445 Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146Riferimenti bibliografici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
La gestione e la vendita dei beni confiscati allacriminalitaAngelo Buscema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1491 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1492 Analisi della gestione dei beni confiscati per tipologie . . . . . . . . 1503 Gli ultimi dati relativi ai beni immobili confiscati alla
criminalita organizzata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1544 Le novita della procedura di vendita introdotta dalla Legge
finanziaria per il 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1555 Gli effetti delle nuove disposizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1566 Le reazioni negli ambienti coinvolti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1577 Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Politiche energetiche e manovra economica per il 2010Cosimo Magazzino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1612 La cornice normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1623 Stato attuale dei mercati del settore energetico . . . . . . . . . . . . . 1654 Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176Riferimenti bibliografici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
ii
“La*manovra*finanziaria*per*il**2010” — 2010/5/10 — 10:18 — page IX — #5 ii
ii
ii
Indice IX
Legge finanziaria 2010 e occupazione giovanileNicoletta Fontanarosa e Valerio Lo Mauro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1831 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1832 La disoccupazione giovanile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1843 La Legge finanziaria 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1894 Altri strumenti di sostegno all’occupazione giovanile . . . . . . . . . 1935 Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197Riferimenti bibliografici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
ii
“La*manovra*finanziaria*per*il**2010” — 2010/5/10 — 10:18 — page 1 — #7 ii
ii
ii
Presentazione
Gaetana Trupiano
Universita degli Studi Roma Tre, CREI
Per il sesto anno consecutivo vengono presentate alcune riflessioni sutemi rilevanti che riguardano l’annuale manovra finanziaria. Gran partedegli interventi sono stati svolti dagli stessi studiosi nel corso degli anniattribuendo, cosı, una struttura ed un carattere specifico alla raccoltadi opinioni.
Il volume inizia con una mia illustrazione dei principali interventiche caratterizzano il complesso delle decisioni partendo dall’esame delDocumento di programmazione economico-finanziaria, DPEF. L’analisiprosegue con la manovra anti–crisi dell’estate 2009 e con la Relazionerevisionale e programmatica. Un’attenzione specifica riguarda la Leggefinanziaria, LF, per il 2010, mentre anche alcuni provvedimenti successi-vi alla LF sono esaminati attentamente. E sembrato opportuno, inoltre,soffermarsi su temi istituzionali quali la riforma delle regole di bilancioe la revisione del sistema fiscale.
Sulla riforma delle norme di contabilita e finanza pubblica (L.196/2009) si e concentrato Antonio Pedone che ha sottolineato il con-tributo potenziale che la nuova disciplina puo offrire nell’affrontare treaspetti critici dell’attuale processo di bilancio: 1. il funzionamento dellasessione di bilancio e il connesso rapporto tra Decisione di finanza pub-blica, legge di stabilita e legge di bilancio; 2. l’integrazione piena nelprocesso di bilancio sia delle regole fiscali europee, sia delle modalitadi attuazione del federalismo fiscale; 3. il controllo della spesa pubblica
ii
“La*manovra*finanziaria*per*il**2010” — 2010/5/10 — 10:18 — page 2 — #8 ii
ii
ii
2 Gaetana Trupiano
predisponendo e applicando adeguati strumenti di analisi e valutazione.Gian Cesare Romagnoli si occupa del rapporto tra LF e crescita
economica. L’intervento indica una direzione di causalita che vede l’in-terruzione della crescita dipendere dalle LF che si sono succedute negliultimi venti anni, con qualche eccezione, mostrando l’assenza di un ci-clo politico elettorale a la Nordhaus. Negli ultimi anni l’unica rispostavalida offerta dalla LF e stata data al fine di obbedire alle logiche delPatto di stabilita e crescita, della Banca centrale europea e del Fondomonetario internazionale. L’evocazione di questi temi ha riproposto ildibattito sul finanziamento in debito della spesa pubblica.
Antonio Di Majo esamina gli aspetti della manovra che riguardanole imprese e che assumono un certo rilievo macroeconomico con effettiche dipenderanno dall’evolversi della situazione economica. Si trattadella riforma della tassazione sugli utili di impresa, gia avviata con leLF precedenti, oltre che dell’introduzione di incentivi agli investimentie alla partecipazione al capitale di rischio delle imprese. Si e avutoun maggiore finanziamento degli incentivi alla ricerca e innovazione el’esclusione dall’imponibile del 50% delle spese di investimento.
Bruno Bises si sofferma sull’art. 2 della L. 191/2009 che prevede ilrifinanziamento dell’agevolazione fiscale agli investimenti in Ricerca eSviluppo e l’utilizzabilita dei nuovi stanziamenti anche per nuovi inve-stimenti. Viene, inoltre, prevista la possibilita di ridefinire le tipologiedi interventi suscettibili di agevolazione, le modalita di fruizione delcredito d’imposta ed i soggetti meritevoli di agevolazione. Utile e lavalutazione delle caratteristiche, del significato e dell’efficacia dei prov-vedimenti in relazione agli strumenti fiscali adottati e all’andamentodegli investimenti in Ricerca e Sviluppo realizzati.
L’intervento di Elena Granaglia si concentra sui trasferimenti indi-rizzati a soggetti le cui risorse economiche sono al di sotto di una certasoglia. Obiettivo e quello di esaminare gli effetti della LF per il 2010 edel DPEF 2010-2013 su tali trasferimenti; viene rilevata una sostanzialeriduzione dell’impegno finanziario. Le conclusioni offrono alcune valu-tazioni sia sull’entita della poverta secondo alcune fonti statistiche, siadella carenza del sistema di sostegno del reddito. Nel DPEF si hannoindicazioni a favore del potenziamento di alcune politiche di contrasto
ii
“La*manovra*finanziaria*per*il**2010” — 2010/5/10 — 10:18 — page 3 — #9 ii
ii
ii
Presentazione 3
alla poverta: istruzione, mercato del lavoro e ammortizzatori sociali.Monica Auteri afferma che con il recente Patto per la salute e stato
ottenuto un risultato complessivamente favorevole. La LF stanzia, tut-tavia, solo una prima trance delle risorse aggiuntive previste dal Patto,rinviando a successivi provvedimenti il compito di assicurare l’interoimporto previsto. Il Patto inasprisce le misure relative ai piani di rien-tro delle Regioni in difficolta (quali il blocco del turn over del personalee la possibilita di ulteriori ticket); inoltre, non prevede interventi persostenere i processi di riorganizzazione, senza i quali le misure, anche lepiu rigorose, sono inutili.
Gianfranco D’Alessio si occupa della legislazione sul lavoro pubbli-co rilevando che nella LF per il 2010 si incontra un limitato numerodi disposizioni che interessano la materia del personale delle PA. Unprimo gruppo di norme attiene alla determinazione delle risorse per leretribuzioni dei pubblici dipendenti, ed ai relativi miglioramenti; altreprevisioni riguardano il controllo e il contenimento delle spese per ilpersonale del Servizio sanitario nazionale, SSN; si vuole, inoltre, moni-torare la spesa del personale e assicurare il versamento unificato delleritenute previdenziali e fiscali. Tali indicazioni si collocano nell’ambitodegli interventi del 2009.
Sulla Banca per il Mezzogiorno e le precedenti esperienze si soffermaGiovanpietro Scotto Di Carlo. Tale Banca puo avvalersi di due strumen-ti: 1. la creazione di titoli ad aliquote ridotte (dal 12,5% al 5%) per leimposte sugli interessi; 2. la garanzia dello Stato su questi titoli emessia favore dello sviluppo dell’area. Gli operatori interessati a farne par-te sono le banche cooperative e le poste che, riorganizzate, dovrebberooperare anche a vantaggio delle piccole e medie imprese. La nuova Ban-ca dovra essere in grado di competere sul mercato globale fortementecompetitivo.
Cosimo Magazzino rileva che nel corso del 2009 si sono succedutivari provvedimenti rilevanti per il settore energetico. La LF per il 2010prevede uno stanziamento totale per il settore energetico, per il triennio2010-2012, di 866,488 milioni. Diversi sono gli interventi auspicabili nelsettore, quali l’effettiva liberalizzazione dei mercati, in particolare delgas; il rafforzamento della separazione proprietaria tra le attivita di
ii
“La*manovra*finanziaria*per*il**2010” — 2010/5/10 — 10:18 — page 4 — #10 ii
ii
ii
4 Gaetana Trupiano
gestione delle reti e la produzione e vendita di energia. Importanti sonogli obiettivi di tutela dell’ambiente e delle fasce deboli.
Angelo Buscema, sulla gestione e vendita dei beni confiscati alla cri-minalita organizzata, si occupa del regime giuridico dei beni confiscati.Analizza il problema della gestione dei beni confiscati per tipologie epresenta gli ultimi dati relativi ai beni immobili confiscati. Passa, quin-di, ad esaminare la novita della procedura di vendita introdotta dal-la LF per il 2010, l’art. 2, comma 47 e gli effetti previsti dalle nuovedisposizioni, tenuto conto delle reazioni degli ambienti coinvolti.
Il lavoro di Nicoletta Fontanarosa e Valerio Lo Mauro affronta il temadell’occupazione giovanile e delle misure di contrasto alla difficile realta.Viene esaminata, quindi, la situazione della disoccupazione dei giovaniin Italia con alcuni utili confronti internazionali. Nella seconda parte unapprofondimento e dedicato al sostegno all’occupazione giovanile nellaLF per il 2010 con il Fondo di sostegno per l’occupazione e l’impren-ditoria giovanile che, tuttavia, non ha caratteristiche di novita. Sonoillustrati altri strumenti di aiuto ai giovani contro la precarizzazione eper lo sviluppo di nuove imprenditorialita.
ii
“La*manovra*finanziaria*per*il**2010” — 2010/5/10 — 10:18 — page 161 — #167 ii
ii
ii
Politiche energetiche e manovra economica peril 2010
Cosimo Magazzino
Universita degli Studi Roma Tre, CREI
1 Introduzione
In questo lavoro si propone un’analisi degli interventi di politica eco-nomica aventi ad oggetto il settore energetico, alla luce della manovraeconomico-finanziaria per l’anno 2010. Premessa di base del saggio e chel’energia sia uno dei fattori fondamentali per assicurare la competitivitadell’economia e la qualita della vita della popolazione.
Inizialmente si fornisce un quadro di sintesi dei principali interventinormativi aventi ad oggetto il settore dell’energia varati dalle autoritadi governo dell’economia nel corso del 2009, richiamandone le disposi-zioni salienti. Si prendono in considerazione soprattutto la L. 2/2009 (cosiddetta “Legge anti-crisi”), la L. 99/2009 (“Disposizioni per lo svi-luppo e l’internazionalizzazione delle imprese”), nonche, in materia dienergia, il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 29 aprile2009 ( “Indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercatoelettrico”) e la Legge finanziaria, LF 2010.
In seguito si discute lo stato attuale dei principali mercati del settore(energia elettrica, gas naturale, fonti rinnovabili, rifiuti urbani).
Infine si inseriscono gli interventi di politica energetica discussi inprecedenza in un quadro allargato di politica economica.
L’economia internazionale e entrata, nell’ultimo trimestre del 2008,in una fase di recessione, che ha raggiunto il suo culmine nel corso del2009, con pesanti ricadute sull’occupazione, sui redditi, sui consumi,
ii
“La*manovra*finanziaria*per*il**2010” — 2010/5/10 — 10:18 — page 162 — #168 ii
ii
ii
162 Cosimo Magazzino
sugli investimenti e sui saldi di bilancio pubblico. In Italia, poi, all’im-patto della crisi finanziaria sull’economia reale si sono sommati ritardistrutturali di lungo periodo che, nel loro complesso, costituiscono lacausa della lenta crescita economica, della difficile competitivita, dellastagnante produttivita, della difficolta dell’export. Il settore dell’energiapuo, dunque, costituire un possibile volano per la ripresa economica.
2 La cornice normativa
Come ricordato nell’introduzione, le principali norme in tema di energiavarate dalle autorita politiche nel corso del 2009 sono state due leggi,un decreto ministeriale e la LF 2010.
Iniziamo analizzando la L. 2 del 28 gennaio 20091, presto ribattezzatadagli analisti “Legge anti-crisi”, proprio perche avente quale principalefinalita il contrasto alla forte crisi economico-finanziaria in atto in tuttoil pianeta.
Ai nostri fini, cio che rileva e il contenuto dell’art. 3, denominato“Blocco e riduzione delle tariffe”. Al comma 1, di portata generale, tral’altro, vi si legge: “Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico deicittadini e delle imprese [. . . ] e sospesa l’efficacia delle norme statali cheobbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi adoggetto l’adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di personefisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero adaltri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti alrecupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tarifferelative al servizio idrico e ai settori dell’energia elettrica e del gas, efatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione”.
Tuttavia, sono i successivi commi 8, 9 e 10 che piu direttamenteconcernono il settore energetico.
Il primo di questi (comma 8) riguarda il monitoraggio dei prezzi daparte dell’Autorita per l’energia elettrica e il gas; al successivo com-ma 9, fra l’altro, si stabiliscono misure per le famiglie economicamente1 Conversione in legge, con modificazioni, del D.Lg. 185 del 29 novembre 2008,
recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese eper ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
ii
“La*manovra*finanziaria*per*il**2010” — 2010/5/10 — 10:18 — page 163 — #169 ii
ii
ii
Politiche energetiche e manovra economica per il 2010 163
svantaggiate. Mentre il comma 10, piu articolato, ha un impatto spe-cifico sui prezzi e sui mercati di riferimento, concernendo la disciplinadel mercato elettrico e i relativi tempi di attuazione, in riferimento allacrisi.
Le principali norme contenute nel Decreto del Ministro dello Svi-luppo economico del 29 aprile 2009 sono l’articolo 2, dove leggiamo lefinalita e l’oggetto del provvedimento, in merito ai minori oneri perfamiglie e imprese.
In seguito, al Capo I (“Indirizzi per la riforma”) l’art. 3 concerne imercati dell’energia elettrica, istituendo il mercato infragiornaliero. Ilsuccessivo art. 4 riguarda la trasparenza dei dati sulle offerte nei mercati,mentre l’art. 5 disciplina il mercato dei servizi di dispacciamento. Laselezione delle risorse nel mercato del servizio di dispacciamento avvienesulla base di offerte formulate dagli operatori abilitati.
Nell’ambito del Capo II, “Direttive di attuazione della riforma”, al-l’art. 6 si sancisce l’integrazione tra il mercato infragiornaliero e il mer-cato del servizi o di dispacciamento a decorrere dal 1 gennaio 2010; al-l’art. 8 si stabilisce che il mercato del servizio di dispacciamento vengareso operativo a partire dalla stessa data.
La L. 99 del 23 luglio 2009, “Disposizioni per lo sviluppo e l’inter-nazionalizzazione delle imprese, nonche in materia di energia”, contie-ne un gran numero di disposizioni in materia energetica. In partico-lare, gli artt. 21–24 riguardano le iniziative a favore dei consumatorie della trasparenza dei prezzi; gli artt. 25–26 contengono una delegaal Governo in materia nucleare. L’art. 25 stabilisce delega il Governoall’individuazione dei siti nucleari. Mentre all’art. 26 troviamo scritto:
“Con delibera del CIPE [. . . ] sono definite le tipologie degli impian-ti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essererealizzati nel territorio nazionale”.
Il lungo art. 27 ha per oggetto le misure per la sicurezza e il poten-ziamento del settore energetico: in particolare, tratta di incentivazionedell’utilizzazione dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili; ef-ficienza energetica pubblica; promozione di nuova edilizia a rilevante ri-sparmio energetico; riqualificazione energetica degli edifici esistenti; svi-luppo dei sistemi di micro generazione; sostegno alla domanda di titoli
ii
“La*manovra*finanziaria*per*il**2010” — 2010/5/10 — 10:18 — page 164 — #170 ii
ii
ii
164 Cosimo Magazzino
di efficienza energetica e di certificati verdi; interventi sugli elettrodotti;procedure per la costruzione e l’esercizio di terminali di rigassificazio-ne di gas naturale liquefatto; ricerca di idrocarburi; coordinamento deipiani regionali degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani.
In seguito, l’art. 29 sancisce l’istituzione dell’Autorita per la sicurez-za nucleare con funzioni e compiti di regolamentazione tecnica, controlloe autorizzazione ai fini della sicurezza delle attivita concernenti gli im-pieghi pacifici dell’energia nucleare, la gestione e la sistemazione deirifiuti radioattivi, la protezione dalle radiazioni.
Agli artt. 30–35 si prevedono misure per l’efficienza del sistema ener-getico e il risparmio energetico. Mentre l’art. 37 regola l’istituzione del-l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo eco-nomico sostenibile (ENEA), come ente di diritto pubblico che opera inpiena autonomia, e “finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologi-ca nonche alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia,con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economicosostenibile”.
L’art. 38 ha a che fare con l’innovazione nel settore energetico,promuovendo ricerca e sperimentazione nel campo, con particolareriferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione.
L’art. 45 stabilisce l’istituzione del “Fondo per la riduzione del prezzoalla pompa dei carburanti nelle regioni interessate dall’estrazione diidrocarburi liquidi e gassosi”.
L’art. 51 disciplina la conoscibilita dei prezzi dei carburanti.Infine, la LF 2010 contiene all’art. 2, comma 44 l’unica disposizione
in proposito di energia:“Al fine di consentire lo sviluppo del tessuto produttivo nel territorio
delle regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia,Sardegna e Sicilia, delle province di Frosinone e di Latina, dei Comunidelle province di Rieti e di Viterbo, nonche dei Comuni della provinciadi Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina,di cui all’articolo 3 della L. 646 del 10 agosto 1950, attraverso l’incen-tivazione di progetti coordinati dal Consiglio nazionale delle ricerchee dall’ENEA, secondo le specifiche competenze, in materia di tecnolo-gie avanzate per l’efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie
ii
“La*manovra*finanziaria*per*il**2010” — 2010/5/10 — 10:18 — page 165 — #171 ii
ii
ii
Politiche energetiche e manovra economica per il 2010 165
innovative per il made in Italy agroalimentare, produzione di farmacibiotecnologici, e autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno2010, 15 milioni di euro per l’anno 2011 e 20 milioni di euro per l’anno2012 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche e dell’ENEA”.
Decisamente troppo poco per poter ragionevolmente pensare di uti-lizzare le politiche energetiche quale strumento di contrasto alla fortecrisi economico-finanziaria che l’intero pianeta sta attraversando. An-che alla luce delle rilevanti questioni geo-politiche che evocano i temidel petrolio, del gas naturale, del nucleare e delle biomasse, oltre glievidenti impatti ambientali.
Cionondimeno, la LF 2010 prevede:
- nella Tabella C (“Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizio-ni di legge la cui quantificazione annua e demandata alla LF”) lostanziamento di 87,977 mln per il 2010, di 87,973 mln per il 2011 e di87,973 mln per il 2012, in base alla succitata L. 2/2009, art. 3, com-ma 9, “Compensazione degli oneri derivanti dalle tariffe agevolateper la fornitura di energia elettrica e di gas”;
- nella Tabella C lo stanziamento di 197,441 mln per il 2010, di 197,441mln per il 2011 e di 198,191 mln per il 2012, in base alla L. 282/1991,alla L. 61/1994 e alla L. 95/1995, “Riforma dell’ENEA”;
- nella Tabella C lo stanziamento di 3,164 mln per il 2010, di 3,164 mlnper il 2011 e di 3,164 mln di euro per il 2012, in base alla L. 91/2005,art. 1, comma 1, “Contributo volontario al Fondo di cooperazionetecnica dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica”.
Dunque, in sostanza, la LF 2010 prevede uno stanziamento totale alsettore energetico, per il triennio 2010–2012, pari a 866,488 mln, cosıripartito: 288,582 mln per l’anno 2010, 288,578 mln per l’anno 2011 e289,328 mln per l’anno 2012.
3 Stato attuale dei mercati del settore energetico
Le vendite delle unita di produzione nazionali, pari a 22,2 milioni diMWh, sono diminuite del 6,2% rispetto a novembre 2008. A livello ma-crozonale ancora in evidenza la Sardegna (-12,5%) ed il Nord (-11,1%);
ii
“La*manovra*finanziaria*per*il**2010” — 2010/5/10 — 10:18 — page 166 — #172 ii
ii
ii
166 Cosimo Magazzino
in controtendenza il Sud (+1,7%). In aumento le importazioni (venditesulle zone estere), pari a 4,3 milioni di MWh (+1,7%). L’analisi per tec-nologia di produzione rivela da un lato l’incremento tendenziale dellevendite degli impianti a ciclo combinato (+18,9%) — particolarmentesensibile nella macrozona Nord (+28,9%) e in Sicilia (+27,5%) — de-gli impianti eolici (+25,2%) e geotermici (+3,9%), dall’altro la decisariduzione delle vendite degli impianti idroelettrici (-36,1%), in partico-lare a pompaggio (-64,2%), e degli impianti termoelettrici tradizionali(-17,9%). La quota delle vendite degli impianti a ciclo combinato e sa-lita pertanto al 58,8% (+10 punti percentuali rispetto ad un anno fa)(GME, 2009b).
Venendo al mercato dei combustibili, gli incrementi di prezzo regi-strati ad ottobre hanno portato le quotazione del Brent stabilmentesopra i 75 $/bbl. Nei primi 19 giorni del novembre 2009 il prezzo delBrent Dated ha registrato variazioni giornaliere superiori ai 3 $/bblmuovendosi fra un valore minimo di 74,4 $/bbl e un valore massimodi poco inferiore a 78,3 $/bbl. Dopo il balzo di ottobre 2009 quindi ilBrent e rimasto su valori elevati, anche se il sentiment di mercato rima-ne piuttosto cauto. In questo momento le dinamiche di prezzo sembranopiu influenzate dalle notizie che quotidianamente arrivano sul mercatocirca il livello di scorte che da trend marcati legati ai fondamentali. Lequotazioni elevate sono anche il riflesso della situazione di marcata de-bolezza del dollaro sui mercati valutari. Se a novembre il tasso di cambiodollaro-euro e rimasto intorno a 1,49 $/euro, sforando 1,5 $/euro solol’11 novembre, nel mese di dicembre esso ha superato la soglia di 1,5$/euro nella prima meta del mese, per poi diminuire (Platts, 2009).
Nell’ultimo Oil Market Report redatto dall’International EnergyAgency, IEA, venivano nuovamente riviste al rialzo le previsioni suiconsumi di petrolio, sia per l’anno in corso che il per il 2010. Per il 2009l’Agenzia stima un incremento di 210.000 barili/giorno (84,85 mln dibarili/giorno), mentre per il 2010 si stima un consumo di petrolio paria 89,19 mln di barili/giorno. Le ragioni dell’incremento di domanda sti-mata sono da ricercarsi nelle migliori attese per la richiesta provenienteda Stati Uniti d’America e Asia. Bisogna sottolineare che le continuerevisioni al rialzo delle stime dell’IEA stanno generando diverse criti-
ii
“La*manovra*finanziaria*per*il**2010” — 2010/5/10 — 10:18 — page 167 — #173 ii
ii
ii
Politiche energetiche e manovra economica per il 2010 167
che fra gli operatori. Infatti da piu parti si sono sollevate critiche circala sostenibilita della crescita di domanda ipotizzata per il 2010. Moltianalisti stimano variazioni piu contenute, anche grazie a modificazionipermanenti delle abitudini di consumo statunitensi (Tab. 1).
Anche l’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, OPEC, siallinea alle stime 2009 elaborate dall’IEA con una previsione di calo didomanda nel 2009 pari a 1,4 mln di barili/giorno.
Tabella 1. Domanda mondiale di petrolio
2008 2009 Var. %
OECD 47,6 45,5 −4,5%Non-OECD 38,7 39,3 +1,5%Totale 86,3 84,8 −1,8%
Fonte: IEA (2009a).
Dal lato dell’offerta, il rapporto dell’IEA evidenzia che ad otto-bre 2009 la produzione di greggio e cresciuta su base congiunturaledi 650.000 barili al giorno, attestandosi a quota 85,6 mbbl/g. Su ba-se tendenziale invece l’offerta rimane sostanzialmente stabile. Le stimedell’OPEC sui livelli di produzione 2010 evidenziano una crescita paria 360.000 barili giorno per i paesi non aderenti al cartello con un livelloatteso di 51,2 mln di barili/giorno.
I prezzi dei principali prodotti derivati dal petrolio hanno seguitoun andamento analogo a quello delle quotazioni petrolifere. La dina-mica delle quotazioni dei principali carboni ha registrato una dinamicaanaloga a quella dei derivati petroliferi. Nelle prime due settimane diottobre si registra una crescita delle quotazioni dei diversi carboni. L’ef-fetto combinato dell’aumento dei costi del carbone e del gas fa sı cheil prezzo dei titoli di emissione necessario per rendere conveniente ilpassaggio dal primo al secondo combustibile, con riferimento al parcotermoelettrico italiano, nel novembre 2009 si collochi tra i 50 e i 55euro/tCO2 (IEA, 2009a).
L’andamento di crescita graduale ma costante del valore dei certifi-cati verdi (CV) registrato tra giugno e ottobre 2009 si e interrotto nel
ii
“La*manovra*finanziaria*per*il**2010” — 2010/5/10 — 10:18 — page 168 — #174 ii
ii
ii
168 Cosimo Magazzino
corso di novembre 2009: nelle sessioni novembrili, infatti, i prezzi si so-no mantenuti stabili attorno a 88 euro/MWh. Il recente trend sembraconfermare l’allineamento dei prezzi di mercato al prezzo di ritiro 2010.I volumi scambiati continuano ad essere consistenti e sensibilmente piuelevati di quelli fatti registrare negli stessi mesi del 2008: nelle sessionidi borsa dell’ultimo mese sono stati negoziati CV per circa 165 GWh,mentre nel mese di ottobre e transitato sulla piattaforma bilaterali piudi 1 TWh di CV.
Se prendiamo in esame i dati della “BP Statical Rewiew 2005” estimiamo la popolazione mondiale in 6,3 mld di persone, dal confrontorisulta che il consumo energetico mondiale pro-capite e di 1,62 tep2,laddove quello dell’Unione Europea a 25 e di 3,9 tep pro-capite, delGiappone di 4,0 tep pro-capite e degli USA di ben 7,9 tep pro-capite.Il consumo energetico, in questo caso, ci da la misura della potenzaindustriale degli Stati; al gruppo di testa, entro i prossimi quindici anni,si accodera il BRIC (Brasile, Russia, India e Cina).
Come osservato da Bastianelli (Bastianelli, 2006), l’UE 25 importail 75% del petrolio di cui ha bisogno, il 57% del gas naturale, il 40%del carbone, e la sua dipendenza energetica dalle importazioni di idro-carburi e destinata a crescere a causa della inevitabile riconversioneche i 10 nuovi Stati membri dovranno effettuare riducendo l’utilizzo delcarbone per privilegiare gli idrocarburi. Ne deriva una crescente e sem-pre piu preoccupante dipendenza dall’estero che richiede, da parte delleistituzioni comunitarie, l’elaborazione di una nuova ed efficace strategiacomune.
Per cio che concerne il mercato dell’energia elettrica, secondo i datipubblicati da “Terna”3, nel mese di ottobre 2009 la domanda di energiaelettrica ha raggiunto in Italia 26,9 TWh, facendo registrare una dimi-nuzione del 5,1% rispetto ai volumi del corrispondente mese del 2008. Lariduzione della domanda normalizzata rispetto agli effetti di temperatu-ra e ai giorni lavorativi e risultata essere pari al 4,6% visto che l’ottobre
2 Con l’espressione “tep” si indicano le tonnellate equivalenti di petrolio in quanto epossibile riportare con un calcolo matematico a tep tutte le varie fonti energeticheper renderne possibile la comparazione.
3 Si confronti il sito web www.terna.it.
ii
“La*manovra*finanziaria*per*il**2010” — 2010/5/10 — 10:18 — page 169 — #175 ii
ii
ii
Politiche energetiche e manovra economica per il 2010 169
2009 si e caratterizzato sia per una temperatura media mensile inferioredi circa mezzo grado centigrado che per un giorno lavorativo in meno ri-spetto all’ottobre 2008. Anche i dati normalizzati confermano pertantol’estrema debolezza della domanda di energia elettrica nel nostro Paese,nonostante i principali indicatori del ciclo economico abbiano iniziatoad indicare l’inizio di una fase di ripresa. Ancora una volta la debolezzadella domanda e stata molto disomogenea a livello territoriale: la suariduzione tendenziale e infatti risultata essere pari all’8,9% nelle regio-ni del Nord, al 3,9% in quelle del Centro e all’1,8% in quelle del Sud(isole comprese). In particolare, a favore della riduzione tendenziale re-lativamente piu contenuta che ha nel complesso caratterizzato il Sude le isole rispetto alle altre zone sembra aver giocato l’incremento ten-denziale del 2,4% registrato dalla domanda di energia elettrica in Sicilia(GME, 2009a; AA. VV., 2009).
Secondo i dati disaggregati sulla produzione lorda, dopo due mesiconsecutivi di riduzioni tendenziali nel mese di ottobre 2009 la produzio-ne idroelettrica e tornata ad aumentare (+3,6%) erodendo ampie quotedi produzione termoelettrica (-10,3%). Ai fini della copertura del fabbi-sogno e infine aumentato anche il contributo dell’import netto (+4,4%rispetto all’ottobre 2008), sostanzialmente guidato dagli ancora ampidifferenziali di prezzo registrati nello scorso mese sulla borsa elettricaitaliana rispetto alle borse elettriche francese e tedesca (Tab. 2).
Tabella 2. Domanda e offerta di energia elettrica
Ottobre 2009 Ottobre 2008 Var. %
Domanda 26,943 28,378 -5,1%Produzione lorda 25,377 27,232 -6,8%Idroelettrico 3,058 2,953 +3,6%Termoelettrico 21,098 23,511 -10,3%Geotermoelettrico 453 444 +2,0%Eolico 768 324 +137%Saldo estero 3,005 2,879 +4,4%
Note: Italia, GWh e variazioni tendenziali.Fonte: REF (2009).
ii
“La*manovra*finanziaria*per*il**2010” — 2010/5/10 — 10:18 — page 170 — #176 ii
ii
ii
170 Cosimo Magazzino
A livello di fasce orarie l’ulteriore calo congiunturale dei prezzi del-l’energia elettrica italiani e stato maggiore nelle ore di basso carico (-7%circa) rispetto a quelle di alto carico (-1% circa), con un corrispondenteampliamento del differenziale peak/off-peak dai circa 32,5 euro/MWhdi ottobre ai circa 34,8 euro/MWh della prima meta di novembre.
Da un punto di vista zonale, nella zona Sud e in Sardegna la dimi-nuzione congiunturale dei prezzi dell’energia elettrica e stata molto piuaccentuata rispetto a quanto accaduto nelle zone continentali in cui sisono registrate riduzioni sostanzialmente in linea con la media nazio-nale (-3% in baseload). In particolare, i prezzi baseload si sono ridottidel 12,2% nella zona Sud e del 10,1% in Sardegna. Tali riduzioni han-no pertanto consentito alla zona Sud di confermarsi come la zona delmercato italiano con il prezzo dell’energia elettrica piu basso (circa 47,1euro/MWh in baseload nei primi 15 giorni di novembre) e alla Sardegnadi vedere i propri prezzi maggiormente allineati a quelli delle zone con-tinentali dopo i notevoli incrementi registrati tra maggio e settembre2009 (Fig. 1).
Fig. 1. Mercato del Giorno Prima: prezzi baseload zonali
40
50
60
70
80
90
100
110
120
23/1
1/20
08
23/1
2/20
08
23/0
1/20
09
23/0
2/20
09
23/0
3/20
09
23/0
4/20
09
23/0
5/20
09
23/0
6/20
09
23/0
7/20
09
23/0
8/20
09
23/0
9/20
09
23/1
0/20
09
Nord Centro-Nord Centro-Sud Sud Sicilia Sardegna
Fonte: GME (2009).
ii
“La*manovra*finanziaria*per*il**2010” — 2010/5/10 — 10:18 — page 171 — #177 ii
ii
ii
Politiche energetiche e manovra economica per il 2010 171
La domanda di gas naturale in Italia ha segnato a ottobre e no-vembre 2009 un primo aumento su base tendenziale. Questa dinamicae certamente collegata sia al livello particolarmente basso dei prelievinello stesso periodo del 2008, sia all’effetto delle temperature piu rigide,che hanno determinato un aumento prossimo al 25% dei prelievi delladistribuzione (+26,3% a ottobre, +23,7% a novembre). Anche la doman-da industriale, tuttavia, ha mostrato una certa ripresa (+2,4% a otto-bre, +8,2% a novembre), mentre i prelievi del segmento termoelettricohanno registrato a ottobre ancora un vigoroso calo (-9,5%) e soltantoa novembre un primo aumento (+6,7%), sempre su base tendenziale(Tab. 3).
Tabella 3. Domanda di gas naturale
Ottobre 2009 Ottobre 2008 Var. %
Termoelettrico 88 98 -9,5%Industriale 43 42 +2,4%Distribuzione 67 53 +26,3%Altro 8 9 -14,4%Totale prelevato 206 202 +2,2%Temperature 15 17 -
Note: Italia, Mmc/g e variazioni tendenziali.Fonte: REF (2009).
Il moderato incremento della domanda e stato compensato nel mesedi ottobre non da un parallelo aumento delle importazioni, che regi-strano anzi una variazione tendenziale del -3,0%, ma da una minoreiniezione negli stoccaggi (-69,5%): una dinamica simile si e osservataanche a novembre, caratterizzato nel 2009 da una moderata erogazione,e nel 2008 dal perdurare di una debole iniezione. Nonostante il mag-giore ricorso agli stoccaggi, a novembre anche le importazioni hannoregistrato un aumento su base tendenziale (+8,8%), trainate probabil-mente dall’andamento della domanda. E aumentata inoltre, tra otto-bre e novembre, la capacita massima di importazione disponibile, inconseguenza dell’entrata in funzione del terminale di rigassificazione di
ii
“La*manovra*finanziaria*per*il**2010” — 2010/5/10 — 10:18 — page 172 — #178 ii
ii
ii
172 Cosimo Magazzino
Rovigo (Tab. 4).
Tabella 4. Offerta di gas naturale (Italia, Mmc/g e variazioni tendenziali)
Ottobre 2009 Ottobre 2008 Var. %
Importazioni 186 192 -3,0%Produzione nazionale 24 24 +0,6%Stoccaggi -4 -14 -69,5%Capacita massima 310 298 +4,2%Load factor 60% 64% -7,0%
Fonte: REF (2009).
Guardando piu in generale ai mercati europei, si segnala un’impor-tante iniziativa del gestore del mercato elettrico della Repubblica Ceca,OTE, che ha annunciato il lancio, il 1 gennaio 2010, di una borsa spotdel gas naturale, organizzata attraverso aste continue in due sessionigiornaliere; da aprile 2010 sara possibile anche scambiare, sullo stessomercato, partite di gas withinday. Nonostante il mercato ceco sia an-cora caratterizzato dalla presenza molto forte dell’incumbent “R.W.E.Transgas”, piu di 20 imprese hanno annunciato di voler richiedere alregolatore ERU l’accesso al nuovo mercato.
Sul mercato dei Certificati Verdi (CV) nel mese di novembre so-no stati scambiati 238.657 CV, mentre nel mese di ottobre sono statiscambiati 105.348 CV. Il prezzo medio ponderato dei CV con anno diriferimento 2009 e stato di 88,56, in lieve aumento rispetto al mese pre-cedente (88,05). Anche nel mese di novembre, cosı come in ottobre, gliscambi si sono concentrati sui CV con anno di riferimento 2009, con235.294 CV scambiati, in aumento rispetto ai 103.177 di settembre.
Infine, e utile illustrare le potenzialita del Combustibile da Rifiutidi Alta Qualita (CDR-Q) quale fonte di energia per la co-combustionenelle centrali elettriche e nei cementifici.
Il CDR-Q utilizzato in co-combustione in cementifici o centralitermoelettriche presenta molteplici benefici ambientali ed energetici:
ii
“La*manovra*finanziaria*per*il**2010” — 2010/5/10 — 10:18 — page 173 — #179 ii
ii
ii
Politiche energetiche e manovra economica per il 2010 173
- benefici in termini di gestione dei rifiuti (promozione raccolta diffe-renziata, riduzione delle discariche);
- benefici in termini di riduzione delle emissioni di CO2;- benefici in termini di produzione di energia da fonti rinnovabili;- benefici in termini di risparmio energetico.
Il primo beneficio ottenibile attraverso il CDR-Q e quello di essere unostrumento sul quale fare convergere le politiche integrate per la gestionedei rifiuti. La crescita della produzione di rifiuti urbani (RU) costituisceun problema ambientale e territoriale comune a tutti i paesi industrializ-zati, ma con connotati piu gravi per l’Italia e, in particolare, per alcunearee del nostro paese. In Italia il ritmo annuale di crescita della produ-zione di RU e del 2,1% negli ultimi 10 anni, contro una crescita del PILdell’1,3% annuo (Fig. 2).
Fig. 2. Produzione di rifiuti e crescita del PIL (Italia, 1995–2005)
95
100
105
110
115
120
125
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
PIL Rifiuti urbani
Fonte: Nomisma (2009).
ii
“La*manovra*finanziaria*per*il**2010” — 2010/5/10 — 10:18 — page 174 — #180 ii
ii
ii
174 Cosimo Magazzino
Come mostra la Fig. 3, in Italia prevale ancora il ricorso a discarica,300 kg per abitante, contro i 233 kg dell’UE.
Fig. 3. Rifiuti urbani pro-capite in UE
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Svizzera
Paesi Bassi
Svezia
Danimarca
Belgio
Germania
Austria
Francia
Rep. Ceca
UE 15
Polonia
Norvegia
UE 27
Portogallo
Finlandia
Italia
Romania
Spagna
Ungheria
Regno Unito
Grecia
Fonte:Nomisma (2009).
Il grande vantaggio del CDR-Q, che si traduce in benefici ambientalie in ritorno economico, e il fatto che per circa la meta e composto dabiomassa “non vergine” che da tempo in tutti i paesi industrializzati ericonosciuta essere una fonte di energia rinnovabile.
Il secondo beneficio ottenibile e quello di ridurre le emissioni di CO2,in quanto vengono sostituiti combustibili fossili, carbone nelle centralie coke da petrolio nei cementifici, con la biomassa “non vergine” con-tenuta nel CDR-Q. Nelle centrali termoelettriche la riduzione e di 4,7Mt/anno di CO2 e nei cementifici di 2,4 Mt, per una riduzione annualetotale di 7 Mt di CO2.
Il terzo beneficio ottenibile attraverso il CDR-Q consegue dal suocontenuto di biomassa “non vergine”, mediamente rilevato al 50%, per
ii
“La*manovra*finanziaria*per*il**2010” — 2010/5/10 — 10:18 — page 175 — #181 ii
ii
ii
Politiche energetiche e manovra economica per il 2010 175
cui il CDR-Q utilizzato nelle centrali permette la produzione di energiaelettrica da Fonti Energetiche Rinnovabili, FER. L’aumento della pro-duzione di energia elettrica da FER sarebbe di 2,7 mld di kWh (TWh).L’Italia ha un obiettivo di 75 TWh nel 2010 e uno di poco inferiore ai100 TWh nel 2020, contro una produzione nel 2006 di 53 TWh.
Il quarto beneficio del CDR-Q consegue in termini di risparmio ener-getico. Nei cementifici, per la parte di biomassa del CDR-Q, e possibileottenere certificati bianchi del terzo tipo relativi al risparmio energeti-co di fonti fossili per un ammontare complessivo di 0,33 mln tep. Talevalore va confrontato con un obiettivo di risparmio energetico al 2009di 2,9 mln tep.
I precedenti benefici possono essere quantificati sotto il profilo eco-nomico congiuntamente a quelli derivanti dal risparmio del combustibileimportato. In particolare il valore dei benefici e dato da:
- risparmio dei combustibili, carbone e coke di petrolio, interamenteimportati, per 158 mln all’anno; cio supponendo cautelativamenteprezzi del carbone intorno agli 80 $/t, in sostanziale arretramentorispetto ai picchi oltre i 120 $/t di ottobre 2007;
- risparmio per minori emissioni di CO2 per 137 mln all’anno, valoriz-zando ogni tonnellata di CO2 al prezzo di 19,5 euro/t, quale mediadelle quotazioni del 2007 relative a permessi per il secondo periodo;
- valore dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili pari a 343mln all’anno, in base ad un prezzo dei certificati verdi ipotizzato allivello del 2006 di 12,528 cent/kWh;
- valore dei certificati bianchi ottenibili per il risparmio energetico paria 11 mln all’anno, partendo da un valore del certificato bianco di33,84 euro/tep.
Complessivamente i benefici ottenibili possono essere quantificati in649,8 mln l’anno (Nomisma Energia, 2008).
Infine, uno sguardo al futuro e doveroso, soprattutto in riferimentoall’eventuale ritorno italiano all’energia nucleare. Nel mese di febbraio2010 il Governo italiano ha varato un decreto legislativo che disciplinala localizzazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di produzione
ii
“La*manovra*finanziaria*per*il**2010” — 2010/5/10 — 10:18 — page 176 — #182 ii
ii
ii
176 Cosimo Magazzino
di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combu-stibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato edei rifiuti radioattivi. Il provvedimento detta le regole per individuarei siti e assicura incentivi sotto forma di sgravi sulla spesa energetica,ma anche sulle imposte, alle popolazioni che accoglieranno le centrali;sono peraltro previste campagne informative. Le compensazioni riguar-dano i territori nel raggio di 20 km dai reattori e 10 dagli impiantidi produzione e trattamento del combustibile radioattivo. Lo schemaeconomico dei benefici viene cosı ripartito: 10% alle Province, 55% aiComuni dell’impianto e 35% a quelli limitrofi), ma chiarisce come i be-nefici debbano andare per il 40% alle amministrazioni pubbliche e peril 60% direttamente ai cittadini e alle imprese, anche per il tramite diriduzioni delle imposte sui rifiuti e sui redditi. Piu nel dettaglio, talibenefici vengono suddivisi in due fasi. Nella prima, quella di realizza-zione dell’impianto, sono misurati sulla base di 3.000–4.000 euro annuiper MW di potenza installata, con una maggiorazione del 20% per leeventuali potenze supplementari; pertanto, un singolo reattore nucleareda 1.600 MW dovrebbe produrre circa 5 mln di euro annui di compen-sazioni. Con la seconda fase, quella legata alla messa in esecuzione degliimpianti, i benefici diventano pari a 0,4 euro per MWh immesso in rete.
Il ritorno al nucleare nell’obiettivo governativo dovrebbe assicura-re una maggiore differenziazione delle fonti energetiche, una maggioreindipendenza dalle fonti estere e tagli del 30% ai prezzi finali.
4 Conclusioni
Per favorire la ripresa economica e il rilancio dei consumi sono necessariinterventi e riforme di natura strutturale, finalizzati a qualificare, inno-vare e rafforzare il tessuto economico ed imprenditoriale, creando le con-dizioni affinche venga incentivata e si sviluppi nuova imprenditorialitacon conseguente creazione di posti di lavoro.
Il nostro Paese per uscire dalla deriva economica negativa prodottadalla crisi sui mercati finanziari ha bisogno, quindi, di interventi miratisu tutto il territorio nazionale per un rilancio economico che necessa-riamente deve passare attraverso una riduzione dei costi amministrativi
ii
“La*manovra*finanziaria*per*il**2010” — 2010/5/10 — 10:18 — page 177 — #183 ii
ii
ii
Politiche energetiche e manovra economica per il 2010 177
e gestionali delle imprese ed un incremento del peso competitivo dellestesse in termini di innovazione e sviluppo.
A cio si aggiunge la constatazione che le riserve stimate mondiali dipetrolio sono situate per il 57% in Medio Oriente — mentre l’Europane detiene solo l’1,4%4 — e che anche le riserve stimate mondiali di gasnaturale si trovano per il 40% in Medio Oriente e il 26% in Russia —mentre l’Europa ne ha appena il 4,5%5. E evidente, allora, che la riduzio-ne della dipendenza dall’estero e la sicurezza dell’approvvigionamentodebbono costituire la base di azioni di politica energetica comunitaria,integrate con una lungimirante ed essenziale attivita della diplomaziadell’UE, in considerazione della complessa problematica geopolitica.
Questi dati mettono cosı bene in evidenza che l’UE, alla luce delleconoscenze scientifiche attuali, e nell’impossibilita di poter raggiungere,nel prossimo decennio, una soddisfacente, sebbene parziale, indipen-denza energetica dalle altre aree del pianeta. Infatti, il lento processotendente a dotare dapprima la Comunita Economica Europea, CEE,— e successivamente l’UE — di una politica energetica integrata, haseguito, nel tempo, un percorso tortuoso che non ha, purtroppo, ancoraraggiunto l’obiettivo6.
4 I primi cinque Paesi al mondo, in termini di riserve stimate di petrolio, si trovanotutti in Medio Oriente: Arabia Saudita (con 35 mld di tonnellate), Iran (17 mld diton), Iraq (15 mld di ton), Kuwait e Emirati Arabi Uniti (13 mld di ton ciascuno)(Unione Petrolifera, 2005, p.112).
5 I primi cinque Paesi al mondo, in termini di riserve stimate di gas naturale, sono:Russia (con 46 mld di metri cubi), Iran (26 mld di metri cubi), Qatar (25 mld dimetri cubi), Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti (6 mld di metri cubi)(UnionePetrolifera, 2005, p.101).
6 Passi rilevanti in tal senso sono stati la Risoluzione adottata dal Consiglio Europeoil 17 settembre 1974 su “Una nuova strategia per la politica energetica della Co-munita”; la Risoluzione adottata dal Consiglio Europeo il 17 settembre 1985 sulle“Linee direttrici per le politiche energetiche degli Stati membri”; “Trattato sullaCarta dell’Energia”, firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994; il Parere sulla PoliticaEnergetica Comunitaria adottato dal Comitato Economico e Sociale il 14 settem-bre 1994; la “Carta Europea dell’Energia”, firmata a L’Aja il 17 dicembre 1991;il “Libro Verde sull’Energia”, adottato dalla Commissione Europea l’11 gennaio1995; il “Libro Verde Verso una strategia europea di sicurezza dell’approvvigio-namento energetico”, adottato il 29 novembre 2000; l’articolo 157 del “TrattatoCostituzionale dell’Unione Europea”.
ii
“La*manovra*finanziaria*per*il**2010” — 2010/5/10 — 10:18 — page 178 — #184 ii
ii
ii
178 Cosimo Magazzino
Come ha sottolineato la Relazione annuale sullo stato dei servizi edell’attivita svolta dell’AEEG per l’anno 2009: “La crisi ha pure confer-mato come i costi dell’energia incidano sul reddito disponibile delle fa-miglie e sulla possibilita per le imprese di competere nel contesto globa-lizzato. D’altra parte, siamo ancora di fronte ad alcune sfide, strategichee di fondo, riguardanti la sicurezza dei sistemi energetici ed il loro in-flusso su clima ed ambiente, con problematiche di dimensioni globali cherichiedono soluzioni altrettanto globali. In una simile e globale intera-zione di problemi, l’eccessiva volatilita dei prezzi dei prodotti petroliferi,che ancora si formano senza adeguate regole di mercato, su piattaformeopache ed esposte anche ad aggressive speculazioni finanziarie, continuaa determinare un forte impatto sui sistemi energetici, specie quelli ancortroppo dipendenti dagli idrocarburi come i sistemi europeo ed italianoin particolare. Tale dipendenza porta anche ad escursioni significativedei prezzi finali di elettricita e gas, pur se ammortizzate da meccanismiche stiamo utilizzando, specie a protezione dei consumatori piu deboli.Cosı, si sono determinati aumenti per le bollette del 2008 e diminuzionisuccessive che abbiamo avuto il piacere di confermare recentemente, avalere fino alla fine del prossimo settembre”.
Diversi sono, dunque, gli interventi auspicabili nel settore energetico.Innanzitutto, interventi per raggiungere una effettiva liberalizzazionedei mercati, in particolare in quello del gas, in cui la presenza di un solooperatore dominante, oltre a comportare prezzi elevati per i consumatorifinali, e causa anche dei pesanti ritardi infrastrutturali del nostro Paese.
La separazione proprietaria tra le attivita di gestione delle reti e laproduzione e vendita di energia va rafforzata, superando il conflitto conle imprese e intervenendo anche sulle attivita post-contatore.
Destano, invece, preoccupazione le prospettive di aumento di alcu-ne componenti in bolletta, in particolare la copertura degli oneri perla tariffa sociale e degli incentivi alle rinnovabili. Pertanto si affermal’esigenza di trovare soluzioni piu eque per la copertura di tali oneritrasferendoli sulla fiscalita generale, nonche l’esigenza di una politicapiu sostenibile degli incentivi.
Rispetto all’azione di controllo, va evidenziata la discrasia tra lavariazione dei prezzi di riferimento di gas e petrolio e l’andamento delle
ii
“La*manovra*finanziaria*per*il**2010” — 2010/5/10 — 10:18 — page 179 — #185 ii
ii
ii
Politiche energetiche e manovra economica per il 2010 179
tariffe dell’energia, che in questi mesi di profonda crisi ha penalizzato lePMI. Gli obiettivi operativi debbono avere la capacita di incidere sullenorme in vigore (ridefinizione delle competenze strategiche dello Statonella Costituzione; completamento della liberalizzazione dei mercati) esui meccanismi di mercato (incremento dell’efficienza energetica).
Per quanto riguarda gli obiettivi di tutela dell’ambiente e della fascedeboli, occorre perseguire due linee di fondo: a) stilare un gerarchia del-le misure ambientali secondo efficacia, stabilendo un ordine di prioritaa partire da quelle meno costose, in termini di unita di emissioni inqui-nanti evitate; b) sussidi alle fonti rinnovabili piu costose, che dovrebberogravare sulla fiscalita generale e non sui consumatori di energia (giacchela fiscalita generale e improntata — in ossequio ai dettami costituzionali— ai criteri di progressivita, e pertanto permette di ripartire secondoequita i costi ambientali; al contrario, i prelievi sui consumi energeticisono regressivi, essendo l’energia un bene primario e quindi di consumonecessario) (Bollino, 2006).
Una sfida importante per il futuro del settore energetico italianoe senz’altro quella legata alla tecnologia nucleare. La risoluzione deiproblemi pendenti dovuti al passato utilizzo dell’energia nucleare —non solo sistemare definitivamente i materiali, ma anche smantellaregli impianti dismessi — non e soltanto un’esigenza logistica ed operati-va connessa con la gestione dei siti sedi di impianti o centrali: sarebbeanche un chiaro segno della volonta e capacita del Paese di dominaree risolvere questo problema e costituirebbe pertanto un passo impor-tante per togliere argomenti agli oppositori (Risoluti, 2009). Le bozzeche attualmente circolano riguardo il “Pacchetto nucleare” prevedonocompensazioni locali per i territori che ospiteranno le centrali nuclearicosı come il deposito unico nazionale per le scorie ad alta intensita; ta-li compensazioni assumerebbero la forma di aiuti alle amministrazionilocali e ai singoli privati “nuclearizzati” tramite sgravi fiscali e bonusenergetici. Tra gli effetti previsti vi sono la forte differenziazione dellefonti energetiche, una maggiore indipendenza energetica del Paese, etagli ai prezzi finali.
Infine, rilanciamo una proposta operativa (Bollino, 2006): stabilire ildivieto per lo Stato o gli enti locali di riscuotere dividendi dalle impre-
ii
“La*manovra*finanziaria*per*il**2010” — 2010/5/10 — 10:18 — page 180 — #186 ii
ii
ii
180 Cosimo Magazzino
se nei settori di pubblica utilita (energia, trasporti, telecomunicazioni,etc.) in misura superiore al tasso di rendimento corrente dei titoli diStato. L’eventuale eccedenza dovrebbe essere obbligatoriamente versa-ta al “Fondo di ammortamento del debito pubblico”. Cio avrebbe diversieffetti positivi: eliminerebbe la tentazione, per i pubblici poteri, di acca-parrarsi “rendite monopolistiche” a scapito dei consumatori; avvierebbeun serio dibattito sulle liberalizzazioni e privatizzazioni; concorrerebbea migliorare il quadro della finanza pubblica italiana; costituirebbe unamisura di equita inter-generazionale, abbattendo l’oneroso fardello deldebito a vantaggio delle generazioni future.
Riferimenti bibliografici
AA. VV. (2009), Ricerche per l’economia e la finanza, vol. XI, n. 127,pp. 3–36. Newsletter Osservatorio Energia.
Acocella, N. (2006), Fondamenti di politica economica: Carocci.AEEG (2009), “Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attivita
svolta”, Autorita per l’Energia Elettrica e il Gas.AEEG (2008), “Terzo Rapporto annuale sul meccanismo dei titoli di
efficienza energetica”, Autorita per l’Energia Elettrica e il Gas.AEEG-AGCM (2005), “Indagine conoscitiva sullo stato della liberaliz-
zazione dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale”, AutoritaGarante della Concorrenza e del Mercato e Autorita per l’EnergiaElettrica e il Gas.
Bastianelli, F. (2006), “La politica energetica dell’Unione Europea e lasituazione dell’Italia”, La Comunita Internazionale, vol. LXI, n.3, pp.443–468.
Bollino, C. A. (2006), “Politiche energetiche, tra vecchi obiettivi e nuovestrategie”, Federalismi.it, vol. 14, pp. 1–7.
Confcommercio (a cura di) (2009), Manifesto Ambientale. Politicheambientali europee ed interventi governativi: www.confcommercio.it/.
Curcio, E. (2006), “Le paure del nostro futuro energetico”, Bol-lettino di Informazione dell’Associazione Italiana degli Economistidell’Energia, vol. 1–2.
ii
“La*manovra*finanziaria*per*il**2010” — 2010/5/10 — 10:18 — page 181 — #187 ii
ii
ii
Politiche energetiche e manovra economica per il 2010 181
D’Ermo. V. (2005), “Il futuro dell’energia tra sfide politiche, economichee ambientali”, L’Ape ingegnosa – Rivista del Dipartimento di Scienzedello Stato, vol. 1-2, pp. 235–250.
Forte, F. (2006), Analisi economica del diritto, vol. 2: Iiriti.GME (2009a), Newsletter del GME, vol. 22: Gestore dei Mercati
Energetici.GME (2009b), Relazione annuale 2008: Gestore dei Mercati Energetici.GSE (2008), “Incentivazione degli impianti fotovoltaici”, Gestore dei
Servizi Elettrici.IEA (2009a), “Oil Market Report”, International Energy Agency.IEA (2009b), “World Energy Investment Outlook”, International
Energy Agency.Nomisma Energia, N. (2008), “Politiche energetiche e ambientali: le
potenzialita del combustibile da rifiuti di qualita elevata, CDR-Q”,Ingegneria, vol. 37, n. 4, pp. 5–108.
Platts (2009), “Platts Energy & Metals Bulletin”.Risoluti, P. (2009), “Nucleare e falsi problemi”, L’ircocervo, vol. 3, n. 2,
pp. 64–68, giugno.Unione Petrolifera (2005), Statistiche economiche, energetiche e
petrolifere.