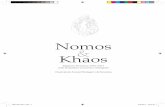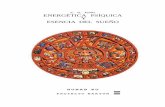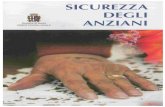Sicurezza energetica e geopolitica del gas in Europa
Transcript of Sicurezza energetica e geopolitica del gas in Europa
SCUOLA DI SCIENZE POLITICHE “CESARE ALFIERI”
CORSO DI LAUREA IN RELAZIONI INTERNAZIONALI E STUDI EUROPEI____________________________________________________________________
CORSO DI STUDIO IN TEORIE DELLA POLITICA INTERNAZIONALE
SICUREZZA ENERGETICA E
GEOPOLITICA DEL GAS IN EUROPA
Professore: Dott. Luciano Bozzo
Candidato: Angelo Berchicci
Matricola: 5804930
1
Indice
Introduzione..........................................................................................................................................3
1. Che cos'è la sicurezza energetica......................................................................................................6
2. Fattori critici per la sicurezza energetica..........................................................................................7
2.1. La dimensione tecnica...............................................................................................................7
2.2. La dimensione economica.........................................................................................................9
2.3. La dimensione politica............................................................................................................12
3. Il legame tra gas e sicurezza energetica..........................................................................................14
4. Le direttrci dell'approvvigionamento in Europa.............................................................................17
5. Prospettive future per un incremento della sicurezza energetica europea......................................21
Conclusioni.........................................................................................................................................25
Bibliografia.........................................................................................................................................33
Sitografia............................................................................................................................................33
2
Introduzione
Che cos'è la sicurezza? si può affermare che per un individuo il termine sicurezza indica laprotezione della propria incolumità (tutela della vita e dell'integrità fisica) e della propria autonomia(libertà da ingerenze esterne). A mio avviso è questa la dimensione basilare del concetto disicurezza. Tale definizione può essere ulteriormente arricchita facendo riferimento anche allaprotezione dei beni materiali, della propria ricchezza e in definitiva del proprio interesseeconomico. Ma a ben guardare la dimensione materiale altro non è che uno sviluppo dei due valoriirrinunciabili per l'uomo: il benessere serve per garantirsi la sussistenza e quindi la conservazionedella vita e dell' indipendenza. Il concetto di sicurezza è tradizionalmente associato a quello della violenza e della forza. Questolegame è particolarmente evidente nel pensiero di Thomas Hobbes, il quale concepisce lo stato dinatura, ovvero lo stato in cui gli uomini vivono prima di vincolarsi tramite un patto associativo,come una condizione in cui vige il diritto di tutti a tutto (ius in omnia). In questa situazione, al finedi conservare la propria vita, i propri beni e la propria libertà, gli individui sono legittimati aricorrere a qualsiasi mezzo, persino l'eliminazione fisica e la riduzione in schiavitù del rivale. In untale stato di anarchia e di guerra di tutti contro tutti (bellum omnia contra omnes) quindi vige lamera regola del più forte. Per uscire da questa situazione in cui la libertà e l'incolumità degliindividui sono costantemente minacciate, gli uomini decidono di rinunciare ai propri diritti di naturae stringono tra loro un patto in base al quale si sottomettono ad un essere superiore, il Leviatano, acui conferiscono il potere di istituire delle regole di condotta e di farle rispettare. Si può affermarequindi che Hobbes pone all'origine dello Stato il bisogno degli uomini di garantire la propriasicurezza. In che modo lo Stato garantisce la sicurezza dei propri cittadini? Ricalcando la definizione di Statodata da Max Weber, tramite il monopolio dell'uso legittimo della forza fisica1. Nello Stato modernole autorità politiche controllano, tramite la polizia e le forze armate, la gran parte delle armidisponibili, di cui detengono in maniera sostanzialmente esclusiva il diritto all'utilizzo. La forzapubblica viene utilizzata principalmente per far rispettare le leggi che la collettività si è data equindi per consentire la coesistenza pacifica e il normale funzionamento della società. Quello alla sicurezza è quindi uno dei più basilari diritti di cui i cittadini godono in seguito allacostituzione dello Stato e di cui possono esigere da esso il rispetto in cambio del loro sostegno alsistema politico. Proprio per questo motivo i gruppi politici intenzionati a mettere in discussione lalegittimità del potere costituito tendono ad utilizzare metodi, come quelli terroristici, che mirano adevidenziare la debolezza dello Stato e la sua incapacità di garantire la sicurezza dei propri cittadini. Il tema della sicurezza può essere affrontato anche da un altro fondamentale punto di vista: oltre allasicurezza che un individuo tende a garantirsi nei confronti degli altri vi è anche la sicurezza che unoStato è interessato ad assicurarsi nei confronti delle altre unità statuali. E' questo l'aspetto delproblema che riguarda il sistema internazionale, nel quale, dato il permanere di uno stato dianarchia simile allo stato di natura Hobbesiano, la questione della sicurezza si risolvenecessariamente secondo la logica del più forte e utilizzando spesso strumenti quali la violenza e lacoercizione. A differenza di quanto accade tra gli uomini, a livello internazionale non esiste un potere superioreal quale è rimesso il compito di regolamentare i rapporti tra gli Stati; esiste un insieme di regole dicondotta, ovvero il diritto internazionale, ma in assenza di un potere che ne garantisca il rispetto el'esecuzione coattiva questo corpus di regole non può che avere scarsa efficacia. In tale contestoquindi ciascuno Stato deve provvedere alla propria sicurezza intesa, secondo la definizione diRaymond Aron, come la possibilità di soddisfare l'aspirazione dell'unità politica a sopravvivere2. Storicamente lo strumento principale con il quale gli Stati hanno cercato di tutelare la propria
1 Cfr M.Weber, La scienza come professione. La politica come professione, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2004, p.48.2 Cfr R. Aron, Paix et guerre entre le nations, Calmann-Levy, Paris, 2004, pp 82-83.
3
sicurezza è stato il ricorso al conflitto armato, ovvero alla guerra. Nella sua ricostruzione dellaguerra del Peloponnesso Tucidide individua nel bisogno di garantirsi la sicurezza il motivo di fondodel conflitto tra Sparta e Atene. La vera causa scatenante del conflitto è la paura che la crescita delpotere avversario possa mettere in discussione la propria sicurezza; si tratta quindi di quella cheoggi verrebbe definita una guerra preventiva. Un altro esempio del legame tra guerra e sicurezza inTucidice è dato dal dialogo dei Meli:
94. Meli: "Sicché non accettereste che noi fossimo, in buona pace, amici anziché nemici, conservando intatta la nostraneutralità?".95. Ateniesi: "No, perché ci danneggia di più la vostra amicizia, che non l'ostilità aperta: quella, infatti, agli occhi deinostri sudditi, sarebbe prova manifesta di debolezza, mentre il vostro odio sarebbe testimonianza della nostra potenza".96. Meli: "E i vostri sudditi sono così ciechi nel valutare ciò che è giusto, da porre sullo stesso piano le città che nonhanno con voi alcun legame e quelle che, per lo più vostre colonie, e alcune addirittura ribelli, sono state ridotte aldovere?".97. Ateniesi: "Essi pensano che, tanto agli uni che agli altri, non mancano motivi plausibili per difendere la loro causa;ma ritengono che alcuni siano liberi perché sono forti e noi non li attacchiamo perché abbiamo paura. Sicché, senza contare che il nostro dominio ne risulterà più vasto, la vostra sottomissione ci procurerà maggior sicurezza; tanto più se non si potrà dire che voi, isolani e meno potenti di altri, avete resistito vittoriosamente ai padroni del mare".
Come si evince dall'estratto la sottomissione dell'isola di Melo ad Atene è di primaria importanzaperché influisce sulla reputazione che Atene ha nei confronti delle città sottomesse e dei proprinemici, diventando così una fondamentale questione di sicurezza. Con l'approssimarsi del ventunesimo secolo il problema principale legato al concetto di sicurezza,ovvero la guerra, entra in una nuova fase. La guerra sembra infatti aver mutato profondamente ilproprio paradigma: le guerre di tipo convenzionale ovvero i tradizionali scontri tra Stati sovranistanno cedendo il passo a nuove forme di conflittualità in cui lo Stato non riveste più il ruolocentrale. Come testimoniano i conflitti di natura etnica e religiosa scoppiati dopo la guerra fredda,sono mutati gli attori coinvolti nella guerra (non più eserciti regolari espressione di un'entità statalericonosciuta ma soggetti privati come i contractors e combattenti non professionisti definiti, aseconda dei contesti, ribelli, miliziani, guerriglieri, paramilitari, terroristi...), sono mutati i metodicon cui la guerra viene combattuta (al posto degli scontri aperti vi è un ricorso sempre maggiore atattiche di guerriglia), gli obiettivi (non tanto piegare la volontà e la capacità di resistenza delnemico quanto eliminarlo fisicamente) e gli effetti della guerra (essa non è più uno strumentorisolutivo e i conflitti quindi non trovano una soluzione durevole. Vi è inoltre una difficoltàcrescente nel distinguere tra civili e combattenti). L'emergere di nuove modalità di conflitto implica per gli Stati la necessità di rivedere il proprioconcetto di sicurezza. Se fino ad ora la principale preoccupazione dei governi è stata quella digarantirsi uno strumento di difesa adeguato contro eventuali aggressioni provenienti dagli Statirivali, l'attuale contesto internazionale impone una strategia difensiva rivolta sopratutto contro attorinon statali. All'interno del processo di “aggiornamento” del concetto di sicurezza si possono individuare duetendenze; da un lato vi è il superamento del tradizionale rapporto tra potenza e minaccia: in passatosi riteneva che la sicurezza di uno Stato fosse minata da concorrenti più o altrettanto potenti mentreal giorno d'oggi le principali minacce sembrano provenire dagli Stati più deboli, dai cosiddettiFailed e Fragile States (tornando al discorso precedente, una delle caratteristiche che rendono unoStato “fallito” è l'aver perso il monopolio dell'uso legittimo della forza fisica e il non essere quindiin grado di garantire la sicurezza dei propri cittadini), sui quali si concentra quindi l'attenzione dellacomunità internazionale. Dall'altro lato si assiste ad un progressivo venir meno della distinzione tra livello interno e livellointernazionale della sicurezza. Seguendo questa logica numerose questioni tradizionalmentecorrelate alla politica interna vengono sempre più indicate come minacce alla sicurezza statale:l'immigrazione, la presenza di quartieri e zone particolarmente disagiate, la criminalità organizzata
4
(evocativo è l'utilizzo delle forze armate per compiti di polizia e di contrasto alla criminalità, comel'operazione Strade Sicure), le emergenze ambientali, la perdita di competitività del sistemaeconomico e produttivo rispetto ai concorrenti stranieri (si veda il grande ricorso di alcuni Staticome Francia e USA all'intelligence economica per sostenere le proprie imprese), il collasso delladimensione cyber con il venir meno delle fondamentali infrastrutture informatiche e infinel'interruzione dei flussi commerciali, in particolare se si tratta di materie prime energetiche. Tuttiquesti fattori, se portati alle estreme conseguenze, possono compromettere l'integrità e l'autonomiadi un'unità politica, al pari di un conflitto armato. Nel mio lavoro ho scelto di approfondire un determinato aspetto tra quelli appena elencati: hodeciso di occuparmi delle ricadute che le scelte in campo energetico possono avere sulla sicurezzadi uno Stato e di un insieme di Stati come l'Unione Europea.Considerando la dipendenza delle infrastutture tecnologiche sia civili sia militari dalle risorseenergetiche appare evidente come un'interruzione nella fornitura di energia costituisca un danno benpiù grave di quello meramente economico, in quanto in grado di provocare la paralisi dell'interasocietà3. Nelle moderne società industrializzate la disponibilità di grandi quantità di energia elettricaè una condizione indispensabile per il funzionamento delle attività produttive e per l'attuazione deiservizi fondamentali come la comunicazione e la sanità. A ben guardare nell'attuale societàtecnologica anche le più basilari attività umane dipendono dal costante impiego di una fonteenergetica. Il nostro fabbisogno di energia non si limita a quella elettrica; anche gli idrocarburisvolgono un ruolo insostituibile nel garantire la mobilità degli individui e quindi sono ilpresupposto di tutte le attività ad essa collegate come il commercio o la difesa del territorio da partedelle forze armate e di polizia. Infine in alcune zone particolarmente inospitali la disponibilità dienergia è alla base della presenza stessa dell'uomo, è questo il caso di aree in cui la rigidità delclima rende necessario il riscaldamento o di zone desertiche in cui la dissalazione dell'acqua marinaè l'unica possibilità di accesso alle risorse idriche. In conclusione la dimensione energetica è a mio avviso uno dei temi che meglio rappresentano ilmutamento intercorso nella natura della sicurezza. I problemi relativi all'approvvigionamento dienergia esplicano perfettamente il nuovo e più ampio significato dato a tale concetto: non si trattapiù di tutelare l'integrità fisica dei cittadini e di difendere l'indipendenza e la sovranità dello Stato(ovvero l'aspetto classico della sicurezza), quanto di garantire la capacità del tessuto sociale dicontinuare a svolgere le proprie funzioni. Essendo quello al corretto funzionamento della società uno degli interessi centrali di qualsiasi unitàpolitica, la sicurezza energetica, vista anche la complessità del tema, non può che rientrare tra icompiti affidati in prima persona allo Stato. Tuttavia, come vedremo, anche in questo ambito siassiste ad una messa in discussione della presenza statale, che fa da corollario a quel processogenerale di crisi e di marginalizzazione del ruolo dello Stato in atto in molti campi dell'attualesocietà. Mi accingo quindi ad affrontare il tema delle politiche in campo energetico e delle loro ripercussionisulla sicurezza dei Paesi europei, concentrandomi in particolare sul gas naturale, una fontestrategica il cui peso all'interno dei panieri energetici degli Stati è destinato ad aumentaredrasticamente. Nel primo capitolo di questa relazione viene presentato il significato del terminesicurezza energetica mentre nel secondo si affrontano le principali problematiche che deveaffrontare chi si occupa di tale ambito. Nel terzo capitolo spiego, basandomi sui più recenti datistatistici disponibili, perché il gas naturale svolge un ruolo così importante per gli Stati e la loro
3 Nella storia sono numerosi i casi di black out che hanno interessato zone vaste e densamente popolate per periodi di tempoprolungati generando situazioni di emergenza a causa del mancato funzionamento dei servizi indispensabili. Tra i casi più recentie signifcativi si ricorda il black out che il 14 agosto del 2003 colpì la provincia Canadese dell'Ontario e diversi stati Americanidel nord-est lasciando 55 milioni di persone senza corrente per numerose ore (la corrente venne completamente ripristinata solodopo due giorni). A settembre dello stesso anno toccò all'Italia subire il suo più grande black out di sempre. Il 28 settembre perquasi 12 ore (in alcune zone per oltre 24 ore) l'intero paese esclusa la Sardegna rimase senza corrente elettrica. Infine il piùgrande black out della storia si è verificato il 30 luglio 2012 in India. In questa occasione oltre 620 milioni di persone rimaserosenza energia per 24 ore, e in alcuni casi per più di 48 ore.
5
sicurezza energetica. Nel quarto capitolo mostro le direttrici di approvvigionamento del gas inEuropa e le principali infrastrutture di trasporto. Infine nel quinto capitolo vengono descritti gliscenari futuri e le relative problematiche che l'Unione dovrà affrontare riguardoall'approvvigionamento del gas e ai rapporti con i Paesi fornitori.
1. Che cos'è la sicurezza energetica
Uno degli antesignani del concetto di sicurezza energetica, sicuramente quello più celebre, vieneindividuato in Winston Churchill. Durante la prima guerra mondiale, in qualità di Primo Lorddell'Ammiragliato Britannico, Churchill fu tra i primi a spingere per abbandonare l'uso del carbonecome combustibile per la flotta da guerra britannica e per la conversione di quest'ultima all'uso delpetrolio. I derivati del petrolio infatti avrebbero garantito una maggiore efficienza delle navi, intermini di un'aumentata autonomia e velocità. Egli era tuttavia consapevole che ai vantaggi tecnicigenerati dal ricorso al nuovo tipo di alimentazione si sarebbe associato un problema nuovo: quellodi garantirsi un adeguato livello di rifornimenti. Se il carbone infatti poteva essere prodottointernamente al Regno Unito, i giacimenti di petrolio si trovavano in aree lontane, non sempresottoposte al controllo britannico o non sempre facilmente difendibili. Nasceva così la questionedella sicurezza energetica a cui Churchill rispondeva con la differenziazione delle fonti diapprovvigionamento:
“La sicurezza e la certezza negli approvvigionamenti di petrolio risiedono nella varietà e soltantonella varietà.”4
Il concetto di sicurezza energetica fa quindi la sua prima comparsa applicato alle esigenze belliche.Dopo la guerra il poderoso sviluppo industriale ed economico vissuto dagli Stati Uniti negli anniventi genera un boom del consumo e della richiesta di energia. In questo contesto la questioneenergetica viene elevata a priorità per il governo statunitense e l'attenzione agli approvvigionamenti,aspetto una volta limitato ai tempi di guerra, diventa un principio fondamentale della politicaeconomica ed estera dei governi anche in tempo di pace. Tuttavia solo nella seconda metà delsecolo il tema acquisisce una notevole rilevanza accademica su entrambe le sponde dell'Atlantico.L'enorme fabbisogno energetico di un apparato bellico vasto come quello statunitense nel periododella guerra fredda e le crisi petrolifere degli anni '70 infatti contribuiranno a spostare sempre piùl'attenzione di studiosi di discipline molto diverse, dall'economia agli studi strategici, verso lasicurezza energetica. Negli ultimi trent'anni si è assistito quindi ad un moltiplicarsi delle definizionidi questa materia di studio e al tentativo di delineare quelli che sono i suoi aspetti tipici.Una delle letture più semplici ed esaustive di questo tema è quella di Matteo Verda, il quale,riprendendo la definizione di Daniel Yergin5, descrive la sicurezza energetica come “la disponibilitàdi rifornimenti energetici affidabili a prezzi ragionevoli” 6. Tale definizione sottolinea in maniera efficace la duplice natura della questione. Secondo il primoaspetto, quello dell'affidabilità (reliability), le materie prime energetiche devono poter essere estrattee trasportate ai mercati finali senza interruzioni. Il secondo criterio, quello dell'economicità(affordability), richiede che i prezzi delle materie prime non varino in maniera imprevedibile edeccessiva.
4 Cfr D. Yergin, Ensuring Energy Security, Foreign Affairs, https://www.foreignaffairs.com/articles/2006-03-01/ensuring-energy-security.
5 Ivi, “è possibile definire la sicurezza energetica come la disponibilità di approvvigionamenti sufficienti a prezzi ragionevoli”.6 Cfr M. Verda, Politica estera e sicurezza energetica. L'esperienza europea, il gas naturale e il ruolo della Russia, Edizioni Epokè,
Novi Ligure, 2012, p.18.
6
2. Fattori critici per la sicurezza energetica
Il tema della sicurezza energetica assume connotati diversi a seconda della quantità di materie primepresenti nel territorio dello Stato interessato. Per gli Stati il cui sottosuolo si presenta ricco diidrocarburi la questione della pianificazione energetica consiste sostanzialmente in un problema dipolitica economica e ambientale. Anche in questo caso l'aspetto della sicurezza è rilevante ma essoo riguarda le relazioni internazionali in misura limitata (in genere si tratta di proteggere le grandiinfrastrutture da minacce interne) oppure non può essere circoscritto esclusivamente alladimensione energetica (l'eventualità di minacce alle infrastrutture nazionali provenienti da altri Statiriguarderebbe l'ambito della difesa e della sicurezza tout-court). Il discorso è diverso invece per quei Paesi che dipendono dalle importazioni di materie primeprovenienti da altri Stati. In questa ipotesi la continuità dei flussi e il loro costo sono variabilisottratte al controllo dello Stato-consumatore per il quale la questione energetica va ad interessaresoprattutto il campo della politica estera e delle relazioni internazionali. E' principalmente perquest'ultima tipologia di Paesi, dentro la quale possiamo collocare la maggior parte degli Statieuropei, che la questione delle forniture di materie prime diventa un autentico problema disicurezza, ed è quindi dal loro punto di vista che, nella mia trattazione, affronterò il tema dellasicurezza energetica. Nel prendere i provvedimenti adatti ad implementare la sicurezza del proprio Paese in campoenergetico i decisori politici devono confrontarsi con tre dimensioni fondamentali: quella tecnica,quella economica e quella politica. La complessità delle scelte di sicurezza energetica è data dalfatto che ciascuna di tali dimensioni richiede misure specifiche che potrebbero avere ripercussioninegative e spesso difficilmente prevedibili negli altri settori.
2.1. La dimensione tecnica
La dimensione tecnica della sicurezza energetica racchiude tutte quelle misure volte a garantire lacontinuità dei flussi di materie prime energetiche nel breve periodo e, qualora si verificassero delleinterruzioni, a limitare gli effetti negativi di queste ultime sul benessere dei cittadini e sull'economianazionale. L'interruzione degli approvvigionamenti è un rischio che può generare da molteplici fattori. Unprimo ordine di cause sono gli incidenti e i malfunzionamenti che possono interessare leinfratrutture energetiche. E' questa un'evenienza a cui si può far fronte tramite l'adozione di controllirigorosi e di standard di sicurezza elevati, ma che non può essere del tutto esclusa, soprattutto acausa dell'elevato livello di complessità raggiunto da alcune infrastrutture e alla luce del fatto che iprogressi tecnologici degli ultimi decenni hanno permesso di aumentare la distanza tra i luoghi diproduzione e quelli di consumo delle materie prime, amplificando in proporzione i rischi diincorrere in rotture e avarie della rete di trasporto (statisticamente maggiore è la lunghezza di ungasdotto o di un oleodotto, maggiori sono le possibilità che si verifichi un problema in un puntodella conduttura). Inoltre, anche quando non vi siano carenze strutturali negli impianti, è semprepresente la possibilità di incorrere in danni provocati da un errore umano del personale addetto(anche in questo caso la presenza di personale adeguatamente qualificato può solo diminuire ilrischio di errori ma mai eliminarlo del tutto) o da un evento naturale imprevedibile. L'adozione di standard tecnici elevati consente di ridurre il rischio che si verifichino incidenti einterruzioni dei flussi. Tuttavia quando un incidente accade è necessario minimizzarne l'impatto e leconseguenze; a questo scopo è quindi fondamentale la predisposizione di piani d'emergenza e diesercitazioni per far si che il personale non risulti impreparato e sappia gestire al megliol'emergenza. Questi provvedimenti ovviamente riguardano le iniziative che possono essere prese alivello nazionale mentre i flussi di materie prime interessano in genere due o più Stati. In questocaso i Paesi consumatori non possono che affidarsi alle capacità dei propri partner commerciali di
7
evitare errori e di saper gestire le emergenze.Rischi non meno importanti per la sicurezza energetica sono quelli che provengono da azioni ostilidi terzi nei confronti delle infrastrutture: le petroliere e le metaniere continuano ad essere le vittimepreferite dai pirati7 e le condotte di trasporto sono particolarmente vulnerabili ad atti di sabotaggioperpetrati da terroristi o criminali comuni. Gli attacchi alle infrastrutture fisse sono un problemaparticolarmente sentito per gli Stati importatori, sia perché possono arrecare loro notevoli danni siaperché spesso essi non possono fare molto per evitarli dipendendo dalle misure di sicurezza messein atto dal paese produttore o dai paesi di transito. I provvedimenti che possono essere presi per scongiurare tale tipo di eventi in genere si situano alivello internazionale e vertono soprattutto sulla collaborazione e cooperazione tra gli Stati inambito di intelligence e di contrasto alla pirateria marittima8. A livello nazionale gli Stati possonoricorrere all'utilizzo di personale militare imbarcato a scopi difensivi sulle proprie navi mercantili(Nuclei militari di protezione) e a tutte quelle attività di informazione e di polizia miranti allaprevenzione e al contrasto delle attività criminali rivolte contro le infrastrutture energetiche9.I flussi di materie prime energetiche possono essere interrotti anche a causa di una espressadecisione dei governi degli Stati produttori o di transito. L'interruzione degli approvigionamenti puòessere dovuta alla volontà deliberata dei produttori di danneggiare o fare pressione sui paesiconsumatori, come nel caso della crisi petrolifera del 197310, oppure, in caso di gasdotti e oleodotti,essere la conseguenza di una crisi diplomatica tra uno Stato produttore e un paese di transito, comenel caso delle crisi Russo-Ucraine del 2006 e del 200911.In generale possiamo affermare che per aumentare la resistenza del sistema Paese a shock diqualsiasi natura nella disponibilità di materie prime energetiche le strade più efficaci sono due: la
7 Nel 2014 gli attacchi di pirati a navi mercantili sono stati 245, di questi 130 hanno interessato navi petroliere. Le acquemaggiormente battute dai pirati sono quelle che circondano il Corno d'Africa, sopratutto in corrispondenza dello stretto di Babel-Mandeb, lo stretto di Hormuz (tra la penisola arabica e l'Iran), il canale di Suez e le coste meridionali dell'India. A proposito si
veda R. De Forcade, Petroliere nel mirino dei pirati, Il Sole 24 Ore, http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2015-01-20/petroliere-mirino-pirati-105509.shtml?uuid=AB2LsngC.
8 Il primo passo in tale direzione è stato posto in essere dall'Unione Europea che nel 2008 ha lanciato la missione militareAtalanta, il cui scopo era il controllo della navigazione in prossimità delle coste somale. Nel 2009 anche la NATO si è impegnatanel combattere i pirati somali, prima con l'operazione Allied Protector e in seguito con Ocean Shield. Compiti simili svolgeanche la Combined Task Force 151 che opera nel contesto della Combined Maritime Force, una forza marittima multinazionalenon strutturata nell'ambito di un'istituzione internazionale. E' degno di nota il fatto che l'Italia sia stata la prima nazione adislocare unilateralmente una una propria unità al largo delle coste somale nel 2005 con l'operazione Mare Sicuro. A proposito siveda S. D'Auria, Pirateria marittima da Terzo Millennio, GNOSIS. Rivista italiana di intelligence,http://gnosis.aisi.gov.it/gnosis/Rivista33.nsf/ServNavig/33-14.pdf/$File/33-14.pdf?OpenElement.
9 Uno degli Stati che sentono maggiormente la necessità di garantire la sicurezza delle proprie infrastrutture sensibili dalleminacce interne è la Federazione Russa. A tal riguardo l'articolo 12 della Legge Federale sugli Armamenti approvata nel 2007stabilisce che le “imprese strategiche” possono dotarsi delle armi, degli uomini e dei mezzi necessari per garantire la sicurezzadelle loro attività nel rispetto della legge federale. In seguito all'approvazione di questa norma l'impresa energetica di statoGazprom si è dotata di una vera e propria forza armata privata i cui compiti vanno dal garantire la sicurezza del personale, delleinfrastrutture e dei trasporti a mansioni di intelligence e controspionaggio. A riguardo si veda C. Hurst, The militarization ofGazprom, Foreign Military Studies Office, http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/Militarization-of-Gazprom.pdf.
10 In seguito all'attacco condotto da Egitto e Siria nei confronti di Israele il 6 ottobre 1973, giorno dello Yom Kippur, gli Stati Unitie alcuni Paesi europei appoggiarono la causa israeliana. Come risosta i Paesi arabi membri dell'OPEC che sostenevano gliaggressori decisero di interrompere le esportazioni di petrolio verso Stati Uniti e Paesi Bassi fino al marzo 1974.
11 Grazie alla sua posizione geografica l'Ucraina ha un ruolo centrale nelle esportazioni di gas russo verso l'Unione Europea (il67,7% dei flussi di gas russo diretti in Europa, tra cui la totalità di quelli destinati all'Italia, passa sul suo territorio). In cambiodei diritti di passaggio l'Ucraina riceve ogni anno un pagamento in natura, pari a circa 25 Gmc (miliardi di metri cubi). Il restantefabbisogno di gas storicamente veniva coperto tramite l'acquisto ad un prezzo più basso di quello di mercato (50 dollari ognimille metri cubi, la Russia applica tali tariffe di favore nei confronti dei Paesi che appartengono alla Comunità degli StatiIndipendenti). Nonostante i prezzi scontati l'Ucraina iniziò già dal 1993 a non pagare le forniture e a distogliere parte dei volumidestinati ai Paesi europei utilizzandoli per il consumo interno. La questione si aggravò dopo la rivoluzione arancione del 2004,in seguito alla quale l'ago della politica ucraina si spostò verso l'Unione Europea prendendo le distanze dalla tradizionaleinfluenza russa. Come risultato Gazprom estese anche nei confronti dell'Ucraina le tariffe in vigore per i Paesi europei (230dollari ogni mille metri cubi). Dopo il rifiuto di Kiev di accettare il nuovo livello dei prezzi la Russia interruppe nel gennaio2006 e nuovamente nel gennaio 2009 tutti i flussi diretti all'Ucraina, la quale reagì prelevando il gas destinato ai Paesi europei,che vennero danneggiati dall' improvvisa diminuzione dei volumi destinati loro. Cfr M. Verda, Una politica a tutto gas.Sicurezza energetica europea e relazioni internazionali, Università Bocconi Editore, Milano, 2011, pp 138-139.
8
creazione di un'adeguata capacità di stoccaggio e la diversificazione. Questi sono due aspetti chedevono necessariamente essere affrontati congiuntamente per la definizione di un' efficace strategiadi sicurezza energetica. Per quanto la capacità di stoccaggio sia fondamentale per compensaredifficoltà di approvvigonamento nel breve periodo, le caratteristiche delle attuali società occidentali,che si basano su un enorme consumo di energia, rendono impossibile la creazione di un livello discorte tale da garantire ai Paesi autonomia anche in caso di crisi durature. Essenziale risulta quindila differenziazione, la quale può attuarsi su più livelli:- diversificazione delle fonti che compongono il paniere energetico (gas, carbone, petrolio, nucleare,rinnovabili);- diversificazione dei metodi di rifornimento della stessa materia prima (ad esempio il gas naturalepuò essere importato sia via gasdotto sia via mare facendo ricorso al GNL);- diversificazione dei tracciati di trasporto all'interno di una stessa infastruttura (i gasdotti in generepresentano più condotte tra loro distanziate per evitare che, in caso di danneggiamento di una diesse, il flusso di gas venga interrotto completamente);- diversificazione dei partner commerciali, sia in termini di Paesi produttori che in termini di Paesidi transito. In materia di gas la posizione della Germania è un caso esemplare di diversificazione deipartner commerciali. Il 30% del gas importato proviene dall'Ue (Regno Unito, Danimarca masoprattutto Paesi Bassi) e il 33% dalla Norvegia. In entrambi i casi si tratta di forniture cheraggiungono la Germania senza passare per Paesi terzi e quindi altamente affidabili data lavicinanza politica e geografica tra produttore e consumatore. Il restante 37 % proviene dallaFederazione Russa. Per ovviare agli eventuali rischi che possono interessare questi flussi data lamaggiore distanza del Paese produttore e la presenza di Paesi di transito non particolarmenteaffidabili dal punto di vista politico, la Germania ha prestato particolare attenzione alladiversificazione dei percorsi di importazione del gas russo: una prima direttrice è data dal gasdottoTransgas che parte dall'Hub Ucraino di Uzhgorod e attraversa la Slovacchia e la Repubblica Ceca,un secondo percorso è rappresentato dal gasdotto Yamal-Europa che tocca la Bielorussia e laPolonia e una terza via dal recente Nord Stream che collega direttamente la Russia alla Germaniaattraverso i fondali del Mar Baltico12.
2.2. La dimensione economica
Mentre la dimensione tecnica della sicurezza energetica riguarda i rischi relativi all'affidabilità deiflussi quella economica interessa la ragionevolezza e la stabilità dei prezzi delle materie primeenergetiche. Un aumento incontrollato dei prezzi di tali materie prime infatti può generare danniallo Stato importatore altrettanto gravi di quelli causati dall'interruzione dei flussi. Questo è dovutoal fatto che nel breve periodo la domanda energetica si caratterizza per una bassa elasticità rispettoal prezzo: il consumo di gas e di petrolio è alla base del funzionamento di attività fondamentali perla società quali i trasporti, il riscaldamento e le attività produttive e in quanto tale non può essereridotto più di tanto anche in presenza di un aumento dei prezzi. Il mercato energetico è quindiparticolarmente rigido nel breve periodo13. Come conseguenza, per i Paesi importatori uninnalzamento dei prezzi può avere gravi ripercussioni negative sul benessere dei consumatori e sullacompetitività del sistema produttivo (a causa delle dinamiche inflazionistiche), e nei casi più gravipuò condurre ad un collasso dell'economia con l'esplosione della disoccupazione e seri problemi di
12 Ivi, pp 133-134.13 Si assume che nel lungo periodo lo Stato possa reagire all'aumento del prezzo di una materia prima facendone diminuire la
domanda grazie ad interventi strutturali come la riduzione dell'intensità energetica della società e la conversione verso l'utilizzodi fonti alternative. Da un punto di vista meramente economico più aumenta il prezzo di una fornitura energetica più aumenta lapossibilità che quest'ultima venga sostituita nel lungo periodo. Poniamo l'esempio del gas utilizzato per generare energiaelettrica: il prezzo di quest'ultimo potrebbe aumentare al punto tale da spingere i Paesi consumatori a ricorrere sempre più atecnologie alternative come l'idroelettrico e le altre rinnovabili o il nucleare. Inoltre l'aumento dei prezzi potrebbe renderecompetitivo l'utilizzo di eventuali giacimenti interni in precedenza ritenuti sconvenienti perchè troppo difficili e costosi daraggiungere.
9
stabilità sociale e politica.Per quanto riguarda la prima fonte energetica al mondo per importanza, ovvero il petrolio, il suoprezzo si esprime in dollari al barile ed è determinato sostanzialmente dalle dinamiche delladomanda e dell'offerta. Anche il mercato finanziario influisce notevolmente tramite le speculazionisui prodotti collegati al mercato petrolifero e i meccanismi di formazione delle aspettative sugliandamenti dei prezzi, tuttavia gli effetti di questo canale sono per lo più limitati al breve periodo14. Seguendo le logiche del mercato l'aumento dei prezzi è generato da un eccesso di domanda rispettoall'offerta, a sua volta frutto di un innalzamento della domanda o di una diminuzione dellaproduzione. La contrazione dell'offerta può generare dalla scelta deliberata di un monopolista o di un cartello diproduttori di far valere il proprio potere di mercato diminuendo la produzione e spingendo al rialzo iprezzi. E' questa la logica con la quale l'OPEC ha cercato negli ultimi decenni di mantenere unelevato livello dei prezzi sul mercato del petrolio. Tale processo iniziò con la crisi del 1973 inoccasione della quale i paesi dell'OPEC decisero di innalzare il prezzo del petrolio da 17 a quasi 55dollari al barile15. Nel 1982 inoltre venne stabilito il sistema delle quote produttive ponendo un tettoalla produzione annua dei Paesi membri. Al giorno d'oggi invece questa tendenza si è invertita: la decisione dell'Arabia Saudita presa alvertice Opec del 27 novembre 2014 di non tagliare ulteriormente la sua quota di estrazione, unita alboom della produzione di petrolio non convenzionale statunitense (tight oil detto anche shale oil)sta aumentando l'offerta di petrolio sul mercato spingendo i prezzi al ribasso16.In passato contrazioni significative dell'offerta di materie prime energetiche sono state causateanche da eventi bellici o stravolgimenti politici che hanno interessato i Paesi produttori. E' questo ilcaso della rivoluzione iraniana del 1979, in occasione della quale il Paese precipitò nel caos e leattività di estrazione e di esportazione del petrolio furono interrotte generando un innalzamento neiprezzi del barile a cui storicamente ci si riferisce con il termine di “seconda crisi energetica”17. La diminuzione dell'offerta può essere causata anche da un insufficiente livello di investimenti innuova capacità produttiva. Nel settore petrolifero infatti gli investimenti sono particolarmentecostosi ed è necessario quindi un livello di prezzi abbastanza elevato per ripagare il capitaleinvestito. Inoltre le tempistiche per la realizzazione dei grandi investimenti sono piuttosto lunghe.L'effetto combinato di questi due fattori in determinate condizioni può produrre un innalzamentodei prezzi. In un periodo come quello attuale di prezzi in diminuzione e in cui non si hannoaspettative di aumento in tempi brevi gli incentivi agli investimenti crollano. Come conseguenza,nel momento in cui la domanda torna a crescere, la capacità produttiva non può essere aumentatapiù di tanto e i prezzi tendono a salire. Occorre quindi aspettare anni prima che i nuovi investimentientrino a regime aumentando l'offerta e assorbendo così l'eccesso di domanda. L'aumento dei prezzi può essere causato anche da un consistente aumento della domanda comequello verificatosi a partire dal 1990 in seguito allo sviluppo dell'economia cinese. L'intensa eprolungata crescita economica di un'area geografica o di un Paese particolarmente vasto tuttavianon genera aumenti di prezzo tali da costituire una minaccia per la sicurezza energetica degli altriStati. Una caratteristica fondamentale del mercato delle materie prime energetiche a livello globale è ilruolo centrale del petrolio, non solo come fonte energetica preponderante ma anche come
14 A livello globale il petrolio fornisce un terzo dei consumi totali di energia. A livello europeo la quota è ancora più elevataarrivando al 38% dei consumi. Nel complesso i fattori che influiscono sulla determinazione del suo prezzo sono molteplici; oltrea quelli già elencati possiamo menzionare anche la quantità di riserve di valuta e di petrolio detenute dai paesi produttori,l'andamento del dollaro (l'unica valuta di riferimento) e l'instabilità politica in molti paesi esportatori. Cfr M. Verda, Politicaestera e sicurezza energetica, op. cit, p 27, 43.
15 I prezzi sono espressi in dollari deflazionati al 2013. Fonte: Agi energia http://www.agienergia.it/QuotazioniPetrolio1990.aspx. 16 Cfr J. C. Hulsman, I sauditi puntano sul barile a saldo per tenersi stretti gli Usa, Limes. Rivista italiana di geopolitica, La Russia
in guerra, 12/2014, pp 175-179.17 L'effetto combinato della rivoluzione iraniana e della successiva guerra tra Iran e Iraq portarono il prezzo del petrolio a
raggiungere i 104 dollari al barile nel 1980. Fonte: Agi energia http://www.agienergia.it/QuotazioniPetrolio1990.aspx.
10
riferimento di prezzo (benchmark) per le altre materie prime. Infatti le principali fonti energetichescambiate a livello internazionale derivano il proprio prezzo in misura più o meno significativadalle quotazioni del petrolio greggio. Il caso più importante di “indicizzazione” al petrolio riguardail mercato del gas naturale, il cui prezzo è determinato secondo un meccanismo chiamato netback.Secondo questo sistema il prezzo del gas si determina in base ad una media ponderata del prezzodei combustibili più costosi che esso sostituisce, per lo più derivati del petrolio. 18 L'ancoraggio dei prezzi del gas a quelli del petrolio è una notevole fonte di squilibri e di incertezzaper il mercato, sia perchè la caratteristica volatilità dei prezzi del petrolio si trasmette anche al gas,sia perchè l'andamento della domanda di quest'ultimo potrebbe divergere da quella del petrolio, congravi ripercussioni sulla dinamica degli investimenti. Per esempio, in un periodo di prezzi delgreggio bassi, la domanda di gas naturale potrebbe essere in forte crescita. Tuttavia il basso prezzodel gas renderebbe poco conveniente per i produttori effettuare nuovi investimenti in capacitàproduttiva. Questa sembrerebbe la situazione che sta vivendo il mercato Europeo attualmente: si prevede cheentro il 2020, a causa dell'effetto combinato dell'aumento della domanda di gas (impiegato inmaniera crescente nella generazione di energia elettrica in sostituzione del carbone e del nucleare) edella contrazione della produzione interna, la domanda di importazioni dovrebbe crescere di circa50-70 Gmc.19 Tuttavia il crollo nel prezzo del petrolio e conseguentemente in quello del gasverificatosi negli ultimi anni è stato uno degli elementi che hanno contribuito all'abbandono dientrambi i progetti di gasdotti che avrebbero dovuto rifornire i Paesi del sud-est dell'UnioneEuropea, collegandoli o ai giacimenti del Mar Caspio (Nabucco) o ai giacimenti russi del Mar Nero(South Stream). Quali sono quindi i provvedimenti che i policy makers dei Paesi consumatori possono adottare permitigare o prevenire gli effetti di un andamento avverso dei prezzi delle materie prime? Innanzituttogarantire che le imprese nazionali del settore energetico mantengano un adeguato livello diinvestimenti nelle infrastrutture critiche. Questo compito è reso più difficile dal fatto che nei Paesiappartenenti all'Unione Europea vi sia una spinta sempre maggiore a diminuire la presenza delloStato nel settore energetico. Se prima infatti lo strumento privilegiato dei governi in tale ambitoerano le compagnie monopolistiche pubbliche che coprivano tutti gli ambiti della filiera ora, inseguito al processo di liberalizzazione dei mercati energetici e di scorporamento delle aziendeverticalmente integrate in corso negli ultimi anni, i decisori politici possono intervenire soloindirettamente nelle scelte degli operatori economici a cui competono gli investimenti. Nonostantequeste difficoltà l'azione dei decisori statali, tramite la regolamentazione del mercato e la creazionedi incentivi fiscali e tariffari, è fondamentale per compensare l'eventuale incapacità degli operatoriprivati di fornire adeguati investimenti lungo la filiera. Un altro limite per i decisori politici riguarda ovviamente la dimensione strettamente nazionaledella loro azione; in altre parole gli investimenti nelle grandi infrastrutture di trasporto come igasdotti internazionali dipendono anche dalla volontà dei Paesi produttori e dei Paesi di transito,che tuttavia poossono essere in disaccordo con i Paesi consumatori circa l'opportunità e lecaratteristiche dell'investimento. Altri importanti azioni di tutela della sicurezza energetica sono tutte quelle politiche volte adaumentare l'efficienza energetica del Paese. La diminuzione della quantità di energia necessaria alcorretto funzionamento della società, essendo una tematica che non coinvolge attori esterni, è unodegli strumenti più efficaci e meno problematici per aumentare la “resilienza” del sistema agliaumenti dei prezzi (in quanto diminuisce l'esborso necessario a garantirsi approvvigioniamentisufficienti) e alle interruzioni dei flussi (permette alle scorte di durare più a lungo). Anche in questocaso fondamentali sono gli investimenti in tecnologie avanzate e in ricerca e sviluppo. Infine il primo e più importante elemento per garantire la sicurezza energetica dal punto di vista
18 Cfr M. Verda, Una politica a tutto gas, op. cit, pp 37-39.19 Ivi, pp 112-113.
11
economico è disporre di un'economia florida, competitiva e in continuo sviluppo. Le materie primeenergetiche sono infatti merci come le altre e come tutti i beni scambiati sul mercato hanno unprezzo. Quanto più alto è il tenore economico di uno Stato tanto maggiore è la capacità diquest'ultimo di acquistare energia e di sopportare rialzi nei prezzi. Di conseguenza un altrofondamentale strumento per garantire la sicurezza economica di un Paese è predisporre le misurenecessarie a garantirne la costante crescita economica. Come si è potuto vedere quindi, mentre la dimensione tecnologica riguarda per lo più il breveperiodo, quella economica comprende azioni che i governi possono mettere in atto nel medio-lungoperiodo.
2.3. La dimensione politica
I decisori politici nel mettere in atto le proprie scelte di sicurezza energetica devono confrontarsianche con aspetti che non sono direttamente tecnici o economici: devono infatti tenere conto anchedelle ricadute delle loro dicisioni in altri ambiti come quello ambientale o sociale. Questo fa si chela ricerca di un compromesso tra i vari interessi in gioco porti spesso a soluzioni non ottimali dalpunto di vista tecnico ed economico o, al contratio, che una scelta incentrata esclusivamente sullarazionalità dal punto di vista della sicurezza energetica abbia serie ripercussioni negative in altricampi. Un esempio del “trade-off” che spesso si crea tra la sicurezza energetica e la stabilità socialeè dato dalla cosiddetta “sindrome NIMBY” (Not In My Back Yard), ovvero la propensione degliabitanti delle zone interessate dal progetto di una infrastuttura ad ostacolarne la costruzione a causadel timore degli effetti negativi che quest'ultima possa avere sul territorio. Questo atteggiamentonon colpisce solo discariche, termovalorizzatori o depositi di sostanze pericolose ma anche leinfrastrutture strategiche per la sicurezza energetica come dimostrano le proteste inscenate daicomuni, dalle associazioni cittadine e dai comitati locali salentini contro la realizzazione delgasdotto TAP (Trans-Adriatic Pipeline, il quale, come vedremo, attraversando la Grecia, l'Albania eil Mare Adriatico terminerà la sua corsa in provincia di Lecce e metterà in collegamento l'Italia coni giacimenti di gas azeri).Tra i diversi ambiti con i quali le scelte di politica energetica devono confrontarsi, quello dellapolitica estera ricopre un ruolo di primo piano per gli Stati che ricorrono in misura rilevante alleimportazioni. Una volta decisa la costruzione di una infrastruttra come un gasdotto o un oleodottoquest'ultima lega a doppio nodo il Paese produttore e il Paese consumatore. Si crea infatti unasituazione di interdipendenza in cui i Paesi importatori dipendono dalla continuità dei flussi dimaterie prime e dalla stabilità dei prezzi mentre i produttori si basano sui proventi degli scambicommerciali per garantire la stabilità finanziaria ed economica del Paese. Una tale situazione non può che avere enormi ripercussioni sulla politica estera dei rispettivi Stati:da un lato la decisione di instaurare una collaborazione commerciale tra due Paesi può favorire unamaggiore cooperazione bilaterale, in termini economici, politici e persino militari. Gli scambicommerciali in campo energetico quindi possono generare importanti esternalità positive e fungereda propulsore per investimenti incrociati in molteplici ambiti e in generale per l'instaurazione dirapporti di amicizia tra gli Stati. Le scelte di sicurezza energetica non hanno solo implicazioni positive sulla politica estera. Adesempio un rapporto privilegiato con un produttore può limitare l'azione di politica estera del Paeseconsumatore. In caso di crisi diplomatica che interessi un fornitore infatti, difficilmente i suoi clientipotranno prendere una posizione a lui ostile senza sacrificare in parte gli interessi nazionali.Possiamo quindi affermare che la scelta dei partner commerciali in un settore delicato come quelloenergetico deve essere fatta molto attentamente e deve includere valutazioni non solo tecniche edeconomiche ma anche politiche e strategiche in quanto, una volta instaurati determinati rapporti,essi tendono a “legare le mani” ai decisori politici. A mio avviso la situazione italiana in tema diapprovvigionamento del gas è un ottimo esempio di come la dimensione politica possa provocare
12
gravi difficoltà ai Paesi consumatori: per ben due volte nella recente storia infatti l'Italia si è trovatanella scomoda situazione di dover mediare tra la sua posizione di Paese saldamente inserito nelcontesto di un'alleanza militare (NATO) e di una unione politica (UE) con tutti i vincoli che questocomporta e i propri contrapposti interessi nazionali in campo energetico e commerciale, conriferimento all'intervento militare in Libia del 2011 e alla perdurante crisi tra Russia e Ucraina. La scelta delle controparti quindi non può prescindere da una valutazione che tenga conto anche deilegami e delle tendenze storiche di un determinato Paese, della propria posizione geopolitica e dellasituazione politica interna e internazionale. In particolare nel caso della Libia, retta da un governodittatoriale, storicamente attraversata da un alto livello di conflittualità interna su base locale etribale e dal punto di vista internazionale invisa ai principali Paesi occidentali, non sarebbe statodifficile prevedere che ci si stava legando ad un partner che non solo non avrebbe dato garanzie dalpunto di vista della stabilità interna e quindi dell'affidabilità dei flussi di gas, ma che avrebbe potutomettere l'Italia in stuazioni imbarazzanti davanti ai propri alleati occidentali20. Come fare quindi per conciliare le esigenze tecniche, quelle economiche e quelle politiche? La risposta non può vertere in maniera semplicistica sull'evitare di farsi coinvolgere in legami conPaesi “scomodi”. Il mercato del gas infatti per sua natura non è perfettamente concorrenziale bensìgli scambi avvengono su base regionale. La posizione geografica di un Paese quindi limitafortemente le opzioni che quest'ultimo ha in materia di partner (i gasdotti sono economicamenteconvenienti e materialmente fattibili solo entro una determinata distanza. La possibile risposta aquesto inconveniente potrebbe essere il ricorso al GNL che, essendo trasportato via mare, permettedi stabilire legami commerciali anche al di fuori della propria area regionale, tuttavia quest'ultimadirettrice è ancora poco sviluppata al giorno d'oggi).L'unica risposta valida che si può dare a questa domanda è quella di fare affidamento su di unelevato livello di differenziazione dei fornitori. In questo modo viene attenuato l'effetto negativoche una situazione di dipendenza da un produttore può avere sulle relazioni internazionali del Paeseimportatore. Fino ad ora ci siamo occupati di descrivere le ripercussioni che le scelte di sicurezza energeticahanno sulla politica estera di un Paese. Ma l'interazione tra politica estera e sicurezza energeticacomporta un'influenza reciproca: possiamo quindi affermare che anche le scelte di politica esterahanno ricadute importanti in campo enrgetico. E' questo il caso dell'Iran, uno dei principaliproduttori mondiali di petrolio e di gas, il quale, a causa della propria volontà di diventare unapotenza nucleare e della sua politica estera ostile allo Stato di Israele e ai suoi alleati occidentali, hadovuto subire a partire dagli anni 2000 pesanti sanzioni che ne hanno significativamentecompromesso gli scambi energetici.
20 Nel 2004 è stato ultimato il gasdotto GreenStream che ha collegato i giacimenti libici con la Sicilia. Nel 2010, primadell'interruzione dei flussi dovuta allo scoppio della guerra civile e all'intervento militare internazionale le importazioni di gaslibico sono state di 9,4 Gmc, il 12% delle importazioni totali di gas, rendendo così la Libia il terzo fornitore di gas dell'Italiadopo Algeria e Russia. Cfr. M. Verda, Una politica a tutto gas, op. cit, pp 188-190. Nel 2010 lo stop delle forniture libiche èdurato 8 mesi, dopo i quali le estrazioni dai giacimenti di Bahr Essalam e di Wafa sono riprese mentre il giacimento di AbuAttifel in Cirenaica è tutt'ora chiuso a causa dell'instabilità che caratterizza l'area. Un altro momento critico si è avuto nel marzo2013 quando l'impianto di trattamento di Mellitah è stato bloccato per un paio di giorni da uomini armati della comunità berberaper protesta contro il governo. Attualmente la produzione e il trasporto del gas verso l'Italia funzionano regolarmente, seppur inun clima di incertezza data dalla presenza in Libia di due governi che si affrontano per il potere. Le infrastrutture dell'ENI sitrovano nella zona occidentale del Paese controllata dal governo di Tripoli ma il gas passa dalla città di Zintan, controllata damilizie fedeli al governo di Tobruk e sede in passato di scontri armati.
13
3. Il legame tra gas e sicurezza energetica
In questo lavoro si pone particolare attenzione sull'importanza del gas naturale in relazione allatematica della sicurezza energetica. Infatti tra le diverse fonti che concorrono a soddisfare ilfabbisogno energetico europeo e italiano quest'ultimo ricopre un ruolo particolarmente delicato,tanto da far risultare il suo approvvigionamento cruciale per le esigenze basilari dell'economia edella società. I motivi per cui il gas naturale è così rilevante sono molteplici: innanzitutto il suo peso quantitativoè elevato sia a livello dell'Unione Europea (il 21,6% del consumo totale di energia21; Si veda fig.1)ma soprattutto dal punto di vista italiano (32,8%22); inoltre tali percentuali nei prossimi anni sonodestinate ad aumentare in quanto si stima che il gas verrà utilizzato sempre più nella generazione dienergia elettrica in sostituzione di fonti più inquinanti come il carbone o più costose come ilnucleare. Il successo del gas naturale per la produzione di energia elettrica è dovuto al fatto che gli impiantitermoelettrici sono più rapidi ed economici da costruire rispetto alle centrali elettronucleari che, purcomportando costi inferiori a parità di elettricità prodotta, richiedono grandi investimenti iniziali ecomportano tempistiche piuttosto lunghe per quanto riguarda la realizzazione degli impianti, oltre agenerare in molti Paesi malcontenti di tipo politico e sociale legati alla maggiore pericolositàpercepita dell'energia atomica e alla problematicità della gestione delle scorie23. Rispetto all'altro suo concorrente, ovvero il carbone, il gas può vantare la caratteristica di emetteremeno sostanze inquinanti e meno anidride carbonica durante la combustione, a parità di energiaprodotta. Ciò lo rende particolarmente vantaggioso soprattutto nei paesi dell'UE dove si guarda conattenzione alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica24. Proprio l'uso che si fa del gas è uno dei motivi che evidenzia il suo ruolo strategico per gli Stati: lacomponente termoelettrica è fondamentale per la produzione di energia elettrica in molti Paesieuropei (come il nostro in cui il gas produce il 38,7% dell'elettricità totale25) e come abbiamo piùvolte ripetuto l'energia elettrica è la base di ogni attività produttiva, sociale, di tutela dell'ordine e didifesa tanto da essere vitale per la stabilità di un Paese. Di conseguenza l'approvvigionamento dellematerie prime con cui generare energia elettrica assume un valore particolarmente importante intermini di sicurezza. Ad attirare l'attenzione su questa fonte energetica contribuisce il fatto che, all'aumentare della suaimportanza, coincida una progressiva diminuzione della sua disponibilità nel sottosuolo europeo.Basta dare una rapida occhiata alla Statistical Review of World Energy 2015 stilata dalla BP e inparticolare ai dati che mostrano i consumi, le riserve e la produzione di gas nel 2014 per capirecome l'Europa sia destinata ad andare incontro sempre più ad un aggravamento della propriasituazione di dipendenza dalle importazioni.
21 Su un totale di 1611,4 MTOE (Milioni di Tonnellate Equivalenti di Petrolio) di energia consumata nell'UE nel 2014, 348,2 sonostate prodotte dal gas naturale. Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2015http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf.
22 Su un totale di 1.749.792 TCAL (Teracalorie) di energia consumata in Italia nel 2013, 573.935 sono state prodotte dal gasnaturale e 699.480 (il 40%) dal petrolio. Fonte: Bilancio Energetico Nazionale 2013 redatto dal Ministero dello SviluppoEconomico http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/ben/ben_2013.pdf.
23 Il principale Paese che ha optato per la sostituzione dell'energia atomica è la Germania, che nel 2011, a seguito della catastrofe diFukushima, ha deciso di porre fine entro il 2022 alla generazione nucleare sostituendola con quella termoelettrica e con le fontirinnovabili.
24 La strategia Europa 2020 ha stabilito l'obbiettivo per gli Stati membri dell'Ue di ridurre le emissioni di gas serra del 20% rispettoai livelli del 1990 entro il 2020.
25 Nel 2013 l'energia elettrica totale prodotta in Italia è stata di 289.803,2 Gwh (Gigawattora). Il 68,5 % di questo ammontare(198.644 Gwh) è stato prodotto dal settore termoelettrico e geotermoelettrico. All'interno di questo settore il 56,5% dell'energia(112.301,3 Gwh) è stata prodotta dalla combustione del gas naturale. Fonte: Terna, Dati statistici sull'energia elettrica in Italia,2013 http://www.terna.it/LinkClick.aspx?fileticket=EhuoPsMXv1s%3d&tabid=418&mid=2501. La percentuale di gas dedicataalla generazione elettrica è stata il 39% del consumo totale di gas. Fonte: International Energy Agencyhttp://energyatlas.iea.org/?subject=-1165808390&datapresentation=2&lang=en.
14
Nello specifico, per quanto riguarda le riserve di gas, esse sono concentrate nell'ex UnioneSovietica che dispone di 54,6 Tmc (bilioni di metri cubi), ossia il 29,2% delle riserve mondiali, e inMedio Oriente dove vi sono 79,8 Tmc, ovvero il 42,7% delle riserve mondiali. Il Sud-Est Asiatico,l'Africa e il Sud America dispongono rispettivamente dell'8,2% (15,3 Tmc), del 7,6% (14,2 Tmc) edel 4,1% (7,7 Tmc). La situazione europea in quanto a riserve è decisamente marginale: nelsottosuolo dei Paesi membri dell'Unione Europea complessivamente vi sono 1,5 Tmc di gas, ovverolo 0.8% a livello globale, a cui possiamo sommare il dato della Norvegia che da sola possiede piùriserve di tutti i Paesi dell'UE, ovvero 1,9 Tmc pari all'1% delle riserve mondiali. Per quantoriguarda gli Stati Uniti, nel corso del decennio passato essi sono stati in grado di raddoppiare leproprie riserve grazie all'applicazione di nuove tecnologie che permettono di estrarre gas dagiacimenti non convenzionali (shale gas); al giorno d'oggi gli USA dispongono di 9.8 Tmc, il 5,2%del totale mondiale. 26
L'ammontare di riserve in assoluto tuttavia non è sufficiente per comprendere la situazione dellediverse aree geografiche; questo dato infatti non ci mostra la quantità di tali riserve che vieneestratta. Per evidenziare l'intensità con la quale le riserve vengono sfruttate è necessario mettere inrelazione questi dati con quelli della produzione di gas; in questo modo è possibile farsi un'ideadella velocità alla quale le varie riserve stanno esaurendosi. Basandosi sul rapportoriserve/produzione dei Paesi nel 2013 (e ponendo per ipotesi che la produzione rimanga stabile nelfuturo e non vengano scoperti nuovi giacimenti) l'Eni, nella sua World Oil and Gas Review 2014,mette a punto una stima del tempo necessario per giungere all'esaurimento delle risorse; il datorisultante viene quindi utilizzato per fare una media del tempo di sfruttamento residuo per areegeografiche: secondo tale calcolo le riserve di gas del Medio Oriente dovrebbero esaurirsi tra 144anni, quelle dell'Africa tra 87 anni, quelle della Russia e dell'Asia Centrale tra 76 anni, quelle delSud America tra 36 anni, quelle del sud-est asiatico tra 35 anni, quelle dell' Europa tra 19 anni equelle del Nord America tra 13 anni27 (si veda fig.2).Guardando questi dati sorgono spontanee due considerazioni: innanzitutto ci si potrebbe domandarecome mai l'Africa, le cui riserve hanno un peso modesto a livello mondiale, si posizioni al secondoposto per durata dei propri giacimenti e come mai gli Stati Uniti, che a livello di riserve sono messidecisamente meglio dell'Europa, occupino invece l'ultima posizione. Quello che fa la differenzaovviamente è il diverso andamento della produzione. In base ai dati BP gli Stati Uniti sono il primoproduttore al mondo di gas con 728,3 Gmc prodotti nel 2014 (il 21,4 % della produzione totale alivello globale) mentre i giacimenti africani sono decisamente poco sfruttati, ammontando laproduzione totale di gas in Africa a 202,6 Gmc (5,8%). Dai paesi dell'ex Unione Sovietica sono statiprodotti 760,3 Gmc (21,9%), da quelli del Medio Oriente 601,0 Gmc (17,3%), da quelli del Sud-EstAsiatico 531,2 Gmc (15,3%), da quelli europei 241,1 Gmc (6,9%) e infine quelli del Sud America175,0 Gmc (5,0%)28.L'ultimo dato necessario per avere un quadro completo sull'andamento del mercato del gas è quellorelativo al consumo. Al giorno d'oggi la domanda di gas naturale sta rapidamente aumentando inmolti Paesi in via di sviluppo, tuttavia il consumo è ancora relativamente concentrato nei Paesiindustrializzati: Stati Uniti (nel 2014 il primo consumatore in assoluto con 759,4 Gmc, il 22,7% delconsumo globale di gas), Unione Europea (386,9 Gmc/11,4%), Federazione Russa (secondoconsumatore al mondo con 409,2 Gmc, ossia il 12,0% del consumo globale) e Giappone (quinto con112,5 Gmc/3,3%) formano da soli circa metà della domanda globale (49,4%). Assolutamente dirilievo, anche per la crescita esponenziale che ha avuto negli ultimi anni (un aumento del 7,7%
26 I primi dieci paesi al mondo per quantità di riserve sono in ordine decrescente: Iran (34,0 Tmc/18,2%), Russia (32,6Tmc/17,4%), Qatar (24,5 Tmc/13,1%), Turkmenistan (17,5 Tmc/9,3%), Stati Uniti (9,8 Tmc/5,2%), Arabia Saudita (8,2Tmc/4,4%), Emirati Arabi Uniti (6,1 Tmc/3,3%), Venezuela (5,6 Tmc/3,0%), Nigeria (5,1 Tmc/2,7%) e Algeria (4,5 Tmc/2,4%).
27 A livello di Paesi produttori quelli che fanno meglio sono l'Iran (211 anni), il Qatar (146), l'Arabia Saudita (102), la Russia (75),l'Algeria (55), l'Indonesia (35), la Cina (29), la Norvegia (25), gli Stati Uniti (14) e il Canada (12).
28 Gli altri principali produttori di gas dopo gli Stati Uniti sono: la Russia (578,7 Gmc/16,7%), il Qatar (177,2 Gmc/5,1%), l'Iran(172,6 Gmc/5,0%), il Canada (162,0 Gmc/4,7%), la Cina (134,5 Gmc/3,9%), la Norvegia (108,8 Gmc/3,1%), l'Arabia Saudita(108,2 Gmc/3,1%), l'Algeria (83,3 Gmc/2,4%) e l'Indonesia (73,4/2,1%).
15
rispetto al 2013), è il consumo della Cina, che con 185,5 Gmc (5,4%) è diventato il terzo maggiorconsumatore di gas. Tra i primi dieci consumatori mondiali figurano anche due importanti Paesiproduttori, oltre alla Russia: l'Iran (quarto con 170,2 Gmc/5,0%) e l'Arabia Saudita (sesta con 108,2Gmc/3,2%). I principali mercati europei, Germania (ottava con 70,9 Gmc/ 2%), Gran Bretagna(decima con 66,7 Gmc/ 2,0%) e Italia (undicesima con 56,8 Gmc/ 1,7%), sono ancora nelle primeposizioni ma sono destinati ad essere scalzati dai Paesi emergenti. Secondo le previsioni, per il 2020i consumi mondiali passeranno dagli attuali 3460,6 Gmc a oltre 3600 Gmc, con circa un quarto deinuovi consumi generato dalla sola Cina. Che conclusioni possiamo trarre da questi dati? E' lampante che le riserve di gas dei Paesioccidentali si stanno rapidamente esaurendo, a causa sia della scarsità delle riserve (l'aspettopreponderante nel caso europeo) sia dell'enorme sfruttamento a cui sono sottoposte (evidentesoprattutto nel caso americano). Man mano che le poche riserve dei grandi Paesi industrializzati siridurranno, questi dovranno fare ricorso in misura crescente ai Paesi del Medio Oriente e a quellidell'ex URSS, in cui esistono ancora abbondanti giacimenti da sfruttare. Inoltre si prevede che entroil 2020 il consumo di gas dell'UE dvrebbe aumentare fino a raggiungere la soglia di 510 Gmc perl'effetto combinato della sostituzione di altre fonti energetiche e della ripresa economica. Per questimotivi quindi è inevitabile che, nel prossimo futuro, l'UE aumenti sensibilmente il proprio grado didipendenza dalle importazioni di gas (si stima un aumento delle importazioni compreso tra 50 e 70Gmc entro il 202029) e con esso anche la propria esposizione verso potenziali minacce per lasicurezza energetica. Le aree geografiche verso le quali è plausibile che si orienti l'aumentatadomanda di gas europea infatti vivono rilevanti problemi di stabilità, essendo il Medio Orienteattraversato dalla minaccia dell'Isis e in generale del terrorismo islamico e l'ex URSS attraversata davecchie e nuove tensioni legate alla “dinamica” politica estera russa. Interessanti sono anche lepotenzialità dell'Algeria che ha abbastanza riserve da giustificare un'espansione della produzione edella Nigeria, che ha addirittura maggiori riserve dell'Algeria a fronte di una produzione del tuttomarginale. Ma anche in questo caso sorgono notevoli problematiche circa la stabilità di tali Paesi(l'Algeria, a differenza della vicina Tunisia, fino ad ora non ha dovuto fronteggiare grandi minacceal proprio ordine interno ma rimane in una zona, il Nord Africa, altamente instabile e che stavivendo l'offensiva del terrorismo islamico; terrorismo islamico che invece ha precipitato nel caosla Nigeria, una parte della quale oggi è controllata dai jihadisti di Boko Haram).L'ultimo motivo che rende il gas particolarmente importante per la sicurezza energetica è il modo incui avviene l'approvvigionamento. I dati della BP ci mostrano che nel 2014 il 66,6% dei commerciinternazionali di gas è avvenuto tramite gasdotto contro il 33,4 via GNL. Questo aspetto haconseguenze importanti perchè i gasdotti sono infrastrutture che richiedono enormi investimenti ecomportano quindi tempi lunghi di sfruttamento per essere economicamente vantaggiose. Uno deglieffetti dei commerci via gasdotto è quindi quello di vincolare strettamente e per un periodo di tempopiuttosto lungo il Paese produttore e il Paese consumatore. Inoltre l'utilizzo dei gasdotti restringe dimolto le opzioni che i consumatori hanno in merito alla scelta dei fornitori in quanto si stima che iltrasporto via gasdotto sia conveniente fino a circa 6000km in condizioni normali, 4000 km in casodi tubi posati sul fondo del mare e 2000km in caso di acque profonde.Il ricorso al GNL risolve questi problemi e garantisce ai Paesi consumatori una maggiore libertà discelta e un minor grado di dipendenza dai produttori in quanto virtualmente il gas proveniente daqualsiasi centro di liquefazione può essere trasformato in qualsiasi centro di rigassificazione equindi immesso sulla rete nazionale. Tuttavia allo stato attuale il gas liquefatto è poco utilizzatoperché le infrastrutture di rigassificazione sono particolarmente costose da costruire e manutenere eperché il procedimento necessario per riportare il GNL allo stato gassoso genera una significativaperdita di gas, pari ad una quota compresa tra il 10 e il 24% del volume trasportato, contro meno del5% nel caso dei gasdotti30.
29 Cfr M.Verda, Una politica a tutto gas, op. cit, pp 112-113.30 Ivi, p. 36.
16
Il relativo scarso successo del commercio via mare è da ricercarsi anche nel fatto che non tutti iPaesi reputano la differenziazione dei fornitori una strategia utile per la propria sicurezzaenergetica. Alcuni Paesi ritengono al contrario che la creazione di una condizione diinterdipendenza tra consumatore e produttore sia uno strumento più efficace della differenziazioneper garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e tendono quindi ad aumentareesponenzialmente gli scambi commerciali con un fornitore privilegiato ricorrendo ad ampiinvestimenti in gasdotti.
4. Le direttrici dell'approvvigionamento in Europa
In base ai dati della BP nel 2014 i Paesi europei hanno importato complessivamente 361,9 Gmc digas via gasdotto e 52,1 Gmc di GNL lungo tre direttrici principali, Sud (Nord Africa), Est (exUnione Sovietica) e Nord (Mare del Nord), a cui si sommano le importazioni via GNL da Paesiremoti, come Qatar, Trinidad & Tobago, Nigeria e Perù, che rivestono tuttavia un ruolo marginale(34,1 Gmc complessivamente, l'8,2 % delle importazioni totali, si veda fig 3).La direttrice Sud è quella che ha fornito ai Paesi europei meno gas rispetto alle altre (40 Gmc traimportazioni via gasdotto e GNL, il 9,6% delle importazioni totali di gas). Essa è composta daquattro gasdotti: il GreenStream con capacità annua di 10 Gmc che collega la Libia all'Italia (nel2014 ha trasportato 6,0 Gmc di gas), il Transmed “Enrico Mattei” con capacità di 30,5 Gmc checollega l'Algeria all'Italia passando per la Tunisia (fortemennte sottoutilizzato, l'Italia ha importatovia Transmed 6,2 Gmc), il Gaz Maghreb Europe (capacità annua 12 Gmc) e il Medgaz (8 Gmc) checollegano l'Algeria alla Spagna, dai quali nel 2014 sono transitati complessivamente 11,1 Gmc. Il corridoio Sud comprende anche i flussi di GNL tra gli impianti di liquefazione in Algeria e irigassificatori italiani (nel 2014 0,1 Gmc), francesi (4,4 Gmc), spagnoli (4,9 Gmc), turchi (4,1Gmc), belga (4,4 Gmc) e britannici (0,5 Gmc). Negli anni precedenti anche dagli impianti diliquefazione libici ed egiziani proveniva una discreta quantità di GNL verso l'Europa e inparticolare verso l'Italia. Le esportazioni di tali Paesi tuttavia sono state recentemente interrotte perl'instabilità della situazione interna nel caso della Libia e per l'aumento della domanda domestica digas nel caso dell'Egitto. La capacità di importazione dal Nord Africa è destinata ad aumentare in futuro in quanto si prevedeche entro il 2020 l'Algeria, spinta anche dall'aumento dei consumi interni, dovrebbe espandere lapropria capacità di produzione a circa 120 Gmc all'anno. Grazie all'attuale sottoutilizzo dei gasdottiche collegano l'Algeria all'Italia e alla Spagna parte della nuova produzione potrebbe essere avviataverso i mercati europei senza bisogno di ulteriori investimenti. Nonostante ciò nel 2003 è statopresentato un ambizioso progetto per la realizzazione del gasdotto GALSI, che dovrebbe collegarel'Algeria all'Italia attraversando la Sardegna. Tale gasdotto, la cui portata dovrebbe essere di 8 Gmcall'anno, sarebbe fondamentale per la metanizzazione della Sardegna, l'unica regione non collegataalla rete nazionale del gas, e per la diversificazione delle rotte di approvvigionamento. Si trattaquindi di un'opera che darebbe un apporto significativo alla sicurezza energetica italiana. Tuttavia,nonostante il finanziamento di 120 milioni di euro da parte della Commissione Europea che haclassificato il progetto tra quelli di interesse comunitario, al giorno d'oggi esso vive una fase distallo. La domanda italiana di gas che stenta a crescere e il fatto che, contemporaneamente a taleprogetto, nel 2008 e nel 2012, sono stati realizzati ampliamenti della capacità utile del Transmed,rendono le prospettive di ricavo del progetto non particolarmente favorevoli. La direttrice Sud è interessata anche da un altro progetto di gasdotto, il Trans Saharan Gas Pipeline,che attraversando Nigeria e Niger dovrebbe giungere in Algeria presso Hassi R'Mel, snodo crucialedal quale partono i tre gasdotti algerini diretti verso l'Europa (fig.4). Lo scopo di questocollegamento sarebbe quello di sfruttare i gasdotti algerini per rifornire il mercato europeo con 30Gmc annui di gas proveniente dagli ingenti giacimenti nigeriani. Tuttavia vi sono non pochi dubbi
17
sull'effettiva realizzabilità di tale opera, sia per la rivalità tra Nigeria e Niger, sia per la situazioneinterna in Nigeria. Vi sono inoltre dubbi sull'affidabilità di una rotta che attraversa una regioneparticolarmente instabile e difficile da controllare. Infine bisogna considerare che la capacitàinutilizzata dei gasdotti algerini può essere pienamente compensata dalla produzione dei giacimentidi Hassi R'Mel, sicuramente meno costosa di un eventuale flusso di gas che proviene da giacimentilontani oltre 4000 Km. Anche nel caso del Trans Saharan quindi non sembrano esserci prospettivedi ricavo sufficienti per la realizzazione dell'opera.La direttrice più importante dal punto di vista quantitativo è quella che proviene da Nord: lamaggior parte delle importazioni di gas in Europa (158,5 Gmc, il 38,3% del totale) proviene daigiacimenti Norvegesi, Olandesi e Britannici nel Mare del Nord.I principali gasdotti del corridoio Nord sono il Langeled Pipeline che trasporta il gas dalla Norvegiaal Regno Unito, gli Europipe I e II che collegano la Norvegia con la Germania, il Zeepipe chemette in collegamento la Norvegia con il Belgio, il Franpipe che collega la Norvegia con la Francia,l'Interconnector che collega la Gran Bretagna al Belgio, il BBL che mette in comunicazione GranBretagna e Paesi Bassi (fig. 5) e il TENP (Trans Europa Naturgas Pipeline) che collega i Paesi Bassialla Svizzera attraversando la Germania e include anche un collegamento con il Belgio dal qualeaffluisce il gas proveniente dalla Norvegia. Il TENP infine si ricongiunge al Transitgas che trasportail gas alla rete nazionale italiana attraversando la Svizzera (fig. 6). Fanno parte di questa direttriceanche gli impianti di liquefazione norvegesi dai quali proviene il GNL diretto soprattutto in Spagna,Turchia e Francia. La direttrice Nord-Sud nel complesso è ben ramificata e fornisce ai paesidell'Europa occidentale una parte indispensabile dei loro consumi di gas; tuttavia è improbabile chein futuro le importazioni da tale corridoio possano aumentare in quanto la produzione norvegese equella olandese dovrebbero stabilizzarsi essendo i giacimenti in una fase matura, mentre laproduzione e le esportazioni britanniche dovrebbero diminuire essendo i giacimenti britannici quellisfruttati più intensamente e per lo più per il consumo interno. La terza direttrice è quella che viene da Est e comprende le importazioni di gas dalla FederazioneRussa (che è il paese dal quale l'Europa importa più gas in assoluto, 147,7 Gmc, il 35,6% delleimportazioni totali) e quelle dall'Azerbaigian (5,3 Gmc diretti verso la Turchia). I gasdotti checompongono il corridoio est sono il Nord Stream che collega la Russia e la Germania attraversandoil Mar Baltico, lo Yamal-Europa (conosciuto anche come “Luci del Nord”) che partendo dallaRussia attraversa la Bielorussia e la Polonia e arriva in Germania, il Bratstvo (fratellanza) e il Soyuz(unione) che partendo dalla Siberia attraversano l'Ucraina per giungere allo snodo di Huzhgorod. Interritorio ucraino il Soyuz subisce una ramificazione che dà vita al Trans-Balkan Pipeline, il qualetrasporta il gas russo in Turchia attraversando Moldavia, Romania e Bulgaria. Ad Huzhgorod igasdotti provenienti dalla Russia confluiscono nel Transgas, il quale trasporta il gas in Germaniaattraversando la Slovacchia e la Repubblica Ceca. A completamento dell'intricata rete di gasdottiche fa perno sull'Ucraina, in territorio slovacco una diramazione del Transgas dà vita al TAG (TransAustria Gas Pipeline) che trasporta il gas russo in Italia attraversando l'Austria (fig. 7). Le infrastruttre che attraversano l'Ucraina sono particolarmente critiche per la sicurezza energeticaeuropea. Dai due storici gasdotti costruiti in epoca sovietica e dal Trans-Balkan passano ogni annocirca 100 Gmc di gas, il 28,7% dei consumi totali dell'Unione Europea. Tale dato, per quantopreoccupante, non riflette la reale dimensione del problema. Mentre i paesi dell'Europa Occidentaleinfatti possono contare su altre direttrici di approvvigionamento, quelli dell'Europa Sud-Orientalehanno una drammatica dipendenza dalle importazioni di gas via Ucraina. I paesi più esposti sonol'Austria, per la quale il gas via Ucraina rappresenta il 55,7% dei consumi totali di gas, laRepubblica Ceca e l'Ungheria con un grado di dipendenza del 69%, la Slovacchia in cui la totalitàdei consumi si basa sul gas proveniente dall'Ucraina, la Grecia (68%) e la Bulgaria (72%); laRomania invece grazie alla produzione interna dipende dalle forniture via Ucraina solo per il 30%dei propri consumi. La scarsa differenziazione dei fornitori che caratterizza tali Paesi è resa ancora più preoccupante
18
alla luce delle controversie tra Ucraina e Russia che in passato, nel 2006 e nel 2009, hanno condottoad una drastica riduzione dei volumi in arrivo in Europa 31. La situazione si è ripresentata il 16giugno 2014, quando Gazprom ha ridotto la quantità di gas veicolata in territorio ucraino per ilmancato versamento di un acconto. Gazprom ha preteso infatti il pagamento anticipato del gasesportato in Ucraina a causa dei mancati pagamenti accumulatisi nel tempo da parte dellacompagnia nazionale energetica ucraina Naftogaz, pari a circa 4 miliardi e mezzo di dollari. Lacontestualità di questa iniziativa con le tensioni diplomatiche tra la Russia e l'Ucraina, appoggiatadall'UE e dagli Stati Uniti, mette in luce il rischio che tali rotte possano essere utilizzate comestrumento per esercitare pressione politica sull'Occidente sia da parte della Russia che dell'Ucraina;è quindi cruciale per l'Unione Europea correre ai ripari ed aumentare la resilienza degli Statimembri orientali a eventuali turbamenti delle forniture provenienti da Est. Pur non appartenendo la Turchia all'Unione Europea, la sua posizione strategica la rende parteintegrante della direttrice di approvvigionamento Est-Ovest. Un'infrastruttra fondamentale per ilPaese della Mezzaluna è il Blue Stream, inaugurato a fine 2005, che trasporta il gas naturale dallaRussia alla Turchia attraversando il Mar Nero. Per quanto riguarda il gas proveniente dai giacimenti del Mar Caspio il gasdotto di riferimento è ilrecente (fine 2006) South Caucasus Pipeline (SCP) che mette in comunicazione i giacimenti di ShahDeniz in Azerbaigian con la Turchia attraversando la Georgia. I Paesi europei guardano da tempo con attenzione alle ingenti riserve di gas dell'area caspica e sudcaucasica32 in quanto tale direttrice potrebbe essere utilizzata per rompere la posizione di monopoliorussa nei rifornimenti dal lato orientale. La crisi ucraina del 2014 e il conseguente raffreddamentodei rapporti tra Russia e Unione Europea hanno dato un'ulteriore spinta alla volontà europea didiminuire la propria dipendenza dalle forniture russe e hanno quindi ridato slancio all'ipotesi di unSouthern Corridor, il concetto su cui si basa la strategia energetica dell'Unione Europea, ovvero uncorridoio che faccia affluire in Europa gas dai giacimenti caspici in modo da diminuire il peso delgas russo. A tal proposito nel 2002 nacque l'idea di un'infrastruttura di trasporto, ribattezzata Nabucco, cheavrebbe dovuto rifornire i Paesi dell'Unione Europea con 30 Gmc di gas all'anno proveniente daigiacimenti di quest'area. Tale gasdotto avrebbe avuto una lunghezza di 3300 km e avrebbe collegatol' Hub di Erzurum in Turchia con quello di Baumgarten in Austria attraversando Bulgaria, Romaniae Ungheria. Ad Erzurum il gas sarebbe affluito dai giacimenti azeri, kazaki e turkmeni del MarCaspio e da quelli dell'Iran e dell'Iraq settentrionale (fig. 8). Tuttavia, nonostante un finanziamentodi 200 milioni di euro da parte della Commissione Europea che ha sempre sostenuto con forza ilprogetto, esso è stato definitivamente accantonato nel 2013. I motivi che hanno reso impossibile realizzare il Nabucco sono collegati all'eccessiva onerosità delprogetto (il costo ufficiale era di 8 miliardi di euro ma si stima che il costo reale sarebbe stato circail doppio) e alla difficoltà nel garantire adeguati approvvigionamenti di gas. Gli unici giacimentifacilmente accessibili infatti sono quelli azeri, che tuttavia non sarebbero sufficienti a garantirel'afflusso di gas previsto potendo arrivare al massimo a 20 Gmc annui. Per raggiungere i giacimentiKazaki e Turkmeni bisognerebbe far passare delle condutture sul fondo del Mar Caspio, il cui statuslegale è incerto e rende problematica la costruzione di tali infrastrutture33. Per quanto riguarda l'Iran
31 Si veda nota 11.32 In ques'area i giacimenti si trovano sul fondale del Mar Caspio e sono quindi di competenza dei cinque Stati rivieraschi (Russia,
Kazakistan, Azerbaigian, Turkmenistan e Iran), oltre che nel territorio dell'Uzbekistan, dell' Iran e dell'Iraq settentrionale.33 Gli Stati rivieraschi sono divisi sul regime giuridico con cui regolare lo status del Mar Caspio e sull'esatta collocazione dei
confini tra ciascun Paese, in base alla quale stabilire la titolarità delle risorse presenti sul fondo del mare. Tuttavia nel settembre2014, al summit di Astrakhan, i Paesi interessati hanno concordato una dichiarazione politica nella quale sono stati posti iprincipi fondamentali che dovranno ispirare una futura Convenzione sullo Status del Mar Caspio. La dichiarazione ricalcasostanzialmente la proposta fatta dalla Russia, in base alla quale le acque territoriali di ogni Paese dovrebbero estendersi per 15miglia nautiche oltre la costa e la zona di pesca esclusiva per 25 miglia. Secondo questo sistema il centro del mare rimarrebbeuna zona comune, dove ogni progetto avrebbe bisogno dell’approvazione di tutti e cinque gli Stati. In questo modo la Russiaavrebbe vita facile a porre il proprio veto su ogni condotta che attraversa il Caspio, in modo da conservare il primato sulleesportazioni di petrolio e gas dall’Asia centrale all’Europa. A proposito di veda C. Carletti, Il regime giuridico del Caspio:
19
e l'Iraq il loro coinvolgimento venne ritenuto inattuabile, nel caso dell'Iran per l'isolamento politicoin cui versava 34 e nel caso dell'Iraq per la situazione di guerra nel Paese, incalzato dall'avanzaredelle milizie dello Stato Islamico. Per fare concorrenza al Nabucco e mantenere il primato della Russia lungo la direttrice Est,Gazprom (coadiuvata dall'ENI) mise a punto un progetto alternativo: il South Stream, con capacitàdi circa 60 Gmc annui, che partendo dalle sponde russe del Mar Nero avrebbe raggiunto l'Austriacorrendo sul fondale marino e attraversando la Bulgaria, la Serbia e l'Ungheria. Inoltre era previstauna diramazione in territorio bulgaro che avrebbe raggiunto l'Italia, attraversando la Grecia e ilMare Adriatico (fig.9). Nel dicembre 2014 tuttavia il presidente russo Vladimir Putin, in occasionedi una visita ufficiale ad Ankara, ha dichiarato che il progetto del South Stream è statodefinitivamente archiviato. All'abbandono del progetto hanno sicuramente contribuito motivazionipolitiche, come l'inasprirsi delle relazioni tra la Russia e l'Unione Europea in seguito all'aggravarsidella crisi ucraina35, tuttavia i principali motivi sono di natura economica: il crollo del prezzo delpetrolio e le sanzioni occidentali che hanno precluso alla Russia i finanziamenti delle bancheinternazionali hanno reso difficile sostenere l'elevato costo del progetto (circa 15 miliardi di euro).L'altro limite del progetto South Stream è la capacità di assorbimento dei mercati finali. Il gasdottoinfatti avrebbe potuto soddisfare da solo la maggior parte della nuova domanda di gas naturale al2020 e sarebbe stato quindi economicamente conveniente solo in assenza di altri progetti, piùpiccoli e con possibilità di essere finanziati e realizzati in tempi minori, quali il raddoppio delNordstream ad opera della stessa Gazprom che dovrebbe far aumentare l'offerta di gas russo suimercati europei di altri 25 Gmc all'anno entro il 2019, e soprattutto i gasdotti TAP e TANAP. Dopo l'abbandono del Nabucco, la realizzazione del Southern Gas Corridor ha preso la forma di unprogetto meno faraonico ma più facilmente realizzabile; tale progetto si divide in tre parti: la primafase prevede un aumento della portata dei giacimenti di Shah Deniz e del gasdotto SCP; il secondopassaggio è la costruzione del gasdotto TANAP (Trans Anatolian Natural Gas Pipeline) che parte daErzurum, Hub turco in cui termina il SCP, e arriva alla città greca di Kipoi, in prossimità del confinetra Turchia e Grecia, attraversando tutta la Penisola Anatolica in lunghezza e lo Stretto deiDardanelli; il TAP (Trans Adriatic Pipeline) è il tassello finale: esso parte da Kipoi e attraversandola Grecia, l'Albania e il Canale d'Otranto giunge in Italia entrando nella rete nazionale in prossimitàdel comune salentino di Melendugno (fig. 10). Si prevede che il TAP, il quale farà affluire versol'Italia un volume di 10 Gmc di gas all'anno, entrerà in funzione nel 2019.Per quanto riguarda il GNL, come abbiamo detto all'inizio del capitolo le importazioni europee digas via metaniera ammontano a 52,1 Gmc, ovvero il 12,5% delle importazioni totali. La maggiorparte dei flussi di GNL proviene da Paesi remoti come Qatar, Trinidad & Tobago, Nigeria e Perù,(34,1 Gmc complessivamente, l'8,2 % delle importazioni totali di gas). Il resto viene fornitodall'Algeria e dalla Norvegia. I paesi con la maggior capacità di rigassificazione sono la Spagna con65 Gmc all'anno (che però produce solo 10 Gmc), il Regno Unito con 55 Gmc (11 Gmc), la Franciacon 25 Gmc (7 Gmc) e l'Italia con 16 Gmc (5 Gmc). Nel complesso il volume di GNL importato
implicazioni per la sicurezza regionale, in M. Valigi, Il Caspio. Sicurezza, conflitti e risorse energetiche, Editori Laterza, Bari,2014.
34 Attualmente tale condizione sembra essere vicina a mutare. La necessità dell'UE di diversificare i fornitori lungo la direttrice Estin seguito alla crescente tensione tra l'Occidente e la Russia, l'accordo tra Stati Uniti e Iran in merito al programma nucleareiraniano e il ruolo che il Paese potrebbe giocare nel contrasto allo Stato Islamico lo rendono un potenziale interlocutoredell'Occidente nei prossimi anni.
35 La Russia, stando alle parole dello stesso Putin, punterà sempre più sulla collaborazione con nuovi partner commerciali come laTurchia e la Cina. Tuttavia sembra difficile che Gazprom rinunci facilmente al suo principale cliente (secondo i dati BP nel 2014le esportazioni verso l'UE hanno coperto il 59% delle esportazioni totali di gas dalla Russia). Non è da escludere quindi chel'avvicinamento tra Mosca e Ankara possa essere strumentale a rendere la Turchia un Paese di transito per le forniture russerivolte verso l'Europa. A conferma di questa tesi vi sarebbero le parole del presidente Putin, che nella stessa occasione halanciato la proposta di una collaborazione tra Russia e Turchia per la realizzazione del Turkish Stream, un gasdotto cheattraversando il Mar Nero giunga in territorio turco presso la Tracia Orientale e di qui attraversando la Grecia giunga in Europa(fig.12). A ben guardare con questo progetto (ancora allo stato embrionale) la Russia, piuttosto che abbandonare il campoeuropeo, dimostra di voler rilanciare il proprio intento di fare concorrenza al gas azero per le forniture del corridoio meridionale.
20
nell'Unione Europea è un quarto di quanto le infrastrutture già esistenti consentirebbero. Talesottoutilizzazione è da ricondurre in larga parte alle caratteristiche dei contratti di fornitura via tubo,nello specifico alle cosiddette clausole “take or pay”. In poche parole, i contratti di fornitura vigentiin Europa occidentale impegnano l'acquirente a ritirare un volume minimo annuo, o a pagarlo anchese non ritirato. In questo modo le imprese tendono a saturare il mercato finale con il gas ricevuto viatubo e di conseguenza la domanda di GNL rimane piuttosto bassa. La capacità di rigassificazione non utilizzata (circa 150 Gmc, il 43% dei consumi di gas dell'UE)offre un importante vantaggio in termini di sicurezza energetica. In caso di emergenza infattisarebbe possibile aumentare il tasso di utilizzo degli impianti di rigassificazione per compensare iminori flussi in entrata su un gasdotto. Tuttavia la capacità inutilizzata è un valore aggiunto checaratterizza esclusivamente i Paesi occidentali (a parte quelli citati prima, terminali per la ricezionedel GNL si trovano anche in Portogallo, Paesi Bassi, Belgio e Svezia). Tra i paesi orientali solo laGrecia dispone di una modesta capacità di rigassificazione pari a 6 Gmc annui (fig.11).
5. Prospettive future per un incremento della sicurezza energetica europea
Il problema più stringente per l'Unione Europea è quello di alleviare la dipendenza dei proprimembri orientali e balcanici dalle forniture di gas russo che transitano per l'Ucraina. La crisi ucrainaha evidenziato il rischio che corrono questi Paesi in caso di black out energetico e ha spinto leistituzioni statali e comunitarie a prendere atto della necessità di lavorare su tale situazione. Lavulnerabilità del sistema è imputabile soprattutto alla mancanza di infrastrutture che possano darevita ad una direttrice ovest-est e sud-nord, in modo da favorire il flusso dalle zone occidentali benrifornite ai quadranti orientali. Attualmente infatti tutti i gasdotti che attraversano l'Unione vanno daest (Russia) verso ovest (UE) e da nord (Mare del Nord) verso sud (Fra,Ger,Ita). Al fine di aumentare la sicurezza energetica europea il nostro Paese, grazie alla propria posizionegeografica, riveste un ruolo chiave. La direttrice mediterranea consente all'Italia già allo statoattuale di attivare forniture extra tramite i propri gasdotti e i propri impianti di ricezione di GNL.Tali caratteristiche ci connotano come un potenziale mercato di transito sud-nord, come confermanoi programmi di reverse flow, ovvero di inversione dei flussi, in atto sui gasdotti Transitgas, TENP eTAG36. La direttrice sud-nord potrebbe essere poi ulteriormente rafforzata dal GALSI, cheaumenterebbe il peso dell'Italia dotandola di ulteriori volumi di gas da riversare sul mercatocomunitario. La realizzazione di questo progetto tuttavia non sembra essere possibile nel breve-medio periodo, sia perché la capacità di trasporto tra l'Italia e gli altri Paesi europei non è ancorastata realizzata, sia perché non si prevede che nel breve periodo la domanda di gas aumenti al puntoda rendere conveniente la costruzione di tale opera. L'economia italiana infatti non riuscirebbe dasola a generare un livello di domanda tale da giustificare la costruzione di un ulteriore gasdotto(ricordiamo che quattro quinti della capacità del Transmed è inutilizzata e che dovrebbe essere inarrivo il TAP) e al contempo gli Stati dell'Europa orientale sono legati alle forniture russe concontratti di lungo periodo. Infine bisogna considerare che l'Algeria sta vivendo una fase diincremento della domanda interna di gas e si prevede che entro il 2020 i consumi domesticiaumenterebbero al punto che la quantità di gas destinato all'esportazione potrebbe essere inferiorealle aspettative europee. La diminuzione del gas algerino potrebbe essere compensata dal gasnigeriano proveniente dal Trans Saharan, ma non è opportuno fare troppo affidamento su diun'opera la cui realizzazione sembra più che mai difficile e in ogni caso lontana nel tempo. Una strategia volta a valorizzare il ruolo dell'Italia e a renderla il fulcro delle forniture provenientidall'Africa potrebbe fornire un notevole apporto alla sicurezza energetica europea, tuttavia bisognaessere consapevoli che questa da sola non basterebbe a garantire margini di sicurezza sufficienti. In
36 Cfr. M. Paolini, Nella guerra del gas Mosca riparte da Ankara, Limes. Rivista italiana di geopolitica, La Russia in guerra, 12/2014, pp. 181-190.
21
caso di blocco delle forniture russe via Ucraina, l'Italia sarebbe in grado di compensare i flussimancanti in quanto potenzialmente connessa ad altre fonti di approvvigionamento; tuttaviadiventerebbe a sua volta un Paese vulnerabile per il venir meno di una direttrice diapprovvigionamento fondamentale. L'Europa non può quindi prescindere dalle forniture russe viaNord Stream e Yamal, le quali, grazie al gasdotto Opal, possono confluire dalla Germania allaRepubblica Ceca e di qui, grazie alla capacità del Transgas di operare in reverse flow, confluireverso la Slovacchia e lo snodo austriaco di Baumgarten, dal quale parte il TAG. Tuttavia il flusso dal gasdotto Opal è attualmente bloccato a causa di una controversia tra Gazprome l'Unione Europea. L'Opal infatti è stato realizzato grazie ad una collaborazione tra la compagniaenergetica russa e la tedesca Wintershall, tra le quali sono divise al 50% anche le quote della societàche gestisce il gasdotto. Tuttavia Gazprom è anche il produttore del gas che circola attraverso l'Opale quindi è incappata nelle restrizioni del Terzo Pacchetto Energia. Quest' ultimo è un insieme dinorme che si compone di tre regolamenti e due direttive emanate nel 2009 e volte alla realizzazionein ambito europeo di un mercato dell'energia integrato e concorrenziale. Tali norme stabiliscono pergli Stati membri l'obbligo di affidare le tre fasi della filiera, ovvero la produzione, il trasporto e lafornitura, ad aziende diverse. In base alla legislazione europea quindi Gazprom, che come abbiamodetto gestisce sia la produzione che il trasporto del gas, dovrebbe cedere le sue quote della OpalGastransport GmbH & Co. Kg. In risposta alle pretese dell'UE il ministro dell'energia russoAlexander Novak ha affermato che la legislazione comunitaria non può imporre a Gazprom lacessione delle quote societarie e ha annunciato di aver avviato la procedura per rimettere lacontroversia alla World Trade Organization. Per fare pressione su Mosca quindi l'Unione Europeaha bloccato il gasdotto adducendo a motivo di questa scelta non meglio precisati “problemi tecnici”.Ma in caso di emergenza Bruxelles è tenuta a dare la priorità al transito via Opal dei rifornimentiper i Paesi orientali ed è quindi fondamentale ristabilire al più presto la circolazione da tale gasdottoin modo che, se necessario, il gas possa raggiungere in poco tempo l'Europa orientale e meridionale.Per quanto riguarda la direttrice di approvvigionamento da Est, l'Europa, anche grazie alla pressioniche provengono dall'altra sponda dell'Atlantico, continua a sostenere la strategia delladifferenziazione dei fornitori e a concepire la dipendenza dal gas russo come una debolezza a cuiporre rimedio. Per quanto tale visione sia assolutamente corretta bisogna evitare che questa strategiaporti ad una radicalizzazione della contrapposizione tra Russia e UE. Per quanto l'esposizione versoil gas russo possa essere ridimensionata (ed è effettivamente necessario che ciò avvenga) la Russianon può che rimanere un fornitore indispensabile per i Paesi europei, ed è quindi auspicabile che sigiunga presto ad un riavvicinamento tra le due parti in merito alla questione principale che ledivide, ovvero la crisi ucraina. Ma ancor più importante è evitare di incorrere in nuovi episodi che possano alimentareulteriormente la tensione tra est e ovest. Il riferimento in questo caso è alla Bielorussia. Ritengo che la situazione di questo Paese sia particolarmente delicata e che l'Ue debba guardarsibene dal favorire che a Minsk possa ripetersi qualcosa di analogo a quanto accaduto a Kiev. Alcunielementi portano a pensare che una destabilizzazione del Paese non sia un'ipotesi così remota: laBielorussia è infatti guidata da 21 anni in maniera dittatoriale da Alexander Lukashenko e l'UnioneEuropea ha più volte criticato i brogli elettorali e le violazioni dei diritti politici e civilicontinuamente perpetrate non solo nei confronti dell'opposizione ma anche nei confronti dellaminoranza polacca. Nonostante la repressione del regime, nel Paese è presente una cospicuaopposizione democratica filo-occidentale sostenuta a livello politico da alcuni Stati europei, primafra tutti la Polonia. Il malcontento della popolazione Bielorussa potrebbe venire fomentato in futuroanche da un probabile andamento non favorevole dell'economia. Il debito pubblico negli ultimi anniè aumentato così come il deficit della bilancia commerciale che ha raggiunto i 369 miliardi didollari; è probabile quindi che in futuro il governo metta in atto misure economiche restrittive voltea favorire un riequilibrio dei conti pubblici. Inoltre la Bielorussia eredita dalla tradizione Sovieticauna forte ingerenza dello Stato nell'economia che grava sulla competitività dei principali settori
22
produttivi. Non è quindi da escludere che, sull'onda dello scontento per la situazone politica edeconomica del Paese, possano verificarsi proteste di piazza volte a sovvertire il regime e adinstaurare un governo filo-occidentale, ricalcando quanto accaduto in Ucraina con l'Euromaidan. Un'ipotesi del genere è quanto mai rischiosa per l'Unione Europea, alla luce del fatto che laBielorussia è, insieme al Kazakistan e alla Russia, uno dei tre Paesi fondatori dell'UnioneEconomica Eurasiatica, un progetto politico ispirato al processo di integrazione europeo e mirante acreare un'alternativa all'UE che abbia come baricentro la Federazione Russa37. A sottolineare che ilrischio è concreto c'è il legame tra lo scoppio delle proteste in Ucraina e il progetto di cooperazioneeconomica fortemente voluto da Putin: la situazione ha cominciato a deteriorarsi quando l'expresidente ucraino Yanukovich ha rifiutato le proposte di associazione all'Unione Europea e halasciato intendere che il Paese avrebbe fatto parte dell'altra unione, quella sponsorizzata dallaRussia. Se dopo l'Ucraina anche la Bielorussia si sottraesse alla sfera di influenza russa attratta dal“richiamo dell'Ovest” la risposta della Russia non si farebbe di certo attendere; tale eventualitàavrebbe gravissime ripercussioni sulla nostra sicurezza energetica sia perché potrebbe fardeteriorare irrimmediabilmente i rapporti tra Russia e UE sia perché estenderebbe lo stato diincertezza che caratterizza le forniture via Ucraina anche al gas trasportato dallo Yamal. Unasituazione che l'Europa difficilmente riuscirebbe a gestire. Dove invece l'Unione dovrebbe osare maggiormente, a mio avviso, è sul corridoio meridionale.Grazie al teatro caspico l'Ue ha la possibilità di aumentare drasticamente la propria sicurezzaenergetica in quanto potrebbe sfruttare tale direttrice per diminuire la dipendenza dei Paesi orientalidal gas russo. Ad oggi l'unico progetto che non è rimasto solo sulla carta è il TAP-TANAP, il qualetuttavia deve affrontare una serie di criticità: innanzitutto la portata di gas che può provenire dai soligiacimenti in Azerbaigian non è sufficiente a soddisfare completamente le esigenze europee (20Gmc all'anno, bastano a malapena per Turchia, Grecia e Italia), in secondo luogo non sonoattualmente previste diramazioni che portino il gas verso nord andando ad emulare quello che era ilprogetto del Nabucco. Allo stato attuale quindi il progetto del Southern Corridor gioverebbeesclusivamente alla Grecia e all'Italia e non comporterebbe nessun passo in avanti nellarealizzazione di capacità di trasporto sud-nord. Infine il progetto deve affrontare la concorrenzadella Federazione Russa che non ha intenzione di rimanere a guardare mentre l'Europa cerca diintaccare la propria posizione di fornitore dominanate ad est. Tale concorrenza ha preso la formaprima del South Stream e ora del Turkish Stream38 (fig.12). La Russia sembra puntare sempre piùsul malcontento verso l'Unione Europea di Grecia (per come viene gestita la crisi del debitopubblico) e Turchia (a causa dello stop dato al processo di adesione turca all'UE) per convincere taliPaesi ad abbandonare il progetto TAP-TANAP in favore dell'alternativa russa. Il governo di Atene,per fare pressione sull'Europa, ha già fatto intendere che un'uscita della Grecia dall'eurozonapotrebbe comportare un suo avvicinamento a Mosca, siglando di recente l'intesa preliminare con laRussia per il passaggio del Turkish Stream sul territorio greco. Per quanto riguarda la Turchia, gli obbiettivi della sua politica estera sono tradizionalmente quellodi far acquisire al Paese il ruolo di leader della regione e di principale snodo energetico eurasiatico. I recenti negoziati tra l'Iran e i cinque membri permanenti del consiglio di sicurezza dell'ONU più laGermania che hanno portato ad un accordo sul programma nucleare iraniano potrebbero averegrandi ripercussioni sulle relazioni russo-turche. Di fronte ad un Iran in rinascita e meno isolato,entrambi i Paesi potrebbero impegnarsi per difendere i propri interessi geopolitici e limitare quindil'influenza di Teheran sul Caucaso. Oltre che alla conservazione della propria influenza regionale, ilriavvicinamento tra Mosca e Ankara sarebbe strumentale anche a realizzare il secondo obbiettivoturco, ovvero quello di rendere la Penisola Anatolica il principale hub di riferimento per i flussi di
37 Si veda C.Tosi, La guerra in Ucraina rilancia la neutrale Bielorussia. Limes. Rivista italiana di geopolitica http://www.limesonline.com/rubrica/la-guerra-in-ucraina-rilancia-la-neutrale-bielorussia; M. De Bonis, Con Unione Eurasiatica e Cina, Putin volta le spalle all'Europa, ivi http://www.limesonline.com/rubrica/unione-eurasiatica-e-accordo-con-la-cina-persa-lucraina-putin-guarda-a-est.
38 Si veda nota 35.
23
gas diretti verso l'Europa. Il progetto europeo di fare affidamento sul gas azero infatti nongarantirebbe alla Turchia il ruolo a cui aspira; al contrario la proposta di Putin di un raddoppio delBlue Stream e della costruzione di un gasdotto da 47 Gmc annui come il Turkish Stream èdecisamente più allettante per il presidente turco Erdogan. In realtà se Grecia e Turchia cedessero al fascino della proposta russa a giovarne sarebbeesclusivamente Mosca, che conserverebbe il proprio ruolo di monopolista nelle forniture da est.L'Unione Europea e la Turchia hanno infatti lo stesso problema, quello di un'eccessiva dipendenzadal gas russo, che in questo caso verrebbe ulteriormente incrementata. Gli interessi di Bruxelles equelli di Ankara in campo energetico sono quindi convergenti.La carta vincente dell'Unione Europea potrebbe essere quella di favorire una collaborazione incampo energetico tra Iran e Turchia. A questo scopo sarebbe necessaria la definizione di un progettopiù vasto di quello attuale che, riprendendo in parte l'idea del Nabucco, includa anche il gasiraniano tra le fonti di approvvigionamento del corridoio meridionale. A guadagnarci sarebberotutti: l'Iran vedrebbe implementato il processo di rottura del proprio isolamento politico edeconomico e il “disgelo” con i Paesi occidentali. Inoltre la realizzazione di un tale progettoimplicherebbe necessariamente il venir meno per Teheran delle restrizioni in campo finanziario, inmodo da rendere disponibile il denaro da investire nel settore energetico. La Turchia riuscirebbe nel proprio intento di diversificare le fonti di approvvigionamento ediminuire la propria dipendenza dalla Russia, diventerebbe finalmente un punto nevralgico per iflussi energetici diretti verso l'Europa e assumerebbe un ruolo strategico negli equilibri Est-Ovest.Inoltre un avvicinamento politico tra Iran e Turchia potrebbe permettere ad Ankara di “teneresott'occhio” la politica estera iraniana nella regione da una posizione di alleato piuttosto che diconcorrente.L'Unione Europea infine riuscirebbe a ridimensionare il ruolo politico ed energetico della Russiasenza esasperare i rapporti con quest'ultima e potrebbe fare affidamento su un fornitore conun'enorme disponibilità di gas che, con i dovuti investimenti, potrebbe essere indirizzato verso l'areabalcanica e centro-orientale, costituendo per tali Paesi una vera e propria “manna dal cielo”. Infineun'apertura europea all'Iran dal punto di vista energetico potrebbe essere il presupposto per unaumento dei commerci e degli investimenti tra le due aree.Per quanto riguarda la direttrice sud l'Europa deve impegnarsi maggiormente nel compito gravosodi garantire la stabilità dei Paesi nord-africani. Nello specifico si tratta di riuscire a trovare uncompromesso tra i due schieramenti contrapposti in Libia per la creazione di un governo di unitànazionale. Questo è un presupposto fondamentale per contrastare in maniera efficace le miliziejihadiste affiliate al Daesh che in Libia controllano parte del territorio e trovano terreno fertile peraddestrarsi e per preparare attacchi contro gli Stati vicini, come dimostrano i recenti attentatiterroristici in Tunisia ed Egitto. Mantenere sotto controllo la situazione in Libia è fondamentale nonsolo per le esportazioni di gas che provengono da quest'ultima, ma anche per la stabilità di Tunisia eAlgeria, Paesi strategici per la sicurezza energetica europea. L'Europa dovrebbe rendersi conto del fatto che la risoluzione dei problemi provenienti dal NordAfrica, siano essi l'immigrazione, il terrorismo o le interruzioni nei flussi energetici, non può esserelasciata agli Stati direttamente coinvolti ma deve assumere la forma di un impegno di naturacomunitaria. Non si tratta solamente dello scarso contributo che fin'ora l'UE ha dato a Italia e Grecianella gestione dell'emergenza immigrazione ma in generale della mancanza di una risposta comunealle minacce che provengono da sud, anche in campo energetico (è emblematico che i mancati flussidi gas dalla Libia all'Italia sono stati compensati con un aumento delle importazioni dalla Russia enon tramite trasferimenti intra UE). La dipendenza dei Paesi orientali e balcanici dal gas cheattraversa l'Ucraina e l'esposizione di quelli mediterranei nei confronti di un'area di grandeinstabilità non sono problemi che interessano solo i singoli Stati membri bensì si tratti di aspetticritici per la sicurezza energetica dell'intera Unione Europea, e in quanto tali dovrebbero essereaffrontati con maggiore impegno dalle istituzioni comunitarie.
24
Conclusioni
E' importante che l'Unione Europea si doti al più presto di una coerente strategia di politica esterache tenga ben presente tutti gli aspetti della questione energetica prima analizzati. E' mia opinioneche fino ad ora l'Unione abbia agito non considerando le ricadute negative sul versante energeticodella propria azione in politica estera, come dimostra l'aver stretto un'intesa sugli scambicommerciali (il Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, che prevede la creazione di unazona di libero scambio con l'abbattimento progressivo delle barriere doganali) con un Paese comel'Ucraina che da anni stava lavorando per dare vita insieme a Russia, Bielorussia e Kazakistanall'Unione Economica Eurasiatica. Ritengo che se si fosse data più importanza alla sicurezzaenergetica all'interno della Politica Estera e di Sicurezza Comune (e se si fosse dato meno ascolto ai“consigli” che provengono da oltre oceano) la scelta di puntare su un avvicinamento tra UE eUcraina non sarebbe apparsa più così conveniente. Al contrario la creazione di un legameparticolareggiato tra Russia e Ucraina avrebbe probabilmente consentito di superare le controversietra i due Paesi dovute al prezzo e ai mancati pagamenti delle forniture di gas, controversie che nel2006 e nel 2009 hanno provocato notevoli problemi ai membri orientali dell'UE.Altro caso in cui l'Europa (e l'Italia) si è esibita in un “harakiri” dei propri interessi in campoenergetico è stato l'intervento militare in Libia del 2011. In questa occasione l'Unione Europea nonha avuto particolare voce in capitolo, essendo stata costretta ad accettare la decisione del suo alleatostatunitense e di alcuni zelanti Paesi membri come Francia e Gran Bretagna di ricorrereall'intervento armato sotto l'ombrello delle Nazioni Unite per far cadere il regime del colonnelloGheddafi. Se ci si sforza di guardare all'accaduto esclusivamente dal punto di vista della sicurezzaenergetica l'episodio sembra paradossale: i Paesi europei hanno contribuito a minare le basi dellastabilità sul continente nord-africano, un effetto sicuramente non voluto ma facilmente prevedibile,e con esse anche l'affidabilità delle forniture di gas che provengono da quest'area. E' quindi della massima importanza che i policy makers dei singoli Stati e dell'Unione prendano leloro decisioni di politica estera in maniera coordinata e coerente con quelle che sono le esigenze egli interessi europei in materia di approvvigionamenti, cosa che solo l'inserimento della dimensioneenergetica tra le priorità della PESC e la predisosizione di un' articolata strategia d' insieme a livelloeuropeo può rendere possibile. A parte scelte di politica estera poco lungimiranti, la sicurezza energetica in Europa è minata anchedall'inesistenza di un vero mercato unico e integrato dell'energia. I Paesi europei sono caratterizzatida mercati in cui operatori a carattere prevalentemente nazionale gestiscono la produzione,l'importazione e lo stoccaggio dell'energia in modo sostanzialmente autonomo. Come conseguenzadal punto di vista infrastrutturale non esiste una vera e propria rete europea ma singole reti nazionaliscarsamente interconnesse tra loro e messe in comunicazione per lo più tramite i grandi gasdottiinternazionali. La realizzazione di un mercato unico del gas (e dell'energia elettrica) garantirebbeall'Unione un elevato livello di resilienza agli shock che potrebbero verificarsi in una singola zonain quanto sarebbe possibile far affluire in poco tempo gli approvvigionamenti dagli altri Paesi. Iprogrammi di reverse flow attualmente in atto sui principali gasdotti europei sicuramentecontribuiscono a tale obbiettivo tuttavia, oltre a permettere ai gasdotti di trasportare il gas inentrambe le direzioni, è necessario anche agire sulle singole reti nazionali in modo da creare unaserie di interconnessioni capillari con i sistemi di distribuzione dei Paesi vicini.In quest'ottica la politica della Commissione è stata quella di imporre alle imprese integratenazionali che gestivano il settore energetico nei principali Paesi europei39 la separazione delleattività di produzione, trasporto e distribuzione e l'apertura delle reti e dei mercati finali anche aglialtri operatori. Dietro questa scelta vi era la convinzione che l'aver garantito l'accesso alle attività di
39 Ente nazionale idrocarburi (ENI) e Ente nazionale energia elettrica (ENEL) in Italia; Electricitè de France (EdF) e Gas de France(GdF) in Francia; Viag e Rwe in Germania; British Gas, Central Electricity Generation Board e British Petroleum nel RegnoUnito.
25
distribuzione dell'energia anche alle imprese di altri Paesi avrebbe spinto ad una maggioreintegrazione delle infrastrutture di trasporto tra gli Stati. Tuttavia la liberalizzazione del mercato dell'energia non sembra aver dato sufficienti risultati dalpunto di vista dell'integrazione delle reti nazionali. Al contrario essa ha incontrato l'opposizione nonsolo delle imprese interessate ma anche dei rispettivi governi i quali, non a torto, hanno sottolineatocome tale politica indebolisca il potere contrattuale delle imprese nazionali nei confronti deifornitori extra UE. La profonda differenza tra l'assetto del mercato nei Paesi produttori, tipicamentegestiti da un monopolista strettamente controllato dallo Stato, e la presenza di tanti operatori inconcorrenza tra loro sul mercato nazionale potrebbe avere ripercussioni negative sulle condizionieconomiche dei contratti di fornitura ed essere quindi deleteria per la sicurezza energetica europea. L'opposizione degli Stati alle liberalizzazioni è dovuta anche al fatto che in questo modo essiperderebbero un importante margine di influenza sulle decisioni strategiche in campo energetico, ilche non è poco considerando che in tale ambito le scelte commerciali influenzano strettamentequelle politiche e viceversa. L' iniziativa privata senza un adeguato supporto politico rischia diessere controproducente o quanto meno inefficace in un contesto dove i Paesi fornitori consideranoancora le imprese produttrici importanti strumenti al servizio della politica statale. Questa decisioneè evidente soprattutto nel caso di Gazprom, i cui dirigenti preferiscono trattare coi governi nazionalipiuttosto che solo con le imprese private. Attualmente i governi dei Paesi europei non possono più influenzare in maniera diretta le scelte dipolitica energetica tramite le grandi imprese a controllo pubblico; essi possono contare solamente sustrumenti indiretti quali la regolamentazione del mercato e la concessione di sgravi ed incentivi. Talistrumenti tuttavia risultano poco efficaci soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo infrastrutturale,per il quale lo Stato deve limitarsi ad attirare gli investimenti privati. Anche a livello dell'Unione siadottano provvedimenti volti a favorire la realizzazione di opere di interesse comunitario, come ifinanziamenti e l'esenzione temporanea per l'investitore dall'obbligo di concedere l'utilizzodell'infrastruttura ai concorrenti. Questi metodi tuttavia continuano a rivelarsi insufficienti nel garantire la costruzione diinfrastrutture fondamentali per la sicurezza energetica europea, soprattutto quando le condizionieconomiche non sono favorevoli, come dimostrato dal caso del corridoio meridionale per il qualesarebbe necessario un investimento più importante di quello in corso. Tuttavia le variabili economiche attuali, ossia prezzo del gas e livello della domanda, non sono talida giustificare e rendere conveniente agli occhi dei privati un investimeno di tale portata (anzi comeabbiamo visto i progetti riguardanti tale direttrice sono stati via via ridimensionati). Tutto questogioca a sfavore della sicurezza energetica perché, nel momento in cui si presenterà la necessità diuna maggiore quantità di gas proveniente dal Caspio, l'aumento dei flussi sarà reso impossibiledall'inadeguato livello di investimenti affontati in passato.I privati agiscono secondo le logiche del mercato e non si può chiedere loro di rinunciare aconsiderare il ritorno economico immediato dei propri investimenti. Il compito di attuare unapianificazione di lungo periodo delle opere strategiche per il Paese e di realizzarle, anche se questova contro considerazioni strettamente economiche, non può che essere affidato agli Stati, a maggiorragione se si considera che la sicurezza energetica è un bene pubblico al pari della difesa o delmantenimento dell'ordine, mansioni che non possono essere demandate ai privati. Altrettanto nocivo sarebbe affidare la competenza della politica energetica esclusivamente al livellostatale. In tale ambito la sicurezza di un singolo Stato può essere garantita al meglio soloimplementando il livello di resilienza dell'intera Unione. Compito dell'UE deve essere quello diconcertare e coordinare le varie politiche nazionali in modo da renderle compatibili con ilraggiungimento di un elevato grado di sicurezza a livello europeo. E' fondamentale quindi lapredisposizione di una strategia d'insieme e dei mezzi per adeguare le iniziative dei singoli Stati atale strategia, in modo da evitare azioni tra loro contrastanti (come potrebbe essere la costruzione diun gasdotto che rifornisca la Grecia di gas russo mentre i Paesi orientali premono per diminuire il
26
peso delle forniture russe). Bisognerebbe insomma mettere da parte le divergenti posizioni neiconfronti dei fornitori e riuscire a parlare con un'unica voce. La supervisione dell'Unione dovrebbe essere fondamentale non solo nella scelta dei fornitori maanche nello spronare gli Stati ad intraprendere programmi che portino alla progressiva unificazionedelle reti di trasporto intra-Ue e alla diminuzione dell'assorbimento energetico delle principaliattività. Tra le altre cose è fondamentale che l'Unione Europea adotti politiche utili a favorire la ripresaeconomica nei suoi Stati membri. Un'aumentata pressione a livello europeo volta a spronarel'adozione di riforme strutturali negli Stati e l'adozione di criteri di politica fiscale meno lesivi dellacrescita economica sono provvedimenti essenziali anche in campo energetico perché, come si è giàdetto, la garanzia di poter disporre anche in futuro degli approvvigionamenti necessari è datainnanzitutto dal benessere economico. Infine non bisogna dimenticare che la cooperazione in campo energetico è alla base del processo diintegrazione europea, il quale iniziò con l'obbiettivo politico di ridurre il rischio di conflittoattraverso la gestione comune dell'energia (il Trattato di Parigi del 1951 istituì la CECA, Comunitàeuropea del carbone e dell'acciaio, e uno dei Trattati di Roma del 1957 istituì la Comunità europeadell'energia atomica, detta anche Euratom). Nulla ci vieta quindi di sperare che in futuro unmaggiore impegno e una maggiore collaborazione a livello sia statale sia comunitario nelperseguimento della sicurezza energetica europea possa costituire un fattore in grado di darefinalmente il via ad una nuova fase di integrazione politica ed economica.
27
Fig. 10 percorso dei gasdotti TAP, TANAP ed SCP
Fig. 11
Fig. 12 percorso del gasdotto Turkish Stream confrontato con quello del South Stream
32
Bibliografia
- Aron R., Paix et guerre entre le nations, Calmann-Levy, Paris, 2004;- Demurtas A., Galietti F., Marini L., Santangelo S., Schibotto E., Tajani F., Torelli S.M., Italia,potenza globale?, Fuoco Edizioni, Roma, 2012;- Di Nolfo E., Storia delle relazioni internazionali 1918-1999, Laterza, Bari, 2000;- Limes. Rivista italiana di geopolitica, Cina, Russia, Germania unite da Obama, 8/2014;- Limes. Rivista italiana di geopolitica, La Russia in guerra, 12/2014;- Valigi M., Il Caspio. Sicurezza, conflitti e risorse energetiche, Editori Laterza, Bari, 2014;- Verda M., Politica estera e sicurezza energetica. L'esperienza europea, il gas naturale e il ruolodella Russia, Edizioni Epokè, Novi Ligure, 2012;- Verda M., Una politica a tutto gas. Sicurezza energetica europea e relazioni internazionali,Università Bocconi Editore, Milano, 2011;- Weber M., La scienza come professione. La politica come professione, Piccola Biblioteca Einaudi,Torino, 2004.
Sitografia
- Bellomo S., South Stream, Putin mette la parola fine al progetto del gasdotto, Il Sole 24 Ore, http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-12-01/putin-russia-abbandona-progetto-gasdotto-south-stream ; - Bielorussia, Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2015, Ministero degli Affari Esteri, http://www.esteri.it/mae/pdf_paesi/europa/bielorussia.pdf ; - Bilancio Energetico Nazionale 2013, Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/ben/ben_2013.pdf;- Conflicting Greek Gas Policy, Natural Gas Europe, http://www.naturalgaseurope.com/conflicting-greek-gas-policy-24174 ; - Dai Pra A., Il fattore petrolio e la primavera araba, Aspenia online, http://www.aspeninstitute.it/aspenia-online/article/il-fattore-petrolio-e-la-primavera-araba;- Dati statistici sulla produzione di energia elettrica in Italia, Terna, http://www.terna.it/LinkClick.aspx?fileticket=EhuoPsMXv1s%3d&tabid=418&mid=2501;- D'Auria S., Pirateria marittima da Terzo Millennio, GNOSIS. Rivista italiana di intelligence, http://gnosis.aisi.gov.it/gnosis/Rivista33.nsf/ServNavig/33-14.pdf/$File/33-14.pdf?OpenElement; - De Bonis M., Con Unione Eurasiatica e Cina, Putin volta le spalle all’Europa, Limes. Rivista italiana di geopolitica, http://www.limesonline.com/rubrica/unione-eurasiatica-e-accordo-con-la-cina-persa-lucraina-putin-guarda-a-est ; - De Forcade R., Petroliere nel mirino dei pirati, Il Sole 24 Ore, http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2015-01-20/petroliere-mirino-pirati-105509.shtml?uuid=AB2LsngC . - Dominelli C., Eni: nessun impatto dei disordini sulla produzione, Il Sole 24 Ore, http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2015-02-18/eni-nessun-impatto-disordini-produzione-063651.shtml?uuid=ABZG5dwC ; - Dyer G., Giochi petroliferi nel Mar Caspio, Internazionale, http://www.internazionale.it/opinione/gwynne-dyer/2014/11/19/giochi-petroliferi-nel-mar-caspio ;- Evoluzione storica dei prezzi del petrolio, AGI Energia, http://www.agienergia.it/QuotazioniPetrolio1990.aspx; - Hurst C., The militarization of Gazprom, Foreign Military Studies Office, http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/Militarization-of-Gazprom.pdf;
33
- IEA Energy Atlas, http://energyatlas.iea.org/?subject=-1165808390;- Italia: l'importanza geoeconomica e geopolitica del TAP, Geopolitica italiana, https://geopoliticaitaliana.wordpress.com/2013/07/12/italia-limportanza-geoeconomica-e-geopolitica-del-tap/; - La competizione tra Unione europea e Russia nel corridoio sud del gas, Geopolitica italiana, https://geopoliticaitaliana.wordpress.com/2013/06/25/la-competizione-tra-unione-europea-e-russia-nel-corridoio-sud-del-gas/; - La sicurezza energetica nel XXI secolo: prospettive dall'Italia e dal mondo, supplemento al n. 6/2013 di Informazioni della Difesa, http://www.difesa.it/InformazioniDellaDifesa/periodico/periodico_2013/Documents/S6_2013/S6_2013.pdf;- Nazemroaya M. D., Turkey and Iran: the ties that bind, Global Research, http://www.globalresearch.ca/turkey-and-iran-the-ties-that-bond/5365958 ; - Polychroniou C.J., Political fears of a Russia-Greece axis are groundless, Aljazeera, http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/07/political-fears-russia-greece-axis-groundless-150701055745465.html ; - Priority Projects, Gazprom Export, http://www.gazpromexport.ru/en/projects/ ; - Rapoza K., “Yats” Wants EU To Nix Russian Pipeline, Forbes, http://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2014/06/03/yats-wants-eu-to-nix-russian-pipeline/; - Saccone U., Nuovi scenari di sicurezza energetica, Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, http://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2014/09/Nuovi-scenari-sicurezza-energetica-Umberto-Saccone.pdf; - Saul J. e Gloystein H., Gas, Europa pensa a importazioni dall'Iran se saranno eliminate sanzioni, Reuters Italia, http://it.reuters.com/article/idITL6N0RP35Z20140924?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true ; - Southern Gas Corridor, Trans Adriatic Pipeline, http://www.tap-ag.com/the-pipeline/the-big-picture/southern-gas-corridor ; - Stagnaro C., La sicurezza energetica, GNOSIS. Rivista italiana di intelligence, http://gnosis.aisi.gov.it/gnosis/Rivista22.nsf/ServNavig/22; - Statistical Review of World Energy 2015, BP, http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf; - Tosi C., La guerra in Ucraina rilancia la “neutrale” Bielorussia, Limes. Rivista italiana di geopolitica, http://www.limesonline.com/rubrica/la-guerra-in-ucraina-rilancia-la-neutrale-bielorussia ; - Transportation, Gazprom Export, http://www.gazpromexport.ru/en/projects/transportation/ ; - Verda M., Energia e geopolitica. Gli attori e le tendenze del prossimo decennio, ISPI, http://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/ispi_-_energia.pdf; - World Oil and Gas Review 2014, ENI, http://www.eni.com/it_IT/attachments/documentazione/wogr/2014/O-G-2014.pdf; - Yergin D., Ensuring Energy Security, Foreign Affairs, https://www.foreignaffairs.com/articles/2006-03-01/ensuring-energy-security .
Ultimo accesso ai siti internet: 14/07/15.
34