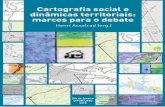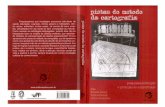Cartografia digitale per la ricerca e la didattica
Transcript of Cartografia digitale per la ricerca e la didattica
13
PREMESSA
Con tutta l’umiltà che la materia trattata reclama, decido di dare alle stampe questa mia fatica, che arricchirà– spero – il già ampio e articolato panorama di manuali di Cartografia, editi per varie destinazioni ed utenze. Inquesto caso, gli immediati destinatari sono gli studenti dei miei corsi universitari ed anche i discenti dei corsi dispecializzazione all’insegnamento, ma oso sperare che anche i docenti delle scuole e gli immancabili ‘amatori’della scienza cartografica si sentano interessati, soprattutto se cultori delle scienze sociali e della storia delterritorio: giacché il presente è soprattutto un corso di Cartografia geografica – relativo a carte antiche e carterecenti e attuali, ma cartografia geografica, ripeto – per umanisti. Ben vengano naturalmente quei lettori dimatrice rigorosamente scientifica che, abbandonando vecchie e razzistiche posizioni di presunta superioritàdelle scienze esatte, notoriamente non meno ‘fallaci’ di quelle umane, sentono l’urgenza della reductio ad unumdella conoscenza e del suo uso non tecnocratico per una sostenibile e integrata pianificazione territoriale.
Preciso subito che concepisco la presente come la prima edizione di un volume in progress, che nelle suc-cessive sarà calibrato in base alla ‘risposta’ degli interlocutori, con affinamenti, aggiunte, decurtazioni, sempli-ficazioni o complessificazioni, a seconda delle esigenze emerse. Quel che mi ha mosso a rompere gli indugi e“uscire in piazza” è stata comunque l’esperienza pluridecennale dell’insegnamento universitario, soprattutto lefrustrazioni del didatta rispetto alla idiosincrasia vieppiù accentuata degli studenti verso i contenuti tecnico-astronomici della Cartografia, benché dal sottoscritto somministrati con ‘piacevolezze’. Di qui l’opportunità dieliminare il “superfluo” dalla materia strettamente “tecnica” e di mostrare perfino l’”utile poesia” di certe carte,il che non significa che il messaggio perda in qualità professionalizzante.
Qui si è scelta una via di mezzo: fermo restando il valore formativo della Cartografia geografica, si sono evitatele superfetazioni retorico-culturali, ridimensionando e semplificando alcuni aspetti geometrico-matematici chesono a monte della carta, come suoi principi costruttivi. Poco, ad esempio, è stato concesso alle malfamate “proie-zioni”, assillo sempiterno delle menti umanistiche, croce dei discenti ma pure di quei docenti non inquinati daquello “spirito persecutorio” che talora spinge al sadismo verso i propri studenti. Lo stesso apparato bibliografico,piuttosto che generale, è legato per la massima parte ai contenuti dei singoli capitoli o paragrafi.
Poiché tuttavia non è possibile sempre scientificamente divulgare con l’eccesso di semplificazione, pena lanullificazione della conoscenza, ho preferito tagliare del tutto alcuni temi classici della manualistica cartografica,approfondendone altri. Parecchio impegno e spazio è stato ad esempio riservato a far comprendere che unacarta geografica non va confusa col territorio, che – a stretto rigore ragionando – muta dopo la rilevazione (percui si potrebbe dire che ogni carta è storica..); che essa non è solo un prodotto tecnico, ma un fatto culturale insenso lato, ossia comunicazionale, sociale, simbologico e simbolico-soggettivo, improntato a valori e finalitàparticolari, anche a palesi e talora nascoste ‘ideologie’. Tanto più se si tratta di carte antiche, la cui varietà (perscala, criteri di redazione, uso o meno della stampa, committenti, finalità, supporti usati, ecc.) e tanta è talenello snodarsi dei millenni, da doversi sempre usare – a mio parere – il plurale, lungi dalla pretesa di potersiadottare un’unica chiave di lettura per tutti i tempi e gli spazi, su presunti “universali unificanti” che invecerendono astratto ogni serio approccio conoscitivo. Bando, dunque, ad ogni discorso sulla carta “in generale”…
Ciò significa – e questo è un secondo aspetto che ho voluto esaltare – che essa va interpretata con intelligen-za e spirito critico, senza prescindere tuttavia da alcune cognizioni tecnico-astronomiche utili a decifrarne lasegnica. Ciò vale soprattutto nell’interpretazione di carte redatte con criteri non empirici, a partire dalla fine delSettecento. Molte pagine, pertanto, sono state dedicate ai criteri interpretativi sia di carte del passato, sia dicarte topografiche più recenti (livello in cui si può leggere meglio il rapporto società-natura e quello orizzontaletra diversi luoghi), ma soprattutto ad alcune esemplificazioni pratiche, nell’uno e nell’altro caso.
14
Si sono così volutamente proposti, oltre ai classici, nuovi modelli di decodifica: commentando il noto Fo-glio Isola d’Ischia-Napoli, ho riportato anche stralci di saggi di altri autori sull’area dei Campi Flegrei, permostrare quale dialettica socio-politica, economica ed ecologico-culturale si animasse sotto i freddi e staticisegni leggibili in carta. In un altro caso, quello della tavoletta Eboli, ho proposto – forse per la prima volta in unmanuale cartografico – una lettura diacronica del territorio, sulla base del confronto tra edizioni di diversaepoca.
Molto più succintamente sono state decifrate altre carte a scala topografica, dell’I.G.M. e non.Sempre poi è stato evidenziato il ruolo documentale e identitario, sia delle confinazioni amministrative, sia
soprattutto – tanto da meritare un lungo e insolito paragrafo – della toponomastica, fuori e dentro le cartegeografiche, dove costituisce quella insostituibile “metà del cielo” purtroppo finora trascurata a favore dell’at-tenzione al solo disegno geometrico-astronomico. Oltre le generali “istruzioni per l’uso” dei nomi di luogo, difatto la loro analisi è in questo libro presente ovunque, sia pur con graduazioni diverse di approfondimento, adimostrazione fattuale – scientifica e didattica – delle concettualizzazioni teoriche e geolinguistiche: chiunquevoglia comprendere seriamente le strutture profonde e stratificate del territorio si convincerà ormai che dellalettura toponimica non potrà fare a meno.
A rinforzare questo tentativo di lettura “diversamente classica”, sono stati illustrati, in apposito paragrafo,anche i formidabili strumenti – nella ricerca e nella didattica – della Cartografia digitale, con esempi di applica-zione dei G.I.S, cui si aggiunge un’altra “novità”, la chiamata in causa della cartografia presente nei mass-media, che nel recuperare gli aspetti “primitivi” e connotativi delle carte pregeodetiche si rivela di forte utilitàsociale e culturale.
Il messaggio euristico centrale derivante dalla impostazione scelta è che non basta la compitazione e lalettura tecnico-formale dei simboli per comprendere a pieno una carta, ma occorre che si risalga alla “filosofia”dell’ente (o persona) che l’ha prodotta, dalla quale discende la selezione dei dati rappresentati (a scapito di altririmasti ignoti) e la “invisibile” realtà, mutevole e dialettica, che sottende alla rappresentazione di quella partedel “visibile” presa in considerazione nel disegno (comunemente detta “paesaggio geografico”). Per afferrarel’“invisibile”, ossia le strutture portanti dei fenomeni fisico-naturali, sociali, economici e culturali nelle lororeciproche relazioni, occorrerà trasformarsi in ricercatori, andando a studiare su tutte le possibili fonti noncartografiche (originarie e bibliografiche) che attengono al territorio raffigurato in carta.
Ergo: la conoscenza rifluita nella carta illuminerà quella derivante da altra documentazione (anche orale)siccome quest’ultima illuminerà la prima. Solo operando “filologicamente” con umiltà secondo tale approcciointerfontuale e interdisciplinare in prospettiva geografica si potrà centrare l’obiettivo di comprendere il funzio-namento della realtà sistemica che struttura in profondità il paesaggio visibile nella sua organicità e spessodisorganicità. Ecco l’ottica tramite cui la carta apparirà non più “dèmone” da esorcizzare, in quanto espressionedel “potere”, ma formidabile strumento – tra altri – di conoscenza e governo del territorio.
L’AUTORE*
* Stante il tutorato scientifico dello scrivente, il sottopar. a1 del par. 2 - cap. II - parte I (Il paesaggio dalle carte riproducenti ilpaesaggio della Certosa di Padula) e il sottopar. b5 (Paesaggi e identità microlocali riflessi o caratterizzati dalle torri costiere) del par.5 - cap. II - parte I, nonché il par. 2 (La cartografia Digitale nella ricerca e nella didattica geocartografica) del cap. II - parte II vannoattribuiti a Silvia Siniscalchi.
Maria Rosaria De Vita e Giovanni Romano sono autori del sottopar. b. (Il paesaggio ‘emanato’ dalle istituzioni politico-amministra-tive) del par. 2 - cap. I - parte I.
Un particolare ringraziamento va alla Dr. Silvia Siniscalchi per la preziosa collaborazione offerta nella strutturazione delpresente volume.
263
Il ricordo dell’insediamento romano o medioevale è assicurato da parecchi toponimi (Quarto, nome di uncomune il cui sito si trovava certamente al quarto miglio di una strada, probabilmente iniziante a Pozzuoli;Stufe di Nerone, tra Baia e Arco Felice; Cast.° di Baia, ecc.) mentre spazio è riservato anche a nuovi qualificatiinsediamenti industriali, oggi purtroppo dismessi (Pirelli S.M.P.), come altri di cui si è già parlato. Dove infinecompare uno spazio bianco, come in prossimità di Bagnoli, il cartografo ha omesso di rappresentare alcunchéper motivi di segretezza militare.
2. La Cartografia Digitale nella ricerca e nella didattica geocartografica
a. I Sistemi Informativi Geografici (G.I.S.) per l’analisi territoriale
a.1. Introduzione
I Sistemi Informativi Geografici – Geographical (o Geographic) Information System (più brevemente: G.I.S.)– sono strumenti della cosiddetta Information Technology, ossia di quella branca della tecnologia specificamen-te dedicata alla gestione e al trattamento dell’informazione (in questo caso geografica). I G.I.S., infatti, sipresentano come programmi particolarmente complessi che consentono di controllare anche dinamicamentetutti i possibili dati attinenti a un determinato contesto ambientale e/o territoriale, misurandone con esattezzageometrica gli elementi, che, opportunamente ‘interrogati’ e interrelati, possono produrre ulteriori conoscenze,ampliando gli ambiti di una ricerca geografica tout court.
Questi programmi (definiti per la prima volta “G.I.S.” negli Stati Uniti alla fine degli anni Cinquanta del secoloscorso), quale risultato dello sviluppo di diverse tecnologie di poi interrelate (tra cui quelle dei Database, deltelerilevamento e della fotointerpretazione), non hanno una data di nascita univoca. Di fatto, i primi G.I.S. vedonola luce tra U.S.A. e Gran Bretagna nel corso degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, grazie all’operato diisolati ricercatori, che con tale termine denotano dei «sistemi per la gestione e controllo dell’uso del suolo ovveroper la razionalizzazione delle reti di trasporto in grandi aree urbane» (Lodovisi-Torresani, 1996, p. 287). Gli studidel settore sarebbero di poi proceduti attraverso l’intreccio di tentativi piuttosto differenti, più o meno riusciti; laloro implementazione è inizialmente sostenuta dall’Esercito, dalla Marina Militare e dalla CIA statunitensi (ascopo di controllo e difesa), nonché da alcune università, anche europee (impegnate già dalla fine degli anniCinquanta nella messa a punto di tecnologie informatiche per la produzione cartografica), e da differenti realtàgovernative (volte a preservare su supporti informatici i dati geografici relativi ai rispettivi paesi).
Questi primi G.I.S., frutto di una tecnologia ancora ‘pionieristica’, possiedono già, tuttavia, i due requisitifondamentali di un Sistema Informativo Geografico: la possibilità di archiviare e trattare dati (1); la disponibilitàdi procedure automatiche di disegno che consentano la sovrapposizione (overlay) di tematismi differenti riguar-danti un’area geografica (2). Dopo gli esperimenti degli anni Settanta, nel corso del decennio successivo sarebbecosì nato un vero e proprio settore industriale dedicato a questi programmi, sino alla loro trasformazione, neglianni Novanta, in un prodotto commerciale, volto a «costituire il propellente di una vera e propria “rivoluzionegeografica”, la più rilevante a partire dal Rinascimento» – secondo alcuni autori – nonché a «offrire alla comunitàdei geografi l’opportunità di assolvere un ruolo preminente in campo scientifico e sociale fornendo le condizioniper ottenere alla geografia il definitivo status di scienza» (Lodovisi-Torresani, 1996, p. 295).
In effetti, da un punto di vista strettamente operativo, i G.I.S. rendono possibile visualizzare differenti stratiinformativi, separati o sovrapposti, consentendo di attuare molto rapidamente, e con estrema precisione, inda-gini geografiche di tipo diacronico, sincronico e tematico (un tempo realizzate attraverso la sovrapposizione dilucidi su carte più o meno “mute” delle aree esaminate), arricchite delle possibili relazioni tra elementi eteroge-nei. I G.I.S., infatti, hanno la specifica peculiarità di consentire l’associazione tra cartografia e informazionidesunte da una o più banche-dati interrelate e costantemente aggiornabili58 . Inoltre, l’agevole modificabilitàdei vari strati informativi – altra caratteristica peculiare dei G.I.S. – permette un veloce aggiornamento delleinformazioni, adeguandole ai mutamenti territoriali. Nella rappresentazione in tempo (quasi) reale di questiultimi, si realizza così il ‘sogno’ (coltivato da generazioni di cartografi e geografi) di modificare in tempo realeuna carta geografica: ogni fattore di variazione territoriale, inserito come elemento informativo ‘spazializzato’nella banca dati collegata a un G.I.S., può essere infatti subito visualizzato cartograficamente. Pertanto, lacomplessità, potenzialmente inesauribile, delle relazioni esistenti tra gli elementi di un contesto territoriale (o
264
ambientale), nonché tra quest’ultimo e altri settori, anche non direttamente geografici, rende i G.I.S. dei potentistrumenti di monitoraggio, attraverso cui ottenere rapidamente una visione sintetico-olistica e, allo stesso tem-po, analitica, di elementi e/o situazioni riferiti a un determinato ambito geografico59 .
Tale circostanza è resa possibile dal fatto che ogni elemento spazialmente identificabile e codificabile, po-tenzialmente interagente con una base cartografica o topologicamente riferita (città, strade, fiumi, monumenti,aree geografiche, ecc.), può essere inserito e rappresentato in un G.I.S., che pertanto si configura come una verae propria «tecnologia digitale integrata per l’archiviazione, l’analisi, l’organizzazione e la comunicazione didati spaziali» (Colella, 2006, p. 10).
58 La spiegazione del singolo significato delle tre parole che compongono l’espressione inglese Geographical Information System(G.I.S.) può forse offrire una chiave di maggiore comprensione dell’argomento; con la prima – «sistema» – ci si riferisce innanzitutto aun «insieme di parti interagenti»; con la seconda – «informazione» – si intende «che le parti interagenti in qualche modo produconoinformazione cioè trattano i dati che, una volta interpretati, arricchiscono la conoscenza su un dato argomento»; infine, con la terza –«geografica» – si «vuol dire che l’informazione può essere riferita al territorio, ovvero è georeferenziata o georeferenziabile». I virgolettatisono tratti da Favretto, 2000, pp. 22-23. A questo stesso autore (2000, pp. 25-28) si rimanda per una breve panoramica storica sui GIS,dagli anni ’70 a oggi.
Fig. 133. Rappresentazione tipica dei diversi “strati” di un G. I. S. nello spazio territoriale. In quasi tutte le pubblicazionil’immagine canonica del G.I.S. è una rappresentazione a più livelli di tematismi cartografici, una specie di ‘torta’ a piùstrati sovrapponibili nello stesso sistema di riferimento spaziale. Gli strati sono tra loro comunicanti e comprendonoqualunque tipo di informazione spaziale (foto aeree, dati geofisici e da satellite, tematismi cartografici e qualsivogliaelemento rappresentabile in coordinate spaziali).
Fonte: Colella, 2006, p. 10.
265
Perché tale condizione si realizzi, tuttavia, è necessario che questi ultimi siano esattamente misurati, ossiageoreferenziati; le informazioni inserite in un G.I.S., infatti, «oltre ad avere una definizione quantitativa e/o qualitativaintrinseca, sono collocate spazialmente, cioè definite con affidabilità nota nella loro posizione spaziale rispetto adun sistema di riferimento unificato»60 . La selezione adeguata di quest’ultimo è di vitale importanza per l’efficien-za di un G.I.S.: infatti, «uno dei più immediati e potenti strumenti di correlazione tra le informazioni è certamentecostituito dalle coordinate che a ciascuna informazione vengono assegnate per definirne la posizione e attraversocui si possono determinare relazioni di vicinanza, influenza, conflitto, appartenenza e così via. Tale potere dicorrelazione è pienamente sfruttabile se, prima dell’immissione delle informazioni, è stato correttamente definitoil sistema di riferimento. Solo a tali condizioni la correlabilità spaziale tra dati qualitativi potrà diventare strumentoefficace di ricerca ed interrogazione; e solo a tali condizioni si potrà sfruttare compiutamente l’ingente patrimoniodi dati territoriali già acquisito e consegnato dall’opera dei rilevatori agli archivi cartacei (cartografici e alfanumerici).Infatti, comunque si articoli l’interazione tra utente e sistema informativo, essa non può non partire dalle domandeelementari del dove (cioè in corrispondenza di quali coordinate si trovi un elemento informativo presente nelsistema o vada inserita una nuova informazione) e/o del cosa (cioè quali e quanti elementi informativi ricadonototalmente o parzialmente in una data area geografica definita da una sequenza di coordinate)»61 .
Appare pertanto chiaro che, a tal fine, un G.I.S., composto da parti diverse, non necessariamente omogenee,ma contenente almeno una parte di dati memorizzati riferiti al territorio, è sicuramente uno strumento informativosuscettibile di impiego nell’ambito progettuale, ma necessita innanzitutto di dati e informazioni di partenza atten-dibili. I Sistemi Informativi Geografici, quindi, pur costituendo uno degli strumenti più avanzati per gli studi diGeografia, richiedono una ricerca scientifica di base sull’oggetto indagato, in assenza della quale qualsiasi cono-scenza e/o risultato, per quanto tecnicamente perfetto, rimarrebbe pressoché ‘muto’ e privo di significato.
A tale proposito, la cartografia storica costituisce un indubbio patrimonio informativo che, opportunamenteelaborato, può suggerire nuovi e avvincenti elementi di analisi, offrendo soprattutto la possibilità di effettuareindagini comparative sullo sviluppo di una determinata area nel corso dei secoli. Infatti, in questo tipo di studii G.I.S. potenziano efficacemente qualità e quantità delle possibili comparazioni di tipo sincronico, diacronico,“retrospettivo” o stratigrafico tra rappresentazioni cartografiche (e relativi documenti) di un determinato terri-torio, nel confronto tra passato e presente, riconoscendo in quest’ultimo elementi di continuità e innovazione erendendo possibile «elaborare costruzioni cartografiche nuove su quadri spaziali d’insieme o su selezionitematiche facenti riferimento a un preciso taglio cronologico, oppure a una ricostruzione diacronica, di breve olungo periodo, dello svolgimento di un processo di trasformazione del territorio» (Rombai, 2002, pp. 14-18).
a.2.L’applicazione dei GIS alla cartografia storica: l’esempio della “Carta topografica dei terreni irrigabilidal fiume Picentino nella piana di Salerno e Montecorvino” (1834).
Quale esempio dell’impiego possibile dei G.I.S. applicati alla cartografia storica, si è scelto di commentarei risultati di un’indagine condotta da chi scrive sulla Carta topografica dei terreni irrigabili dal fiume Picentinonella piana di Salerno e Montecorvino del 1834, comparata con cartografia successiva dell’area considerata,prodotta dall’I.G.M.62
59 I risultati cartografici di un Sistema Informativo Geografico, utilizzabili sia in chiave analitica che pianificatoria, sono in praticadati numerici digitali, visualizzabili in tre differenti modalità: come immagini raster (corrispondenti a matrici di pixels), come vettori(ossia come elementi geometrici, generalmente definiti shapefiles) o come tabelle di un Data Base (ossia come contenitori di datistrutturati, testuali o numerici, suddivisi in colonne – o campi – con un determinato dominio, vale a dire l’insieme dei possibili valori conle relative caratteristiche che possono essere acquisiti da un elemento all’interno di una Base di Dati).
60 Storace online, p. 4. Georeferenziare un dato significa attribuirgli una coppia di coordinate geografiche (distanze angolari) e/oplanimetriche (distanze lineari), che ne fissino la posizione all’interno di un determinato sistema di riferimento (datum). Quest’ultimo,in base a un complesso di regole, permette di associare i punti della superficie terrestre a dei numeri reali, che ne denotino stabilmentela posizione; per ottenere tale risultato, i geodeti hanno approssimato la forma della terra a quella di un ellissoide, la figura geometricache più le si avvicina, definendone i parametri. Nel corso degli anni, sono stati così calcolati vari ellissoidi di rotazione (lievementediversi, relativamente ai valori attribuiti alla lunghezza della circoferenza terrestre, al raggio equatoriale, ecc.), a cui corrispondonoaltrettanti sistemi di riferimento geodetico, con differente orientamento e origine delle coordinate. Queste ultime, quindi, non hanno unvalore assoluto e uno stesso punto geografico può essere indicato con coordinate leggermente diverse, a seconda del sistema di riferi-mento in cui è rappresentato.
61 Storace online, p. 4.62 A riguardo, in corrispondenza dei limiti della carta esaminata, sono state usate le Tavolette 197 I-NE (Pontecagnano Faiano), 197
I-SE (Aversana) e le Sezioni 467 II (Battipaglia) e 467 III (Salerno) dell’I.G.M.
266
La carta storica esaminata, opera di Giovanni Rosalba, valente architetto e ingegnere salernitano attivo tra il1827 e il 1866, mostra una situazione territoriale caratteristica della Piana del Sele prima della bonifica: comegià in precedenza osservato (cfr. qui il capitolo II, sottopar. 3.d), infatti, la sua funzione principale consiste neldelimitare i confini di proprietà dei terreni coltivati della zona, oggetto di frequenti conflitti, per lo più derivantidall’assenza di una regolamentazione ufficiale sull’uso delle acque. Nella Piana del Sele, prima della bonificafascista degli anni Trenta del XX secolo, era infatti molto diffusa l’abitudine di deviare arbitrariamente il corsodei fiumi, a scopo irriguo, senza che vi fossero alla base di tali interventi dei piani organici e coerenti, né tantomeno risolutivi della grave condizione di degrado ambientale dei territori circostanti. L’uso dell’acqua eraquindi una delle ragioni di conflitto tra i proprietari e, pertanto, «anche quando l’esigenza di far allestire dellecarte era puramente inventariale (necessità di confini certi, divisioni ereditarie, ecc.), la motivazione profondarestava di natura preventiva contro usurpazioni dall’esterno, tutt’altro che insolite nella travagliata storia locale(causa ed effetto di quella generale) del Regno di Napoli» (Aversano, 2009 [a], p. 34).
A ulteriore dimostrazione della sua finalità, la carta mostra le foci dei fiumi Picentino (che segna il confineoccidentale della Piana con il Salernitano) e Tusciano, molto importanti per le colture e i cui nomi compaiononel titolo stesso della pianta 63 .
63 Si noti a riguardo che, mentre l’acqua del Sele sarebbe stata impiegata a fini irrigui solo dal 1930, quella del Tusciano e delPicentino lo era già da molto tempo (Migliorini, 1949, p. 52), grazie a una precoce messa a coltura operata da «borghesi intraprendentie contadini» con un «variegato quadro agricolo» (Aversano, 1998, p. 19).
64 La conversione della scala è stata fatta considerando il moggio ebolitano come equivalente a 0,408789 ettari (Guariglia, 1936, p.12), ossia a una superficie di circa mezzo ettaro attuale, corrispondente a 4.087,89 m2, la cui radice quadrata dà come risultato 63,93 mlineari. Questa misura corrisponde a 1 moggio lineare che, moltiplicato per 7 (poiché la scala è di 7 moggia lineari), dà un prodotto di447,55 m (ossia di 44.755,62 cm).
65 I punti di riferimento scelti a tale scopo sono stati gli incroci principali della Strada Statale 18 (antica Strada per le Calabrie), unicavia di collegamento (tuttora esistente) che, al tempo del Rosalba, attraversasse l’intera Piana del Sele, percorrendola in prossimità delleparti interne e, dunque, non impaludate.
Il valore agricolo dell’area inquadrata (priva di paludi in un periodo in cui l’intera Piana era ancora impaludata)diventa ancora più emblematico in considerazione del nuovo contesto storico apertosi con la prima metà del-l’Ottocento, allorché lo stato borbonico, anche a seguito del decennio napoleonico, cerca con più decisione dieliminare i privilegi e i soprusi dei maggiori proprietari terrieri della Piana, regolamentando la distribuzionedelle acque a beneficio anche di altre zone della provincia (per un approfondimento di tale argomento, oltre alcapitolo II, par. 2c di questo testo, cfr. Aversano, 2006 [b]).
Dal punto di vista tecnico, la Pianta del Rosalba presenta una «Scala di 7 moggia lineari» (attualmentecorrispondenti a circa 44.775 cm)64 e risulta di notevole precisione geometrica e perfezione tecnica, grazie allaquale la georeferenziazione condotta con i G.I.S. è stata effettuata abbastanza agevolmente sulla base delleTavolette I.G.M. del 195665 .
Fig. 134. G. Rosalba, Carta topografica dei terreni irrigabili dal fiume Picentino nella piana di Salerno e Montecorvino,1834 (per un’immagine ingrandita della carta, cfr. qui il cap. II, sottopar. 3.d, Fig. 84).
Fonte: ASS, Intendenza, b. 1456, f. lo 1.
267
Fig. 135 a-b. Georeferenziazione della Carta topografica dei terreni irrigabili dal fiume Picentino nella piana di Salerno eMontecorvino su cartografia I.G.M. al 25. 000 del 1956. Il Sistema di riferimento è stato trasformato da Roma 40 a WGS 84.
a. sovrapposizione in trasparenza.
b. sovrapposizione semplice
268
La rappresentazione dei campi coltivati, riprodotti nei minimi particolari (al punto di rendere visibili lecisterne, gli edifici, gli orti, gli alberi – disegnati a tre dimensioni e con la proiezione dell’ombra verso sud-est– e persino la direzione dell’aratura), ma denotati con i nomi dei rispettivi proprietari del tempo, non contieneelementi toponomastici particolarmente indicativi per una loro identificazione sulla cartografia attuale.
Fig. 136 a-b. Come si può osservare dalla sovrapposizione delle due carte (in trasparenza [a] e semplice [b]), nelle zone incui sorgono i campi coltivati disegnati dal Rosalba, già nel 1956 compaiono – a sostituirli – i capannoni industriali, comemostrato dai numerosi simboli della Tavoletta I.G.M.
a
b
269
Fig. 137 a-b. La sovrapposizione della carta del Rosalba alla corrispondente Tavoletta I.G.M. del 1956 (in trasparenza [a] e semplice[b]) mostra lo straordinario sviluppo urbano delle zone di Pontecagnano e Fuorni già dopo la bonifica e la riforma agraria.
a
b
270
La precisione geometrica della carta supplisce tuttavia a tale mancanza, permettendo un raffronto precisocon la situazione successiva agli anni della bonifica. A tale proposito, risulta estremamente interessante osser-vare come le zone disegnate dal Rosalba e corrispondenti ai campi coltivati siano divenute, già nel 1956, sediproduttive molto sviluppate (sono infatti ben visibili nella cartografia I.G.M. i simboli dei capannoni industria-li), mentre le aree nord-orientali della pianta abbiano visto lo straordinario sviluppo dei centri, come Fuorni ePontecagnano (cfr. figg. 135 a-b e successive). A Fuorni, in particolare, è stata localizzata una “zona industria-le” nell’ambito della politica “dei poli e degli assi”realizzata nel Salernitano agli inizi degli anni Sessanta(Caterina, 2009, pp. 55-63).
Fig. 138 a-b. La sovrapposizione (in trasparenza [a] e semplice [b]) della carta del Rosalba alle corrispondenti SezioniI.G.M. del 1996 mostra come la parte vicina alla costa dell’area inquadrata abbia sostanzialmente conservato la propriafisionomia agricola, con una suddivisione dei terreni simile, nell’aspetto, a quella disegnata dal Rosalba nel 1834.
a
b
271
a.3. Creazione degli strati informativi vettoriali: un esperimento di comparazione sull’uso del suolo attra-verso la carta di Giovanni Rosalba.
a.3.1 Tipi di colture rappresentate dalla pianta di Giovanni Rosalba
Per mostrare un altro possibile impiego dei G.I.S. nell’ambito della cartografia storica, alla carta del Rosalbaè stato successivamente sovrapposto uno strato vettoriale, al fine di analizzarne uno degli aspetti più interessan-ti, relativo alla suddivisione dei campi coltivati, rappresentati con diversi elementi cromatici, i nomi dei rispet-tivi proprietari e la relativa estensione in moggia.
Fig. 139 a-b. Sovrapposizione (in trasparenza [a] e semplice [b]) della carta del Rosalba alle Sezioni I.G.M. del 1996, conevidenziazione dell’ulteriore accrescimento dei centri abitati di Fuorni e Pontecagnano. Si noti la quasi perfetta corrispon-denza dell’asta fluviale del fiume Picentino (Fig. 139 b), disegnata dal Rosalba, con quella della Sezione I.G.M.
a
b
272
La puntualità certosina del disegno e l’uso sapiente dei colori potrebbero far pensare a una distinzione tracolture che il Rosalba intende rappresentare, ma, considerate le finalità della carta, tale conclusione appareimprobabile. In effetti, nella relazione allegata alla carta (Rosalba,1834), le indicazioni in proposito sono abba-stanza povere, dal momento che lo scopo prioritario della rappresentazione, come già evidenziato, consiste nelfornire una soluzione ‘visiva’ al problema della regolamentazione idrica, facilitando la stesura [e, ovviamente,l’osservanza] del regolamento amministrativo richiesto.
Come già evidenziato in precedenza (cfr. qui il cap. II, sottopar. 3.d), è però evidente l’importanza delrapporto tra l’uso dell’acqua, relativamente alla quantità e alla frequenza dell’irrigazione, e i tipi di colture:infatti il Rosalba, nella sua relazione, nell’enumerare le varie sorgenti, regola il suo intervento in base al sistemadi coltivazione biennale del granone e procede a una regionalizzazione del territorio in cinque contrade (diSiglia e delle abolite risaje, sulla sponda dritta; di Sardone, di S. Giorgio e de’ Cannameli, sulla sponda sinistra).Per quanto riguarda il paesaggio agrario vero e proprio, beneficiato dall’irrigazione, e i tipi di coltivazionepraticati, il Rosalba spiega che questi ultimi erano suddivisi, molto semplicemente, in campestre (grano egranone) e arbosto (viti maritate ad alberi vivi).
La carta ottocentesca ci mostra quindi la coesistenza nell’attuale zona di Fuorni e Pontecagnano Faiano diproprietà grandi, medie, piccole, destinate a cereali e vigneti. Dal disegno emergono per l’appunto i tralci dellavite, non coltivata in filari ma tradizionalmente maritata ai salici o ad altri alberi. Si conferma in tal modol’esistenza di aree difformi rispetto al generale paesaggio di acque stagnanti e coltivazioni estensive che carat-terizzavano la Piana: una maggiore articolazione produttiva caratterizzava la corrispondente zona interna diMontecorvino, compresa tra i corsi del Tusciano e del Picentino, nella quale, oltre al riso, al frumento e al gelso,si producevano olio e vino in discreta quantità, mentre in alcune tenute era stata introdotta anche la coltivazionedel tabacco (Bruno-Lembo, 1982, p. 9).
a.3.2. Comparazione tra la Carta del Rosalba e la Carta dell’Uso Agricolo del Suolo (C.U.A.S.) della Regio-ne Campania.
In considerazione delle caratteristiche descrittive della carta del Rosalba, la costruzione del livello vettoriale,dopo la creazione di un apposito “shapefile”, non ha tenuto conto dei colori utilizzati nella pianta originale, nondisponendo di alcun dato per stabilire un nesso certo tra questi ultimi e la specie cerealicola a cui fanno riferi-mento. Diverso è invece il caso delle viti maritate, disegnate con un retinato di colore verde intenso e, dunque,assolutamente inconfondibili. Per la scelta dei colori, ci si è pertanto uniformati alla legenda della Carta del-l’Uso Agricolo del Suolo, ossia alle relative proprietà del “layer” vettoriale fornito dalla Regione Campania.
È stata quindi creata una tabella in cui sono stati inseriti, come attributi di ciascun elemento vettoriale(poligoni), la tipologia e l’area. Il lavoro vero e proprio è dunque consistito nel disegnare gli elementi vettorialiin corrispondenza dei singoli elementi della carta: sono stati così contornati i lati dei campi coltivati, degliedifici e delle cisterne (vie di comunicazione e aste fluviali escluse66 ), per un totale di 412 poligoni, corrispon-denti a 6 tipologie cromatiche differenti, di cui 2 volte a distinguere le colture cerealicole dai vitigni e 4 perindicare, rispettivamente, orti, giardini, edifici e cisterne.
La comparazione, sebbene fondata su informazioni scarsamente dettagliate, conferma nel complesso laprofonda trasformazione conosciuta dalla produzione agricola della Piana del Sele negli anni successivi allabonifica e, soprattutto, alla seconda guerra mondiale. Durante il “boom economico” all’inizio degli anni Ses-santa, infatti, «il completamento della bonifica del Sele, che aveva già permesso l’impianto di aziende capitali-stiche di grande dimensione, fu completato dalla costruzione di una vasta rete irrigua e dall’insediamento di unapiccola proprietà coltivatrice indirizzata alle colture ortofrutticole, mentre la media azienda si specializzavanella produzione di materie prime industriali per i relativi impianti di trasformazione (tabacco, zucchero, con-serve). Per tali caratteristiche la piana del Sele, già avvantaggiata da interventi più completi e meglio strutturatinel ventennio fascista, si impone come la sola zona in cui sia stato organizzato un sistema agro-industrialeintegrato» (Cavalcanti, 2006, p. 25).
66 Non sono stati trasformati in poligoni vettoriali né le strade né i corsi d’acqua, che non avrebbero aggiunto informazioni utili allacomparazione proposta.
273
Successivamente, inoltre, si è registrato l’impatto pesante della localizzazione di una zona specificamenteindustriale, come già ricordato in precedenza.
Tale trasformazione è d’altra parte frutto altresì dello spostamento della popolazione dalle fasce montane aquelle di pianura, del dilatarsi dei grandi centri urbani e dello sviluppo delle reti di trasporto e comunicazione.La coltura estensiva della grande proprietà ha pertanto lasciato il posto a quella intensiva, come appare evidentedalla sovrapposizione della rappresentazione vettoriale realizzata sulla carta del Rosalba e la Carta dell’UsoAgricolo del Suolo della Regione Campania, di seguito mostrate.
Fig. 140. Visualizzazione della copertura vettoriale sovrapposta alla carta del Rosalba georeferenziata. La prevalenza deicampestri (colture cerealicole), sugli arborati (viti maritate), evidente soprattutto nei terreni prossimi al mare, è qui con-trassegnata, rispettivamente, dai colori giallo e fucsia, propri della Legenda della C.U.A.S. della Regione Campania.
274
Fig. 141. Visualizzazione ingrandita della copertura vettoriale realizzata sulla carta del Rosalba: si notino le sagome degliedifici e le linee di confine tra i campi.
Fig. 142. Sovrapposizione ingrandita del livello vettoriale della carta del Rosalba a quello della Carta dell’Uso Agricoloattuale. Mentre il colore fucsia indica i vigneti, il giallo denota le colture cerealicole, che al tempo del Rosalba si estende-vano laddove oggi sorgono i capannoni industriali (contrassegnati dal colore grigio della C.U.A.S.).
275
Fig. 143. La Carta dell’Uso Agricolo del Suolo attuale, nella quale si osserva lo straordinario sviluppo delle coltivazioniintensive, con la prevalenza di frutteti (contrassegnati dal colore rosa) e colture ortofrutticole (contrassegnate dal coloreviola).
Fig. 144. Legenda dell’attuale Carta dell’Uso Agricolo del Suolo della Regione Campania.
276
b. Le potenzialità didattiche della cartografia digitale, con particolare riguardo a Google Earth
b.1 I Mappamondi Digitali: una breve introduzione storica
Lo sviluppo degli apparecchi satellitari ha radicalmente modificato la concezione cartografica tradizionale.I satelliti, infatti, sempre più sofisticati, rendono possibile fotografare da grandi distanze, con estrema precisio-ne e nitidezza, la superficie del nostro pianeta, ripresa in immagini disponibili per analisi, fotointerpretazione ecostruzione di carte geografiche, di vario tipo e a differente scala.
Al di là degli impieghi cartografici ‘professionali’ a cui sono destinate, queste immagini, grazie a program-mi gratuiti scaricabili dalla rete internet, possono oggi essere visualizzate dalla maggior parte degli utenti delweb, messi così nella condizione di potere virtualmente ‘viaggiare’ in ogni parte del globo. La diffusione el’impiego di questi programmi negli ultimi anni sono infatti aumentati in maniera esponenziale, anche grazie aimass media, che ne fanno largo uso, soprattutto nell’ambito dell’informazione e della pubblicità (sebbene nonsempre nel rispetto della necessaria consapevolezza geografica e cartografica).
La storia di questi programmi è dunque indubitabilmente legata a quella dei satelliti orbitanti attorno allaTerra (l’anno di svolta, in tal senso, è il 1972, allorché viene lanciato nello spazio il primo satellite ‘fotografo’della serie Landsat), ma anche al concetto di “Terra digitale” (DE: “Digital Earth”). Quest’ultimo, difatti,denota un sistema capace di registrare e integrare informazioni geografiche riguardanti la superficie terrestre,rendendole globalmente disponibili per la consultazione attraverso Internet.
Il progetto originario di tale sistema risale al 1998, allorché l’allora vicepresidente degli U.S.A., l’ambientalistaAl Gore, lo presentò nell’ambito di un discorso tenuto al California Science Center di Los Angeles67 , al fine dicontribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica mondiale sui rischi dei mutamenti climatici. I danni ambientali,i cambiamenti naturali e/o artificiali della superficie terrestre, infatti, diventano particolarmente evidenti nelleimmagini della Terra inviate con regolarità, e a diverse risoluzioni, dai satelliti geostazionari con orbita quasipolare68 .
Dal 2000 in poi, pertanto, il programma delle Nazioni Unite dedicato all’ambiente (United Nations EnviromentalProgramme) decide di adottare il progetto DE (che avrebbe tuttavia subito una battuta d’arresto dopo la sconfittadi Al Gore nelle elezioni presidenziali del 2001), aggiungendovi l’idea di realizzare un geobrowser (o “mappa-mondo virtuale”), per rendere fruibili anche ai non addetti ai lavori, attraverso Internet e su base cartograficadigitale, le informazioni riguardanti il pianeta. Nascono dunque da tali circostanze una serie di mappamondivirtuali oggi disponibili in rete, di cui Google Earth è sicuramente il più conosciuto e impiegato69 .
b.2 Google Earth: elementi di visualizzazione e interazione
Google Earth è uno dei primi geobrowser per la visualizzazione globale e interattiva della Terra, basato su unatecnologia originariamente sviluppata dall’azienda statunitense “Keyhole Technology Inc.” e acquistata nel 2004dalla “Google” (società celebre in tutto il mondo innanzitutto per l’efficienza del suo motore di ricerca).
A differenza di Google Maps – prodotto sempre dalla “Google”, ma utilizzabile attraverso un semplicebrowser abitualmente impiegato per la ‘navigazione’ in rete (come Internet Explorer di Microsoft, Safari diApple, Firefox di Mozilla e così via) – Google Earth è un vero e proprio programma a sé stante, con funzioni diconsultazione e interazione specificamente ed esclusivamente geografiche, disponibile nella versione gratuita(dotata di funzioni base) e a pagamento (dotata di funzioni avanzate).
67 «Si tratta di un mondo virtuale di risorse conoscitive, a disposizione di tutti gli utenti connessi dalla rete, che integra immaginitelerilevate multitemporali, fotografie, testi, modelli tridimensionali, dati statistici di tipo socio-economico collegati a modelli di calcoloprevisionali, ecc.» (Favretto, 2009, p. 13).
68 Sono così definiti i satelliti posizionati sul piano dell’equatore e percorrenti un’orbita quasi circolare intorno alla Terra (di cui sonocapaci di monitorare tutta la superficie, giacché passano per i poli), di cui hanno lo stesso periodo di rotazione (viaggiano, cioè, alla suastessa velocità angolare). Pertanto, a un eventuale osservatore questi satelliti, visti dalla Terra, apparirebbero immobili.
69 Oltre al più celebre Google Earth (http://earth.google.it/), tra i mappamondi virtuali impiegati, gratuitamente scaricabili dalla rete,si annoverano oggi World Wind (http://worldwind.arc.nasa.gov/java/) della NASA (attivo dal 2003), Microsoft Virtual Earth (http://microsoft-virtual-earth.en.softonic.com/) della MICROSOFT (attivo dal 2005) e ArcGis Explorer (http://www.esri.com/software/arcgis/explorer/index.html) della ESRI (attivo dal 2006). Per una descrizione approfondita dell’argomento, si rimanda a Favretto, 2009.
277
A tale proposito, conviene evidenziare preliminarmente che le funzioni di base della versione gratuita –oggetto della presente descrizione – sono orientate più alla visualizzazione che non all’interazione, piuttostolimitata70 . Per quanto riguarda la prima, tuttavia, Google Earth si presenta come uno dei migliori prodotti oggidisponibili, rendendo fruibili immagini digitali del pianeta ad alta definizione, che possono essere ingrandite orimpicciolite con un apposito zoom, passando dalla visualizzazione di immagini telerilevate a piccola scala aquella di ortofoto a grande scala. Da un punto di vista didattico, pertanto, anche nella sua versione gratuita, ilprogramma consente una serie di operazioni molto utili per la comprensione immediata di alcuni concetti dibase della cartografia (scala, prospettiva, e così via), nonché della geografia nel suo complesso, rendendovisibili i differenti elementi caratterizzanti la morfologia della superficie terrestre.
A tale proposito, infatti, esaminando la varietà di visualizzazioni disponibili, si può osservare come, oltrealla variazione della scala (riportata in basso a sinistra ed espressa in km e m)71 , Google Earth consenta lavariazione dell’angolo di osservazione sul terreno, variabile dai 90 gradi della visualizzazione prospettica ditipo zenitale, “schiacciata a terra”, ai pochi gradi della visualizzazione prospettica “a volo d’uccello”, simile aquella delle carte rinascimentali o moderne (cfr. fig. 150 a-b). Proprio quest’ultimo particolare angolo di osser-vazione consente di osservare il terreno quasi ‘dal vivo’, come lo si potrebbe vedere dall’oblò di un aeroplanoin volo, rendendo molto più semplice la comprensione intuitiva dei rilievi (raffigurati dalle carte topografiche,come noto, attraverso le isoipse), della conformazione delle valli (ad esempio, la differenza tra quelle glaciali,a U, e quelle fluviali, a V) e di tutti gli aspetti riguardanti le forme di una determinata area indagata72 .
In analogia con la cartografia storica, utilizzando i vari “livelli” di osservazione (strati tematici posizionatisu una barra laterale del programma, che può essere visualizzata e attivata dall’utente nelle sue diversearticolazioni: cfr. fig. 145), il programma consente altresì l’apertura di ‘finestre informative’ interattive (incorrispondenza del livello “luoghi di interesse”), relative alle località ‘esplorate’ e contenenti indicazioni divaria natura (geografiche, storiche, turistiche, commerciali e così via), nonché, in corrispondenza del livello“Panoramio”, fotografie rilevanti che la riguardino (cfr. fig. 146).
Al di là delle pur interessanti analogie con la cartografia storica, l’uso dei livelli è molto utile anche persovrapporre all’immagine digitale visualizzata degli strati informativi di tipo geometrico-vettoriale (analoga-mente a quanto avviene in un G.I.S.), che, compatibilmente con la scala di visualizzazione scelta, consentono diindividuare facilmente i confini amministrativi (provinciali, regionali e statali) nonché le principali reti viarie(strade comunali, provinciali, statali e reti autostradali), le tratte ferroviarie e gli eventuali collegamenti marit-timi e fluviali dell’area considerata (cfr. fig. 149).
Molto interessante è anche lo strato “3d Buildings”, che permette la visualizzazione a tre dimensioni degliedifici più importanti di una città (cfr. fig. 150 a-b). A tali strumenti, infine, Google ha recentemente aggiuntoanche il cursore temporale, che permette di visualizzare una stessa area in date diverse, procedendo secondouna sequenza cronologica scelta dall’utente (cfr. figg. 151-152). Tale strumento, come evidente, rendendo im-mediato il raffronto di due o più rappresentazioni differenti di una stessa superficie geografica, rende moltoagevoli eventuali ragionamenti e approfondimenti di tipo analitico-comparativo, soprattutto per quanto riguar-da gli elementi visibili del paesaggio raffigurato.
Per quanto riguarda gli aspetti interattivi della versione gratuita di Google Earth, questi si riassumono fon-damentalmente nella possibilità di contrassegnare una determinata località con un simbolo (definito segnapostoo placemark), a cui si può aggiungere una breve descrizione e una fotografia, archiviando il tutto nel propriospazio virtuale oppure condividendolo con altri utenti o con l’intera rete, secondo una procedura alquantocomplessa, ma certamente utile da trasmettere nell’ambito di un laboratorio didattico di tipo prettamentecartografico73 .
70 Per una descrizione completa delle funzioni di base della versione gratuita di Google Earth si rimanda all’indirizzo http://earth.google.com/support/bin/static.py?page=guide_toc.cs.
71 A tale proposito, tra gli strumenti interattivi si rivela particolarmente utile il “righello”, che consente di valutare con esattezza ladistanza lineare tra due punti, espressa, in base alla scelta dell’utente, con diverse unità di misura (cm, m, km, miglia, gradi e così via).
72 Proprio sfruttando tale possibilità, Google Earth consente di attivare un “simulatore di volo”, che permette di programmare edeffettuare dei viaggi virtuali, ‘sorvolando’ paesi, città, regioni, stati e continenti.
73 La procedura esige da parte dell’utente la conoscenza di alcuni elementi di georeferenziazione, nonché della sintassi di base dellinguaggio di descrizione KML (Keyhole Markup Language), derivato dall’XML. Per orientarsi a tale riguardo, si veda la Guida del-l’Utente di Google Earth (http://earth.google.com/intl/it/userguide/v4/ug_toc.html).
278
Fig. 145. Visualizzazione della barra laterale di Google Earth (posizionata sul lato sinistro), attraverso la quale si possonoeffettuare ricerche di località specifiche e attivare i vari livelli (layers) di sovrapposizione disponibili. Si notino anche, inalto a destra, i comandi di zoom, cambiamento di prospettiva e orientamento geografico.
Fig. 146. Visualizzazione del livello “Luoghi di interesse”, con la relativa apertura di una ‘finestra informativa’.
279
Fig. 147. Questa carta del Regno di Napoli di A. Bulifon (datata 1698), conformemente alla consuetudine dell’epoca,presenta in alto a destra un cartiglio ‘informativo’, con una dedica all’Infante di Spagna, Re di Napoli (Carlo II d’Asburgo).Il particolare rivela una potenziale affinità tra la cartografia antica e le modalità di visualizzazione cartografica offerte daGoogle Earth.
280
Fig. 148. Visualizzazione dei livelli vettoriali di Google Earth, relativi ai confini amministrativi provinciali (linee di coloreverde) regionali (linee di colore bianco) e statali (linee di colore giallo).
Fig. 149. Visualizzazione dei livelli vettoriali di Google Earth relativi alle reti autostradali (linee di colore giallo scuro),statali (linee di colore giallo chiaro), ferroviarie (linee di colore nero) e marittime (linee di colore celeste).
281
Fig. 150. a. Visualizzazione del livello “Edifici 3D”. Ben visibile in primo piano la celebre Piazza del Plebiscito di Napolie alcuni edifici notevoli: la cupola della Basilica di S. Francesco di Paola (di colore bianco, al centro dell’immagine) con,di fronte, il Palazzo Reale dei Borboni (alle cui spalle si vedono il Castel Nuovo, o “Maschio Angioino” e, alla destra diquest’ultimo, la Stazione Marittima) e il Palazzo della Prefettura, sul lato sinistro. Visibili anche i grattacieli del CentroDirezionale (in fondo) e, isolato sulla sinistra, il “Jolly Hotel”.
b.Visualizzazione del livello “Edifici 3D”. Ben visibile al centro il “Colosseo” (Anfiteatro Flavio) di Roma con (da sinistraa destra, in senso orario) l’Arco di Costantino, il Foro romano, la Basilica di S. Pietro in Vincoli. Si notino anche, sul-l’estrema sinistra, il monumento del Vittoriano di Pazza Venezia e, in fondo, il palazzo di Montecitorio.
282
Fig. 151. Roma, Piazza del Colosseo (1943).
Fig. 152. Roma, Piazza del Colosseo (2010). Dalla comparazione di quest’immagine con la precedente (fig. 151) emergela sostanziale conservazione – a distanza di 60 anni – del paesaggio urbano.
282
Fig. 151. Roma, Piazza del Colosseo (1943).
Fig. 152. Roma, Piazza del Colosseo (2010). Dalla comparazione di quest’immagine con la precedente (fig. 151) emergela sostanziale conservazione – a distanza di 60 anni – del paesaggio urbano.
283
BIBLIOGRAFIA
AVERSANO V., “La Piana del Sele secondo due recenti studi”, in La Geografia nelle scuole, XXI, 1976, n. 2, pp. 82-87.AVERSANO V., “In destra Sele: rapporti montagna/collina/pianura e frazionamento amministrativo negli ultimi due se-
coli”, in Aversano V., Trotta M., Postiglione L., Gallo I., Amedeo Moscati e il suo tempo, Cava de’Tirreni, AvaglianoEditore, 1998, pp. 15-37.
AVERSANO V., “La cartografia storica in una ricerca-didattica di Geografia”, in ID., La Geografia interpreta il territorio.Cifra scientifico-applicativa e strategie didattiche, Fisciano, Editrice Universitaria Salernitana, 2006 [a], pp. 89-140.
AVERSANO V., “Giovanni Rosalba”, in ID. (a c.), Studi del Car.topon.st. 1-2 (2005-2006), Fisciano, Gutenberg Edizioni,2006 [b], pp. 37-50.
AVERSANO V., “Per i ‘carneadi’ della cartografia: il microterritorio da posta in gioco a emozione (significati e ‘non-catalogo’ di una mostra cartografica)”, in ID. (a cura), Studi del La.Car.topon.st. 3-4 (2007-2008), Fisciano, GutenbergEdizioni, 2009 [a], pp. 31-57.
AVERSANO V. “Il territorio del Cilento nella Cartografia (secc. XVI-XIX)”in ID. (a c.), Il territorio del Cilento nellacartografia e nella vedutistica (secc. XVII-XIX), Vatolla, Edizioni Palazzo Vargas, 2009 [b], pp. 19-107.
AZZARI M., FAVRETTO A. (a c.), Acqua, risorsa e bene culturale. Sistemi Informativi Geografici per il monitoraggio, lagestione e la tutela delle acque. Atti del VI workshop “GIS per i beni ambientali e culturali” (Firenze, 16 novembre 2006),Pisa, Kinzica, 2008 (in CD ROM).
AZZARI M., FAVRETTO A. (a c.), VII Workshop. Beni Ambientali e culturali e GIS. Comunicare l’Ambiente, Bologna,Pàtron Editore, 2009.
BRUNO G., “Uso delle acque e sviluppo dell’agricoltura durante l’Ottocento”, in Consorzio di bonifica in destra delfiume Sele, Acque & terra nella piana del Sele: irrigazione e bonifica ‘32-’82. Irrigazione e bonifica nel comprensorio indestra del Sele fra XIX e XX secolo, a cura di Giovanni Bruno e Rosario Lembo, Salerno, s.n., Tip. Jannone, 1982, pp. 3-63.
CATAUDELLA M., La Piana del Sele: popolazione strutture insediative: corso di geografia regionale, Salerno, s.n., 1975.CATERINA G., Teorie spaziali e sviluppo industriale del Mezzogiorno, Battipaglia, Laveglia & Carlone, 2009.CAVALCANTI M.L., Economia. La Campania, Napoli, Guida, 2006.CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE, online: http://www.bonificadestrasele.it/.FAVRETTO A., Nuovi strumenti per l’analisi geografica. I G.I.S., Bologna, Pàtron Editore, 2000.FAVRETTO A., I mappamondi virtuali. Uno strumento per la didattica della Geografia e della Cartografia, Bologna,
Pàtron, 2009.GUARIGLIA E., Antiche misure agrarie della Provincia di Salerno, Salerno, 1936 [Ente per le antichità e i monumenti
della Provincia di Salerno, pubblicazione n. V]LEMBO R., “La ‘Bonifica integrale’ della Piana del Sele”, in Consorzio di bonifica in destra del fiume Sele, cit., pp. 67-
127.MIGLIORINI E., “La Piana del Sele”, Napoli, 1949 [Memorie di Geografia Economica, I, Lug.-Dic.,Vol. I, pp. 39-175].ROMBAI L., Geografia storica dell’Italia. Ambienti, territori, paesaggi, Firenze, Le Monnier, 2002.ROSALBA G., Memoria legale-idraulica sulle acque del fiume Picentino, Salerno, Nella Tipografia dell’Intendenza,
1834.RUOCCO D., Memoria illustrativa della Carta della utilizzazione del suolo della Campania (Fogli 14, 15, 16, 17 e 19
della Carta della utilizzazione del suolo d’Italia), Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche,1970.VISCONTI F., “Del Sistema metrico uniforme che meglio si conviene a’ Dominj al di qua del Faro del Regno delle due
Sicilie”, Atti della Reale Accademia delle Scienze, Sezione della Società Reale Borbonica, Napoli, Nella Stamperia Reale,1832, vol. III, pp. 77-142.
LINKOGRAFIA
STURACE L., La georeferenziazione dei dati territoriali, dispensa online all’indirizzo:http://www.geoforus.it/index.php?option=com_content&task=view&id=471&Itemid=12 (consultazione del 17/03/
2010).
303
Stampato presso la Tipografia Gutenberg s.r.l.Via Ponte Don Melillo, 55 - Fisciano (SA)
Tel. 089.891385 - Fax [email protected] - www.gutenbergedizioni.it