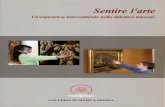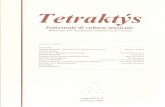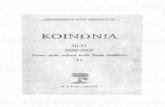G. Di Benedetto, Didattica e percorsi progettuali , in ... nella continuità. La didattica del...
Transcript of G. Di Benedetto, Didattica e percorsi progettuali , in ... nella continuità. La didattica del...
0_copertina e quarta.qxp_Layout 1 09/12/14 16:10 Pagina 1
La continuità, la didattica del progetto e il sasso lanciato nello stagno
Ho più volte insistito con i miei colleghi sul fatto che il libro sulla didattica del progettooffrisse un’occasione per porre l’accento, pur fra le tante riforme universitarie subite e at-tuate, sulla continuità esistente tra la Facoltà Architettura di Palermo e l’attuale Dipartimentodi Architettura. Pensavo che questo trait d’union si potesse rappresentare con una copertina cheavesse per tema una delle scale della Facoltà di via Maqueda, ad esempio quella di Gino Pollini,messa in relazione con quella che caratterizza l’edificio della didattica di viale delle Scienze,parte della nuova sede della Facoltà progettata negli anni Novanta da Pasquale Culotta, GiuseppeLaudicina, Bibi Leone e Tilde Marra. Vincenzo Melluso ha elaborato l’immagine definitiva della copertina, distaccandosi totalmente daquella che era stata la mia indicazione. Quando mi sono recato nella sua stanza in Dipartimentoper scegliere fra i bozzetti da lui elaborati, ho notato che questi avevano per tema dei cerchiconcentrici. Il contenuto rimandava alla continuità tipica di questa figura geometrica e le im-magini realizzate rimandavano, in modo diverso, ad una eco senza fine. Ma fra i due bozzetti,posti alla mia attenzione, ho immediatamente scelto quello pubblicato in copertina perché pur in-terpretando l’idea della continuità attraverso la sequenza dei cerchi concentrici, richiamava unafigura che Pasquale Culotta descriveva con una certa frequenza. Amava dire a proposito di un’ar-chitettura, di un libro, di una lezione, di un viaggio, in generale di un’esperienza da lui ri-tenuta importante che questa aveva lo stesso effetto di un sasso lanciato in uno stagno, cioè,provocava delle benefiche onde di propagazione. Dei flussi che potevano orientare, influenzare ilnostro agire, la nostra esperienza nell’architettura, in alcuni casi, anche in modo decisivo l’in-tera vita di qualcuno di noi. Quando ho ricordato a Vincenzo Melluso che la sua immagine possedevain maniera sottesa anche questo significato, lui mi ha risposto: «è vero, il sasso lanciato nellostagno». Il ricordo di questa immagine mi ha fatto rinunciare di buon grado alla mia idea inizialeperché, in modo implicito o del tutto oscuro per alcuni, in modo esplicito per altri, anche questolibro che raccoglie l’esperienza della didattica del progetto di architettura, di interni e delpaesaggio, svolta in questi ultimi anni a Palermo, può essere pensato come una delle tante ondepropagatesi dalla “lezione”, per me sempre presente, di Pasquale Culotta, maestro indimenticato.
Andrea Sciascia
EDAebook 05
In copertina: Vincenzo Melluso, Il sasso lanciato nello stagno, 2014
0_copertina e quarta.qxp_Layout 1 09/12/14 16:10 Pagina 1
20,00 euro
ISBN 978-88-548-7953-9
0_copertina e quarta.qxp_Layout 1 09/12/14 16:10 Pagina 1
La continuità, la didattica del progetto e il sasso lanciato nello stagno
Ho più volte insistito con i miei colleghi sul fatto che il libro sulla didattica del progettooffrisse un’occasione per porre l’accento, pur fra le tante riforme universitarie subite e at-tuate, sulla continuità esistente tra la Facoltà Architettura di Palermo e l’attuale Dipartimentodi Architettura. Pensavo che questo trait d’union si potesse rappresentare con una copertina cheavesse per tema una delle scale della Facoltà di via Maqueda, ad esempio quella di Gino Pollini,messa in relazione con quella che caratterizza l’edificio della didattica di viale delle Scienze,parte della nuova sede della Facoltà progettata negli anni Novanta da Pasquale Culotta, GiuseppeLaudicina, Bibi Leone e Tilde Marra. Vincenzo Melluso ha elaborato l’immagine definitiva della copertina, distaccandosi totalmente daquella che era stata la mia indicazione. Quando mi sono recato nella sua stanza in Dipartimentoper scegliere fra i bozzetti da lui elaborati, ho notato che questi avevano per tema dei cerchiconcentrici. Il contenuto rimandava alla continuità tipica di questa figura geometrica e le im-magini realizzate rimandavano, in modo diverso, ad una eco senza fine. Ma fra i due bozzetti,posti alla mia attenzione, ho immediatamente scelto quello pubblicato in copertina perché pur in-terpretando l’idea della continuità attraverso la sequenza dei cerchi concentrici, richiamava unafigura che Pasquale Culotta descriveva con una certa frequenza. Amava dire a proposito di un’ar-chitettura, di un libro, di una lezione, di un viaggio, in generale di un’esperienza da lui ri-tenuta importante che questa aveva lo stesso effetto di un sasso lanciato in uno stagno, cioè,provocava delle benefiche onde di propagazione. Dei flussi che potevano orientare, influenzare ilnostro agire, la nostra esperienza nell’architettura, in alcuni casi, anche in modo decisivo l’in-tera vita di qualcuno di noi. Quando ho ricordato a Vincenzo Melluso che la sua immagine possedevain maniera sottesa anche questo significato, lui mi ha risposto: «è vero, il sasso lanciato nellostagno». Il ricordo di questa immagine mi ha fatto rinunciare di buon grado alla mia idea inizialeperché, in modo implicito o del tutto oscuro per alcuni, in modo esplicito per altri, anche questolibro che raccoglie l’esperienza della didattica del progetto di architettura, di interni e delpaesaggio, svolta in questi ultimi anni a Palermo, può essere pensato come una delle tante ondepropagatesi dalla “lezione”, per me sempre presente, di Pasquale Culotta, maestro indimenticato.
Andrea Sciascia
EDAebook 05
In copertina: Vincenzo Melluso, Il sasso lanciato nello stagno, 2014
0_copertina e quarta.qxp_Layout 1 09/12/14 16:10 Pagina 1
20,00 euro
ISBN 978-88-548-7953-9
EDAebook
La Collana, promossa dal Diparti-mento di Architettura dell'Uni-versita! di Palermo (d’ARCH), sipropone di diffondere le ricerchedei docenti italiani dell'area08D (progettazione architetto-nica, architettura del paesaggio,architettura degli interni ed ur-banistica) nonche" dei docentidelle universita! straniere impe-gnati in attivita! di ricerca in-tegrata sui suddetti temi ed in-teressati a far conoscere inambito internazionale e accade-mico la propria attivita! didat-tica e di studio. La scelta delformato e-book facilitera! la dif-fusione presso gli studenti chepotranno consultare i contenutiutilizzando il tablet o anche unnormale pc, ingrandendo le imma-gini ad alta risoluzione.I temi delle pubblicazioni sa-ranno centrati sul progetto diarchitettura e del paesaggio,analizzeranno l’opera di grandiarchitetti, nonche" di importantiesempi di architettura.Sono previste pubblicazioni inlingua italiana, inglese, spa-gnola, tedesca e francese.
0_Indice_08.11.qxp_Layout 1 09/12/14 23:53 Pagina 1
EDAebook
DirettoreOlimpia NiglioKyoto University, Japan
Comitato scientificoGiuseppe GuerreraUniversita! degli Studi di PalermoTaisuke KurodaKanto Gakuin University, Yokohama, JapanRube"n Herna"ndez MolinaUniversidad Nacional, Bogota", ColombiaAlberto ParducciUniversita! degli studi di PerugiaPastor Alfonso Sa"nchez CruzUniversidad Auto"noma “Benito Jua"rez“ de Oaxaca, Me"xicoEnzo SivieroUniversita! Iuav di Venezia, VeneziaAlberto SpositoUniversita! degli Studi di Palermo
0_Indice_08.11.qxp_Layout 1 09/12/14 23:53 Pagina 2
scritti diValentina Acierno
Cesare AjroldiMarcella AprileGaetano Cuccia
Giuseppe Di BenedettoGiuseppe Guerrera
Renzo LecardaneManfredi Leone
Giuseppe MarsalaVincenzo Melluso
Emanuele PalazzottoMarcello Panzarella
Adriana SarroMichele SbacchiAndrea SciasciaZeila Tesoriere
Giovanni Francesco Tuzzolino
a cura diAndrea Sciascia
0_Indice_08.11.qxp_Layout 1 09/12/14 23:53 Pagina 3
Copyright © MMXIVAracne editrice S.r.l.
via Raffaele Garofalo, 133/A-B00173 Roma(06) 93781065
ISBN XXX-XX-XXX-XXXX-X
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,di riproduzione e di adattamento anche parziale,con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopiesenza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: dicembre 2014
La cura redazionale del volume è di Zeila Tesoriere.Il volume è stato impaginato da Simona Marchello e Guido Ospedale.
Università degli Studi di PalermoDipartimento di ArchitetturaVolume pubblicato con il contributo dei fondi di ricerca FFR 2012
0_Indice_08.11.qxp_Layout 1 09/12/14 23:53 Pagina 4
10-11 Nota introduttiva12-17 La didattica del progetto a Palermo
Andrea SciasciaCoordinatore del CdL LM4_PA
18-21 Laboratorio I di progettazione architettonicaMarcello Panzarella (coordinatore), Gaetano Cuccia, Giuseppe Marsala, Michele Sbacchi
22-41 Sulla didattica del primo anno Marcello Panzarella
42-61 Progetto di un’abitazione unifamiliare in un contesto urbanoGaetano Cuccia
62-81 Come abitiamo?Giuseppe Marsala
82-97 Regole per costruire in campagnaMichele Sbacchi
98-101 Laboratorio II di progettazione architettonicaAndrea Sciascia (coordinatore), Emanuele Palazzotto
102-121 Abitare insiemeAndrea Sciascia
122-137 Tra i luoghi dell’incompiutoEmanuele Palazzotto
INDICE ... nella continuitàLa didatticadel progetto aPalermo
0_Indice_08.11.qxp_Layout 1 09/12/14 23:53 Pagina 5
138-141 Laboratorio III di progettazione architettonicaGiovanni Francesco Tuzzolino (coordinatore), Giuseppe Di Benedetto, Adriana Sarro
142-161 Architettura e spazi per l’accoglienza a LampedusaGiovanni Francesco Tuzzolino
162-181 Didattica e percorsi progettualiGiuseppe Di Benedetto
182-201 Nei luoghi dell’accoglienza. Progetti didattici per l’isola di LampedusaAdriana Sarro
202-205 Laboratorio di architettura degli interniVincenzo Melluso (coordinatore), Gaetano Cuccia, Giuseppe Marsala
206-223 A casa del signor G. Progetti per un interno. 19 committenti, 54 cittàVincenzo Melluso
224-243 Un’architettura ipogea. Progetto del rifugio di un guardaboschiGaetano Cuccia
244-263 Il progetto di interni come architettura della post-productionGiuseppe Marsala
0_Indice_08.11.qxp_Layout 1 09/12/14 23:53 Pagina 6
264-267 Laboratorio IV di progettazione architettonicaCesare Ajroldi (coordinatore), Valentina Acierno, Zeila Tesoriere
268-285 L’ordine dell’architetturaCesare Ajroldi
286-305 Progettare la complessitàValentina Acierno
306-325 Esperienza della didattica. Architettura e infrastruttura nella città contemporaneaZeila Tesoriere
326-329 Laboratorio di arte dei giardini e architettura del paesaggioMarcella Aprile (coordinatore), Manfredi Leone
330-347 Paesaggio e cittàMarcella Aprile
348-367 Il paesaggio necessarioManfredi Leone
368-371 Laboratorio V di progettazione architettonicaVincenzo Melluso (coordinatore), Giuseppe Guerrera, Renzo Lecardane
0_Indice_08.11.qxp_Layout 1 09/12/14 23:53 Pagina 7
372-389 Non c’è forma che non si trasformi. Palermo: città come esperimentoVincenzo Melluso
390-407 La didattica del progettoGiuseppe Guerrera
408-427 Territori mediterranei. Progetti per Palermo 2019, Trapani 2020, Marsiglia 2030Renzo Lecardane
428-437 Note biografiche
0_Indice_08.11.qxp_Layout 1 09/12/14 23:53 Pagina 8
11
Il libro, nella sua struttura, fa riferimento al quadro didattico delCorso di Laurea quinquennale in Architettura, a ciclo unico, diPalermo. In questo sistema trovano posto, per tutte e cinque leannualità, i laboratori di progettazione architettonica e urbana aiquali si aggiungono, al terzo anno, il laboratorio di architetturadegli interni, e al quarto quello di arte dei giardini e architetturadel paesaggio. Il volume offre al lettore la possibilità di conoscere,per l’intero quinquennio, le modalità di insegnamento e gli esitiraggiunti delle materie appartenenti ai settori scientifico-disciplinari ICAR 14, 15 e 16, da qualche tempo inclusi nell’unicomacrosettore 08 D1 Progettazione Architettonica. Si tratta dellafotografia di un lavoro in fieri che riunisce gli autori dellapresente pubblicazione in un unico momento di comune riflessione. È un lavoro che sembra ripetersi di anno in anno, ma che in realtà sirinnova giornalmente attraverso il rapporto con gli allievi e la lorocrescita quotidiana. Allo stesso tempo, questa istantanea è utile agli stessi studenti perriflettere su quanto fatto e su quanto resta da fare nel loro percorsoe ai colleghi di altri atenei per produrre un utile confronto.
Nota introduttiva
0.1_Nota introduttiva (5).qxp_Layout 1 04/12/14 14:11 Pagina 11
Didattica e percorsi progettualiGiuseppe Di Benedetto
163
PremessaAggregare e integrare costituiscono le locuzioni principali,fondative e di strutturazione della stessa idea progettuale chedoveva essere perseguita dagli studenti, in relazione alle finalita!d’uso proposte dal programma del corso, incentrato sul temadell’architettura per l’accoglienza. Aggregare significa, comerecitano i dizionari, «unire insieme, associare, ammettere a farparte di un gruppo», o con valore di reciprocita! dei soggettidell’azione aggregativa puo! significare: «associarsi, unirsiinsieme». Con altro significato, puo! anche voler dire: «sommareinsieme dati parziali per ottenere dati globali relativi adeterminati fenomeni»1.Integrare, invece, puo! significare: «completare, rendere intero operfetto, supplendo a cio! che manca o aggiungendo quanto e! utile enecessario per una maggiore validita!, efficienza, funzionalita!»; ein un’azione riflessiva e reciproca puo! indicare il «completarsil’un l’altro: parti, elementi, attivita!, forze che si integrano avicenda». Il termine integrare puo! significare anche «comporsiarmoniosamente, adattarsi perfettamente, o costituire un’unita! organica
Laboratorio III di progettazione architettonicaa.a. 2012-2013prof. G. Di Benedetto
CollaboratoriG. BadamiL. BarraleD. CardamoneG. Licata
3.2_Giuseppe Di Benedetto_08.11 .qxp_Layout 1 04/12/14 13:00 Pagina 163
e funzionale di forze, di mezzi e risorse»2. In ogni caso l’azionedell’aggregare e dell’integrare, sia nelle relazioni tra individui siain architettura, non comporta alcuna forma di omologazione o di perditadelle individualita! e delle identita! iniziali di ciascun soggetto,elemento o attore che partecipa alla duplice azione di confluenzaassociativa.Da qui, l’idea che il centro comunitario per l’accoglienza,l’aggregazione e l’integrazione interetnica doveva essere immaginatocome assemblaggio di diversi elementi tipologicamente individuabiliper differenze, condensati all’interno del disegno unitario di unmanufatto architettonico complessivo.Nella proposta ideativa si doveva evitare di pervenire alladefinizione di un’architettura compatta regolata da semplici leggidi simmetria, o a un impianto progettuale stabilito dal disegno diuna figura principale che determina anche la disposizione dellefigure secondarie per mezzo di rapporti di subordinazionegerarchica. Al contrario, ogni singolo elemento della composizionedel progetto (spazi per le attivita! ricettive e di aggregazione, dimeditazione spirituale, mensa e alloggi) doveva assumere una sortadi autonomia e individualita! formale, riconoscibile in se".Aggregare significa d’altronde, come si diceva all’inizio, mettere
Giuseppe Di Benedetto
164
pagina seguenteAree di progetto(dall’alto in basso):batteria del porto diSant’Erasmo;Cala e Castellammare;porto dell’Addauraarea dell’ex cantierenavale Roma e dell’Istituto deipadri vocazionisti Roosevelt
3.2_Giuseppe Di Benedetto_08.11 .qxp_Layout 1 04/12/14 13:00 Pagina 164
Giuseppe Di Benedetto
166
insieme cose diverse per farne una sola, poiche! gli elementiarchitettonici utilizzati possano essere uniti perdere la loroindividualita".
Metodologia didatticaL’esperienza didattica progettuale e" stata incentrata attorno adalcune questioni proprie della metodologia d’insegnamento delladisciplina, con specifico riferimento alla declaratoria del profilodella materia, che possono essere cosi" sintetizzate:- incoraggiare gli studenti ad un uso divergente delle categorie dipensiero e degli schemi interpretativi dati, al fine di una miglioree cosciente comprensione delle modalita" attuative, dei principi,delle regole di strutturazione e delle logiche organizzative chestanno alla base di un modo attuale del comporre in architettura;- offerta di letture interpretative di repertori progettuali, permezzo della formazione di quadri comparativi definiti non peranalogie funzionali o formali delle opere, ma per similitudini oantitesi concettuali, affinita" delle strutture formative e assuntiteorici sottesi alla condizione figurale dell’architettura stessa;- dimostrazione di come il processo progettuale, a prescindere dalsuo grado di complessita", debba essere inteso come iter variamente
3.2_Giuseppe Di Benedetto_08.11 .qxp_Layout 1 04/12/14 13:00 Pagina 166
A. Colace, centro di accoglienzainteretnica nell’areadella batteria delporto di Sant’Erasmo
3.2_Giuseppe Di Benedetto_08.11 .qxp_Layout 1 04/12/14 13:00 Pagina 167
Giuseppe Di Benedetto
168
articolato che necessita di uno specifico atteggiamentometodologico e operativo a garanzia di una disponibilita! assolutaalla verifica, ai riscontri critici e sperimentali di quelle ideeche risultano fondative della personale concezione architettonica.Non ultima tra le questioni metodologiche emergenti nella didatticadel progetto, vi e! stata quella relativa al disegno. Alla capacita!dello studente, quindi, di saper trasmettere e comunicare le proprieidee e i risultati via via raggiunti mediante l’impiego di strumentiappropriati e di modalita! rappresentative e illustrative efficaci,proprie dello specifico disciplinare. Non a caso si parla dirappresentazione e non di disegno, perche" essa nei termini delpensiero filosofico e! un atto conoscitivo (progettare e! conoscere)intermedio tra sensazione-percezione e l’intellezione3.
Obiettivi formativiL’obiettivo del laboratorio, sulla base del profilodell’insegnamento, e! consistito nell’indurre a riflessioni sui modidi affrontare gradualmente un progetto di architettura,soffermandosi su alcuni aspetti propri del processo formativo dellostudente riassumibili nella necessita! di trovare la giusta misuradi uno spazio architettonic. Nell’ottenere una corretta
pagina seguenteM. Messana, centro di accoglienza interetnica all’Addaura
3.2_Giuseppe Di Benedetto_08.11 .qxp_Layout 1 04/12/14 13:00 Pagina 168
Giuseppe Di Benedetto
170
interpretazione della logica dei principi compositivi, nel prenderecoscienza della nozione di luogo, acquisendo la capacita! direlazionare il progetto ad un determinato contesto fisico.L’analisi del rapporto tra progetto di architettura e contesto, inquanto connaturato e pertinente all’architettura stessa e archetipofondativo della disciplina, e! utile all’individuazione di temiprogettuali fondamentali letti attraverso i concetti di identita! edifferenza, continuita! e discontinuita!. In tal modo, si e! cercatodi far comprendere allo studente l’inscindibilita! esistente tra ilmomento analitico-conoscitivo e il momento sintetico-progettuale.L’esperienza progettuale didattica si e! configurata come unprocesso graduale che tenta di risolvere attraverso successiveapprossimazioni, con una lenta e paziente riflessione fatta dipiccoli passaggi, il complesso sistema di relazioni che ogniprogetto pone in atto.
I luoghiIl tema del laboratorio e! stato localizzato a Palermo in tre diversearee lungo la costa: nei pressi della Batteria del porto diSant’Erasmo; in via del Castello, nei pressi del porto della Cala;lungo il litorale dell’Addaura, in un’area a valle della strada
pagina seguenteM. Messana, centro di accoglienza interetnica all’Addaura, modello
3.2_Giuseppe Di Benedetto_08.11 .qxp_Layout 1 04/12/14 13:00 Pagina 170
Giuseppe Di Benedetto
172
lungomare Cristoforo Colombo; all’interno dell’ambito spazialedell’ex Cantiere navale Roma e dell’Istituto dei padri vocazionistiRoosevelt.Tutte e tre le aree, immaginate come possibili ideali approdi, sonolegate dalla prossimita! a piccole o grandi aree portuali enell’essere possibili capisaldi del paesaggio urbano lungo la lineadi costa. Il mare con le sue forme di percorribilita!, alternative a quelladella terraferma, appare l’elemento di maggiore connessione tra letre aree, in grado di costituire quegli aspetti di tramite e dilegame che trasformano singoli episodi in sistema di particoncatenate.Rispetto alle relazioni istituite con i nuclei urbani consolidatidi riferimento, esse risultano aree non omologabili, nella loroirrisolta identita! rispetto alle particolarita! ambientali estoriche ancora espresse, al valore delle preesistenze contenute,e ai caratteri architettonici delle possibili nuove edificazioni.I luoghi oggetto dell’intervento possiedono caratteri peculiari,ma risultano notevolmente differenziati per le rilevanti relazioniistituite con gli aspetti urbani e paesaggistici.In tutti i casi sono stati richiesti agli studenti un’attenta
pagina seguente E. De Blasi, centrodi accoglienza interetnica all’Addaura
3.2_Giuseppe Di Benedetto_08.11 .qxp_Layout 1 04/12/14 13:00 Pagina 172
Giuseppe Di Benedetto
174
riflessione e un approccio progettuale sensibile e ampio. Dalleproposte progettuali doveva emergere, cioe!, un’idea di architetturarisultante dai caratteri dei luoghi, soprattutto se, come in questicasi, essi sono ricchi di valori ambientali.
Struttura del corsoL’attivita! del laboratorio e! stata articolata in diverse fasiprincipali. La prima fase, con carattere introduttivo, e! statabasata sia sull’indagine conoscitiva dei luoghi sia sull’analisi ede-costruzione critica di progetti esemplari (i riferimenti),indirizzata all’individuazione delle regole formative e diordinamento degli elementi costitutivi i singoli progetti mediantespecifici tagli analitici e metodologici. In questa fase si e!definita la metodologia di approccio alle problematiche teoricheche la pratica del progetto di architettura pone in atto. La suafinalita! principale e! consistita nell’orientare le scelte operativesuccessive. La seconda fase e! stata caratterizzata dallo sviluppopreliminare dell’ipotesi progettuale, alle scale architettonicheadeguate, a partire dai riferimenti precedentemente studiati dagliallievi che hanno costituito dei modelli critici per i loroprogetti, quasi un repertorio di archetipi formali in grado di
pagina seguenteS. La Puma, centro di accoglienza interetnica all’Addaura, piantadel primo livello
3.2_Giuseppe Di Benedetto_08.11 .qxp_Layout 1 04/12/14 13:00 Pagina 174
orientare, logicamente e coerentemente, lo sviluppo di un percorsoprogettuale personale.La terza fase, infine, e! stata dedicata all’approfondimento proget-tuale definitivo secondo gli orientamenti espressi nella fase pre-cedente, tendendo al pieno soddisfacimento degli obiettivi fissatidal corso. Le diverse dimensioni delle ipotesi di progetto sonostate riguardate da due diversi punti di vista: quello dellerelazioni con il luogo e quello della sua specifica autonomia.Questo stadio di progettualita! ha costituito il passaggio obbligatoverso il seminario di progettazione conclusivo svolto secondo varilivelli di approfondimento, tutti finalizzati al compimentodell’esperienza didattica del laboratorio.
Esiti didatticiAgli studenti sono stati richiesti livelli di approfondimentoprogettuale differenziati, per assicurare la qualita! del lorolavoro, rispondenza alle finalita! stabilite, soddisfacimento dellerichieste del programma.In particolare, per le aree di progetto localizzate all’Addaura ea Sant’Erasmo, tenuto conto dei loro attuali elementi morfologici,e! stato necessario individuare strategie d’intervento che
Giuseppe Di Benedetto
176
pagina seguenteS. La Puma, centro di accoglienza interetnica all’Addaura, modello
3.2_Giuseppe Di Benedetto_08.11 .qxp_Layout 1 04/12/14 13:00 Pagina 176
Giuseppe Di Benedetto
178
privilegiassero gesti formali di accompagnamento alle condizionitopografiche dei due diversi luoghi. La valorizzazione deitracciati preesistenti e il paesaggio sono stati assunti comeindicatori principali della qualita! ecosistemica di questicontesti. Cio! ha comportato che gli interventi dovessero mantenereuna chiara visione paesistica, ove le ipotesi trasformative fosseroconcepite in stretta relazione ai valori orografici, morfologicied estetici delle aree. Si e! trattato, talvolta, di agire anchemediante la sistemazione del suolo, intervenendo soprattutto sullastruttura dei percorsi e dello spazio aperto. Le forme emergentidel paesaggio antropogeografico di queste aree (i residui dellabatteria fortificata di Sant’Erasmo, le rampe dello scalo di alaggioall’Addaura) sono state reinterpretate come gli elementi principalidei loro fattori identitari. Il perseguimento progettuale di un’ ecologia della visione haconsentito di isolare singole vedute, immaginate come quadriambientali, la cui sequenza ha ricondotto all’unita! del raccontodella scena paesistica, attuata mediante l’individuazione di unarete di percorsi e di punti di osservazione gettata sulle aree diintervento come una mappa di scorci contemplativi.In tutti i casi, i luoghi di accoglienza, aggregazione e
pagina seguenteC. Asta, centro di accoglienza interetnica all’Addaura
3.2_Giuseppe Di Benedetto_08.11 .qxp_Layout 1 04/12/14 13:00 Pagina 178
Giuseppe Di Benedetto
180
integrazione interetnica sono stati immaginati come ambiti disvolgimento di vita di una piccola comunita! piu! che mai aperta agliscambi relazionali con l’esterno; priva, cioe!, di qualsiasi formadi ghettizzazione e di isolamento. Il programma funzionale ha tenutoconto sia di una dimensione di vita comunitaria e associativa, chedelle esigenze del vivere individuale o di piccoli nuclei familiariche si ricompongono. Per tale ragione, gli alloggi dovevano essereconcepiti tenendo conto di esigenze differenziate: suddivisione persesso, per etnie, per nuclei familiari e presenza di minori. Inogni caso, essi dovevano offrire condizioni di autonomia e diindipendenza dei servizi annessi, assicurando un’organizzazione perpiccoli raggruppamenti.Particolare attenzione si e! richiesta nella definizione degli spaziaperti di relazione, con l’intento di connotarli come luoghi diriferimento per i momenti qualificati di aggregazione collettivasia della comunita! insediata, sia di quella locale, suscitando unasensazione di familiarita! e di civilta! urbana.
3.2_Giuseppe Di Benedetto_08.11 .qxp_Layout 1 04/12/14 13:00 Pagina 180
Didattica e percorsi progettuali
181
Bibliografia essenziale- PalermoSalvatore Mario Inzerillo, Urbanistica e societa! negli ultimi duecento anni aPalermo. Crescita della citta! e politica amministrativa dalla “ricostruzione” alPiano del 1962, Quaderno dell’Istituto di Urbanistica e PianificazioneTerritoriale della Facolta! di Architettura di Palermo, n.14, Stass, Palermo 1984.- Tema progettualePasquale Culotta, Andrea Sciascia, L’architettura per la citta! interetnica,L’Epos, Palermo 2005. Giuseppe Di Benedetto, Adriana Sarro, Giovanni Francesco Tuzzolino, Nei luoghidell’accoglienza, Aracne, Roma 2014.- Composizione/progettazioneFranco Purini, Comporre l’architettura, Laterza, Roma-Bari 2000.Angelo Torricelli, Oltre lo specchio, la forma, in Dove va l’architettura, a curadi M. Fagioli, Aio!n, Firenze 2011.- Riflessioni sugli assunti teorici dell’architetturaPeter Zumthor, Pensare architettura (1998), Electa, Milano 2009.Francesco Venezia, Che cosa e! l’architettura, Mondadori Electa, Milano 2011.
Note1 Devoto-Oli. Vocabolario della lingua italiana, Mondadori, Milano 2014, voce Aggregare.2 Idem, voce Integrare.3 Cfr. V. Ugo, Mi"me#sis. Sulla critica della rappresentazione dell’architettura,Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN) 2008. Osserva Vittorio Ugo ad esergodel volume: «Assunta la centralita! del progetto quale forma specifica della conoscenzaarchitettonica, la rappresentazione si configura come luogo privilegiato tanto dellasua formazione ed elaborazione, quanto dell’interpretazione e dell’analisi criticadell’opera edificata. La rappresentazione va allora intesa come struttura tecnica econcettuale che regola e gestisce, in entrambi i versi, il completo rapporto cheintercorre tra gli ambiti obiettivamente eterogenei delle parole e delle cosedell’architettura progettata».
3.2_Giuseppe Di Benedetto_08.11 .qxp_Layout 1 04/12/14 13:00 Pagina 181
Giuseppe Di Benedetto (1961), dottore di ricerca (Palermo) ericercatore in Composizione architettonica e urbana presso ilDipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo.Sino al 2012 ha insegnato Museografia presso l’Accademia di Belle Artidi Palermo. Al suo attivo ha una lunga esperienza di ricerca sulladidattica del progetto e sulla storia urbana. Su questi temi hapubblicato saggi e volumi, tra cui: La scuola di architettura diPalermo, 1779-1865 (Roma 2007), Per un atlante dell’architetturamoderna in Sicilia (Palermo 2012). Ha partecipato a concorsi diprogettazione ottenendo riconoscimenti e primi premi: Museo laFabbrica di Guglielmo a Monreale (con Studio Azzurro, 2010);Architettura e Cultura Urbana al XXIII Seminario Internazionaledi Camerino (2013). È autore di diversi interventi di restauro edi allestimenti museali.
Giuseppe Guerrera (1948), è professore ordinario di Composizionearchitettonica e urbana presso il Dipartimento di Architetturadell’Università degli Studi di Palermo, di cui è componenete dellaGiunta. Coordina il master Architettura per l’archeologia e ilprogetto LIFE natura GECO. È membro del gruppo degli Advisor dellaTriennale di Milano e direttore della rivista «URUK-Overview onarchitecture». È stato visiting professor presso il Pratt Institutedi New York, USA (1986–1989) e presso il V.P.I. di Blaksburg inVirginia, USA (1990). È membro del Comitato Scientifico del seminarioIl progetto pubblico per l'architettura del terzo millennio (1996). Hadiretto il «Giornale dell’Architettura» (1993–2002) e l’Editrice MEDINAdi Palermo (1990–2002). Nel 1987 è stato invitato alla mostre: Le cittàimmaginate (Triennale di Milano), L'architetto come sismografo (1996) eNext (2002, Biennale di Venezia). Ha svolto incarichi professionali e diconsulenza per enti pubblici e committenti privati. Principalipubblicazioni: Contaminazioni (2005), «URUK» (2010-2012), I tre paesaggidella Conca d’Oro (2012), Le diverse forme del paesaggio (2013).
8_Note biografiche_30.11_9.qxp_Layout 1 11/12/14 21:35 Pagina 431