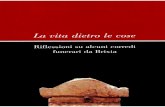Le parole delle cose e i morti fradici nella vigna muranese di d'Annunzio
Transcript of Le parole delle cose e i morti fradici nella vigna muranese di d'Annunzio
Direttore : Cesare De MichelisCondirettori : Armando Balduino,Saveria Chemotti, Silvio Lanaro,
Anco Marzio Mutterle, Giorgio TinazziRedazione : Beatrice Bartolomeo
*
Indirizzare manoscritti, bozze, libri per recensionie quanto riguarda la Redazione a : « Studi Novecenteschi »,
Dipartimento di Italianistica, Università di Padova(Palazzo Maldura), Via Beato Pellegrino 1, i 35137 Padova.
*
« Studi Novecenteschi » è redatto nelDipartimento di Italianistica, Università di Padova.
Registrato al Tribunale di Padova il 17 luglio 1972, n. 441.Direttore responsabile : Cesare De Michelis.
*
Per la migliore riuscita delle pubblicazioni, si invitano gli autoriad attenersi, nel predisporre i materiali da consegnare alla Redazione
ed alla casa editrice, alle norme specificate nel volumeFabrizio Serra, Regole redazionali, editoriali & tipografiche,
Pisa · Roma, Serra, 20092 (Euro 34,00, ordini a : [email protected]).Il capitolo Norme redazionali,
estratto dalle Regole, cit., è consultabile Online alla pagina« Pubblicare con noi » di www.libraweb.net.
*
« Studi Novecenteschi » is an International Peer-Reviewed Journal.The eContent is Archived with Clockss and Portico.
anvur: a.
www.libraweb.net
Fabrizio Serra editorePisa · Roma
xxxix, numero 84, luglio · dicembre 2012
rivista di storia della letteraturaitaliana contemporanea
Indirizzare abbonamenti, inserzioni, versamenti e quanto riguardal’amministrazione a : Fabrizio Serra editore®, Casella postale n. 1,
Succursale n. 8, i 56123 Pisa, [email protected]
*
Uffici di Pisa : Via Santa Bibbiana 28, i 56127 Pisa,tel. 050/542332, fax 050/574888, [email protected]
Uffici di Roma : Via Carlo Emanuele I 48, i 00185 Roma,tel. 06/70493456, fax 06/70476605, [email protected]
*
I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o Online sono consultabilipresso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net
Print and/or Online official subscription prices are availableat Publisher’s web-site www.libraweb.net.
*
Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione,l’adattamento, anche parziale o per estratti, per qualsiasi uso e con
qualsiasi mezzo effettuati, compresi la copia fotostatica, il microfilm,la memorizzazione elettronica, ecc.,
senza la preventiva autorizzazione scritta dellaFabrizio Serra editore®, Pisa · Roma.
Ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.
*
I diritti di riproduzione e traduzione sono riservati per tutti i paesi.
Proprietà riservata · All rights reserved© Copyright 2013 by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma.
Fabrizio Serra editore incorporates the Imprints Accademia editoriale,Edizioni dell’Ateneo, Fabrizio Serra editore, Giardini editori e stampatori in Pisa,
Gruppo editoriale internazionale and Istituti editoriali e poligrafici internazionali.
Stampato in Italia · Printed in Italy
issn 0303-4615issn elettronico 1724-1804
275
SOMMARIO
scrittori del novecento
Giovanni Accardo, Il senso della realtà nell’opera di Luigi Ma- lerba 279
saggi
Monica Lanzillotta, Gli svelamenti ironici di Dinner party di Pier Vittorio Tondelli 317Valentino Baldi, Zeno dopo Freud 345Lucilla Lijoi, Xevno~ e Bavrbaro~. Lettura dell’Ospite di Cesa- re Pavese 371Saverio Vita, Rimozione freudiana e riemersione letteraria nel Male Oscuro di Giuseppe Berto. Il sogno della libreria Rossetti 399Christopher Nissen, Le parole delle cose e i morti fradici nella vigna muranese di d’Annunzio 415Maria Borio, Metropoli e pensiero tragico : un’analisi dell’opera di Milo De Angelis 433Giulia Guarnieri, La Spartenza : l’indentità frammentata di un emigrante in America 451
recensioni
Beniamino Mirisola, Debenedetti e Jung. La critica come pro- cesso di individuazione (Veronica Tabaglio) 467
Note sugli autori 471
Norme redazionali della casa editrice 473
415
LE PAROLE DELLE COSE E I MORTI FRADICI
NELLA VIGNA MURANESE DI D’ANNUNZIO
Christopher Nissen
La valle dei sette morti’ è un racconto di fantasmi notevolmente diffuso nella laguna veneta. Le versioni stampate, che includo-
no quelle di Manlio Cortelazzo, Pietro Ermanno Serena, Umberto Bognolo, Dario Galimberti, Alfonso Lanza, Domenico Perini e Jan Morris, derivano perlopiù da Chioggia, ma alcune rivelano legami con altre comunità lagunari. 1 Esse variano nei particolari, ma non nel nucleo essenziale : sei (o talvolta sette) pescatori, essendo andati sulla laguna a pescare, trovano un morto annegato, e lo portano su un’isola dove li aspetta un ragazzo, che prepara loro da mangiare. Per burla, i pescatori mandano il ragazzo ad invitare il morto a pran-zo, ma quando il ragazzo riferisce loro che il morto ha accettato dav-vero l’invito, rimangono agghiacciati dalla paura. I pescatori, dopo che il morto si era recato a tavola, muoiono tutti in modo misterioso fuorché il ragazzo, che in tutte le versioni fugge e rimane l’unico
1 Si vedano M. Cortelazzo, Una leggenda dei pescatori veneti, « Lares » xxviii, 1962, pp. 122-128, che provvede tre versioni dialettali di Chioggia, di Grado, e di Muggia ; P. E. Serena, Fior da fiore. Poesie dialettali, Venezia, Zanetti, 1920, pp. 38-44 (di Murano, in versi dialettali) ; U. Bognolo, Venezia nel prodigio. La leggenda e il miracolo, Venezia, « Gazzettina illustrata » ix, 1931, pp. 231-234 (di Venezia, in italiano) ; D. Galimberti, Meteorologia popolare chioggiotta. Due leggende chioggiotte, Udine, Del Bianco, 1943, pp. 15-16 (di Chioggia, in italiano) ; A. Lanza, I canti de la mia laguna, a cura di F. Lanza, Varese, Pin, 1957, pp. 54, 58 (di Chioggia, in pochi versi dialettali di un canto rimasto incompiuto) ; D. Perini, La vale dei sete morti. Storia ciosota, Chioggia, avis Comunale di Chioggia, 1977 (di Chioggia, in versi dialettali) ; J. Morris, Venice, Londra, Faber, 1993, pp. 293-295 (di Venezia, raccontata in inglese ed ambientata sull’isola lagunare ‘Cason dei setti morti’). Si veda anche D. Coltro, Leggende e racconti popolari del ve-neto, Roma, Newton, 2010, pp. 134-135, che offre un rimaneggiamento in italiano del racconto chioggiotto di Cortelazzo. Nella terminologia lagunare, ‘valle’ vuol dire un tratto di acqua circonvallato dalle isole che impediscono la fuga dei pesci ; A. Lanza, op.cit., p. 55, nota, e M. Cortelazzo, op. cit., p. 123, nota.
‘
Christopher Nissen
416
testimone. In ogni variante della narrazione, ci sono sette morti : al-cune volte ci sono sette pescatori morti, altre sei pescatori ai quali si aggiunge il morto annegato.
L’atteggiamento irriverente dei pescatori verso il morto, il cui ca-davere viene spesso montato sulla prora della barca dopo esser stato pescato, dà una dimensione morale alla vendetta dell’annegato in tutte le versioni elencate sopra. Nella versione di Bognolo, il ragaz-zo Zanetto soffre di fame perché i pescatori « malvagi » gli negano la polenta a meno che non riuscirà a far venire a tavola l’annegato. L’annegato, che Zanetto crede un semplice dormiglione, si rianima solo quando il ragazzo disperato prega San Teodoro (U. Bognolo, op. cit., p. 233). La versione trascritta in versi dialettali dal chioggiotto Perini, il quale dice di averla tramandata da suo nonno, ci offre una visione apertamente allegorica in termini cristiani : i sei pescatori rappresentano sei dei sette peccati mortali, e come dice egli stesso, l’annegato è il settimo, l’ira, mentre il ragazzo, detto il figlio di uno dei pescatori, rappresenta l’innocenza. 1 Pure nel racconto di Galim-berti l’annegato dichiara di essere il settimo peccato, senza precisa-re il peccato specifico (D. Galimberti, op. cit., p. 16). Nell’esempio di Perini e in quello di Cortelazzo derivato da Muggia, si racconta che i pescatori trasgredirono le norme religiose andando a pescare a Ognissanti invece di onorare i morti. 2 Dal punto di vista folkloristi-co, il racconto fa parte di un motivo ben diffuso, quello del fantasma che si lamenta del trattamento del proprio cadavere, combinato con il tema della vendetta del convitato di pietra (anch’esso un fantasma) nelle varie narrazioni di Don Giovanni. 3 Ma nel caso dei ‘Sette mor-
1 Pure la versione incompiuta di Lanza offre un’interpretazione similmente al-legorica, come scrive l’editore, suo figlio Franco, in una nota ; però in questo caso i peccati sono rappresentati tutti e sette dai sette pescatori stessi, anziché dal morto (A. Lanza op. cit., p. 58). L’influenza di Lanza su Perini è evidente anche nei nomi che questi dà ai pescatori, che derivano in gran parte dall’abbozzo descritto nella nota di Franco Lanza (A. Lanza, op. cit., p. 58).
2 Per i racconti dei fantasmi che riguardano i pescatori veneti, e anche le supersti-zioni lagunari della notte dei morti, si vedano R. Battaglia, Folklore delle lagune vene-te, « Riviste di antropologia : atti della Società romana di antropologia », xxvii, Roma, Società romana di antropologia 1925-1926, pp. 22-23 ; e la rima ‘La note dei morti’ di A. Lanza (A. Lanza, cit., pp. 14-15).
3 Per i motivi dei morti che si vendicano si vedano S. Thompson, Motif-Index of Folk Literature, 6 voll., Bloomington, Indiana University Press, 1957, motivi E200-299, specialmente E235 ‘Return from dead to punish indignities to corpse, or ghost,’ e E235.2 ‘Ghost returns to demand proper burial’ ; e anche M. Milani, Streghe, morti
Le parole delle cose e i morti fradici nella vigna muranese di d’Annunzio
417
ti’ si tratta di un morto rianimato, di un cadavere che cammina e parla, invece di un fantasma nel senso tradizionale.
Questo racconto trascende i limiti della letteratura regionale folkloristica in una sola occasione, quando trova un posto di rilievo nella Licenza alla Leda senza cigno, una delle opere della cosidetta ‘fase notturna’ di Gabriele d’Annunzio. Questa versione, che prece-de cronologicamente tutte le altre elencate sopra, è indubbiamente quella più conosciuta, ma anche poco studiata nonostante la sua unicità rispetto al racconto tradizionale. Le fonti letterarie di questo episodio, in cui d’Annunzio offre al lettore una delle sue visioni più straordinarie dell’estetismo della morte nel contesto della Grande Guerra, presentano una confluenza singolare di un testo classico con il racconto popolaresco dei fantasmi, ambedue atti, tramite una concezione particolarmente dannunziana, ad esprimere non solo l’irrequietezza delle vittime di mala morte, ma anche il senso di col-pa del sopravvissuto.
Due sono le opere narrative di d’Annunzio che comprendono più spiccatamente le esperienze dell’autore a Venezia durante la guer-ra : il poema in prosa Notturno (1921), e la Licenza, l’opera della sua produzione memorialistica che venne pubblicata accanto al breve romanzo La Leda senza cigno nel 1916. Sia il Notturno sia la Licenza trattano in maniera autobiografica le riflessioni sull’arte e sulla vita dell’autore mentre si riprendeva nella sua casa veneziana da una feri-ta all’occhio, subita in conseguenza di un incidente aereo nel febbra-io del 1916. I temi principali del libro, che è fatto di episodi sconnes-si come le altre opere memorialistiche di questa fase dannunziana, includono le riflessioni sulla guerra e sull’alleanza ideale tra le due genti latine, i francesi e gli italiani. Solo in certi momenti l’autore descrive le visioni-rimembranze che pullulano sullo schermo del suo occhio ferito dopo l’incidente aereo, le quali invece sono centrali nel meno realistico Notturno. Una di queste visioni della Licenza riporta d’Annunzio indietro nel tempo durante una serata passata in una vigna sull’isola di Murano, la serata in cui egli sente raccontare ‘La valle dei sette morti.’ 1
ed esseri fantastici nel Veneto oggi, Padova, Esedra, 1994, pp. 231-233. Per le origini della leggenda del convitato di pietra e dei morti scherniti che fanno visita ai banchetti, vedi A. Farinelli, Don Giovanni, Milano, Bocca, 1946, pp. 39-57.
1 Le vigne di Murano e di Burano risultano infestate dai fantasmi o dalle streghe anche in altri racconti lagunari ; cfr. R. Battaglia, op. cit., pp. 25, 35.
Christopher Nissen
418
L’episodio esordisce con un riferimento a Circe, incarnata dal-la compagna che l’autore chiama ‘Nontivolio’ (in realtà la france-se Odette Hubin), che nella fantasia dell’autore porge una pozione misterica ai convitati della sua isola, suggerendo fin dall’inizio l’at-mosfera di un racconto di trasformazioni fantastiche in un contesto mitologico e conviviale che si estenderà nella prima metà dell’epi-sodio :
La vita è bella. Sotto le pergole di quella vigna Nontivolio avrebbe dovuto curvarsi come la grande Circe quando versa il filtro nelle coppe delle mense collocate presso il suolo. Era una vigna di Murano, una solitaria vigna in pergole, appena appena inclinata verso l’acqua, all’estremità dell’isola. 1
Lo scrittore arriva a Murano di sera con un gruppo non identificato di compagni. Prima vedono « un monastero senza monache », para-dossalmente « popoloso e vuoto » siccome è affollato di donne cen-ciose e di bambini malati i quali muovono il narratore a sdegno ; però lì si vede pure « l’ara di un vetraio... un cuore di fuoco domato » una visione che in altri luoghi delle sue opere l’autore utilizza come me-tafora affascinante dell’atto creativo. 2 L’atmosfera si va paganizzan-do sempre di più : il monastero pieno di pezzenti ripugnanti, privo di monache e quindi di santità in termini cristiani, adesso acquista una nuova aria santa nella forma dell’ara infuocata del vetraio, un’im-magine che suggerisce i riti pagani del sacrificio. Successivamente la metafora si trasforma in una similitudine dove si rivela il senso del rito e dell’ara, che ricorrerà più volte nell’episodio, la similitudine dell’oggetto di vetro lavorato : passeggiando tra le viti della vigna, la brigata vede tutto « come in un’opera di vetro freddo e verde » (p. 1044), come se fosse « un che di vitreo, un che di fragile, qualcosa come un ghiaccio verdiccio che s’incrinasse, che si screpolasse » (p. 1045). La vigna si descrive come « un labirinto di pergole basse » sot-
1 G. d’Annunzio, La Leda senza cigno, racconto seguito da una licenza, a cura di N. Lorenzini, in Prose di romanzi, edizione diretta da E. Raimondi, ii, Milano, Monda-dori, 1989, p. 1044. L’episodio della vigna di Murano è la terza di una serie di cinque sezioni consecutive della narrazione che elogiano la bellezza della vita, ciascuna in-testata con la frase anaforica « La vita è bella ».
2 G. d’Annunzio, Licenza, cit., p. 1044. Per il fascino ricorrente delle vetrerie di Murano, vedi G. d’Annunzio, Taccuini, a cura di E. Bianchetti e R. Forcella, Milano, Mondadori, 1965, pp. 205-207 ; G. d’Annunzio, Il fuoco, in Prose di romanzi, ii, cit., pp. 432-439 ; e G. d’Annunzio, Il compagno dagli occhi senza cigli, in Prose di ricerca, a cura di A. Andreoli e G. Zanetti, i, Milano, Mondadori, 2005, p. 1451.
Le parole delle cose e i morti fradici nella vigna muranese di d’Annunzio
419
to cui la gente è costretta ad andare quasi carponi, cercando una via d’uscita (p.1045). Si finisce nella parte più remota dell’isola, sulla sponda della laguna, in un luogo già frequentato dai pescatori. Si tro-vano oggetti rotti e abbandonati che rimandano all’idea di persone che muoiono da sole in acqua :
V’era legato a un piuolo, con una corda stramba, un sandalo marcito ; e un mozzicone di remo, una forcola consunta, una gottazza senza manico da-vano al silenzio raccolto in quel legno cavo una tristezza umana che faceva pensare agli annegati solitarii. (p. 1045)
Gli oggetti inanimi suscitano le emozioni umane, e danno avvio al tema dei naufraghi tristi, un tema caro a d’Annunzio in questo pe-riodo, siccome ha la testa adombrata dai compagni caduti in mare durante la guerra, come vedremo.
La brigata sente, di là dagli sterpi, « l’afa dell’acqua morta, sciacquii e fruscii misteriosi nel limaccio. Erano i serpi che calavano ad accop-piarsi con le anguille in amore ? » (p. 1046). Pure il motivo dei serpenti che si accoppiano con le anguille suggerisce un legame con i misteri del mondo classico, poiché risale al bestiario dello scrittore romano Eliano. 1 Sono i suggerimenti vagamente minacciosi di invisibili atti sconvolgenti e subliminali che forse si trovano in tanti altri momenti del simbolismo dannunziano ; però qui, in un contesto apertamente autobiografico, si presentano con un’immediatezza che trascende qualsiasi astrazione lirica : si ha l’impressione che questa gente sia davvero qui sulla sponda selvaggia di Murano, ad esaminare gli strani oggetti e a sentire i rumori turbanti che suggeriscono le perversioni impossibili. Il gruppo si sente trascinato da una strana apprensione, e i loro corpi non sembrano più normali, come se stessero sull’orlo di una trasformazione misteriosa in qualcosa di verde, simile al « vetro verde » dell’ambiente stesso :
Non so che apprensione ci respingeva verso i dubbii intrichi della vigna. Erravamo ancóra di pergola in pergola, abbassandoci, risollevandoci. Vede-vamo sopra ogni pampano una stella, posata come un acino di luce. Tasta-vamo i grappoli immaturi per trovare un granello meno acerbo. Ci pareva che l’umidità c’inverdisse fino alla cintola. Il bianco degli occhi, in chi mi camminava allato, era stranamente bianco. (p. 1046)
1 C. Eliano, La natura degli animali, a cura di F. Maspero, Milano, Rizzoli, 1998, pp. 90-93 (i, 50), e pp. 578-581 (ix, 66).
Christopher Nissen
420
D’Annunzio e i suoi amici arrivano poi alla destinazione fatale, a un luogo che si dimostrerà abitato dai fantasmi e dalle visioni dei cada-veri ambulanti.
A un crocicchio ci abbattemmo in una tavola rustica, senza tovaglia, intorno a cui erano disposte le scodelle e le panche. Non v’era alcuno seduto, se non una figura di spavento. Noi ci sedemmo, trasognati, obbedendo a una sùbita stanchezza. (p. 1046)
La brigata ha scoperto un luogo che una volta era conviviale, ma adesso è permeato da un’atmosfera di trance che richiama quella del ladro stanco e sbadigliante del canto venticinquesimo dell’Inferno di Dante, anch’egli sull’orlo di una trasformazione, anch’egli schiavo di un potere soverchiante. 1 C’è anche la suggestione di una seduta spiritica, con la brigata di trasognati raggruppata intorno a una vec-chia tavola rovinata dalle intemperie, nella presenza di « una figura di spavento » Il termine trasognare, già caro a d’Annunzio, segnala la presenza di un imminente assalto psicologico, un contrasto spesso violento tra la realtà e la fantasia, come si vede in una definizione che lo scrittore aveva offerto nel Venturiero senza ventura delle Faville del maglio, in un capitolo del 1899 :
Quante volte la mia vita non è se non trasognamento ! Sognare è una cosa, trasognare è un’altra. La realtà mi si scopre a un tratto e mi si approssima con una sorta di violenza imperiosa... A un tratto ella si dissolve, si difforma, si trasforma, assume l’aspetto del mio più segreto fantasma. 2
È proprio lui, il più segreto fantasma dello scrittore trasognato, che sta per fargli visita nella vigna. A qualcuno del gruppo che accom-pagna l’autore a Murano, mai identificato, viene l’idea di raccontare una storia di fantasmi proprio come se fosse reale, poiché la tavo-la stessa è descritta come un vero ricordo di quell’avvenimento ag-ghiacciante :
Allora ci fu uno che ruppe il silenzio per dire : “Questa tavola è fatta col fasciame della barca che pescava l’alga nella Valle dei sette morti.” Vi sono parole che sembrano crearsi nell’aria indistinta e non portare la forma delle labbra note. Vi sono le parole delle cose e non soltanto le lacrime delle cose,
1 Dante, La divina commedia, i, xxv, vv. 88-90, a cura di N. Sapegno, Firenze, La nuova Italia, 1984.
2 G. d’Annunzio, Il venturiero senza ventura, in Prose di ricerca, i, cit., p. 1104.
Le parole delle cose e i morti fradici nella vigna muranese di d’Annunzio
421
reali le une e le altre. Udendo quelle, non le attribuimmo a una gola amica ma a uno spirito che dimorasse in quel luogo o vi passasse. (p. 1046)
È notevolissimo qui l’eco di un verso del primo libro dell’Eneide di Virgilio, allorché Enea vede le immagini della guerra di Troia dipinte sui muri del tempio di Cartagine e si consola al pensiero dell’univer-salità della compassione umana : « ...sunt hic etiam sua praemia lau-di/ sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt » (qui pure la gloria ha il suo premio, e le pene hanno lagrime, toccan le cose degli uomini l’animo). 1 Il mondo dei misteri pagani suggerito dal riferi-mento a Circe all’inizio dell’episodio, e poi dall’ara infuocata e dai serpi che si accoppiano stranamente con le anguille, viene rafforzato dal richiamo a un verso virgiliano tanto famoso per la sua ambigui-tà : per secoli i classicisti non hanno saputo interpretare esattamente cosa intendesse Virgilio con queste « lacrimae rerum ». 2 Però tale am-biguità serve perfettamente al filosimbolista d’Annunzio, per il quale la suggestione vale tanto più della chiarezza. Enea sta commentando un caso di ekphrasis, cioè, la descrizione dell’arte visuale in un’opera letteraria ; così il lettore capisce che le cose artificiali, in qualsiasi for-ma, possono servire misteriosamente a comunicarci i veri sentimen-ti, proprio come gli oggetti abbandonati dai pescatori all’orlo della vigna suggeriscono all’autore della Licenza « una tristezza umana ». 3 In questo momento, d’Annunzio adotta il tema virgiliano del potere trascendente delle arti, e lo trasferisce alla propria narrazione. Se le lacrime possono incorporare le cose meste, e quindi diventare qual-cosa di diverso dalle vere lacrime, ci sono anche delle parole che non sono come le vere parole : sono qualcosa d’altro, qualcosa che non si identifica, qualcosa che sa comunicare senza essere formato dalle labbra umane. La voce del narratore si sente, ma chi è questo narra-tore ? D’Annunzio non lo ha mai rivelato, e così si ha l’impressione che le parole si formino dall’aria o da uno spirito che si sente ma non si vede. Il potere delle parole di suscitare le apparizioni è anche
1 Virgilio, Eneide, i, vv. 461-462, trad. di R. C. Onesti, Torino, Einaudi, 1967, 2 Per uno studio comprensivo dell’ambiguita` di questo verso, si veda D. Whar-
ton, Sunt lacrimae rerum : An Exploration in Meaning, « The Classical Journal » ciii, 3, 2008, pp. 259-279.
3 D’Annunzio richiama questi versi virgiliani anche nel Compagno dagli occhi senza cigli, dove servono ad attenuare un suo « sgomento ignoto » : « Mi riveleva forse Vergi-lio le lacrime delle cose ? o ero nato per adunarle in me e per temprarne la mia stessa amarezza ? » G. d’Annunzio, Prosa di ricerca, i, cit., p. 1508.
Christopher Nissen
422
centrale nel concetto di d’Annunzio della sua arte ‘notturna,’ come scrive in un passo della Licenza che si trova poco prima dell’episodio di Murano :
V’era, qua e là, alcun tratto d’arte notturna. V’erano parole d’uno strano potere, che sembravano tracciate a occhi chiusi. Tra riga e riga, gli aspetti della vita assumevano il carattere delle apparizioni. 1
Nella vigna di Murano, il lettore sarà nello stesso tempo anche lo spettatore della messa in scena di questo concetto : il ruolo delle pa-role e della loro capacità di suscitare le apparizioni nell’arte notturna dannunziana.
Un altro aspetto centrale della produzione notturna di d’Annun-zio si rivela nella metafora virgiliana che egli adotta per descrivere la genesi del Notturno, asserendo di averlo scritto, mentre era accecato, su delle strisce di carta, le cosidette « foglie sibilline ». 2 Così si riaffer-ma l’ambiguità di comunicazione che si diffonde per queste opere : come dice Virgilio nei libri terzo e sesto dell’Eneide, e poi ribadisce Dante nel canto 33 del Paradiso, le cose che le Sibille scrivono sul-le foglie, soggette ai capricci del vento, non sono affatto affidabili. 3 Laddove Virgilio e Dante insistono sulla necessità morale che ci si rivolga ai mezzi più sicuri della comunicazione, evitando i pronun-ciamenti che si scrivono sulle foglie effimere, d’Annunzio si compia-ce di chiamare apertamente i suoi scritti ‘sibillini,’ in quanto godono della moltiplicità di interpretazioni che le parole offrono al lettore, e anche del suggerimento che i suoi scritti abbiano vaghe qualità divine. Come ha notato Barbara Zandrino, le parole delle Sibille non sono le nostre parole, e la loro maniera di scrivere sulle foglie diventa per d’Annunzio l’essenza di un nuovo stile, « l’allegoria dell’essenzia-lità e della frammentarietà di questa scrittura notturna ». 4
Nonostante la centralità di questa metafora virgiliana nel Nottur-
1 G. d’Annunzio, Licenza, cit., p. 1037. Sul significato di questo passo nel contesto dell’arte ‘notturna,’ si veda G. Luti, D’Annunzio notturno e l’avanguardia storica, in D’Annunzio notturno. Atti dell’viii Convegno di studi dannunziani, Pescara 8-10 ottobre 1986, Pescara, Centro nazionale di studi dannunziani, 1987, p. 114.
2 G. d’Annunzio, Notturno, in Prose di ricerca, I, cit., pp. 162, 167, 353, 390, 393, 402-403. Le foglie sibilline si menzionano anche in G. d’Annunzio, Licenza, cit., p. 1035.
3 Virgilio, Eneide, cit., iii, vv. 441-452, e vi, vv. 74-76 ; Dante, La divina commedia, iii, a cura di N. Sapegno, Firenze, La nuova Italia, 1981, vv. 65-66.
4 B. Zandrino, La scrittura dall’ipogeo : il Notturno di Gabriele d’Annunzio, in D’An-nunzio notturno, cit., p. 220.
Le parole delle cose e i morti fradici nella vigna muranese di d’Annunzio
423
no, la presenza di Virgilio nelle opere notturne di d’Annunzio non è affatto imponente, rispetto a quella di Dante, la quale traspare in quasi ogni pagina ; e più volte è stata vista, inoltre, l’influenza di Dan-te sulla ripresa del tema delle foglie sibilline in d’Annunzio, invece dell’influenza di Virgilio. 1 Poiché è rarissimo trovare una citazione diretta del poeta romano quale « le lacrime delle cose », in questo ca-so il richiamo virgiliano spicca in maniera notevole, attissimo ad at-tirare l’attenzione del lettore. In effetti, la citazione dell’Eneide, che prende lo spunto dalla menzione della ‘Valle dei sette morti,’ do-vrebbe segnalare una chiave di lettura virgiliana di tutto l’episodio della vigna muranese, così carico di riferimenti ai misteri del mondo pagano : se riconosciamo in Virgilio il poeta della compassione uni-versale, delle lacrime delle cose e della variabilità dell’espressione ar-tistica, egli è anche il poeta dei morti irrequieti in mare, che sono di-sposti a lamentarsi del trattamento del proprio corpo nel sesto libro dell’Eneide. D’Annunzio richiama l’ambiguità d’espressione implicita nelle lacrime delle cose per preannunciare la visione di un fantasma di tipo virgiliano, uno che somiglia proprio ai compagni di Enea che si lamentano della mancanza della sepoltura decorosa di qua dallo Stige, negli inferi dell’Eneide : Oronte, Leucaspi, e Palinuro. 2
All’occhio ferito di d’Annunzio, che sta seduto alla tavola nella vi-gna con la testa tra le mani, viene una visione macabra del cadavere di uno dei suoi compagni di guerra, il sardo Roberto Prunas, mentre si aspetta che la voce misteriosa cominci a raccontare ‘La valle dei sette morti’ :
Tenevo le palpebre socchiuse ; e rivedevo – con l’occhio che non riconosce più i viventi ma riconosce i fantasmi – rivedevo Roberto Prunas, il mio com-pagno sardo, caduto nella laguna con le ali rotte, rivoltolato e trascinato dal-la corrente, non ritrovato se non dopo molti giorni dai palombari, laggiù,
1 Cfr. P. Valesio, Dante e D’Annunzio, in D’Annunzio a Yale : Atti del Convegno, Yale University, 26-29 March, 1987, Quaderni dannunziani iii-iv, 1988, pp. 191-222 : 192 ; P. Vale-sio, Gabriele d’Annunzio : The Dark Flame, New Haven, Yale University Press, 1992, pp. 94-95 ; F. Spera, Le forme del racconto notturno, in D’Annunzio notturno, cit., p. 212 ; e G. d’Annunzio, Licenza, cit., la nota di N. Lorenzini sulle Sibille, p. 1443.
2 Virgilio, Eneide, cit., vi, vv. 333-383. Pure l’episodio celebrato di Polidoro, la cui anima si lamenta del sepolcro impio tramite un ramo sanguinante, va ammesso a questo elenco, anche se Polidoro non fu naufragato (Virgilio, Eneide iii, vv. 19-68). Gli echi virgiliani sono evidenti anche nel lamento di Manfredi riguardo al maltratta-mento del proprio cadavere nel Purgatorio iii, vv. 130-132 (Dante, La divina commedia, ii, a cura di N. Sapegno, Firenze, La nuova Italia, 1968).
Christopher Nissen
424
agli Alberoni, tutto disfatto nel sacco del suo gabbano, con mezza carne del viso distaccata dal teschio. (p. 1047)
Il mero ricordo della leggenda contribuisce alle allucinazioni dell’au-tore, che adesso immagina di essere anch’egli sott’acqua, alla presen-za di qualcosa di marcio e di spaventoso : « V’era, in quel verdore di sott’acqua, non so che spavento bianchiccio ». 1
Il verdore della vigna è diventato il verdore del mare in cui il ca-davere dell’annegato si rotola, e d’Annunzio figura sé stesso quasi come se fosse un partecipante alla disgrazia, sott’acqua con il morto. In preda alle visioni, egli non sa più se ascolterà una narrazione o guarderà gli avvenimenti nella loro realtà :
L’antica leggenda lagunare trasformava la vigna in barena. Ascoltai ? o guar-dai ?Sette uomini dei lidi, raccoglitori d’alga, passando con la barca lungo una barena, scoprirono il corpo d’un annegato che giaceva sul fianco tra i fiori di tapo, deposto dalla magra. 2 Non gli s’appressarono per tirarlo a bordo o
1 G. d’Annunzio, Licenza, cit., p. 1047. ‘Bianchiccio’ è fra gli aggettivi preferiti da d’Annunzio per descrivere i cadaveri fradici in mare ; cfr. G. d’Annunzio, La contem-plazione della morte, in Prose di ricerca, ii, cit., p. 2176 ; e un’altra descrizione del cadave-re di Prunas nel Notturno, in G. d’Annunzio, Prose di ricerca, i, cit., p. 357.
2 La voce tapo (bassofondo, barena), piuttosto rara nei dialetti veneti e non at-testata nemmeno in G. Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, Venezia, Cecchini, 1867 (si veda G. d’Annunzio, Licenza, cit., p. 1444, dove la nota fa pensare che tapo sia invece una specie di fiore), dà rilievo all’influenza su d’Annunzio di Biagio Marin (1891-1985), un poeta di Grado la cui prima raccolta di rime dialettali si chiama ap-punto Fiuri de tapo e include tra i suoi temi quello dei fantasmi non sempre quieti e delle ossa abbandonate che si sporgono dalle barene lagunari (B. Marin, Fiuri de tapo, Gorizia, Seitz, 1912 ; ristampa anastatica Grado, Edizioni della laguna, 1991). La presenza di Marin nella Licenza si conferma non solo nei vari riferimenti ai « fiori di tapo » in un contesto funebre (si veda anche la p. 1061, dove d’Annunzio scrive « fiuri de tapo » alla gradese, e inoltre in due luoghi di G. d’Annunzio, Taccuini,cit., lxxxi, 757, e xciii, 857), ma ancora più vistosamente nella citazione diretta di due versi della quarta strofa della rima ‘Canto d’autuno’ di Fiuri de tapo (p. 28), la quale d’Annunzio inserisce nella Licenza in una descrizione della vista di Grado dal suo velivolo :
O Gravo belo, me no posso dìEl canto eterno de la to belessa... (G. d’Annunzio, Licenza, cit., p. 1063).Marin non è menzionato né nelle note di questa edizione della Licenza, né in quel-
le dell’edizione mondadoriana curata da Clelia Martignoni nel 1940, né nelle note a G. d’Annunzio, Taccuini cit. (cfr. quella che spiegherebbe il significato dei fiori di tapo, p. 1319), nonostante la sua influenza evidente su d’Annunzio. Nonostante che le poesie giovanili di Marin tendano a seguire più fedelmente le orme di Pascoli che non quelle di d’Annunzio, in Fiuri de tapo l’ambiente e la tematica dei ‘Sette morti’ so-
Le parole delle cose e i morti fradici nella vigna muranese di d’Annunzio
425
almeno per legarlo con una cima e prenderlo a rimorchio. Passarono oltre. Attesero a raccogliere l’alga. Poi accadde che, venuta l’ora del pasto, si riac-costassero a quella barena per cuocere la polenta e scodellarla.
Era con loro un fanciullo, il figlio d’uno d’essi. E il fanciullo, mentre il paiuolo bolliva, si dilungò dalla barca. Vide sul margine della barena, tra i fiori di tapo, un uomo coricato che non si mosse. Tornò egli al padre, e dis-se : Padre, v’è laggiù uno che dorme. Allora il padre gli fece : Va’, e sveglialo, che venga a mangiare con noi.
Il figliuolo andò, e toccò alla spalla il giacente, un poco lo scosse. L’uomo si svegliò, e si rizzò in piedi, e si mise a camminare dietro il bambino.
I sette avevano già scodellato la polenta ; e s’erano posti innanzi alle sco-delle fumanti, e attendevano.
Come scorsero l’ombra di colui che veniva a mangiare con loro, di sùbito piegarono il capo, né più lo rialzarono ; né fecero motto, né diedero fiato. Così stettero, rimasero. (pp. 1047-1048)
Dopo che la voce misteriosa ha finito il racconto, d’Annunzio alza la testa, e vede il corpo fradicio di Prunas ancora una volta, camminan-do verso lui sotto le pergole.
Allora levai la testa, e guardai. E vidi venire per la notte verde, sotto la per-gola bassa, il corpo alzato di Roberto Prunas nel sacco fradicio del suo gab-bano impellicciato. E la carne macera gli tremolava su l’osso del viso ; e la mascella era scoperta, perché mancava il pezzo del labbro ; e la fossa del naso e un’occhiaia erano vuote. (p. 1048)
E così finisce l’episodio.Nel Notturno, nella Licenza e nelle pagine dei Taccuini che riguarda-
no la guerra, d’Annunzio si ricorda spesso dei suoi giovani compagni che caddero nel mare nei loro aerei. 1 Tra questi morti indimentica-bili ci sono Luigi Bresciani e Roberto Prunas, dispersi nella laguna in un idrovolante il 3 aprile, 1916. Mentre il corpo di Bresciani fu subito ricuperato, quello di Prunas risultò ancora smarrito ; fu ritrovato vi-
no sostanzialmente evidenti nelle poesie ‘Ordole,’ ‘La mota dii Sieghi,’ ‘Le varvuole,’ ‘Caligo,’ ‘De note,’ ‘Sera dei morti,’ e ‘Il simisterio de Barga’ (sul sepolcro di Pascoli). Per la voce tapo nei dialetti veneti e nel volume di Marin si veda M. Cortelazzo, Parole venete, Vicenza, Neri Pozza, 1996, p. 285.
1 G. d’Annunzio, Notturno, cit., pp. 184-211, 260-262, 322-323, 326-330, 357, 382 ; G. d’Annunzio, Licenza, cit., pp. 1005-1006, 1009-1010, 1051-1061 ; G. d’Annunzio, Tac-cuini, cit., pp. 853, 854, 857, 915-17, 919-20, 970, 1002, 1033, 1056, 1144. Nel Notturno, le condizioni del cadavere di Prunas abbandonato in mare vengono descritte anche alle pp. 328-329, 330, e 357.
Christopher Nissen
426
cino ad Alberoni sul Lido e sepolto a San Michele solo dopo qualche giorno. Nei suoi libri memorialistici, d’Annunzio rimane ossessiona-to della morte e dei funerali dei suoi compagni aviatori, ma è solo il fantasma di Prunas che a volte lo spaventa, e che gli dà un senso di colpa, che gli infesta i sogni nella forma di un cadavere disfatto e insepolto.
In un certo senso, Prunas rimane il naufrago eternamente introva-bile, quello a cui si nega la sepoltura per sempre, almeno per quanto riguarda le esperienze di d’Annunzio come le si descrivono nella Li-cenza. L’aviatore sardo viene menzionato nel testo solo una volta do-po la visione di Murano, quando l’autore raggiunge l’isola cimitero di San Michele per cercare « i suoi morti », le tombe di Bresciani e di Prunas, a luglio del 1916 (G. d’Annunzio, Licenza, cit., pp. 1054-1059). Quelle sono le uniche tombe che non riesce a trovare, pur avendo cercato a lungo. Mentre le cerca, d’Annunzio si ricorda delle facce degli amici persi, quella di Bresciani giovane e sorridente, quella di Prunas che invece pare rattristata e invecchiata dai solchi profondi intorno alla bocca, i solchi che l’autore si figura come i canali in cui scorrono le lacrime : « I solchi delle lacrime erano scolpiti nelle gote fin giù al mento. E sembrava che da un momento all’altro dovessero riempirsi » (p. 1056). D’Annunzio trova tante altre lapidi che portano i nomi dei marinari persi in guerra, e si domanda se non si trovino male in questo cimitero decrepito, sotto le croci rotte e le ghirlande artificiali di zinco. Di nuovo gli torna il pensiero del cadavere di Pru-nas, anch’esso forse triste di trovarsi in questo luogo malinconico :
Forse era meglio che Roberto Prunas non fosse ritrovato dai palombari lun-go la diga solitaria. Forse era meglio ch’egli sentisse ancóra passare sopra sé le torpediniere a fuochi spenti in rotta verso i porti dell’Istria. Era meglio che sottomare si cangiasse “in qualcosa di ricco e di strano.” Qui non ha più nome ; né il suo pilota [Bresciani] ha nome. (p. 1057)
La citazione « in qualcosa di ricco e di strano » riferisce all’iscrizione sulla lapide del più illustre dei vari naufraghi di d’Annunzio, il poeta inglese Percy Bysshe Shelley, che morì annegato nel Mar Ligure e fu sepolto al cimitero Testaccio di Roma nel 1822. L’iscrizione, che viene spesso menzionata nelle opere di d’Annunzio, deriva dalla can-zone ‘Full fathom five my father lies’ nel Tempest dello Shakespeare (atto primo, scena seconda), la quale descrive appunto le condizioni del cadavere di un naufrago che giace al fondo del mare con le ossa di corallo e gli occhi di perle ; però la parte eterna di lui subisce un
Le parole delle cose e i morti fradici nella vigna muranese di d’Annunzio
427
cambiamento misterioso sotto il mare, « a sea-change » che lo fa di-ventare qualcosa di trascendente, « something rich and strange ». 1 Se Shelley, un poeta famosissimo dotato di un gran nome nonostante la morte prematura, fu trasfigurato dall’esperienza di essere perso in mare, d’Annunzio vuole immaginare che forse la stessa trasfigu-razione sia successa a Prunas, e così l’aviatore eroico sarà alquanto consolato nel luogo deprimente in cui il suo corpo finì, ingiustamen-te innominato.
Però, va notato che d’Annunzio non trova mai la tomba del suo amico nella descrizione del cimitero che si trova nella Licenza. Con-tinua a cercare le due tombe, finchè non chieda l’aiuto di un custode che gli fa vedere « la cruda miseria » della fossa di Bresciani, la quale è purtroppo priva di nome (p. 1058). Ma della fossa di Prunas d’Annun-zio non scrive più niente, come se non fosse affatto ritrovabile ; e così l’aviatore sardo sparisce dalle pagine della Licenza, in effetti perso per sempre, il naufrago eterno. 2 La sua trasfigurazione in « qualcosa di ricco e di strano » non si attesta mai ; invece, rimane fissa nell’ultima vista che si ha di lui nella vigna muranese : un cadavere ambulante in decomposizione, un corpo empiamente trascurato che sembra di suscitare un senso di colpa nell’autore.
Nel Notturno, mentre la salma di Bresciani sta già nella camera mortuaria a Venezia dove la gente le fa la veglia, il narratore imma-gina che il fantasma di Prunas galleggi nel canale sotto la sua casa, battendo contro il gradino della riva :
1 W. Shakespeare, The Tempest, a cura di N. Frye, in The Complete Pelican Shake-speare : The Comedies and the Romances, Harmondsworth, Penguin, 1969, p. 512. Per i riferimenti alla lapide di Shelley in d’Annunzio, si veda G. d’Annunzio, Licenza, cit., la nota di N. Lorenzini, p. 1447. D’Annunzio abbina Shelley con Prunas, ambedue recuperati tardi dal mare, anche nei Taccuini cxvi ; lì Prunas appare come « un povero cadavere introvabile » (p. 1056). Per altre visioni del cadavere di Shelley nelle opere di d’Annunzio, si vedano G. d’Annunzio, La contemplazione della morte in Prose di ricerca, ii, cit., p. 2114, e G. d’Annunzio, Taccuini vi, cit., p. 81.
2 Questo risultato non riflette ciò che accadde davvero quel giorno nel cimitero, il 21 luglio 1916, siccome gli appunti di d’Annunzio nei Taccuini che descrivono questa stessa visita includono anche un riferimento alla tomba di Prunas : « Su la tomba di Prunas poco strame - Alcune conchiglie nella terra. Un cartoccio di zinco con un poco d’acqua » (G. d’Annunzio, Taccuini xciii, cit., p. 857). Nonostante questo, sem-bra che d’Annunzio voglia escludere ogni riferimento alla riscoperta della tomba del sardo dalla Licenza, appunto per accrescere la percezione di un destino fatale, di un uomo scomparso e abbandonato totalmente.
Christopher Nissen
428
Ecco che il corpo di Roberto Prunas viene a battere contro la riva. Sono tutto di gelo. Egli vuole essere con noi tre. Egli vuole che io l’ami come questi altri due.
(G. d’Annunzio, Notturno, cit., p. 330)
Poco dopo, il narratore accecato si rende conto dall’odore dell’alga morta che è bassa marea, il momento in cui molta gente credeva una volta che si potesse morire, secondo una superstizione prevalen-te nelle regioni marittime d’Europa. 1 Gli penetra fino al cuore « un odore verdastro di tomba umida » (p. 331). Prunas affligge la mente del narratore appunto perchè il suo cadavere è rimasto abbandonato in mare ; quindi vuole che d’Annunzio lo vegli, che lo ami come ama i compagni già ricuperati. In effetti, è un fantasma di lignaggio pret-tamente virgiliano, che rievoca lo spirito del timoniere sciagurato Palinuro, colui che implora ingiustamente e inutilmente il passaggio dello Stige da Enea : « Da dextram misero et tecum me tolle per un-das » (la tua destra da’ al misero, prendi anche me sulle onde, Virgi-lio, Eneide, cit., vi, v. 370). Però, come gli dice la Sibilla, il permesso di passare oltre il fiume gli sarà negato finché la sua salma non sarà ritrovata e sepolta con i riti giusti (vv. 372-376).
Quello che si rivela piuttosto apertamente in questo brano del Notturno è trattato in maniera molto più sottile nella Licenza, attra-verso il riferimento alle lacrime delle cose del Virgilio e il racconto ‘La valle dei sette morti.’ Le parole delle cose dannunziane, suggeri-te dalle lacrime delle cose virgiliane, non sono astrazioni delle cose,
1 L’idea che si può morire solo mentre la marea si sta abbassando risale alla Storia naturale di Plinio (ii, capitoli 101-102) ; si veda Plinio il vecchio, Storia naturale, a cu-ra di F. Della Corte, i, Pisa, Giardini, 1987. Si veda anche A Dictionary of Superstitions, a cura di I. Opie e M. Tatem, Oxford, Oxford University Press, 1989, pp. 406-407. Nel Notturno, la bassa marea si associa anche con il funerale del pilota Giuseppe Miraglia (p. 211), con la vita che s’abassa (p. 272), con la putredine della morte (pp. 327, 328), e con la tristezza del poeta cieco e immobilizzato (p. 262). D’Annunzio trova già un legame tra la bassa marea e il presentimento della morte o le visioni dei cadaveri dei naufraghi in vari luoghi della Contemplazione della morte (1912), ben prima della guerra ; si veda G. d’Annunzio, Prose di ricerca, II, cit., pp. 2135, 2143, 2175 ; e anche G. d’Annunzio, Taccuini lxii, cit., p. 607. Per la bassa marea veneziana come segno del-la morte, si vedano anche G. d’Annunzio, Il fuoco in Prose di romanzi, II, cit., p. 481, e la descrizione delle tombe all’isola di S. Michele in G. d’Annunzio, Altri taccuini, a cura di E. Bianchetti, Milano, Mondadori, 1976, capitolo 35, p. 301, e in G. d’Annun-zio, Licenza, cit., p. 1054.
Le parole delle cose e i morti fradici nella vigna muranese di d’Annunzio
429
sono le cose davvero, in quella maniera incomprensibile delle foglie sibilline, che comunicano senza comunicare. In termini linguistici, si potrebbe dire che il significante di queste parole salta direttamen-te al referente senza ricorrere neanche minimamente al significato. Nella vigna di Murano, dopo la trasformazione effettuata dal tra-sognamento, d’Annunzio non percepisce più attraverso i sensi nor-mali, quindi deve domandarsi, « Ascoltai ? o guardai ? » Le parole si ascoltano, le cose si guardano, per lo meno in teoria ; ma qui tutto si percepisce in una nuova maniera, proprio come la guerra di Troia si percepisce insolitamente negli affreschi del tempio di Cartagine. La prima visione del cadavere fradicio di Prunas sta nella memoria : « rivedevo Roberto Prunas », scrive il narratore, ricordando le visioni già avute del corpo che gli infestano continuamente i sogni, e che si rivelano per lo più tra le pagine del Notturno ; ma lo rivede all’inizio solo con l’occhio morto, « quello che riconosce i fantasmi », quindi si tratta di una semplice visione interiore. 1 Però la seconda visione, che gli viene dopo che ha sentito il racconto, si presenta come un oggetto reale che egli vede davvero, rialzando la testa : « E vidi venire per la notte verde, sotto la pergola bassa, il corpo alzato di Roberto Prunas... » È stato il racconto delle « parole delle cose » a trasformare la visione del compagno morto da una mera memoria a una cosa ap-parentemente tangibile, che sembra di apparirgli davanti agli occhi. Si tratta di quell’assalto della realtà alla fantasia che l’autore conside-ra un aspetto fondamentale del fenomeno del trasognamento.
Le due visioni contrastanti di Prunas sono collegate dal racconto dei sette morti che si colloca al centro delle quali e che viene presen-tato in una forma del tutto unica, rispetto alla tradizione folkloristica che si riflette nelle altre versioni. In questa versione riconcepita da d’Annunzio, non ci sono più i pescatori, in contrasto con ogni altra versione pubblicata del racconto ; invece qui ci sono i più dimessi raccoglitori di alga, l’alga che d’Annunzio presenta continuamente come il simbolo della bassa marea veneziana, quando è esposta e emana l’odore della morte. L’alga evoca il colore verde che si mani-festa dappertutto nella vigna di Murano, un luogo permeato da un
1 Sulla « visionarietà » dell’occhio ferito di d’Annunzio e il suo modo di concepire la realtà con esso, si veda G. Barberi Squarotti, La tragicità notturna, in D’Annunzio notturno, cit., pp. 9-28 ; e R. Mertens-Bertozzi, L’antirealismo di Gabriele D’Annunzio, Firenze, La Nuova Italia, 1954, pp. 61-107.
Christopher Nissen
430
« verdore di sott’acqua ove il respirare era simile al boccheggiare » (p. 1046), in cui ci si sente inverdire « fino alla cintola » (p. 1046) ; inoltre il colore appare anche in vari luoghi del Notturno, sempre associato con la morte. 1 Solo nel racconto di d’Annunzio il cadavere non si ri-pesca dal mare ; invece lo si trova giacente sul fianco, anzi « coricato » come un dormiente, tra i fiori di tapo ; è stato lasciato lì dalla magra, dalla bassa marea che suscita sempre il pensiero fatale. 2 Qui manca perfino un riferimento al testimone oculare, al ragazzo che sopravvi-ve tradizionalmente e riporta le brutte notizie al mondo. Dopo aver invitato il morto a pranzo, di lui non si hanno più notizie ; quindi alla fine del racconto si ha l’impressione che nessuno sopravviva all’in-contro con il fantasma misterioso.
Forse l’aspetto più straordinario della versione dannunziana del racconto è rappresentato dalla mancanza della certezza moralistica, così evidente nelle versioni tradizionali. Il tema centrale della ven-detta dell’annegato è fortemente diminuito nel racconto della Licen-za, nonostante la trascuratezza dei barcaioli che vedono il cadavere tra i fiori di tapo ; in effetti, sembrano più indifferenti che maliziosi,
1 Si veda per esempio questo brano di G. d’Annunzio, Notturno, cit., p. 389 : « Vedo verde. Vedo nell’ombra le mie mani verdi. Tutta la stanza è verde come una pergola folta. È come se avessi la testa avviluppata nel lauro tondo che mi fosse divenuto tut-to di vetro screpoloso ». Subito dopo il fantasma del soldato morto Oreste Salomone sale la scala della casa dello scrittore e gli appare davanti : « La mia visione lo inverdi-sce come se fosse morto da quattro giorni ». Si veda anche l’episodio nel Notturno del « fiotto verde » con cui l’autore scrive i sogni (pp. 284-285) ; e anche G. d’Annunzio, Licenza, cit., pp. 1060, 1064 (« le ombre glauche’ dei morti »). Il legame simbolico tra questo colore e la putrefazione (accanto ai tanti altri significati simbolici che il color verde può reggere) si descrive nel Dictionnaire des symbols : mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, nombres, a cura di J. Chevalier e di A. Gheerbrant, Paris, Laffont, 1969, sotto la voce vert. L’immagine risale anche a un testo chiave del decadentismo europeo ; cfr. il « vert cadavre » di un quadro di Des Esseintes in J.-K. Huysmans, À rebours, Parigi, Union Générale d’Éditions, 1975, p. 129.
2 Il morto che sembra di dormire sui fiori della barena diventa, in un altro luogo della Licenza, l’autore stesso, mentre fantastica dell’ultimo viaggio del sommergibile Jalea, che fu affondato da una mina austriaca nel 1915 : « Così il mio ricordo si con-verte in sogno, mentre coricato su i fiori funerei della barena, supino, attendo che si riparta » (G. d’Annunzio, Licenza, cit., p. 1066). L’immagine di d’Annunzio che giace come un morto richiama la concezione ricorrente del Notturno, in cui l’autore cieco e immobile si immagina già rinchiuso nella bara, pur contemplando e scrivendo (cfr. G. d’Annunzio, Notturno, cit., p. 164 ; e G. Barberi Squarotti, La tragicità notturna, in D’Annunzio notturno, cit., pp. 10, 21-22). I fiori della barena saranno raccolti dall’au-tore per un ultimo ricordo di lutto per i morti del Jalea, da buttare dal suo aereo (G. d’Annunzio, Licenza, cit., pp.1060-1061, 1074).
Le parole delle cose e i morti fradici nella vigna muranese di d’Annunzio
431
e del loro atteggiamento riguardo al morto nulla ci è dato sapere. D’Annunzio vuole dare l’impressione che i barcaioli non si ricordino neppure che il cadavere ci sia, quando tornano alla barena per fare il pranzo. Non mandano il fanciullo ad invitare il cadavere a pranzo per burla : il fanciullo lo trova da sè, per caso, e crede che sia sempli-cemente « uno che dorme ». Il padre del ragazzo gli dice di invitarlo a pranzo senza un’evidente malizia, e l’ambiguità della scena ci invita ad immaginare che forse il padre non si renda conto neppure che si tratti del cadavere incontrato in precedenza. 1 Inoltre, questo rac-conto fatto dalle « parole delle cose » è in gran parte privo di dialogo : il fanciullo non dice niente al morto svegliandolo, e il morto non rimprovera affatto i convitati quando si presenta al loro banchetto. Il racconto si svolge quasi del tutto in silenzio. In ogni altra versione la reazione dei pescatori impauriti e tardo pentiti è sempre un elemen-to essenziale, ma non qui, dove i barcaioli sembrano così trasogna-ti come d’Annunzio e i suoi compagni, quasi indifferenti, piegando la testa in un gesto drammatico appena vedono arrivare l’invitato, accettando, a quanto pare, come l’autore stesso e i tanti martiri di guerra dannunziani, l’inevitabilità della morte.
La crisi virgiliana, sostanzialmente religiosa e quindi condivisa da una società intera, può essere risolta attraverso la sepoltura pia e decorosa dei morti sciagurati ; però la crisi dannunziana, essen-zialmente psicologica e limitata alle esperienze dell’autore stesso, non si risolverà mai. Invece, la si presenta in tutta la sua ambigui-tà, l’ambiguità delle foglie sibilline le quali Virgilio respinge per la loro inaffidabilità nel comunicare la volontà degli dei, l’ambiguità che si esprime addirittura tramite una versione della ‘Valle dei set-te morti’ che si dimostra stranamente priva di contenuto morale. D’Annunzio, sentendosi in un certo senso colpevole del destino del suo compagno perso nella laguna, esprime i suoi sentimenti turbati non solo con un richiamo alle lacrime delle cose e ai morti annegati dell’Eneide, i quali suscitano tanta pietà per i loro cadaveri insepolti,
1 Tra le tante versioni del racconto elencate sopra, solo quella di Perini indica che il ragazzo è il figlio di uno dei barcaioli, come nel racconto di d’Annunzio. Però, nel caso di Perini, non è il padre che manda il ragazzo ad invitare il morto, ma lo fa un altro pescatore. D’Annunzio è l’unico che accresce la dimensione ironica della narrazione, facendo mandare il figlio dal padre il quale forse non si rende conto di commettere un atto essenzialmente peccaminoso che risulterà fatale a sé e a tutti i suoi compagni.