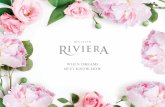Itinerari europei di vita e di cultura. I fratelli Frizzoni in visita a ...
"L’amarezza delle cose belle: villa Velluti tra storia, arte e memoria". Saggio ospitato in...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of "L’amarezza delle cose belle: villa Velluti tra storia, arte e memoria". Saggio ospitato in...
3
LUOGHI E ITINERARI
DELLA RIVIERA DEL BRENTA
E DEL MIRANESE
a cura di
ANTONIO DRAGHI
Volume Quarto
(NB: nel volume originale immagini a colori ad alta
definizione)
PANDA EDIZIONI
4
ISBN 9788899091095
© copyright 2014
Panda Edizioni - C.P. 160 - 31033 Castelfranco Veneto www.pandaedizioni.it
69
L’AMAREZZA DELLE COSE BELLE: VILLA VELLUTI
TRA STORIA, ARTE E MEMORIA di Mauro Manfrin
Tutte le ricerche hanno un’origine, un punto di partenza. La mia ha
inizio da una suggestione, quella della storia dell’evirato cantore1
Giovanni Battista Velluti, la cui voce bellissima possiede, ai nostri
occhi così lontani dai suoi tempi, il retrogusto amaro delle sofferenze
inflittegli per ottenerla. È l’amarezza delle cose belle, quella che
ritroviamo anche nelle poesie o nei dipinti nati dall’espressione
dell’inquietudine dell’animo umano o dai vissuti difficili dei loro
autori. Una malinconica amarezza pervade anche l’ultima dimora del
sopranista, come se certi luoghi si facessero carico per sempre dei
trascorsi dei loro abitanti. Un brano di paesaggio fluviale, tra Dolo e
Mira, tra i più ricchi di fascino, un topos che rimanda a suggestioni
artistiche canore, teatrali, pittoriche e letterarie. La Riviera del Brenta
tutta deve molto a questo luogo che è stato rifugio per artisti la cui
fama, inevitabilmente, ha irradiato tutto il corso del Naviglio.
Impossibile non notare, percorrendo la strada o il fiume, la lunga e
armoniosa cortina grigia di edifici dove il tempo non sembra essersi
fermato, anzi, sembra piuttosto aver voluto sottolineare alcune
caratteristiche di un passato che evidentemente non esiste più. Come
1 Solo una volta userò la definizione di “evirato cantore”, che gli esperti mi
dicono essere il modo più corretto per descrivere tale arte - condizione,
preferendo in seguito usare quelli di “sopranista” oppure “musico”, termine
quest’ultimo ampiamente utilizzato proprio a tal scopo per tutto il ‘700. Mi
sembra doveroso evitare che sia la condizione fisica a pervadere la memoria di
questo grande interprete, entrato a pieno titolo nella storia del teatro.
70
un’anziana signora, rugosa e sfatta, di cui però si intuisce il passato di
bellissima ragazza, magari per gli occhi ancora luminosi e che per
questo risulta tutt’oggi piacevole.
Scorcio autunnale del Naviglio e dei complessi di villa Velluti e villa Tito.
Foto di Lorenzo Fuortiboni, al quale va il mio ringraziamento.
Tra le arti, è la fotografia che riesce a cogliere la malinconia emanata
da questa quinta scenica sul fiume, grazie alla complicità involontaria
di una giornata nebbiosa. I grigi intonaci delle costruzioni si
confondono nella monotonia cromatica della nebbia, come questa
fosse un morbido velo, un sipario immateriale che chiude la stagione
gloriosa della villa. È una “architettura crepuscolare” struggente, che
l’avvicina idealmente alla condizione del suo ospite più illustre, cui si
è legata per sempre, il sopranista Velluti. Il momento del crepuscolo è
una fase di “transizione” tra il giorno e la notte, immagine che Luca
71
Scarlini2 associa al musico quando scrive: “come a tutti coloro che
vivono un'era di transizione, a Velluti toccò quindi l'arduo compito di
essere esotica curiosità per un pubblico da lui diverso: l'arte gli offrì
un ruolo centrale nella società per poi indicargli la strada dell'ombra
tenacemente cercata nel palazzo, avvolto di nebbia e silenzio sulle
rive del Brenta, pieno di ricordi di un tempo tramontato per sempre”.
Il crepuscolo del Velluti ha il colore grigio della nebbia, il colore del
suo palazzo sulla Brenta.
Vi sono dei reticoli invisibili di relazioni e avvenimenti che
trasformano uno spazio fisico - pietre, infissi, arredi - in quello
immateriale dei ricordi, delle esperienze, del vissuto dei suoi abitanti.
Memoria e pietra in alcuni luoghi si intersecano, diventano termini
che rimandano reciprocamente l’uno all’altro. I muri, muti e anonimi
che vediamo continuamente, acquistano nuova luce quando le pietre
cominciano a parlare. Un triste destino il loro: non hanno il diritto
all’oblio e si imbevono dei ricordi, della vita, della storia di chiunque
vi abbia lasciato un segno.
È per queste ragioni che è inutile tentare di descrivere un luogo come
questo con gli unici strumenti dell’architetto o dello storico, perché
non gioverebbe al tentativo di svelarlo. Va piuttosto usato il metodo
del Marco Polo di Italo Calvino quando descrive la città di Zaira3 al
Kublai Khan: “Potrei dirti di quanti gradini sono le vie fatte a scale,
di che sesto gli archi dei porticati, di quali lamine di zinco sono
ricoperti i tetti; ma so già che sarebbe come non dirti nulla” perché
Zaira, come villa Velluti, “non dice il suo passato, lo contiene come le
linee d'una mano, scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle
finestre, negli scorrimano delle scale, nelle antenne dei parafulmini,
nelle aste delle bandiere, ogni segmento rigato a sua volta di graffi,
2 “Lustrini per il regno dei cieli: ritratti di evirati cantori” di Luca Scarlini.
Bollati Boringhieri, 2008. Pagina 83. 3 “Le città invisibili” di Italo Calvino. Einaudi editore, Torino 1972.
Descrizione della città di Zaira in “Le città e la memoria. 3”.
72
seghettature, intagli, svirgole”. Solo così si potrà assaporarne la
bellezza e, volendo, comprenderne l’amarezza.
La ricerca ha inizio dall’analisi di un documento inedito: il Catastico
della Settima Presa4 del 1679, che descrive, tra le altre, le terre di
proprietà5 a Sambruson dei “NN. HH. ser Zorzi e Fratelli Bafi” la cui
conformazione è perfettamente riconoscibile tant’è la precisione
ammirevole del rilievo di Paolo Rossi, perito della Serenissima
incaricato di realizzare la ricognizione. I terreni sono due, divisi dalla
strada - l’attuale via Seriola - e confinano con le proprietà dei Badoer,
principalmente, ma anche di altri Nobil Homini quali “Francesco
Monfardini e Andrea Tascha a levante”. Curiosamente il fronte
canale, ovvero la maresana, ed il vicino ambito che corrisponde
all’attuale villa Tito sono di proprietà di tale “D. Zan Batta Gaglin”
che vi “lauora in casa”.
Queste informazioni sono preziose e confermano quanto già
individuato dal Baldan6, pur con alcune precisazioni. Già nel 1661
risultano proprietari di campi ottanta con casa dominicale7 i figli di
Domenico Baffo: Zan Andrea, Matteo, Sebastian e Zorzi.
4 La “Presa” era un comprensorio in cui veniva attivato un sistema idraulico,
che oltre a evitare inondazioni ed altro, portava vantaggi per l’agricoltura e la
navigazione. Il “Consorzio di Bonifica Settima Presa Superiore” ha avuto
origine dal 1604 ed uno dei pezzi più preziosi della documentazione
dell’archivio, inedito, è del 1679: il “Catastico della Settima Presa della
Brenta che contiene le ville tutte di essa cioè S. Brusò, Gambarare, Lugo, […]
fatto ad ordine delli NN. HH. D. Pietro Sagredo Abbate di San Giorgio
Maggior, […]. Da me Paolo Rossi perito […] l’anno MDCCLXXVIIII”.
Attualmente parte degli Archivi storici delle “Prese” sono gestiti dalla
Fondazione Cassamarca, custoditi nella tenuta di Ca’ Tron di Roncade (TV). 5 Mappali 82 e 83 in proprietà dei “NN. HH. E. Zorzi e Fratelli Bafi” e
lavorate da tale “Zuane Santello”. 6 “Storia della Riviera del Brenta” Volume III di Alessandro Baldan. Moro
Editore, 1980. 7 L’abitazione del “dominus”, il proprietario.
73
Particolare del Catastico della Settima Presa Superiore del 1679 delle
proprietà Baffo a Sambruson.
74
In particolare è Zorzi ad essere più spesso citato dai documenti8,
probabilmente il maggiore dei fratelli.
Secondo i genealogisti i Baffo risiedevano a Venezia fin dal IX secolo
e facevano parte della nobiltà legittimata dalla serrata del Maggior
Consiglio. Zorzi aveva sposato in prime nozze Cecilia Santasoffia9 e il
matrimonio aveva suggellato l'intesa tra una casa della “vecchia”
nobiltà, che si trovava in condizioni economiche non molto floride,
con una casa “nuova”, vale a dire aggregata nel corso della guerra di
Candia o successivamente, che intendeva in cambio di una dote
sostanziosa ottenere appoggi in seno alla classe dirigente10
.
Zorzi Baffo fu il nonno del celebre poeta Zorzi Alvise Baffo,
conosciuto fuori Venezia semplicemente come Giorgio Baffo11
. Il
chiacchierato poeta, noto per la licenziosità dei versi e per essere
maestro e amico di Giacomo Casanova che lo considerava “genio
sublime, poeta nel più lubrico dei generi, ma grande e unico”12
, aveva
solo dieci anni quando nel 1704 i possedimenti di Sambruson vengono
8 “Zorzi e fratelli bafi” è la dicitura più usuale. Zorzi (nome che è
l’equivalente veneziano di Giorgio) ed un fratello, Zan Andrea, erano stati
“titolati” ad entrare nei consigli giudiziari. Il primo era stato provveditore a
Corfù e giudice del Piovego, il secondo era stato camerlengo a Brescia.
L’altro fratello, Sebastian, divenne provveditore di Salò e un “Quaranta”
ovvero apparteneva alla Quarantia, uno dei massimi organi costituzionali
dell'antica Repubblica di Venezia, con funzioni sia politiche che di tribunale. 9 “Grazia Cecilia di Bartolomeo Santasoffia sposa Baffo Giorgio fu Domenico
il 30 aprile 1659” da «Avogaria di comun. Matrimoni patrizi per nome di
donna» periodo 1309 – 1797. Indice manoscritto. ASVe. 10 “Politica e cultura nella Venezia di metà Settecento: la «poesia barona» di
Giorgio Baffo «quarantiotto»” di Piero Del Negro, in COMUNITA' - Rivista
mensile culturale fondata da Adriano Olivetti. Edizione 184, 1982. 11 Nato nel 1694 dai patrizi Zan Andrea e Chiara Querini fu chiamato Zorzi
Alvise in onore dei due nonni, paterno e materno. 12 “Baffo osceno” di Giorgio Baffo, a cura di Marco Dotti e Ludovico Mian.
Stampa alternativa, 2001.
75
venduti dal nonno al N.H. Francesco Vezzi13
. Chissà se, risalendo
pigramente la Brenta da Venezia verso Padova con un burchiello la
notte del 2 aprile 173414
, il poeta Giorgio Baffo, accompagnando
l’attrice e cantante Giovanna Casanova e suo figlio Giacomo di nove
anni, contemplò quei possedimenti che una volta furono del nonno.
Il passaggio delle proprietà Baffo - Vezzi è un tipico esempio di
avvicendamento tra vecchia e nuova nobiltà. Le entrate della famiglia
13 Nel 1704, con atti del notaio veneziano Francesco Brombilla, la proprietà
dei Baffo venne acquistata con quaranta campi da Francesco Vezzi che
abitava a Venezia, e la sua denuncia del 1711 a Sambruson comprende: “casa
domenicale con fabbriche e tutte sue habentie con brolo cinto di muro e
campi 40”. Inoltre egli denuncia a Nervesa altri 630 campi con l'intenzione di
costruirvi “un’altra casa domenicale”. Da “Studio storico ambientale artistico
della Riviera del Brenta” di Alessandro Baldan. Edizioni Bertato, Villa del
Conte, 1995. Pagg. 282 – 283. 14 “Storia della mia vita” di Giacomo Casanova, a cura di Piero Chiara e
Federico Roncoroni. Mondadori, Milano, 1989. Voll. 3, pagg. 28-29. Riporto
parte del brano perché, oltre a raccontare dell’amicizia tra Giorgio Baffo e
Casanova, narra di un “viaggio sulla Brenta” che è l’essenza stessa della
Riviera, sviluppatasi lungo le sue rive: “Il letto era basso e non scorgevo la
riva: attraverso la finestra vedevo solo le cime degli alberi che in due file
ininterrotte fiancheggiavano il fiume. La barca andava con moto così eguale
che non me ne potevo accorgere; così, gli alberi che scomparivano
rapidamente al mio sguardo suscitarono stupore. «Oh madre cara» esclamai.
«Cosa succede? Gli alberi camminano!» In quel momento entrarono i due
signori [...]. Essi risero, ma mia madre sospirò e mi disse in tono
compassionevole: «È la barca che cammina, non gli alberi. Vestiti.» [...]. Sto
quasi per piangere, ma chi mi rende la vita è Baffo, che mi abbraccia e mi
bacia teneramente dicendomi: «Hai ragione tu, bimbo mio. Il sole non si
muove, fatti animo, tira sempre le conseguenze logiche dai tuoi ragionamenti
e lascia che gli altri ridano.» Mia madre gli chiese se era matto a darmi
insegnamenti del genere, ma quel filosofo, senza degnarla di una risposta,
seguitò ad illustrarmi una teoria adatta alla mia mente semplice ed ancora
intatta”.
76
Baffo, nonostante il blasone di antica origine, non erano più molto
floride15
e facevano affidamento unicamente sui “sacchetti” che
ricevevano in quanto membri delle Quarantie. Totalmente diversa la
storia della famiglia Vezzi. Francesco quondam Zuanne Vezzi (1651 –
1740) nacque a Udine in una famiglia modesta e da giovane si spostò
a Venezia dove divenne apprendista di un orafo e nell’ambito di
quest’arte fece una rapida fortuna. Il suo nome resterà per sempre
legato alla vicenda della “Casa Eccellentissima Vezzi” una delle prime
tre fabbriche di porcellana in Europa, la primissima in Italia.
Francesco che, come detto acquisì beni a Sambruson nel 1704, sei
anni dopo ottenne il titolo di conte da Carlo III di Spagna e nel 1716 il
titolo di patrizio veneto in seguito al versamento di centomila ducati,
di cui sessantamila a fondo perduto e il rimanente a sottoscrizione di
un prestito di guerra emesso dalla Repubblica durante l’assedio
dell’Impero Ottomano a Corfù, allora veneziana16
.
Fu però il figlio primogenito di Francesco, Giovanni (1687- 1746), ad
accordarsi con un tale Christoph Conrad Hunger, detentore del
millenario segreto per la realizzazione della porcellana, a dare avvio il
5 giugno 1720 alla realizzazione della famosa Porcellana Vezzi. Egli
investì cinquantamila ducati per avviare la produzione ed Hunger
venne nominato Fabriciere Principale: con il suo ricco bagaglio di
15 In occasione della redecima del 1740, Zan Andrea (il padre del poeta) aveva
dichiarato di possedere, oltre alla casa in cui abitava, soltanto un'altra
proprietà nella campagna trevigiana, affittata ad un altro quarantioto. (ASVe.
Redecime 1740). 16 Documenti: copia della supplica della famiglia Vezzi e della delibera dei
Pregadi presso la Biblioteca del Museo Correr di Venezia, Archivio Donà
delle Rose, 474-101; Commissione araldica «Nobili veneti», indice
manoscritto del 1870 contenente «Elenco delle famiglie insignite di titoli
araldici della Repubblica veneta per conferma o per nuova concessione»,
ASVe. Quest’ultimo rimanda al decreto del Senato e ai Provveditori sopra
feudi, datato “1716.18.3”.
77
esperienze e facendo arrivare il caolino17
clandestinamente dalla
Sassonia, riuscì a portare la manifattura Vezzi ad un immediato
successo.
La storia della porcellana Vezzi è estremamente stimolante e ben
documentata18
, ma qui interessa seguirne un aspetto in particolare: la
successione ereditaria che investì anche i beni di Sambruson.
Dalla ricostruzione fatta dagli storici che hanno tolto dall’oblio la
vicenda, sembra si sia svolta così: il conte Francesco Vezzi, il 15
giugno 1719, mentre si trovava in viaggio a Vienna affida con una
procura tutti i suoi affari ed averi al figlio Giovanni. Quest’ultimo,
forse con l’iniziale aiuto del padre19
, dà avvio all’esperienza della
fabbricazione della porcellana nel 1720, attingendo a piene mani nel
patrimonio paterno che gli era stato affidato. Purtroppo però la
produzione aveva altissimi costi, in particolare per le maestranze
17 Il caolino è una roccia sedimentaria costituita prevalentemente da caolinite
(il nome deriva dalla località di Kao Ling, in Cina), un minerale silicatico
delle argille. La scoperta del primo giacimento europeo nel 1709 da parte
dell'alchimista Johan Friedrich Bottger rese possibile la formulazione della
ricetta per la porcellana. Christoph Conrad Hunger era un collaboratore di
Bottger ed è grazie a lui che il segreto della fabbricazione della porcellana
europea giunse tra le lagune dando origine alla fabbrica Vezzi. 18 Si vedano in merito: “Venezia e la magia dell’oro bianco” di Elisabetta Dal
Carlo in “Arti Decorative a Venezia” speciale a cura di Cinzia Boscolo.
Venice International Fondation, 2010; “Porcellane della Casa Eccellentissima
Vezzi. 1720-1727” di Francesco Stazzi, Milano 1967; “Giovanni Vezzi e le sue
porcellane” di Luca Melegati. Bocca, 1998; “At the Centre of the Old World:
Trade and Manufacturing in Venice and on the Venetian Mainland (1400-
1800)” di Paola Lanaro. Centre for Reformation and Renaissance Studies,
2006; “Privilegi d’industria e diritti di proprietà nelle manifatture di
ceramica della repubblica di Venezia. (XVII-XVIII secolo) di Giovanni Favero
in “Quaderni Storici” 135/a. XLV, n. 3, dicembre 2010. 19 Francesco Vezzi dovrebbe aver convinto Hunger a spostarsi da Vienna,
dove lavorava presso la manifattura imperiale.
78
specializzate20
, i risultati economici ottenuti non erano quelli sperati e
fu così che Francesco, il 10 marzo 1724, decise di trasmettere al figlio
Giovanni la proprietà completa di tutti i capitali già impiegati nella
fabbrica, scindendoli dal resto dei propri beni. Fu un tentativo di
salvaguardare il patrimonio complessivo da un’impresa che sembrava
non riuscire a decollare. Giovanni Vezzi, che aveva legato i destini
della sua manifattura esclusivamente ai finanziamenti del padre, si
trovò a corto di capitali ed incapace di autofinanziarsi poiché tutto ciò
che possedeva risultava già investito. Dopo sette anni di lavorazioni,
di esperimenti e nonostante fosse riuscita finalmente a raggiungere
risultati degni di rilievo sotto il profilo qualitativo e quantitativo, la
Casa Eccellentissima Vezzi chiuse e, per ironia, proprio per volontà
del vecchio Francesco preoccupato del crescente passivo. Nel 1727,
infatti, fu il padre che si offrì di tacitare i creditori a condizione che la
fabbrica fosse chiusa per sempre e i forni venissero distrutti. In seguito
Giovanni ebbe relazioni con Cozzi, Ginori ed altri nuovi imprenditori
nel campo delle porcellane21
. Un amore il suo mai sopito.
Il 17 aprile 1739 Francesco mandò a chiamare un notaio per
consegnargli il suo testamento olografo. Questo si apre con la richiesta
di molte sante messe in suffragio, dispone elargizioni benefiche, e
passa quindi alla destinazione del patrimonio che viene lasciato ai figli
maschi del figlio Giovanni, il quale però non aveva figli maschi bensì
quattro ormai adulte figlie femmine e una moglie troppo cagionevole
di salute per partorire ancora. Francesco aggiunse, infine, che in caso
20 Il segreto della porcellana era stato svelato, ma la differenza tra porcellane
di alta o bassa qualità veniva data dalle caratteristiche delle materie prime e da
accorgimenti tecnici propri delle maestranze, che si vendevano al miglior
offerente. 21 Dopo la chiusura sembra siano rimasti a Giovanni Vezzi molti pezzi non
finiti, probabilmente decorati e passati in terza cottura in forni per maioliche e
messi in vendita da lui stesso fino al 1740 circa, quando risultano concluse le
ultime vendite.
79
di mancanza di figli maschi i beni passassero interamente al Pio
Ospitale della Pietà, che effettivamente ricevette l'intero patrimonio
del vecchio Vezzi.
Ed è così che nel 1740 troviamo che l'ospedale della Pieta di Venezia
denuncia nelle redecime: “rese inutili le pretese dei figli dell’eredità
del conte Francesco Vezzi a Sambruson. Casa domenicale con
fabbriche e brolo cinto di muro, affittato a Rizzi per ducati 120 e a
Nervesa e Soravilla: altra casa domenicale”22
. A onor del vero già
alla visita pastorale del 1739 l’oratorio della casa dominicale risulta in
carico alla famiglia di Gaetano Rizzi, affittuario del Pio Ospedale.
È il primo crepuscolo a cui assistiamo: quello della società dirigente
veneziana. La vecchia nobiltà, rappresentata dai Baffo, cede il posto ai
nuovi nobili, i Vezzi, i quali però si trovano in difficoltà economica
perché non trovano investitori e per la mancanza di ogni tipo di
sussidio pubblico della Serenissima, concesso invece ad altri
imprenditori23
. L’assenza di una manifattura di importanza europea,
come quella Vezzi, si fece presto sentire ed il Senato veneziano
promulgò nel 1728, un anno dopo la chiusura della fabbrica, un
decreto teso ad accordare protezione ed esenzioni fiscali a chiunque si
fosse dimostrato in grado di migliorare la produzione di maiolica e di
introdurre quella di porcellana nello Stato veneto al fine di ridurre
l’importazione dall’estero24
. Ci volle quasi un trentennio per avere una
produzione di porcellane come quella Vezzi, i cui esemplari sono oggi
conservati nei principali musei europei. Se vogliamo è già percepibile
22 “Studio storico ambientale artistico della Riviera del Brenta” di Alessandro
Baldan. Edizioni Bertato, Villa del Conte, 1995. Pagg. 282 – 283. 23 Il sussidio fu ritenuto, forse, poco opportuno nel caso di una famiglia
patrizia veneziana che aveva acquistato il titolo nobiliare da pochissimi anni. 24 La vicenda della partecipazione dello Stato a questa ed altre imprese è ben
descritta in “Finanziamento e governance in un’impresa veneziana del
Settecento” di Riccardo Cella in “Studi e Note di Economia”, Anno XVII, n.
2-2012. Pagg. 297-322.
80
una certa amarezza delle cose belle: l’inseguimento di un sogno
artistico (quello di Giovanni), per la realizzazione delle belle e
preziose porcellane, infranto contro i limiti imposti dalla necessità
imprenditoriale di un adeguato ritorno economico (del padre
Francesco) e dalla società veneziana in cambiamento.
Le tracce lasciate dai Vezzi a Sambruson non sono molte, ma a
Francesco si deve certamente la costruzione dell’oratorio. È del 26
marzo 1734 la concessione della curia vescovile ad edificare un
oratorio pubblico purché sia “decentemente costruito con una sola
porta e quella sulla pubblica strada lontano dagli usi domestici” 25
. È
per questo che sorge così lontano dalla villa, come era in uso per tutti
gli oratori aperti al pubblico. Sarà benedetto il 2 ottobre dello stesso
anno.
La storia dei Vezzi a Sambruson non è comunque destinata a finire
così presto. Alla morte di Giovanni, nel 1746, l’area diventa proprietà
di donna Anzola (Angela) Vezzi fu Francesco, sorella di Giovanni.
Angela è la consorte di Avogadro Marino quondam Vido26
e, ironia
25 Il testo completo della concessione: “Essendo stato visitato il sito nel quale
il N.H. Francesco Vezzi, Patrizio Veneto, desidera far costruire un pubblico
oratorio presso la casa della di lui abitazione posta dentro li confini della
Parrocchia di Sambruson di questa diocesi, ed essendo stato trovato
opportuno come appare attestato dal molto reverendo Don Pietro Barrì
Arciprete della Villa di Sambruson, che di ordine nostro lo visitò, concediamo
licenza a esso Nobil Homo Vezzi di poter fabbricare esso oratorio con questo
che sia decentemente costruito con una sola porta e quella sulla pubblica
strada lontano dagli usi domestici e che il tutto sia fabbricato a norma delle
costituzioni sinodali, dovendo terminata che sia la fabbrica essere a voi fatta
relazione per ordinare la visita prima di rilasciare il mandato per benedirlo.
Datum Padova Cancelleria Episcopali, 26 marzo 1734”. Archivio Capitolare
di Padova. Diversorium. 26 Il matrimonio, celebrato il 25 gennaio 1717, è registrato in «Avogaria di
comun. Matrimoni patrizi per nome di donna» periodo 1309 – 1797. Indice
manoscritto a cura di Giuseppe Giomo. ASVe.
81
della sorte, la troviamo citata ancora ne “La storia della mia vita” di
Casanova: “Nel casino della signora Avogadro, donna spiritosa e
amabile nonostante i suoi sessant'anni, feci la conoscenza di un
gentiluomo polacco, molto giovane, a nome Gaetano Zawoiski. Egli
aspettava del denaro dal suo paese e intanto gliene davano le dame
veneziane, sedotte dalla sua bellezza e dai suoi gentili modi polacchi”.
Secondo gli studiosi del Casanova, non ci possono essere dubbi che si
tratti di Angela Avogadro nata Vezzi, sposa di Marin Avogadro, per il
tipo di donna che si dimostrò essere e poiché era l'unica della famiglia
che in quel periodo aveva l’età indicata dal Casanova.
Fu così che da metà Settecento, e per quasi un secolo, la proprietà
passò alla famiglia Avogadro27
. Dello stesso periodo è la famosa
ricognizione di G. F. Costa28
degli edifici più rilevanti lungo la Brenta.
Frutto di pazienti e scrupolosi rilevamenti effettuati con l'aiuto della
camera ottica, nell'intento di fornire una completa e obiettiva
illustrazione dei luoghi, il lavoro manca della ricognizione dei
possedimenti Vezzi – Avogadro, mentre vi sono tutti gli altri dalla
Mira Vecchia al Dolo. Eppure, come visto, la documentazione
sull’esistenza di edifici dominicali e dell’oratorio non manca. Non
ultimo, esiste la cartografia attribuita ad Antonio Rizzi Zannoni29
che
coincide in larga misura con la coeva ricognizione del Costa, dove
sono indicati due corpi edilizi vicini con uno, o forse due, oratori.
27 La famiglia Avogadro fu inclusa nel patriziato dal governo veneziano,
attorno al 1437-38, nella figura di Pietro Avogadro per l'aiuto militare offerto
alla Serenissima nel corso del consolidamento delle conquiste di terraferma. 28 “Delle delicie del fiume Brenta espressa ne' palazzi e nei casini situati
sopra le sue sponde dalla sboccatura nella laguna di Venezia fino alla città di
Padova disegnate ed incise da G.F. Costa architetto e Pittore veneziano” di
Costa Giovanni Francesco. 2 voll., Venezia, 1750 – 1756. 29 Giovanni Antonio Bartolomeo Rizzi Zannoni (Padova, 1736 – Napoli,
1814) famoso cartografo e geografo noto per alcune restituzioni molto
importanti come “La Gran Carta del Padovano” di fine settecento.
82
Particolare della mappa acquerellata attribuita ad Antonio Rizzi Zannoni di
metà ‘700. Fondazione Bianchi, Mirano, 2005.
Le incisioni delle delicie del Costa hanno permesso ai posteri di
individuare edifici ben più modesti del complesso che noi oggi
chiamiamo villa Velluti. Ma forse non è vero che non ci forniscano
delle informazioni interessanti.
Esaminando con attenzione la Tavola LX del volume primo, “Veduta
del Palazzo del N.H. Molin”, sulla riva destra del fiume risalendolo da
Venezia verso Padova, si scorgono appena dopo l’ansa del fiume,
sottolineata con la presenza di un burchiello che si allontana, due
edifici appena delineati che sembrano trovarsi esattamente in
corrispondenza delle proprietà Vezzi - Avogadro. La verifica è
semplice poiché, avendo usato la camera ottica, il Costa ci permette di
individuare esattamente il punto di presa e replicarlo. In effetti, dove
egli accenna a due edifici vicini e ad un muro di cinta, oggi è
rilevabile il complesso della villa.
83
Veduta del Costa del Palazzo del N.H. Molin. Appena dopo l’ansa del fiume
sono abbozzati due edifici. Il confronto con una foto attuale mostra come nel
medesimo punto oggi si intravveda la mole di villa Velluti.
Si può ragionevolmente pensare che il Costa non abbia disegnato tali
edifici perché, come da lui stesso abbozzato, non erano allora
meritevoli di essere segnalati. Questo potrebbe significare che il
84
complesso architettonico, pur avendo origine dalla fine del ‘600, è
stato totalmente rivisto, inglobato ed allargato, dopo la seconda metà
del ‘700 proprio dalla famiglia Avogadro.
Nel resoconto della visita pastorale del 1778 troviamo che l’oratorio è
di proprietà di Vido Avogadro con dedica alla “Concezione della
Beata Maria Vergine”. Vido, senatore, era uno dei quattro importanti
figli di Marino e Angela Vezzi assieme a Francesco, Claudio e
Giovanni Andrea. Quest’ultimo prese gli ordini come gesuita e
divenne nientemeno che vescovo di Verona.
Successivamente, nel 1797, sono quattro gli Avogadro proprietari
della villa: Claudio per “metà palazzino” e poi i nipoti Costantino,
Piero e Marin in sesta parte per ognuno30
.
Claudio Avogrado, “che sostenne le magistrature di prima istanza
civile e criminale, ed aspirava alla rettoria di Vicenza quando crollò
la Repubblica”31
, entrò nelle cronache e nei pettegolezzi veneziani
perché sposò nel 1783 una donna di “rango inferiore”, una non nobile
30 Possiamo conoscere meglio questi ultimi grazie alle informazioni
genealogiche (vedasi nota successiva) da cui, oltre a venire a conoscenza che
la “nob. Famiglia si mantenne in questo eminente Stato fino alla caduta della
Repubblica […], ottennero la conferma di loro nobiltà colle Sovrane
Risoluzioni di Sua Maestà I. R. A. del 1818”, apprendiamo che si tratta dei
fratelli: Marin Angelo Baldissera del fu Francesco e della nobile sig.ra
Catterina Carminati, nato il 18 giugno 1765; Pietro Maria Gasparo, nato il 9
gennaio 1772 e Costantino Alessandro, nato il 16 novembre 1776,
quest’ultimo congiuntosi in matrimonio colla nobile Catterina Camilla
Soranzo. 31 “Teatro araldico ovvero raccolta generale delle armi ed insegne gentilizie
delle più illustri e nobili casate che esisterono un tempo e che tutora
fioriscono in tutta l'Italia”. Di I. Tettoni e F. Saladini, volume quinto. Lodi,
pei tipi di CL. Wilmant e figli, 1841. In questo testo è visibile un albero
genealogico piuttosto completo nel quale ritroviamo gli stessi nomi emersi
nella ricerca effettuata presso l’ASVe.
85
di nome Marina Dorotea Sanzonio32
. Ebbero un figlio il 14 giugno
1787, Giovanni Andrea fu Claudio che troviamo essere il possessore a
Sambruson di “casa da villeggiatura” e varie “case d’affitto” censite
nel Catasto Napoleonico del 1808. In quello stesso anno ebbe a
sposare la nobile Isabella Maria Boldù33
ed in seguito ebbero sei figli.
Particolare della mappa catastale del Consorzio di Bonifica Settima Presa
Superiore del 1810 circa34.
32 “Protogiornale per l'anno 1787 ad uso della Serenissima Dominante Città
di Venezia”. È riportato il matrimonio, avvenuto nel 1783, all’interno di una
breve lista di matrimoni di patrizi abbienti con donne di diversa condizione.
Era un fatto non rarissimo ma comunque inusuale. 33 “Isabella di Giacomo Boldù sposa Avogrado Giovanni Andrea di Claudio il
6 settembre 1808” registrato in «Avogaria di comun. Matrimoni patrizi per
nome di donna», ASVe. Inoltre, grazie alla raccolta di necrologi “Menzioni
onorifiche de' defunti scritte nel nostro secolo: ossia Raccolta cronologica-
alfabetica di lapidi, necrologie, biografie, prose e poesie dei defunti nell'anno
1846” di Giovanni Battista Contarini, 1854, sappiamo che “nel dì 27
Novembre moriva in Venezia, in età di 72 anni la N. D. Isabella Boldù,
vedova del patrizio veneto Gio. Andrea Avogadro”. 34 “In sancto Ambrosone: uomini ed eventi a Sambruson fra l'alto Medioevo e
il primo Ottocento” di Mario Poppi. Associazione culturale Sambruson la
nostra storia, 2008. Pag. 129.
86
Gli Avogadro ebbero sicuramente la disponibilità economica ed il
tempo per apportare le modifiche ai possedimenti di Sambruson con
quel gusto settecentesco che contraddistingue ancora oggi la parte
centrale della villa.
In seguito, intorno agli anni venti del 1800 (probabilmente nel 1822),
divenne proprietario del complesso l’allora molto noto cantante
Giovanni Battista Velluti.
La storia del sopranista Velluti è l’emblema dell’amarezza delle cose
belle. La sua voce, che veniva considerata simile a quella che
dovrebbero avere gli angeli, era frutto di una menomazione avvenuta
prima della pubertà, in età infantile, allo scopo di mantenere la voce
acuta in età adulta.
Tralascio volentieri la descrizione della pratica terribile35
, inferta con
il benestare delle famiglie di origine a bambini che, semplicemente,
dimostravano buone capacità canore nei cori parrocchiali e che vedeva
una mortalità elevatissima e sofferenze inaudite, per soffermarmi su
questo personaggio assai singolare.
Nato nelle Marche, a Montolmo - oggi Corridonia - il 27 gennaio
1780, giunse in breve tempo ad esibirsi nei maggiori teatri d’Europa,
ottenendo un successo via via crescente. Molti ritengono che divenne
noto, oltre che per le sue eccezionali doti artistiche, per i suoi
atteggiamenti “divistici”. Gli venivano attribuiti amori con le donne
più belle ed esibizioni capricciose di fronte ai vari esponenti di rango
venuti per ascoltarlo, come la principessa del Galles o addirittura
l'imperatore Napoleone, oltre che ai grandi compositori come
Gioachino Rossini. In realtà non è facile sapere come siano andate
veramente le cose. Dobbiamo considerarlo alla stregua di una odierna
“star”, notando come le cronache ottocentesche siano ricchissime di
35 Il tema è stato molto dibattuto in letteratura. È di facile reperibilità il testo
“Lustrini per il regno dei cieli: ritratti di evirati cantori” di Luca Scarlini
(2008), che delinea con poche efficaci pennellate un mondo a noi oggi
incomprensibile.
87
“siparietti” a lui attribuiti in ogni parte d’Europa, ma registrando
anche come la popolarità dell’artista possa aver amplificato oltremodo
fatti piuttosto banali o mai avvenuti.
Sicuramente un dato è importante: il periodo storico in cui trovò ad
esprimersi era in vorticoso cambiamento. Napoleone esportava idee
nuove e lo scontro con l’ancien regime non era solo politico, ma
anche culturale. Si trovò il Velluti, suo malgrado, in mezzo a tale
scontro che interessò tutte le arti ma che trovò nel teatro luogo ideale
di espressione. L’allontanamento delle donne dai teatri non aveva da
tempo più senso agli occhi di tutti, ma si cominciava anche a dare
diverso spazio - dopo un incerto regno del contralto - anche al tenore,
uomo a ogni titolo, anzi sovente prototipo di “macho” che incarna
valori “nuovi” d'eroismo.
Non deve essere stato facile per il Velluti essere l’ultimo esponente di
un mondo che cominciava ad esigere dell’altro. Non a caso è
considerato l’ultimo ad esibirsi nei teatri ed in effetti, pur con qualche
rara eccezione, è quello che avvenne, poiché i suoi pari continuarono
per lo più ad esibirsi nelle chiese sui temi della musica sacra. Si trovò
spesso a confrontarsi tra coloro che lo consideravano un fenomeno da
circo, anacronistico e simbolo di un tempo passato, e coloro che lo
definivano l’ultima voce sublime e grande interprete36
. Ciò non toglie
che le sue soddisfazioni artistiche furono enormi.
36 Si veda in proposito: “Veluti in speculum: The twilight of the castrato” di J.
Q. Davies in Cambridge Opera Journal, Cambridge University Press, Volume
17. Novembre 2005, pagg. 271-301. L’autore gioca con il nome del
Sopranista ed il latino (non è cosa nuova, nel corso dell’800 fu fatto più volte)
ed esamina in dettaglio l’accoglienza ostile del Velluti nella stampa inglese.
Egli evidenzia come il sopranista divenne rapidamente una figura
inconcepibile per il pubblico sassone a seguito dell’affermarsi di idee
dominanti (romantiche) che lo descrivevano come “innaturale”. Infine, in
merito, vorrei citare la bella lettera “Defense of Velluti”, pubblicata nel 1826
in una rivista inglese da Mary Shelley, l'autrice del romanzo gotico
Frankenstein, indicando come fosse del Velluti unicamente “l’effeminatezza
88
Immagine satirica pubblicata nel 1825 che descrive come “cosa da nulla”
l’esecuzione del Velluti e una stampa più rispettosa del 1828 raffigurante il
Velluti in vestito di scena. Entrambe illustrano l’esecuzione de “Il Crociato in
Egitto” e si trovano presso la Harry R. Beard Collection del Victoria and
Albert Museum di Londra.
Tra i suoi estimatori quale “ultimo grande virtuoso” troviamo operisti
e librettisti importantissimi come Rossini e Felice Romani, Meyerbeer
e Gaetano Rossi che concepirono ruoli e drammi creati su misura delle
sue peculiari e originali virtù canore ed espressive.
La ricchezza delle sue “fioriture” e la forza intensa del suo “canto
sentimentale” ebbero rilevanti influenze sulla scrittura dei suoi autori,
ma anche sul gusto degli interpreti e del pubblico37
.
ad offendere molti inglesi”. Traduzione a cura dello scrivente. “A Mary
Shelley Encyclopedia” di Lucy Morrison, Staci L. Stone. Greenwood
Publishing Group, 2003. Pagina 111. 37 Al riguardo è di grande interesse il “Catalogo dei fondi musicali Antonio
Miari e Giovanni Velluti della Biblioteca civica di Belluno” di Paolo Da Col.
Fondazione Levi, 2008.
89
Lascio ad altri il compito di dipingere una biografia38
del musico, per
concentrarmi sul suo rapporto con i possedimenti sulla Brenta.
Sappiamo che diverse lettere sono inviate e ricevute presso questi
luoghi, ma in realtà quella in Riviera non sembra essere inizialmente
la sua dimora stabile. Egli è un grande viaggiatore e si muove in tutta
Europa, praticamente ovunque ci sia un teatro degno di questo nome.
Nel 1823 Velluti scrive a Giacomo Meyerbeer39
una lettera nel cui
incipit si intravede la sua non stanzialità, anzi sembra quasi un
inseguimento: “Trieste. 8 settembre 1823. Amatissimo Mio Giacomo.
La vostra pregiatissima lettera direttami alla Mira Vecchia in data 27
agosto, l’ho ricevuta soltanto ieri ed ora mi faccio un dovere
rispondere al carissimo mio Giacomo. La prima che mi inviaste a
Firenze la ricevetti ancor quella tardissimo”. Nello stesso periodo è
Gaetano Rossi a scrivere a Meyerbeer lamentando che non riceve
“lettere di Velluti da oltre un mese: mi scriveva che m’avrebbe
prevenuto con lettera del suo passaggio per Verona onde stare
assieme un po’ d’ore: non vedo più lettere. Lo aspettai, lo aspetto.
Ignoro se sia alla Mira e se partirà presto, dovendo per i primi di
settembre essere a Trieste”. Il Velluti e Rossi fanno accenno alla
“Mira Vecchia” perché era la località, per vicinanza, a cui faceva
38 Esiste un'unica biografia: “Giovan Battista Velluti cantante lirico (1780-
1860)” di Ermanno Illuminati per conto e a cura del Comune di Corridonia,
1985. Essa ha avuto il merito di essere la prima ricerca di rilievo, ma andrebbe
aggiornata, corretta in alcune parti, e completata in particolare per le
tematiche riguardanti il ruolo del cantore nella rivoluzione avvenuta nel
mondo della musica e del teatro negli anni della sua attività, anche in base alla
documentazione riguardante Rossini e gli altri compositori.
Sempre di origine marchigiana è un documentario del 2007, ideato e
promosso da ARTEsetTIMA, per la regia di Angelucci Cominazzini
Massimo, dove sono presenti anche alcune scene girate all’interno della villa
di Sambruson. 39 “Giacomo Meyerbeer: Briefwechsel und Tagebücher” di Heinz Becker,
Gudrun Becker. Walter de Gruyter, 1959.
90
riferimento questo tratto del fiume Brenta. È difficile da queste lettere
pensare che Velluti potesse passare lunghi periodi in Riviera, senza
contare la lunga parentesi passata in Inghilterra al King’s Theatre
attorno agli anni 1825-182640
.
Perché un uomo ricco e che conobbe i fasti e le bellezze di tutta
l’Europa decise di stabilirsi in questo luogo, rimarrà un suo segreto.
Se è vero che in questo periodo storico, traumatico della storia di
Venezia, molti nobili o ricchi borghesi decisero di spostarsi
stabilmente in terraferma41
è altresì vero che egli non era veneziano e
che in laguna non aveva interessi particolari, ma vi transitava come in
altre città italiane ed europee. Possiamo azzardare l’ipotesi che fosse
un sito più comodo per gli spostamenti, localizzato com’è tra Padova e
Venezia, per andare a Trieste, Verona, Milano, Parma e le altre città
che spesso frequentava. Inoltre, per il medesimo motivo, posto lungo
il percorso di quello che rimaneva del Grand Tour poteva ricevere i
suoi ospiti lontano da occhi indiscreti, poiché la campagna gli
garantiva quell’anonimato che la città ed i suoi abitanti, amanti dei
teatri, non gli potevano serbare. Certo è che se decise di passare il
resto della vita in questo luogo e qui essere sepolto, vuol dire che alla
fine deve averlo preferito a tutti gli altri a lui noti. Mi sembra
comunque difficile possa essere una “inspiegabile coincidenza”42
che
tre dei più grandi ultimi musici, Gaetano Guadagni43
, Gaspare
40 In merito è molto dettagliata la ricostruzione, particolarmente interessante
perché coeva all’autore e non postuma, leggibile in: “Seven Years of the
King's Theatre” di John Ebers. W. H. Ainsworth, 1828. 41 “Venezia Austriaca: 1798-1866” di Alvise Zorzi. Libreria Editrice
Goriziana, 2000. Pagina 28. 42 “Il crepuscolo degli angeli: Guadagni, Pacchierotti e Velluti, gli ultimi
castrati in terra veneta” di Giovanni Toffano, contenuto nel quaderno n. 4
(dicembre 2003), di Erta Italia Onlus–European Recorder Teachers
Association. 43 Gaetano Guadagni, contraltista e poi sopranista, è nato Lodi attorno al 1729
e deceduto a Padova nel novembre 1792.
91
Pacchierotti44
ed il Velluti, dopo anni trascorsi a raccogliere successi e
trionfi per i maggiori teatri d'Europa, siano andati a trascorrere
l’ultimo periodo della loro vita in questi luoghi, a Padova i primi due e
sulla Brenta a metà strada tra Padova e Venezia il Velluti, “quasi
confondendo il loro tramonto con il declino e la definitiva scomparsa
della Repubblica di Venezia, nei cui teatri trascorsero alcuni dei
momenti più importanti della loro carriera artistica”45
.
Evidentemente, per il loro tipo di arte, queste zone dovevano
assicurare un ritorno adeguato al loro prestigio. Forse andrebbe
indagato in modo più approfondito il rapporto tra Pacchierotti e
Velluti, entrambi marchigiani, entrambi amici di Rossini, entrambi
acquistarono una villa di campagna dove passare gli ultimi anni di
vita. Ad oggi non ho riscontrato prove di particolare amicizia tra i due,
ma in effetti sembra che il Velluti, di quarant’anni più giovane, abbia
seguito le tracce del Pacchierotti anche prima di morire: come Gaspare
adottò un nipote, al quale diede il cognome e di cui curò
meticolosamente la formazione e che nominò suo erede universale,
anche il Velluti prese con sé il nipote marchigiano Luigi, che ereditò
tutte le sue fortune.
L’addio alle scene, convenzionalmente, viene dato attorno il 1830,
dopo la tournée de “Il crociato in Egitto”46
.
In un articolo del 1826, che è in realtà una lettera di un corrispondente
per una rivista culturale in visita al Teatro la Fenice, leggiamo che:
“Velluti è qui, l’ho incontrato l'altro giorno nei giardini, ma è
abbastanza en particulier ed ha, credo, dato l’adieu al palco. Dicono
44 Gaspare (o Gasparo) Pacchiarotti, anche noto come Pacchierotti, è nato a
Fabriano nel 1740 e deceduto a Padova nel 1821. È considerato uno dei
maggiori “musici” dell'ultima fase della loro storia. 45 Vedasi nota 42. 46 Un melodramma eroico in due atti di Giacomo Meyerbeer, su libretto di
Gaetano Rossi che debuttò alla Fenice di Venezia il 7 marzo 1824. Il ruolo del
protagonista, Armando d'Orville, fu scritto espressamente per il Velluti
92
che si sia arricchito enormemente in Inghilterra, ma che non si goda
la sua ricchezza. Ha acquistato un bel posto sulla Brenta, tra Venezia
e Padova, e in generale ci vive in grande solitudine”47
. In realtà
sappiamo che si esibì ancora. I biografi di Stendhal ebbero a riportare
come nel salone del Quadri, il noto caffè di Venezia, nel 1831 egli
poté ascoltare il Velluti. Questi cantava nel Carnevale di quell’anno
alla Fenice, nella nuovissima opera del maestro Pavesi, “la Muta di
Portici”. Invitato, non si rifiutò di farsi udire in privato da pochi
ammiratori e clienti del Quadri, accompagnato al pianoforte da
Perrucchini48
. Stendhal, nell'unica lettera nota dello scrittore inviata da
Venezia (23 gennaio 1831), scrive che “Velluti non aveva mai cantato
meglio”49
. Nonostante il lusinghiero giudizio del grande romanziere
francese, molti erano i critici della voce dell’ormai cinquantenne
Velluti. Le esibizioni si fecero estremamente rare e cominciò nuova
vita sulle rive del bel fiume Brenta. Dalle visite pastorali sappiamo che l’oratorio della villa venne sospeso
nel 1822, ma è del 1832 il rilascio50
di un “permesso a benedire il
pubblico oratorio riadattato di G. B. Velluti”, come se nel decennio
precedente il cantore non avesse potuto o voluto occuparsene,
aspettando il suo ritiro pressoché definitivo dalle scene. Come decise
47 “The Oriental Herald. And journal of general letterature”. Volume 12 del
1827. Articolo “Letters from a Continental traveler”. Pag. 435. Traduzione a
cura dello scrivente (le parole in francese sono state mantenute come da testo
originale). 48 Giovanbattista Perrucchini (1784 –1870) fu segretario della corte d’appello
di Venezia e dilettante di musica. Si esibì spesso al pianoforte come solista
nelle case patrizie ed accompagnò sovente il Velluti. Musicò, inoltre,
componimenti in veneziano ed in italiano di Pietro Buratti (1772 – 1832),
anch’egli amico del sopranista, citato sovente nelle sue poesie. 49 “Dal Greco al Florian: scrittori italiani al caffè” di Riccardo Di Vincenzo.
Archinto, 2003. 50 Archivio Capitolare di Padova. Diversorium. Volume 25 (agosto 1821 –
aprile 1857), pag. 103.
93
di intervenire nella chiesetta, con ogni probabilità riadattò a proprio
gusto anche il complesso della villa. Per capire come doveva essere il palazzo del Velluti, ancora una
volta51
ci viene in aiuto un esponente della famiglia Von Martens,
Cristian, uno dei 14 figli del console danese52
a Venezia il quale aveva
la propria abitazione alla Mira Vecchia, poco distante da quella del
Velluti. Egli realizzò una mappa del fiume dalla località di Mira Porte
al Dolo, datata ottobre 1827, con l’inserimento di piccole viste ad
acquerello, piuttosto inusuali e di evidente gusto ottocentesco, delle
principali ville, tra cui quella del Velluti53
. È l’unica veduta del
complesso ad oggi conosciuta, nonché totalmente inedita54
. Per quanto
solo abbozzata ci permette di vedere che il corpo principale era
isolato, non aveva le due ali laterali, e di notare che il fronte del fiume
è rimasto immutato sino agli anni venti del ‘900 dove, in foto e rilievi
d’epoca, troviamo una situazione ad essa molto simile: tra la villa e
l’oratorio non vi era ancora nessuna costruzione ma solo un lungo
muro.
51 Un’interessante iconografia prodotta dagli esponenti dell’illustre famiglia
Von Martens sono state pubblicate anche nei precedenti due volumi de
“Luoghi ed Itinerari della Riviera del Brenta e Miranese”. Non sempre di
rilevante interesse sotto il profilo artistico, sono importanti per l’aspetto
documentario, perché ritraggono luoghi normalmente trascurati dai vedutisti
che pur hanno affollato le rive della Brenta. 52 Vedasi la ricerca “La famiglia Martens alla Mira Vecchia” di Mauro
Manfrin pubblicata in Rive 8, Comune di Mira, 2008. 53 Sono segnalate anche la vicina villa “Camerata”, la quale è caratterizzata da
un bellissimo vialetto di accesso al fiume, e dalle note sulla planimetria
scopriamo che l’altra vicina villa, oggi conosciuta come Tito, era a
disposizione dell’Ispettore delle Finanze. 54 Per gentile concessione di Massimo Zabeo, a cui va il mio ringraziamento.
La cartografia è stata presentata al pubblico alla mostra “L’Acqua di Venezia
e la Seriola Veneta” nel marzo-aprile 2014 a Dolo.
94
È accertato che, con il tempo, il sopranista cominciò a dedicarsi ad
altri interessi, in particolare si occupò di coltivazioni e di giardinaggio.
Anche di questa sua parte di vita risultano esserci molti aneddoti55
. Si
disse ad esempio che visitò in incognito la villa di Luigi Garzoni a
Mirano, con lo scopo di studiarne i giardini assieme ad alcuni suoi
ospiti, ma che venne smascherato dalla sua incapacità di trattenersi
dall’esibirsi alla vista di un magnifico pianoforte. Oppure che a
Mestre durante l’assedio austriaco, in visita per motivi di salute a
Pietro Berna56
, si trovò suo malgrado impegnato a liberare degli
arrestati.
Mi preme ricordare un episodio, che è riportato in un testo in lingua
francese del 185757
, poiché è emblematico di come siano inattendibili
molti aneddoti che riguardano il sopranista - da taluni dati per veritieri
pur essendo solo pettegolezzi del secolo scorso58
- ma anche perché
coinvolge una personalità estremamente importante per la Riviera e,
55 “Giambattista Velluti, ultimo dei sopranisti sulle liriche scene” di C.
Parolari. In «Rivista musicale italiana», XXXIX (1932), pagg. 263-298:274-
275. L’articolo racconta aneddoti raccolti dalla viva voce dei discendenti
Gioacchino Velluti e sua moglie Emilia Stadlbaur, alla quale è dedicato un
componimento poetico in apertura dello scritto. Certamente possiamo ben
vedere che il sopranista non viveva in esilio come spesso si scrive. Sono citati
tra i suoi amici oltre che Garzoni e Berna anche il professor Federico Moja,
insegnante di prospettiva all'Accademia di Belle Arti di Venezia, villeggiante
a Dolo, e molti altri. 56 Dovrebbe trattarsi del farmacista e più volte sindaco di Mestre, Pietro
Berna, ma le date non sembrano essere perfettamente coincidenti. 57 “La vie élégante à Paris” di François-Jérôme-Léonard de Mortemart de
Boisse. Hachette, 1857. Pagg. 345-347. 58 Lo stesso aneddoto, con piccole varianti, è da altri citato come avvenuto a
Milano, quando il Velluti si esibiva alla Scala, cambiando il De Blangy con un
anonimo parrucchiere. Inoltre in Francia veniva attribuito a Domenico
Giuseppe Biancolelli, detto Dominique (1636 – 1688), un attore italiano che
recitava come Arlecchino.
95
infine, perché fa riferimento a quella “malinconia” che, in fondo,
evoco nell’approccio sentimentale all’analisi della villa. In questo
testo si afferma che tale visconte De Blangy, un amabile dottore di
Venezia, durante una cena svoltasi alla Mira Vecchia assicura ai suoi
ospiti di aver conosciuto un uomo che si dice “affetto da profonda
malinconia”. Dopo un primo colloquio, egli gli consiglia del buon
vino, ma il malato in tutta risposta afferma di averne una cantina
fornitissima. Allora gli propone un bel viaggio, e il malato afferma
che è inutile, perché la malinconia lo insegue. Infine il De Blangy gli
suggerisce di andare ad ascoltare a teatro il cantante Velluti poiché
con la sua arte comunica a tutti verve e allegria, e questo gli risponde:
è solo una maschera, nulla di più, perché il Velluti sono io!
Quello che rende interessante ai rivieraschi tale aneddoto è che il
visconte De Blangy era soprattutto un grande chimico e divenne
famoso per aver perfezionato la produzione delle candele steariche59
,
fondando la fabbrica di Mira che poi divenne la Miralanza. Già nel
1837 il visconte Luigi Enrico De Blangy aveva ottenuto il privilegio
dall’Imperial Regio Governo di fondare la fabbrica a Mira, ricevendo
nel 1838 la medaglia d’oro ai “Premi d'agricoltura e d'industria del
Regno Lombardo-Veneto” per la sua produzione di candele60
. Ritengo
più che credibile che il Velluti potesse conoscere il De Blangy,
considerata la loro forte personalità e la presenza di entrambi alla
Mira.
59 Il testo più importante sul primo periodo della fabbrica è: “L'arte del ceraio
a Venezia e la fabbrica candele di Mira” di Bruno Polese ospitato in “La
chimica e le tecnologie chimiche nel Veneto dell'800: atti del settimo
Seminario di storia delle scienze e delle tecniche nell'Ottocento veneto,
Venezia, 9 e 10 ottobre 1998” a cura di Angelo Bassani. Istituto veneto di
scienze lettere ed arti, 2001. 60 “Atti della solenne distribuzione de’ premj d'agricoltura e d'industria fatta
in Venezia il 16 ottobre 1838. Con relativo discorso del sig. professore
Valeriano-Luigi Brera (etc.)” di Valeriano-Luigi Brera. Giuseppe Antonelli,
1839.
96
Particolare de “Il corso della Brenta dalle porte del Dolo sino alle porte della
Mira” del 1827 di Cristian Von Martens.
97
Degli anni ‘30 e ’40 dell’Ottocento, coevo agli aneddoti sul Velluti
“signorotto di campagna”, è il rilievo molto preciso del catasto detto
“Austriaco”. Rispetto alle precedenti cartografie, l’individuazione è
minuziosa. In particolare è rilevabile la presenza degli edifici a corte
posti tra i due corpi principali, che rappresentano forse il nucleo più
antico dell’intera struttura e, staccato rispetto al complesso, l’oratorio
pubblico cui è stato aggiunto sul retro un corpo di fabbrica piuttosto
allungato verso sud.
Particolare del Catasto detto “Austriaco”. 61
61ASVe. Censo Stabile, Mappe Austriache, cartella 31, foglio III. La
riproduzione è stata eseguita dalla Sezione di Fotoriproduzione dell’Archivio
di Stato di Venezia su gentile concessione del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali - Archivio di Stato di Venezia, atto di concessione 60/2014
prot. 5473/28.13.07.1.
98
Del 1856 è una lettera inviata dall’amico Meyerbeer al Velluti, oramai
settantaseienne, nella quale scrive: “Ho ritardato da un giorno
all’altro a venire nella vostra [dimora di] campagna, dove voi mi
avete gentilmente invitato, volendo prima guarire dalla mia
malaugurata tosse, per potermi abbandonare più liberamente al
fascino dell’escursione al Tusculum62
dell’immortale artista di nome
Velutti [sic]; ma, ahimé, non sono ancora guarito ed ecco che una
lettera appena ricevuta mi obbliga a partire immediatamente per
Berlino. Sarò dunque privato del piacere di servirvi ancora, caro ed
illustre amico. Ma lasciatemi almeno che vi dica in queste righe
quanto sono stato felice di rivedervi a Venezia dopo tanti anni di
lontananza: voi, mio illustre Velutti, che io ammiro come uno dei più
grandi artisti [auteurs] che la vostra patria tanto feconda abbia
prodotto, e che allo stesso tempo io amo come uno degli animi più
nobili ed elevati. Sono fiero e fortunato dell’amicizia di cui voi mi
onorate e vi prego di conservarmela, come io serberò per voi, per
tutta la mia vita, una sincera riconoscenza per la vostra ammirevole
prima esecuzione [création] del ruolo del Crociato, a cui sono
debitore del successo che quest’opera ha avuto la fortuna di
ottenere”63
.
Mi sembra importante segnalare come in avanzata età, tutt’altro che
isolato dal mondo, il Velluti invitasse ancora i vecchi amici a casa.
Come afferma Paolo Peretti nel suo preciso lavoro, il più interessante
nel panorama attuale circa la figura del Velluti: “Meyerbeer si scusa
62 Tusculum è stata una città pre-romana, romana e medievale del Lazio, posta
sui Colli Albani nell'area dei Castelli Romani. Aveva notevoli costruzioni,
abbellita da una corona di giardini e ville, soprattutto nella sua parte bassa,
quella rivolta verso Roma. 63 La lettera è riportata in lingua francese in: “Lettere di musicisti esistenti nel
Museo civico di Padova” di G. Marangoni, in “La cronaca musicale”, XIII,
nr. 9 (sett. 1909), pagg. 260-264. La traduzione dal francese è di Paolo Peretti
(vedasi nota seguente).
99
di non poter andare, da Venezia in cui temporaneamente soggiornava
e dove i due si erano da poco rivisti dopo lungo tempo, a rendere una
promessa visita al cantante nella sua agreste dimora di Sambruson:
località non apertamente nominata ma che, nel dotto paragone
epistolare, diviene idealmente per la Venezia dell’epoca quello che
Tusculum - con le sue splendide ville - fu per l’antica Roma. Dal tono
alquanto formale, si evince tuttavia una sincera stima del compositore
per l’anziano cantante, sia sul piano artistico sia su quello umano” 64
.
Pochi anni dopo la citata lettera, nel 1861, alla veneranda età di 81
anni Giovanni Battista Velluti morì proprio nella sua villa di
Sambruson. Nel registro parrocchiale, alla quinta riga dell’anno 1861,
è scritto: “lì 24 Gen. Il Signor Giovanni Battista fu Saverio Velluti, e
fu Lucia N., nubile d’anni 81, munito di tutti gli aiuti spirituali morì
jer l'altro, alle ore 8 pom. e fu sepolto alle ore 11 ant.”.
Illuminati scrive che “le esequie furono semplici, al seguito del feretro
i familiari, alcuni estimatori e la gente del luogo; la salma venne
inumata all'interno del sagrato della chiesa parrocchiale e il nipote
Luigi vi pose una lapide di marmo. Alcuni anni dopo, la spoglia del
cantante venne traslata nella nuova cappella funeraria eretta dai
Velluti nel cimitero di Sambruson; la lapide posta nel sagrato venne
rimossa e murata nella parete esterna destra della chiesa” 65
. La bella
lapide posta dal “dolentissimo nipote Luigi” porta il fregio di una lira e
l’usignolo, gli emblemi della vita del Velluti. La sua morte ebbe una
certa eco nel mondo del teatro e della musica. D’altro canto con lui se
ne andava una parte di quel “mondo dell’arte” che probabilmente lo
aveva sostituito ma non dimenticato. Certamente, molto amato.
64 “Il ‘musico’ e l'usignolo. Omaggio a Velluti, ma non solo” di Paolo Peretti,
in “Studia Picena”, LXXVI (2011), pagg. 289-362. All’autore va il mio più
sentito ringraziamento per avermi inviato il risultato del suo importante
lavoro. 65 “Giovan Battista Velluti cantante lirico (1780-1860)” di Ermanno
Illuminati per conto e a cura del Comune di Corridonia, 1985. Pagina 21.
100
Lapide murata nella chiesa di Sambruson in memoria di Gio. Batta Velluti ed
un suo ritratto di metà Ottocento (collezione privata).
Gli furono riservati sonetti ed epigrafi e, tra quanti ho potuto
visionare, scelgo la seguente “menzione onorifica”:
“Gio. Battista Velluti di Pausola nel Piceno, gloria del canto italiano,
cessò di vivere la sera del giorno 29 cor. Gen., nel suo poderetto sul
Brenta presso il Dolo. […] Solo chi è maestro nell' arte, potrà
adeguatamente giudicare del suo merito musicale, che certo fu
grande, se Rossini non dubitò di chiamare il Velluti imperadore del
dolcissimo canto, e Mayerbeer, un prodigio miracolo della melodia,
ed il celebre Emanolito Garcia, fratello della Malibran, a me che
scrivo queste righe decantava miniera inesauribile di modi eletti e
purissimi per vestire musicalmente qualsiasi concetto. Né dovea
essere altrimenti, se il Velluti colle sue tre diverse maniere di canto,
rispondenti alle diverse stagioni della sua artistica carriera, intendo
coll' ardita ed immaginosa, coll’appassionata e commovente, colla
101
studiata e finita giunse a strascinare dietro a sé, novello Orfeo,
meravigliate Italia, Germania, Inghilterra. […] Egli che potea farsi
ricchissimo, se meno dell’oro non avessero in lui potuto la buona fede
ed un nobile disinteresse, lasciò in eredità ai suoi nipoti modesto
censo. Vogliano essi rendere onorata testimonianza al nome del loro
zio, imitandone le virtù, e serbando tra loro quella scambievolezza di
affetti, che agli sguardi di quello spirito eletto, fa e sarà sempre il
pegno più ragguardevole della loro rispettosa riconoscenza. Un
amico.” 66
Interessante l’individuazione delle “tre maniere diverse di canto”
corrispondenti alle diverse età, ma il censo lasciato agli eredi è
tutt’altro che modesto. Il nipote Luigi, oltre a vari possedimenti
terrieri, poté disporre di un’ingente somma di denaro che investì
prontamente in un’impresa manifatturiera, una fornace di mattoni, e si
dimostrò certamente un abile imprenditore. Nato a Montolmo nel
1822, era figlio di Tossano fu Saverio Velluti (1788-1849) ovvero del
fratello minore del sopranista. Sembra che sia stato inviato, ancora
adolescente, a vivere presso lo zio nella villa sulla Brenta. In seguito
sposò tale Caterina Bressanin ed ebbero una decina di figli.
Sappiamo che Luigi non fu l’unico nipote del sopranista a spostarsi
dalle Marche al Veneto. Anche Gaetano Velluti, che sposò tale
Marconi Giuseppina67
, prese possesso di proprietà a Saonara (luogo di
66 “Menzioni onorifiche dei defonti ossia Raccolta di lapidi, necrologie,
poesie, annunzii ad alcuni defonti di Venezia, nell'anno 1861” a cura di G. B.
Contarini. Tipografia Perini, 1861. Pagina 9. 67 Nel testo: “Bibliografia italiana ossia elenco generale delle opere d'ogni
specie e d'ogni lingua stampate in Italia e delle italiane pubblicate all'estero”,
Milano, 1842, nella rubrica “Libri in dialetti diversi” leggiamo dell’esistenza
di un componimento dedicato “All’egregio amico e incomparabile cantante
Giambattista Velluti per le faustissime nozze del diletto nipote Gaetano
Velluti colla signora Giuseppina Marconi. Gregorio Trentini offriva. Padova.
Tip. Sicca, 1842”.
102
cui un loro figlio, Giovanni Battista, fu segretario comunale68
), e dove
diedero origine ad una prolifica dinastia “padovana” dei Velluti.
Il catasto detto “Austro-Italiano” degli anni Sessanta dell’800 mostra
la presenza del primo impianto della fornace voluta dall’erede del
musico. Mentre dalla Gazzetta Ufficiale sappiamo che l’Ispettorato di
Padova stipulò un contratto in data 18 luglio 1866 con Luigi per la
vendita di una serie di fondi in Sambruson e Camponogara69
, fondi
che gli servirono per estrarre l’argilla e realizzare i mattoni nella
nuova manifattura. Anche la mappa dell’Istituto Geografico Militare
del 1887 evidenzia l’importante presenza della fornace. Dello stesso
anno è da segnalare la morte di Luigi, infatti, il registro parrocchiale
riporta in data 27 ottobre 1887 che “Velluti Luigi fu Tossano e Ridolfi
Gioconda, d’anni 65, colpito di morte repentina […] morì il 24
ottobre”, sembra a seguito di un colpo inferto dal calcio di uno dei
suoi cavalli, di cui era grande appassionato.
La fornace Velluti fu probabilmente il primo forno Hoffmann70
costruito nella zona della Riviera del Brenta, e rappresenta oggi
un’interessante area di archeologia industriale inserita in un sito di
particolare valore paesaggistico, compreso com’è tra i due corsi
68 “Volendo dare un attestato di Nostra Sovrana soddisfatione a quelle
persone che in special modo si segnalarono per intelligente ed efficace
cooperazione nel lavori del censimento generale della popolazione del Regno,
eseguito al 31 dicembre 1881” è stato insignito con “menzione onorevole” il
segretario municipale di Saonara, Gio Batta Velluti. Gazzetta Ufficiale del
Regno d'Italia. Roma - Supplemento al n. 289 del 1882. Segnalo, inoltre, che
Gio Batta fu il padre del parroco Felice Velluti (1883 – 1972), molto noto ed
amato nel padovano per il suo impegno verso i più deboli. 69 Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, n. 314 del 18 novembre 1868. Reca
un decreto di approvazione di “n° 76 vendite di vari appezzamenti di terreno
erariale nel Veneto ai proprietari che vi stanno a confine”. 70 “Quei campanili industriali che svettano in Riviera. Un patrimonio storico
di grande valore simbolico in pericolo da conoscere, recuperare e
valorizzare” di Gianna Riva, pubblicato in Rive 2, Comune di Mira, 2002.
103
d’acqua della Seriola Veneta e del Naviglio del Brenta, e che sembra
non essere sufficientemente tutelato71
. Fu un’industria molto
importante per l’economia della zona e arrivò a superare il centinaio
di operai impiegati (nel 190572
furono contati 69 operai, mentre nel
192073
ne furono indicati 105).
L’impianto, realizzato dapprima a 16 camere, ampliato a 24 camere
nel 1943 dalla ditta Valdadige, venne ristrutturato con la costruzione
di forni a tunnel negli anni Sessanta del Novecento e dalla stessa ditta
gestito fino alla definitiva chiusura nel 1977.
Oltre agli impianti più recenti, ancora esistenti, e all’ammasso dei
ruderi del forno Hoffmann, sopravvive la vecchia ciminiera, ancora
integra e in discreto stato di conservazione. La presenza e lo stato di
abbandono di questa struttura non può che influire nella percezione di
mestizia che avvolge oggi l’intero complesso.
Alla morte di Luigi Velluti la villa e la fornace con tutti i possedimenti
terrieri passarono ai figli e, successivamente, la divisione ereditaria
portò uno di loro, Gioacchino (1882-1960), ad occuparsene
stabilmente.
71 Non posso far finta di ignorare, per formazione professionale ma
specialmente per amore della Riviera, che il Piano Regolatore Generale di
Dolo prevede in quest’area una lottizzazione (Progetto Norma 3: area ricettiva
ex fornace Valdadige) per un volume residenziale di 31.000mc (207 abitanti
per 150mc/ab) e ricettiva di 12.800mc (80 persone per 160mc/ab) per un
totale di quasi 44.000mc. Una colata di cemento che questo brano di territorio
proprio non si merita. 72 “Bollettino dell'Ufficio del Lavoro”, Vol. 3. Tip. nazionale di G. Bertero
e.c., 1905. Leggiamo: “Fornace Eredi Velluti in Dolo, 69 operai a L. 1.40 con
orari da 6 a 11 ore. Operai organizzati costruttori e accenditori si misero in
sciopero il 5 aprile essendo loro stato rifiutato un aumento di salario”. 73 “Sindacato e corporazione: bollettino del lavoro e della previdenza sociale;
informazioni corporative”. Vol. 34 del 1920. Leggiamo: “A Dolo sciopero
nella fornace di laterizi della Ditta Eredi Velluti. Gli scioperanti (105)
chiedevano ed ottennero aumenti di salario (dal 19 maggio al 7 giugno)”.
104
L’individuazione della Fornace Velluti sul catasto detto “Austro-Italiano”
redatto intorno al 186574 e su Tavoletta IGM del 1887.
La figura di Gioacchino è una delle più significative per lo studio del
complesso che nel corso del ‘900 subirà modifiche importanti, ma
oltre a lui, tra gli eredi di Luigi, è fondamentale citare anche Lucia
(1878-1956) che nel 1900 sposò il pittore Ettore Tito (1859–1941),
dando origine ad un sodalizio familiare ed artistico durato più
generazioni e particolarmente importante per tutta la Riviera del
Brenta. Non è possibile affrontare qui un tema che da solo
richiederebbe una monografia75
, ma necessariamente va delineato un
breve profilo.
74 ASVe – Censo stabile attivato, Mappe, cartella 25, fogli 3 e 4. La
riproduzione è stata eseguita dalla Sezione di Fotoriproduzione dell’Archivio
di Stato di Venezia su gentile concessione del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali - Archivio di Stato di Venezia, atto di concessione 60/2014
prot. 5473/28.13.07.1. 75 Circa la vicenda artistica dei Tito in Riviera del Brenta si vedano: “I Tito.
Un secolo e mezzo di arte” di Matteo Mazzato. In Rive 5, edito dal Comune di
Mira (anno 2002); “Ettore Tito 1859-1941” in Archivi della Pittura
105
Ettore Tito, originario di Castellamare di Stabia ma di madre
veneziana, è stato uno dei più importanti pittori veneziani di tutto il
‘900, spesso definito dai suoi contemporanei “l’erede di Tiepolo”76
.
Sposò Lucia, di diciotto anni più giovane di lui, incontrata in
montagna, nel Cadore, luogo amatissimo da entrambe le famiglie.
Lucia aveva la passione per i cavalli, ereditata dal padre Luigi, visibile
in alcuni dei quadri più belli dell'artista, come “L’amazzone” del
1906. In quegli stessi anni la famiglia Tito prende possesso della villa
vicina a quella dei Velluti ed Ettore, come per la sua casa veneziana,
ne segue un restauro particolarissimo rendendola un’opera d’arte77
.
Felice Carena78
, commemorando Ettore, ricordava la casa di
Sambruson come “uno dei luoghi ove si conservavano più vivida la
sua vera anima di poeta, la materia della sua pittura e la sua tenera
malinconia”. Ancora una volta la malinconia in questo brano del
Brenta. Qui Ettore fu molto attivo e le due famiglie vivevano usando
spesso gli stessi spazi. In particolare la corte formata dagli annessi
delle due ville, oggi non più comunicanti, era una sorta di area
comune e vi si poteva accedere dall’una e dall’altra abitazione.
Ettore e Lucia già avevano due figli quando Gioacchino Velluti sposò
Stadlbaur Emilia nel 1909. Dal loro matrimonio nacquero cinque figli:
Veneziana, a cura di Alessandro Bettagno. Fondazione Giorgio Cini, Electa
1998; “La dimora di Ettore Tito” di A Mazzanti. In “Artista”, 1993. 76 Villa Tito è ricchissima di riferimenti a Giandomenico Tiepolo: dalla
riproposizione al piano nobile de “il Mondo Nuovo” al pappagallo rosso
affrescato nella cedraia, molto simile a quello presente a Ca’ Rezzonico
(Venezia) ed a molti altri che Tiepolo usava dipingere quasi come una firma. 77 A titolo d’esempio si deve ad Ettore Tito la monumentale cancellata che
unisce la villa al complesso dell'atelier e della cappella, studiata nei minimi
particolari (come dimostrano i suoi bozzetti preparatori), e che unisce
materiali, forme e colori presi in prestito dalla tradizione veneta e dalla natura,
rielaborati in un disegno architettonico di rara bellezza. 78 “Armonie degli spazi nelle dimore e nelle decorazioni parietali di Ettore
Tito” di A. Mazzanti, Electa 1998. Citazione pag. 45.
106
Luisa (1899–1918); Luigi detto “Gigetto” (1908-1985); Gioconda
detta “Dina” (1910–1977); Lucia (1918-1979) e Anna Maria (1920)
detta “Anny” la quale divenne la nuora di Ettore, sposandone il figlio
Luigi, anch’egli artista importante.
I nipoti erano presenze abituali nella casa di Ettore Tito che, come si
evince dalla giovane moglie, era sempre stato attratto dalla freschezza
giovanile, attrazione che si manifestò anche nella sua pittura79
.
Opere di Ettore Tito. Nell’ordine: Ritratto di Gigetto Velluti, 1918 (Museo
Civico di Rovereto); Dina Velluti in un particolare de “La sarabanda”, 1934
(Venezia, collezione privata); Lucia Velluti in un particolare de “La
preghiera”, 1932-33 (Venezia, collezione privata).
79 Egli ritrarrà molto spesso i nipoti e particolarmente famosi sono il quadro
“la Sarabanda” del 1934 che ritrae Dina e “La Preghiera” del 1932-33 dove
compare anche la nipote Lucia. Tra quelli meno noti segnalo il bellissimo
ritratto del giovane Gigetto. Nel catalogo “L'arte riscoperta”, 2000 (pagg.
220-221) l’autore Pizzamano scrive: “L'opera raffigura il giovane Luigi
Velluti, nipote di Ettore Tito, che in seguito si affermerà come scultore. [...] Il
ritratto, probabilmente eseguito intorno al 1918, è caratterizzato da una
pittura sintetica, quasi trasparente, nella stesura del colore, esaltato da un
gioco di pennellate luminose. Tito sa cogliere nel volto del nipote la
spontaneità, la dolcezza mista a malinconia, la poesia dell'infanzia, […]”.
107
È evidente che tale contesto, annoverando la presenza continua in casa
Tito di ospiti provenienti dal mondo culturale veneziano, non poteva
che influenzare molto la famiglia Velluti ed i luoghi da loro abitati.
Non sorprende quindi che nel 1922 la rivista “The Architectural
Forum” abbia dedicato a villa Velluti un lungo articolo. I due autori
dello scritto intrapresero un viaggio alla ricerca delle opere palladiane,
a partire dal palazzo alla Malcontenta, per una passione del mondo
sassone per il nostro Palladio che dura immutata nel tempo ancora
oggi.
Perché tra le ville palladiane venga inserito anche un lungo articolo su
villa Velluti è presto detto: si volle dimostrare come fossero state
messe in pratica, per secoli, le idee dell’architetto rinascimentale sulla
distribuzione degli spazi architettonici, e questa venne presa ad
esempio. Certamente non può essere stata casuale la scelta. Poiché gli
esempi cui potevano attingere erano centinaia, mi sono convinto che
gli autori dovessero essere guidati da qualcuno che conoscesse i
proprietari e che fosse “di casa”. Due anni dopo, nel 1924, l’arch.
Carlo Scarpa80
seguì dei lavori di ampliamento nella villa per conto di
Gioacchino Velluti e successivamente ebbe altri incarichi sia a
Venezia che a Dolo per conto della famiglia81
.
80 Carlo Scarpa è stato un noto architetto legato al razionalismo italiano. Una
personalità eclettica con una cultura alimentata oltre che dai suoi studi anche e
soprattutto dalle molteplici frequentazioni con artisti e studiosi (il prototipo
dell’architetto che deve essere anche e soprattutto intellettuale). Nacque a
Venezia nel 1906, nel 1919 si iscrisse al corso di architettura della Reale
Accademia di Belle Arti di Venezia e nel 1922-24 lavorò nello studio
dell’architetto Vincenzo Rinaldo. In quegli anni seguì alcuni lavori per la
famiglia Velluti. 81 Questi fatti sono riportati da diversi biografi dell’architetto e anche nei
registri dell’archivio dell’Istituto Universitario di Architettura di Venezia
(Unità archivistica progetti e incarichi professionali “Annesso alla villa
Velluti, Sambruson di Dolo (VE) / Carlo Scarpa . - [1924-1925]” Segnatura:
Scarpa-1.PRO/1/003 ). Purtroppo l’archivio è stato smembrato e gli enti che
108
La pubblicazione dell’articolo e l’interessamento dell’architetto
Scarpa non mi sembrano semplici coincidenze. Tra le interessanti
argomentazioni pubblicate82
vi è la descrizione del giardino: “la
passione per il Giardino Inglese, che un tempo imperversava in Italia
come una pestilenza, distruggendo molto di ciò che di prezioso già
esisteva e lasciando al suo posto solo in piccola misura ciò che vi era
di buono nello stile inglese, conquistò anche i proprietari di villa
Velluti. Di conseguenza vi è un bosco con un piccolo ruscello, un'isola
artificiale con, ovviamente, una collinetta che dimostra artificialità
altrettanto evidente, poi ponti rustici e tutti gli altri piccoli inganni di
cui i Capability Brown83
italiani di quegli anni facevano ricorso”.
Credo si possa affermare con certa sicurezza che si debba al sopranista
la sistemazione del giardino in stile romantico, su modello di quelli
inglesi che ebbe modo di apprezzare di persona in Inghilterra. Di
se ne occupano, in primis la Fondazione MAXXI di Roma, non sono riusciti
a rintracciare la documentazione, quindi non sono stato in grado di
quantificare la portata del suo operato. Nel registro si riporta che: “Su incarico
del veneziano Gioacchino Velluti, Scarpa si dedica alla progettazione in
autonomia, realizzando per il committente un annesso (ottanta metri
quadrati) alla settecentesca villa Velluti, a Sambruson di Dolo (Venezia),
lungo la riviera del Brenta. Per lo stesso Velluti egli realizzerà
successivamente una sopraelevazione del suo palazzo veneziano situato alle
Zattere (Calle dello squero)”. L’amicizia tra Carlo Scarpa e la famiglia
Velluti è stata comunque confermata anche da Federico Velluti, nipote di
Gioacchino. 82 “Villas of the Veneto. The Villa Velluti, at Mira Vecchia, canale di Brenta”
di Harold Donaldson Eberlein e Robert B. C. M. Carrere” contenuto in “THE
ARCHITECTURAL FORUM”, vol. 37, Billboard Publications, gennaio
1922. Traduzione dall’inglese a cura dello scrivente. 83 Lancelot Brown detto Capability Brown (1716 –1783) è stato un architetto
inglese, noto soprattutto per il suo peculiare stile architettonico dei giardini e
dei parchi che venne definito “all'inglese”, diffusosi poi anche nel resto
dell'Europa in reazione allo stile prima “italiano” e poi “francese” dominante
fino alla seconda metà del Settecento.
109
quanto elencato dai due architetti in giardino oggi non vi è quasi
traccia, ma un altro punto interessante riguarda i colori: “come ci si
aspetterebbe, la casa è costruita di mattoni e ricoperta di stucco. Ciò
suona abbastanza prosaico se ricordiamo quale diversità di colori gli
italiani impartiscono sulle superfici a stucco; in egual misura
pensando alle gradazioni di tonalità che si ritrovano nei tetti di
tegole: marrone, rosso, giallo, arancio e i verdi profondi dei muschi e
licheni. In questo caso lo stucco è un grigio rosato84
, i davanzali sono
di pietra bianca, e le persiane, cornici e figure sono di colore bianco”.
Così rispondendo, forse, ad un quesito ricorrente tra gli amanti di
questa villa che più volte hanno cercato un possibile colore originale.
Tra tutto però mi preme segnalare la parte conclusiva dell’articolo
dove i due autori affermano: “che la villa possieda un fascino
distintivo, è evidente a prima vista. Per determinare esattamente in
cosa consista l'essenza di questo fascino, tuttavia, il processo è più
sfuggente. L'insieme di tutto il gruppo di edifici contribuisce senza
dubbio in modo importante a determinarlo. Come contribuiscono
certamente il colore e gli altri elementi quali il tocco, molto
palladiano, dei frontoni sui lucernari posti ai due lati, caratterizzati
da finestre semicircolari di gusto romano, ma ciò che forse è più
importante di tutto è la composizione simmetrica e lineare del corpo
principale, con la sua disposizione gradevole di vuoti e pieni”. Analisi
intensa e condivisibile anche oggi, nonostante tutte le modifiche
apportate ai luoghi.
Dalle fotografie e dai disegni pubblicati possiamo notare che già era
presente, sotto il timpano della facciata principale, un orologio
meccanico (il quadrante è crollato in anni recenti a seguito di un
fortunale) che mediante due indici mobili, collegati a meccanismi
interni, segnava con notevole approssimazione le ore medie mentre
una soneria a maglio trasmetteva alle campane l’indicazione delle ore
84 In originale “pinkish gray” che, da una ricerca in rete, sembra corrispondere
ad un “color tortora”.
110
principali. Dal rilievo di alcuni particolari scopriamo che, su un fregio
posto sopra le campane, compaiono le iniziali di Luigi Velluti, il
nipote del sopranista. Fu lui, forse, a commissionarle per scandire il
lavoro degli operai della fornace.
Sulla facciata dell’oratorio oltre ai due angioletti, che qualcuno vuole
posti in onore della voce angelica del musico G.B. Velluti, ancora
esistenti, vi erano altre due testine andate perdute. Anche il
campaniletto a vela era totalmente diverso da quello attuale.
In generale, rispetto alla situazione attuale, spicca la modifica di tutto
il fronte del Naviglio (ad esclusione del corpo centrale della villa)
avvenuto quindi nel corso del ‘900.
112
Estratti dal reportage “Villas of the Veneto. The Villa Velluti, at Mira Vecchia,
canale di Brenta” di Harold Donaldson Eberlein e Robert B. C. M. Carrere”
contenuto in “THE ARCHITECTURAL FORUM”, vol. 37, Billboard
Publications, gennaio 1922.
A colori una foto odierna, per un diretto confronto con il rilievo proposto
nell’articolo.
113
Gioacchino, rimasto orfano da ragazzino, accolto sotto l’ala protettiva
della sorella maggiore Lucia ed accudito da un tutore fino alla
maggiore età, acquisì un titolo di studio in agraria e si interessò alle
moderne tecniche di agricoltura85
. È interessante la sua figura per
quanto riguarda le vicende della fornace. Nel 1927, in una rivista con
lo scopo di divulgare tecniche di debellamento della piaga della
malaria86
, leggiamo: “Sembrerebbe futile occuparmi di questo
argomento, oltre i limiti imposti dai doveri di ufficio, se non avessi
acquistata la convinzione che accanto al danno vi può essere il
rimedio, avendo recentemente potuto studiare la razionale
trasformazione agraria eseguita nelle cave di prestito annesse alla
fornace di laterizi di proprietà del cav.87
Gioacchino Velluti, in
territorio di Mira. Da una ininterrotta serie di acquitrini e
pozzanghere residuati all'escavo di argilla protratto per molti anni e
per uno spazio di parecchi ettari, il detto industriale ha ricavato una
fiorente campagna, che dà tutti i prodotti e permette anche la
coltivazione assai rimunerativa di ortaglie”. L’estrazione dell’argilla
provocava normalmente la creazione di bacini d’acqua che divenivano
facilmente, in quegli anni, luogo di proliferazione delle zanzare
malariche. La scelta di stoccare momentaneamente la terra fertile e
85 Tra le citazioni della sua attività nel campo agricolo segnalo il “Bollettino
del Laboratorio di zoologia agraria e bachicoltura del R. Istituto superiore
agrario di Milano”, Volume 3. Università di Milano, Istituto di entomologia
agraria, 1930. L’autore di un articolo sulla coltivazione dei bachi da seta
afferma: “Era mio intendimento di compiere degli esperimenti su vasta scala
presso l'azienda del Cav. Velluti di Dolo (Venezia) che gentilmente ci aveva
offerto l'ospitalità. Ma per un incidente indipendente dalla nostra volontà si
dovette rinunciare all'impresa”. La partita di bachi, proveniente dalla Marche,
risultò ammalorata. 86 Rivista di malariologia. Volume 6 del 1927. Pagg. 437 - 439. 87 Gioacchino risulta essere stato nominato Ufficiale dell’Ordine della Corona
d’Italia nel gennaio del 1932 (Gazzetta Uff. del Regno d'Italia del 6 aprile
1932) e commendatore nel 1942 (Gazzetta uff. del 15 ottobre 1942).
114
ripristinare, una volta esaurita l’estrazione dell’argilla, la campagna
per la normale coltivazione agricola fu un’idea moderna e vincente.
Sempre all’estrazione dell’argilla si deve il rinvenimento di materiale
archeologico sulle proprietà Velluti. Proprio Gioacchino aiutò a
salvarne una parte prestando anche i locali per la costruzione del
primo museo88
. Tra i ricordi tramandati “in famiglia” risulta che i
funzionari della Valdadige ordinarono agli operai di frantumare le
tombe alla cappuccina e di disperdere i ritrovamenti che affioravano
nei campi, prima che la moglie di Gioacchino, Emilia, nata in Baviera
e dotata di un buon bagaglio culturale, se ne accorgesse e fermasse lo
scempio. Sempre a lei si deve una particolare attenzione nel
preservare ciò che restava dei documenti del cantante ed il recupero di
materiali archeologici (armi e ceramiche cinquecentesche) salvati in
extremis durante un dragaggio nel greto del canale davanti alla villa89
.
Dopo la morte di Gioacchino la proprietà della villa passò ai figli90
.
88 Circa la storia dei ritrovamenti, piuttosto importanti, si veda: “Ad
duodecimum Mansio Maio Meduaco. Sambruson in epoca preromana e
romana” di Monica Zampieri, Associazione culturale Sambruson la nostra
storia, 2009. 89 Informazioni fornite da Federico Velluti, nipote di Gioacchino. 90 Luigi Velluti fu nominato coerede assieme alle tre sorelle. La nuda
proprietà dell’immobile e dei terreni passò in seguito a Gioconda detta “Dina”
che la riscattò tramite permuta ed acquisto. Quest’ultima, rimasta nubile,
nominò a sua volta eredi due nipoti, i figli del fratello Luigi. Dina è ricordata
con affetto in Riviera per l’apertura della villa ad eventi musicali. Al riguardo
è interessante il ricordo di Egida Sartori: “feci amicizia con le famiglie Tito e
Velluti, che abitavano in due antiche ville venete. Con i fratelli Velluti si
stabilì un simpatico scambio, amanti come sono e come furono sempre per
tradizione di ogni forma d'arte e della musica in particolare. Io suonavo in
cambio di generi alimentari. Bach, Beethoven, Franck erano scambiati con
uova fresche! Chi avrebbe pensato, allora, che dopo molti anni sarei stata
chiamata da Dina a inaugurare nella sua villa i “Concerti degli Amici della
Musica del Brenta”. Da “Cronaca di una favola chiamata musica: biografia
115
Il maggiore, Luigi, nato nel pieno della fiorente stagione di Ettore
Tito, intraprese l’attività artistica91
come anche la sorella Gioconda. In
particolare egli cercò una propria strada nel mondo dell’arte come
scultore, ottenendo anche qualche risultato di rilevo92
, ma dopo gli
eventi bellici dovette abbandonare le velleità artistiche.
Nell’ordine: “Ritratto di Lucia Velluti”, scultura in bronzo di Francesco
Messina del 1943; “Bambolotto Tonino” punta di diamante della ditta Furga
del 1955 realizzato da Gioconda “Dina” Velluti; scultura di cavallo in gesso
realizzato da Luigi “Gigetto” Velluti negli anni ’40, probabile studio per la
realizzazione di un bronzo (collezione privata).
artistica di Egida Sartori (1910-1999)” di Elena Pessot. Leo S. Olschki,
2005. Pagina 58. 91 Alcuni lavori di Luigi e Gioconda sono catalogati in “Cent'anni di
collettive: Fondazione Bevilacqua La Masa, 1899-1999”. Cicero, 1999. 92 Nel 1935 vinse un premio per la miglior scultura “Op. Bevilacqua la Masa”
e nel 1936 ottenne un buon piazzamento alle Olimpiadi di Berlino, nelle
competizioni artistiche, per la scultura “Pugile abbattuto”. Altri
riconoscimenti furono ottenuti intorno agli anni ’40, annoverando
partecipazioni alla Biennale di Venezia e alla Quadriennale di Roma. In
particolare furono apprezzate una certa personalità nella tecnica di lavorazione
ed alcune sue ricerche sulle argille.
116
Mi preme segnalare come entrambi siano stati molto attivi nella
resistenza veneziana durante l’epilogo della Seconda Guerra
Mondiale. In particolare lo studio veneziano di “Gigetto”, come
veniva chiamato Luigi, era una delle basi principali dei partigiani
operanti nel centro storico, e sappiamo che teneva i contatti con il
CLN e che organizzò l’evasione di alcuni prigionieri dalla caserma
della Guardia Nazionale Repubblicana di San Zaccaria: “Fu
organizzata una spedizione da Gigetto Velluti, un tipo allampanato e
occhialuto, dall'aria non mentita di studioso, che tante ne pensò, tante
ne fece, ma che noi ricordiamo soprattutto per un suo fantastico volo
attraverso la tromba delle scale che lasciò incretiniti i militi neri
andati ad arrestarlo nella sua casa”93
. Scoperto, riuscì
fortunosamente a scappare in montagna, in Valpolicella, ritornando
saltuariamente a Venezia e a Dolo, dove poté osservare la sua villa e
la fabbrica requisita dai tedeschi94
. Alcuni aneddoti95
vedono in prima
linea anche Gioconda, detta “Dina”, che studiò all’Accademia e che in
quella sede nascose delle armi usate dai partigiani anche per un’azione
93 Molte di queste vicissitudini sono narrate in “Vent'anni di resistenza al
fascismo” di A. Gavagnin. Einaudi, 1957. Autore attendibilissimo, Armando
Gavagnin (1901–1978) è stato direttore de “Il Gazzettino” e sindaco di
Venezia. Nel testo ampio spazio è dedicato anche a Mario e Luigi Tito, figli di
Ettore, anch’essi molto attivi tra i partigiani. Il secondo approfondì tali
esperienze, spesso drammatiche, anche nella propria ricerca artistica (“Luigi
Tito. Gli anni della resistenza” a cura di Mario De Michieli. Grafiche Turato,
Padova 1997). Alcuni aneddoti su Gigetto Velluti sono ripresi con maggiori
dettagli in “Giustizia e libertà e Partito d'azione a Venezia e dintorni” di
Renzo Biondo, Marco Borghi. Nuova dimensione, 2005. 94 Fatti ricordati da Alberto Ongaro, noto giornalista, scrittore e fumettista, in
un intervista contenuta in “Memoria resistente: la lotta partigiana a Venezia e
provincia nel ricordo dei protagonisti” a cura di Giulia Albanese, Marco
Borghi. Nuova dimensione, 2005. 95 “Volontarie della libertà” di Mirella Alloisio e Giuliana Gadola Beltrami.
Lampi di stampa, 2003. Pagg. 153-154.
117
dimostrativa al Teatro Goldoni. Dopo la guerra fu lei, inoltre, ad avere
un breve ma interessante successo. Infatti, a metà degli anni ’50
realizzò il modello del bambolotto Tonino96
, punta di diamante della
celeberrima ditta Furga e uno dei simboli del “boom economico”.
I fratelli Velluti frequentavano e facevano pienamente parte di quel
vivace gruppo di artisti veneti di allora che si bilanciava tra gli ultimi
sprazzi di una cultura eclettica, o per meglio dire accademica e l’inizio
del modernismo. Tra gli amici di Gigetto e Dina in quegli anni
troviamo anche Francesco Messina (1900-1995) noto scultore che,
come ricorda egli stesso97
, fu ospitato a Sambruson, e che nel 1943
realizzò un busto di Lucia, sorella minore di Luigi e Gioconda, che
aveva allora 25 anni. Luigi, invece, possedeva una scultura donata da
Arturo Martini, suo amico e per un certo tempo affittuale della loro
casa veneziana98
.
96 “Furga: le più belle bambole del mondo” di Elisabetta Sgualdini. Turris,
2000. 97 “Poveri giorni: Frammenti autobiografici, incontri e ricordi” di Francesco
Messina. Rusconi, 1974. Messina racconta: “Da un lato era il canale e la
strada provinciale per Venezia, schermata da pioppi, e dall'altro la piatta
campagna in fondo a cui si innalzava la mole della chiesa di San Bruson, con
il campanile svettante sulla pianura come un missile in procinto di partire.
Paesaggio delicatissimo, fiorito di intatta grazia veneta nelle stagioni
intermedie, soffocato dalla calura in estate, desolato in inverno. La guerra vi
appariva remota quando arrivammo, e per più di un anno non ci pesò troppo.
[…] Ma arrivammo al 1944 e l'agonia della guerra, con i bombardamenti e
mitragliamenti indiscriminati e la lotta civile, divenne la nostra agonia
quotidiana. La morte ci dormiva accanto, la notte. La mia era la sola
automobile privata che circolasse nella zona e sovente mi veniva richiesta per
il trasporto di ammalati. Poi, quando alcuni paesi vicini furono distrutti da
bombardamenti a tappeto, si rese necessaria per il trasporto dei feriti e degli
estratti dalle macerie. […] Verso la fine dell'anno l'automobile mi fu requisita
dal comando dell'Organizzazione Todt”. 98 Lo studio di Arturo Martini a Venezia si trovava nella casa di proprietà
Velluti, in calle dello Squero, nei pressi della punta della Dogana. Vi si era
118
Nel concludere la narrazione delle vicende di villa Velluti mi avvarrò
del racconto estremamente dettagliato dei lavori di restauro iniziati da
Federico Velluti, erede diretto di “Gigetto”, che lui stesso mi ha
gentilmente inviato99
. Federico, da sempre impegnato nella tutela dei
beni artistici, è diplomato all’Istituto Centrale per il Restauro di Roma
e guida una delle più note équipe di restauro del Veneto, ottenendo
prestigiosi incarichi di livello nazionale ed internazionale. Si
innamorò già negli anni ‘70 del bellunese dove è andato a risiedere e
da trent’anni cura il restauro del Castello di Lusa, acquisito con
l’intento di garantirne il recupero e la fruizione pubblica. Ha donato il
materiale in suo possesso, riguardante il musico G.B. Velluti, alla
biblioteca di Belluno che ne cura oggi il patrimonio documentale. I
suoi resoconti si sono rivelati molto importanti per il connubio tra la
familiarità con i luoghi in cui ha abitato e la grande competenza
nell’arte del restauro, ma spesso narrano di un allontanamento
tenacemente cercato da una Riviera del Brenta che egli ha visto
sfiorire, travolta da una bulimia di cemento100
, caratterizzata
dall’incuria se non dal ripudio di un paesaggio che era tra i più belli
trasferito dal novembre 1942 per svolgere l'attività didattica presso
l’Accademia. Luigi Velluti ebbe modo di assistere alle sue lezioni – per
quanto la guerra glielo permettesse – e con lui ebbe un interessante scambio
epistolare. L’ultima lettera di Martini a Velluti è datata 18 febbraio 1947.
Morirà a Milano appena un mese dopo. 99 Userò qui alcune tracce della vivace corrispondenza avuta con Federico
Velluti, che ringrazio infinitamente per lo sforzo, anche doloroso, dei ricordi
condivisi. 100 L’idea che la bulimia cementizia non si sia mai interrotta è facilmente
dimostrabile pensando alle grandi speculazioni passate ed in corso in quello
che viene chiamato il “Bilanciere Veneto” tra Padova e Venezia. E come non
fare riferimento al progetto della Romea Commerciale “Orte-Mestre” il cui
tragitto prevede proprio di passare sulle aree archeologiche di Sambruson e
vicino alle ville Velluti, Tito e Badoer, in uno dei pochi varchi rimasti liberi.
Una follia che, vivamente, mi auguro rimanga solo sulla carta.
119
d’Europa. Venendo alla struttura architettonica della villa, questa è
composta da un corpo centrale settecentesco distribuito su tre piani,
dei quali l’ultimo è ammezzato, più il corpo centrale dell’abbaino
sopraelevato e coronato da un frontone timpanato. È scandito da sette
assi, il cui centrale è anche asse di simmetria, e su questo si addensano
gli elementi architettonici più significativi come, al piano nobile, il
portale ad arco a tutto sesto in pietra che si apre su di un balconcino in
ferro battuto, e l’orologio meccanico che si trovava posto al livello
dell’abbaino. A richiamare il tema musicale vi sono sulla sommità del
frontone due statue che riproducono dei musici e un fastigio in ferro
con campane.
Questa parte centrale ingloba, con buona probabilità, alcune parti del
nucleo più antico risalente forse al XVII secolo. Lo testimonia il
contorno lapideo della porta che dà accesso al salone centrale nel
fronte verso il giardino. La cornice della porta, coronata da un
timpano, è composta da elementi di pietra di Nanto, materiale che non
appare frequentemente negli edifici settecenteschi della Riviera del
Brenta. Anche il sovrastante poggiolo in ferro battuto, formato da un
intreccio di motivi lobati, mostra caratteri stilistici che non
appartengono alle tipologie settecentesche. Le finestre centrali ad arco
leggermente ribassato sono state rimesse in luce durante un’indagine
condotta dallo stesso Federico ed il fratello, nel tentativo di
ripristinare la fisonomia originaria dell’edificio.
L’interno della casa era tutto controsoffittato con intonaco su arelle,
intervento ascrivibile al rinnovamento del primo Ottocento fatto
eseguire dal cantante Velluti. Tali strutture, particolarmente fatiscenti
e prive di pregio, sono state molto lesionate. I danni più consistenti si
sono verificati a causa della burocrazia, quando la sospensione
dell’erogazione di un contributo per il restauro del tetto da parte
dell’Ente Ville Venete ha fatto sì che la risistemazione della copertura
rimanesse incompleta per lungo tempo. Benché fossero stati
approntati dei ripari di emergenza, un fortunale ha strappato i teloni
protettivi riversando molta pioggia negli ambienti interni, con
120
conseguenze rovinose per le strutture e per gli arredi. Dopo tale
evento, parte delle controsoffittature sono crollate mettendo in luce le
antiche travature a vista, scialbate a calce ma prive di decorazioni. Gli
intonaci delle pareti, rifatti anch’essi nell’Ottocento, ricoprivano i resti
di una semplice malta scialbata a calce, priva di qualsiasi decorazione.
Il salone del piano terra era l’unico che conservava l’originario
apparato decorativo settecentesco costituito da una serie di tele con
figurazioni mitologiche ascrivibili all’ambito del pittore Francesco
Zugno (1709-1787). Ai margini delle tele, resecati e ridipinti,
apparivano i resti dell’incorniciatura a volute monocrome che
simulavano dei contorni a rilievo in stucco lasciando intuire che il
ciclo, in origine, possedeva una sua particolare impaginatura
architettonica. Il nucleo dei dipinti è stato, purtroppo, smembrato
durante la divisione ereditaria e non è più presente nella villa. La serie
era costituita da cinque quadri di forma rettangolare allungata. La
commissione di questo ciclo decorativo che ornava il salone del piano
terra e la pala della chiesetta (parzialmente bruciata in un incendio e
della quale si conserva solo la parte centrale) sarebbe da attribuire a un
ramo degli Avogadro. A tale proposito Federico rinvenne una
“ducale” settecentesca, a stampa della Repubblica Veneta, dove la
famiglia è menzionata. Il foglio, appallottolato, era stato infilato in un
anfratto della travatura di una stanza e fu trovata durante la pulitura da
incrostazioni di calce.
Tutti gli arredi interni, sedimentati nel corso di due secoli, erano stati
ulteriormente arricchiti dagli acquisti di Gioacchino Velluti e
costituivano un interessantissimo assieme di dipinti, mobili e
suppellettili varie che spaziavano dal XVII secolo al tardo periodo
impero. Buona parte di questo patrimonio, che assommava anche i
ricordi del cantante Velluti: stampe, acquerelli, ritratti, costumi di
scena, è stato smembrato e disperso malgrado la richiesta di vincolo
presso la Soprintendenza ai Beni Storico Artistici del Veneto per
alcuni nuclei più significativi, legati storicamente alla casa.
121
Alcuni scatti degli esterni ed interni della villa, fatti nel 2006, in occasione del
documentario ideato e promosso da ARTEsetTIMA, per la regia di Angelucci
Cominazzini Massimo. Per gentile concessione dello studioso Pietro Molini,
autore degli scatti, che ringrazio sentitamente anche per l’aiuto nella
ricostruzione dell’albero genealogico del musico.
122
Particolarmente interessante è la cucina col camino alla valesana
circondato da alti seggioloni. Durante i lavori di ripristino di questo
ambiente è riemersa la vecchia travatura a vista con decorazioni
seicentesche a tempera, parzialmente reintegrate, che mostrano
evidenti tracce di un rimpiego di materiale proveniente dall’edificio
preesistente. Analoghe travature dipinte sono state reimpiegate in un
ambiente della barchessa. La struttura architettonica di quest’ala,
ritmata delle finestre ovali scolpite in pietra d’Istria e ornate da
mascheroni di gusto longhenesco, fanno parte del nucleo seicentesco
sopravvissuto alle varie manomissioni.
Il corpo che collega la barchessa all’edificio centrale è stato
malamente alterato nei primi anni del XX secolo eliminando parte
delle aperture ovali e degli spioventi del tetto che davano continuità
alla struttura. Alcuni degli ovali sono stati inseriti nell’ala destra del
corpo centrale, frutto di una ricostruzione tarda. Anche la chiesetta
settecentesca ha subito un rimaneggiamento interno in epoca
neoclassica e presenta pareti affrescate in finto marmo ed una statua
incastonata nella nicchia dell’altare raffigurante Cristo flagellato alla
colonna.
Il giardino, pressoché inesistente nelle fotografie del primo novecento,
è stato ridisegnato da Gioacchino e dai suoi figli recuperando nel
mercato antiquario, prima che venissero esportate in America, le
statue seicentesche, in pietra di Costozza, che coronavano in origine i
muri di cinta della villa Fabbris di Camponogara rappresentanti i 12
mesi dell’anno. Federico per un periodo pose anche delle statue sul
fronte del Naviglio, davanti alla villa, come si vede in molte foto
pubblicate tra gli anni ’80 e ‘90, ma successivamente, per salvarle da
atti vandalici e furti, sono state poste nel giardino. Le uniche statue
settecentesche originali erano poste sui pilastri del cancello volto
verso la campagna, le quali stilisticamente si apparentano con quelle
di villa Widmann Foscari di Mira Taglio.
La facciata del corpo centrale rivolta verso il giardino conservava il
vecchio intonaco a marmorino profilato dai relativi marcapiani a
123
bugnato che in seguito furono occultati da un discutibile spatolato
sintetico di colore violaceo. Il busto marmoreo seicentesco che
campeggia sotto il timpano è un elemento ornamentale di recupero e
non corrisponde all’effige del cantante, come molti pensano. Un pregevolissimo elemento di fontana, scolpito con una teoria di
cherubini di gusto lombardesco, proviene da un edificio rustico che
sorge non lontano dalla villa, lungo la riva della Seriola. Con buona
probabilità il frammento lapideo, inglobato nella fontana novecentesca
posta al centro del giardino ed anch’essa recentemente danneggiata
dalla caduta di un monumentale albero, era originariamente inserito
nella sagrestia di una chiesa legata ad un complesso conventuale
soppresso.
Ville Velluti e Tito. Ripresa aerea dell’autore e di Maurizio Ruzzon (2014).
124
Questa la sua architettura e questa la sua storia. Eppure solo in parte
riusciamo a svelare questo luogo. Villa Velluti ha una sua memoria
segreta, un’aura inafferrabile emanata dalle sue mura e dal suo
giardino, che non potrà mai essere rivelata in un saggio di carattere
storico e che rimarrà sepolta tra le sue pietre e nei confini del
romantico fondale arboreo, nel suo silenzio, interrotto solo dal ritmo
incessante del picchio rosso che vi ha preso dimora. È uno di quei
luoghi che attraggono l’ignaro viandante attraverso un codice
misterioso che chiede di essere decifrato. Io ne sono stato l’ennesima
vittima e non sarò l’ultima.
Le pietre, gli infissi, gli arredi, tutto è impregnato della storia dei suoi
abitanti: dei sogni dei Baffo e dei Vezzi, della incredibile carriera e
degli aneddoti sul buen retiro dell’illustre cantante Velluti,
dell’imprenditorialità del nipote e della freschezza dei suoi eredi che
giovò all’arte pittorica di Ettore Tito e, persino, degli echi della
resistenza partigiana veneziana. Non tutti i luoghi sono così fortunati.
È come un romanzo scritto e riscritto, dove alle cancellature si
susseguono le aggiunte di note a margine, postille e nuovi capitoli. Ne
emerge così un capolavoro letterario composto in più stili: romantico,
accademico e modernista. Ma l’essenza del fascino, che sfuggiva per
loro stessa ammissione agli studiosi anglofoni degli anni ‘20, non è
formale, è in realtà sentimentale. È una percezione di varie suggestioni
velate di mestizia, della tristezza che traspare dall'aspetto un po’ cupo
e rassegnato, da un’aura decadente marchiata da tutti i crepuscoli che
la villa rappresenta: non ultimo quello della Riviera del Brenta stessa.
Le pietre, chissà come, riescono a trasmettere queste sensazioni, forse
le stesse che infondevano il bel canto del sopranista Velluti e che
turbano l’animo con quella che mi piace definire “l’amarezza delle
cose belle”.