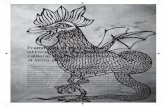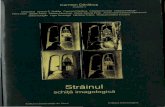Riti del fieno e del latte. Alpi, inizio XXI sec.
Transcript of Riti del fieno e del latte. Alpi, inizio XXI sec.
ATTI SPEA 11 (Seminario permanente di etnografia alpina) in corso di stampa
(16 settembre 2006, Malè)
‘Riti’ del fieno e del latte (Alpi, inizio XXI secolo)
di Michele Corti
Introduzione
Nel mondo industrializzato si moltiplicano gli eventi di‘celebrazione della vita rurale’. Si tratta di manifestazioni chesi sviluppano a partire da sagre/feste a contenuto alimentare oreligioso e che si evolvono in vere e proprie rievocazionicelebrative della vita e del lavoro rurali preindustriali. Moltospesso, però, dietro le apparenze o si celano eventi costruiti atavolino, in cui il legame con la tradizione è flebile o assente.Anche in Italia - dove per lungo tempo la cultura dominante hatrasmesso immagini denigratorie dell’attività rurale - ilcontadino, la sua ‘gastronomia’, ma anche le sue abilità manuali(agricole ed artigianali), i suoi passatempi, sono oggetto diidealizzazione e di amorevole ricostruzione; non già nel chiusodelle sale dei musei etnografici, ma in forma vivente nelle piazzee nelle strade, nelle contrade, nei campi, con protagonisti uominie donne, anziani e giovani e, molto spesso, gli animali1. Sull’ondadi questo revival vengono organizzati eventi delle più varietipologie, alcuni smaccatamente finalizzati a scopi di promozioneturistica, altri di trasmissione un’immagine rassicurante (emistificata) delle attività agroalimentari2, altri ancora, alcontrario, sorgono sulla base di dinamiche interne alle comunitàlocali, per rispondere alle esigenze identitarie delle stesse.
1 Per le feste della transumanza in Francia cfr. J.C.Garnier , F. Labounesse, P.Laurence, C. Salmon. Les fetes de la transhumance en France et leur multiplication recente: premieresobservations, in: Animal production and rural tourism in Mediterranean regions, edby Flamant J.C., Portugal A,V., Costa G.P., Nunes A.F., Boyazoglou J., EAAPPubl. N° 74, Wageningen, Wageningen University Press 1995. 193-197; per quellesull’Arco alpino italiano: M. Corti, Le valenze turistiche ed educative del sistema delle alpipascolive: indagine sugli eventi turistici sul tema dell’alpeggio, Quaderni SoZooAlp (Società perlo studio e la valorizzazione dei sistemi zootecnici alpini) n. 1, StampaTipografia Artigianelli, Trento, 2004, pp . 53-89.2 L. Holloway, Showing and telling farming: agricultural shows and re-imaging British agriculture,Journal of Rural Studies, 20, 2004, pp.319-330.
Queste iniziative, nella loro diversità di attori, pubblico,livello di organizzazione, possono contribuire ad una riflessione(e ad una riconsiderazione) del ruolo della festa popolare nellasocietà contemporanea, su quello alcune forme rituali (a basealimentare ma non solo) quali sfere pubbliche e, più in generale,sui termini del rapporto tra tradizione e modernità.
1.0 - Tradizione/heritage: una realtà definita nel presente e proiettata al futuro
«Traditions are always defined in the present»3
L’ideologia modernista e razionalista considera la tradizione ele espressioni ritualizzate di essa come sopravvivenze, elementiresiduali, qualcosa di ‘naturalistico’ che si perpetua stancamenteed inconsapevolmente. Nell’opposizione dicotomica tra ‘Tradizione’e ‘Modernità’ gli attributi di razionalità e riflessività sonoassegnati alla modernità4. Alla luce di questa ideologia dominanteil revival delle tradizioni festive popolari è interpretato in chiavealternativamente di ‘folclore’ (regressivo o nostalgico) o di‘invenzione’ (con finalità strumentali).
Alla base dell’incomprensione da parte dell’ideologiamodernista del significato delle espressioni sociali rituali efestive vi è la sottovalutazione del loro ruolo per la formazionedelle idee, del consenso e del legame sociale e una specularesopravalutazione dell’importanza delle scelte razionali e dellasfera pubblica dello Stato e dei media. Il ruolo fondamentale perla vita sociale delle cerimonie rituali, anche nell’ambito dellesocietà moderne è stato però da tempo riconosciuto dallasociologia. La partecipazione ad azioni simboliche comuni,eseguire gli stessi gesti, lanciare le stesse grida, cantareinsieme, consumare gli stessi cibi – specie se questi ultimirimandano a un proprio contenuto simbolico – risponde ad unafondamentale esigenza di comunione sociale. Secondo Durkheim lapartecipazione a riti collettivi periodici non è solo una delletante possibilità di stabilire i legami che definiscono il grupposociale, ma una condizione necessaria. Oltre a mantenere lasolidarietà sociale questi riti periodici la rinnovano e larafforzano. I sentimenti e le idee collettive che rappresentano il3 R. Bendix, Tourism and Cultural Displays: Inventing Traditions For Whom?, Journal ofAmerican Folklore, 102/104, 1989, pp. 131-146.4 X. Costa, Festive Tradition in modernity: the public a sphere of the festival of the ‘Fallas’ in Valencia(Spain), The Sociological Review, 50, (4), 2002, pp. 482-504.
collante sociale possono essere riaffermate solo in forme in cuigli individui sono strettamente riuniti partecipando ad azionirituali che ‘non differiscono in natura dalle cerimoniereligiose’.5 Costa sottolinea come la tradizione sia in strettarelazione con la modernità attraverso una molteplicità di legami ericollega gli aspetti artistici e ludici della socievolezza (cosìcome definita da Simmel) a quella ‘socievolezza festiva’ che sisviluppa presso una comunità che, in modo consapevole, coltiva irituali della festa popolare quale tradizione6. Questo autore nonmanca di rilevare come la festa tradizionale rappresenti una sferapubblica che non è in opposizione con le forme moderne diesperienza e riflessività sociale, ma che, al contrario, leincorpora nell’ambito di una dialettica tra la tradizione el’esperienza di vita quotidiana. Attraverso le attività in cui siesplica la socievolezza festiva si realizza la trasmissionedinamica della tradizione. Su questa linea si colloca anche Bendix7
che, a proposito dell’ ‘invenzione’ di feste popolari a Interlaken(Svizzera), rigetta l’interpretazione che vede in questi eventiuna strumentalizzazione della comunità locale dal momento che «theprocess of inventing traditions is always tied into the socioeconomic constellation of acommunity»8. In questa prospettiva la tradizione può essereconcepita solo in relazione con il presente e la modernità.Vedremo oltre, analizzando il caso di studio principale oggettodella nostra indagine, che l’elemento di riflessività e di legamecon il presente e con i bisogni attuali della comunità, risultanocon chiarezza nel caso della Sagra del Pradèir [falciatore] di Piattadi Valdisotto (So): una pratica tradizionale, che in passato eracaratterizzata da un forte contenuto simbolico e che - con latrasformazione del sistema agricolo - aveva subito unaconnotazione di marginalità e residualità (accompagnata dallaperdita e dal depotenziamento degli elementi simbolici), assumeoggi nuovi significati che recuperano gli elementi simbolicipreesistenti utilizzandoli ai fini di una forma di celebrazionefunzionale ad una strategia consapevole della comunità. Ciòavviene individuando nella falciatura un aspetto chiave della vitatradizionale e costruendo intorno ad esso un evento celebrativoche, con la sua ripetizione annuale9 e ritualizzata, assume esso5 E. Durkheim, Le forme elementari della vita religiosa, Milano, 1963, p. 449.6 X. Costa, op. cit.7 R. Bendix, op. cit.8 Ibidem.9 Eckman, a proposito del revival di rievocazioni a carattere storico e culturalelocale in Svezia osserva come: «[…] even though these cultural manifestations differ in formand content as well as in the degree of authenticity and innovation they still emphasize local values and
stesso i connotati della tradizione. Nella tradizione, neirituali celebrativi pare impossibile scindere gli aspetti dirichiamo al passato dalle finalità e dai bisogni del presente;tradizioni e riti sono un fattore di cambiamento e di innovazione,ma una nuova celebrazione di riti assume forza e legittimità inforza del richiamo ad esperienze rituali precedenti e ad un riccocorredo simbolico. Quando l’interpretazione tende adipostatizzare questi ultimi aspetti senza approfondire ledinamiche sociali sottese è inevitabile che si incorra nelfraintendimento modernista. Bessière10 propone un superamentodella dicotomia tra Tradizione e Modernità basatosull’introduzione di un terzo elemento: l’Heritage che definiscecome interazione tra i due termini dell’opposizione, unacombinazione di conservazione e innovazione una costruzionedinamica in continua evoluzione che genera nuovi significati equindi identità, risolvendo in sé i termini del dualismo. LaTradizione è quindi individuata come continuità, permanenza,stabilità, riproduzione in opposizione alla Modernità cherappresenta il termine della frattura, del cambiamento, deldinamismo, della costruzione, della creazione. In linea con gliautori precedentemente citati ci pare di poter sostenere una‘pura’ Tradizione (ma anche una ‘pura’ Modernità) così definitenon esistono nella realtà sociale effettuale e che la tradizionenon può che esistere nei termini che Bessière attribuisceall’Heritage. Per Bessière l’“Heritage (along with traditional practice) is part ofthe present, and at the same time holds promises for the future; the problem of the past isa modern one”. Di più l’Heritage rappresenterebbe, sempre per questoautore, una riserva di significati per comprendere il mondo, perelaborare alterità e, conseguentemente, un’ identità.
Turismo, dinamiche di comunità, revival rurale
through repetition they establish link with an appropriate past». (A-K. Ekman, The Revival of CulturalCelebration in Regional Sweden. Aspects of Tradition and Transition, Sociologia Ruralis, 39 (3)1999, pp.280-293. A proposito delle sagre organizzate negli Stati Uniti sul temadi determinati cibi Lewis osserva che anche nel caso di celebrazioni‘inventate’: « this fictively instigated social cohesion will actually remain in the community once thefestival is over-to (again, hopefully) be ritualistically renewed the following year».( G. H. Lewis,Celebrating Asparagus: Community and the Rationally Constructed Food Festival, Journal ofAmerican culture, 20 (4), pp.73-78).
10 J. Bessière, Local Development and Heritage: Traditional Food and Cuisine as Tourist Attractions inRural Areas, Sociologia Ruralis, 38, (1), 1998, pp. 21-34.
«Tourism thus permits partecipation in consumption and celebration of a series of local rites,including numerous events set up to show off heritage riches, allowing the tourist social and culturalintegration in the local group by absorbing and reproducing cultural codes. Gastronomy would be such acode»11.
Il turismo rurale si colloca nel solco della crescita di formedi turismo interessate alle tradizioni e alle diversitàculturali12, alle peculiarità culturali regionali e non daiclassici luoghi della cultura13. Rispetto al turismo di massa(‘moderno’), caratterizzato dall’esperienza turisticasuperficiale, dalla standardizzazione, il turismo ‘postmoderno’era già stato identificato già da MacCannel14 all’inizio degli anni’70 del secolo scorso con la ricerca di ‘autenticità’ comereazione a uno stile di vita sempre più ‘artificiale’.
Il successo del turismo rurale, che, in seguito, si è in estesoe rafforzato, deve essere ricercato nell’impatto dei processi dimodernizzazione e globalizzazione sulla società urbana. La ricercadi una identità, di una comunità sono da porre in connessione conla reazione alla crescente complessità del mondo moderno nel qualeil legame sociale si indebolisce o si spezza, i rapporti socialisono sempre più mediati e formali, i ruoli non sono più definiti estabili. L’esigenza di punti di riferimento spazio-temporali, dicontinuità, di valori ‘autentici’ è sempre più avvertita inrelazione alla moltiplicazione delle immagini e di realtàvirtuali, all’accelerazione del cambiamento di prospettive,certezze, valori, alla rapidità con cui i cicli delle mode edell’innovazione tecnologica consumano il presente nella tensione,indotta artificialmente dal consumismo, tra nostalgia (surrogata)per passati immaginati e fantasie precorritrici del futuro15.
Uno degli aspetti dei processi di alienazione sociale che intempi recenti hanno ricevuto crescente attenzione, tanto daportare al riconoscimento delle problematiche dell’alimentazionequali primario terreno di scontro sociale e politico16, è quello11 Ibidem.12 U. Bernardi , V. Filippi, Dal turismo ai turismi: trasformazioni sociali e sfide culturali.Aggiornamenti sociali, (5), 2002, 398-409.13 R. Bachleinter, A.H. Zins, Cultural Tourism in Rural Communities: The Residents’ Perspective.J. Busn. Res., 44, 1999, 199-209.14 D. MacCannel, Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in Tourism Settings. AmericanSociological Review, 79, 1973, pp.589-603.15 A. Appadurai, Modernità in polvere, Roma, 2001.
16 Cfr. anche per i riferimenti bibliografici M.Corti, Contadini e allevatori del Nordnelle transizioni rurali del XIX e XX secolo, SM Annali di S.Michele, 18, 2005, pp. 135-174.
dell’alienazione (o anomia) alimentare. Il cibo offerto dalsistema agroindustriale è de-identificato ossia de-stagionalizzato, de-localizzato (ri-localizzato), de-ritualizzato.17 I processi di trasformazione rendono sempre menoriconoscibile la natura del prodotto di partenza; lecaratteristiche organolettiche del cibo sono sempre più “coperte”e quindi manipolabili, la distanza tra produttore agricolo econsumatore aumenta sempre più e viene compensata da meccanismiistituzionalizzati e impersonali di ‘garanzia di origine’.
Il desiderio del ritorno ad una alimentazione ‘naturale’ legataal passato è l’inevitabile controtendenza all’anomia alimentare.Il mercato sa abilmente sfruttare questa tendenza presentandoprodotti di massa in modo da lasciar supporre una provenienzacampagnola od offrendo la cucina del territorio in ristoranticostosi18; ma, d’altra parte, il consumatore sta imparando acercare rapporti diretti (di tipo tradizionale o innovativo)19 coni produttori agricoli ‘rurali’ (ovvero non fagocitati all’internodelle filiere agroindustriali e dei corrispondenti sistemi direlazioni sociali verticali). Non deve meravigliare in questocontesto come una delle motivazioni principali del turismo ruralesia rappresentata dal consumare i prodotti rurali sul luogo diproduzione, sia acquistandoli direttamente in azienda chedegustandoli presso osterie e ristoranti di campagna o presso lefeste o sagre che celebrano il cibo e la gastronomia locali.
L’importanza simbolica e culturale di queste pratiche diconsumo e di partecipazione ad eventi sul tema del cibo e dellagastronomia rurali è stata sottolineata da Bessière che coglie inesse il desiderio di integrazione in una realtà sociale opposta aquella dell’industria alimentare e ad appropriarsi, sia pure inmodo effimero, di un’identità rurale20. La domanda, leaspettative del turista/consumatore nei confronti della dimensionerurale (gastronomica e non) hanno pertanto alla base i seguentibisogni: integrazione in riti e significati, re-identificazione,ricerca di autenticità.
17 N. Herpin, Le repas comme institution, Revue Française de Sociologie, 29 (3), 1988,pp. 18 J. Bessière, op. cit.19 Cfr. le nostre note sulla ‘creatività commrciale’ (M. Corti, 2005, op.cit.)20 «By eating a so-called natural or traditional product, the eater seems to incorporate, in addition tonutritional and psychosensorial characteristics of the food, certain symbolic characteristics: oneappropriates and embodies the nature, culture and identity of an area. It also represents integration into asocial world as opposed to the universe of industrialized food. Eating farm-fresh products, for example, mayrepresent for the urban tourist non only a biological quality, but also a short-lived appropriation of a ruralidentity. He symbolically integrates a forgotten culture». J. Bessière, op. cit.
A questo punto è lecito chiedersi chi, perché e come puòsviluppare un’offerta in grado di corrispondere a questi bisogni ecercare di capire su quale terreno e con quali conseguenze questedomande e le rispettive offerte si possano incontrare.
Per soddisfare questi quesiti va considerata una fondamentalepremessa: in parallelo con l’alienazione urbana e, in particolare,con il suo corollario dell’alienazione alimentare, si è sviluppatauna forma di alienazione rurale che è diretta conseguenza deiprocessi di industrializzazione della produzione agroalimentare esulla quale ci soffermeremo maggiormente in ragione della
1.3 - Alienazione rurale
‘Campagne senza agricoltura e agricoltura senza campagne’21 inquesta espressione si può condensare il senso di un processo diconcentrazione e specializzazione della produzione agricola ealimentare che si è fisicamente separata, allontanata da moltearee rurali nelle quali, in ragione della diversa prossimità acentri urbani e/o turistici si sono innescati fenomeni dimarginalizzazione (sino allo spopolamento) o di un neo-ruralismo amatrice residenziale e ricreativa, tali da determinare fenomeni digrave perdita di identità sociale e territoriale22. Le attivitàagrozootecniche residue in molte aree rurali hanno subito processidi modernizzazione e di integrazione subalterna che hannotrasformato il produttore in un trasformatore di materie primeacquistate dall’industria (pesticidi, carburanti, mangimi,farmaci, integratori alimentari) e in un venditore di una solamateria prima destinata alla trasformazione industriale, cedutaalle condizione imposte da un mercato globalizzato in cui ilprezzo di un prodotto divenuto commodity , come il latte conferitoalle centrali di raccolta dallo stesso allevatore alpino, è legatoalle condizioni climatiche che si registrano in lontane parti delmondo23. Questi processi determinano fatti rilevanti per la nostraanalisi del significato delle manifestazioni di celebrazione dellavita rurale e, nella fattispecie, di quelle legate al ciclo dellaproduzione zootecnica alpina. Un primo aspetto da considerare ècostituito dalla perdita della dimensione comunitaria dellaproduzione agrozootecnica intesa come processo ecologico e sociale21 C F. Cassola , Storia delle campagne padane dall’Ottocento a oggi, Milano,1996,Introduzione.22 M. Corti, 2005, op. cit.23 E’ il caso dell’andamento congiunturale del prezzo del latte nel 2007influenzato dalla siccità in Australia con la conseguente riduzione delleforniture alle industrie di produzione del latte in polvere europee.
di interscambio fisico e sociale tra la comunità insediata e leproprie risorse territoriali. I produttori agricoli hannoprogressivamente rescisso le reti orizzontali locali disolidarietà e sono risultati incapsulati in filiere verticalidominate dall’industria e dalla tecnoburocrazia24. La sorte dellelatterie sociali (già turnarie) di villaggio (che hanno costituitoun importante fattore di aggregazione sociale oltre che economicain molte comunità alpine) è a questo proposito emblematica e, nona caso, emergerà anche nel contesto della nostra analisi deglieventi celebrativi della vita rurale: sotto la spinta degliallevatori più grandi - indotti da varie pressioni da parte delmilieu corporativo a conferire il latte agli impianti ditrasformazione industriale - le latterie di villaggio sono statechiuse o, in alcuni casi, sono state ‘colonizzate’ dai caseificiindustriali25.
D’altra parte quella che era in passato una gestionecomunitativa delle risorse dei pascoli e degli alpeggi 26 si ètrasformata in una gestione imprenditoriale da parte delle pocheaziende zootecniche rimaste attive come conseguenzadell’applicazione di politiche produttivistiche e di una mioperiduzione dell’attività agricola a fatto monofunzionale,economicistico, aziendalistico, del tutto indifferente non soloalle funzioni di produzione di significati sociali e simbolici(sarebbe chiedere troppo!), ma, molto matericamente, anche allefunzioni di accudimento del territorio. Sulla base delle mereconsiderazioni di profitto aziendale, una volta integrata l’unitàdi produzione in una filiera industriale in stretta relazione conil mercato globale, la scelta di acquistare il foraggio sulmercato e di sfalciare solo quei prati dove risulta possibile lacompleta meccanizzazione delle operazioni colturali. Laconseguenza è un territorio soggetto all’ ‘inselvatichimento’nell’impotenza di una comunità che vede il suo stesso spaziofisico modificarsi e restringersi in stridente contrasto con unpassato in cui le attività agrosilvopastorali se da una parteconsentivano – a costo di fatiche oggi impensabili – alimenti edaltri mezzi materiali di sostentamento, dall’altra strutturavano edavano un senso allo spazio fisico e sociale in una densaproduzione di significati.
24 M. Corti, 2005, op. cit.25 Anonimo, Il formaggio raro dei maggenghi, Cheese Time, n. anno 4, n. 6 2007 p.6; F.Gusmeroli, Le latterie di Valtellina si rinnovano, Cheese Time, n. anno 4, n. 6 2007 p.6.26 M.Corti, Süssura de l aalp. Il sistema dell’alpeggio nelle Alpi lombarde, SM Annali di S.Michele,17, 2004, pp 31-155.
Oggi la possibilità di operare un controllo su questo spaziorisulta demandata a pochi soggetti privati (gli imprenditoriagricoli a titolo principale’), condizionati da esigenze diprofitto, o alle ‘istituzioni’, condizionate da meccanismi checomportano costi elevatissimi per operare quegli interventi untempo garantiti dalla capillare e continua opera di manutenzionedei contadini. Vi è quindi una grave perdita di produzione disignificati, di costruzione e senso di appartenenza dellalocalità, di identità.
Al di là di questi aspetti legati al ‘divorzio tra agricolturae rurale’27 l’alienazione rurale assume anche altri aspetti:impiegati in attività industriali, nei servizi, nel turismo –spesso in centri più o meno distanti dalla località di residenza -i membri della comunità non sono più uniti da interessi esentimenti comuni, che, in passato, erano assicuratidall’esercizio, da parte di ognuno, dell’attivitàagrosilvopastorale. Quest’ultima, infatti, presupponeva condizionied esperienze comuni quando non l’esigenza di forme di aiutoreciproco che i membri delle comunità alpine ex-rurali sentono ilbisogno celebrare nel presente alla ricerca di elementi diidentità e solidarietà.28
Per le piccole comunità ‘tagliate fuori’ dallo sviluppoindustriale e turistico, ma anche per la popolazione locale dicentri ‘sviluppati’, che hanno visto modificata profondamente lapropria identità a seguito della presenza di lavoratori immigrati,‘nuovi venuti’ in fuga dalla realtà urbana) turisti che occupanole ‘seconde case’, l’esigenza di riaffermare e rielaborare -attraverso la memoria del passato della comunità - una proprianuova riconoscibile identità appare quale un bisogno fortementesentito. In funzione della condizione specifica della comunitàl’alienazione rurale determina una serie di esigenze: riproduzionedi memoria sociale e di senso di condivisione, mobilitazione dienergie al di fuori di una routine caratterizzata dall’impoverimentodi interessi sociali e/o dalla loro focalizzazione al di fuoridell’ambito della comunità, affermazione di alterità e diidentità, ri-vitalizzazione culturale ed economica. Questi bisogninon solo in contraddizione con il turismo, ma, anzi, propriodall’incontro tra le esigenze indotte dall’alienazione urbana e da
27 C.Barberis, Il divorzio della campagna dall’agricoltura, Rivista di sociologia, 10, 1972, pp.95-108.28 P.Heady, Il popolo duro. Rivalità. Empatia e struttura sociale in una valle alpina, Udine, 2001,pp.191-195.
quella rurale possono scaturire innovazioni, iniziative, soluzionipositive.
1.4 - Un interscambio indispensabile
Il successo economico dell’offerta di eventi rievocativi dellavita rurale tradizionale quali prodotti turistici non risulta incontrasto con le finalità culturali ed identitarie29. Ilmantenimento di legami comunitari e dell’orgoglio per il propriopatrimonio culturale rappresentano, anzi, una premessa importanteaffinché i residenti siano coinvolti in modo attivo nellaprogrammazione e nella realizzazione di iniziative di turismorurale culturale30. Queste ultime possono, a loro volta,contribuire a rinsaldare ulteriormente l’identità locale in unprocesso di rinforzo reciproco. 31 Bessière sostiene che siverifica convergenza tra il processo di costruzione esterna ditipo turistico (valori inerenti al viaggiare e alla ‘ricercaturistica’ da un punto di vista simbolico e mitico) e il processodi costruzione interna dell’Heritage e mette in evidenza come letradizioni gastronomiche rurali traggono nuova vitalità edispirazione dalle contraddizioni e dalle crisi della vitametropolitana e arriva a concludere che ‘in some rural areas, city dwellersdevelop heritage consciousness’.32 Il turista non gioca solo unindispensabile ruolo economico ma svolge anche un ruolo importantenel processo culturale di ri-costruzione di una memoriaidentitaria. Rappresenta un pubblico, il recettore di unarappresentazione del rurale che si rafforza nell’interazione conun destinatario che mostra di apprezzarla e di condividerla.Ekman33 nota come le manifestazioni di revival culturale localerappresentino al tempo stesso una ricerca di identità, lapromozione del turismo e una mobilizzazione a favore dellosviluppo economico e sottolinea come gli elementi di rafforzamentodell’identità locale risultino inestricabilmente connessi con la
29 K. Bres K., J Davis , Celebrating group and place identity. Tourism Geographies, 3, (3),2001, pp. 326-337.30 S. Lankford S., Attitudes and Perceptions toward Tourism and Rural RegionalDevelopment. Journal of Travel Research 32, (3), 2004, pp. 35-43.31 Riferendosi alle feste sul tema di particolari cibi organizzate negli StatiUniti Lewis osserva come «Spawned by the desire of communities to put themselveson the map, creating positive images and symbols for themselves (which in turn,generates spirit as well as attracting tourists and business interests)». G.H.Lewis, op.cit.32 J. Brassière, op. cit.33 A-K. Ekman, op. cit.
rivitalizzazione economica comportando effetti positivi specie perle località svantaggiate. Anche se, come nota la Ekman, glieventi rievocativi possono assume significato diverso per lediverse categorie di partecipanti (turisti e ‘nuovi venuti’ da unaparte, elemento locale dall’altra)34, è importante il ruolo che i‘nuovi venuti’ svolgono quali volontari nell’organizzazione deglieventi a fianco dell’elemento locale. Nel mentre gli eventirievocativi mantengono o rafforzano il carattere distintivo dellalocalità rispetto ad altre ripristinando anche – sul pianoculturale - vecchi confini amministrativi35, esse, all’internoassumono un ruolo di rafforzamento del senso di appartenenzaattraverso il ruolo di accettazione e inclusione sociale di nuovigruppi. Questo aspetto, ovvero le relazioni tra gruppi sociali haimplicazioni tutt’altro che banali: l’organizzazione di eventicelebrativi della memoria locale può risolvere problemi diconflittualità potenziale o effettiva tra i locali, i ‘nuovivenuti’ e i turisti.
1.5 - La rappresentazione contesa del rurale
Il sottolineare le implicazioni sociali positive dell’incontrotra le esigenze del turismo rurale alla ricerca di ‘autenticità’ ele dinamiche di re-identificazione e mobilitazione delle comunitàlocali non significa ignorare che, molto spesso, spesso i bisognialla base del revival rurale trovano risposte surrogatorie,mistificate, che implicano nuove forme di mercificazione econsumismo e la legittimazione di quel sistema di produzione econsumo che è all’origine dei fenomeni stessi di alienazioneurbana e rurale. Uno degli aspetti che tendono a ‘corrompere’ ilcarattere autentico delle manifestazioni legate al cibo e ad altriaspetti della vita rurale e della festività tradizionale è legatoalla tendenza all’imitazione di formule ‘di tendenza’ che hannoincontrato il favore del pubblico36 o che sfruttano più o meno
34 «Local history festivals mean different things to different people. The tourist or the incomer may have aninterest in antiques and in learning old techniques, while to the locals these are familiar things and theyexperience the festival more in terms of social contexts and continuity». Ibidem.35 Ibidem.36 […] «all too often, the images and traditions created are imitative and shallow. In the end, the‘authentic’ tradition of one community may be, for all cultural intents and purposes, much like any other-asinterchangeable as local malls and fast food outlets». G.H. Lewis, op. cit. «Some heritage ortradition may be misunderstood, misrepresented or may even be considered genuine inherited, when theyare in fact recent artificial constructions void of any historical substance. Such ‘folklore’ products maybecame a form of escape therapy, and may have a dimension especially created for one particularoccasion», J. Bessière, op. cit.
consapevolmente il modello mitico della celebrazione comunitariaper finalità meramente commerciali o promozionali37. Trapiantatein un diverso contesto culturale le iniziative realizzate per purospirito imitativo, realizzate senza preoccupazioni diapprofondimento e di coerenza culturali, con scarso coinvolgimentodella comunità e dei gruppi locali, possono determinare impattisociali e culturali negativi fino a sviluppare la percezione dellamercificazione e dell’esproprio della propria cultura e quindiindurre nuove diffidenze da parte di un comunità locale cherischia di chiudersi ancora più in sé stessa e nella passività.
La rappresentazione del rurale è oggi contrassegnata daconflitti simbolici che vedono impegnate le comunità e iproduttori rurali da una parte, gli apparati industriali etecnoburocratici dall’altra. Costruire una rappresentazionesociale significa far interagire esperienze personali econvinzioni che, veicolate dalla letteratura, dai media, dallostato, dalla famiglia, dagli amici, dalle istituzioni, assumono ilcarattere di un portato tradizionale38. La tradizione, che siconferma quale costruzione definita nel presente (e in funzionedel futuro) è quindi un elemento chiave per l’affermazione diopposte visioni del rurale. La strategia iconograficadell’industria sottolinea l’aspetto folcloristico, stereotipato,decontestualizzato della tradizione in perfetta corrispondenza conl’ideologia modernista che vede in essa qualcosa appartenente alpassato, finito ‘inevitabilmente’ per sempre.
Il richiamo al passato serve quale richiamo emotivo per ilconsumatore sollecitato dall’immagine dell’idillio alpestrementre sul piano razionale l’industria si presenta come l’eredelegittima di questo passato attraverso una spregiudicataoperazione di ‘esproprio della memoria’ che trova la suaespressione nel paradigma del Mulino Bianco: l’idillio ruralecommodificato. 37 «Festivals of this type are ‘invented’ usually by groups who have an economic interest in generatingbusiness and public relations in an area, and can beviewed as using a fictive altruistic and mythic model ofcommunity celebration as their rationale, while at the same time being centrally focused on attractingattention and dollars to particular communities and groups». G.H. Lewis op. cit. Ilcarattere fittizio di queste manifestazioni emerge con evidenza nei tentativi ditrapiantare in ambito urbano il modello della sagra paesana promossi daassociazioni di quartiere o da associazioni di commercianti di determinate zonecittadine. L’utilizzo di alcuni elementi esteriori non basta a ‘scaldare’ ilclima di questi eventi ma è significativo di come di un certo ribaltamento divalori tra la campagna e la città che accoglie al suo interno forme culturaliprovenienti dalla, fino a ieri, disprezzata ‘campagna’.38 K. H. Halfacree, Locality and social representation: space, discourse and alternative definitions of the rura, Journal of Rural Studies 9 (1), 1993, pp. 23–37.
Quanto più la produzione alimentare si separa dalla realtàrurale e assume il carattere di complessi processi tecnologici,quanto più l’immagine del food system è associata a devastantiimpatti ambientali39 agli scandali alimentari, all’evidenza dellasofferenza animale insita nei sistemi intensivi di allevamento40,tanto più il sistema agroindustriale stesso ricorre a strategie di‘re-imaginig’41. L’esibizione accattivante di animali, bidoni dilatte, vecchi attrezzi agricoli, ragazze in costume rappresenta iltentativo ricollocare in una dimensione ‘rurale’ (meglio seaspaziale e atemporale) un sistema agroindustriale che, comeabbiamo già avuto modo di osservare, ha da lungo tempo divorziatostoricamente e fisicamente dal rurale42.
Questa rappresentazione sociale del rurale, funzionale allestrategie di legittimazione dell’agroindustria, è ovviamentecontestata dai produttori rurali in modo tanto più vivace quantopiù questi ultimi oggi non rappresentano un ‘residuo’ di unsettore di piccola produzione agricola destinato alla scomparsama, al contrario, un’avanguardia di aziende che hanno deciso dipercorrere una traiettoria diversa da quella dellaspecializzazione e dell’espansione della scala produttiva (conl’inevitabile corollario della subordinazione alle filiereindustriali) puntando sulla ‘filiera corta’ (con l’esempioemblematico della distribuzione automatica del latte crudosfuso43), sulla differenziazione, sulla reintegrazione nell’unitàdi produzione agricola dei processi di trasformazione alimentare,sulla multifunzionalità (offerta di servizi didattici, educativi),tutti aspetti che implicano l’intreccio di multiformi relazionieconomiche, sociali e culturali con il consumatore (residente oturista) e la ri-produzione di valori sociali e simbolici. Quelle
39 Livestock’s Long Shadow, xxxxxxxxxxxx, Fao, xxxxxx, 200640 Cfr. la documentazione sui maltrattamenti inflitti alle vacche da latteprodotta dalla Lav (Lega antivivisezione) negli allevamenti e nei macelli dellaLombardia e dell’Emilia-Romagna xxxxxxxxxxx alla fine del 2006 e riportata sadiversi media.41 «The image thus created of farming tends to collude in the reproduction of a perspective that ‘forgets’particular issues (including slaughter, but also aspects of intensive livestock production), and instead tendsto associate farming with spectacular or appealing live animals, a sensual experience of food and thefarmed landscape, and conservation practices». L. Holloway, op. cit. 41 «Social representation of agriculture tend to locate that shere of activity in simultaneous representationsof rurality, so that attempts to re-image agriculture simultaneously implicate particular socialrepresentations of rurality». Ibidem.42 M. Corti, Le piccole aziende ………….. Caseus n. 3, 2007, pp. ….
42
43
che l’agroindustria utilizza come icone nella rappresentazionestrumentale di una ruralità idealizzata da ‘natura morta’, per iproduttori rurali costituiscono, oltre che a degli strumenti dilavoro, dei simboli viventi di una reale continuità con il saperfare tradizionale, nel solco di una produzione che si qualificaper il contenuto di manualità, assenza di standardizzazione,artigianalità. La contesa intorno a questi simboli è aspra inquanto la legittimazione che può conseguire per uno dei due campicontrapposti dall’affermazione della propria rappresentazione delrurale comporta, inevitabilmente, la delegittimazione dell’altrocampo44. Anche considerando che la diversa qualità organoletticadei prodotti rurali può rappresentare un termine di paragone nonfavorevole per la produzione industriale45 risulterebbe
44 Tra i produttori rurali dell’Associazione produttori Valli del Bitto (noti come i‘ribelli del Bitto’) e il CTCB (Consorzio di tutela Casera e Bitto - i formaggiDop della Provincia di Sondrio -) è da anni in corso quella che è stata definitala ‘guerra del Bitto’ che ha trovato eco sulla stampa nazionale e persino suimedia di altri paesi europei (T. Santagostino Antropologia della tipicità. Il caso del Bittodella Valtellina. Elaborato finale. Corso di Laurea in Scienze Umane dell’Ambiente edel Paesaggio. Università degli Studi di Milano, aa. 2005/2006. Relatore Prof.S. Allovio). Uno degli elementi della battaglia simbolica tra questi soggetti èrappresentato dal calec’, la capanna casearia, costituita da un recinto di murettoa secco sormontato da un semplice telone impermeabile, dove tutt’ora – inparecchi casi - si lavora il latte per la produzione del formaggio Bitto. Se dauna parte gli esponenti ‘modernisti’ del CTCB esibiscono il calec’ come iconaricostruendolo nell’ambito delle manifestazioni fieristiche e, in formamuseificata, all’interno dei maxi-agriturismi di alcune delle più grandi aziendezootecniche del fondovalle valtellinese, dall’altra essi considerano il suoutilizzo incompatibile con i presupposti di una produzione igienica qualificandocome ‘trogloditi’ coloro che ‘insistono’ ad utilizzarlo (M.Corti, Bitto: una storiaesemplare una questione aperta, Caseus, n. 3 a. 2006, pp. 20-39.). Nelle ultimestagioni d’alpeggio, e ancor più in quella in corso [2007] non solo l’uso delcalec’ è stato ripristinato in alcuni alpeggi ‘ribelli’, ma anche in un alpeggio-agriturismo gestito dal più grande caseificio sociale valtellinese (con unruolo chiave nel CTCB) che lo utilizza come ‘vetrina’. 45 Quest’ultima anche quando presentata come ‘tipica’ attraverso l’uso didenominazioni tradizionali (forma concreta di esproprio della tradizione) ècaratterizzata da prodotti con caratteristiche poco marcate in relazione aiprocessi di termizzazione del latte (di varie e variabili provenienze),all’impiego delle medesime attrezzature, dei medesimi innesti di fermentiselezionati (o comunque da pochi tipi sempre uguali a se stessi e della medesimaprovenienza industriale). Il consumatore ‘moderno’ tende a prediligere questotipo di prodotti dai gusti appiattiti, dolci, di poco impegno gustativo; sitratta di preferenze dettate dai mutamenti degli stili di vita e di consumo, maspesso dipendono dal fatto che le sue esperienze di consumo sono chiuseall’interno della gamma di prodotti industriali e non ha avuto la possibilità diconfronti con prodotti artigianali. Questo processo di costruzione dellepreferenze del consumatore, in funzione delle esigenze del food system, èravvisabile nella crescente preferenza per la frutta immatura, la carne non
incomprensibile la preoccupazione dei grandi caseifici industrialial di fuori del conflitto simbolico che abbiamo delineato.
2.0 - Lo studio empirico: i casi e la metodologia
Nell’ambito del revival delle celebrazioni della vita ruralealpina abbiamo circoscritto la scelta dei casi di studio oggettodi indagine empirica ad una valle alpina, la Valtellinaincludendo, però, un evento particolare al di fuori di quest’area.Quanto al tema delle celebrazioni – indipendentemente dallaconnessione più o meno superficiale con il reale contenuto di esse– si sono considerati i richiami ai cicli del fieno e dellatransumanza alla base delle condizioni di riproduzione fisica edel legame sociale delle comunità alpine e fondamentale scansionedel tempo annuale46. Delle quattro manifestazioni prese in esamesolo una: la Sagra del pradèir di Piatta di Valdisotto (So) haall’attivo diverse edizioni, le altre sono molto recenti dalmomento che la loro prima edizione risale al 2005 o 2006.
Evento (denominazione)
Località Primaedizione
Data disvolgimento
Sagra del Pradèir Piatta di Valdisotto (alta Valtellina)(So)
2000 30.07.2006/29.07.2007
Transumanza Aprica (Valtellina)(So) 2005 02.09.2006Festa del fieno Livigno (alta Valtellina)
(So)2006 08.08.2006
Transumanza dei bergamini
Abbiategrasso (valle del Ticino) (Mi)
2005 15.10.200547
I metodi di ricerca impiegati sono stati di tipo qualitativo.La Sagra del Pradèir è stata oggetto di osservazione partecipata daparte dell’autore48 che ha avuto la possibilità di eseguire riprese
frollata, a tutto detrimento delle qualità organolettiche e nutrizionali diquesti prodotti. Le esperienze gustative ‘diverse’ possono ribaltare questastruttura di preferenze come appare evidente nel caso del latte crudo. Ilsuccesso della vendita del latte crudo, non pastorizzato, non omogeneizzato, nonscremato (il latte definito in modo mistificatorio ‘intero’ dalla normativavigente subisce una parziale scrematura del quantitativo di grasso eccedente iltenore minimo imposto dalla normativa stessa) è in larga misura legato al gusto‘pieno’ del latte non privato del suo contenuto lipidico.46 E’significativo un proverbio inciso su una trave lignea di una delle piùantiche dimore rurali di Bormio: Agn de nef, agn de fen, agn de ben [annata nevosa,annata di fieno, annata di abbondanza].47 La manifestazione si è svolta anche nell’ottobre del 2006. 48 Che, nel caso della Sagra del Pradèir è stato (immeritatamente) anche cooptatonella giuria della ‘gara de la segànda’ (prova di falciatura); la partecipazioneall’evento ha riguardato le fasi salienti: dalla fine della mattinata a tutto il
fotografiche, eseguire brevi interviste non strutturate,raccogliere note di campo scritte nel corso dell’edizione del2007, mentre, in occasione di quella precedente, aveva avuto lapossibilità di somministrare una lunga intervista non strutturataa Duilio Tagliaferri, organizzatore dell’evento e animatore delGruppo tradizionale S. Anna di Piatta, di ottenere fotografie illustrantivari aspetti del suo svolgimento e di acquisire materiale astampa. Nel caso della Transumanza (dell’Aprica) la breve duratadelle azioni costitutive dell’evento ha consentito l’osservazionediretta da parte dell’autore di tutte le fasi del medesimo, conesecuzione di riprese fotografiche, registrazione sonora diconversazioni, commenti di organizzatori e spettatori in partestimolati da domande dell’autore. Per le altre manifestazioni nonè stato possibile effettuare osservazioni partecipate; sono stateperaltro analizzate riprese fotografiche fornite dagliorganizzatori (Livigno) o eseguite appositamente da uncollaboratore (Abbiategrasso) e sono state eseguite breviinterviste telefoniche con gli organizzatori o testimoniprivilegiati. In tutti i casi sono stati analizzati i materialitestuali ricavati da pagine internet, depliant, locandine, menù.
2.1 La Sagra del Pradèir di Piatta di Valdisotto
«Con le nostre attività sosteniamo la latteria turnaria del paese […]»49
«Da come la gente pratica lo sfalcio, risulta chiaramente che non è solo un modoper ottenere fieno, ma anche un modo per imporre l’ordine»50
La Sagra del Pradèir di Piatta, giunta alla settima edizione,
appartiene a pieno titolo alle manifestazioni di celebrazionedell’ Heritage della comunità locale. Si tratta di un eventoaltamente organizzato, frutto di un lungo, appassionato,impegnativo lavoro di preparazione che mobilita una significativacomponente della piccola comunità di Piatta, una frazione delComune di Valdisotto a 3 km da Bormio. «Su 500 abitanti a Nataleper le rievocazioni partecipano più della metà, 70 partecipanoalle diverse iniziative»51. Come sottolineato da tutti gliintervistati i giovani del paese contribuiscono attivamente afianco degli anziani. La storia del Gruppo tradizionale S. Anna di Piatta,
pomeriggio.49 Intervista dell’autore a Duilio Tagliaferri (di seguito D.F.), organizzatore della Sagra del Pradèir.50 D. Heady, op. cit. p. 26.51 Intervista dell’autore a D.F.
sorto a seguito del successo del ‘presepio vivente’ del 1999,costituisce un interessante esempio di combinazione traspontaneità e riflessività, di partecipazione volontariaentusiastica e di lucido perseguimento di finalità strategiche.«Ci teniamo ad essere un gruppo tradizionale non un gruppofolcloristico» tiene a precisare il fondatore e animatore delGruppo, Duilio Tagliaferro, che aggiunge anche che il Gruppo,nonostante la partecipazione a importanti eventi in varie partidella Lombardia, i riconoscimenti ricevuti in ambito locale eregionale, l’organizzazione di attività didattiche sui temi dellavita rurale tradizionale nelle scuole medie della zona abbiamantenuto un carattere informale, di aggregazione in ambitoparrocchiale, tanto da non tenere una contabilità autonomarispetto alla parrocchia stessa. Il legame con la parrocchia econ le espressioni della religiosità popolare emerge anche nellacoincidenza della Sagra del Pradèir con la festa patronale di S.Anna. Ciò consente già due importanti osservazioni: come ogninuova forma di ritualizzazione la Sagra del Pradèir traelegittimazione e capacità di coinvolgimento dei partecipanti dalcollegamento con provviste simboliche e forme rituali precedenti;lo stretto legame tra l’organizzazione della festa e la parrocchiaè la diretta conseguenza dell’importanza della parrocchia qualeelemento di identificazione per una piccola comunità fisicamenteprossima a centri di ben maggiori dimensioni, dove gravitanoinevitabilmente gli interessi sociali degli abitanti in condizionelavorativa o scolastica.
Un altro aspetto che contraddistingue l’attività del Gruppotradizionale di Piatta è il suo impegno in un ciclo annuale di attivitàrievocative52 che impegnano in modo continuativo i partecipanti indiverse attività di preparazione degli eventi stessi. Il Gruppo,infatti, non si limita ad esibire vecchi attrezzi o costumi, ma èimpegnato nella loro riparazione e allestimento ex-novo e, fattosignificativo per la connessione con la pratica agricola,l’esigenza di rievocazione degli ‘antichi mestieri’ ha portato aintraprendere (sia pure su piccolissima scala) coltivazioni dilino, segale e duméga (un tipo di orzo). Nell’ambito del Gruppo sipratica la tessitura (con telaio di legno) di lino e lana. Unaspetto dell’attività del Gruppo chiarisce il senso del rapportotra la Sagra del Pradèir e altre manifestazioni che vedono lapartecipazione dei componenti del gruppo stesso53. «Partecipiamoalle iniziative turistiche in piazza a Bormio organizzate da albergatori e
52 Oltre alle rievocazioni natalizie un altro evento celebrativo è rappresentatodalla Giornata del pastorello.
Azienda di promozione turistica per finanziare la promozione dellanostra manifestazione»54. La distinzione tra le due categorie dieventi, almeno nella rappresentazione soggettiva di unprotagonista, non potrebbe essere più netta. Un elemento chiaveper comprendere il significato della Sagra del Pradèir (nel contestodell’attività del Gruppo tradizionale) è la connessione che gliorganizzatori intendono stabilire con il presente e il futurodella comunità, specie in relazione al mantenimento e al rilanciodelle attività agricole («Con le nostre attività sosteniamo lalatteria turnaria del paese […]»)55. Come vedremo su questo puntola visione degli organizzatori diverge da quella degliamministratori pubblici che – pur sostenendo la Sagra, e magaripartecipandovi in prima persona – non colgono il valoredell’azione culturale di valorizzazione dell’ Heritage quale‘anticipo di futuro’ e, comunque, quale stimolo alla soluzione deiproblemi attuali della comunità e dello spazio territoriale che nerappresenta una componente inscindibile. Come abbiamo già avutomodo di osservare una visione settoriale, produttivistic,a che halargamente sottovalutato le valenze socio-territoriali connesseall’esercizio delle attività zoocasearie in area alpina, hapromosso la chiusura delle latterie di paese in nome dimotivazioni di razionalizzazione produttiva e commerciale (oggi,peraltro, largamente rimesse messa in discussione56) con ilrisultato di disperdere un patrimonio di strutture ed esperienzedi aggregazione e di solidarietà comunitarie. Le discussioni sultema delle latterie di paese, oggetto in molte localitàvaltellinesi e sparse per le Alpi di vivace contrasto politico,trovano riflesso nell’attività del Gruppo tradizionale di Piatta,fornendo un’ulteriore prova che la dimensione della celebrazionedel patrimonio culturale e della vita rurale tradizionali siintreccia con la dimensione del presente, con il conflitto tradiverse visioni e modelli di sviluppo economico e sociale che si
53 Si tratta di occasioni etichettate come ‘Serata contadina’, ‘Mestieri inpiazza’ finalizzate ad animare le strade e le piazze del grosso centro turisticodi Bormio durante la stagione estiva. Anche se in questi eventi non è estraneauna componente educativa e di autorappresentazione, prevale, almeno dal punto divista dei promotori la finalità spettacolare e folcloristica. E’ un esempiodella polivalenza di significati simbolici che è spesso associata alle azioniritualizzate e che ne rappresenta al tempo stesso un elemento di attrazione e diambiguità.54 Intervista a D.F.55 Ibidem.56 Che oggi con il ritorno alle filiere corte e alle forme di associazione tra produttori e consumatori torna a rivestire un forte valore
condensano intorno alle questioni del cibo ‘di una volta’ e dellaproduzione alimentare locale:
«A Valfurva [comune limitrofo] abbiamo organizzato nella latteria una cena delgruppo con degustazioni dei prodotti ‘di una volta’. Il Sindaco si è inc...atoperchè in questo modo abbiamo riacceso il problema della latteria»57
Collocato sullo sfondo dell’attività del Gruppo tradizionale losvolgimento della Sagra del Pradèir risulta così comprensibile nelsuo carattere di evento corale che coinvolge le persone, gli spaziedificati del paese, il suo spazio esterno rappresentato daiprati. Uno svolgimento complesso che comprende diversi eventi dicontorno che non devono oscurare il tema centrale ma nesottolineano l’importanza oltre che servire a trattenere piùvisitatori per più tempo58. Nel caso della Sagra del Pradèir gliaspetti ‘di contorno’ comprendono il fondamentale aspetto dei ritialimentari collettivi un aspetto in realtà centrale in tutte lemanifestazioni del genere grazie all’atmosfera convivialeinformale che essi sono in grado di suscitare nei partecipanti.E’evidente, la preoccupazione di marcare la differenza tra laSagra del Pradèir o e le mille sagre che vengono organizzate sul temadei prodotti ‘tipici’. I diversi ‘appuntamenti’ gastronomicidella giornata rimandano tutti al tema centrale dellacelebrazione: il taglio e la raccolta del fieno. Si inizia alle6.30 con la colazione del Pradèir (con degustazione della rosumàda, abase di uova sbattute) per arrivare alle 12.00 (de meśdì inànz [damezzogiorno in poi] al Pranzo del Pradèir («a tavola nel periodo dellafienagione tra sapori riscoperti nella memoria e nellatradiziona»)59 e si continua alle 16.30 con La merenda nel mondo alpino60
57 Intervista a D.F.58 G.H. Lewis, op. cit.59 Il menù del ‘Pranzo del Pradèir’ è ben diverso da quello delle sagre ‘salamellee polenta’ con diverse portate e possibilità di scelta. Si inizia con i primi abase di pasta fatta in casa: la pàšta šcarelèda de la trùegia de da camàna [la pastalavorata dalla padrona di casa] e i gnòch šbatù de la reštàza [gli gnocchetti di panedella nonna], seguono le carni: al braśà del nòclu [lo stracotto di manzo del nonno]e al filòn del purcèl bir [la lombatina di maiale dell’ospite], i contorni (i maiasìch delšòber [i contorni del calzolaio]: i carcàgl e la bòglia [le patate lesse e la polenta],l’insalata di bàgul e öf [l’insalata di patrate e uova], l’èrba del löch [l’insalatadell’orto]), i formaggi (la frùa de la reštelögna [i prodotti dellacontadina]) : al solàndru [lo ‘scimudìn’], la magnöc(h)ia [la ‘scimùda’], i dolci: imanźulìn de la làmeda [i ‘manzulin’ della zia], al pichè de Sant’Ana [il ‘capriccio’ diSant’Anna].60 Con il pane di segale del forno a legna, il vino e il caffè del pignatin, la šlinziga [carne essiccata, salata e leggermete affumuicata], il [formaggio] magro di Piatta e lo scimudin.
per finire alle 20.00 con La cena della Reštelögna [donna addetta aradunare il fieno con il rastrello]61. La manifestazione che, conbuona ragione, viene definita ‘Giornata gastronomica e culturale’,non perde occasioni per sottolineare la distanza con le sagre apura base gastronomica e per rimarcare con puntiglio la coerenzaculturale dei suoi contenuti. Il menù del pranzo62 rappresenta unesercizio di filologia gastronomica con manifesti intentipedagogici volti a marcare le differenze linguistiche con lestesse comunità della valle e al recupero all’uso corrente dielementi lessicali a rischio di scomparsa per l’affermazione diuna koinè locale63. Sempre sul piano della trasmissione dei saperilinguistici va segnalata la tessera a punti che consente diaccedere all’intero percorso di degustazione del mezzogiorno64. Latessera è costituita da 18 punti del valore di 1 € ciascuno, omeglio di 1 cuzèir, l’unità ‘di conto’ che viene utilizzatanell’ambito della festa. Ogni punto (da staccare dalla tessera)corrisponde ad un oggetto tradizionale (nel caso dell’edizione del2007 gli oggetti corrispondono ai semplici giocattoli autoprodottidai ragazzi del ‘tempo che fu’). Per ciascun oggetto vieneriportata la denominazione nella parlata locale con la traduzionein italiano65. Anche questo è un modo per tenere vivo il patrimoniolinguistico e per trasmettere conoscenze etnografiche. Va anchenotato che alla redazione dei menù (come ad altri espetti dellaSagra) non è estranea una vena di sottile umorismo, elemento chela ricollega alle tradizioni festive popolari, ma che la distinguedalle manifestazioni plebee in cui scadono ‘feste’ prive diriferimenti tradizionali66.
Prima di passare al cuore della Sagra legato al rito dellosfalcio vogliamo ancora citare qualche evento di contorno. Dalle10 alle 12 nelle vie del villaggio si svolge ‘L’incontro con la
61 Con le ‘tonificanti’ minestre, i saporiti prodotti della becherìa [salumi] e lagustosa’pizza del Pradèir’62 Vedi nota precedente n. 58.63 Si veda l’utilizzo delle voci solàndru e magnöc(h)ia per indicare rispettivamentelo scimudìn (formaggio fresco di latte intero tipico del bormiese ormaiconosciuto anche fuori della Valtellina a seguito di una ‘globalizzazioneregionale’ che, con l’attribuzione della DOP vede la sia produzione concentrarsinella … bassa Valtellina) e la scimùda (termine altovaltellinese per indicare ilformaggio64 “Mi batto perché gli ingredienti e i piatti siano autentici, veri piatti delpradèir, con le salsicce guadagneremmo anche noi come gli alpini, così rimane poco” Intervista a D. T.65 Es. la šquitarola (la cerbottana)66 La festa tradizionale è semmai segnata da connotati carnascialeschi che siesprimono nelle forme della satira e della trasgressione.
famiglia del Pradèir’. Si tratta dell’accurata ricostruzione perle vie del paese e in alcuni ambienti con accesso dalla pubblicavia, di ‘arti dimenticate e antichi mestieri’: la lavorazionedella pietra per le coperture dei tetti, il lavoro del ciabattino(la šcòber è l’esponente di quella che in passato è stata, per lacomunità, un’importante forma di emigrazione stagionale), laproduzione del sapone, il bucato, la lavorazione al telaio, lalavorazione del latte67. In quest’ultimo caso si esplica, neiconfronti dei turisti più disponibili all’approfondimentoquell’azione di tipo educativo nei confronti del pubblico deiconsumatori che rappresenta una delle principali preoccupazionidegli organizzatori di eventi agricoli68 e che, come vedremo,risulta al centro di un altro caso di studio da noi indagato: la‘Transumanza’ dell’Aprica. Molti dei ‘figuranti’ (ma pareinappropriato definirli così) indossano – con la massimanaturalezza - abiti tradizionali; non un costume inventato estandardizzato si badi bene. «Ci teniamo ad essere un gruppotradizionale non un gruppo folkloristico»69 tiene a precisareDuilio Tagliaferri. La giornata si conclude con la serata danzatesotto le stelle.
L’evento centrale prende inizio alle 15.0070 con il formarsi diun corteo preceduto dai falciatori (ben attenti a mantenere altele falci onde evitare spiacevoli incidenti) seguiti da sbuffantitrattrici d’epoca. Dietro si incolonnano centinaia di abitanti,turisti, curiosi. Nella complessa struttura simbolica della festatradizionale, una struttura che la Sagra del Pradèir tendeconsapevolmente a ricalcare, la parata (come nel caso delcarnevale, ma anche in quello delle processioni religiose, i deicortei politici), rappresenta un momento topico in cui la massadei partecipanti tende, marciando verso un’unica meta, a perdereil carattere amorfo per raggiungere un’espressione di unità. Laparata termina di fronte alla chiesetta della Madonna della Salute67 «A chi vuole facciamo assaggiare tutto: il latte intero, il latte scremato,la panna, al gàll prima che il coagulo precipiti, la cagliata prima del taglio edopo il taglio, il siero, il latticello, il siero che rimane dopo fatta laricotta, il formaggio senza sale dopo un ora». D.F.68 L. Holloway, op. cit.69 Intervista a D.F.70 In realtà alle 15.30 per la difficoltà a mettere in marcia le sbuffantitrattrici d’epoca che costituiscono una concessione ad un elemento spettacolareche ha trovato negli ultimi anni grande diffusione presso varie manifestazioni,ma che non è privo di una sua giustificazione: a Piatta, come in molti altriinsediamenti rurali il primo automezzo ad essere introdotto e a rappresentarel’ingresso nell’era della meccanizzazione non è stato un’automobile, ma unatrattrice agricola.
presso la quale si trova il ‘campo di gara’ ovvero il prato dafalciare. Alla gara partecipano una dozzina di squadre di duefalciatori ciascuna in rappresentanza di comunità più o menovicine, più diversi iscritti ‘liberi’ che provengono da diverselocalità lombarde (una coppia di anziane falciatrici – alla garasono ammesse anche le donne – proviene dalla limitrofa provinciadi Bolzano). I concorrenti sono costituiti da un ‘nocciolo duro’71
che ha partecipato a tutte o a buona parte delle edizioniprecedenti e da alcune new entries. Ogni partecipante ‘sega’(falcia) procedendo parallelamente alle curve di livello delterreno (il prato è in forte pendenza per mettere in evidenzal’abilità del falciatore alpino ed anche perché, oggigiorno, soloi prati con acclività proibitiva per i mezzi meccanici sonosfalciati a mano). La striscia ‘segata’ è lunga una quindicina dimetri. La valutazione con la quale i giudici esprimono il lorogiudizio sulla coppia è espressa mediante un punteggio da 5 a 10con votazione palese effettuata alzando delle palette numerate. Ilgiudizio è di tipo sintetico e tiene conto (o almeno dovrebbe) diquattro parametri: la tecnica, valutata fondamentalmente sullabase dell’ampiezza del taglio e dalla scioltezza dell’azione, lapostura (capacità di mantenere l’equilibrio e di produrreun’azione efficace), la bravura nell’affilare la lama (e, almenoin teoria, nel martellarla). Ogni falciatore deve essereequipaggiato con cote e portacote oltre che con il martello el’incudine da infiggere nel terreno. Gli attrezzi dovrebberoessere in legno (tranne, ovviamente, la lama)72. Uno degli aspettiche viene penalizzato è la velocità del taglio73 mentre moltoapprezzata è l’ ‘eleganza’ e l’armonia dei gesti che, all’occhiodel profano potrebbero apparire un aspetto estetico e, invece,dimostrano l’abilità di un falciatore, la sua padronanzadell’attrezzo e la tecnica di mantenersi saldamente in equilibriosu un terreno in forte pendenza, la sua capacità di svolgereun’azione di sfalcio regolare per un lungo periodo. Al momentodella competizione segue quello dell’azione collettiva cherappresenta, a giudizio dell’autore, quello più spettacolare e, altempo denso di significati dell’intero evento: tutti ipartecipanti, disponendosi a debita distanza l’uno dall’altro,provvedono a ‘segare’ l’intero prato. La ‘Gara della segànda’ è71 L’espressione è di D,F.72 L’autore ha però osservato anche falci con asta metallica.73 Osservando i membri della giuria e anche commentando l’azione dei concorrenticon alcuni di loro l’autore ha constatato una grande severità dei giudici (quasitutti esperti falciatori ‘in pensione’) nei confronti di coloro che si esibivanoin un’azione ‘muscolare’.
definita nel programma ufficiale della Sagra «l’antica danza del‘Giardiniere delle Alpi’». Estetismo deteriore, potrebberoobiettare in molti, a cominciare da quei farmer che considerano unatotale perdita di identità la dipendenza del proprio redditodall’adesione a quelle misure agroambientali che presuppongono unatrasformazione in ‘giardinieri dell’ambiente’.74 Ma il‘giardiniere delle Alpi’ non operava al servizio di enti percepiticome distanti apparati burocratici (‘Bruxelles’, ‘la Regione’) eneppure al servizio dei turisti (o dell’industria alberghiera) chedesiderano un paesaggio curato come fondale delle loro vacanza.Operava per ricavare indispensabili mezzi di sostentamentomateriali, ma anche per imprimere, attraverso la cura el’organizzazione dell’orizzonte spaziale della comunità un ordinemorale e cosmico in accordo con profonde esigenze di ordine spiritualeche – nelle società tradizionali – assumono altrettanta importanza diquelle materiali.
«Da come la gente pratica lo sfalcio, risulta chiaramente che non è solo unmodo per ottenere fieno, ma anche un modo per imporre l’ordine. Un prato falciato viene descritto come net –‘pulito»75
La fienagione impedendo l’avanzata del bosco lascia lo spazio‘aperto’ alla luce; è l’espressione di un’alleanza tra l’uomo e ilsole contro la natura caotica76. La natura caotica con il suocarattere ctonio è rappresentata dal serpente che si insinuanell’erba alta minacciando le case. Questo aspetto è statorichiamato da Heady a proposito delle sue considerazioni suisignificati simbolici dello sfalcio, ma può essere colto in unaqualsiasi conversazione con la gente di montagna77.
74 R.J.F. Burton, Seeing Through the ‘Good Farmers’s Eyes: Toward Developing an Understanding ofthe Social Symbolic Value of ‘Productivistiv’ Behavoiur, Sociologia Ruralis, 44, 2004, 195-215.75 D. Heady, op. cit. p. 27?76 Ibidem?. L’autore cita a proposito la frequenza della presenza di simbologiesolari nelle decorazioni dei portacote, ma la grande diffusione di esse non cipare poter costituire un elemento specifico a questo proposito.77 La vecchia cascina dell’Alpe Li Piani a 2100 m in comune di Brusio (CantonGrigioni) è autogestita da un’associazione culturale; in occasione della festadell’alpe (luglio 2007) il proprietario Avv. Plinio Pianta nell’illustrandomi ilprincipio di ‘soggiorno attivo’ che vede coloro che trascorrono alcuni giorni divacanza presso l’alpe impegnati in piccoli lavori di manutenzione e cura delfabbricato e delle sue pertinenze, si esprimeva in questi termini sullafalciatura dello spazio intorno alla cascina: «Sono venuti su e hanno falciatotutto intorno per bene. Altrimenti ci troviamo le vipere in casa». Oltre che aconsiderazioni pratiche questa preoccupazione di ‘pulire’ risponde indubbiamentea esigenze di altro ordine.
E’ in ogni caso evidente che la preoccupazione per ilmantenimento dei prati va al di là di considerazioni pratiche edestetiche e che la disapprovazione per la non coltivazione deiessi (come la corrispondente approvazione per chi esegue losfalcio) si colorano in Carnia come a Piatta di un connotatomorale. La Sagra del Pratèir mira a rafforzare questeconsiderazioni e a portare l’attenzione su un presente in cui lacura della montagna appare sempre più problematica. Pur non ingrado di indicare delle soluzioni, la Sagra rappresenta unincitamento a ricercarne facendo leva sulle risorse dellacomunità, sulla mobilitazione sociale e culturale dal momento chele forze economiche e istituzionali appaiono incapaci di farlo.
Nonostante il tono brillante ed umoristico utilizzato dallo lospeaker ufficiale della manifestazione (un amministratore di uncomune della zona) nei commenti ricorrono spesso alcune ‘parolechiave’ : ‘Celebrazione’, ‘Cura della montagna’, ‘Accudimentodella montagna’; il senso strategico della manifestazione emergechiaramente in coincidenza con l’assegnazione del ‘Premio per ipiccoli falciatori’, un auspicio di continuità, una scommessa inun futuro che appare incerto.
Nonostante il largo impegno profuso le finalità degliorganizzatori della Sagrà del Pradèir si scontrano con la difficoltàdell’ambiente istituzionale locale a cogliere il significato dellamanifestazione. Di essa viene apprezzato il clima positivo el’attivismo suscitati, ma si manifesta poi una notevole dose discetticismo quanto alla sua capacità di suscitare dinamiche ingrado di contrastare l’ulteriore contrazione delle attivitàagrosilvopastorali78. L’incomprensione dei significati della Sagra78 «Le sagre servono per fare memoria ma di per sé una sagra non può cambiare lecose». Anche sulla capacità della sagra di mantenere in vita competenzetradizionali si avanzano riserve «Imparare? A saper martellare la falce sarannorimasti in 10 in tutta la valle». Enrico Giacomelli, Direttore del ConsorzioForestale Alta Valtellina, un ente che fornisce alcuni supporti tecniciall’organizzazione della Sagra. Rino Dei Cas è un testimonio privilegiato:‘assessore della frazione’ con delega alla cultura ai servizi sociali è ancheuno dei falciatori che hanno partecipato alla gara di sfalcio e che, come lagran parte dei pradeir xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Egli sottolineal’aspetto legato al ricordo, al valore di «tenere viva una tradizione (magariun domani con la crisi del turismo e dell’industria ci può essere un ritornoall’agricoltura)», riconosce che l’evento attraverso la partecipazione attiva dibuona parte della comunità coinvolge i giovani del paese ma, secondo la suaopinione, senza suscitare un reale interesse per la vita rurale del passato e,tanto meno, per un loro ritorno alle attività agricole, definitivamenteabbandonate da parte della gran parte della popolazione in favore del lavoro nelturismo, nei servizi, nell’industria. Come in tante altre località i pochi(due!) allevatori professionali eseguono lo sfalcio solo dove è possibile
deriva dell’influenza sulla mentalità corrente delle fratture chela modernità introduce tra economia e cultura (spesso ridotta a‘ninnolo’), tra produzione e consumo, tra lavoro e ‘svago’, dallasottovalutazione del ruolo della comunità (a favore del rapportotra ‘cittadini’ e istituzioni), dall’incapacità di andare oltre ilpresente e di collegare il passato al futuro riducendo latradizione al ‘folclore’. La Sagra, con la sua puntigliosaricerca di autenticità e di rifiuto del folclore, contribuisce asollevare importanti questioni: senza ‘veri’ falciatori, senza una‘vera’ produzione locale artigianale di formaggio essa perderebbedi significato. La Sagra del Pradèir celebra un passato che è ancora(in parte vivo) e a cui si assegnano valori e significati per ilfuturo della comunità (e non solo) inserendosi nel confrontoattuale tra i diversi discorsi sul rurale e sulla montagna econfermando pertanto che questo tipo di manifestazioni puòrappresentare uno spazio pubblico, assumere significato non soloculturale, ma anche politico. Oltre a sollevare in modo efficacei problemi del rapporto della tradizione con il presente la Sagraha in questi anni conseguito risultati importanti stimolando lamobilitazione della comunità e attirando in termini positivil’attenzione dell’ambiente esterno su una piccola comunità conun’identità a rischio.
2.3 La ‘Transumanza’ dell’Aprica
“Perché prima la si faceva, ma senza coinvolgere la gente, adesso è una forma diturismo, Aprica s’è cambiata ….prima venivamo giù da soli noi e cercavamo di nonfarci vedere perché eravamo sporchi, perché eravamo su da tutta un’estate …invece adesso il turismo è cambiato…” 79
operare in modo meccanizzato. Le stalle del paese sono rimaste vuote e sono solootto i proprietari di bestiame. Secondo Dei Cas le scelte della Regione, con lacessazione dell’erogazione del contributo allo sfalcio del fieno che, qualcheanno fa, era erogato anche ai piccoli proprietari di terreni senza la qualificadi imprenditori agricoli e senza bestiame e che oggi è concesso solo in funzionedel bestiame allevato e ai soli imprenditori agricoli, non hanno certo aiutato amantenere la coltivazione dei prati. Per la raccolta del fieno concludel’assessore ci vorrebbero delle cooperative. Oltre all’assessore Dei Caspartecipano alla manifestazione (anche come falciatori) altri amministratoripubblici; il fatto non pare casuale e riflette l’efficacia, in termini dirivalutazione dell’immagine del rurale, dei processi culturali innescati dallaSagra stessa.
79 Intervista dell’autore a un organizzatore dell’evento.
La ‘transumanza’ dell’Aprica rappresenta dichiaratamente un‘evento per i turisti’; a differenza della Sagra del Pradèir losvolgimento si esaurisce in poco più di due ore el’organizzazione, piuttosto semplice, non implica l’impegno e lamobilitazione della comunità. Gli attori sono alcuni giovaniallevatori, alcuni organizzatori della locale Pro Loco(significativamente ex-allevatori) e i turisti. Nonostante questepremesse l’evento si presta a più di una considerazione circa ilsignificato attuale della rievocazione della vita rurale, dellesua scansioni temporale, dei suoi riti. La discesa dall’alpeggiocostituiva molto spesso nella comunità tradizionale alpina unevento festivo, ritualizzato80. Il caso dell’Aprica mette inevidenza come la data fissa della discesa dagli alpeggi fosselegata all’organizzazione comunitativa delle risorse; essaimplicava l’apertura (di necessità ad una data stabilita) deiprati di proprietà privata siti al di sopra del villaggio chevenivano così resi disponibili per il pascolo del bestiame dellacomunità secondo la consuetudine del ‘libero pascolo’ checonsentiva il razionale utilizzo del ricaccio autunnale. Ladiscesa dagli alpeggi avveniva quindi in forma collettiva.
«il 2 settembre venivano giù da tutte le malghe, cominciavano le prime brine e allora giù … le mucche non avevano più latte o poco e qui sui prati bassi c’era erba …esi andava a bàragh [libero pascolo]».81
Il rientro in paese era certamente un’occasione di festa per ipastori «eravamo sporchi, perché eravamo su da tutta un’estate»82.Mentre «[…] prima venivamo giù da soli noi e cercavamo di nonfarci vedere […] invece adesso il turismo è cambiato[…]»83. Pastorie turisti si evitavano, oggi, invece, la discesa lungo la pista dasci della (non proprio numerosa) mandria proveniente da MalgaMagnolta è seguita dai turisti che la attendono in uno spiazzoall’arrivo della funivia. Se il contenuto spettacolare della‘transumanza’ risulta modesto (come conseguenza della quasiscomparsa del patrimonio zootecnico del noto centro turistico) varilevato che l’evento – che prende avvio – con l’arrivo deldrappello di vacche scese dalla malga, assume il connotato di una‘festa degli animali e del latte’ non priva di elementi dispontaneità e di interesse. Ad attendere le bovine che hanno
80M. Corti, op. cit., 2004. 81 Intervista dell’autore a un organizzatore dell’evento.82 Ibidem.83 Ibidem.
effettivamente trascorso l’estate in alpeggio oltre ai turisti eagli organizzatori vi è anche un gruppo di gruppetto di capre dirazza ‘gentile’, dalle mammelle voluminose; sono animali che inalpeggio non sono saliti di certo! La loro partecipazione allafesta costituisce, però, una rappresentazione dell’evelozione incorso realtà della zootecnia di molte località alpinecaratterizzata dalla differenziazione produttiva, dal sorgere dipiccoli allevamenti che puntano sulla trasformazione aziendale, lavendita diretta, l’agriturismo.
Subito dopo l’arrivo delle vacche d’alpeggio inizial’operazione della mungitura al cospetto del pubblico che siavvicina, osserva, fa domande. Un aspetto importante della‘festa’ è offerto dalla possibilità, da parte dei turisti, diosservare da vicino gli animali e di porre domande sulla lorovita, il loro comportamento. Sono indubbiamente anche lorosoggetto e oggetto della ‘festa’. Così essi vengono in qualchemodo re-incorporati entro quella ‘comunità allargata’ alla quale,nella società tradizionale essi appartenevano a pieno titolo, edalla quale sono stati espulsi e segregati (socialmente efisicamente) in seguito all’industrializzazione della zootecniache li ha reificati a ‘macchine da latte’ (o, peggio, da carne),riducendoli a numeri intercambiabili, ‘usa e getta’.
Appena i secchi si riempiono gli organizzatori invitanoall’assaggio del latte appena munto che viene offerto inbicchierini di plastica84. Questa azione costituisce una fasedeterminante dello svolgimento della festa: rappresenta unannullamento ritualizzato della distanza tra produzione e consumoche caratterizza il sistema alimentare industriale. A differenzadi molti eventi zootecnici dove questo annullamento è solosimbolico e funzionale ad un’operazione strumentale superficialedi re-imaging dell’agrofood system85 (che non ne mette in
84 Qualche anno orsono il peso dei condizionamenti igienistici e l’affermatasuperiorità culturale del modello della manipolazione alimentare industrialeavrebbero indotto molti a rifiutare mentre oggi la maggior parte dei presentiaccetta di buon grado l’assaggio.85 Nell’analisi di Holloway (L. Holloway, op. cit.) emerge come da parte degliorganizzatori delle mostre agricole e zootecniche inglesi ci sia lapreoccupazione di far conoscere ai consumatori la ‘verità’ sulla produzionealimentare. («we think we do have an educational role, and that it is necessary and desiderable thatpeople should understand that milk comes from somewhere before it comes out of the bottles» affermaun manager). Questa vocazione ad educare il pubblico ‘ignorante’ viene assuntaquale imperativo morale. La finalità strategica, però, è quella di persuadere ilpubblico circa l’importanza del ruolo dell’agricoltura nell’ambito delle filiereagroindustriali, operazione tanto più importante quanto più il settore agricolosi percepisce in crisi e – dal suo punto di vista – ingiustamente sottoposto a
discussione il carattere sempre più industrializzato), quil’incontro tra produzione e consumo assume una dimensione reale.Gli attori che animano la scena, mungendo, discutendo con ituristi, rispondendo alle loro domande sono giovani impegnatinella trasformazione aziendale, nella vendita diretta,nell’agriturismo . « […] con il latte a 30 centesimi ti paghi ilfieno e la paglia, io ho 10 vacche e faccio l’agriturismo» affermaun giovane allevatore-casaro impegnato nella lavorazione del lattesotto gli occhi dei turisti. Per questi giovani la partecipazioneall’evento è parte della loro attività, un’azione dai risvoltisocializzanti ed educativi, ma comunque finalizzata allapromozione aziendale. Non sono certo comparse.
Al termine dell’assaggio del latte appena munto, utilizzandoattrezzature tradizionali, collocate ben in vista al centro delprato, si da il via alla caseificazione. Si lavora il latte ancoracaldo (vaccino e caprino mescolati insieme) sino alla messa infascera della cagliata e poi si procede anche alla produzionedella maschèrpa (ricotta grassa) mettendo in evidenza come il sierovenga utilizzato per fornire un’ulteriore pregiato prodotto.Durante tutte le fasi della lavorazione i turisti hanno lapossibilità di chiedere spiegazioni e viene loro offerta lapossibilità di effettuare l’assaggio della cagliata.
Quello che, in apparenza, poteva apparire solo un evento‘inventato’, con legami molto deboli con la cultura tradizionale,ad un’analisi ravvicinata mette in evidenza alcuni aspetti checostituiscono la rielaborazione di una nuova ritualità, in cui ilvalore simbolico degli animali, della produzione del latte lungidal risultare mistificato è direttamente funzionale ad una visionee ad una prassi ‘multifunzionale’ dell’allevamento. In questavisione – pur non esente da contraddizioni - si colgono lecondizioni di una continuità tra passato e presente che si esprimenella solidarietà intergenerazionale tra ex-allevatori (gliorganizzatori dell’evento) e i giovani allevatori. L’evento,presupponendo la collaborazione tra più aziende agricole,rappresenta anche un terreno nuovo in cui si ricreano forme dicooperazione orizzontali e in cui il gruppo sociale degliallevatori mostra di essere in grado di relazionarsi sia alproprio interno che all’esterno con altri gruppi sociali al difuori delle paralizzanti mediazioni istituzionalizzate in cui essicritiche. Ovvio poi il tentativo dell’agricoltura industrializzata di sparare leultime cartucce rimaste di una retorica che per lungo tempo ha (con lacompiacenza dei politici) sfruttato l’immagine dell’azienda famigliare,dell’agricoltura di montagna per sollecitare sostegno corporativo per le grandiaziende industrializzate.
erano stati incapsulati. Non va dimenticata infine la valenzazooantropologica della re-incorporazione degli animali entro lasfera sociale. Queste considerazioni confermano il ruolo positivosul piano socio-culturale di tali eventi rievocativi86. Neiconfronti dei turisti, al di là dell’aspetto promozionale, icontenuti dell’evento indicano chiaramente che non vi è da partedegli organizzatori il solo intendimento dell’intrattenimento, mauna chiara finalità educativa che assume i connotati dell’impegnomorale a far conoscere ‘da dove viene il latte e come si fanno iformaggi’.
1.4 - La ‘Festa del Fieno’ a Livigno
I livignaschi hanno esorcizzato, apparentemente con successo,il rischio che la oro comunità risultasse disintegrata dall’impetuoso sviluppo turistico, commerciale, finanziario (legatoalla zona extra-doganale) con la concreta conseguenza delpassaggio del controllo dell’economia locale da parte di interessiesterni. A Livigno non ci sono grattacieli e i nomi delle vie sonomonolingui, non in italiano, ma in lombardo-alpino! Fattiesteriori, ma che corrispondono ad una ‘tenuta’ del tessuto localeattraverso i cicli dello sviluppo commerciale e turistico. Tuttociò è stato conseguito ‘investendo’ (simbolicamente e non) incoesione comunitaria, continuità, ancoraggi valoriali. Parecchisono gli eventi a carattere festivo di rievocazione della vitarurale. Essi hanno per oggetto il bestiame o particolari cibi‘etnici’, ma vengono celebrati normalmente al di fuori dei periodidi forte presenza turistica.
Ai primi di agosto, in un tempo quindi non dedicato allacelebrazioni formali della comunità, vi è un frenetico via vai dimodernissimi (e costosi) mezzi agricoli specializzati. Interefamiglie ex-agricole si dedicano a ‘segare’, a curare e atrasportare il fieno. A Livigno la fienagione è da tempo una‘festa’ implicita. Commercianti e albergatori continuano a‘curare’ le loro strisce di prato non certo per motivi economici,ma, palesemente, per motivi sociali e simbolici, ovvero perriconoscersi parte di una comunità che nell’orgoglio di un comunepassato (sempre più mitico) di duro lavoro agricolo, dalmantenimento del patrimonio linguistico e di tradizioni, trovaelementi di celebrazione della propria unità e continuità, unpunto di riferimento. Accanto a questa ‘Festa del fieno’ nonproclamata, ma intensamente partecipata e che non manca di86 M. Corti, op. cit., 2005. T
esprimere evidenti connotati ritualistici dal 2006 è stataproclamata una ‘Festa del fieno’ che arricchisce il ricco panoramadi intrattenimenti e di eventi ‘folcloristici’ risolti ai turisti.La dimensione rievocativa assume un aspetto ludico e coreografico.con i ragazzi del paese che – brandendo attrezzi ‘di una volta’ siesibiscono nel ‘costume locale’, mimando le azioni della raccoltasotto la regia dallo staff di animatori della Natur Card (‘pacchettoeventi’ offerto agli ospiti dall’associazione albergatori).L’evento prevede anche animazioni e momenti ludici per i ragazzi‘ospiti’. Il collegamento con la dimensione tradizionale è offertodalla presenza della coppia di falciatori ‘storici’ livignaschiche per diversi hanno vinto la competizione di ‘segànda’ allaSagra del Pradèir a Piatta (vedi sopra). Domenico Pedrana e il suocompagno, danno dimostrazione della loro grande abilità edeleganza (sia nell’abbigliamento tradizionale, questo sìautentico, che nelle movenze). Personaggi come questi sonopresenti spesso in eventi rievocativi divenendo icone viventi nelpresupposto che la loro presenza costituisca una garanzia diautenticità dell’evento. Ovviamente non può essere così e la‘Festa del fieno’, con il suo duplice aspetto di festa implicita(quella di chi ‘sega’ realmente, esibisce i nuovi mezzi meccanici,percorrendo, quasi in parata, con il carico di fieno le stradebrulicanti di auto e turisti) e di ‘festa’ turistica, resta,nell’insieme una festa a metà, una festa mancata. Senza mezzitermini un tecnico agricolo del paese, interpellato sulla ‘Festadel fieno’ (quella ufficiale, esplicita) l’ha sbrigativamenteliquidata «è una festa popolare che rallegra i turisti organizzatadagli albergatori»87. Gli esponenti del mondo agrozootecnicolivignasco indicano come importanti eventi la Festa degli allevatori, laFesta del patrono (questa, però, è fresca di riscoperta!) e altrieventi accomunati dalla centralità di rituali alimentari e rivoltia rinsaldare il legame di gruppo e comunitario, senza turisti.
Sentendosi al riparo dei problemi di crisi del modelloproduttivistico che abbiamo incontrato nei casi precedenti, ilmileu zootecnico livignasco, forte di un importante patrimonio dibestiame, di una nuovissima super latteria sociale dai costistratosferici e, soprattutto, del sostegno assistenzialistico diun comune ‘più-che-autonomo’, forte delle entrate sulla venditadei carburanti extra-doganali, non è indotto o a riconsiderare laseparatezza tra economia zoocasearia e cultura, tradizione efolclore. Ma i problemi non mancano (gli allevatori, nonostantetutto si lamentano – come loro habitus - per un prezzo del latte87 Intervista telefonica a Gianni Bormolini
basso, come altrove) e, forse, potrebbe essere utile anche aLivigno ripensare la ‘Festa del fieno’.
1.5 - La ‘Transumanza dei bergamini’ ad Abbiategrasso
Abbiategrasso, pianura lombarda. Il legame con le Alpi, peròc’è, ed è strettissimo. Per secoli i mandriani transumanti dellaValsassina (nell’attuale provincia di Lecco) sono scesi a svernarein pianura, acquistando il fieno presso delle cascine della zona eproducendo per tutto l’inverno gli ‘stracchini’88. Da qualche annoa questa parte sia da parte di coloro che sono tornati a risiederepresso i paesi di origine che di quelli (la maggioranza) ch, sonorimasti in pianura per esercitare l’attività agricola (o passandopoi ad altri settori) vi è un forte interesse a rispolverare lamemoria di questa ‘epopea’ che rischia di essere dimenticata, mache ha segnato profondamente lo sviluppo dell’economia zoocasearialombarda89. Il bestiame di montagna in occasione della‘Transumanza dei bergamini’ scende oggi al piano trasportato daautomezzi, ma, ovviamente in passato il percorso era coperto apiedi effettuando diverse tappe giornaliere. Le masserizie e - lacosa più importante – gli attrezzi per la caseificazione, eranotrasportati con dei carretti. Gli allevatori valsassinesi (tra cuialcuni che da bambini la transumanza a piedi l’hanno vissuta) sonosfilati con orgoglio con le loro vacche, i loro vecchi carrettirestaurati per l’occasione e che della ‘Transumanza dei bergamini’costituiscono uno dei principali elementi simbolici. Unarievocazione senza contenuti turistici, ma tutta giocata sullatrasmissione della memoria sociale dei transumanti e dellavalorizzazione delle ‘radici’ di una componente significativadella popolazione attuale di Abbiategrasso e dintorni.L’interesse degli abbiatensi di origine ‘bergamina’ si era giàmanifestato in occasione di affollate conferenze presso la salacomunale tanto che in questo contesto è maturata la decisione, daparte del Comune e dell’Associazione Provinciale Allevatori diComo e Lecco di organizzare la rievocazione.
Anche in occasione dell’evento di Abbiategrasso si è rinnovatoil ‘rito’ della mungitura e della lavorazione in piazza del latte.Pur senza escludere quelle finalità generali di carattere88 M. Corti , op. cit., 2004.89 L’importanza della transumanza bovina dei ‘bergamini’ emerge dalla sempliceconstatazione che è proprio dall’ambiente della Valsassina e nel legame tra lamontagna e la pianura che nasce la moderna industria casearia italiana. Da quiprovengono i fondatori di primarie aziende lattiero come Galbani, Invernizzi,Locatelli (oggi tutte controllate dalla francese Lactalis).
promozionale ed educativo che abbiamo già avuto modo di osservarenel corso dell’esame degli altri casi di studio, non si puòdubitare della coerenza storico-culturale di questo aspetto dellamanifestazione. La lavorazione del latte durante le soste dellatransumanza richiama al lascito duraturo che la transumanza ha indiverse aree della pianura, ma in modo particolare in quest’areadella valle del Ticino. Ma, circostanza di cui gli organizzatorisono forse meno consapevoli, la ‘festa della transumanza deibergamini’ è anche una ‘festa della mucca’ che nel contesto dellarievocazione si ‘emancipa’ dal ruolo di oggetto, di ‘macchina dalatte’ per conquistare quello della protagonista.
Conclusioni
Sullo sfondo di una generale alienazione urbana che, perquanto ci riguarda nello specifico, assume i contorni della de-identificazione del cibo e delle deprivazione del contatto con glianimali ‘utili’, si sono sviluppate negli ultimi anni una serie dimanifestazioni celebrative della vita rurale centrate suifondamentali cicli della vita contadina alpina: la fienagione,l’alpeggio, la lavorazione del latte. Le tipologie, le finalità,gli attori di questi eventi appaiono del tutto dissimili, ma ciònon impedisce di trarre qualche considerazione generale.
I membri delle comunità locali, coloro che sono tutt’oraimpegnati nelle attività zootecniche (o che lo sono stati inpassato) appaiono orgogliosi di rappresentare la vita rurale.L’interesse del pubblico e l’apprezzamento dimostrato per lerievocazioni realistiche della vita rurale tradizionale con lapresenza degli animali, la loro mungitura sul posto, lalavorazione del latte in presenza dei turisti, contribuiscono arafforzare la consapevolezza da parte delle comunità locali e deigruppi sociali più legati all’attività agrozootecnicadell’importanza delle tradizioni a attraggono l’attenzione suirischi di una scomparsa od ulteriore rarefazione delle attivitàagrozoocasearie nella montagna alpina.
In linea con i significati profondi della socievolezza festivaqueste manifestazioni assumono carattere di innovazione e distimolo al cambiamento in direzione di sistemi economiciterritoriali in cui il ruolo delle attività agricole possa essereri-valutato e ri-definito. Considerata la crisi del modelloproduttivistico, corporativo, settoriale ‘agricolturalista’ alfine di garantire un futuro all’agricoltura alpina e all’opera di
accudimento del territorio pare indispensabile operare sul pianoculturale per favorire l’emancipazione delle restanti attivitàagricole da un’integrazione verticale integrata nelle filiereindustriali e tecno-burocratiche (mediante la de-specializzazione,la de-industrializzazione) e una loro re-integrazione nelle retidi solidarietà orizzontale della comunità. In tal modol’agricoltura, può, a sua volta, contribuire attivamente allosviluppo di un’economia identitaria. Su un piano più generalequesti processi richiamano l’esigenza di ricomposizione dellefratture ‘moderniste’ tra cultura ed economia, tra produzione econsumo e mettono quanto mai in evidenza come la tradizione siauna realtà vivente, definita nel presente e orientata al futuro.