l’Istria: dai castellieri al sistema delle ville romane, dalle ville ai villaggi altomedievali ed...
Transcript of l’Istria: dai castellieri al sistema delle ville romane, dalle ville ai villaggi altomedievali ed...
AntiCHitÀ AltOAdRiAtiCHe
lXXVi
le mOdifiCAziOni del pAeSAggiOnell’AltOAdRiAtiCOtRA pRe-pROtOStORiA
ed AltOmediOeVOa cura di
giuseppe Cuscito
editReg tRieSte 2013
CentROdi AntiCHitÀ
AltOAdRiAtiCHeCASA BeRtOli
AqVileiA
«Antichità Altoadriatiche»© Centro di Antichità AltoadriaticheVia patriarca poppone 6 - 33053 Aquileia (ud)www.aaadaquileia.it; e-mail:[email protected] responsabile: giuseppe CuscitoAutorizzazione del tribunale di udine n. 318 del 27 ottobre 1973
© editreg di fabio prencSede operativa: via g. matteotti 8 - 34138 triestetel./fax ++39 40 362879, e-mail: [email protected]
iSSn 1972-9758
le immagini di proprietà dello Stato italiano sono state pubblicate su concessione del miBACt - dipartimento per i Beni Culturali e paesaggistici - direzione Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici del friuli Venezia giulia - Soprintendenza per i Beni archeo- logici del friuli Venezia giulia ed è vietata l’ulteriore riproduzione e duplicazione con ogni mezzo senza l’autorizzazione della Soprintendenza.
iniziativa promossa in collaborazione con:
Dipartimento di Scienze Umanisticheuniversità degli Studi di trieste
Scuola Interateneo di Specializzazione in Beni Archeologici università di trieste, udine e Venezia
e con il sostegno di:
Soprintendenza per i Beni archeologici del fVg
5
PremeSSA
L’ambiente in ogni suo aspetto, geologico, ecologico, geografico, antropologico, e le sue modifiche attraverso il tempo sono un importan-te elemento per l’analisi dello sviluppo storico, determinato non solo dall’economia, dalle ideologie, dalle religioni e dalle guerre.
Ecco perché si è deciso di considerare questo tema e di dedicargli un numero della nostra rivista.
Come spesso accade alcuni relatori, per le più disparate ragioni, non hanno potuto inviare il proprio contributo per la stampa.
Tra questi, dispiace l’assenza delle relazioni di Mauro Rottoli e di Gabriella Petrucci, con cui già in passato si era collaborato e le cui rela-zioni in sede di convegno avevavno destato notevole interesse.
Per quanto riguarda la relazione di Alessandro Fontana, questa è stata compresa nell’articolo a più mani con Serena Vitri e Giovanni Tasca, cui si rimanda.
Vivo dispiacere desta la mancata pubblicazione dei due interventi a più mani sugli aspetti paesaggistici e vegetazionali di Aquileia e di Trieste, in parte colmati dall’analogo articolo su Venezia e la Laguna veneta, che in certo modo può sopperire anche all’assenza dello studio sull’antico assetto territoriale della stessa laguna.
In sede di convegno si erano dimostrate estremamente interessanti, ci preme ricordarlo, anche le considerazioni proposte sulle tecniche di costruzioni navali in Alto Adriatico e quello delle trasformazioni paesag-gistiche della Baia di Medolino e del promontorium pollaticum nei pressi di Pola in Istria.
prof. giuseppe CuscitoPresidente del
Centro di Antichità Altoadriatiche
7
introduzione ai lavori ................................................................................................diario ........................................................................................................................elenco degli iscritti ...................................................................................................
Studi
Giovannella CreSCi Marrone, Le modifiche del paesaggio nel processo di roma-nizzazione ..................................................................................................................
Serena vitri, Giovanni taSCa, aleSSandro Fontana, Il Basso Friuli tra età del bronzo ed età del ferro ..............................................................................................
Guido roSada, Fonti e confronti. Regionis forma e loca voluptatis, quasi amunia
Patrizia BaSSo, Marianna BreSSan, FranCeSCa Ghedini, Paola zanovello, Le Aquae patavinae. Popolamento e paesaggio nella prima età imperiale ..................
FranCa MaSelli SCotti, Aquileia prima della fondazione: il paesaggio ...............
rita aurieMMa, aleSSandro CanCi, aleSSandro Fontana, dario Gaddi, Paola MaGGi, SuSanna Mauro, Alle porte del mare. La laguna di Marano in età romana ......................................................................................................................
Corinne rouSSe, Opérations de canalisation dans les ports fluvio-maritimes de la Regio X Venetia Histria : réflexions sur l’urbanisme et les transformations du terri-toire à l’époque romaine ..........................................................................................
JaCoPo Bonetto, Caterina Previato, Trasformazioni del paesaggio e trasforma-zioni della città: le cave di pietra per Aquileia ........................................................
Sauro GeliChi, Paesaggio e insediamenti nell’arco adriatico nell’alto medioevo: osservazioni su alcuni paradigmi .............................................................................
Klara Buršić-Matijašić, roBert Matijašić, L’Istria: dai castellieri al sistema delle ville romane, dalle ville ai villaggi altomedievali ed oltre ...............................
GiuSePPe CuSCito, Spazio cristiano e modifiche dell’ambiente nell’arco altoa-driatico .................................................................................................................
p. 9» 12» 14
» 17
» 31
» 51
» 65
» 85
» 93
» 123
» 141
» 163
» 181
» 199
INDICe
8
Gian Pietro BroGiolo, MarCo neBBia, FranCeSCa Benetti, Ricerche sul pae-saggio dell’isola di Arbe ...........................................................................................
PoSter
JaCoPo Bonetto, Caterina Previato, Tecniche costruttive e contesto ambientale. Le sottofondazioni a sedimenti nella Cisalpina e nel Mediterraneo ........................
Silvia Marvelli, MarCo MarCheSini, Il paesaggio vegetale naturale ed antropico nella laguna veneziana ricostruito attraverso i reperti archeobotanici ...................
p. 217
» 231
» 265
181
Est enim proxima nobis regio supra sinum maris Ionii constituta, olivis refera, segetibus ornata, vite copiosa 1.
Ci piace iniziare con questa frase di Cassiodoro, nella quale il Senatore, prefetto del pre-torio della corte ostrogota a Ravenna si riferisce all’istria con parole probabilmente esaltate dal bisogno di corteggiare gli Istriani per ragioni fiscali 2. ma l’istria, “piena di ulivi, decorata da coltivazioni, abbondante di viti”, era veramente un giardino, una zona agricola produttrice di grandi quantità di vino, olio e grano? Certamente non in misura uguale durante un arco di tempo molto vasto, dalla fine della preistoria all’inizio del Alto Medioevo. Le modifiche del paesaggio sono conseguenza diretta dell’azione umana, del suo intervento nell’ambiente na-turale. Il paesaggio è l’insieme di una realtà naturale e culturale, l’interfaccia tra spazio fisico e spazio mentale, conseguenza del rapporto tra uomo e natura 3. l’antropizzazione del pae-saggio istriano, cioè quel processo con il quale il “territorio” (naturale) diventa “paesaggio” (umano) inizia in modo massiccio con l’estendersi dei gruppi umani nella preistoria.
Prima d’intraprendere qualunque discorso sul tema è lecito iniziare con la geografia dell’istria, la sua posizione e le caratteristiche geomorfologiche: la penisola istriana, dalla superficie di circa 3000 km2, si trova nella parte superiore del mare Adriatico, ha una forma quasi triangolare, dai lati ammorbiditi dal millenario lavoro del mare, con scogli, insenatu-re, valli e promontori. il suolo istriano, che si è in gran parte plasmato nel medio evo della formazione della terra, cioè durante l’era geologica del mesozoico, si presenta in gran parte di terra rossa (fascia costiera, istria Rossa), poi c’è l’istria grigia (o Verde, o gialla, l’interno della penisola), ed infine l’Istria Bianca 4.
il clima mediterraneo con gli inverni miti e piacevoli estati ha favorito un popolamen-to costante della penisola fin dal Neolitico. La prima apparizione del uomo in Istria, durante il paleolitico, già intorno ad 800.000 anni fa, dobbiamo lasciarla da parte per le condizioni completamente diverse che regnavano in questa parte d’europa. da notare soltanto che la costa era molto più a sud, nel medio Adriatico, all’altezza di una linea immaginaria che collega le odierne città di zara, sulla costa orientale, e Ancona, su quella occidentale dell’Adriatico. Anche se in Istria non ci sono grandi fiumi e fonti d’acqua, l’uomo ha da sempre saputo raccogliere questo prezioso elemento in stagni, pozzi o cisterne.
gli insediamenti si fanno più numerosi durante il neolitico, seguito dall’eneolitico e poi dall’età del Bronzo, quando gruppi umani si insediano sui castellieri. questi abitati d’altura sono un primo forte e ben visibile fenomeno archeologico che riguarda il paesaggio di tutta la penisola. i castellieri come forma insediativa perdureranno per due millenni ed oltre, anche dopo la conquista romana.
Klara Buršić-Matijašić, Robert Matijašić
l’iStRiA: dAi CAStellieRi Al SiStemA delle Ville ROmAne, dAlle Ville Ai VillAggi AltOmedieVAli ed OltRe
1 CaSS. Var. 12, 22.2 ruGGini 1961, pp. 341-349.3 viSentin 2010, p. 153.4 PeriCin 2001, p. 19.
182
La comparsa dei castellieri non ha significato, però, l’abbandono immediato di altri tipi di siti, come le caverne e gli insediamenti all’aperto. il censimento di quest’ultimi, che è sta-to fatto su una ristretta area, intorno al Canale di leme 5, ci indica l’importanza del “proble-ma”. per la loro funzionalità, come anche per le caratteristiche morfologiche di alcune zone dell’istria, i castellieri divennero molto presto il principale tipo d’insediamento nel periodo dell’età del Bronzo e quella del ferro. Ci limiteremo a parlare soltanto della loro presenza nel paesaggio tralasciando il discorso sulla cronologia o sulle particolarità di alcuni di loro, o meglio dire, quei pochi di cui abbiamo modesti dati per parlarne di vari aspetti della loro vita: economia, tipi di abitazioni, ceramica, metallo, sepoltura, ecc, ecc.
Verso la fine dell’epoca eneolitica (3500-2200 a.C.) con l’arrivo in Europa di nuove genti, gli indoeuropei, in istria, come altrove compaiono molte innovazioni sociali e cultu-rali. In varie parti d’Europa venivano costruiti villaggi fortificati, abitati da gruppi nei quali prevaleva un’ economia pastorizia rispetto a quella della coltivazione della terra. nello stesso periodo fanno la loro prima apparizione gli oggetti in metallo, il che inizia lo sviluppo della produzione di armi. nella struttura sociale appare un ordinamento particolare della famiglia che si manifesta nel modo di sepoltura ma anche nella fisionomia interna dei villaggi 6.
Anche se il fenomeno dei castellieri nel paesaggio si riconosce oggi per lo più da possenti mura, in un primo momento, le colline non avevano una protezione fissa di muri di difesa 7. Verso la fine dell’eneolitico e l’inizio dell’età del Bronzo, su colline, è importante la comparsa di una manifestazione specifica della ceramica decorata a striature (o pannoc-chiuta) 8. pezzi di questo tipo di ceramica sono molto frequenti sia nelle caverne (Cingare-la, Trogrla, Novačka, Podosojna, Pupićina) che su alture che poi diventeranno castellieri (Golaš, Picugi, Moričovica…) 9.
Castellier - Castelir - Castion - Gradina - Gradiška - Gračišće - Gradec - Kaštelir - Kaštelijer, siti archeologici, resti di abitati arroccatisi su colli, sono un fenomeno più o meno visibile nel paesaggio. in istria, il loro numero varia da 321 (Kandler – già alla metà dell’Ot-tocento), 350 (Marchesetti) fino a 450 10, o 520, del Benussi 11. Secondo l’ultimo censimento negli ultimi 10 anni (fig. 1), nel quale sono stati presi in considerazione quelli veri e propri, la cui vita è testimoniata dalla cultura materiale, come pure quelli ipotetici dei quali non ab-biamo testimonianze direte ma soltanto indicazioni indirette come la loro posizione, oppure il nome topografico della collina, con un’ispezione dettagliata abbiamo catalogato 423 siti, da cui emergono 231 località con prove materiali e 192 posizioni ipotetiche 12. per lo stato di conservazione e della loro riconoscibilità nell’ambiente, abbiamo cercato di proporre una
5 Buršić-Matijašić 2011.6 C’è da dire che, durante la prima età del bronzo, culturalmente, la penisola istriana ebbe uno svi-
luppo diverso della restante parte della costa orientale dell’Adriatico. nella dalmazia domina la Cultura di Cetina (Petrić 1978-79, p. 233) la quale appare sulla penisola in pochissimi esempi (Barbariga: CodaCCi-terlević 2005, pp. 41-74).
7 Baćić 1970, pp. 215-227.8 Secondo gli studiosi questo tipo di ceramica rappresenterebbe l’elemento più occidentale delle
culture del Bronzo antico della pannonia (Mihovilić 1994, p. 106). Il Petrić l’ha definita come cultura di Brioni (per la maggior quantità di esemplari ivi trovatisi), relativamente al bronzo antico dell’istria e del nord Adriatico (Petrić 1978-79).
9 Buršić-Matijašić 1994.10 MarCheSetti 1903, p. 18.11 BenuSSi 1924, p. 35.12 Buršić-Matijašić 2007, pp. 563-564.
KLArA BuršIć-MATIjAšIć, roBErT MATIjAšIć
183
fig. 1. Cartina di distribuzio-ne dei castellieri istriani (da Buršić-Matijašić 2007).
L’ISTRIA: dAI CASTELLIERI ALLE VILLE ROMAnE AI VILLAGGI ALTOMEdIEVALI Ed OLTRE
loro tipologia. Prendendo quale punto di partenza la definizione della tipologia in quanto sistema di classificazione dei reperti archeologici, loro struttura e l’insieme, e di conseguen-za dei fenomeni ed eventi naturali e culturali, abbiamo cercato di valutare e classificare i castellieri in base alle loro caratteristiche morfologiche e funzionali. in grande misura, alla pari di tante altre tipologie, anche la nostra è basata sulla scelta soggettiva e sulla determi-nazione gerarchica dei tipi e delle loro varianti e si adatta alle circostanze naturali dove a causa delle caratteristiche geomorfologiche del territorio 13 gli elementi del castelliere sono talvolta difficili da riconoscere (zone impervie, boschi fitti e quasi impraticabili).
Oggi, le differenze tra le colline una volta abitate e quelle disabitate sono riconoscibili dalla loro superficie piana ed allungata, forma dovuta al modo specifico di costruzione aspor-tando il primo strato di pietra, permettendo in tal modo da spianare il terreno. nello stesso tem-po con il materiale estratto per la livellazione delle terrazze si costruivano le mura di cinta. le
13 Srejović 1997.
184
mura costruite a secco sono spiccati interventi antropici, uno degli esempi con i quali l’uomo è riuscito a inserirsi nella natura senza violarne l’integrità. gli abitati erano circondati da una a tre cerchie concentriche: il loro numero cresceva con l’aumentare del numero degli abitanti o per fornire una difesa più efficace. Col protrarsi dei secoli, oggi, la maggior parte di resti di muraglioni a secco si trovano in vari stadi di conservazione ed hanno assunto perlopiù la forma di un terrapieno. negli insediamenti si entrava attraverso porte che erano di grande importanza per la difesa, in quanto rappresentavano dei punti deboli nella difesa. Ance loro, come le mura, a seconda delle esigenze, erano soggette a varie modifiche 14.
i castellieri si differenziano tra loro per le dimensioni e per la forma 15. la loro funzio-ne principale era abitativa e difensiva, mentre un gruppo di castellieri formava nello stesso tempo un sistema di difesa di tutto il territorio circostante 16. un esempio sono i castellieri lungo la catena montuosa della Vena (Ciciaria), i quali svolgevano il ruolo di difesa dei pas-saggi – spesso mulattiere – attraverso la montagna, ma contemporaneamente difendevano un vasto territorio dell’istria pedemontana 17.
C’è ancora da capire quali erano i motivi che hanno portato le genti a stabilirsi in alcu-ne zone della penisola. la concentrazione più evidente di castellieri è registrata nei dintorni di Rovigno e Villa di Rovigno su alture da 100 a 200 m s.l.m. 18. dalla loro distribuzione è evidente che preferivano le vicinanze delle grandi vie di comunicazione (lungo i fiumi, il quieto e l’Arsia) e nei pressi di valli e campi fertili (Corridico, S. tomaso presso S. pietro in Selve, m. Castelvecchio presso Orici), ma assai di rado in riva al mare. gli insediamenti maggiori come nesazio, Albona, Cunzi/m. Castellier presso dusmani, Valaron, monte ma-donna presso Sissano, gradina sopra il Canal di leme, sono sorti in zone ben protette e a qualche chilometro dal mare. una maggiore concentrazione di castellieri la troviamo sulle colline che circondano la profonda baia della odierna città di pola 19. la baia di pola offriva molteplici benefici a comunità che qui hanno trovato dimora. La profonda e ben protetta baia, abbondante fonte d’acqua, campi fertili, fitti boschi, sono solo alcuni dei elementi che l’uomo sempre sin dall’inizio ha saputo sfruttare.
Purtroppo, in mancanza di analisi più approfondite, di scavi e ricerche, oggi ci è diffi-cile fare una distinzione cronologica e con ciò non possiamo parlare della precisa distribu-zione dei castellieri durante il lungo periodo di due millenni della loro vita. Soltanto in base al materiale archeologico ci si può fare un’idea sulla cronologia, si può dedurre se la vita si era protratta unicamente durante l’età del Bronzo, o il castelliere era sopravissuto pure nel periodo dell’età del ferro.
La loro forma è stata condizionata della configurazione fisica del sito, che stabiliva la grandezza dell’abitato e il tipo di fortificazione, come pure il numero, le dimensioni e la
14 Analizzando le entrate di cinque castellieri, prettamente dell’Istria meridionale, Baćić ha consta-tato che sono stati tutti edificati in tre fasi successive. La prima fase consiste nel recintare lo spazio vitale, la seconda nel restringere i passaggi delle porte e rinforzare la difesa. nella terza le entrate perdono la loro funzione e tramezzando lo spazio tra le mura questo diventa necropoli (monte Orcino, gradina sopra il Ca-nal di leme, nesazio) (Baćić 1970, pp. 215-226). le ultime ricerche al castelliere di moncodogno hanno mostrato un vasto sistema di difesa delle due porte, costruito successivamente al fabbisogno dell’abitato (hänSel, Mihovilić, teržan 1997, pp. 50-65).
15 MarCheSetti 1903; Baćić 1978, p. 32; Buršić-Matijašić 2007, pp. 485-504.16 GovedariCa 1982, p. 114.17 Buršić-Matijašić 2001.18 Buršić-Matijašić 1998a, pp. 192-193.19 Buršić-Matijašić 2006, pp. 16-17.
KLArA BuršIć-MATIjAšIć, roBErT MATIjAšIć
185
struttura delle mura 20. la maggior parte sono insediamenti circolari (Vintian, monvè, m. S. pietro/tondolon, m. Bumberi), ovali (mandriol, torre di Boraso, monpaderno), ellittici (turulù, nesazio, momorano), sebbene troviamo anche alcuni a ferro di cavallo (monte Castellier presso Altura, S. Elisabetta presso Ieseni), a forma allungata (Kitica, šiljar/Ca-stellier sopra molini Blaz, gradina presso porgnana) e rettangolare (Castellier – Stanzia gati). i risultati sulla valutazione della loro dimensione sono modesti. i castellieri in base alla loro grandezza 21 possono essere: grandi, oltre 100 m di diametro (m. Castellier/Vintian, Brioni, moncodogno, moncastello presso Valle, Valaron, monte Orcino, golzana Vecchia, m. Corona presso Corridico, finida); medi, da 50 a 100 m di diametro (m. mortesin, por-gnana, Briani, Morozula) e quelli piccoli, fino a 50 m di diametro (rompelak, M. Bumberi, Pricejak) 22.
la forma dei castellieri ha condizionato la costruzione delle mura, ma altrettanto l’organizzazione dello spazio interno. la suddivisione in varie sezioni, come acropoli, città alta, città bassa, sobborghi, terrazze, evidenzia l’esistenza di una struttura sociale. nella forma urbanistica di alcuni castellieri si riconosce l’organizzazione concentrica o a spirale che partendo dal limite interno delle mura finiva al centro dell’insediamento 23. tale caratteristica è conosciuta in alcuni abitati odierni le cui radici affondano nell’epoca preistorica (pola).
A seconda della loro funzione i castellieri potevano essere stabili dimore (pinguente), oppure sedi temporanee (m. Cuc). gli insediamenti temporanei erano eretti in caso di neces-sità e potevano essere in funzione di guardia, rifugio, o erano di carattere stagionale durante il periodo della transumanza. Alcuni, probabilmente a causa di vari mutamenti, potevano cambiare la propria funzione. i castellieri potevano anche cambiare carattere attraverso i secoli, aumentando lo spazio utile e costruendo ulteriori sistemi di difesa.
un altro elemento paesaggistico sono sicuramente le parti interne dell’abitato. lo spa-zio d’uso abitativo dell’insediamento preistorico dipendeva dalla grandezza dello stesso e dalle necessità degli abitanti, mentre l’architettura era condizionata dal carattere del terreno e dal materiale edilizio a disposizione. resti di edifici, perlopiù rettangolari 24, troviamo a moncodogno, Cas, tondolon, pola, mentre nelle località di masin, Carasta, m. glavizza presso Radmani 25 sono evidenziati solamente alcuni elementi edilizi. nel territorio istriano
20 ŠkilJan 1980, pp. 11-12. i castellieri che si trovavano su terreni rialzati di zone prevalentemente pianeggianti dovevano avere una protezione fisica maggiore, con mura di dimensioni particolarmente co-spicue (monte Orcino, Castelliere presso umago).
21 Il tentativo di determinare il numero degli abitati ci permette di fare alcune speculazioni. Perciò se nelle case vivevano membri consanguinei, in un edificio da 30 a 50 m² potevano vivere da 6 a 10 persone. dato che le case si addossavano una all’altra, in castellieri come quelli di moncodogno, nesazio e Valaron potevano abitare anche fino a 1000 persone. Il numero di abitanti di una comunità dipendeva d’altra parte dalla grandezza delle greggi e dal pascolo utilizzabile.
22 Le dimensioni medie di un insediamento sono di circa 1 ettaro (10.000 m²) e da ciò risulta che il castelliere ha il diametro di 112,86 m.
23 Mohorovičić 1954.24 la tradizione e la continuità della costruzione con pietra è presente anche nell’edilizia popolare
dell’eredità etnografica dell’Istria. Anche questa, come le costruzioni preistoriche, è condizionata dalla posizione geografica e dalle condizioni geologico-pedologiche. I resti odierni delle casette di campagna e delle casite, costruite in modo primitivo, ma con una sapiente tecnica di costruzione a secco, senza cioè l’impiego di materiale connettivo, confermano la continuità della costruzione tradizionale presente negli insediamenti abitazionali preistorici (StePinaC-FaBijanić 1988, pp. 125-129; laGo 1994).
25 Buršić-Matijašić 2012a, pp. 16-18.
L’ISTRIA: dAI CASTELLIERI ALLE VILLE ROMAnE AI VILLAGGI ALTOMEdIEVALI Ed OLTRE
186
le fondamenta delle case erano di pietra con la quale erano costruite anche le parti inferiori delle case. i muri ed i tetti erano costruiti combinando pietra, legno o intonaco 26. gruppi di edifici abitativi, costituiti di più parti (vani), erano disposti in fila, lungo le mura interne. I pavimenti erano fatti di terra battuta, e per isolarli dall’umidità forse ricoperti di materiale ligneo. Nelle case si entrava da aperture nelle quali era infissa la porta 27. le porte davano su strade di comunicazione (moncodogno).
parlando del paesaggio dei castellieri, dobbiamo immaginare rapporti molto intensi in un’area ristretta, come pure in un’area più ampia. gli abitanti dei singoli castellieri do-vevano intrattenere relazioni socio-economiche molto intense tra gli abitati limitrofi: svol-gendo le loro attività quotidiane i loro contatti dovevano essere intensi e frequenti. gruppi di castellieri su un territorio ristretto erano collegati da un’integrazione economica, sociale e probabilmente spirituale, e doveva certamente esistere anche una qualche gerarchia tra i singoli castellieri entro una zona gravitante. empiricamente è stato constatato che i castel-lieri superanti una certa dimensione erano di norma il centro di un determinato territorio 28. Alcuni castellieri spiccano per le loro dimensioni e nelle loro vicinanze non ci sono altri importanti insediamenti. Ciò fa supporre che siano stati la sede di un’autorità centrale per il territorio circostante (moncodogno, monte Orcino, m. meia, Valaron). la divisione e la gestione del territorio si può ipoteticamente ricostruire in modo empirico, com’è stato fatto per la zona del castelliere di Moncodogno (fig. 2). L’analisi spaziale mediante i cosiddetti “poligoni di Thiessen” ci hanno fatto notare delle particolarità, però questo tipo di schema non prende in cosiderazioni la morfologia del territorio, le cui caratteristiche dovevano avere un peso importante nell’organizzazione territoriale. un altro esempio di divisione territoriale presentano i castellieri a nord del Canal di leme, nel parentino. qui notiamo gruppi di tre abitati (pizzughi) e poi un gruppo di cinque con il castelliere di montisana al centro (fig. 3).
mentre al passaggio dall’età del Bronzo a quella del ferro nascevano nuovi abitati, la vita su molti castellieri cessò. Durante i secoli successivi le trasformazioni hanno portato al-cuni di loro a livello di centri protourbani, e questi si sono infine evoluti in centri urbani veri e propri. lungo la costa istriana talli esempi sono soltanto parenzo e pola (ma anche Ossero sull’isola di Cherso) 29. qui dobbiamo notare anche fianona, che è altrettanto un esempio di passaggio da abitato preistorico a città romana 30, anche se in epoca romana l’abitato si è probabilmente trasferito in riva al mare, per ritornare sulla collina nella tarda Antichità. Simili sono i casi di Alvona (Albona), Piquentum (pinguente/Buzet) e Rotium (Rozzo), che sussistono come comunità indigene in epoca romana, ma, se anche c’era vita sul castelliere, in età classica si svilupparono i corrispondenti centri ai piedi del castelliere, in posizione più comoda rispetto alle comunicazioni.
nel caso dei borghi medievali sorti su colline in precedenza occupate da castellieri (con o senza soluzione di continuità in epoca romana), la forma dell’abitato preistorico si può spesso ricostruire dalla conformazione naturale del terreno e dalla planimetria medieva-le. in molti casi sono ancora oggi visibili poderose mura che circondano le città, mura che seguono il tracciato (o un tracciato) del vallo preistorico. È questo il caso di San lorenzo del
26 Buršić-Matijašić 1998a, pp. 23-42; Mihovilić 2001, p. 11; hänSel, Mihovilić, teržan 1997.27 hänSel, Mihovilić, teržan 1997, pp. 37-107.28 čače 1982, p. 45.29 Buršić-Matijašić 2012.30 Fianona è specifica tra loro per la particolarità dello spostamento dell’abitato romano ai piedi del
antico castelliere (Buršić-Matijašić 2011).
KLArA BuršIć-MATIjAšIć, roBErT MATIjAšIć
187
fig. 2. distribuzione dei castellieri nella zona di Moncodogno (da Buršić,-Matijašić 2007).
fig. 3. distribuzione dei castellieri nella zona dei Pizzughi (da Buršić-Matijašić 2007).
L’ISTRIA: dAI CASTELLIERI ALLE VILLE ROMAnE AI VILLAGGI ALTOMEdIEVALI Ed OLTRE
188
pasenatico 31, di Valle, di mormorano, di grisignana ed altri (come la menzionata fianona) mentre gli edifici e le vie medievali e moderne seguono il tracciato delle comunicazioni interne del castelliere. la città di pola ne è un bel esempio: una semplice planimetria con lo schema a ragnatela e le due vie circolari e altre radiali che collegano il centro con le mura, cioè la “città alta” con la “città bassa” 32.
Sono pochi, come abbiamo visto, i castellieri che hanno continuato ad esistere in epo-ca romana. in alcuni casi, anche se non abbiamo dati concreti, possiamo supporre che in epoca romana, gli abitati non si sono allargati fuori le mura preistoriche, come nell’esempio di fianona, che ha continuato ad esistere in collina nonostante la formazione di un’abitato romano in riva al mare. in molti altri casi le dimore in collina venivano man mano abban-donate. dopo la conquista romana e l’inizio della romanizzazione 33, gli interessi economici degli abitanti hanno fatto sì che – non essendo più necessario proteggersi dietro mura pos-senti in cima al colle – la vita continuasse nella vallata, meno protetta ma più comoda.
la vittoria dei Romani sugli istri, nel 177 a. C. 34 segnò l’inizio di un nuovo periodo nella storia politica, ma non subito nella storia del paesaggio. infatti, pare che a breve termi-ne niente fosse cambiato nel rapporto tra uomo e natura 35 in istria come conseguenza della vittoria, in quanto i Romani hanno impostato una rete di punti di controllo per impedire agli istri di agire contro gli interessi di Roma, ma senza grandi movimenti migratori, ne cam-biamenti sociali. pochi si sono occupati del periodo di transizione tra la conquista romana e la fondazione delle colonie (177 - metà del i secolo a.C.) 36, per ovvie ragioni: mancanza di fonti scritte e mancanza di testimonianze archeologiche ragionevolmente sicure. Anche se in questo lasso di tempo i contatti fra Romani e indigeni si fecero sempre più intensi, soltan-to dopo il proconsolato di Cesare (59-49 a.C.), quando vennero fondate le colonie romane di Pola e Parentium 37, iniziava la romanizzazione 38, il processo di colonizzazione, preceduto dalla riorganizzazione del paesaggio antropico. Colonizzazione significava distribuzione della terra ai coloni cittadini romani, e doveva essere preceduta dalla centuriazione.
il paesaggio istriano mostra ancora oggi chiari segni della presenza romana appunto nella forma di una rete catastale (fig. 4) visibile in alcune zone anche dopo duemila anni 39. i muri a secco, i sentieri ed anche qualche strada maggiore, importante ancor oggi, seguono il tracciato della centuriazione, coeva alla fondazione di Pola, che ha probabilmente di poco preceduto la fondazione di Parentium. La centuriazione come fatto fisico rappresenta, natu-ralmente, un’innovazione radicale nel paesaggio, e riflette un cambiamento anche nell’am-bito etnico e sociale. gli istri, abitanti dei castellieri furono espropriati dei loro beni en-
31 MiraBella roBerti 1953.32 MiraBella roBerti 1986, pp. 194-200.33 Matijašić 1991, p. 251.34 il famoso assedio e la conquista di nesactium: liv. 41, 11.35 MitChell 2002, p. 5.36 Vi si è riferito nel consueto modo lucido in roSSi 2001, pp. 87-115 ( = roSSi 2008, pp. 311-335);
utile, anche se incentrato su Tergeste, roSSi 2002.37 Appare oggi ben sicura la tesi di Augusto fraschetti sulla fondazione cesariana di Pietas Iulia Pola:
FraSChetti 1983; sulla fondazione di Parentium persistono alcune perplessità, anche se prende sempre più fondamento la tesi di jaroslav šašel sulla fondazione contemporanea anche di questa colonia: ŠaŠel 1992.
38 per il concetto della romanizzazione delle nostre regioni è istruttivo Bandelli 2009.39 gli studi fondamentali sulla centuriazione romana dell’istria, scoperta da pietro Kandler nel Ot-
tocento (cfr. attolini 1983), sono: Suić 1955; BradFord 1957, pp. 175-178; Chevallier 1961; raMilli 1972-73 e MarChiori 2010. un’apporto importante anche quello di Choquer 2007.
KLArA BuršIć-MATIjAšIć, roBErT MATIjAšIć
189
tro gli agri delle colonie, gli insediamenti su altura furono abbandonati, e gli istri probabilmente anche fisicamente allontanati. Però, è possibile anche degli istri siano rimasti entro l’agro, nelle zone marginali, anche se que-ste erano divise in cen-turie. l’archeologia non mostra tracce di questo processo, non sappiamo se la pulizia etnica sia stata immediata e totale, oppure graduale e parzia-le. L’epigrafia latina nelle zone attorno alle colonie mostra, infatti, solo deboli tracce di relitti onomastici istri, e marchiori crede di poter mettere in relazione la densità di popolamento dei due agri, entrambi co-perti da un’unica maglia di centurie (anche se resta aperta la questione della sequenza cronologica), con le dinamiche e carattere diversi di insediamento 40. Sono signi-ficative, per il loro numero relativo, le dediche alle divinità autoctone nella zona di Nesazio (e nell’istria liburnica aldilà del Arsia) 41: anche questo va probabilmente spiegato nella luce delle sopravvivenze autoctone nel ager publicus, marginali, ma pur esistenti.
Anche se si sono recentemente rinvigorite le attività di ricerca su alcuni problemi an-cora aperti: non ultimo tra questi e la questione della contiguità spaziale e cronologica tra la centuriazione di Pola e quella di Parentium, e la collegata questione del punto generatore della griglia, cioè l’ubicazione dell’umbilicus, ma non è questa la sede in cui dilungarsi
40 MarChiori 2010, pp. 81-84.41 Cfr. ŠaŠel koS 1999, pp. 63-80; jurKić Girardi 2005.
fig. 4. Gli agri centuriati di pola e parentium (da Marchiori 2010).
L’ISTRIA: dAI CASTELLIERI ALLE VILLE ROMAnE AI VILLAGGI ALTOMEdIEVALI Ed OLTRE
190
fig. 5. Cartina di distribu-zione delle ville rustiche (da Matijašić 1998).
su questi problemi: ci interessano di più le conseguenze della centuriazione sul paesaggio fisico, sociale ed economico.
il modello insediativo che deriva dalla colonizzazione e dalla centuriazione in età cesariana ed augustea, quello delle ville rustiche, è ampiamente documentato lungo tutta la costa occidentale e meridionale della penisola. l’agro di Pola comprende tutta l’istria settentrionale, a sud della linea Canale di leme - Canale dell’Arsia, passando a nord degli abitati di Canfanaro, Sanvincenti e Barbana; l’agro di Parentium comprende la zona tra il Canale di Leme e il bacino del Quieto, mentre da Montona a Corridico la linea di confine verso l’istria interna segue il letto del torrente Cipri e la Valle di leme 42. nel 1988 abbiamo registrato, entro questi confini, circa 200 siti d’epoca romana (fig. 5), con tracce di edifici di carattere rurale, probabili ville rustiche 43. il loro numero è cresciuto negli ultimi anni
42 questa è stata, in sostanza, l’estensione dell’agro proposta da Suić 1955.43 Matijašić 1988; la versione in lingua italiana è stata pubblicata in Matijašić 1994.
KLArA BuršIć-MATIjAšIć, roBErT MATIjAšIć
191
grazie a nuove scoperte, in modo particolare durante i lavori per la posa del gasdotto e per la costruzione di autostrade 44.
la distribuzione delle ville coincide in modo evidente con la prossimità della costa e della valle del fiume Quieto, mentre non si vede, allo stato attuale delle ricerche, un collega-mento tra la distribuzione delle ville e l’asse stradale principale, la Via Flavia, che da Aqui-leia collegava Tergeste, Parentium e Pola 45. era evidentemente il mare la via principale di comunicazione, in quanto conveniva maggiormente esportare i prodotti delle ville, l’olio e il vino, per mare (o fiume). Le ville rustiche erano perciò rivolte principalmente al mare. Sono molto numerose nella fascia di un paio di chilometri dalla costa, sensibilmente meno numerose nella fascia seguente di 10 km (che comprende la Via Flavia), e decisamente poco numerose nell’interno. nonostante tracce di centuriazione siano ben visibili su tutta la su-perficie dei due agri 46, e ciò significa che tutta l’area è stata divisa (non si può più parlare di zona marginale, indivisa, ager compascuus ecc) e organizzata in lotti, in alcune zone interne non vi sono assolutamente tracce di ville rustiche, ma sarà compito dell’archeogia indivi-duarle in futuro. naturalmente, la mancanza di strutture romane del tipo villa rustica nell’in-terno dell’istria (zona di pisino e pinguente) non meraviglia affatto, poiché non facevano parte del paesaggio romano in zone di insediamento prevalentemente indigeno, fuori dagli agri colonici. Gli Istri, parzialmente romanizzati, hanno lasciato tracce di sé nell’epigrafia e nell’onomastica 47, ma non nell’architettura o in altre forme archeologiche.
È nota in dettaglio, più o meno, una ventina di ville rustiche indagate e pubblicate du-rante il novecento 48, e alcune di queste sono state scavate durante l’ultimo decennio. le ville si dividono in due categorie essenziali: residenziali e produttive, più una categoria mista, con caratteristiche residenziali (ma non lussuose) e produttive. famosa è la villa marittima di Barbariga, scavata nel 1902 49, con sontuosi mosaici ed affreschi, i cui resti in situ sono trascurati e oggi quasi interamente distruti. nello stesso stato si trova la villa di Valbandon, scavata dal gnirs pochi anni più tardi. Anton gnirs ha scavato anche la villa di Siana, nonché quella di monte Collisi sull’isola di Brioni. la villa di Val Catena 50, sull’isola di Brioni, ap-partiene al tipo misto: si tratta di un complesso lussuoso, con elementi produttivi.
per quanto riguarda le ville, le isole di Brioni appartengono ad una categoria a se stante 51, in quanto il paesaggio dell’isola principale era ed è un’entità chiusa, diversa dalla terraferma. le isole erano rimaste fuori della centuriazione e probabilmente fuori dell’as-segnazione di terra: avevano un proprietario unico, di ceto senatoriale, probabilmente la famiglia dei Laecanii 52, che avevano però possedimenti terrieri anche a Fasana. Il paesaggio
44 Bulić, Matijašić c.s.45 Alla stessa conclusione è arrivato MarChiori 2010, pp. 84-86.46 MarChiori 2010, p. 77.47 Cfr. i volumi delle Inscr. It. X, 2, 255 (S. Andrea di Caroiba), Inscr. It. X, 3, 105 (Piquentum), 108
e 110 (milino), 113 e 114 (dobrova) e molte altre nel comprensorio di piguente, Rozzo e pedena. un’im-portante studio in lingua croata è KrižMan 1991, pp. 144-178.
48 Sulle ville esplorate all’inizio del secolo cfr. GnirS 1908a, ma anche Matijašić 2001, dove è citata la ricca bibliografia precedente.
49 SChwalB 1902.50 tutte le ville più importanti scavate da Anton gnirs all’inizio del novecento sono pubblicate in
GnirS 1908a. Soltanto sulla villa di Val Catena si è lavorato anche in epoca recente, benché si tratti solo di lavori di revisione: BeGović 1990.
51 BeGović, SChrunK 2000.52 BezeCzky 1998.
L’ISTRIA: dAI CASTELLIERI ALLE VILLE ROMAnE AI VILLAGGI ALTOMEdIEVALI Ed OLTRE
192
produttivo di Fasana era specifico, in quanto c’era una figulina con dei forni per la produ-zione di anfore, tegole e probabilmente anche altro materiale fittile 53, mentre nella tarda Antichità vi è stato installato un oleificio, di cui sono stati scoperti recentemente nuovi dettagli 54. C’erano altre due figuline a Cervera e a Loron, poco a nord di Parenzo: la prima scavata dalla prof.ssa Girardi jurkić 55, e l’altra da un équipe internazionale con in testa l’università di Bordeaux iii (francis tassaux e Corinne Rousse), e l’università di padova (guido Rosada e Antonio marchiori) 56. non è un caso che gli impianti per la produzione della ceramica, in quanto complementari alla produzione agricola, sono situati sulla costa, sempre per ragioni di trasporto. un terzo possibile centro produttivo, ma le fornaci non sono state finora localizzate, si trovava sotto Montona, nella Valle del Quieto: il rinvenimento di un deposito di tegole con il marchio di manlio Acilio glabrione, assieme con il toponimo Monforno, sono per ora le uniche tracce 57.
Non può mancare, in un discorso sul paesaggio antico, un accenno anche al cam-biamento del livello del mare rispetto alla costa. dalla considerazione che lungo la costa istriana i resti di ville romane sono oggi in parte sommersi (una parte dei resti di muri è al livello del mare) si è dedotto, già nel primo novecento, che il livello del mare è cre-sciuto di 2 m dall’antichità ad oggi 58. Vari studi del fenomeno effettuati recentemente da geologi e archeologi hanno sostanzialmente confermato tale dato puntualizzando che il livello del mare è cambiato durante gli ultimi 2000 anni per varie ragioni (eustatiche, cioè innalzamento del livello a causa del aumento globale del volume dell’acqua, isostatiche, cioè i micromovimenti tettonici con i quali la crosta terrestre risponde a questi cambia-menti) e non in maniera uniforme. le ultime conclusioni pubblicate 59 portano ad una sti-ma del livello del mare, in base a dati geomorfologici, sedimentologici, paleo-ambientali ed archeologici, di -1 m (± 48 cm). Inoltre, pare che dopo il 1450 d.C. si sia verificato un’innalzamento del livello del mare di 60 cm dovuto a ragioni tettoniche 60, e allora il dato grossolano di circa 2 m di differenza dall’antichità ad oggi sembra confermato e scientificamente chiarito.
Ritornando all’archeologia, vediamo ora i cambiamenti nella tarda Antichità nel con-testo istriano 61. nel periodo “del declino e della caduta dell’impero Romano” (per usare la frase del titolo del famoso libro di edward gibbon) le trasformazioni sociali ed economiche sono state molteplici e a lungo termine hanno contribuito a causare cambiamenti drastici anche nel paesaggio. già dopo il iV secolo, l’involuzione dell’economia, in seguito alla crisi in cui precipitava sempre più l’impero, ha avuto come conseguenza l’indebolimento della produzione agricola, la riduzione del volume degli scambi 62.
le ville rustiche vennero gradualmente ridimensionate e abbandonate, e alcune di esse sulla costa si trasformarono nel V secolo in agglomerati fortificati: Civitas nova (Cit-tanova), Humagum (umago), e il cosiddetto Castrum di Brioni, mentre alcuni sorgono su
53 GnirS 1910.54 Bulić, KonCani uhač 2010, pp. 130-133.55 jurKić 1979; Carre et alii 2011, pp. 182-186.56 Sugli scavi di loron cfr. Carre et alii 2011, pp. 173-181; Carre et alii 2012, pp. 599-604.57 Matijašić 1989-90; Matijašić 1998a, pp. 260-262.58 GnirS 1908b, pp. 1-56.59 Carre et alii 2011, pp. 69-88.60 Cfr. anche FouaChe 2005, pp. 116-134.61 per un primo approccio, cfr. Matijašić 1982-83.62 Matijašić 1998b.
KLArA BuršIć-MATIjAšIć, roBErT MATIjAšIć
193
castellieri abbandonati: Ursaria (Orsera), Ruginium (Rovigno), Piranon (pirano) 63. Come ci documenta il “placito del Risano” (del 804) 64, città fortificate erano poi anche Albona, pinguente, pedena 65 e montona, ma solo le prime due sono note dalle fonti dell’antichità classica. le città maggiori, Pola, Parentium, nesactium, continuarono a vivere senza so-luzione di continuità anche dopo il V secolo (anche se nesactium per non molto tempo) e videro un periodo di relativa fioritura ai tempi di Giustiniano, almeno per quanto riguarda l’architettura ecclesiale. i cambiamenti radicali non furono, infatti, immediati, ma frutto di un processo di lunga durata.
una caratteristica notata recentemente e l’installazione di impianti produttivi (gene-ralmente torchi per l’olio) in città, anche in posti strani, sulle mura di cinta, vicino al por-to, nelle terme… Così a Pola, Nesazio e Parenzo, come anche nel cosiddetto Castrum di Brioni, nel V-Vi secolo troviamo torchi per la produzione dell’olio e del vino nell’ambito urbano 66, cosa che prima era impensabile: tali impianti nei secoli precedenti facevano parte esclusivamente del paesaggio agrario. il loro trasferimento dalla campagna in città è uno dei segni evidenti del graduale abbandono dell’agro e delle ville. Certamente non si trattò di ab-bandono improvviso e totale, di una riduzione dei siti: nella fascia costiera la vita continuò su scala ridotta 67, mentre nell’interno le poche ville vennero progressivamente abbandonate e contemporaneamente la popolazione si raggruppava nei primi castella.
una spia ulteriore della persistenza della vita nel paesaggio tardoantico-altomedievale istriano sono le chiesette, oggi isolate nelle campagne, lontano dagli abitati moderni. dopo l’abbandono dei villaggi alla fine del Medio Evo (dopo le ripetute epidemie di peste nel trecento e quattrocento) 68, le chiese sono rimaste in uso oppure ricostruite dai nuovi abi-tanti ed oggi rappresentano l’unica testimonianza del grado di popolamento nel medio evo. gli esempi più noti, San eliseo presso fasana 69, San michele di Bagnole preso dignano 70, Santa fosca, ma anche molti altri – particolarmente numerosi nella zona di fasana, gallesa-no, dignano e Barbariga 71 – illustrano le due fasi successive nell’evoluzione del paesaggio: la formazione di villaggi nel periodo tra tarda Antichità e Alto medio evo, e il loro abban-dono dopo alla fine del Medio Evo.
63 MiClauS 2004, p. 228.64 per il testo del placito cf. Petranović, MarGetić 1983-84; edizione precedente in udina 1932.65 da notare che MiClauS 2004, p. 230, riporta erroneamente “pisino” al posto di “pedena” (Petina
nel documento).66 Matijašić 2007a; Matijašić 2007b; Matijašić 2008. l’ultimo rinvenimento di questo tipo, quel-
lo di un torchio nei pressi della basilica di Santa maria formosa, in riva al mare, probabilmente nel porto, risale al 2007-08, cfr. ujčić 2008, pp. 365-366.
67 L’oleificio di Barbariga, per esempio, fu ridotto nella sua capacità di torchiatura, ma sopravvisse fino al VI-VII secolo, cfr. Matijašić 1998a, pp. 188-192. la riduzione della capacità di produzione dell’olio a Barbariga era avvenuta probabilmente anche prima del V-Vi secolo; la cronologia del sito andrebbe pro-fondamente rivista dopo gli auspicati scavi di verifica del sito.
68 Solo nell’istria meridionale più di settanta villaggi sono stati abbandonati, come testimoniano i toponimi consevati delle fonti d’archivio; cfr. de FranCeSChi 1939-40; Matijašić 1983-84b.
69 Marušić 1958, pp. 331-351.70 la chiesa esplorata e pubblicata da riSMondo 1910, è stata riscavata e conservata nel 2004-08,
cfr. Barada, MuStač 2005, pp. 243-245; Barada 2006, pp. 271-273; Barada, GrGeta 2007, pp. 312-314.
71 molto importanti ed interessanti sono i risultati di ricerche effettuate nell’ultimo decennio su di-versi siti attorno a guran (dignano), cfr. terrier Carre et alii 2005; terrier Carre et alii 2006; terrier Carre et alii 2006.
L’ISTRIA: dAI CASTELLIERI ALLE VILLE ROMAnE AI VILLAGGI ALTOMEdIEVALI Ed OLTRE
194
fig. 6. Capo Promontore, loc. Stupice, foto satelli-tare di GoogleEarth (da Matijašić 2012).
fig. 7. Capo Promontore, loc. Castril, foto satellita-re di GoogleEarth (da Matijašić 2012).
Ritornando all’antichità, concludiamo con un’altra nota sul paesaggio istriano antico, i resti di piantagioni antiche nella forma di impronte nel terreno, leggibili da foto aeree – e fenomeno raro in ambiente carsico quale l’istria “rossa”, zona degli agri colonici di Pola e Parentium. Sulla costa di punta promontore, l’estrema punta meridionale dell’istria, in località Stupice (Stupizze) sono stati notati buchi quadrati incavati nella pietra viva di circa 150-170 cm di lato, profondi oggi sui 15 cm, esposti all’erosione del mare, disposti in filari regolari, a distanza di 150-170 cm uno dall’altro 72. non c’è dubbio che si tratti di resti “fossilizzati” del paesaggio agricolo romano, di una piantagione di alberi, forse di ulivi, posti a distanza di 3-3,5 m l’uno dall’altro. ma con le nuove tecnologie di telerilevamento (fig. 6) è stato possibile riconoscere tutta la rete di quadrati sull’intera penisola di Stupice 73, non solo sulla costa esposta all’erosione del mare, e ci si rende conto della grandezza della piantagione. ma la stessa rete continua lungo la costa a nord e a sud della stessa penisola ai piedi del monte Stupice 74, nelle zone non coperte dal bosco di pini, e si ripete nella zona di Castril, dove le foto da satellite mostrano un’altra griglia simile (fig. 7), con orientamento diverso, dall’asse leggermente spostato da nord verso ovest 75. Si sostiene che sul Capo Promontore non ci siano tracce di centuriazione, ma ciò non significa che il territorio non fosse organizzato in modo antropico. l’estensione di queste piantagioni, conservate nel
72 Avendo saputo del fenomeno da Boris Baćić che l’aveva notato negl’anni Sessanta, ne abbiamo dato una prima notizia in Matijašić 1998a, pp. 342-343 con una piantina schematica a p. 347.
73 “Scoglizo” sulla tav. igm 1:25.000; sul sito più dettagliatamente in Matijašić 2012, pp. 75-89.74 “m. Stupiz” sulla tav. igm 1:25.000.75 Il sito archeologico, castelliere preistorico e possibile fortificazione tardoantica (Castril < Ca-
strum), cfr. Matijašić 2007c, pp. 221-228, si trova su uno dei punti più alti di Capo promontore, dal quale si stende un’ampia vista panoramica a 360° sul mare circostante. la zona con i resti di buche per gli alberi da frutto è posta sul pendio meridionale di Castril, esposto al sole.
KLArA BuršIć-MATIjAšIć, roBErT MATIjAšIć
195
paesaggio fossile, ci fa ritornare al punto di partenza, alle affermazioni di Cassiodoro 76. l’istria era effettivamente, almeno in certi periodi, “piena di ulivi, decorata da coltivazioni, abbondante di viti”. lo dimostra anche plinio, per il quale l’olio d’oliva istriano era pari a quello della Baetica ispanica, e assieme erano secondi solo all’olio dell’agro campano di Venafrum 77. Con l’economia cambia anche la congiuntura, e niente dura in eterno, neanche troppo a lungo. la storia del paesaggio, la storia dell’ambiente ce lo insegnano forse meglio della storia politica.
BiBliOgRAfiA
attolini 1983 = i. attolini, La riscoperta della centuriazione di Pietro Kandler, in Misurare la terra, centuriazione e coloni nel mondo romano, modena, pp. 170-171.
Baćić 1970 = B. Baćić, Prilozi poznavanju prahistorijske gradinske fortifikacije u Istri, in Adriatica prae- historica et antiqua Gregorio novak dicata, zagreb, pp. 215-227.
Baćić 1978 = B. Baćić, Prahistorijska izložba, Vodič III, Arheološki muzej Istre u Puli, Pula, pp. 27-44.Bandelli 2009 = g. Bandelli, note sulla categoria di romanizzazione con riferimento alla Venetia e
all’Histria, «Antichità Altoadriatiche», 68, pp. 29-69.Barada 2006 = m. Barada, Sv. Mihovil Banjolski, «Hrvatski arheološki godišnjak», 3, pp. 271-273.Barada, MuStač 2005 = m. Barada, S. MuStač, Sv. Mihovil Banjolski, «Hrvatski arheološki godišnjak»,
2, pp. 243-245.Barada, GerGeta 2006 = m. Barada, K. GerGeta, Sv. Mihovil Banjolski, «Hrvatski arheološki
godišnjak», 4, pp. 312-314. BeGović dvoržaK 1990 = V. BeGović dvoržaK, Antička vila u uvali Verige na Brijunima (Roman Villa in
Verige Bay, Brijuni Islands), «Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu», 3.s., 23, pp. 97-110.BeGović, SChrunk 1999-2000= V. BeGović, i. SChrunk, Villae rusticae na Brijunskom otočju / Villae
rusticae on the Brijuni Islands, «Opuscula Archaeologica», 23-24, pp. 425-439.BenuSSi 1924 = B. BenuSSi, L’Istria nei suoi due millenni di storia, trieste.BezeCzky 1998 = t. BezeCzky, The Laecanius amphora stamps and the villas of Brijuni, Wien.Bulić, KonCani uhač = d. Bulić, i. KonCani uhač, Figlina u Fažani i njezina preobrazba u kasnoj
antici / The pottery workshop at Fažana and its transformation in the Late Roman Period, «Histria Archaeologica», 40, pp. 109-146.
Bulić, Matijašić c.s. = d. Bulić, r. Matijašić, L’architettura rurale romana dell’agro polese in luce delle indagini recenti, in Arheološki park Severnega Jadrana, a cura di i. lazar e K. zanier, «Annales mediterranei», in corso di stampa.
Buršić-Matijašić 1994 = K. Buršić-Matijašić, La ceramica a striature in Istria, in Atti della XXIX riu-nione scientifica IIPP, firenze, pp. 247-260.
Buršić-Matijašić 1998a = K. Buršić-Matijašić, Gradina Monkodonja, Tipološko statistička obra-da keramičkih nalaza srednjobrončanodobne istarske gradine Monkodonja kod Rovinja / The Monkodonja Hillfort, A Typological and Statistical Analysis of Pottery Finds from the Middle Bronze Age Hillfort of Mokodonja near Rovinj, «Monografije i katalozi», 9, Arheološki muzej istre, pula.
Buršić-Matijašić 1998b = K. Buršić-Matijašić, Monkodonja, Iznova otkrivena gradina / Moncodogno, La riscoperta del castelliere, «Katalog», 54, Ami-pula, pula.
Buršić-Matijašić 2001 = K. Buršić-Matijašić, Gradinski obrambeni sustav sjeverne Istre, «Buzetski zbornik», 27, pp. 15-22.
76 CaSS., Var. 12, 22: Est enim proxima nobis regio supra sinum maris Ionii constituta, olivis refera, segetibus ornata, vite copiosa.
77 Plin., n.H. 15, 8: Principatum in hoc quoque bono obtinuit Italiae e toto orbe, maxime agro Venafrano… Reliquum certamen inter Histriae terram et Beticae par est (…).
L’ISTRIA: dAI CASTELLIERI ALLE VILLE ROMAnE AI VILLAGGI ALTOMEdIEVALI Ed OLTRE
196
Buršić-Matijašić 2006 = K. Buršić-Matijašić, Luka Pula u prapovijesno i rimsko doba, in Zbornik Iz povijesti Pulske luke, pula, pp. 5-43.
Buršić-Matijašić 2007 = K. Buršić-Matijašić, Gradine Istre – Povijest prije povijesti, pula.Buršić-Matijašić 2010 = K. Buršić-Matijašić, Bale i keramički materijal iz palače Soardo-Bembo
(istraživanje 2000. – 2003.) / Bale and the pottery from the Soardo-Bembo Castle (Research 2000-2003), «Opuscula Archaeologica», 34, pp. 7-35.
Buršić-Matijašić 2011 = K. Buršić-Matijašić, Fianona, dal castelliere preromano al porto romano, «Atti e memorie della Società istriana di Archeologia e Storia patria», 111, pp. 205-219.
Buršić-Matijašić 2012 = K. Buršić-Matijašić, dal castelliere alla città, Esempi di passaggio da abitati preistorici a città classiche nell’Alto Adriatico, in I processi formativi ed evolutivi della città in area adriatica, a cura di G. de MariniS, G. M. FaBrini, G. PaCi, r. Perna e m. SilveStrin, British Achaeological Reports, S2419, Oxford.
Buršić-Matijašić 2012a = K. Buršić-Matijašić, neki aspekti naselja i nastambi u Istri u prapovijesti / Alcuni aspetti degli insediamenti e delle abitazioni in Istria durante la preistoria, Tabula 10, pula, pp. 7-38.
Carre et alii 2011 = m-B. Carre, v. Kovačić, F. taSSaux, L’Istrie et la mer. La côte du Parentin dans l’antiquité, Ausonius Éditions, mémoires 25, Bordeaux.
Carre et alii 2012 = m-B. Carre, v. Kovačić, C. rouSSe, F. taSSaux, Lorun-Loron et Busuja-Bossolo, Poreč-Parenzo, Istria, Les campaignes de recherche 2011, «Histria Antiqua», 21, pp. 599-608.
Choquer 2007 = g. Choquer, La centuriation de Pola (Croatie, Istrie), (http://www.archeogeographie.org/index.php?rub=arpentage/romain/pola; visionato il 5 marzo 2013).
Chevallier 1961 = R. Chevallier 1961, La centuriazione romana dell’Istria e della dalmazia, «Atti e memorie della Società istriana di Archeologia e Storia patria», 61, pp. 11-23.
CodaCCi-terlević 2004 = g. CodaCCi-terlević, Prilog poznavanju brončanodobnih pogrebnih običaja u Istri – stanje istraženosti istarskih tumula te rezultati istraživanja tumula iz Uvale Marić kod Barbarige / The results of the research conducted on a Bronze Age tumulus above the Bay of Marić near Barbariga, «Histria Archaeologica», 35, pp. 41-74.
čače 1982 = S. čače, Liburnske zajednice i njihovi teritoriji, «dometi», 12, pp. 41-52.čović 1983 = B. čović, Regionalne grupe ranog bronzanog doba, Istra; Srednje bronzano doba u Istri, in
Praistorija jugoslavenskih zemalja, IV, Sarajevo, pp. 114-132; 233-242.de FranCeSChi 1929-1940 = C. de FranCeSChi, La toponomastica dell’antico agro polese desunta dai docu-
menti, «Atti e memorie della Società istriana di Archeologia e Storia patria», 56-57, pp. 119-198. FraSChetti 1983 = A. FraSChetti, La pietas di Cesare e la colonia di Pola, Annali del seminario di studi
del mondo classico, «Archeologia e storia antica», 5, pp. 77-101.GaBroveC, Mihovilić 1987 = S. GaBroveC, K. Mihovilić, Istarska grupa, in Praistorija jugoslavenskih
zemalja, V, Sarajevo, pp. 293-339.Girardi jurKić 2005 = V. Girardi jurKić, duhovna kultura antičke Istre. Knjiga I. Kultovi u procesu
romanizacije antičke Istre, zagreb.GnirS 1908a = A. GnirS, Istrische Beispiele für Formen der antik-römischen villa rustica, «jahrbuch für
Altertumskunde», 2, pp. 124-143.GnirS 1908b = A. GnirS, Beobachtungen über den Fortschritt einer säkularen niveauschwankung des
Meeres während der letzten zwei Jahrtausende, «geographische mitteilungen», pp. 1-56. GnirS 1910 = A. GnirS, Eine römische Tonwarenfabrik in Fasana bei Pola, «jahrbuch für Altertumskun-
de», 4, pp. 79-88.GovedariCa 1982 = B. GovedariCa, Prilozi kulturnoj stratigrafiji praistorijskih gradinskih naselja u
jugozapadnoj Bosni / Beiträge zur einer kulturellen Stratigraphie prähistorische Wallburgsiedlun-gen in südwest Bosnien, «Godišnjak CBI ANuBiH», XX/18, pp. 111-189.
hänSel et alii 1997 = B. hänSel, K. Mihovilić, B. teržan, Monkodonja – utvrđeno protourbano naselje starijeg i srednjeg brončanog doba kod Rovinja u Istri / Monkodonja – a fortifield protourban settlement from the older and middle bronze age near Rovinj in Istria, «Histria archaeologica», 28, pp. 37-108.
jurKić 1979 = V. jurKić, Scavi in una parte della villa rustica romana a Cervera Porto presso Parenzo (I), campagne 1976-1978, «Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno», 9, pp. 263-298.
KrižMan 1991 = m. KrižMan, Rimska imena u Istri. Osobna imena na istarskim natpisima iz rimskog doba, zagreb.
KuKoč 2011 = S. KuKoč, Liburnska nekropola u prirodnom i kulturnom okolišu, «Histria Antiqua», 20, pp. 189-220.
laGo 1994 = l. laGo, Pietre e paesaggi dell’Istria centro-meridionale, Le “Casite”, fiume-trieste.
KLArA BuršIć-MATIjAšIć, roBErT MATIjAšIć
197
MarCheSetti 1903 = C. MarCheSetti, I castellieri preistorici di Trieste e della regione Giulia, trieste, ristampa 1981.
MarChiori 2010 = A. MarChiori, Centuriazioni d’Istria: studio evolutivo delle disuguaglianze, «Agri centuriati», 6, pp. 71-97.
Marušić 1958 = B. Marušić, Kratak doprinos proučavanju kontinuiteta između kasne antike i ranog srednjeg vijeka te poznavanju ravenske arhitekture i ranosrednjovjekovnih grobova u južnoj Istri. Izvještaj o iskapanju kod Sv. Elizeja kraj Fažane / Ein kurzer Betrag dem Studium des Kontinuitäts zwischen der späten Antike un des frühen Mittelalters, wie auch der Kenntnis der ravennischen Ar-chitektur un der früh-mittelalterlichen Gräber in Süd-Istrien, «jadranski zbornik», 3, pp. 331-351.
Matijašić 1983-84a = R. Matijašić, Alcune considerazioni sulle forme di insediamento rustico in Istria dal III al VI sec., «Atti dei Civici musei di Storia ed Arte di trieste, quaderni», 13, 2, pp. 231-243.
Matijašić 1983-84b = R. Matijašić, Toponomastica storica dell’antico agro polese di Bernardo Schiavuz-zi, «Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno», 14, pp. 307-344.
Matijašić 1988 = R. Matijašić, Ageri antičkih kolonija Pola i Parentium i njihova naseljenost od I. do III. stoljeća, zagreb.
Matijašić 1991 = R. Matijašić, L’Istria tra Epulone e Augusto: archeologia e storia della romanizzazione dell’Istria (II sec. a. C. – I sec. d. C.), «Antichità Altoadriatiche», 37, pp. 235-251.
Matijašić 1994 = R. Matijašić, Gli agri delle colonie di pola e di parentium, «Atti e memorie della So-cietà istriana di Archeologia e Storia patria», 94, pp. 7-104.
Matijašić 1997 = R. Matijašić, L’Istria tra l’antichità classica e la tarda antichità, «Arheološki vestnik», 48, pp. 203-218.
Matijašić 1998a = R. Matijašić, Gospodarstvo antičke Istre, Arheološki ostaci kao izvori za poznavanje društveno-gospodarskih odnosa u Istri u Antici (I. st. pr. Kr. – III. st. posl. Kr.), pula
Matijašić 1998b = R. Matijašić, La produzione agricola in Istria nel VI – VII secolo, in Acta XIII Con-gressus Internationalis Archaeologiae Christianae, Vol. ii, «Studi di antichità cristiana pubblicati a cura del Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana», LIV, Città del Vaticano pp. 1107-1120.
Matijašić 2001 = R. Matijašić, Le ville rustiche istriane (bilancio storico-archeologico), in: Abitare in Cisalpina, L’edilizia privata nelle città e nel territorio in età romana, «Antichità Altoadriatiche», 49, pp. 693-711.
Matijašić 2007a = R. Matijašić, Impianti antichi per olio e vino in contesto urbano in Istria, «Histria Antiqua», 15, pp. 13-26.
Matijašić 2007b = R. Matijašić, O nalazu kasnoantičkih tijesaka u Poreču 1997. godine (On the discove-ry of Late Antique presses in Poreč in 1997), «Opuscula Archaeologica», 31, pp. 265-281.
Matijašić 2007c = R. Matijašić, Još jednom o Kastrilu na premanturskom rtu Kamenjak (Medulin) / Another Look at Kastril on the Premantura Cape of Kamenjak (Medulin), «prilozi instituta za arheologiju u Zagrebu», 24, pp. 221-228.
Matijašić 2008 = R. Matijašić, Ostatci tijesaka u dvorištu rimske vile u uvali Madona na Brijunima (tzv. Kastrum) / The remains of a press in the courtyard of the Roman villa in Madona Bay on Brijuni Island („Kastrum“), «Archaeologia Adriatica», 2, 1, pp. 289-300.
Matijašić 2009 = R. Matijašić, Società e commercio nell’Istria e i rapporti con il Mediterraneo nella Tar-da Antichità, in Il Cristianesimo in Istria fra Tarda Antichità e Alto Medioevo. novità e riflessioni (Atti della giornata tematica dei Seminari di Archeologia Cristiana, Roma, 8 marzo 2007), a cura di e. Marin e d. Mazzoleni, Sussidi allo Studio delle Antichità Cristiane, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, Città del Vaticano, pp. 47-69.
Matijašić 2012 = R. Matijašić, Još jedan primjer fosiliziranog antičkog krajolika u Istri: Rt Kamenjak, Premantura, Pula / Un altro esempio di paesaggio fosilizzato antico in Istria: Punta Promontore, «tabula», 10, pp. 75-89.
MiClauS 2004 = l. MiClauS, I borghi d’altura istriani: dinamiche insediative tra tardoantico e altomedio-evo, «Antichità Altoadriatiche» 56, pp. 225-238.
Mihovilić 1994 = K. Mihovilić, Preistoria dell’Istria dal paleolitico all’età del ferro, in Atti della XXIX riunione scientifica, Preistoria e Protostoria del Friuli-Venezia Giulia e dell’Istria (trieste, 28-30 settembre 1990), firenze, 101-118.
Mihovilić 2001 = K. Mihovilić, nezakcij, Prapovijesni nalazi 1900.-1953. / nesactium. Praehistoric finds 1900-1953, «Monografije i katalozi», 11, Arheološki muzej Istre, Pula.
MiraBella roBerti 1953 = MiraBella roBerti, La chiesa e le mura di San Lorenzo del Pasenatico, in Arte del primo millenio (Atti del convegno per lo studio dell’arte dell’Alto medio evo, pavia, 1950), torino, pp. 91-110.
L’ISTRIA: dAI CASTELLIERI ALLE VILLE ROMAnE AI VILLAGGI ALTOMEdIEVALI Ed OLTRE
198
MiraBella roBerti 1986 = m. MiraBella roBerti, Urbanistica romana di Trieste e dell’Istria, «Anti-chità Altoadriatiche» 28, pp. 185-200.
MitChell 2002 = W.j.T. MitChell, Imperial Landscapes, in Landscape and Power, a cura di W.j.T. MitChell, Chicago, pp. 5-34.
Mohorovičić 1954 = A. Mohorivičić, Prikaz nekih karakterističnih elemenata u razvoju urbanističke strukture naselja na području sjeverozapadne Istre, «Ljetopis jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti», 59, pp. 227-232.
PeriCin 2001 = C. PeriCin, Fiori e piante dell’Istria distribuiti per ambienti, Rovigno-trieste.Petranović, MarGetić 1983-84 = A. Petranović, A. MarGetić, Il Placito del Risano, «Atti del Centro
di ricerche storiche di Rovigno», 14, pp. 55-70. Petrić 1978-79 = n. Petrić, Introduzione alla preistoria dell’Istria, «Atti del Centro di ricerche storiche
di Rovigno», 9, pp. 183-248.raMilli 1972-73 = g. raMilli, Gli agri centuriati di Padova e Pola nell’ interpretazione di Pietro Kan-
dler, «Atti e memorie della Società istriana di Archeologia e Storia patria», 72-73, pp. 5-72.riSMondo 1908 = d. riSMondo, La primitiva chiesa di S. Michele di Bagnole presso dignano, «Atti e
memorie della Società istriana di Archeologia e Storia patria», 24, pp. 352-373.roSSi 2001 = R. f. roSSi, nesazio e le città romane dell’Istria, «Atti e memorie della Società istriana di
Archeologia e Storia patria», 101, pp. 87-115 (= roSSi 2008, pp. 311-335). roSSi 2002 = R. f. roSSi, L’espansione romana nel nord-est e i problemi dei limiti confinari, in Un pianeta
diviso. Contributi alla geografia dei popoli e dei confini, a cura di g. BattiSti, trieste, pp. 51-64 (= roSSi 2008, pp. 337-348).
roSSi 2008 = R. f. roSSi, Scritti vari sulla decima Regio con altri saggi di argomento giuliano, trieste.ruGGini 1961 = l. ruGGini, Economia e società nell’“Italia Annonaria“. Rapporti fra agricoltura e com-
mercio dal IV al VI secolo d.C., milano, pp. 341-349. StePinaC-FaBijanić 1988 = t. StePinaC-FaBijanić, Paleontološka istraživanja kamenih poljskih kućica
okruglog tlocrta u Istri, «Problemi sjevernog jadrana», 6, pp. 109-132.Suić 1955 = m. Suić, Limitacija agera rimskih kolonija na istočnoj jadranskoj obali / Limitation of Roman
Colonies on the Eastern Adriatic Coast, «Zbornik Instituta za historijske nauke u Zadru», 1, pp. 1-36.
SChwalB 1902 = H. SChwalB, Römische Villa bei Pola, Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, Schrif-ten der Balkankommission, Antiquarische Abteilung, 2, pp. 1-52.
Srejović 1997 = d. Srejović, Arheološki leksikon, preistorija Europe, Afrike i Bliskog istoka, grčka, etrur-ska i rimska civilizacija, Beograd.
ŠaŠel 1992 = j. ŠaŠel, Stages in the administative development of Roman Parentium, in Opera Selecta, Situla, 30, Ljubljana, pp. 661-668.
ŠaŠel koS 1999 = m. ŠaŠel koS, Pre-Roman diviniteis of the eastern Alps and Adriatic, Situla, 38, Lju-bljana.
ŠkilJan 1980 = m. ŠkilJan, L’Istria nella protostoria e nell’età protoantica, «Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno», 10, pp. 9-37.
terrier et alii 2005 = j. terrier, M. jurKović, i. Matejčić, La basilique a trois nefs, l’église Saint-Simon et l’ancienne agglomération de Guran en Istrie (Croatie): troisieme campagne de fouilles archéo-logiques, «Hortus Artium medievalium», 11, pp. 325-341.
terrier et alii 2006 = j. terrier, M. jurKović, i. Matejčić, Les sites de l’église Saint-Simon, de la basilique a trois nefs, de l’agglomération de Guran et de l’ l’église Sainte-Cécile en Istrie (Cro-atie). Quartieme campagne de fouilles archéologiques, «Hortus Artium medievalium», 12, pp. 253-270.
terrier et alii 2008 = j. terrier, M. jurKović, i. Matejčić, Les sites de l’église Saint-Simon, de l’ancien-ne agglomération de Guran et de l’ l’église Sainte-Cécile en Istrie (Croatie). Sixieme campagne de fouilles archéologiques, «Hortus Artium medievalium», 14, pp. 231-248.
udina 1932 = R. udina, Il placito del Risano. Istituzioni giuridiche e sociali nell’Istria durante il dominio bizantino, «Archeografo triestino», s. 3, 17, pp. 1-84.
ujčić 2008 = Ž. ujčić, Pula – Flaciusova ulica, «Hrvatski arheološki godišnjak», 5, pp. 364-367.viSentin 2010 = C. viSentin, I Paesaggi delle Archeologie. Una passeggiata culturale nella memoria,
in Il paesaggio agrario italiano. Protostorico e antico. Storia e didattica (Summer school emilio Sereni, 26-30 agosto 2009), a cura di g. Bonini, a. BruSa e R. Cervi «quaderni del museo Cervi», 6, pp. 153-161.
KLArA BuršIć-MATIjAšIć, roBErT MATIjAšIć


























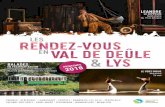











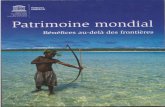
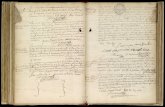

![Slovo v 'Romane' [Word/Discourse in 'Roman']](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6320b784c5de3ed8a70ddab7/slovo-v-romane-worddiscourse-in-roman.jpg)





