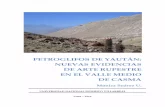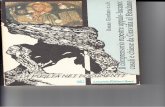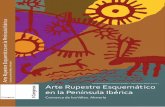A che punto è lo studio dell'arte rupestre della Valcamonica
L'arte rupestre delle Alpi occidentali: confronti con la tradizione rupestre camuna - 1995 - Angelo...
Transcript of L'arte rupestre delle Alpi occidentali: confronti con la tradizione rupestre camuna - 1995 - Angelo...
Comune di CuneoMuseo Civico
Soprintendenza Archeologicadel Piemonte
Cooperativa ArcheologicaLe Orme dell'Uomo
Immagini dalla PreistoriaIncisioni e pitture mpestri: nuovi messaggi dalle rocce
delle Alpi occidentali
Mostra documentaria in San FrancescoCuneo 28 settembre - 22 ottobre 1995
La mostra e il catalogoIMMAGINI DALLA PREISTORIAsono stati promossi e realizzati daSoprintendenza Archeologica del PiemonteComune di Cuneo, Museo CivicoCooperativa Archeologica Le Orme dell'Uomo - Cerveno
in occasione della XXXII Riunione scientifica dell'IstitutoItaliano di Preistoria e Protostoria, Alba, 29-30 settembre IO ottobre 1995
con il contributo diRegione Piemonte - Assessorato alla culturaComune di EntracqueParco Naturale dell'ArgenteraPresa Cementi - Robilante~PRE~~iOO:!JnJ~FlOll'l-"N1{(C_1
il catalogo è stato realizzato da
testi:Andrea Arcà (M),Le Orme dell'UomoDaniele Arobba (DA),Museo Civico di Finale LigureGiuseppe Canavese (CC),Parco Naturale dell'ArgenteraChiara Conti (ChC),Museo Civico di CuneoAngelo Fossati (AF),Le Orme dell'UomoFilippo Maria Gambari (FMC),Soprintendenza Archeologica del PiemonteLivio Mano (LM),CuneoElena Marchi (EM),Le Orme dell'UomoAngelo Morisi (AM),CuneoAlberto Santacroce (AS),Torino
Giancarlo Soldati (CS),CuneoEmanuela Tognoni (ET),Le Orme dell'Uomo
fotografie:Andrea ArcàArchivio GRCM,TorinoArchivio Cooperativa Archeologica Le Orme dell'UomoArchivio Museo Civico di CuneoArchivio Soprintendenza Archeologica del PiemonteAngelo FossatiAngelo GhirettiLivio ManoGiorgio Olivero, l'Occhio di Cristallo, CuneoAlberto SantacroceGiuseppe Schiappacasse, GenovaArchivio Museo di Antropologia ed Etnografiadell'Università di Torino
rilievi:Soprintendenza Archeologica del PiemonteSoprintendenza Archeologica della LombardiaCooperativa Archeologica Le Orme dell'UomoGRCMAngelo Ghiretti
hanno inoltre collaborato:Antonio Baroncini, Lugo di RomagnaJack Belfiore, CervenoGian Maria Cametti, TorinoPaolo di Nola, CollegnoValter Gaveglio, RobassomeroPatrizia Meirano, TorinoLivio Manassero, MondovìDaniela Robbiati, CervenoSoci GRCMParco Naturale della Rocca di CavourIl personale del Museo Civico di CuneoSquadre economato ed elettricisti del Comune di Cuneo
PARTECIPANTI ALLE CAMPAGNE DI INDAGINE
E RILEVAMENTO SCIENTIFICO DELLE INCISIONI RUPESTRI
DEL LAGO DEL VEI DEL BOUC 1989 E 1990
Direzione scientifica:Soprintendenza Archeologica del Piemonte (F. M. Gambari)Museo Civico di Cuneo (L. Mano)
Carotaggi pollinici:Daniele Arobba, Museo Civico di Finale Ligure
Campionature biologiche:Angelo Morisi, Cuneo
Campionature geologiche:Giancarlo Soldati, Cuneo
Equipes di lavoro formate da:Andrea Arcà, TorinoOliviero Cima, Soc. Arkaia, TorinoGiorgio Fea, CuneoRiccardo Lerda, CaraglioFederico Magrì, PineroloFabio Martini, CaraglioMarcello Proietti, ValgranaRoberto Querio, Cuorgné
Prospezioni Subacquee:Cesare Battaglia, Soc. Sportiva CuneosubLuigi Fozzati, ServizioTecnico per l'Archeologia SubacqueaAntonino Giuliano, Società Sportiva CuneosubRoberto Jarre, Soc. Sportiva CuneosubNucleo Carabinieri Subacquei, Genova-VoltriFranco Russo, Soc. Sportiva CuneosubMarco Verra, Soc. Sportiva Cuneosub
Aspetti logistici:Alpini Battaglione SaluzzoNucleo Elicotteri Carabinieri, VolpianoResponsabili e Guardiaparco del Parco Naturaledell'Argentera, Valdieri
Sommario
Presentazione Liliana Mercando pago 7
Presentazione Elio Rostagno " 9
Parte I - Studi
L'arte rupestre in Piemonte:problerni di tutela ed indirizzi di ricerca F M. Gambari " 13
Scheda Internazionale per il censimento delle incisioni edelle pitture rupestri delle Alpi occidentali Alberto Santacroce " 21
Tecniche di incisione: il caso della regione del Monte Bego Livio Mano " 27
L'arte rupestre delle Alpi occidentali:confronti con la tradizione rupestre camuna Angelo Fossati " 33
Dalla ricerca all'interpretazione: il ruolo dell' archeologia rupestre Andrea Arcà " 43
Parte II - Siti
Tra Vei del Bouc e Monte Bego " 53In cima al pascolo " 816000 anni sulla roccia " 87Pitture alla Rocca " 91La Roccia della Fata " 97Alle falde del Rocciamelone " 101Arcieri a cavallo " 109I Cervi al Castello " 117Passaggio a nord: l'Alpe Veglia " 125Tavola cronologico - tematica dell'Arte Rupestre Alpina " 128
Valcamonica, Luine roccia 34: figura di cervo in stile paleolitico - epipaleolitico (elaborazione fotografica digitale Le Orme dell'Uomo)
32
I più recenti studi ed approfondimenti dell' arte rupestredelle Alpi hanno mostrato l'esistenza di affinitàcronologiche e tematiche tra i vari siti. Soprattutto l'areaalpina occidentale, con i complessi rupestri della Valle diSusa, del Monte Bego e dell' Alta Moriana, e quella centro-orientale, con la Valcamonica e la Valtellina, offronopuntuali comparazioni e similitudini nelle tecniche e nelle tipologie di un vasto arco schematico e figurativo.L'arte rupestre della Valcamonica in particolare, con lasua ampia cronologia e varietà tema.tica, può essere utilizzata come termine di paragone valido per tutto l'arcol'alpino, per determinare somiglianze stilistiche ed affinità di datazione.
Dalle fasi più antiche all'età del Rame
Lo scioglimento dei ghiacciai alla fine del Paleoliticopermise l'accesso delle popolazioni umane ed animalinelle aree alpine dopo circa 80.000 anni di interdizione.A culture di cacciatori nomadi vanno probabilmente attribuite alcune figurazioni zoomorfe (alci e cervi) di stilenaturalistico e seminaturalistico, databili tra il XII ed il Vmillennio a.c., incise su alcune rocce del sito di Luine,presso Boario Terme in Valcamonica (1). Allo stato attuale delle ricerche dovrebbero essere queste, a nostro
Angelo Fossati
L'arte rupestre delle Alpi occidentali:confronti con la tradizione rupestre camuna
parere, le uniche raffigurazioni assegnabili ad .un'epocacosì antica nelle Alpi. Mentre, infatti, nelle Alpi occidentali non v'è nulla di simile, malgrado alcune figuresomiglianti ad alci in Val Germanasca (2), la presenzadelle figure zoomorfe ed antropomorfe dell' area del TotesGebirge va messa fortemente in dubbio (3). Si potrebbeforse ipotizzare che l'area camuna fosse tra le prime apermettere l'avanzamento delle popolazioni paleomesolitiche nella zona alpina, genti che trovarono nellerocce levigate dai ghiacciai pleistocenici i supporti idealiper realizzare le prime incisioni rupestri.La recente revisione della collocazione cronologica dellefigure di oranti schematici nell' arte rupestre camuna haridimensionato l'estensione dell' arte rupestre neoliticaanche delle altre aree (4). Gli oranti con stilema ad Udegli arti sarebbero infatti attribuibili a fasi tra il BronzoMedio ed il Bronzo Finale, mentre quelli con arti rigidi econtrapposti, sovrapposti a quelli con schema ad U e spesso anche armati, vanno datati al Bronzo Finale, così comeappare anche dal complesso rupestre di Grosio inValtellina. Nelle Alpi, dunque, sarebbero riferibili al Neolitico solo gli oranti incisi sui menhir rinvenuti nel quartiere di St.Guerin a Sion nel Vallese svizzero: questi delimitavano una necropoli di tombe a cista del tipo
33
Alta Valle dell'Ubaye: pugnali a lama triangolare e pomo semilunato
Chamblandes, databile ad un orizzonte della cultura diCortaillod-Lagozza, ma è anche ipotizzabile che le figuresiano state incise posteriormente sui menhir (5).Oltre agli oranti, sugli stessi menhir, sono visibili areemartellinate subcircolari e subrettangolari, probabilmenteinterpretabili come raffigurazioni topografiche, ed una figura di ascia. Le raffigurazioni topografiche di questo tiposono confrontabili con rappresentazioni analoghe incisesulle rocce in Valcamonica sia nell'area di Foppe di Nadropresso Ceto, che in quella di Vite presso Paspardo. InValcamonica il Masso di Borno, un menhir istoriato dell'età del Rame, presenta alcune figure topografiche di questo tipo sottoposte a tre pugnali a lama triangolare con basediritta e pomello semilunato, del tipo cosiddetto
"remedelliano", elementi datanti della composizione dellostile III A incisa sulla faccia B del menhir. Le incisionitopografiche devono pertanto porsi nella prima fase diistoriazione di questi massi, che potremmo probabilmenteattribuire a momenti finali dell'età neolitica o a quelle iniziali dell'eneolitica (6). L'associazione su Borno 1 deimotivi topografici a reticolo, a rettangolo, a semicerchiocon coppelle, con le figure subrettangolari riporta i primial medesimo orizzonte cronologico (7). Questo è importante anche per la datazione delle rappresentazioni analoghe presenti al Monte Bego, soprattutto nell'area diFontanalba (ad. es. La roccia dei coscritti) (8). Problematicainvece l'attribuzione delle figure a rete e quadrangoli che,mentre al Bego o a Ponte Raut possono trovare una collo-
Valcamonica, Masso di Gemmo n. 2: pugnali a lama triangolare e pomo semilunato di tipo remedelliano, età del Rame
cazione all'età del Bronzo, in Valcamonica sembrano appartenere a fasi avanzate dell'età del Ferro, come è testimoniato dalla mappa di Bedolina, e da altre raffigurazioniconsimili (9).Al medesimo orizzonte cronologico (Neolitico finale-inizidell'età del Rame) possono essere attribuite anche le pitture topografiche in colore crema dipinte sulle pareti verticali del Rocher de Chateau a Bessans. Qui, ma in colore rosso scuro, compaiono anche figurazioni antropomorfe a T,tracciati digitali formanti segmenti paralleli verticali odobliqui, ed un gruppo di cervi maschi (10), elemento ricorrente anche sui massi istoriati dell'età del Rame inValcamonica, ad es. su Cemmo 1 e 3. A Bessans però mancano gli elementi datanti che caratterizzano le composizio-
ni figurative dell'età del Rame in Valcamonica: le armi, tracui soprattutto i pugnali del tipo remedelliano. Un'attribuzione all'età del Rame delle pitture di Bessans resta dunque del tutto ipotetica, essendovi anche ampie possibilitàdi comparazione con l'arte schematica iberica per i segnischematici e gli antropomorfi a T (11).Ma non sono solo questi i segni dipinti che abbiano unrapporto con l'arte schematica iberica: dobbiamo infatti quiricordare anche le problematiche pitture della Rocca diCavour e della Valle dell'Ubaye (Les Oullas), queste ultime sottoposte ad una figura antropomorfa incisa e a figuredi pugnali remedelliani perfettamente comparabili con gliesemplari camuni attribuibili all'età del Rame (12). La figura antropomorfa ricorda da vicino lo schematismo tipi-
35
co delle rappresentazioni camune dello stile III A: le braccia sono distese e aperte, con l'indicazione delle dita, particolare evidente anche nei piedi, le gambe aperte a triangolo, il sesso maschile evidenziato; il busto ricorda invecequello della figura di aratore del Masso Borno 1 oppurequello delle figure antropomorfe della roccia 36 di Vitepresso Paspardo (13). La testa circolare è a contorno nonchiuso per la presenza di una frattura: è un particolare deltutto atipico, ma potrebbe trattarsi anche di una figuravolutamente lasciata incompleta.Come abbiamo detto i segni pettiniformi dipinti in rossohanno certamente un rapporto con l'arte levantina, ma sonoanche comparabili con figure analoghe dell'arte megaliticairlandese o dello stile III A nelle stele incise dellaValcamonica (14). Ritornando brevemente alle figureantropomorfe sono attribuibili allo stile III A 1 (fasiremedelliane) camuno anche le rappresentazioni della Peradi} Cros in Val Chiusella, e della Roccia del Mago in ValGermanasca: su queste rocce la presenza di cruciformi accanto alle figure o di ribattiture delle stesse non deve impedire la collocazione cronologica di queste figure a fasiantiche dell'età del Rame, così come accade inValcamonica (emblematico il caso della Roccia del Solea Paspardo): le figure medievali sono infatti per lo più abusto largo, a linea di contorno e ricche di particolari (spesso si tratta di armati), mentre lo stile schematico lineareresta tipico delle fasi preistoriche (15).Problematica invece la collocazione delle figure di spirali in entrambe le aree rupestri: al Monte Bego (Fontanalba)non sono in contesti datanti, anche se pare che, nel complesso, la tradizione rupestre del Bega non oltrepassi gliinizi del Bronzo Medio; sia nell' Alta Moriana (ArcelleNeuve) che in Val di Susa (Mompantero) le spirali paiono associate all' ampia fase dei meandri: a Mompantero,peraltro, i meandri sono sottoposti a figurazioni di asce alargo tranci ante della tarda età del Ferro (16). InValcamonica (Paspardo, In Valle) le spirali appaiono sottoposte a figure di oranti schematici attribuibili al Bronzo
Roccia del Mago, Val Germanasca: figura antropomorfa schematicasottoposta a sigle moderne; croci
Valcamonica, masso di Gemmo n. 2: figure antropomorfeschematiche, pugnali di tipo remedelliano, età del Rame
Medio-Tardo; in Valtellina (Grosio, Rupe Magna) sonosottoposte a guerrieri della prima età del Ferro; aCharschenna sono coperte da canaletti, presumibilmenteappartenenti alla media età del Ferro. Le figure più anti-
che di spirali, in ambito europeo, compaiono nell'artemegalitica irlandese, dove peraltro sono spesso associateanche a cerchi concentrici e a meandri (17). Esse sonopresenti anche nel repertorio iconografico delle prime fasidelle incisioni rupestri del fiume Tago in Portogallo dovesono sottoposte a figurazioni zoomorfe (cervi e cavalli)delineati in stile a raggi X (18) probabilmente attribuibiliall' età del Rame o a fasi antiche dell' età del Bronzo. Comesi vede il problema di una più esatta definizione della collocazione cronologica delle spirali rimane aperto.
L'età del Bronzo: armi, arature ed antropomorfi
Venendo al Bronzo Antico elemento comune nell' area occidentale (Monte Bego, Valle d'Aosta) ed in quella camunaè la rappresentazione delle armi. Alabarde, asce e pugnali ricorrono spesso associate fra loro o con altreraffigurazioni quali i bucrani e le scene di aratura. AlMonte Bego (soprattutto nell' area di Fontanalba) lealabarde sono rappresentate in modo più veristico rispetto a quelle camune. Spesso, infatti, sono incisi anche iribattini, inseriti o accostati al tallone sernicircolare di lamedalla forma triangolare. Al Bego le alabarde, spesso impugnate da antropomorfi, si trovano in connessione conscene di aratura o bucrani, aspetto del tutto assente inValcamonica (19). Solo in una stele della Valtellina (Caven2), peraltro assegnabile all'età del Rame, una figuraantropomorfa regge un' alabarda foliata ben più antica diquelle dell'età del Bronzo. Per quanto riguarda le asce alMonte Bego queste sono un soggetto figurativo raro espesso impugnate da piccoli antropomorfi, del medesimo tipo di quelli che reggono le alabarde. Le lame di queste asce non sono ben definite: un tipo preciso non è benriconoscibile, ma l'associazione con le alabarde rendepossibile una loro collocazione cronologica al BronzoAntico. Anche le asce della roccia della Barmasse, inValtournenche, sono attribuibili a fasi recenti del BronzoAntico, essendo riconoscibile il tipo con taglio a paletta,
una morfologia ben presente anche sulle rocce dellaValcamonica a Foppe di Nadro e a Luine (20). Il medesimo tipo ricorre anche sulla roccia di Castelletto (21), sullago di Garda: si tratta perciò di un tipo molto diffuso nelBronzo Antico in Italia Settentrionale.L'area delle Meraviglie al Monte Bego presenta un impressionante numero di pugnali attribuibili all' antica etàdel Bronzo (e forse alcuni anche all'età del Rame, sia deltipo remedelliano che di quello Ciempozuelos). Il medesimo fenomeno si osserva anche in Valcamonica sia aFoppe di Nadro che a Luine: qui come al Monte Bego,compaiono tipi con lama triangolare con spalla arrotondata e pomo piatto. In altri casi vi sono tipi che potremmo definire poladiani: pomo piatto, spalla a guardinaespansa. Rispetto al Bego, in Valcamonica non abbiamo,allo stato attuale delle scoperte, un tipo di pugnale conuna impugnatura costituita da linee parallele, un motivoche ricorda i manici compositi dei pugnali di tipo alpinocome quelli di Ledro e PoIada, formati da dischetti di bronzo alternati da materiale deperibile quale corno di cervoo cuoio (22).Per quanto concerne le scene di aratura attribuibili all'etàdel Bronzo la Valcamonica può fornire alcune indicazioni utili per una migliore collocazione cronologica di alcune scene del Monte Bego, dove il tema è ben presente:ad es. per quelle scene in cui l'aratore impugna la stegolacon una sola mano, mentre con l'altra impugna un pungolo, che in Valcamonica sono attribuibili all'età del Ferro; nelle scene camune assegnate all'età del Bronzo o all'età del Rame gli aratri sono sempre condotti impugnando con due mani la stegola, in quanto i terreni non eranoancora stati messi a dimora e il tipo di aratro non permetteva una facile conduzione. Il tema dell' aratura non è presente al momento in altre aree alpine, ma si trova nellatradizione rupestre di alcuni siti scandinavi e danesi. Sinotano poi somiglianze tra i corniformi del Bego e dellaValcamonica con le incisioni di bucrani di alcune lastre
37
di pietra di tombe a camera appartenenti allaWartbergkultur e di alcune rocce all'esterno della grottadi Escoural in Portogallo (23).Il Bronzo Medio-Tardo si caratterizza nell'area camunotellina per la presenza di raffigurazioni di oranti con schema a U degli arti inferiori e superiori. La maggior partedelle figure è nella classica posizione dell' orante, cioècon le braccia levate verso l'alto e le gambe simmetricamente contrapposte. Tra le figure si trovano anche numerose rappresentazioni femminili con l'indicazione del sesso e dei seni evidenziate da piccoli segni circolari tra legambe o in corrispondenza del busto. Gli antropomorficon gli arti superiori abbassati sono rari in Valcamonica,mentre nell' area alpina occidentale questa tipologia è piL!frequente: troviamo esempi sulle rocce del Gran Faetto(Val Chisone), della Valgrana e del Rocciamelone (Val diSusa). Tra queste figure si trovano anche alcune figurefemminili. Se si tiene conto che nell' arte rupestre dell'età del Ferro della Valcamonica non si trovano mai figure femminili sembra evidente che questo potrebbe essere un buon indicatore cronologico anche per lefigurazioni di altre aree.Gli antropomorfi schematici con gli arti rigidi e per lopiù simmetricamente contrapposti (a volte hanno però lebraccia abbassate) nell' area camuno-tellina sono difficilmente databili all'età neolitica, come dimostrato dallasottoposizione delle figure antropomorfe con arti con schema ad U con quelle con arti rigidi, e dal fatto che questeultime sono spesso armate (24). Lo schematismo di questi antropomorfi è in ogni caso confrontabile con le decorazioni delle ceramiche hallstattiane, con l'arte delle urnea capanna villanoviana e, per restare ad un' area geografica molto vicina alla Valcamonica, alle decorazioni a puntini degli schinieri di Pergine (Tn) (25). E' assai probabilequindi che possano essere collocati all'età del BronzoFinale o addirittura agli inizi della prima età del Ferro,come dimostra lo studio complessivo delle figure della
'Hl
Valcamonica, PIV 4 e FDN 23: schematismo comune ad arti simmetrici ortogonali e contrapposti tra figure di "oranti" e armati dell'età delBronzo Finale e della prima età del Ferro (rilievi Orme dell'Uomo)
Rupe Magna di Grosio. Nell'arte rupestre delle Alpi occidentali il contesto figurativo in cui appaiono le figure diantropomorfi con arti ortogonali non fornisce quasi maiinformazioni utili ad una loro datazione sicura. Lo stilefigurativo rimane pertanto l'unico appiglio cronologico.Una datazione al Bronzo Finale non è contraddetta peraltro dalla comparazione possibile con le decorazioni delleceramiche del Bronzo Finale nella Francia meridionale incui appaiono anche figure antropomorfe schematiche (26).
Arte rupestre dell'età del Ferro: il linguaggiofigurativo comune degli aristocratici guerrieri
Ma è l'arte rupestre dell'età del Ferro che offre maggioripossibilità di confronti tra le due aree. L'Alta Moriana ela Val di Susa soprattutto mostrano affinità nelle tematichee nello stile figurativo che si presenta assai ricco nellefasi attribuibili alla prima età del Ferro.
Molte figure antropomorfe sia in Alta Moriana che inVal di Susa sono state realizzate nello stile cosiddetto"bi-triangolare" (27). In Valcamonica questo stilema èraramente utilizzato, e si trova soprattutto nelleraffigurazioni attribuibili al VII-VI sec. a.c., come inalcuni armati incisi sulla roccia 27 di Foppe di Nadropresso Ceto.Nelle figure dipinte del Rocciamelone gli armati paionoaffrontarsi non solo con la lancia ma anche con l'arco,che pare l'arma preferita dai guerrieri. La presenza dell'arco non si presta ad alcuna considerazione cronologica,mentre può essere interessante rilevare che si tratta diun' arma da guerra e non da caccia, dato che il cavaliereche lo impugna tiene nell' altra mano uno scudo del tiposubrettangolare allungato di quelli in uso tra l'VIII ed ilVII sec. a.c. in Italia settentrionale ed in Valcamonica,ben presente nelle figurazioni di armati attribuibili allostile IV 1 (28). Il tema del cavaliere armato di arco siripete anche nelle pitture superiori, dove l'armato èequilibrista, come in alcune scene nell' arte rupestrecamuna (29).I confronti stilistici per lo stilema bitriangolare più vicinisi trovano nelle figure bitriangolari dell' arte ceramicahalstattiana delle Alpi occidentali o vicino alle Alpi, comea Kirchenreinbach, Pettenhofen, Niederhofen, nella Germania meridionale, o a Nové Kosariska in Ungheria. Nellaceramica proveniente dal tumulo di Sopron, le figureumane sono triangolari ma gli animali (cavalli) sono raffigurati con lo stilema bitriangolare (30).Il tema della caccia allo stambecco, ben presente sia adAussois che sulla Roccia degli Stambecchi all'ArcelleNeuve (Lanslevillard), pare una peculiarità dell' arterupestre dell' area occidentale delle fasi centrali dell' etàdel Ferro, mentre in quella centro-orientale (Valcamonica,Salisburghese) è assai più diffusa, in tutte le fasi, la caccia al cervo (31). Le modalità dell' attività venatoria nell'arte camuna sono comunque le medesime: il cacciato-
re, quando appare, è armato di lancia; più spesso si trovano solo i cani ad inseguire cervi maschi forniti di unpossente palco, a testimonianza che erano cacciati solocervi adulti in età da riproduzione; rarissima la presenzadi cacciatori armati di arco, più spesso impegnati nell'inseguimento di camosci (come a Seradina r. 12) o in atteggiamento di corsa (Foppe di Nadro r. 23).La tarda età del Ferro è testimoniata in Val di Susa darappresentazioni di hellebardenaxt (ascia-alabarda),un' ascia a largo tranciante, ben presente nell' arte rupestrecamuna della tarda e finale età del Ferro (soprattutto nell'area di Naquane e Paspardo). In Valcamonica abbiamoentrambe le varianti di questo tipo d'ascia: quello a tagliodiritto, più antico, attribuibile al III sec. a.c. ed incisosempre a martellina, e quello a taglio semilunato, più recente (I sec. a.c. - I sec. d.C.), istoriato utilizzando latecnica del graffito (32). Anche in Val di Susa sono presenti le due varianti.Sia l'Alta Mariana (Lac de Sollieres) che la Val Cenischiae la Val di Susa presentano numerose raffigurazioniantropomorfe, spesso armate, attribuibili alla fine dell'etàdel Ferro: si tratta di figure a linea di contorno, pressochéidentiche a quelle attribuibili allo stile IV 5 camuno (ades. Dos Sottolaiolo, In Valle e altre aree di Paspardo) (33).Spesso il busto è caratterizzato da decorazioni a croceche rappresentano decorazioni su armature o i lacci deipettorali. In questa fase l'armamento tende ad impoverirsi progressivamente fino a ridursi a spada e scudo rettangolare.Per quanto concerne le impronte di mani e di piedi benpresenti in quasi tutte le aree nelle Alpi occidentali(Aussois, Sollières, fino al recente riconoscimento delleincisioni della Valle dell' Albedosa), esse sono attribuibiliall'età del Ferro, come mostrano le associazioni con lefigure di guerrieri ed i confronti con l'arte rupestre camunadove il tema è ben attestato a partire dalla fase IV 2 (VIIVI sec. a.c.) (34). In Valcamonica le figurazioni di mani
39
Haute Maurienne, Roccia degli Stambecchi: scena di caccia allo stambecco con guerriero armato di lancia e cane, media età del Ferro
sono assai rare, mentre i pediformi ripetono la forma delle suole o gli intrecci dei calzari. La piccola dimensionedei pediformi camuni avvalora l'ipotesi che le impronterappresentino piedi o calzari di fanciulli, eseguiti probabilmente in occasione delle prove di iniziazione della gioventù aristocratica e guerriera. Si spiegherebbero cosìanche le associazioni che sembrano riguardare semprel'ambito degli armati.Come si è visto la tradizione rupestre camuna risulta certamente importante per i confronti instaurabili con quella
Il () _
di altre aree con incisioni e pitture. Anche se l'arte rupestreha in ogni zona modalità espressive e peculiarità proprie,dall'analisi effettuata risulta indubbio che vi siano connessioni tra l'area alpina occidentale e quella centro-orientale, sia negli stili che nelle tematiche, e questo appareevidente in quasi tutti i periodi. Queste comparazioni sonoperciò importanti al fine di una miglior comprensione delfenomeno "arte rupestre" nell' arco alpino e sottolinea uncollegamento "culturale" insospettabile per tempi cosìremoti.
Valcamonica, Seradina roccia 12: scena di caccia al cervo con guerriero a cavallo armato di lancia e cane, prima età del Ferro
1- Assai dubbie le figurazioni a polissoir rinvenute a Mezzarro e secondo ilPriuli da considerarsi paleolitiche. Si veda PRIUU A., 1985. Incisioni Rupestridella Valcamonica, Ivrea.2 - SEGUE D., RICCHIARDI P., 1980. Recenti scoperte diflgure zoomorfesubnaturalistiche in Val Germanasca, in Studi di archeologia dedicati a PieroBarocelli, Soprintendenza Archeologica del Piemonte, pp. 21-26, Torino.3 - Allo stato attuale delle ricerche le figure risultano infatti irreperibili. Vennero pubblicate da BURGSTALLER E., 1972. Felsbilder in Osterreich,Landesinstitutfur Heimatpflege und Volksbildung, Linz.4 - A proposito si vedano: FERRARIO c., 1992. Leflgure di oranti schematicinell'arte rupestre della Valcamonica, in Appunti, 19, pp. 4 I-44, Breno. FOSSATI A., 1992. Alcune rappresentazioni di "oranti" schematici armati del
Bronzo Finale nell'arte rupestre della Valcamonica, in Appunti, 19, pp. 4550, Breno. DE MARINIS R., 1992. Problemi di cronologia dell'arte rupestredella Valcamonica, in XXVI/I Riunione Scientifica dell'IIPP, XXVIII, pp. 169
195.5 - BLAIN A., 1975. Des gravures sur les menhirs du Chemin des CollinesSion, Valais, Suisse, in BCSP, XII, pp. 154-156.6 - FRONTINI P., 1994. Borno I, in Le Pietre degli Dei. Menhir e Stele del·l'età del Rame in Valcamonica e Valtellina, a cura di S. CASINI, pp. 192- I97,
Bergamo.7 - FOSSATI A, 1994. Le rappresentazioni topograflche, in Le Pietre degliDei. Menhir e Stele dell'età del Rame in Valcamonica e Valtellina, a cura diS. CASINI, pp. 89-91, Bergamo. e ARCA' A., 1995. Vite incisioni
41
topograjie/le: primafase dell'arte rupestre camuna, NAB2 in stampa8 - MANO L., 1995.1pastori del Monte Bego, in Sui sentieri dell'arte rupestre,a cura di A. ARCA' - A. FOSSATI, pp. 17-24, Torino.9 - Ma BELTRAN LLOR[S M., 1972. Los grabados rtlpestre de Bedolina, inBCSP, 8, Capo di Ponte, ritiene la mappa di Bedolina di fasi tardi dell'età delBronzo.IO - NEHL G., 1980. Aperçu sur l'art rupestre de Hallle-Maurienne (73), inLes Cahiers du GERSAR, 2, Milly-Ia-Foret.[[ - Si vedano le comparazioni possibili in JESUS SANCHES de M., 1993.Les abris peints de Serra de Passos (Nord du Portugal) dans l'ensemble del'art rupestre de cette région, in Les representations humaines du Neolitique al'Age du Fer, Actes du 115 congrés national des Sociétés Savantes, pp. 57-69,Paris, e BELTRAN A., 1979. Da cacciatori ad allevatori: l'arte rupestre delLevante Spagnolo, Milano.12 - MULLER A.-JORDAN M.-GASSEND J.M.,1991. Les gravurespréhistoriques de la vallée de l'Ubaye (environ du lac du Longet et des modalitésdu peuplement de la zone intra-alpine, in Le Mont Bego, une montagne sacréede l'Age du Bronze, Tende e ARCA' A., 1995. Tra Piemonte e Valli d'Oc, inSui sentieri dell'arte rupestre, a cura di A. ARCA' e A. FOSSAT[, pp. 32-38,Torino.13 - FOSSAT[ A., [994. Lejigure antropomorfe, in Le Pietre degli Dei. Menhire Stele dell'età del Rame in Valcamonica e Valtellina, a cura di S. CASINI, pp.[27-130, Bergamo.[4 - CASINI S. - ODONE S., 1994. I motivi pettiniformi, in Le Pietre degliDei. Menhir e Stele dell'età del Rame in Valcamonica e Valtellina, a cura di S.CASINI, pp. 109-[ 14, Bergamo.15 - Ma di diverso parere sono ROSS[ M. - P. MICHELETfA, 1980. La Pera dijCros del vallone di Dondogna (Val Chiusella) alla luce delle più recenti ricerche, in Bullettin d'Etudes préhistoriques alpines, voI. XII, pp. 89-116, Aosta.16 - Per l'area di Mompantero si veda: A. ARCA', 1992. Incisioni e pitturerupestri in Valle di Susa. Documentazione e progetti di studio, Comunicazionein occasione del Convegno "Archeologia e arte rupestre in Vallecamonica enell' Arco Alpino", Breno, Giugno 1992, Torino. TON[N[ Y., 1993. Graffiti.Segnalazione di ritrovamenti. Pendice est del Rocciamelone (Val di Susa), inSegusium, 33, 1992, Susa. FOSSAT[ A. - A. ARCA', 1993. Nuove pitturerupestri in Val di Susa, in Survey, V-VI, 7-8, pp. 135- 140, Pinerolo.17 - SHEE-TWOHIG E., 1981. The Megalithic Art ofWestern Europe, Oxford.
18 - Gomez Varela le ritiene per epipaleolitiche. Si veda GOMEZ VARELA,1989. A Mais antiga representaçao de equus do Vale do Tejo, in Almansor, 7,Montemor-o-Novo.19 - DE LUMLEY H., 1992. Le Mont Bego, Valles des Merveilles et deFontanalba, Guides Archeologiques de la France, Paris.20 - FOSSAT[ A. - RUGG[ERO G., in c.s., L'antica età del Bronzo nell'arterupestre della Valcamonica, in L'antica età del Bronzo in Italia, Atti del Congresso, Viareggio.21 - TOGNONI E., 1995.lliscioni del Benaco, in Sui sentieri dell'arte rupestre,a cura di A. ARCA' e A. FOSSATI, pp. 150- 157, Torino.22 - FOSSAT[ A. - RUGG[ERO G., in c.s.23 - Per Warburg eZuschen si veda: GNTHER K., 1990. Neolitische Bildzeichenan einelll ehemaligen Megalithgrab bei Warburg, Kreis Hxter (Westfalen), inGermania, 68; per Escoural: GOMEZ VARELA M., 1989. Arte rupestre econtexto arqueologico, in Almansor, 7, Monlemor-o-Novo.24 - FOSSATI A., 1992.25 - FOSSATI A., 1992.26 - GOMEZ de SOTO J., 1993. "Pictogrammes", jigurations anthropomorphes et zoomorphes sur les cramiques de lajin de l'Age du Bronze, unerévision, in Les representations humaines du Neolitique a l'Age du Fer, Aclesdu 115 congrés national des Sociétés Savantes, pp. 149-164, Paris.27 - BALLET F. - RAFFAELLI P., 1993. Les gravures rupestres anthropomorphes de Savoie: volution de la représentation humaine du Néolitique l'Agedu Fer, in Les représentations humaines du Neolitique a l'Age du Fer, Actes du115 congrés national des Sociétés Savantes, pp. 181-196, Paris.28 - FOSSATI A., 1991. L'età del Ferro nelle incisioni rupestri della Valcamonica, in AA.VV, Immagini di una aristocrazia dell'età del Ferro nell'arte rupestre camuna, Contributi in occasione della mostra, pp. 11-71.29 - FOSSAT[ A., 1991.30 - DOBIAT C., 1982. Menschendarstellungen auf ostalpiner Hallstattkeramik. Eine Bestandaufnahme, in Acta Archaeologica AcademiaeScientiarwn Hungaricae, 34, pp. 279-322.31 - BALLET F. - RAFFAELLI P., 1993.32 - DE MAR[N[S R., 1988. Le popolazioni alpine di stirpe retica, in ItaliaOmniulII terrarulll alwnna, a cura di P. CARRATELLI, Milano.33 - FOSSATI A., 1991.34 - FOSSATI A., 1991.
Bibliografia essenziale
AA. Vv., 1987. Arte rupestre nelle alpi Occidentali, CahiersMuseomontagna, 55, Torino.
AA. Vv., 1991 a. Le Mont Bego. Une Montagne Sacrée de l'Age duBronze, préactes du Colloque, 5-11 luglio 1991, Tende.
AA.VV., 1991b. Immagini di una aristocrazia dell'età del Ferronell'arte rupestre camuna, Contributi in occasione della mostra,Milano.
AA. Vv. , 1992. L'arte in Italia dal Paleolitico all'età del Bronzo.Atti della XXVIII Riunione Scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze 20-22/11/1989, Firenze.
AA.VV., 1994. Le Pietre degli Dei. Menhir e stele dell'età del Ramein Valcamonica e Valtellina, a cura di S. Casini, Bergamo.
AA. Vv., 1995. Sui sentieri dell'arte rupestre, a cura di A. Arcà edA. Fossati, Guide del Centro di Documentazione Alpina, Torino.
ANATI E., 1975. Evoluzione e stile nell'arte rupestre camuna, Archivi 6, Capo di Ponte.
ANATI E. , 1982. I Camuni. Alle radici della civiltà europea,Milano.
BALLET F-RAFFAELLI P., 1990. Rupèstres. Roches en Savoie.Gravures, peintures, cupules, Chambery.
BICKNELL c., 1971. Guida delle Incisioni Rupestri Preistoriche
nelle Alpi Marittime italiane. Traduzione italiana dell'edizione originale inglese (1913), Istituto Internazionale di Studi Liguri,Bordighera.
CONTI C., 1972. Corpus delle incisioni rupestri del Monte Bego,
zona I, Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera
DAUDRY D., 1982. Art rupestre de la Vallée d'Aoste, CahiersMuseomontagna, 19, Torino.
130
DE LUMLEY H., 1992. Le Mont Bego. Vallées des Merveilles et deFontanalba, Guides archéologiques de la France, Paris.
DE LUMLEY H., 1995. Le grandiose et le sacré, Aix en Provence.
GAMBARI F M., in stampa. L'arte rupestre in Piemonte: cenni di
analisi stilistica e cronologica, in Atti del Convegno "Archeologia earte rupestre in Vallecamonica e ne]]' Arco Alpino", Breno, Giugno1992, Bergamo.
GRAZIOSI P., 1973. L'arte preistorica in Italia, Firenze.
GRUPPO RICERCHE CULTURA MONTANA, 1990. La pietra e ilSegno in valle di Susa, a cura di Andrea Arcà, Susa.
ROSSI M. et al., 1989. L'orante neolitico: problematica e
metodologia di studio, in Antropologia Alpina Annual Report, pp.100-141, Antropologia Alpina, Torino.
SCHWEGLER U., 1992. Schalen und Zeichensteine der Schweiz,Società Svizzera di Preistoria e Archeologia, Basel.
Bibliografia specifica
In cima al pascolo
BALDI R., 1992. Antropomorfi schematici in Valle Grana (Cuneo),
in Survey 7-8, pp. 125-130, Pinerolo.
FERRARIO c., 1992. Lefigure di oranti schematici nell'arte rupestre
della Valcamonica, in Appunti 19, pp. 41-44, Breno.
FOSSATI A., 1994. Lefigure antropomorfe, in Le Pietre degli Dei.
Menhir e Stele dell'età del Rame in Valcamonica e Valtellina, a curadi S. Casini, pp. 127-130, Bergamo.
FOSSATI A., 1992. Alcune rappresentazioni di "oranti" schematiciarmati del Bronzo Finale nell'arte rupestre della Valcamonica, inAppunti 19, pp. 45-50, Breno.
ROSSI M.- MICHELETTA P., 1980. La Pera dij Cros del vallone diDondogna (Val Chiusella) alla luce delle più recenti ricerche, inBullettin d'Etudes préhistoriques alpines voI. XII, pp. 89-116, Aosta.
ROSSI M. et al., 1989. L'orante neolitico: problematica emetodologia di studio, in Antropologia Alpina Annual Report, pp.
100-141, Antropologia Alpina, Torino.
6000 anni sulla roccia
ARCA' A., 1995. Tra Piemonte e Valli d'Oc, in Sui sentieri dell'arterupestre, a cura di A. Arcà e A. Fossati, pp. 32-38, Torino.
DE MARINIS R., 1994. La datazione dello stile III A, in Le Pietredegli Dei. Menhir e Stele dell'età del Rame in Valcamonica eValtellina, a cura di S. Casini, pp. 69-87, Bergamo.
MULLER A.-JORDA M.-GASSEND J.M., 1991. Les gravurespréhistoriques de la vallée de l'Ubaye (environ du lac du Longet) etles modalités du peuplement de la zone intra-alpine, in Le Mont Bego,
une montagne sacrée de l'Age du Bronze, préactes du Colloque, 5lI-luglio 1991, Tome I pp. 155-161, Tende.
Pitture alla Rocca
GAMBARI F. M., 1991. Le incisioni rupestri di Montaldo: analisiculturale ed ipotesi di interpretazione, in Montaldo di Mondovì. Un
insediamento protostorico. Un castello, a cura di E. Micheletto e M.Venturino Gambari, QSAP Monografie, l, pp. 29-34, Torino.
GAMBARI F.M., 1992. Le pitture rupestri della Rocca di Cavour
(TO) e le influenze mediterranee nell'arte rupestre dell'Italia nord
occidentale, in Atti della XXVIII Riunione Scientifica dell 'IstitutoItaliano di Preistoria e Protostoria, L'arte in Italia dal Paleolitico
all'età del Bronzo, 20-22/11/1989, pp. 385-396, Firenze.
SEGLIE D.- RICCHIARDI P.- CINQUETTI M., 1988. Pitture
rupestri preistoriche nel Parco Regionale Rocca di Cavour, in Survey
3-4, pp. 40-42, Pinerolo.
La Roccia della Fata
ARCA' A., 1992. La roccia 13 di Vite, Paspardo: elementi per unarchivio di archeologia rupestre, Appunti, 19, pp. 25-31, Breno.
BICKNELL c., 1971. Guida delle Incisioni Rupestri Preistoriche
nelle Alpi Marittime italiane. Traduzione italiana dell'edizione ori
ginale inglese (1913), Istituto Internazionale di Studi Liguri,
Bordighera.
PONS S., 1938. Preistoria valdese: di un antico disegno a calcinadella Valle Germanasca (Alpi Cozie) e di alcune ricerche affini, in
Bollettino della Società di Studi Valdesi, 70, pp. 3-17, Torre Pellice.
SEGLIE D.-RICCHIARDI P., 1988. Pitture rupestri di Ponte Rautin Val Germanasca, in Survey 3-4, pp. 71-73, Pinerolo.
Alle falde del Rocciamelone e Arcieri a cavallo
ARCA' A. 1990. Arte rupestre in Valle di Susa e Alta Moriana: re
centi scoperte e sviluppo delle ricerche, in Survey, 6, pp. 167-175,
Pinerolo.
ARCA' A., Incisioni e pitture rupestri in Valle di Susa. Documentazione e progetti di studio, comunicazione per il Convegno. "Ar
cheologia e arte rupestre in Vallecamonica e nell'Arco Alpino",
Breno, Giugno 1992.
BALLET F.- RAFFAELLI P. , 1990. Rupèstres. Roches en Savoie.
Gravures, peintures, cupules, Chambery.
BALLET F. - RAFFAELLI P., 1994. Les gravures rupestres anthro
pomorphes de Savoie: evolution de la représentation humaine du
Néolitique à l'Age du Fer, in Les représentations humaines du
Neolitique a l'Age du Fer, Actes du 115 congrés national des Sociétés
Savantes, pp. 181-196, Paris.
BIANCHI BANDINELLI R. - GIULIANO A., 1973. Etruschi ed
Italici prima del dominio di Roma, Milano.
131
FOSSATI A.-ARCA' A., 1992. Nuove pitture rupestri in Valle di
Susa, Survey 7-8, pp. 135-139, Pinerolo.
LAGRAND C. - THALMANN J. P., 1973. Les habitats
protohistoriques du Pegue (Drome). Le sOl/dage 1/. 8, in Cahiers du
Centre de Documentation de la Préhistoire Alpine, 2, Grenob1e.
NEHL G. 1980. Spirales et selpentijormes, in Aperçu SUI' l'art
rupestre de l'Haute Maurienne, Les Cahiers du GERSAR, N°2, pp.
27-32, Milly La F6ret.
ROSSI M., 1994. Une probable scène biblique panni les petroglyphes
du Rochemelon, in Bulletin du GERSAR 39, pp. 35-43, Milly La
F6ret.
TONINI v., 1993. Graffiti. Segnalazione di ritrovamenti. Pendice
est del Rocciamelone (Val di Susa), in Segusium, 33, 1992, Susa.
VAN BERGH OSTERRIETH M., 1974. Haches de lafin du deuxième
age du Fer a Naquane (Valcamonica): representations filiformes de
roches n. 62 et 44, "in BCSP Il, pp. 85-117, Capo di Ponte.
I Cervi al Castello
NEHL G., 1980. Aperçu SUI' l'art rupestre de l'Haute Maurienne, In
Les Cahiers du GERSAR, W2., pp. 13-18, Milly La F6ret.
Passaggio a nord: L'Alpe Veglia
GUERRESCHI A. - GHIRETTI A. - GAMBARI F. M., 1992.
Archeologia all'Alpe Veglia, in Le Rive, 4/5, pp. 33-46, Omegna.
Finito di stampare per i tipi della«Artigrafiche CORALL» - Boves
Settembre 1995





















![10.000 ans avant “L’Art du contour” [art rupestre Qurta/Qurta rock art]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63126d9dc32ab5e46f0bf782/10000-ans-avant-lart-du-contour-art-rupestre-qurtaqurta-rock-art.jpg)