Ecclesia de Eucharistia vivit. Riflessione tomista sull'enciclica di Giovanni Paolo II
BISANTI - Paolo Diacono. Profilo bio-bibliografico
Transcript of BISANTI - Paolo Diacono. Profilo bio-bibliografico
Paolo Diacono Profilo bio-bibliografico
Appunti delle lezioni del corso di Letteratura Latina Medievale
(Modulo 2) Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Antichità
Anno accademico 2012-2013 (prof. Armando Bisanti)
2
1. Cenni sulla Rinascita carolingia (VIII-IX sec.) Nel regno franco, dopo la deposizione dell’ultimo re della dinastia dei Merovingi, prende il
potere Pipino il Breve, padre di quel Carlo (poi Carlo Magno) cui si deve l’edificazione del Sacro Romano Impero e, per quello che più qui ci riguarda, il fondamentale impulso dato alla scuola e agli studi. Carlo allargò infatti notevolmente i confini del regno ereditato dal padre, sconfiggendo i Lon-gobardi in Italia, respingendo gli Arabi da gran parte della Spagna, combattendo contro gli Avari, i Sassoni, i Bavari, gli Slavi, i Danesi e proponendosi, in tutte le terre via via conquistate, come un paladino della Chiesa e della fede cristiana (immagine, questa, che perdurerà nell’immaginario col-lettivo fino alle chansons de geste in lingua d’oïl, di almeno tre secoli successive ai fatti narrati). Nella notte di Natale dell’800 papa Leone III lo incoronò a Roma imperatore dei Romani e fondato-re del Sacro Romano Impero, ideale discendente dall’Impero Romano, non solo per la forza politica e militare ma anche per l’intensa e capillare organizzazione culturale.1
Carlo Magno (che era poco più che analfabeta) si rendeva infatti perfettamente conto della importanza degli studi e del valore dei classici, della loro conservazione e dell’insegnamento da essi impartito. In questo, l’imperatore fu validamente coadiuvato da Alcuino di York, il principale pro-motore della cosiddetta “Rinascita carolingia”, il quale, valendosi a sua volta di numerosi collabora-tori, promosse una intensa attività di studio, lettura, trascrizione dei classici latini (utilizzando la scrittura “minuscola carolina” che rendeva tale opera di trascrizione molto più rapida e sicura che in passato), fondando la cosiddetta Schola Palatina, cioè la scuola del palazzo imperiale, cui conven-nero dotti da ogni parte di Europa, dall’Italia (Pietro da Pisa, Paolo Diacono, Paolino da Aquileia), dalla Francia (Angilberto), dall’Inghilterra e dall’Irlanda (lo stesso Alcuino, Dicuil e Dungal), dalla Spagna (Teodulfo).
Sotto questo punto di vista, il sec. IX è infatti (insieme al XII) il più ricco di autori e di ope-re. Tutti i generi vengono trattati, sia quelli poetici (didattica, satira, lirica, poema) che quelli prosa-stici (didattica, teologia, agiografia, biografia, storiografia). Vengono inoltre fondati importanti mo-nasteri, destinati a divenire centri propulsori di cultura (Civate, Nonantola), mentre vengono restau-rati altri monasteri, già preesistenti, nei ducati longobardi (Farfa, Montecassino), vengono aperte importanti scuole, anche in Italia (si pensi alla scuola di Pavia). Si cerca di “restaurare” il latino classico (dopo gli “oscuri” – o presunti tali – secc. VII e VIII), si rimettono in onore gli studi classi-ci, si raccolgono libri dispersi, si costituiscono biblioteche ed officine di scrittura. Gli stessi scrittori gravitanti attorno alla corte di Carlo Magno sono consapevoli del loro ruolo e della “rinascita” da loro promossa: Modoino, per esempio, afferma che Aurea Roma iterum renovata renascitur orbi, mentre Angilberto dice che Carlo intendeva rinnovare la sapienza degli antichi (ut veterum renovet studiosa mente sophiam). Fra l’altro, questa idea della renovatio della classicità pagana è testimo-niata dal fatto che la maggior parte degli scrittori di quest’epoca si attribuisce uno pseudonimo trat-to dal nome di un autore antico: Nasone (Modoino), Omero (Angilberto), Flacco (Alcuino); abbia-mo inoltre notizia di un Marone (che non è possibile identificare), mentre altri scrittori assumono nomi tipici della tradizione bucolica (Tirsi, Menalca, Coridone) o nomi biblici (Paolino di Aquileia volle chiamarsi Timoteo, e lo stesso imperatore assunse il nome di Davide). La cultura professata dai dotti dell’epoca è essenzialmente latina, pur non mancando elementi di cultura greca ed ebraica, i classici più studiati sono ovviamente Virgilio, Orazio e Ovidio, ma non mancano gli autori meno noti e meno rappresentati, come Persio, Cicerone, Giovenale, Lucano e così via.
1 Sull’argomento la bibliografia è, ovviamente, sterminata (come si dice sempre in tali occasioni). Per un qua-
dro generale del periodo (soprattutto per quel che attiene all’organizzazione e alla diffusione della cultura), cfr. almeno I problemi della civiltà carolingia. Atti della I Settimana di Studio del CISAM (Spoleto, 26 marzo-1° aprile 1953), Spole-to 1954; D. BULLOUGH, The Age of Charlemagne, London 1965; P. GODMAN, Poetry of the Carolingian Renaissance, London 1985; D. BULLOUGH, Carolingian Renewal: Sources and Heritage, Manchester 1991; Rosamond MCKITTER-
ICK, The Carolingian and the written World, Cambridge 1989; EAD., Carolingian Culture. Emulation and Innovation, Cambridge 1994; M. LAPIDGE, Il secolo VIII, in Letteratura latina medievale (secoli VI-XV). Un manuale, a cura di Cl. Leonardi [et alii], Firenze 2002, pp. 41-73; P.Chr. JACOBSEN, Il secolo IX, ivi, pp. 75-158 (entrambi i capp. contengono ampie appendici bibliografiche).
3
La quantità degli scrittori di quest’epoca, come si è detto, è molto ampia e varia. Per como-dità di trattazione, in genere si distinguono gli autori fra i letterati della prima generazione carolin-gia (diretti collaboratori di Carlo Magno: Pietro da Pisa, Paolo Diacono, Paolino di Aquileia, Alcui-no di York, Angilberto di Saint-Riquier, Teodulfo d’Orléans, gli irlandesi Dicuil e Dungal) e i lette-rati della seconda e della terza generazione carolingia (vissuti in genere sotto i discendenti di Carlo Magno, da Ludovico il Pio a Lotario, da Carlo il Calvo a Carlo il Grosso: Eginardo, Floro di Lione, Rabano Mauro, Walahfrido Strabone, Godescalco d’Orbais, Lupo di Ferrières, Sedulio Scoto, Inc-maro di Reims, e così via).
Fra i maestri della prima generazione, il primo posto spetta, cronologicamente, agli italiani: Pietro da Pisa († ca. 799), Paolo Diacono (ca. 720 - ca. 799) e Paolino di Aquileia († 802). Cono-sciuto da Carlo in occasione della presa di Pavia del 774, il diacono Pietro da Pisa era già da tempo maestro di grammatica nella scuola dell’ultimo re longobardo, Desiderio. L’imperatore lo portò con sé in Francia, ove Pietro strinse rapporti con Alcuino e con altri letterati della sua generazione. Egli fu il primo insegnante di grammatica alla corte di Carlo e compose una Ars grammatica molto sem-plice e chiara, nonché alcune epistole poetiche.
Dopo Pietro da Pisa e Paolo Diacono (del quale si dirà con ampiezza nel prosieguo di queste pagine), il terzo grande maestro italiano vissuto alla corte di Carlo è Paolino di Aquileia, nato in Italia intorno al 730 e passato quindi al servizio dell’ imperatore ad Aquisgrana, in qualità di mae-stro di grammatica, nominato nel 787 arcivescovo del Friuli, attivo nella polemica contro l’eresia adozionistica sostenuta da Felice vescovo di Urgel (a questo scopo egli compose il suo Libellus sa-crosyllabus contra Elipandum), autore della Regula Fidei (poemetto in esametri sul mistero della Incarnazione di Cristo), il Liber exhortationis (scritto per il marchese Erico del Friuli, un trattato in 66 capitoli che si configura come uno dei primi specula principis della letteratura medievale) e va-rie poesie (ricordiamo gli inni sul Natale, la Pasqua, la Resurrezione, la Purificazione di Maria e il planctus sulla morte di Erico, i Versus de Herico duce).
2. Paolo Diacono. Vita e opere 2.1. Vita Paolo di Warnefrido, detto Paolo Diacono, nacque a Cividale poco dopo il 720 (l’esatta data
di nascita è sconosciuta) da una famiglia longobarda stanziata nel Friuli.2 Suoi genitori furono, ap-punto, Warnefrido e Teodolinda, mentre fra i suoi fratelli si ricorda (anche per l’importanza che eb-be nella vita e nello stesso “destino” di uomo e di scrittore di Paolo), Arechi (o Arichi, del quale si dirà fra breve).
Egli trascorse la propria giovinezza presso la regione di Cividale, che ricorderà sempre con affetto e anche con precisione topografica e onomastica nella sua opera (cfr., per es., Hist. Lang. IV
2 Nella stesura del presente profilo bio-bibliografico di Paolo Diacono (che non riveste evidentemente alcuna velleità scientifica né tende ad alcuna originalità, ma è rivolto essenzialmente agli allievi dei corsi di Letteratura Latina Medievale e di Letteratura Latina Medievale e Umanistica da me svolti, durante l’anno acc. 2012-2013, presso la Facol-tà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Palermo), mi sono giovato principalmente – e talvolta abbondan-temente – dei seguenti contributi generali sullo scrittore longobardo: A. VISCARDI, Le Origini, Milano 1950, pp. 22-33; Cl. LEONARDI, Paolo Diacono e la civiltà altomedievale, in PAULI DIACONI Historia Langobardorum, a cura di M. Fe-lisatti, nuova ed. rivista da L. Tenconi - R. Cassanelli, Milano 1985, pp. 9-26 (poi, col titolo Paolo Diacono: tradizione germanica e cristiana, in Cl. LEONARDI, Medioevo latino. La cultura dell’Europa cristiana, a cura di Fr. Santi, Firenze 2004, pp. 219-236); F. BERTINI, Letteratura latina medievale in Italia (secoli V-XIII), Busto Arsizio (VA) 1988, pp. 46-48; Cl. LEONARDI, La figura di Paolo Diacono, in Paolo Diacono e il Friuli altomedievale (secc. VI-X). Atti del XIV Congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo (Cividale del Friuli - Bottenicco di Moimacco, 24-29 settembre 1999), Spoleto 2001, pp. 13-24 (poi rist. in Cl. LEONARDI, Medioevo latino, cit., pp. 237-247); M. LAPIDGE, Il secolo VIII, cit., pp. 61-64. Ho anche tenuto presenti (soprattutto nella parte dedicata alla presentazione e all’illustrazione delle singole opere) l’informata rassegna di V. SIVO, Studi recenti su Paolo Diacono, in «Quaderni Medievali» 52 (2001), pp. 260-275; e il repertorio bio-bibliografico allestito da Benedetta VALTORTA, Clavis Scriptorum Latinorum Medii Aevi. Auctores Italiae (700-1000), Firenze 2006, pp. 196-219. La principale bibliografia sulle singole opere sarà, comunque, via via citata nelle pagine seguenti (ma, in ogni modo, cfr. l’ampia – anche se certo non esaustiva – bibliografia genera-le e specifica in appendice a questo scritto).
4 37, il celebre, lunghissimo capitolo dedicato alla storia della propria genealogia e alle avventurose vicende dell’avo Lopichis, giunto in Italia in seguito alla disastrosa invasione degli Avari). Di Civi-dale egli mostra, addirittura, di conoscere mirabilmente e precisamente vie, strade, luoghi e nomi di persone (cfr. Hist. Lang. V 17): «E del resto –scriveva Antonio Viscardi – le memorie dei luoghi in cui ha vissuto nei primi anni, rievoca Paolo con abbondanza e freschezza, con un senso nostalgico, ancora nella sua vecchiaia, quando, nel silenzio di Montecassino, attende all’opera sua maggiore».3
Particolarmente vicino al ducato cividalese (si pensi al racconto, particolareggiato e infor-mato, delle vicende del tempo del duca Pemmone, delle sue vittorie e del conflitto col patriarca di Aquileia, in Hist. Lang. VI 26, 45, 51), egli ricevette, fin dai primi anni, un’ampia e articolata for-mazione culturale. Studiò, infatti, a Pavia alla scuola del grammatico Flaviano, erede e continuatore, presso la corte longobarda, di quel grammatico Felice che, come narra lo stesso Paolo (Hist. Lang. VI 7), era stato onorato di preziosi donativi da parte di re Cuniperto, in riconoscimento della gran-dezza e dell’importanza del suo magistero. È probabile inoltre che, alla scuola di Flaviano, egli ab-bia appreso (oltre alle arti liberali e allo studio dei classici latini e, ovviamente, della Bibbia) anche il greco o, almeno, che abbia ricevuto alcuni rudimenti di quella lingua (come sembra emergere dal-la versione latina di un epigramma dell’Anthologia Palatina, del quale si dirà nel paragrafo dedicato ai carmina, 2.2.1): fatto, questo, molto importante e significativo, in una zona e in un periodo stori-co nei quali, ormai da gran tempo, gli studi greci erano largamente caduti in desuetudine.
Raggiunta la maturità, Paolo viene chiamato alla corte pavese in qualità di amico e consi-gliere di Rachis (il terzultimo re dei Longobardi), benché non sia del tutto sicuro «se l’ingresso di Paolo Diacono nel mondo palatino con funzioni ufficiali abbia seguito immediatamente il periodo del suo discepolato» e «se la permanenza alla corte di Rachis sia stata continua, o se il nostro, prima o poi, sia stato qualche tempo in patria a svolgere un’attività ufficiale».4 In ogni modo, Paolo fa il suo ingresso nella gerarchia ecclesiastica sicuramente per decisione e volere del religiosissimo Ra-chis (che per un certo periodo abbandonò addirittura il potere regio per farsi monaco, ritornando pe-rò, qualche tempo dopo, alla propria funzione di sovrano dei Longobardi).
A tal proposito, il Chronicon Vulturnense ci dà una notizia (molto discussa dagli storici e dai biografi), secondo la quale Paolo avrebbe rivestito, per un certo lasso di tempo, la carica di arci-diacono della chiesa di Aquileia. È però da ritenersi – ammesso che la notizia fornita dal cronista sia attendibile e veritiera – che l’attività di Paolo Diacono presso la chiesa di Aquileia sia stata assolu-tamente marginale e debba essere considerata, tutt’al più, come una parentesi. Lo scrittore longo-bardo, in realtà, rimane legato, per gran parte della sua lunga e operosa vita, alla corte pavese. Il Tamassia, oltre un secolo fa, avanzò l’ipotesi che Paolo avesse fatto parte del clero palatino (prece-dentemente instaurato da re Liutprando):5 ipotesi, anche questa, sulla quale non tutti gli studiosi e i biografi si mostrano d’accordo, ma che ad alcuni – per es. al Viscardi – è sembrata «ben fondata: che cioè nel Palazzo il nostro sia stato, non solo come amico e privato consigliere di Rachis, ma proprio con funzioni ufficiali nella Cappella e nella Cancelleria».6 E ciò si giustificherebbe anche alla luce di un’ennesima testimonianza del Chronicon Vulturnense, nella quale, dopo l’accenno all’arcidiaconato aquileiese di Paolo di cui si è detto poc’anzi, si parla dello scrittore come del nota-rius di re Desiderio – l’ultimo sovrano longobardo – termine, questo, che sta a designare un ufficia-le della curia regia.
Comunque sia di ciò, divenuto famoso per le sue qualità umane e per la vastità e la varietà sua cultura (biblica, classica e cristiana), Paolo viene, a un certo punto, nominato precettore di Adelperga, figlia di Desiderio (e il prestigioso incarico la dice lunga, in verità, sulla considerazione di cui egli godeva da parte del sovrano), e la segue anche quando ella si reca a Benevento, per pren-dere in sposo il duca Arechi, corregionale di Paolo. Per lei, appunto a Benevento, scrisse nel 763 la
3 A. VISCARDI, Le Origini, cit., p. 22. 4 Ivi, p. 23. Cfr. anche A. ZANELLA, Cenni biografici su Paolo, in PAOLO DIACONO, Storia dei Longobardi, a
cura di Br. Luiselli - A. Zanella, Milano 1991, pp. 71-100 (in partic., pp. 72-75). 5 Cfr. N. TAMASSIA, Paolo Diacono. Discorso letto in Cividale del Friuli in occasione dell’XI centenario della
morte di Paolo Diacono, Cividale 1900. 6 A. VISCARDI, Le Origini, cit., p. 23.
5 sua prima opera, un carme sulle sette età del mondo (A principio saeculorum) in tetrametri trocaici ritmici, nel quale i versi iniziali delle dodici strofe di tre versi l’una formano l’acrostico Adelperga pia (cfr. par. 2.2.1).
Ancora per Adelperga scrisse quindi i 16 libri dell’Historia Romana (cfr. par. 2.2.7). Non è sicuro se l’opera sia stata composta a Pavia o a Benevento, cioè quando Adelperga era ancora nubi-le o quando, invece, si era già sposata con Arechi. In ogni modo, il periodo vissuto da Paolo a Be-nevento rimane come uno dei più felici della vita dello scrittore,7 che partecipa attivamente al fervo-re culturale della corte del duca, ricevendo, fra l’altro, da Arechi stesso l’incarico di comporre le iscrizioni metriche con le quali ornare il palazzo reale e la chiesa (significativo, fra questi compo-nimenti, l’epitaffio della regina Ansa, moglie di re Desiderio, per cui cfr. par. 2.2.1).
Ma la tragedia – come si suol dire in questi casi – era ormai alle porte. Gli ozi beneventani, infatti, furono bruscamente interrotti, nel 774, dalla caduta del regno longobardo a opera dei Franchi guidati da Carlo. Seguono, per Paolo anni difficili, oscuri e anche poco noti. Sappiamo con certezza che, nel 780, egli si trovava presso il monastero benedettino di Montecassino,8 nel quale era entrato sia per l’amarezza causatagli dalla catastrofe del suo popolo, sia, a quanto pare, in seguito a un pre-ciso decreto ingiuntivo di Carlo re dei Franchi. Suo fratello Arichi, infatti, aveva impugnato le armi al seguito di Rotgaudo duca del Friuli, che aveva organizzato una disperata ribellione – che Paolo stesso, secondo quanto opinato a suo tempo dal Monteverdi,9 aveva favorito – contro i Franchi con-quistatori. La battaglia decisiva fu combattuta sul Brenta nel 776, e in essa i capi della sollevazione perirono, mentre il fratello Arichi venne preso prigioniero e portato in Francia. I beni della famiglia, come avveniva sempre in casi come questi, furono confiscati e incamerati da Carlo. Nella quiete operosa – anche se talvolta sentita più come un esilio che come un otium – del chiostro cassinese, Paolo attese, fra l’altro, alla composizione di alcuni fra i suoi più giustamente celebri, sinceri e toc-canti carmi, per es. quello nel quale piange la sua nuova condizione di recluso, lontano dagli splen-dori delle corti pavese e beneventana (inc. Angustae vitae fugiunt consortia Musae: cfr. par. 2.2.1).
Ma Carlo, tornato in Italia nel 781, aveva dimostrato una certa clemenza nei confronti dei Longobardi vinti. Paolo, così, gli fece avere, attraverso Pietro da Pisa, un’epistola metrica Ad regem (inc. Verba tui famuli, rex summe, adtende serenus: cfr. par. 2.2.1), nella quale supplicava il sovra-no franco di liberare suo fratello e di restituire alla famiglia i beni confiscati. Non solo, ma nel 782 Paolo lascia il monastero cassinese e si reca di persona ad Aquisgrana, per implorare a viva voce, dal re, il perdono per il fratello.
I suoi desideri furono prontamente esauditi, ma, in contraccambio, egli fu in pratica costretto ad accogliere l’invito di Carlo rimanere stabilmente a corte, dove egli visse dal 782 al 786.10 Al suo arrivo, Pietro da Pisa lo accolse salutandolo, in versi retoricamente intonati e un po’ ampollosi, qua-le degno continuatore ed emulo dei grandi scrittori dell’antichità classica (Omero, Virgilio, Orazio, Tibullo), ebraica (Filone Alessandrino) e cristiana (Tertulliano: cfr. Versus Petri grammatici ad Paulum Diaconum, str. 5 Graeca cerneris Homerus, Latina Vergilius, / in Hebraea quoque Philo, Tertullus in artibus, / Flaccus crederis in metris, Tibullus eloquio), lodandolo, soprattutto, quale perfetto conoscitore della lingua greca (e proprio per questa sua distintiva prerogativa Paolo venne chiamato a corte, al fine di istruire ed educare nel greco i chierici palatini deputati ad accompagnare a Costantinopoli la figlia di Carlo, Rotruda, destinata in sposa al figlio dell’imperatore di Bisanzio (matrimonio, questo, che comunque non ebbe più luogo); si leggano, comunque, i seguenti versi di Pietro da Pisa: str. 10 Magnas tibi nos agamus, venerande, gratias, / qui cupis Graeco susceptos erudire tramite. / Quam non ante sperabamus, nunc surrexit gloria). Al carme di Pietro, Paolo ri-sponderà schermendosi e scrivendo, fra il serio e il faceto, che le eccessive lodi a lui tributate dal collega sono dette attraverso la maschera dell’ironia, ché egli non tiene a essere paragonato ai poeti pagani (Versus Pauli Diaconi ad Petrum grammaticum, str. 4-5 Dicor similis Homero, Flacco et Vergi-
7 Cfr. A. ZANELLA, Cenni biografici su Paolo, cit., pp. 76-78. 8 Ivi, pp. 78-82. 9 Cfr. A. MONTEVERDI, Paolo Diacono (abbozzo di un profilo), in «Memorie Storiche Forogiuliesi» 25 (1929),
pp. 1-14. 10 Cfr. A. ZANELLA, Cenni biografici su Paolo, cit., pp. 83-89.
6 lio, / similor Tertullo seu Philoni Memphitico, / tibi quoque, Veronensis o Tibulle, conferor. // Peream, si quenquam horum imitari cupio), ignora l’ebraico e, della lingua greca, conosce appena tre o quattro sillabe, imparate a scuola (str. 6 Graiam nescio loquellam, ignoro Hebraicam. / Tres aut quattuor in scolis quas didici syllabas); e aggiungendo, inoltre, che, se i chierici palatini deputati a scortare a Costantinopoli la figlia di Carlo proferiranno, una volta arrivati in quella città, quel poco di greco che egli potrà insegnare loro, allora saranno apertamente derisi e presi in giro (str. 10 Si non am-plius in illa regione clerici / Graecae proferent loquellae, quam a me didicerint, / vestri, mutis simi-lati deridentur statuis). Ma poi, come exemplum della propria (a suo dire scarsa, ma si tratta del classico procedimento retorico del topos modestiae) conoscenza del greco, egli fornisce un cospicuo saggio di traduzione latina di un epigramma della Anthologia Palatina (cui si è già accennato e del quale si tornerà a discorrere: cfr. par. 2.2.1).
La corrispondenza fra Paolo e Pietro da Pisa continuò anche negli anni successivi, dopo que-ste prime battute relative al 782, e si compone di parecchi testi (in genere poetici) di vario genere e, solitamente, di contenuto puramente letterario (dei veri e propri lusus intellettuali): proposte e solu-zioni di enigmi, interpretazioni di sentimenti e volontà del sovrano (da parte di Pietro, cui Paolo ri-sponde sovente mostrando capacità poetiche superiori a quelle palesate dal dotto amico e collega). Una corrispondenza, questa, che si configura certamente come «documento cospicuo della cultura italiana del sec. VIII e dell’oggetto e dei metodi dell’insegnamento letterario delle scuole d’Italia di cui Pietro è in quell’età insigne maestro».11
Negli anni compresi fra il 782 e il 786 Paolo non risiedette, però, sempre a corte, ma visitò gran parte della Francia, venendo a contatto coi ricordi legati alla figura e all’opera di Venanzio Fortunato (cui egli dedicherà un importante cap. e un epitaffio in Hist. Lang. III 13) e visitando, inoltre, diversi monasteri. Così per il vescovo Angilramno di Metz compose (nell’abbazia di San Martino) i Gesta episcoporum Mettensium (storia del cenobio dal primo vescovo, Clemente, fino al potente Crodegango, predecessore di Angilramno: cfr. par. 2.2.5); mentre per Adalardo di Corbie emendò un codice contenente una piccola raccolta di lettere di Gregorio Magno (come ci è testimo-niato da un’epistola di Paolo allo stesso Adalardo: cfr. par. 2.2.2).
A questo periodo risalgono probabilmente, secondo i più recenti studi, anche la redazione dell’Epitome del De verborum significatu di Pompeo Festo (cfr. par. 2.2.3) e l’Expositio dell’Ars minor di Elio Donato (cfr. par. 2.2.4), testi, entrambi, che si inseriscono nel quadro dell’attività che Paolo esercitò come collaboratore di Alcuino di York per coadiuvarne la politica di sviluppo e “ri-nascita” culturale.
Nel 787 Paolo fece ritorno a Montecassino, dove scrisse, in primo luogo, la Vita beati Gre-gorii papae, biografia di papa Gregorio I Magno (cfr. par. 2.2.9). Dietro richiesta di Carlo, Paolo raccolse quindi in un grande Homiliarium le prediche più celebri dai tempi di san Leone Magno a quelli del Venerabile Beda (cfr. par. 2.2.8).
E nella ritrovata quiete del chiostro, dopo aver dedicato i suoi ultimi anni alla stesura della sua opera di gran lunga più importante, l’Historia Langobardorum (cfr. par. 2.2.6), Paolo morì, or-mai vecchio (doveva avere almeno 75 anni, forse anche 77 o 78), negli ultimi anni dell’VIII secolo (la data tradizionale della sua morte è il 799, ma, come quella relativa alla nascita, non è una data assolutamente certa). Il suo epitaffio fu redatto da Ilderico,12 abate di Montecassino nell’834 e auto-re, anch’egli, di un’Ars grammatica strettamente legata, a quanto sembra, all’insegnamento paoli-no.13
11 A. VISCARDI, Le Origini, cit., p. 29. 12 Cfr. D. BIANCHI, L’epitafio di Ilderico e la leggenda di Paolo Diacono, in «Archivio Storico Lombardo»,
ser. VIII, 3 (1954-1955), pp. 56-115 13 Cfr. A. LENTINI, La grammatica d’Ilderico documento dell’attività letteraria di Paolo Diacono, in Atti del II
Congresso Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo (Grado - Aquileia - Gorizia - Cividale - Udine, 7-11 Settembre 1952), Spoleto 1953, pp. 217-240 (poi in ID., Medioevo letterario cassinese. Scritti vari, Montecassino 1988, pp. 451-476).
7
2.2. Opere
2.2.1. Carmina Come si è visto, Paolo scrisse poesie di vario genere durante tutto l’arco della sua vita. Fra i
generi poetici da lui praticati, si distinguono inni, epitaffi, iscrizioni, elogi, dediche, scherzi poetici, favole (queste ultime, però, ormai, si tende a non considerarle più autentiche) e composizioni di tipo “grammaticale”. Ci sono giunti anche componimenti indirizzati a Pietro da Pisa (e di Pietro a lui), dei quali già in parte si è detto.
La problematica attributiva riguardante i carmina paolini è molto complessa, soprattutto da quando, nel 1908, Karl Neff, sotto lo stimolo e la guida del suo maestro Ludwig Traube, pubblicò l’edizione critica dei carmi di Paolo che, ancor oggi, viene considerata di riferimento per la produ-zione poetica dello scrittore longobardo14 (edizione che era stata preceduta da un’altra, altrettanto autorevole, curata da Ernst Dümmler nel 1881).15
Lo status quaestionis riguardo alle problematiche attributive è stato, di recente, delineato con grande chiarezza e perizia filologica da Francesco Stella, in due distinti interventi.16 Sulla scia delle osservazioni e delle acquisizioni di Stella si è quindi posta, in tempi ancora più vicini a noi, Benedetta Valtorta, che, nella sua Clavis bio-bibliografica degli scrittori vissuti e operanti in Italia fra il 700 e il 1000, apparsa nel 2006,17 ha accordato a Paolo la paternità (pressoché sicura) di 30 componimenti poetici, rispetto ai 52 (41 + 11 in appendice) accolti, sia pur con non irrilevanti mar-gini di dubbio, dal Neff nella sua edizione del 1908.
Tali componimenti sono i seguenti:18 1. Ante fores basilicae (inc. Haec domus est Domini et sacri ianua regni), iscrizione per una
basilica nella quale la menzione (a v. 14) di Arichis spinge a proporne l’attribuzione a Paolo Diaco-no;
2. De speciebus praeteriti perfecti (inc. Post has nectit subsequentes in secunda specie), componimento di stampo “grammaticale” contenuto nel cod. Paris, Bibl. Nat., lat. 7530, importante compilazione di testi grammaticali, retorici e tecnici di vario genere, redatto a Montecassino fra il 779 e il 797 e accuratamente studiato da Louis Holtz nel 1975.19 Il ms. parigino, in particolare, pre-senta anche un altro componimento in versi di argomento “grammaticale” (inc. Adsunt quattuor in prima iunctione species), che però, secondo Ludwig Traube,20 deve attribuirsi non a Paolo Diacono, bensì a Pietro da Pisa;
3. De vino (inc. Pulchrior me nullus versatur in poculis unquam), breve componimento acrostico (le iniziali dei versi formano infatti il nome Paulus) in lode del vino;
4. Epitaphium Adheleidis (inc. Perpetualis amor capiendae et causa salutis), epitaffio di Adelaide, figlia di Pipino il Breve e sorella di Carlo, ancora visibile (insieme ad altre iscrizioni fu-nebri dettate da Paolo per personaggi della corte franca) nel 1549 nella cappella del monastero di Sant’Arnolfo di Metz;
5. Epitaphium Adheleidis filiae Karoli regis quae in Italia nata est, quando ipse eam sibi subegit (inc. Hoc tumulata iacet pusilla puellula busto), epitaffio per Adelaide (da non confondere
14 K. NEFF, Die Gedichte des Paulus Diaconus. Kritische und erklärende Ausgabe, München 1908 (cfr. la re-
cens. di A. CRIVELLUCCI, in «Studi Storici» 19 [1910], pp. 89-98). 15 E. DÜMMLER, Pauli Diaconi carmina, in MGH Poetae, 1, 1881, pp. 35-86. 16 Fr. STELLA, La poesia di Paolo Diacono: nuovi manoscritti e attribuzioni incerte, in Paolo Diacono. Uno
scrittore fra tradizione longobarda e rinnovamento carolingio. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Cividale del Friuli - Udine, 6-9 maggio 1999, a cura di P. Chiesa, Udine 2000, pp. 551-574; ID., Carmina, in P. CHIESA - Fr. STEL-
LA, Paulus Diaconus, in Te.Tra. 2. La trasmissione dei testi del Medioevo. Mediaeval Latin Texts and their Transmis-sion, vol. II, a cura di P. Chiesa - Lucia Castaldi, Firenze 2005, pp. 502-506.
17 Benedetta VALTORTA, Clavis, cit., pp. 196-219 (in partic., pp. 197-198). 18 Riproduco qui di seguito, con modifiche e abbreviazioni di vario genere, l’elenco stilato ivi, pp. 198-210. 19 L. HOLTZ, Le Parisinus Latinus 7530, synthèse cassinienne des arts libéraux, in «Studi Medievali», n.s., 16
(1975), pp. 97-152. 20 L. TRAUBE, Zu den Gedichten des Paulus Diaconus, in «Neues Archiv» 15 (1890), pp. 199-200.
8 con la precedente), figlia di Carlo e di Ildegarda, nata nel 774 negli accampamenti durante l’assedio di Pavia e morta ancora bambina, lontana dai genitori, durante un viaggio sul Rodano;
6. Epitaphium Arichis ducis (inc. Lugentum lacrimis populorum roscida tellus), epitaffio per Arichis, duca di Benevento e marito di Adelperga figlia di re Desiderio (di cui si è detto nel par. precedente), morto a Salerno il 26 agosto 787, all’età di 53 anni (l’epitaffio è stato attribuito a Paolo dall’autore del Chronicon Salernitanum);
7. Epitaphium Fortunati episcopi (inc. Ingenio clarus, sensu celer, ore suavis), epitaffio per il poeta e vescovo di Poitiers Venanzio Fortunato (535-600 ca.), trascritto anche all’interno di Hist. Lang. II 13;
8. Epitaphium Hildegardis filiae (inc. Hildegard, rapuit subito te funus acerbum), epitaffio per Ildegarda, figlia di Carlo, morta bambina il 9 maggio 783;
9. Epitaphium Hildegardis regina (inc. Aurea quae fulvis rutilant elementa figuris), epitaffio per Ildegarda, moglie di Carlo (da non confondersi con la figlia), morta durante il dodicesimo anno di matrimonio col sovrano, il 30 aprile 783, pochi giorni prima della figlia che portava il suo stesso nome;
10. Epitaphium Rothaidis filiae Pippini regis (inc. Hic ego quae iaceo, Rothaid de nomine dicor), epitaffio per la morte di Rotaide, figlia di Pipino il Breve e sorella di Carlo. Anch’esso, co-me quelli per la sorella Adelaide, per la moglie Ildegarda e per le figlie Adelaide e Ildegarda, era collocato nella cappella del monastero di Sant’Arnolfo a Metz;
11. Epitaphium Sophiae neptis (inc. Roscida de lacrimis miserorum terra parentum), epitaf-fio dedicato a una Sofia, probabilmente nipote dello stesso autore, scritto fra il 774 e il 787;21
12. In basilica Sanctae Mariae (inc. O una ante omnes felix pulcherrima virgo), iscrizione di incerta attribuzione;
13. In laude Larii laci (inc. Ordiar unde tuas laudes, o maxime Lari), componimento poeti-co fra i più giustamente celebri di Paolo, in distici elegiaci epanalettici, in lode del lago di Como (che viene descritto secondo le tecniche della descriptio loci e del locus amoenus), redatto verosi-milmente durante la prima fase dell’attività poetica dello scrittore longobardo;22
14. Super sepulcrum domnae Ansae reginae (inc. Lactea splendifico quae fulget tumba me-tallo), epitaffio in onore della regina Ansa, moglie di re Desiderio, composto fra il 774 e il 782;
15. Versus ad Petrum (inc. Candidolum bifido proscissum vomere campum), breve compo-nimento in cui Paolo risolve un enigma a lui proposta da Pietro da Pisa (nel carme Lumine purpureo dum sol perfunderet arva) e ne propone uno nuovo;23
16. Versus ad regem precando (inc. Verba tui famuli, rex summe, adtende serenus), la cele-bre supplica di Paolo a Carlo per il perdono e la liberazione del fratello Arechi, databile al 782 e in-tegralmente fondata sul topos della captatio benevolentiae;
17. Versus. Aemula Romuleis (inc. Aemula Romuleis consurgunt moenia templis); 18. Versus. Angustae vitae (inc. Angustae vitae fugiunt consortia Musae), in distici elegiaci,
tramandato adespoto nel ms. London, British Library, Harley 3685 (sec. XV), fu verosimilmente composto nella solitudine di Montecassino, dopo la disfatta del regno longobardo a opera dei Fran-chi e la successiva sconfitta dei ribelli, fra i quali il fratello Arechi;24
21 Sul componimento, cfr. M. GIOVINI, «Sophia» come «Daphnis», «Io» e «Alcimus». Risonanze classiche in
alcuni epicedi “al femminile” di Paolo Diacono, in «Maia», n.s., 49 (1997), pp. 111-118. 22 Il carme è uno dei più studiati di Paolo: cfr. almeno il saggio (a suo modo riepilogativo delle interpretazioni
precedenti) di M. GIOVINI, «Quel ramo del lago di Como» visto da Paolo Diacono, in «Maia», n.s., 49 (1997), pp. 119-128.
23 Sugli enigmi e gli scherzi poetici che Pietro da Pisa e Paolo Diacono erano soliti scambiarsi, cfr. lo studio di F. ERMINI, La poesia enigmistica e faceta di Paolo Diacono, in «Memorie Storiche Forogiuliesi» 25 (1929), pp. 97-110 (poi in ID., Medio Evo Latino. Studi e ricerche, Modena 1938, pp. 129-140).
24 Sul carme, cfr. M. GIOVINI, Gli «inculta poemata» di Paolo Diacono: Prudenzio e Virgilio in una dichiara-zione di «poetica del dissidio», in «Maia», n.s., 52 (2000), pp. 85-97; e A. BISANTI, Note e appunti di lettura su testi mediolatini, in «Filologia Mediolatina» 8 (2001), pp. 111-122 (alle pp. 111-114).
9
19. Versus. Christe salus (inc. Christe salus, utriusque decus, spes unica mundi), iscrizione (della quale si conservano soltanto i primi sette versi e l’inizio dell’ottavo) dettata da Paolo Diacono per la chiesa dei santi Pietro e Paolo edificata a Salerno dal duca Arichis;
20. Versus contra Petrum (inc. Iam puto nervosis religata problemata vinclis), seconda ri-sposta a un già ricordato componimento di Pietro da Pisa (Lumine purpureo dum sol perfunderet arva);
21. Versus de annis a principio (inc. A principio saeculorum usque ad diluvium), scritto nel 763 per Adelperga figlia di re Desiderio (della quale Paolo, come si è detto, era il precettore), esso è caratterizzato (come anche il breve De vino) dalla tecnica dell’acrostico (le iniziali dei versi forma-no infatti il sintagma Adelperga pia);
22. Versus de episcopis Mettensis civitatis quomodo sibi ex ordine successerunt (inc. Qui sa cra vivaci studio domicilia lustras), di incerta attribuzione, è edito da Neff in appendice alla propria edizione dei carmina di Paolo (Neff opinava che autore del carme, piuttosto che Paolo, possa essere stato Angilramno vescovo di Metz, ma non tutti gli studiosi si sono mostrati d’accordo su tale attri-buzione);25
23. Versus de miraculis sancti Benedicti (inc. Fratres alacri pectore), componimento in di-metri giambici dedicato alla narrazione dei miracoli di san Benedetto e tràdito anche all’interno del lungo cap. della Historia Langobardorum (I 26) dedicato alla lode di san Benedetto da Norcia, sulla scorta della narrazione che, delle vicende del santo, viene condotta da Gregorio Magno nel libro II dei Dialogi;26
24. Versus in laude Sancti Benedicti (inc. Ordiar unde tuos, sacer o Benedicte, triumphos), lungo componimento in distici elegiaci in lode di san Benedetto, inserito anch’esso all’interno della Historia Langobardorum (I 26). Karl Neff ha individuato tre distinte redazioni della poesia: una prima, originaria, risalente al periodo del primo soggiorno di Paolo a Montecassino (quindi prima del 782); una seconda, priva dei vv. 127-130 e 135-138, inserita nella Historia Langobardorum; una terza, opera di un anonimo monaco cassinese, che giustappone ai vv. 127-130 e 135-138 della reda-zione originaria i vv. 139-152, scritti di propria mano, con una conclusione posticcia nella quale viene ripresa la sezione finale del carme in lode del lago di Como;
25. Versus in laudem sancti Iohannem Baptistae (inc. Ut queant laxis resonare fibris), cele-bre inno in strofe saffiche attribuito a Paolo da Ernst Dümmler e quindi anche da Stella,27 ma nega-togli da Karl Neff (che non lo accoglie neppure fra i carmi dubbi, in appendice).28 Il carme è ben noto, soprattutto, per un altro motivo. La prima strofa di esso, infatti suona così: Ut queant laxis re-
sonare fibris / mira gestorum famuli tuorum, / solve polluti labii reatum, / sonde Iohannes. Nell’XI secolo il monaco e musico Guido d’Arezzo, isolando questa prima strofa, ricavò dalle sillabe inizia-li di ciascun emistichio, ordinate melodicamente in gamma, il nome delle sette note musicali: ut (poi divenuta do nella notazione italiana), re, mi, fa, sol, la, si;
26. Versus in tribunali (inc. Multicolor quali species per nubila fulget), di incerta attribuzio-ne;
27. Versus missi ad regem (inc. Cynthius occiduas rapidis declivus ad oras); 28. Versus. Sensi, cuius verba (inc. Sensi, cuius verba cepi exarata pagina), risposta di Pao-
lo al componimento indirizzatogli da Pietro da Pisa al suo ingresso nella corte carolingia di Aqui-sgrana, nel 782. Essi, come si è detto nel paragrafo precedente, si concludono con la traduzione lati-na di un epigramma dell’Anthologia Palatina (VII 542), dal titolo De puero qui in glacie extinctus est, tramandato anche nell’Anthologia Latina sotto il nome di Germanico Cesare (Anth. Lat. 709 Riese), la cui paternità paolina viene però negata da Karl Neff, che considera la versione in oggetto dell’epigramma greco anteriore all’epoca di Paolo Diacono. A tale traduzione conferiva, invece,
25 Status quaestionis e bibliografia in Benedetta VALTORTA, Clavis, cit., pp. 206-207. 26 Su questo, come sul componimento immediatamente seguente, cfr. lo studio di K. SMOLAK, Poetologisches
zu den Benedekthymnen in der «Historia Langobardorum» des Paulus Diaconus, in Paolo Diacono. Uno scrittore fra tradizione longobarda e rinnovamento carolingio, cit., pp. 505-525.
27 Fr. STELLA, La poesia di Paolo Diacono, cit., p. 559; E. DÜMMLER, ed cit., pp. 83-84. 28 Informazione bibliografica completa in Benedetta VALTORTA, Clavis, cit., pp. 208-209.
10 massima attenzione il Viscardi, il quale scriveva non potersi dubitare «che esso sia cosa del Diaco-no […], dato il modo strettissimo con cui l’epigramma stesso è legato al carme paolino, nel cui con-testo entra come documento della ricevuta istituzione nelle lettere greche (il che è stato bene ricono-sciuto e affermato dal Riese)»;29
29. Versus. Sic ego suscepi (inc. Sic ego suscepi tua carmina, maxime princeps), scritto nel 783 in risposta a Carlo;
30. Versus super Crucem (inc. Adam per lignum mortem deduxit in orbem), di incerta attri-buzione.
2.2.2. Epistolae In tutto, di Paolo Diacono ci sono giunte 5 (o 6, se si accetta l’autenticità dell’epist. 6) epi-
stole, e cioè le seguenti: 1) ad Adelperga, epistola dedicatoria dell’Historia Romana; 2) all’abate Teodemaro da Montecassino († 796); 3) a Carlo, epistola dedicatoria della Epitoma Pompei Festi; 4) supplica indirizzata all’abate Adalardo di Corbie, prefatoria a una raccolta di 53 lettere di
Gregorio Magno;30 5) indirizzata, sotto il nome di Teodemaro da Montecassino (ma si suppone che l’autore si
Paolo Diacono), a Carlo, per l’invio di un esemplare della Regula di san Benedetto;31 6) epistola di un tal Paolo (che non è detto sia da identificarsi col nostro autore) a un tal Pie-
tro. 2.2.3. Excerpta ex libris Pompei Festi de verborum significatione Il De verborum significatione di Pompeo Festo (a sua volta esemplato sulla perduta opera
grammaticale e lessicografica di Verrio Flacco) è testimoniato in un solo ms., il cosiddetto cod. Farnesiano, Napoli, Biblioteca Nazionale, IV A. 3, del sec. XI, nonché, appunto, dall’epitome che ne redasse Paolo Diacono durante la sua permanenza alla corte carolingia. L’opera, infatti, è dedica-ta a Carlo.32 Estratti del De verborum significatione di Festo sono poi leggibili negli scholia alle Etymologiae che si trovano nel ms. Roma, Biblioteca Vallicelliana A 18 (i cosiddetti Scholia Valli-celliana),33 scolii che, per lungo tempo attribuiti a Grauso da Ceneda (un oscuro grammatico del sec. XI), sono stati poi identificati con sicurezza come redatti da Paolo da Claudia Villa nel 1984.34
Lo scritto è molto importante non solo come testimonianza dell’attività di grammatico e di maestro che Paolo espletò durante la propria permanenza presso la corte carolingia, ma anche per il fatto che il De verborum significatione di Pompeo Festo ci è giunto gravemente mutilo, e quindi l’Epitome paolina ci consente di integrarlo (almeno in parte). Essa, infatti, è stata molto studiata,
29 A. VISCARDI, Le Origini, cit., p. 29. Sul De puero, cfr. l’analisi dei componimenti costituenti lo scambio
poetico fra Pietro e Paolo condotta da P. MASTANDREA, Classicismo e cristianesimo nella poesia di Paolo Diacono, in Paolo Diacono. Uno scrittore fra tradizione longobarda e rinnovamento carolingio, cit., pp. 293-311 (alle pp. 293-300).
30 Cfr. O. DOBIAS ROZDESTVENSKY, La main de Paul Diacre sur un codex du VIIIe siècle envoyé à Adalhard, in «Memorie Storiche Forogiuliesi» 25 (1929), pp. 129-143.
31 J. NEUFVILLE, L’authenticité de l’«Epistula ad regem Karolum de monasterio sancti Benedicti directa et a Paulo dictata», in «Studia Monastica» 13 (1971), pp. 295-309.
32 L’ed. dell’opera fu approntata da W.M. LINDSAY, Sexti Pompei Festi de verborum significatu quae super-sunt cum Pauli epitome, Lipsiae 1913, pp. 2-121.
33 Cfr. J. WATHMOUGH, Scholia in Isidori Etymologias Vallicelliana, in «Archivum Latinitatis Medii Aevi» 2 (1925-1926), pp. 57-75, 134-169; e W.M. LINDSAY, Glossaria Latina iussu Academiae Britannicae edita, IV, Paris 1930, pp. 73-467 (con gli Scholia Vallicelliana).
34 Claudia VILLA, Uno schedario di Paolo Diacono. Festo e Grauso di Ceneda, in «Italia Medioevale e Uma-nistica» 27 (1984), pp. 56-80; e Patrizia LENDINARA, Gli «Scholia Vallicelliana» e i primi glossari anglosassoni, in Paolo Diacono. Uno scrittore fra tradizione longobarda e rinnovamento carolingio, cit., pp. 251-278.
11 soprattutto in tempi recenti (fra gli interventi principali, si ricordano almeno quelli di Roberta Cer-vani, di Alessandro Moscadi e di Settimio Lanciotti).35
2.2.4. Expositio Artis Donati (seu Incipit Ars Donati quam Paulus Diaconus exposuit) Si tratta di un commento “scolastico” all’Ars minor di Elio Donato,36 dedicato a Carlo e
composto fra il 774/776 e il 780/782. Come l’opera precedente, essa si inserisce perfettamente (an-che se a un minor livello di consapevolezza e di valore letterario) nel quadro dell’attività che Paolo esercitò come collaboratore di Alcuino per coadiuvarne la politica culturale, ma si collega, altresì, con l’interesse sempre dimostrato da Paolo per lo studio della grammatica, come testimonia, fra l’altro, il suo già ricordato Rhytmus grammaticalis (nel ms. Paris, Bibl. Nat., lat. 7530, esemplato fra il 779 e il 797 a Montecassino).37 Redatta forse proprio a Montecassino, l’Expositio artis Donati si fonda, essenzialmente, sul solo manuale elementare di Donato e sulla versione “mista” prove-niente dalla fusione, avvenuta in Italia, fra la tradizione “visigotica” e quella “insulare”. Soprattutto nell’epistola di dedica a Carlo, l’opera mostra «come il testo linguistico il nostro considerasse con l’interesse dell’antiquario, curioso delle istituzioni, dei costumi, della vita, della civiltà romana».38
Si deve a Paolo Diacono, a quanto sembra, anche un Breviarium Pauli abbatis, una breve antologia grammaticale costituita da excerpta dal libro II delle Institutiones di Cassiodoro e attestata nel ms. Erfurt, Amplonianus Fo 10, ff. 44-45. Il breve scritto è stato recentemente edito da Luigi Munzi.39
2.2.5. Gesta episcoporum Mettensium Detti anche Liber de episcopis Mettensibus, oppure Libellus de numero sive ordine episco-
porum qui sibi ab ipso praedicationis exordio in Mettensi civitate successerunt, furono redatti (co-me si è detto nel par. 2.1) per il vescovo Angilramno (o Angelramno) di Metz, nell’abbazia di San Martino, e narrano la storia del monastero, dal primo vescovo, Clemente (una figura, invero, quasi del tutto leggendaria, considerato addirittura discepolo di san Pietro), fino a Crodegango (742-766), predecessore di Angilramno (766-791).40
35 Roberta CERVANI, L’epitome di Paolo Diacono del «De verborum significatu» di Pompeo Festo. Struttura e
metodo, Roma 1978; A. MOSCADI, Verrio, Festo e Paolo, in «Giornale Italiano di Filologia» 31 (1979), pp. 17-36; ID., Problemi filologici nell’«Epitome» di Paolo Diacono del «De verborum significatione» di Sesto Pompeo Festo, in La cultura in Italia tra Tardo Antico e Alto Medioevo. Atti del Congresso tenuto a Roma, Consiglio Nazionale delle Ricer-che, dal 12 al 16 Novembre 1979, Roma 1981, pp. 467-474; S. LANCIOTTI, Tra Festo e Paolo, in Paolo Diacono. Uno scrittore fra tradizione longobarda e rinnovamento carolingio, cit., pp. 237-250. In generale, cfr. P. CHIESA, Epitoma de verborum significatu, in P. CHIESA - Fr. STELLA, Paulus Diaconus, cit., pp. 482-485.
36 Cfr. L. HOLTZ, Le Parisinus Latinus 7530, cit. 37 L’opera ha avuto due edd. nel secolo scorso: A.M. AMELLI, Ars Donati quam Paulus Diaconus exposuit,
Montis Casini 1899; Maria Franca BUFFA GIOLITO, Expositio Artis Donati seu Incipit Ars Donati quam Paulus Dia-conus exposuit, Genova 1990 (con trad. ital. e commento). Fra i principali studi, si segnalano D. BIANCHI, Paolo Dia-cono e l’«Ars Donati», in «Atti e Memorie della Deputazione per le Province Modenesi», ser. VIII, 10 (1958), pp. 185-202; Vivien LAW, The Sources of the «Ars Donati quam Paulus Diaconus exposuit», in «Filologia Mediolatina» 1 (1994), pp. 71-80; P. CHIESA, Expositio artis Donati, in P. CHIESA - Fr. STELLA, Paulus Diaconus, cit., p. 485.
38 A. VISCARDI, Le Origini, cit., p. 31. 39 L. MUNZI, Testi grammaticali e “renovatio studiorum” carolingia, in Manuscripts and Tradition of Gram-
matical Texts from Antiquity to the Renaissance. Proceedings of a Conference held at Erice, 16-23 october 1997, as the 11th Course of International School for the Study of Written Records, edd. M. De Nonno - P. De Paolis - L. Holtz, I, Cassino 2000, pp. 383-385.
40 Sull’opera vi è una discretamente ampia bibliografia. Fra gli studi principali, si segnalano W. GOFFART, Paul the Deacon’s «Gesta episcoporum Mettensium» and the Early Design of Charlemagne’s Succession, in «Traditio» 42 (1986), pp. 59-94; M. SOT, Le «Liber de episcopis Mettensibus» dans l’histoire du genre “Gesta episcoporum”, in Paolo Diacono. Uno scrittore fra tradizione longobarda e rinnovamento carolingio, cit., pp. 527-549; D. KEMPF, Paul the Diacon’s «Liber de episcopis Mettensibus» and the role of Metz in the Carolingian Realm, in «Journal of Medieval History» 30 (2004), pp. 279-299; M. SOT, Faut-il rééditer le «Livre des évêques» de Metz de Paul Diacre?, in Retour aux sources. Textes, études et documents d’histoire médiévale offerts à Michel Parisse, Paris 2004, pp. 971-977; P. CHIESA, Gesta Episcoporum Mettensium, in P. CHIESA - Fr. STELLA, Paulus Diaconus, cit., pp. 495-497.
12
L’opera si configura come un tipico esempio (e uno dei più antichi) del genere storico-letterario, prettamente medievale, dei Gesta episcoporum.41 Ma la sua importanza, come ben ha ri-levato, qualche anno fa, Giuseppe Germano,
«andava ben oltre l’affermazione del rilievo che avrebbe dovuto assumere il vescovado di Metz, fondato, come quelli delle metropoli delle più grandi città della cristianità (come Milano, Aquileia, o Ravenna), da un diretto discepolo di Pietro, perché l’autore le conferì un preciso significato politico, che la rende un esempio molto interessante di storiografia dinastica: Paolo vi coinvolse, infatti, non solo la Roma cristiana, ma anche lo stesso Carlo […], finendo per comporre un’esaltazione della di-nastia carolingia. Egli vi narrava, infatti, anche del vescovo Arnolfo, morto intorno alla metà del VII secolo, da lui considerato il cofondatore della dinastia carolingia, in quanto avrebbe fatto sposare il figlio Anschis con la figlia di Pipino il Vecchio; ma dato che nel nome di Anschis Paolo vedeva figu-rato quello di Anchise, padre di Enea e primo fondatore della grandezza di Roma, egli, suggerendo l’origine troiana dei Franchi, sembrava giustificare così la signoria stessa di Carlo […] su Roma. Sembra acquistare per questo un preciso significato anche il fatto che Paolo qui avesse utilizzato il modello del Liber Pontificalis romano, sostituendo alla storia dei pontefici romani quella dei vescovi di Metz. Alla domanda se questa visione fosse stata ispirata da servilismo nei confronti di Carlo […] non sarebbe facile rispondere, ma va, comunque, rilevato che Paolo, che aveva ottenuto la grazia ri-chiesta per il fratello, non era solo riconoscente nei confronti di Carlo, ma, venuto a contatto con la figura sicuramente fascinosa del sovrano, tanto abile nella politica quanto attento alla cultura, aveva finito per nutrire verso di lui una sincera ammirazione».42 2.2.6. Historia Langobardorum Composta negli ultimi anni di vita di Paolo Diacono, nella quiete operosa del chiostro di
Montecassino, la Historia Langobardorum, in 6 libri, narra la storia del popolo longobardo dalle origini al 744, cioè fino al regno di Liutprando, quando i Longobardi raggiunsero il culmine della loro potenza.43 La narrazione della storia si può suddividere in due fasi, la prima delle quali, abba-stanza lineare, narra le vicende del popolo longobardo prima dell’entrata in Italia; la seconda, inve-ce, narra le gesta di svariati personaggi che si radicano in territori ben precisi e si fondono con i luoghi e le genti. Particolare attenzione viene anche conferita alla Chiesa in Italia durante quel pe-riodo e, talvolta, anche a personaggi che non si intrecciano direttamente con la storia dei Longobar-di in Italia.
Lo schema dell’opera, a grandi linee, può essere così delineato: Libro I: cause delle migrazioni dei Longobardi con leggende legate alle origini del popolo,
le gesta dei primi re fino alla vittoria di Alboino sui Gepidi e la partenza per l’Italia (vi si narra an-che di san Benedetto);
Libro II: i Longobardi prendono il posto dei Goti in Italia, temporaneamente alleati dei Bi-zantini. Descrizione dell’Italia, racconto della conquista di Pavia da parte di Alboino e del suo as-sassinio organizzato dalla moglie Rosmunda, breve regno di Clefi e decennale periodo dei duchi o “dell’anarchia”;
Libro III: rinascita del regno dei Longobardi attraverso Autari, suo matrimonio con Teodo-linda forte presenza di papa Gregorio I;
Libro IV: da Agilulfo a Grimoaldo, attraverso il regno di Rotari;
41 Cfr. M. SOT, Gesta episcoporum, Gesta abbatum, Turnhout 1981 (su Paolo Diacono, pp. 33-35). 42 G. GERMANO, Lo spirito, la storia, la tradizione. Antologia della letteratura latina medievale, vol. I. L’Alto
Medioevo, Napoli 2007, p. 207. 43 L’ediz. canonica è quella di L. BETHMANN - G. WAITZ, in MGH Script. rer. Lang., 1878, pp. 12-187. Fra le
migliori traduzioni italiane, si segnalano PAOLO DIACONO, Storia dei Longobardi, a cura di Br. Luiselli - A. Zanella, Milano 1991; PAOLO DIACONO, Storia dei Longobardi, a cura di Lidia Capo, Milano 1992. La bibliografia sull’opera è amplissima, e comprende numerose edizioni e traduzioni (nelle principali lingue moderne), molti libri e monografie e centinaia di articoli di ogni genere (di impostazione, di volta in volta, storica, letteraria, filologica, interpretativa, anti-quaria, antropologica, e così via, fatto, questo, che mostra come l’opera ben si presti agli approcci più vari e diversifica-ti: si rimanda, a tal proposito, all’ampia – ancorché non certo esaustiva – bibliografia specifica stilata in appendice a questo scritto).
13
Libro V: da Grimoaldo a Cuniperto; Libro VI: da Cuniperto alla morte di Liutprando. Non è un caso che Paolo Diacono abbia tralasciato gli ultimi trenta anni, da lui vissuti diret-
tamente, perché scopo della sua storia è quello di esaltare la potenza dei Longobardi, non quello di narrare il loro declino e la loro rovina.44 L’opera (che per la storia del popolo longobardo rappresen-ta ciò che le storie di Giordane e di Gregorio di Tours rappresentano, rispettivamente, per la storia del popolo goto e per quella del popolo franco) si fonda su fonti di prim’ordine (come la perduta Historia Langobardorum di Secondo, vescovo di Trento e contemporaneo di Gregorio Magno,45 e l’anonima Origo gentis Langobardorum, composta nel 671) e ci fornisce una notevole quantità di notizie. Essa, come giustamente ha affermato Claudio Leonardi, «non è solo un capolavoro storio-grafico, è anche il primo capolavoro di poesia della latinità medievale».46
2.2.7. Historia Romana L’Historia Romana è la prima opera letteraria veramente importante di Paolo Diacono, dopo
alcuni brevi (ma non irrilevanti) componimenti poetici precedenti. Essa, come si è accennato nel pa-ragrafo dedicato al profilo biografico dello scrittore, è legata all’insegnamento da lui impartito ad Adelperga figlia di re Desiderio, e consiste, in parte, in un rifacimento (o rielaborazione) e in una continuazione del Breviarium ab Urbe condita di Eutropio (quest’ultimo, a sua volta, una sorta di “riassunto” degli Ab Urbe condita libri di Tito Livio). L’opera paolina ebbe, durante tutto il Me-dioevo, un’amplissima fortuna e, nella rielaborazione di Landolfo Sagace, venne utilizzata nelle scuole come libro di testo per l’insegnamento e l’apprendimento della storia di Roma.47
Per presentare il testo paolino mi servo, qui si seguito, della sintesi offerta da Antonio Vi-scardi oltre 60 anni fa, ma ancor oggi chiara e valida:
«Appassionato e fervidamente curioso di cose storiche, Paolo aveva trasmesso alla nobile allieva la sua passione e il suo interesse; e aveva cercato di appagarne la viva curiosità, mettendole fra le mani il Breviarium di Eutropio. Ma questo testo si dimostra inadeguato, non può rispondere a tutte le do-mande che la gentile scolara si pone: Eutropio incomincia da Romolo e nulla dice delle vicende itali-che più antiche […], si arresta all’imperatore Valente e Adelperga vuol conoscere le vicende ulteriori della storia al suo tempo […], considera solo il mondo romano e Adelperga vorrebbe sapere in che rapporto siano, cronologicamente, le vicende dell’Urbe con quelle del popolo eletto, rivelatele dallo studio della Storia Sacra. E allora Paolo riprende Eutropio, lo integra, lo amplia, lo rifà […], renden-do […] consona la narrazione di Eutropio sacratissimae historiae, sia dell’Antico sia del Nuovo Te-stamento; e aggiungendo, infine, al Breviarium sei libri, coi quali il racconto è condotto fino all’età di Giustiniano».48 Il fatto che l’Historia Romana si arresti all’epoca di Giustiniano (cioè circa due secoli prima
della sua composizione) è molto significativo, in quanto Paolo, con una scelta deliberata e consape-vole (come sarà poi, con maggiore deliberazione e consapevolezza, per l’Historia Langobardorum) ha voluto scrivere una storia tutta “al passato”, fermandosi proprio nel momento in cui i Longobardi invadono l’Italia (invasione che, come è noto, ebbe luogo nel 568).
44 Cfr. Cl. LEONARDI, Paolo Diacono: tradizione germanica e cristiana, cit., pp. 229-235; e, soprattutto, G.
VINAY, Un mito per sopravvivere: l’«Historia Langobardorum» di Paolo Diacono, in ID., Alto Medioevo latino. Con-versazioni e no, Napoli 1978, pp. 125-149 (poi anche in ID., Peccato che non leggessero Lucrezio, a cura di Cl. Leonar-di, Spoleto 1989, pp. 97-122; e ancora in ID., Alto Medioevo latino. Conversazioni e no, nuova ed. a cura di I. Pagani e M. Oldoni, con la collaborazione di Corinna Bottiglieri e Iolanda Ventura, Napoli 2003, pp. 107-129, certamente uno dei più acuti saggi interpretativi dell’Historia Langobardorum che mi sia mai capitato di leggere).
45 Cfr. Roberta CERVANI, La fonte tridentina della «Historia Langobardorum» di Paolo Diacono, in «Atti dell’Accademia Roveretana degli Agiati» 236 (1986), pp. 97-104.
46 Cl. LEONARDI, Paolo Diacono: tradizione germanica e cristiana, cit., p. 229. 47 L. B. MORTENSEN, The Diffusion of Roman Histories in the Middle Ages. A List of Orosius, Eutropius, Pau-
lus Diaconus and Landolf Sagax, in «Filologia Mediolatina» 6-7 (1999-2000), pp. 101-200. 48 A. VISCARDI, Le Origini, cit., p. 24.
14
Per portare a compimento questo lavoro di integrazione, ampliamento, continuazione del manuale eutropiano, Paolo si avvalse di innumerevoli fonti, che sono state, via via che gli studi sul-lo scrittore e sulla sua opera hanno conosciuto il loro sviluppo, accuratamente e diligentemente in-dagate e individuate dagli studiosi, prima, durante il sec. XIX, dal Droysen,49 quindi, agli inizi del secolo scorso, dal Crivellucci, che ha allestito un’eccellente edizione critica dell’Historia Romana (apparsa nel 1914 nelle “Fonti per la Storia d’Italia”) e ha offerto inoltre un quadro assolutamente completo delle fonti e dei modelli cui lo scrittore longobardo si è ispirato per la composizione della propria opera storiografica.50 Si tratta di un quadro molto interessante, poiché ci fornisce non solo la misura della ricca cultura letteraria di Paolo, ma anche uno “spaccato” dei testi maggiormente in circolazione (almeno, fra i dotti) nella seconda metà del sec. VIII. Oltre, evidentemente, a Eutropio, Paolo Diacono ha infatti utilizzato Orosio, Gerolamo e Prospero, Giordane e l’Eneide di Virgilio col commento di Servio, nonché, ancora, Livio, Ammiano Marcellino, Idazio, Beda, Cassiodoro, Isido-ro di Siviglia, Ennodio, Eugippio, l’Anonimo Valesiano, il Liber Pontificalis, Solino, Frontino, Sul-picio Severo, Giulio Paride, la vita di Ambrogio di Paolino, lo stesso Ambrogio, Agostino, Festo, Aurelio Vittore, Giustino, Orazio, l’Origo gentis Langobardorum e, ovviamente, la Bibbia.
Nei primi 10 dei 16 libri di cui si compone l’opera, Paolo in genere segue il testo eutropiano di riferimento, intercalando a esso (e spesso trascrivendoli alla lettera) brani tratti dalle fonti di cui si è detto. Per quanto concerne invece gli ultimi 6 libri, lo scrittore proclama la sua maggiore indi-pendenza dal modello, affermando di averli composti suo ex maiorum dictis stilo (attingendo diret-tamente, cioè, da ciò che aveva sentito narrare dai propri progenitori). Ma Amedeo Crivellucci ha rilevato come tale affermazione possa essere considerata valida, tutt’al più, soltanto per gli ultimi tre libri, nei quali «si può riconoscere questa maggiore autonomia formale rispetto ai testi adibiti dal compilatore: se pure non derivino anche essi, almeno nelle parti che più sembrano originali, da ignote fonti perdute. Ma in ogni modo, pur essendo essenzialmente un opus musivum, la Historia Romana rivela larghezza di dottrina, fervore di studio, abilità di costruzione, viva curiosità antiqua-ria: denuncia, insomma, una personalità di erudito e di studioso notevole e rilevata».51
2.2.8. Homiliarium Compilato su esplicita richiesta di Carlo, l’Homiliarium è una raccolta di 244 omelie di vari
autori precedenti (soprattutto Leone Magno e Beda), suddivisa in due parti (omelie per il periodo invernale e omelie per il periodo estivo).52 Per l’allestimento e la redazione di tale compilazione, Paolo fece ricorso, in prima istanza, a un’analoga raccolta precedente, erroneamente attribuita a Gregorio Magno, ma, da un lato, integrandola con materiale più recente, dall’altro, eliminandone alcuni testi che potessero essere sospettati di eresia o che, in qualche modo, risultassero non consoni con l’ideologia carolingia.53 La silloge godette di grande fortuna poiché, con modifiche e aggiorna-menti, è stata utilizzata per la liturgia e la predicazione fino al Concilio Vaticano II.
2.2.9. Sancti Gregorii Magni vita Opera agiografica (BHL 3639) sulla vita di papa Gregorio I, fu composta tenendo presenti,
tra le fonti e i modelli, l’Historia Francorum di Gregorio di Tours e l’Historia ecclesiastica gentis Anglorum di Beda. Si tratta di una delle quattro biografie di Gregorio Magno che ci sono pervenute
49 H. DROYSEN, Eutropi Breviarium ab urbe condita cum Pauli additamentis et versionibus Graecis, in MGH
AA., 2, 1879, pp. 4-182, 185-224 lib. I-X (col testo di Eutropio), lib. XI-XVI; ID., Pauli Historia Romana, in MGH Script. rer. Germ., 49, 1879.
50 A. CRIVELLUCCI, Pauli Diaconi Historia Romana, Roma 1914; dello stesso studioso, cfr. Per l’edizione del-la «Historia Romana» di Paolo Diacono, in «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo» 40 (1921), pp. 7-104. Cfr. inoltre P. CHIESA, Historia Romana, in P. CHIESA - Fr. STELLA, Paulus Diaconus, cit., pp. 486-491. Come per l’Historia Langobardorum (cfr. par. 2.2.6), la bibliografia sull’Historia Romana è molto ampia e varia: si rimanda quindi (anche in tal caso) a quanto indicato in appendice a questo scritto.
51 A. VISCARDI, Le Origini, cit., p. 25. 52 Cfr. R. GREGOIRE, L’«Homéliaire» de Paul Diacre, in ID., Homéliaires liturgiques médiévaux. Analyse de
manuscrits, Spoleto 1980, pp. 424-478. 53 Cfr. G. GERMANO, Lo spirito, la storia, la tradizione, cit., pp. 207-208.
15 dall’Alto Medioevo54: le altre tre sono la breve nota scritta nel sec. VII e quindi inserita nel Liber Pontificalis (una silloge altomedievale di biografie dei pontefici), il testo composto agli inizi del sec. VIII in ambiente insulare da un anonimo monaco di origine anglica nel monastero di Whitby (per questo motivo tale biografia viene detta del “monaco di Whitby”, o dell’“anonimo di Whit-by”)55 e l’ampia biografia redatta, negli anni ’70 del sec. IX, a Roma da Giovanni Immonide. Nel Medioevo la Vita fu conosciuta e tràdita in due redazioni ritenute entrambe autentiche, una editio maior (più ampia) e una editio minor (più breve). L’editio maior fu più volte pubblicata come ge-nuina di Paolo, fino a quando, nel 1887, Hartmann Grisar distinse le due redazioni, chiarendo come la versione più lunga fosse, in realtà, opera di un interpolatore di origine romana, che, sullo scorcio del sec. IX, aveva ampliato il testo paolino con brani tratti da una redazione vicina alla biografia re-datta dal monaco di Whitby. Lo studioso tedesco apprestò quindi l’edizione della redazione brevior, fondata (a suo dire) su ben 19 mss.,56 mentre, in realtà, egli utilizzò pressoché esclusivamente il ms. Casinensis 145. Dopo Grisar, parecchi studiosi si sono dedicati allo studio della tradizione ms. dell’opera e alla scoperta di nuovi testimoni (si ricordano, fra gli altri, gli interventi di Brackmann, Limone e Lucia Castaldi)57, fino alla nuova edizione dell’opera, apprestata da Sabina Tuzzo e ap-parsa nel 200258.
Nella Sancti Gregorii Magni vita di Paolo Diacono «viene tratteggiato un essenziale profilo del personaggio, dipinto come l’esemplare del perfetto cristiano. Paolo riserva poco spazio agli epi-sodi leggendari e miracolistici, di cui invece abbondava l’unica biografia precedente di Gregorio, quella dovuta alla penna di un anonimo monaco di Whitby, vissuto nel VII secolo».59
Bibliografia
Bibliografia generale
L. BETHMANN, Paulus Diaconus. Leben und Schriften, in «Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschi-chtskunde» 10 (1849), pp. 247-334; F. DAHN, Des Paulus Diaconus Leben und Schriften, Leipzig 1876; Atti e memorie del Congresso storico tenuto in Cividale (sett. 1899), Cividale 1900; N. TAMASSIA, Paolo Diacono. Discorso letto in Cividale del Friuli in occasione dell’XI centenario della morte di Paolo Diacono, Cividale 1900; C. CIPOLLA, Note bibliografiche circa l’odierna condizione degli studi critici sul testo delle opere di Paolo Diacono, Venezia 1901; E. MENEGHINI, Dello stato presente degli studi intorno alla vita di Paolo Dia-cono, in «Bollettino della Societa Pavese di Storia Patria» 4 (1904), pp. 15-100, 231-285, 313-366; M. MANI-
TIUS, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, I, München 1911, pp. 257-272; A. MONTEVERDI, Paolo Diacono (abbozzo di un profilo), in «Memorie Storiche Forogiuliesi» 25 (1929), pp. 1-14; L. MOHL-
BERG, Note su alcuni sacramentari. II. Paolo Diacono e l’archetipo del sacramentario di Dragone, in «Rendi-conti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia» 16 (1940), pp. 131-179; A. VISCARDI, Le Origini, Milano 1950, pp. 22-33; G. VINAY, Paolo Diacono e la poesia. Nota, in «Convivium» 1 (1950), pp. 97-113; Atti del II Congresso Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo (Grado - Aquileia - Gorizia - Cividale - Udi-ne, 7-11 Settembre 1952), Spoleto 1953 (riguardano la figura e l’opera di Paolo Diacono i seguenti contributi: P.S. LEICHT, Paolo Diacono e gli altri scrittori delle vicende d’Italia nell’età carolingia, pp. 57-74; D. BIAN-
CHI, Per il testo della «Historia Langobardorum» di Paolo Diacono, pp. 121-137; P. LAMMA, Il mondo bizan-tino in Paolo Diacono, pp. 199-215; A. LENTINI, La grammatica d’Ilderico documento dell’attività letteraria
54 Traggo tutte queste notizie, per comodità, da V. SIVO, Studi recenti su Paolo Diacono, cit., p. 271 (che deli-
nea, come sempre, un eccellente status quaestionis). Cfr. inoltre P. CHIESA, Vita Gregorii, in P. CHIESA - Fr. STELLA, Paulus Diaconus, cit., pp. 497-501.
55 Cfr. O. LIMONE, La vita di Gregorio Magno dell’Anonimo di Whitby, in «Studi Medievali», n.s., 19, 1 (1978), pp. 37-67.
56 H. GRISAR, Die Gregorbiographie des Paulus Diakonus in ihrer ursprünglichen Gestalt nach italienischen Handschriften, in «Zeitschrift für katholische Theologie» 11 (1887), pp. 162-173.
57 Cfr. A. BRACKMANN, Reise nach Italien von März bis Juni 1900, in «Neues Archiv der Gesellschaft für älte-re deutsche Geschichtskunde» 26 (1900-1901), pp. 330-333; O. LIMONE, La tradizione manoscritta della «Vita Grego-rii Magni» di Paolo Diacono (BHL 3639). Censimento dei testimoni, in «Studi Medievali», n.s., 29,2 (1988), pp. 888-953; Lucia CASTALDI, Nuovi testimoni della «Vita Gregorii» di Paolo Diacono, in Paolo Diacono. Uno scrittore fra tradizione longobarda e rinnovamento carolingio, cit., pp. 75-126.
58 Sabina TUZZO, Paolo Diacono. Vita sancti Gregorii Magni, Pisa 2002. 59 F. BERTINI, Letteratura latina medievale in Italia, cit., p. 47.
16
di Paolo Diacono, pp. 217-240; I. PERI, Fatti giuridici e fatti sociali nella «Storia dei Longobardi» di Paolo Diacono, pp. 265-274); W. WATTENBACH, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalters. Vorzeit und Ka-rolinger, hrsgg. W. Levison - H. Löwe, II, Weimar 1953, pp. 203-224; H. WALTHER, Paulus Diaconus, sub voc., in Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, V, Berlin-New York 1955, pp. 871-875; D. NORBERG, Le développement du latin en Italie de saint Grégoire le Grand à Paul le Diacre, in I caratteri del VII secolo in Occidente. Settimane di Studio sull’Alto Medioevo, V (Spoleto 1957), Spoleto 1958, pp. 485-503; L.J. ENGELS, Observations sur le vocabulaire latin de Paul Diacre, Nijmegen - Utrecht 1961; K. GAMBER, Il sacramentario di Paolo Diacono: la redazione del Gelasiano sec. VIII in Pavia, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia» 16 (1962), pp. 412-438; K. LANGOSCH, Die «Akademie» Karls des Grossen und der Lango-barde Paulus Diaconus, in ID., Profile des lateinischen Mittelalters. Geschichtliche Bilder aus dem euro-päischen Geistesleben, Darmstadt 1965, pp. 83-133; Fr. BRUNHÖLZL, Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters, I, München 1975, pp. 257-268; O. CAPITANI, La storiografia altomedievale: linee di emergenza della critica contemporanea, in La cultura in Italia tra Tardo Antico e Alto Medioevo. Atti del Congresso tenu-to a Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal 12 al 16 Novembre 1979, Roma 1981, pp. 123-147; Cl. LEONARDI, Paolo Diacono e la civiltà altomedievale, in PAULI DIACONI Historia Langobardorum, a cura di M. Felisatti, nuova ed. rivista da L. Tenconi - R. Cassanelli, Milano 1985, pp. 9-26 (poi, col titolo Paolo Diacono: tradizione germanica e cristiana, in Cl. LEONARDI, Medioevo latino. La cultura dell’Europa cristiana, a cura di Fr. Santi, Firenze 2004, pp. 219-236); M. OLDONI, Paolo Diacono, in Montecassino, dalla prima alla se-conda distruzione. Momenti e aspetti di storia cassinese (sec. VI-IX). Atti del II Convegno di studi sul medioe-vo meridionale (Cassino – Montecassino, 27-31 maggio 1984), a cura di F. Avagliano, Montecassino 1987, pp. 231-258; F. BERTINI, Letteratura latina medievale in Italia (secoli V-XIII), Busto Arsizio (VA) 1988, pp. 46-48; L. CAPO, Paolo Diacono e il problema della cultura dell’Italia longobarda, in Langobardia, a cura di P. Cammarosano - S. Gasparri, Udine 1990, pp. 169-235; H. TAVIANI-CAROZZI, Le souvenir et la légende de Paul Diacre, in Haut Moyen Âge: culture, éducation et société. Études offertes à Pierre Riché, cur. M. Sot, La Garenne - Colombes 1990, pp. 555-573; H. TAVIANI-CAROZZI, La principauté lombarde de Salerno. IXe-XIe siècle, I, Rome 1991; Br. LUISELLI, La società longobardica del secolo VIII e Paolo Diacono storiografo tra romanizzazione e nazionalismo longobardico, in PAOLO DIACONO, Storia dei Longobardi, a cura di Br. Luisel-li - A. Zanella, Milano 1991, pp. 5-47; Br. LUISELLI, Storia culturale dei rapporti tra mondo romano e mondo germanico, Roma 1992, pp. 773-800; A. BREUKELAAR, Paulus Diaconus, sub voc., in Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon, VI (1994), pp. 60-63; L. CAPO, La polemica longobarda sulla caduta del regno, in «Rivista Storica Italiana» 108 (1996), pp. 5-35; S. CANTELLI BERARDUCCI, Cronologia e bibliografia della letteratura mediolatina in Lo Spazio Letterario del Medioevo. 1. Il Medioevo Latino, V, Roma 1998, pp. 409-411; G. GRANELLO, Da Paolo Diacono a Scoto Eriugena: alcuni aspetti della cultura in epoca franca, in Dalla Tarda Latinità agli albori dell’Umanesimo: alla radice della storia europea, a cura di P. Gatti - L. De Finis, Trento 1998, pp. 357-382; Paolo Diacono. Uno scrittore fra tradizione longobarda e rinnovamento ca-rolingio. Atti del Convegno internazionale di studi (Cividale del Friuli - Udine, 6-9 maggio 1999), a cura di P. Chiesa, Udine 2000 (su cui cfr. il resoconto di M.R. MATRELLA, in «Quaderni Medievali» 48 [1999], pp. 147-158; e, soprattutto, la nota critica di V. SIVO, Studi recenti su Paolo Diacono, in «Quaderni Medievali» 52 [2001], pp. 260-275; il vol. comprende i seguenti contributi: R. MCKITTERICK, Paolo Diacono e i Franchi: il contesto storico e culturale, pp. 9-28; Cl. AZZARA, La figura di Gregorio Magno nell’opera di Paolo Diacono, pp. 29-38; L. CAPO, Paolo Diacono e il mondo franco: l’incontro di due esperienze storiografiche, pp. 39-74; L. CASTALDI, Nuovi testimoni della «Vita Gregorii» di Paolo Diacono [BHL 3639], pp. 75-126; M. COSTAM-
BEYS, The Monastic Environment of Paul the Deacon, pp. 127-138; Fl. DE RUBEIS, La tradizione epigrafica in Paolo Diacono, pp. 139-162; Fr. FORNASARO, Notule di chimica e terapia nell’opera di Paolo Diacono, pp. 163-173; L. GATTO, Città e vita cittadina nell’«Historia Langobardorum» di Paolo Diacono, pp. 175-204; Y. HEN, Paul the Deacon and the Frankish liturgy, pp. 205-221; M.W. HERREN, Theological aspects of the wri-tings of Paul the Deacon, pp. 223-235; S. LANCIOTTI, Tra Festo e Paolo, pp. 237-250; P. LENDINARA, Gli «Scholia Vallicelliana» e la lessicografia precedente e coeva, pp. 251-278; O. LIMONE, Santi ed eroi nella «Storia dei Longobardi» di Paolo Diacono, pp. 279-292; P. MASTANDREA, Classicismo e cristianesimo nella poesia di Paolo Diacono (con esempi di analisi intertestuale assistita dal computer), pp. 293-311; I. MAZZINI, La medicina in Paolo Diacono. Contributi alla conoscenza della persona e dello scrittore, pp. 313-331; M. MELI, Eco scandinave nella «Historia Langobardorum» di Paolo Diacono, pp. 333-353; L.B. MORTENSEN, Impero romano, «Historia Romana» e «Historia Langobardorum», pp. 355-366; L. PANI, Aspetti della tradi-zione manoscritta dell’«Historia Langobardorum», pp. 367-412; W. POHL, Paolo Diacono e la costruzione dell’identità longobarda, pp. 413-426; G. PRINCI BRACCINI, La «glossa monzese» all’«Historia Langobardo-rum», altri documenti del culto da san Giovanni Battista presso i Longobardi e l’incantesimo del cod. Vat. Lat. 5359, pp. 427-467; A. RUSCONI, Il canto liturgico nelle regioni nord-italiane all’epoca di Paolo Diacono, pp. 469-485; A.A. SETTIA, Aureliano imperatore e il cavallo di re Alboino. Tradizione ed elaborazione nelle fonti pavesi di Paolo Diacono, pp. 487-504; K. SMOLAK, Poetologisches zu den Benedikthymnen in der «Historia Langobardorum» des Paulus Diaconus, pp. 505-526; M. SOT, Le «Liber de episcopis Mettensibus» dans l’histoire du genre «gesta episcoporum», pp. 527-549; Fr. STELLA, La poesia di Paolo Diacono: nuovi mano-scritti e attribuzioni incerte, pp. 551-574; Cl. VILLA, Cultura classica e tradizioni longobarde: tra latino e vol-
17
gari, pp. 575-600; A. ZIRONI, «Historia Langobardorum» V, 34: la «colomba dei morti» fra Bibbia gotica e sepolture franche, pp. 601-625); Paolo Diacono e il Friuli altomedievale (secc. VI-X). Atti del XIV Congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo (Cividale del Friuli - Bottenicco di Moimacco, 24-29 settembre 1999), Spoleto 2001 (cfr. la recens. di G. FORNASARI, in «Studi Medievali», n.s., 45,1 [2004], pp. 217-247; ri-guardano la figura e l’opera di Paolo Diacono i seguenti contributi: Cl. LEONARDI, La figura di Paolo Diacono, pp. 13-24: poi rist. in Cl. LEONARDI, Medioevo latino. La cultura dell’Europa cristiana, a cura di Fr. Santi, Fi-renze 2004, pp. 237-247; O. CAPITANI, Paolo Diacono e la storiografia altomedievale, pp. 25-44; P. CHIESA, Caratteristiche della trasmissione dell’«Historia Langobardorum», pp. 45-66; G. GANDINO, La dialettica tra il passato e il presente nelle opere di Paolo Diacono, pp. 67-97; P. CAMMAROSANO, Paolo Diacono e il proble-ma della regalità, pp. 99-104; N. CHRISTIE, The “castra” of Paul the Deacon and the Longobard Frontier in Friuli, pp. 231-251; P. PEDUTO, Paolo Diacono e la Cappella Palatina di Salerno, pp. 655-670; P. DE VINGO, Avari e Slavi nel Friuli altomedievale secondo l’«Historia Langobardorum» di Paolo Diacono, pp. 807-815; G. PRINCI BRACCINI, Una mancata “princeps” aldina della «Historia Langobardorum»?, pp. 817-824); M. LAPIDGE, Il secolo VIII, in Letteratura latina medievale (secoli VI-XV). Un manuale, a cura di Cl. Leonardi [et alii], Firenze 2002, pp. 41-73 (su Paolo Diacono, pp. 61-64); F.J. WORSTBROCK, Paulus Diaconus, sub voc., in Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, XI, Berlin-New York 20042, pp. 1172-1186; P. CHIESA - Fr. STELLA, Paulus Diaconus, in Te.Tra. 2. La trasmissione dei testi del Medioevo. Mediaeval Latin Texts and their Transmission, vol. II, a cura di P. Chiesa - L. Castaldi, Firenze 2005, pp. 482-506; B. VALTOR-
TA, Clavis Scriptorum Latinorum Medii Aevi. Auctores Italiae (700-1000), Firenze 2006, pp. 196-219; R.M. POLLARD, Paul, Paulinus and the Rhythm of Élite Latin: Prose Rhythm in Paul the Deacon and Paulinus of Aquileia and its Implications, in La culture du haut moyen âge. Une question d’élites?, cur. F. Bougard - R. Le Jan - R. McKitterick, Turnhout 2009, pp. 63-99; D. DELIYANNIS, Paulus Diaconus, sub voc., in The Encyclo-pedia of the Medieval Chronicle, cur. G. Dunphy, Leiden - Boston 2010, pp. 1190-1192.
Bibliografia delle singole opere
1. Carmina
Repertorium Fontium VIII 521. Mss. - ed. DÜMMLER (cfr. infra), pp. 31-35; ed. NEFF (cfr. infra), pp. XIII-XX; Fr. STELLA, La poesia di Paolo Diacono (cfr. infra), pp. 572-574. Edd. - MIGNE, PL, t. 95, coll. 1591-1604 (soltanto 14 poesie); E. DÜMMLER, MGH Poetae, 1, 1881, pp. 35-86; K. NEFF, Die Gedichte des Paulus Diaconus. Kritische und erklärende Ausgabe, München 1908 (cfr. la recens. di A. CRIVELLUCCI, in «Studi Storici» 19 [1910], pp. 89-98). Transl. - Poesia latina medievale, a cura di G. Vecchi, Parma 1958, pp. 38-43; Scritture e scrittori dei secoli VII-X, a cura di A. Viscardi - Br. Nardi - G. Vidossi, Torino 19772, pp. 88-91; Poesia latina medievale, a cura di G. Gardenal, Milano 1993, pp. 4-9 [cfr. la recens. di A. BISANTI, in «Orpheus», n.s., 16 (1995), pp. 482-487]. Studi: ed. DÜMMLER, pp. 27-35; L. TRAUBE, Zu den Gedichten des Paulus Diaconus, in «Neues Archiv» 15 (1890), pp. 199-200; A.M. AMELLI, Paolo Diacono, Carlo Magno e Paolino d’Aquileia, in un epigramma ine-dito intorno al canto gregoriano e ambrosiano estratto da un codice di Montecassino, Montecassino 1899; V. CAPETTI, De Pauli Diaconi carminibus cum appendice novem eiusdem poetae carminum Italicis versibus red-ditorum, in Atti e memorie del Congresso storico di Cividale (sett. 1899), Cividale 1900, pp. 63-108; A. MA-
SELLI, Di alcune poesie dubbiamente attribuite a Paolo Diacono, Montecassino 1905; A. CRIVELLUCCI, Un’altra poesia di Paolo Diacono attribuita a Paolino d’Aquileia, in «Studi Storici» 19 (1910), pp. 401-406; A.M. AMELLI, L’epigramma di Paolo Diacono intorno al canto gregoriano e ambrosiano, in «Memorie Stori-che Forogiuliesi» 55 (1913), pp. 163-175; F. ERMINI, La poesia enigmistica e faceta di Paolo Diacono, in «Memorie Storiche Forogiuliesi» 25 (1929), pp. 97-110 (poi in F. ERMINI, Medio Evo Latino. Studi e ricerche, Modena 1938, pp. 129-140); Fr.J.E. RABY, A History of Secular Latin Poetry in the Middle Ages, I, Oxford 1934, pp. 197-199; Fr.J.E. RABY, A History of Christian-Latin Poetry from the Beginnings to the Close of the Middle Ages, 2nd edition, Oxford 1953, pp. 162-167; W. VON DEN STEINEN, Karl und die Dichter, in Karl der Grosse. Lebenswerk und Nachleben, cur. W. Braunfels, II. Das geistige Leben, cur. B. Bischoff, Düsseldorf 1965, pp. 67-73; G. VINAY, Intermezzo: omaggio alla poesia, in G. VINAY, Alto Medioevo latino. Conversa-zioni e no, Napoli 1978, pp. 160-170 (quindi in G. VINAY, Alto Medioevo latino. Conversazioni e no, nuova ed. a cura di I. Pagani e M. Oldoni, con la collaborazione di C. Bottiglieri e I. Ventura, Napoli 2003, pp. 133-152); P. GODMAN, Poets and Emperors. Frankish Politics and Carolingian Poetry, Oxford 1987, pp. 49-55; M. GIOVINI, «Sophia» come «Daphnis», «Io» e «Alcimus». Risonanze classiche in alcuni epicedi “al femminile” di Paolo Diacono, in «Maia», n.s., 49 (1997), pp. 111-118; Marco GIOVINI, «Quel ramo del lago di Como» vi-sto da Paolo Diacono, in «Maia», n.s., 49 (1997), pp. 119-128; R. MATERAZZO, Paolo Diacono a Benevento tra progetti politici e attività culturali, in «Rivista Storica del Sannio» 5 (1998), pp. 37-66; M. GIOVINI, Gli «inculta poemata» di Paolo Diacono: Prudenzio e Virgilio in una dichiarazione di «poetica del dissidio», in «Maia», n.s., 52 (2000), pp. 85-97; P. MASTANDREA, Classicismo e cristianesimo nella poesia di Paolo Dia-cono, in Paolo Diacono. Uno scrittore fra tradizione longobarda e rinnovamento carolingio. Atti del Conve-
18
gno Internazionale di Studi. Cividale del Friuli - Udine, 6-9 maggio 1999, a cura di P. Chiesa, Udine -2000, pp. 293-311; K. SMOLAK, Poetologisches zu den Benedekthymnen in der «Historia Langobardorum» des Pau-lus Diaconus, in Paolo Diacono. Uno scrittore fra tradizione longobarda e rinnovamento carolingio. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Cividale del Friuli - Udine, 6-9 maggio 1999, a cura di P. Chiesa, Udine 2000, pp. 505-525; Fr. STELLA, La poesia di Paolo Diacono: nuovi manoscritti e attribuzioni incerte, in Paolo Diacono. Uno scrittore fra tradizione longobarda e rinnovamento carolingio. Atti del Convegno Internaziona-le di Studi. Cividale del Friuli - Udine, 6-9 maggio 1999, a cura di P. Chiesa, Udine 2000, pp. 551-574; A. BI-
SANTI, Note e appunti di lettura su testi mediolatini, in «Filologia Mediolatina» 8 (2001), pp. 111-122 (alle pp. 111-114); Fr. STELLA, Carmina, in P. CHIESA - Fr. STELLA, Paulus Diaconus, in Te.Tra. 2. La trasmissione dei testi del Medioevo. Mediaeval Latin Texts and their Transmission, vol. II, a cura di P. Chiesa - L. Castaldi, Fi-renze 2005, pp. 502-506. 2. Epistolae Repertorium Fontium VIII 522. Mss. - Ed. DÜMMLER (cfr. infra); O. DOBIAŠ ROŽDESTVENSKY, La main de Paul Diacre sur un codex du VIIIe siècle envoyé à Adalhard, in «Memorie Storiche Forogiuliesi» 25 (1929), pp. 129-143; O. DOBIAŠ ROŽDEST-
VENSKY, Itinéraire de Paul fils de Warnefrid en 787-788 et les premiers pas de la minuscule de Cividale en Friuli, in «Memorie Storiche Forogiuliesi» 27 (1931), pp. 55-72 [sul ms. di Sankt-Peterburg; ma cfr. anche L. PANI, Elementi insulari nel codice cividalese dell’«Historia Langobardorum» di Paolo Diacono, in «Memorie Storiche Forogiuliesi» 76 (1997), pp. 16-17, nota 9]; J. NEUFVILLE, in Sources Chrét. 181 (1972), pp. 320-327 [H. HOFFMANN, Autographa des früheren Mittelalters, in «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters» 57 (2001), pp. 17-19]. Edd. - E. DÜMMLER, MGH Epist., 4, 1895, pp. 505-516; K. NEFF, Die Gedichte des Paulus Diaconus. Kritische und erklärende Ausgabe, München 1908 pp. 12-13 (epist. 1), 71-73 (epist. 2), 129-130 (epist. 3) K. HALLINGER - M. WEGENER, in Corp. Consuet. Monast. 1 (1963) 129-136 (epist. 5). Studi: ed. DÜMMLER; K. NEFF, Die Gedichte des Paulus Diaconus, München 1908; J. NEUFVILLE, L’authenticité de l’«Epistula ad regem Karolum de monasterio sancti Benedicti directa et a Paulo dictata», in «Studia Monastica» 13 (1971), pp. 295-309 (sull’epist. 5). 3. Excerpta ex libris Pompei Festi de verborum significatione
Repertorium Fontium VIII 522. Per gli scolii all’opera contenuti in un ms. delle Etymologiae di Isidoro di Siviglia presso la Biblioteca Valli-celliana di Roma (cod. A 18, del sec. XII, Scholia Vallicelliana), cfr. J. WATHMOUGH, Scholia in Isidori Etymo-logias Vallicelliana, in «Archivum Latinitatis Medii Aevi» 2 (1925-1926), pp. 57-75, 134-169; Cl. VILLA, Uno schedario di Paolo Diacono. Festo e Grauso di Ceneda, in «Italia Medioevale e Umanistica» 27 (1984), pp. 56-80; e P. LENDINARA, Gli «Scholia Vallicelliana» e i primi glossari anglosassoni, in Paolo Diacono. Uno scrittore fra tradizione longobarda e rinnovamento carolingio. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Ci-vidale del Friuli - Udine, 6-9 maggio 1999, a cura di P. Chiesa, Udine 2000, pp. 251-278. Mss. - Città del Vaticano, Bibl. Apost. Vat. lat. 5958 [contiene anche un frammento dell’opera di Festo; cfr. ed. LINDSAY (1913) XLX-XXI; ed. Lindsay (1930), cfr. infra; W. BRACKE, La première “edition” humaniste du «De verborum signifìcatione» de Festus (Vat. lat. 5958), in «Revue d’Histoire des Textes» 25 (1995), pp. 189-206]; H. HOFFMANN, Schreibschulen des 10. und des 11. Jahrhunderts im Südwesten des Deutschen Reiches, MGH Schriften, 53/1, 2004, p. 134 (sul ms. Einsiedeln, Stiftsbibl., 364). Edd. - W.M. LINDSAY, Sexti Pompei Festi de verborum significatu quae supersunt cum Pauli epitome, Lipsiae 1913, pp. 2-121; W.M. LINDSAY, Glossaria Latina iussu Academiae Britannicae edita, IV, Paris 1930, pp. 73-467 (con gli Scholia Vallicelliana). Transl. - Scritture e scrittori dei secoli VII-X, a cura di A. Viscardi - Br. Nardi - G. Vidossi, Torino 19772, pp. 92-93 (epistola dedicatoria a Carlo). Studi: K. NEFF, De Paulo Diacono Festi epitomatore. Dissertatio inauguralis quam ad summos in philosophia honores ab amplissimo philosophorum ordine Lipsiensi rite impetrandos scripsit, Erlangae 1891; W.M. LIND-
SAY, New Evidence for the Text of Festus, in «Classical Quarterly» 10 (1916), pp. 106-115; B. BISCHOFF, Die Hofbibliothek Karls des Grossen, in Karl der Grosse, Lebenswerk und Nachleben, cur. W. Braunfels, II. Das geistige Leben, cur. B. Bischoff, Düsseldorf 1965, pp. 43-48; H. BLOCH, Monte Cassino’s Teachers and Libra-ry, in La scuola nell’Occidente latino nell’Alto Medioevo. Settimane di Studio sull’Alto Medioevo, XIX (Spole-to, 1971), II, Spoleto 1972, pp. 569-570; G. CAVALLO, La trasmissione dei testi nell’area beneventano-cassinese, in La cultura antica nell’Occidente latino dal VII all’XI secolo. Settimane di Studio sull’Alto Me-dioevo, XXII (Spoleto, 1974), Spoleto 1975, I, pp. 362-363; R. CERVANI, L’epitome di Paolo Diacono del «De verborum significatu» di Pompeo Festo. Struttura e metodo, Roma 1978, soprattutto pp. 147-167 [cfr. la re-cens. di C.G. MOR, in «Memorie Storiche Forogiuliesi» 58 (1978) 186-187]; A. MOSCADI, Verrio, Festo e Paolo, in «Giornale Italiano di Filologia» 31 (1979), pp. 17-36; A. MOSCADI, Problemi filologici nell’«Epitome» di Paolo Diacono del «De verborum significatione» di Sesto Pompeo Festo, in La cultura in Italia tra Tardo Antico e Alto Medioevo. Atti del Congresso tenuto a Roma, Consiglio Nazionale delle Ricer-
19
che, dal 12 al 16 Novembre 1979, Roma 1981, pp. 467-474; L. VISCIDO, Influenza delle «Institutiones» cas-siodoree su Paolo Diacono, in «Vichiana» 3 (1992), pp. 247-254; S. LANCIOTTI, Tra Festo e Paolo, in Paolo Diacono. Uno scrittore fra tradizione longobarda e rinnovamento carolingio. Atti del Convegno Internaziona-le di Studi. Cividale del Friuli - Udine, 6-9 maggio 1999, a cura di P. Chiesa, Udine 2000, pp. 237-250; A. AI-
RES NASCIMENTO, Festus ex recensione Pauli. Fragmenta de letra carolina em arquivos portugueses, in «Euphrosyne» 33 (2005), pp. 429-446; P. CHIESA, Epitoma de verborum significatu, in P. CHIESA - Fr. STEL-
LA, Paulus Diaconus, in Te.Tra. 2. La trasmissione dei testi del Medioevo. Mediaeval Latin Texts and their Transmission, vol. II, a cura di P. Chiesa - L. Castaldi, Firenze 2005, pp. 482-485; M.-K. LHOMME, De Verrius Flaccus à Paul Diacre: les “vulgarismes” dans le lexique de Festus et leur traitement par Paul Diacre, in La-tin vulgaire – Latin tardif. Actes du VIIIeme Colloque International sur le Latin vulgaire et tardif (Oxford, 6-9 september 2006), ed. by R. Wright, Hildesheim 2008, pp. 492-499; J.A. NORTH, Restoring Festus from Paul’ «Epitome», in «Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae» 48 (2008), pp. 157-170. 4. Expositio Artis Donati (seu Incipit Ars Donati quam Paulus Diaconus exposuit) Repertorium Fontium VIII 523. Mss. - Città del Vaticano, Bibl. Apost., Pal. lat., 1746, ff. 27-40 saec. VIII ex; ed. BUFFA GIOLITO (cfr. infra), pp. 16-21. Edd. - A.M. AMELLI, Ars Donati quam Paulus Diaconus exposuit, Montis Casini 1899; M.Fr. BUFFA GIOLITO, Expositio Artis Donati seu Incipit Ars Donati quam Paulus Diaconus exposuit, Genova 1990, pp. 53-96 (cfr. la recens. di A. BISANTI, in «Schede Medievali» 20-21 [1991], pp. 236-237). Transl. - ed. BUFFA GIOLITO, pp. 97-168. Studi: A. LENTINI, La grammatica d’Ilderico documento dell’attività letteraria di Paolo Diacono, in Atti del II Congresso Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo (Grado - Aquileia - Gorizia - Cividale - Udine, 7-11 Set-tembre 1952), Spoleto 1953, pp. 217-240 (poi in A. LENTINI, Medioevo letterario cassinese. Scritti vari, Mon-tecassino 1988, pp. 451-476); D. BIANCHI, Paolo Diacono e l’«Ars Donati», in «Atti e Memorie della Deputa-zione per le Province Modenesi», ser. VIII, 10 (1958), pp. 185-202; D. BIANCHI, Paolo Diacono e Prisciano, in «Memorie Storiche Forogiuliesi» 43 (1958-1959), pp. 159-172; B. BISCHOFF, Die Hofbibliothek Karls des Großen, in Karl der Große, Lebenswerk und Nachleben, cur. W. Braunfels, II. Das geistige Leben, cur. B. Bi-schoff, Düsseldorf 1965, p. 47; H. BLOCH, Monte Cassino’s Teachers and Library, in La scuola nell’Occidente latino nell’Alto Medioevo. Settimane di Studio sull’Alto Medioevo, XIX (Spoleto 1971), II, Spoleto 1972, p. 568; G. CAVALLO, La trasmissione dei testi nell’area beneventano-cassinese, in La cultura antica nell’Occidente latino dal VII all’XI secolo. Settimane di Studio sull’Alto Medioevo, XXII (Spoleto 1974), I, Spoleto 1975, pp. 361-362; B. LÖFSTEDT, Notizen zu mittelalterlichen Grammatiken, in «Archivum Latinitatis Medii Aevi» 42 (1979-1980, ma pubbl. 1982); L. HOLTZ, Donat et la tradition de l’enseignement grammati-cal. Étude sur l’«Ars Donati» et sa diffusion (IV-IX siècles) et édition critique, Paris 1981, pp. 438, 467; Ed. BUFFA GIOLITO, pp. 171-247; V. LAW, The Sources of the «Ars Donati quam Paulus Diaconus exposuit», in «Filologia Mediolatina» 1 (1994), pp. 71-80; L. MUNZI, Testi grammaticali e “renovatio studiorum” carolin-gia, in Manuscripts and Tradition of Grammatical Texts from Antiquity to the Renaissance. Proceedings of a Conference held at Erice, 16-23 october 1997, as the 11th Course of International School for the Study of Writ-ten Records, edd. M. De Nonno - P. De Paolis - L. Holtz, I, Cassino 2000, pp. 368-369; P. CHIESA, Expositio artis Donati, in P. CHIESA - Fr. STELLA, Paulus Diaconus, in Te.Tra. 2. La trasmissione dei testi del Medioevo. Mediaeval Latin Texts and their Transmission, vol. II, a cura di P. Chiesa - L. Castaldi, Firenze 2005, p. 485. 5. Gesta episcoporum Mettensium Repertorium Fontium VIII 523. Mss. - Ed. PERTZ, pp. 260-261. Edd. - FREHER, Corp. (1613) 171-177; CALMET, Histoire, 1 (1728) Preuves pp. 51-60; G. PERTZ, MGH SS., 2, 1829, pp. 260-268 (col titolo Liber de episcopis Mettensibus); MIGNE, PL, 95, coll. 699-710, 710-722 (dalle edd. Pertz e Calmet). Studi: H.-W. HERMANN, Zum Stande der Erforschung der früh- und hochmittelalterlichen Geschichte des Bis-tum Metz, in «Rheinische Vierteljahresblätter» 28 (1963), pp. 131-199; O. G. OEXLE, Die Karolinger und die Stadt des heiligen Arnulf, in «Frühmittelalterliche Studien» 1 (1967), pp. 250-364; K. U. JÄSCHKE, Die Karo-lingergenealogien aus Metz und Paulus Diaconus, in «Rheinische Vierteljahrsblätter» 34 (1970), pp. 190-218; A. POENSGEN, Geschichtskonstruktionen des frühen Mittelalters zur Legitimierung kirchlicher Ansprüche zu Metz, Reims und Trier, Augsburg 1973 [Marburg Diss. 1971]; M. SOT, Historiographie épiscopale et modèle familial en Occident au IXe s., in «Annales. Economies, Sociétés, Civilisations» 33 (1978), pp. 433-449; W. GOFFART, Paul the Deacon’s «Gesta episcoporum Mettensium» and the Early Design of Charlemagne’s Suc-cession, in «Traditio» 42 (1986), pp. 59-94; M. SOT, Gesta episcoporum, Gesta abbatum, Turnhout 1981, pp. 33-35; H. FLAMMARION, Les sources narratives en Lorraine autour de l’an Mil, in Religion et culture autour de l’an Mil. Royaume capétien et Lotharingie. Actes du Colloque Hugues Capet 987-1987: La France de l’An Mil, Auxerre 26-27 juin 1987 / Metz, 11-12 septembre 1987, curr. D. Iogna-Prat - J.-Ch. Picard, Paris 1990, p. 302; G. ARNALDI, Annali, cronache, storie, in Lo Spazio Letterario del Medioevo. 1. Il Medioevo latino, 1/2,
20
La produzione del testo, Roma 1993, pp. 485-489; M.T. FATTORI, I santi antenati carolingi fra mito e storia: agiografie e genealogie come strumento di potere dinastico, in «Studi Medievali», n.s., 34 (1993), pp. 509-511; M. SOT, Le «Liber de episcopis Mettensibus» dans l’histoire du genre “Gesta episcoporum”, in Paolo Diacono. Uno scrittore fra tradizione longobarda e rinnovamento carolingio. Atti del Convegno Internaziona-le di Studi. Cividale del Friuli - Udine, 6-9 maggio 1999, a cura di P. Chiesa, Udine 2000, pp. 527-549; D. KEMPF, Paul the Diacon’s Liber de episcopis Mettensibus and the role of Metz in the Carolingian Realm, in «Journal of Medieval History» 30 (2004), pp. 279-299; M. SOT, Faut-il rééditer le Livre des évêques de Metz de Paul Diacre?, in Retour aux sources. Textes, études et documents d’histoire médiévale offerts à Michel Pa-risse, Paris 2004, pp. 971-977; P. CHIESA, Gesta Episcoporum Mettensium, in P. CHIESA - Fr. STELLA, Paulus Diaconus, in Te.Tra. 2. La trasmissione dei testi del Medioevo. Mediaeval Latin Texts and their Transmission, vol. II, a cura di P. Chiesa - L. Castaldi, Firenze 2005, pp. 495-497; M. EMBACH, Trierer Literaturgeschichte. Das Mittelalter, in Geschichte und Kultur des Trierer Landes, 8, Trier 2007, pp. 195-196; S. ELLING, Institu-tion versus Individuum, Diözese versus Dynastie. Zu Motiven der Wahrnehmung von Vergangenheit in Paulus Diaconus’ «Liber de Episcopis Mettensibus», in Zwischen Wort und Bild. Wahrnehmungen und Deutungen im Mittelalter, hrsg. H. Bleumer [et alii], Köln - Weimar - Wien 2010, pp. 203-238. 6. Historia Langobardorum
Repertorium Fontium VIII 524. Mss. - L. BETHMANN, Pauli Diaconi hist. Langobardorum, in «Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde» 7 (1839), pp. 274-358; G. WAITZ, Über die handschriftliche Überlieferung und die Sprache der «Historia Langobardorum» des Paulus, in «Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Ges-chichtskunde» 1 (1876), pp. 531-566; G. WAITZ, in ed. BETHMANN - WAITZ (1878), pp. 28-43, e ancora (1878), pp. 22-47; G. CALLIGARIS, Di un nuovo manoscritto della «Historia Langobardorum» di Paolo Diaco-no, in «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo» 10 (1891), pp. 31-92; R. MORGHEN, Il palin-sesto assisiense della «Historia Langobardorum» di Paolo Diacono, in «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo» 38 (1918), pp. 11-23 (sul più antico frammento conservatoci dell’Historia Langobardorum); L. PANI, Elementi insulari nel codice cividalese dell’«Historia Langobardorum» di Paolo Diacono, in «Memo-rie Storiche Forogiuliesi» 76 (1997), pp. 11-23; R. DEUTINGER, Rahewin von Freising. Ein Gelehrter des 12. Jahrhunderts, in MGH Schriften, 47, Hannover 1999, pp. 54-61 (sul cod. New York, Library of the Union Theological Seminary, 39, saec. XIII); L. PANI, Aspetti della tradizione manoscritta dell’«Historia Langobar-dorum», in Paolo Diacono. Uno scrittore fra tradizione longobarda e rinnovamento carolingio. Atti del Con-vegno Internazionale di Studi. Cividale del Friuli - Udine, 6-9 maggio 1999, a cura di P. Chiesa, Udine 2000, pp. 367-412; P. CHIESA, Caratteristiche della trasmissione dell’«Historia Langobardorum», in Paolo Diacono e il Friuli altomedievale (secc. VI-X). Atti del XIV Congresso Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo (Civi-dale del Friuli - Bottenicco di Moimacco, 24-29 settembre 1999), Spoleto 2001, pp. 45-66; K. FRIJS-JENSEN, The Danish Connection. The Gotha Manuscript of Paul the Deacon and its History, in Care and Conservation of Manuscripts. Proceedings of the Eight International Seminar held at the University of Copenhagen (16-17 october 2003), edd. G. Fellows-Jensen - P. Spingborg, Copenhagen 2005, pp. 166-174. Edd. - L.A. MURATORI, R.I.S. 1 (1723), pp. 405-511; MIGNE, PL, t. 95, coll. 433-467 (riproduzione dell’ed. Muratori); L. BETHMANN - G. WAITZ, MGH Script. rer. Lang., 1878, pp. 12-187; L. BETHMANN - G. WAITZ, Pauli Historia Langobardorum, MGH Script. rer. Germ., 48, 1878, pp. 49-242; A. CRIVELLUCCI, Roma 1918 (ed. scolastica, solo i libri I-III); W. F. SCHWARZ, Paulus Diaconus. Geschichte der Langobarden. Historia Langobardorum, Darmstadt 2009. Transl. - Tedesche: O. ABEL, Paulus Diakonus und die übrigen Geschichtschreiber der Langobarden, Leipzig 1939 [rist., Essen 1986, 1992]; C. DIRLMEIER - K. SPRIGADE, in Quellen zur Geschichte der Alemannen, 3, Heidelberg - Sigmaringen 1979, pp. 87-90; Inglesi: W. D. FOULKE, Paul the Deacon. History of the Lango-bards, Philadelphia 1907 (2nd edition 1974); Francesi: F. BOUGARD, Paul Diacre. Histoire des lombards, Tur-nhout 1994; Italiane: A. VIVIANI, Paolo Diacono, Dell’origine e de’ fatti dei Longobardi, 2 voll., Udine 1826-1828; G.S. UBERTI, Paolo Diacono, De’ fatti de’ Longobardi, Cividale 1899; M. FELISATTI, Paolo Diacono, Storia dei Longobardi, Milano 1967 (nuova ed. rivista da L. Tenconi - R. Cassanelli, con una introd. di Cl. Leonardi, Milano 1985); F. RONCORONI, Paolo Diacono, Storia dei Longobardi, introd. di E. Fabiani, Milano 1971; Scritture e scrittori dei secoli VII-X, a cura di A. Viscardi - Br. Nardi - G. Vidossi, Torino 19772, pp. 102-121 (passi scelti); E. BARTOLINI-A. GIACOMINI, Paolo Diacono. Storia dei Longobardi, Milano 1988; I. PIN, Paolo Diacono, Storia dei Longobardi, Pordenone 1990; Br. LUISELLI - A. ZANELLA, Paolo Diacono. Sto-ria dei Longobardi, Milano 1991, pp. 141-547; L. CAPO, Paolo Diacono. Storia dei Longobardi, Milano 1992, pp. 7-365 [cfr. la recens. di A. BISANTI, in «Orpheus», n.s., 15 (1994), pp. 201-207]; G. GERMANO, Lo spirito, la storia, la tradizione. Antologia della letteratura latina medievale, vol. I, Napoli 2007, pp. 213-231 [passi scelti: cfr. la recens. di A. BISANTI, in «Mediaeval Sophia» 4 (2008), pp. 276-279]; F. BONALUMI, Paolo Dia-cono, Storia dei Longobardi, Cinisello Balsamo (MI) 2008. Studi: K. JACOBI, Die Quellen der Langobardengeschichte des Paulus Diaconus, Halle 1877; G. WAITZ, in ed. BETHMANN - WAITZ (1878), pp. 25-28 e anche (1878), pp. 18-22; Th. MOMMSEN, Die Quellen der Langobar-dengeschichte des Paulus Diaconus, in «Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde» 5
21
(1880), pp. 53-103 (poi in Th. MOMMSEN, Historische Schriften, III [= Gesammelte Schriften, VI], Berlin 1910, pp. 485-539; C. RINAUDO, Di alcune fonti della Storia dei Longobardi di Paolo Diacono, Torino 1882; N. TAMASSIA, Un capitolo di storia longobarda di Paolo Diacono, Bologna 1889; D. BIANCHI, Leggende lon-gobarde in Italia, in «Memorie Storiche Forogliuliesi» 20 (1924), pp. 41-89; D. BIANCHI, Riflessi romani nella «Historia Langobardorum», in «Memorie Storiche Forogliuliesi» 25 (1929), pp. 23-58; D. BIANCHI, Senso sto-rico di Paolo Diacono, in «Memorie Storiche Forogliuliesi» 27-29 (1931-1933), pp. 207-221; D. BIANCHI, Storia, leggenda e meraviglioso in Paolo Diacono, in «Memorie Storiche Forogliuliesi» 30 (1934), pp. 1-16; D. BIANCHI, L’elemento epico nella «Historia Langobardorum», in «Memorie Storiche Forogiuliesi» 30 (1934), pp. 119-168; 31 (1935), pp. 1-74; 32 (1936), pp. 1-71; D. BIANCHI, Da Paolo Diacono all’Anonimo Salernitano, in «Memorie Storiche Forogliuliesi» 33-34 (1937-1938), pp. 27-64; G. PONTONI, Introduzione agli studi su Paolo Diacono storico dei Longobardi, Napoli 1946; G.P. BOGNETTI, Processo logico e integra-zione delle fonti nella storiografìa di Paolo Diacono, in Miscellanea di Studi Muratoriani. Atti e Memorie del Convegno di studi storici in onore di Ludovico Antonio Muratori, nel bicentenario della morte, Modena 1951, pp. 357-381 (poi in G.P. BOGNETTI, L’età longobarda, III, Milano 1967, pp. 157-184); D. BIANCHI, Di alcuni caratteri stilistici della «Historia Langobardorum», in «Memorie Storiche Forogliuliesi» 40 (1952-1954), pp. 23-58; D. BIANCHI, Per il testo della «Historia Langobardorum» di Paolo Diacono, in Atti del II Congresso Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo (Grado - Aquileia - Gorizia - Cividale - Udine, 7-11 Settembre 1952), Spoleto 1953, pp. 121-137; P. LAMMA, Il mondo bizantino in Paolo Diacono, in Atti del II Congresso Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo (Grado - Aquileia - Gorizia - Cividale - Udine, 7-11 Settembre 1952), Spoleto 1953, pp. 199-215; P.S. LEICHT, Paolo Diacono e gli altri scrittori delle vicende d’Italia nell’età carolingia, in Atti del II Congresso Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo (Grado - Aquileia - Go-rizia - Cividale - Udine, 7-11 Settembre 1952), Spoleto 1953, pp. 57-74; I. PERI, Fatti giuridici e fatti sociali nella «Storia dei Longobardi» di Paolo Diacono, in Atti del II Congresso Internazionale di Studi sull’Alto Me-dioevo (Grado - Aquileia - Gorizia - Cividale - Udine, 7-11 Settembre 1952), Spoleto 1953, pp. 265-274; D. BIANCHI, L’epitafio di Ilderico e la leggenda di Paolo Diacono, in «Archivio Storico Lombardo», ser. VIII, 3 (1954-1955), pp. 56-115; D. BIANCHI, Da Gregorio di Tours a Paolo Diacono, in «Aevum» 35 (1961), pp. 150-166; E. SESTAN, La storiografìa dell’Italia longobarda: Paolo Diacono, in La storiografia altomedievale. Settimane di Studio sull’Alto Medioevo (Spoleto 1969), I, Spoleto 1970, pp. 357-386 (poi in E. SESTAN, Scritti vari. Alto Medioevo, Firenze 1988, pp. 51-71); M. CAGIANO DE AZEVEDO, Gli edifici menzionati da Paolo Diacono nella «Historia Langobardorum», in Atti del Convegno di Studi Longobardi (Udine-Cividale 1969), Udine 1970; R. MORGHEN, La civiltà dei Longobardi nella «Historia Langobardorum» di Paolo Diacono, in La civiltà dei Longobardi in Europa. Atti del Convegno (Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1974), Roma 1974, pp. 9-23; L. ALFONSI, Romani e barbari nella «Historia Langobardorum» di Paolo Diacono, in «Roma-nobarbarica» 1 (1976), pp. 7-23; O. GSCHWANTLER, Die Heldensage von Alboin und Rosimund, in Festgabe für Otto Höfler, hrsg. H. Birkhan, Wien-Stuttgart 1976, pp. 214-247; P.M. CONTI, La storia dei Longobardi nella narrazione di Paolo Diacono, in «Bollettino Storico Pisano» 47 (1978), pp. 35-55; H. MENKE, Eine sächsische Redaktion der «Historia Langobardorum», in Name und Geschichte. Henning Kaufmann zum 80. Geburstag, cur. F. Debus - K. Puhner, München 1978, pp. 115-123; G. VINAY, Un mito per sopravvivere: l’«Historia Langobardorum» di Paolo Diacono, in G. VINAY, Alto Medioevo latino. Conversazioni e no, Na-poli 1978, pp. 125-149 (poi anche in G. VINAY, Peccato che non leggessero Lucrezio, a cura di Cl. Leonardi, Spoleto 1989, pp. 97-122; e ancora in G. VINAY, Alto Medioevo latino. Conversazioni e no, nuova ed. a cura di I. Pagani e M. Oldoni, con la collaborazione di C. Bottiglieri e I. Ventura, Napoli 2003, pp. 107-129); L. ZUR-
LI, Le “proprietà” del motivo dello “scambio di persona” nella narrativa classica e nel “racconto storico” di Paolo Diacono, in Materiali e contributi per la storia della narrativa greco-latina, II, Perugia 1978, pp. 73-104; C.M. MONTI, Il codice di Berkley, Bancroft Library f 2 ms AC 13 c 5, in «Italia Medioevale e Umanisti-ca» 22 (1979), pp. 396-412; L. ALFONSI, Aspetti del pensiero storiografico di Paolo Diacono, in La storiogra-fia ecclesiastica nella tarda antichità. Atti del convegno tenuto in Erice (3-8 XII, 1978), Messina 1980, pp. 11-25; O. LIMONE, Componenti agiografìche della «Historia Langobardorum» di Paolo Diacono, in Atti del VI Congresso Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo (Milano, 21-25 ottobre 1978), Spoleto 1980, pp. 457-470; F. VAN DER RHEE, Die germanischen Wörter in der «Historia Langobardorum» des Paulus Diaconus, in «Romanobarbarica» 5 (1980), pp. 271-296; K. H. KRÜGER, Zur “beneventanischen” Konzeption der Lango-bardengeschichte des Paulus Diaconus, in «Frühmittelalterliche Studien» 15 (1981), pp. 18-35; K. GARDINER, Paulus the Deacon and Secundus of Trento, in History and Historians in Late Antiquity. Papers from the con-ference Old and New in Late Antique Historiography, cur. B. Croke - A. E. Emmett, Sidney 1983, pp. 147-153; R. CERVANI, La fonte tridentina della «Historia Langobardorum» di Paolo Diacono, in «Atti dell’Accademia Roveretana degli Agiati» 236 (1986), pp. 97-104; D. BULLOUGH, Ethnic History and the Caro-lingians: an Alternative Reading of Paul the Deacon’s «Historia Langobardorum», in The Inheritance of His-toriography 350-900, cur. C. Holdsworth - T. Wiseman, Exeter 1986, pp. 85-106 (poi in D. BULLOUGH, Caro-lingian Renewal: Sources and Heritage, Manchester 1991, pp. 97-122); W. GOFFART, The Narrators of Bar-barian History (A.D. 550-800). Jordanes, Gregory of Tours, Bede and Paul the Deacon, Princeton (N. J.) 1988, pp. 329-341; A. QUACQUARELLI, L’etopeia nella «Historia Langobardorum» di Paolo Diacono, in «Ve-tera Christianorum» 25 (1988), pp. 267-288 (poi in Sapientia et eloquentia. Studi per il 70° genetliaco di Anto-
22
nio Quacquarelli, a cura di G. Otranto [et alii], Bari 1988); G. ZANELLA, La legittimazione del potere regale nelle «Storie» di Gregorio di Tours e Paolo Diacono, in «Studi Medievali», n.s., 31 (1990), pp. 55-84; P. DE-
LOGU, Longobardi e Romani: altre congetture, in Langobardia, a cura di P. Cammarosano - S. Gasparri, Udine 1990, pp. 111-167; A. TAGLIAFERRI, Rileggendo Paolo Diacono. Alla ricerca dell’identità longobarda, in «Fo-rum Julii» 14 (1990), pp. 101-117; Br. LUISELLI, La società longobardica del secolo VIII e Paolo Diacono sto-riografo tra romanizzazione e nazionalismo longobardico, in PAOLO DIACONO, Storia dei Longobardi, a cura di Br. Luiselli - A. Zanella, Milano 1991, pp. 5-48; A. ZANELLA, Cronologia, Cenni biografici su Paolo, Pre-messa al testo, Testimonianze e giudizi critici, Notizia bibliografica, in PAOLO DIACONO, Storia dei Longobar-di, a cura di Br. Luiselli - A. Zanella, Milano 1991, pp. 49-70, 71-100, 101-121, 123-132, 133-137; L. CAPO, Introduzione, in PAOLO DIACONO, Storia dei Longobardi, a cura di L. Capo, Milano 1992, pp. VIII-L; A. PE-
RELLI, Da Scilla ad Erminia (passando per Romilda), in «Rivista di Cultura Classica e Medioevale» 34 (1992), pp. 105-143; M.L. ANGRISANI SANFILIPPO, Un contrasto fra Longobardi e Gepidi: Paolo Diacono, «Historia Langobardorum» I 24, in «Romanobarbarica» 12 (1992-1993), pp. 153-172; H. ROGAN, “Paulus Diaconus laudator temporis acti”. Königsdarstellung und Aufbauprinzip der Buchschlüsse als Antwort auf die Frage nach dem von Paulus intendierten Ende der «Historia Langobardorum», Graz 1993; P. CAMMAROSANO, Gli antenati di Paolo Diacono: una nota sulla memoria genealogica nel Medioevo Italiano, in Nobiltà e chiese nel Medioevo e altri saggi. Scritti in onore di Gerd Tellenbach, a cura di C. Violante, Roma 1993, pp. 37-45; S. CINGOLANI, Le Storie dei Longobardi. Dall’Origine a Paolo Diacono, Roma 1994; W. POHL, Tradition, Eth-nogenese und literarische Gestaltung, in Ethnogenese und Überlieferung. Angewandte Methoden der Frühmittelalterforschung, hrsgg. K. Brunner - B. Merta, Wien - München 1994, pp. 9-29; W. POHL, Paulus Diaconus und die «Historia Langobardorum»: Text und Tradition, in Historiographie im frühen Mittelalter, hrsgg. A. Scharer - G. Scheibelreiter, Wien - München 1994, pp. 375-405; A. BRACCIOTTI, Il ruolo di Peredeo nell’uccisione di Alboino, in «Romanobarbarica» 13 (1994-1995), pp. 99-123; M. OLDONI, I luoghi della cul-tura orale, in Centri di produzione della cultura nel Mezzogiorno normanno-svevo. Atti del XII Convegno del Centro di Studi Normanno-Svevo (Bari 17-20 ottobre 1995), a cura di G. Musca - V. Sivo, Bari 1997, pp. 373-387; F. CURTA, Slavs in Fredegar and Paul Diacon: Medieval “gens” or “scourge of God”, in «Early Medie-val Europe» 6 (1997), pp. 141-167; R. MCKITTERICK, Paul the Deacon and the Franks, in «Early Medieval Europe» 8 (1999), pp. 319-335 (poi, in italiano e con aggiunte, col titolo Paolo Diacono e i Franchi: il conte-sto storico e culturale, in Paolo Diacono. Uno scrittore fra tradizione longobarda e rinnovamento carolingio. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Cividale del Friuli - Udine, 6-9 maggio 1999, a cura di P. Chiesa, Udine 2000, pp. 9-28); L. CAPO, Paolo Diacono e il mondo franco: l’incontro di due esperienze storiografiche, in Paolo Diacono. Uno scrittore fra tradizione longobarda e rinnovamento carolingio. Atti del Convegno In-ternazionale di Studi. Cividale del Friuli - Udine, 6-9 maggio 1999, a cura di P. Chiesa, Udine 2000, pp. 39-74; W. POHL, Memory, Identity and Power in Lombard Italy, in The Uses of the Past in the Early Middle Ages, cur. Y. Hen - M. Innes, Cambridge 2000, pp. 9-28; W. POHL, Paolo Diacono e la costruzione dell’identità lon-gobarda, in Paolo Diacono. Uno scrittore fra tradizione longobarda e rinnovamento carolingio. Atti del Con-vegno Internazionale di Studi. Cividale del Friuli - Udine, 6-9 maggio 1999, a cura di P. Chiesa, Udine 2000, pp. 413-426; P. ORTH, Mit Eugippius unterwegs. Ein Fund zur “Langobardengeschichte” des Paulus Dia-conus, in Scripturus vitam. Lateinische Biographie von der Antike bis in die Gegenwart. Festgabe für Walter Berschin zum 65. Geburtstag, cur. D. Walz, Heidelberg 2002, pp. 741-745; A. BISANTI, L’“interpretatio nomi-nis” nella tradizione classico-medievale e nel «Babio», in «Filologia Mediolatina» (2003), pp. 127-218 (alle pp. 135-139); L. GATTO, Germani e Romani per l’organizzazione dell’occidente cristiano nella «Historia Lan-gobardorum» di Paolo Diacono, in Ovidio Capitani quaranta anni per la storia medioevale, cur. M. C. De Matteis, II, Bologna 2003, pp. 203-228; R. MCKITTERICK, History and Memory in the Carolingian world, Cambridge 2004, pp. 60-83; P. RAJNA, Due scritti inediti. Le leggende epiche dei Longobardi. Storia del ro-manzo cavalleresco in Italia, a cura di P. Gasparini, premessa di L. Formisano, Roma 2004, pp. 41-251, 431-500; Paolo CHIESA, Historia Langobardorum, in P. CHIESA - Fr. STELLA, Paulus Diaconus, in Te.Tra. 2. La trasmissione dei testi del Medioevo. Mediaeval Latin Texts and their Transmission, vol. II, a cura di P. Chiesa - L. Castaldi, Firenze 2005, pp. 491-495; A. PLASSMANN, Origo gentis. Identitäts- und Legitimitätsstiftung in früh- und hochmittelalterlichen Herkunftserzählungen, Berlin 2006, pp. 191-242; E. PIAZZA, Paolo Diacono e i Franchi nel VI secolo, in «Quaderni Catanesi» 6 (2007), pp. 215-258; B.K. VOLLMANN, Paulus Diaconus und das Heldenlied, in Impulse und Resonanzen. Tübinger mediävistische Beiträge zum 80. Geburtstag von Walter Haug, cur. G. Vollmann-Profe [et alii], Tübingen 2007, pp. 45-56; A. PLASSMANN, Mittelalterliche origines gentium. Paulus Diaconus als Beispiel, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken» 87 (2007), pp. 1-35; A. BISANTI, Scilla e Romilda: due modelli per una lavandaia omicida. Sul-la “tragedia” «Due lotrices» di Giovanni di Garlandia, in «Studi Medievali», n.s., 49,2 (2008), pp. 657-677; ed. SCHWARZ (2009), pp. 7-110; A. BISANTI, L’“interpretatio nominis” nelle commedie elegiache latine del XII e XIII secolo, Spoleto 2009, pp. 12-19; F. HARTMANN, Vitam litteris ni emam, nihil est, quod tribuam. Pau-lus Diaconus zwischen Langobarden und Franken, in «Frühmittelalterliche Studien» 43 (2009), pp. 71-93; W. POHL, Paul the Deacon between “sacci” and “marsuppia”, in Ego Trouble. Authors and Their Identities in the Early Middle Ages, cur. R. Corradini [et alii], Wien 2010, pp. 111-123; F. MORES, Come lavorava Paolo Dia-
23
cono, in I Longobardi e la storia. Un percorso attraverso le fonti, cur. Fr. Lo Monaco - F. Mores, Roma 2012, pp. 123-139. 7. Historia Romana Repertorium Fontium VIII 526. Mss. - Ed. CRIVELLUCCI (cfr. infra), pp. IX-XXIII; A. CRIVELLUCCI, Per l’edizione della «Historia Romana» di Paolo Diacono, in «Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo» 40 (1921), pp. 7-104; C. H. BEESON, The Oldest Ms of Paulus Diaconus’ «Historia Romana», in «Memorie Storiche Forogiuliesi» 25 (1929), pp. 15-22; L.B. MORTENSEN, The Diffusion of Roman Histories in the Middle Ages. A List of Orosius, Eutropius, Paulus Diaconus and Landolf Sagax, in «Filologia Mediolatina» 6-7 (1999-2000), pp. 101-200. Edd. - H. DROYSEN, Eutropi Breviarium ab urbe condita cum Pauli additamentis et versionibus Graecis, MGH AA., 2, 1879, pp. 4-182, 185-224 lib. I-X (col testo di Eutropio), lib. XI-XVI; H. DROYSEN, Pauli Historia Ro-mana, MGH Script. rer. Germ., 49, 1879; A. CRIVELLUCCI, Pauli Diaconi Historia Romana, Roma 1914. Transl. - Scritture e scrittori dei secoli VII-X, a cura di A. Viscardi - Br. Nardi - G. Vidossi, Torino 19772, pp. 94-101 (passi scelti). Studi: G. BAUCH, Ueber die «Historia Romana» des Paulus Diaconus. Eine Quellenuntersuchung. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der philosophischen Doktorwürde an der Universität Göttingen, Göttingen 1873; G. PUCCIONI, San Girolamo, Paolo Diacono e l’«Origo gentis Romanae», in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa» 24 (1955), pp. 237-259; G. BRUGNOLI, L’archeologia italica di Paolo Diacono, in «Rivista Benedettina» (1958), pp. 185-203; E. SESTAN, Qualche aspetto della personalità di Paolo Diacono nella sua «Historia Romana», in Miscellanea in onore di Roberto Cessi, I, Roma 1958, pp. 9-28 (poi in E. SESTAN, Ita-lia medievale, Napoli 1966, pp. 50-75); G. BRUGNOLI, Paolo Diacono e l’«Origo gentis Romanae», in «Rivista di Cultura Classica e Medioevale» (1960), pp. 371-387; R. CERVANI, Romanità e cristianesimo nella prospetti-va storiografica altomedievale: l’«Historia Romana» di Paolo Diacono, in «Annali di Storia. Facoltà di Lette-re e Filosofia, Lecce» 4 (1981), pp. 5-40; L.B. MORTENSEN, Civiliserede barbarer. Historikeren Paulus Dia-conus og hans forgængere, København 1991; L.B. MORTENSEN, Impero romano, «Historia romana» e «Histo-ria Langobardorum», in Paolo Diacono. Uno scrittore fra tradizione longobarda e rinnovamento carolingio. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Cividale del Friuli – Udine, 6-9 maggio 1999, a cura di P. Chiesa, Udine 2000, pp. 355-366; P. CHIESA, Storia romana e libri di storia romana fra IX e XI secolo, in Roma antica nel Medioevo. Mito, rappresentazioni, sopravvivenze nella “Respublica Christiana” dei secoli XI-XIII. Atti della quattordicesima Settimana internazionale di studio. Mendola 24-28 Agosto 1998, Milano 2001, pp. 232-258; P. CHIESA, Historia Romana, in P. CHIESA - Fr. STELLA, Paulus Diaconus, in Te.Tra. 2. La trasmissione dei testi del Medioevo. Mediaeval Latin Texts and their Transmission, vol. II, a cura di P. Chiesa - L. Castaldi, Firenze 2005, pp. 486-491; B. CORNFORD, Paul the Deacon's understanding of identity, his attitude to barbar-ians, and his “strategies of distinction” in the «Historia Romana», in Texts and Identities in the Early Middle Ages, cur. R. Corradini [et alii], Wien 2006, pp. 47-60; M.T. KRETSCHMER, Rewriting Roman History in the Middle Ages. The «Historia Romana» and the ms. Bamberg, Hist. 3, Leiden-Boston 2007. 8. Homiliarium Mss. - Cfr. B. VALTORTA, Clavis, pp. 216-217. Edd. - MIGNE, PL 95 (1861), coll. 1159-1566 (299 testi, cioè i 244 trascritti da Paolo, con l’aggiunta di 55 bra-ni di origine carolingia); F. DAHN, Des Paulus Diaconus Leben und Schriften, Leipzig 1876, pp. 93-94 (solo la dedica a Carlo Magno); L. BETHMANN - G. WAITZ, MGH Script. rer. Lang., 1878, p. 12 (dedica a Carlo Ma-gno); E. DÜMMLER, MGH Poetae, 1, 1881, pp. 68-69 (dedica a Carlo Magno); F. WIEGAND, Das Homiliarium Karls des Grossen auf seine ursprüngliche Gestalt hin untersucht, Leipzig 1897, pp. 14-65; NEFF, Die Gedich-te, pp. 133-134 (dedica a Carlo Magno); R. GRÉGOIRE, L’«Homéliaire» de Paul Diacre, in ID., Homéliaires li-turgiques médiévaux. Analyse de manuscrits, Spoleto 1980, pp. 424-478. Studi: G. MORIN, Les sources non identifies de l’homéliaire de Paul Diacre, in «Revue Bénédictine» 15 (1898), pp. 400-403; A. DALL, Notes on the Vocabulary of the Homiliary of Paul the Deacon, in «Archivum Latinitatis Medii Aevi» 6 (1931), pp. 160-175; J. LECLERCQ, Tables pour l’inventaire des homiliaires manu-scrits, in «Scriptorium» 2,2 (1948), pp. 205-214; C.L. SMETANA, Aelfric and the Early Medieval Homiliary, in «Traditio» 15 (1959), pp. 164-180; R. GRÉGOIRE, Gli omiliari liturgici, in «Benedictina» 21 (1974), p. 15; R. QUADRI, Paolo Diacono e Lupo di Ferrières. A proposito di Parigi, BN lat 9604, in «Studi Medievali», n.s., 16 (1975), pp. 737-746; R. ETAIX, L’homéliaire d’Ebrardus retrouvé (Paris, BN lat 9604), in «Revue d’Histoire de Textes» 8 (1978), pp. 309-317; Th. HALL, The Development of the Common of Saints in the Early English Visions of Paul the Deacon’s «Homiliary», in Anglo-Saxon Books and their Readers, ed. by Th. Hall - D. Scragg, Kalamazoo (Michigan) 2008, pp. 31-67. 9. Sancti Gregorii Magni Vita Repertorium Fontium VIII 526. Mss. - ed. H. GRISAR, Praefatio, in Die Gregorbiographie des Paulus Diakonus (cfr. infra); A. BRACKMANN, Reise nach Italien von März bis Juni 1900, in «Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschich-
24
tskunde» 26 (1900-1901), pp. 330-333; O. LIMONE, La tradizione manoscritta della «Vita Gregorii Magni» di Paolo Diacono (BHL 3639). Censimento dei testimoni, in «Studi Medievali», n.s., 29 (1988), pp. 888-953; L. CASTALDI, Nuovi testimoni della «Vita Gregorii» di Paolo Diacono, in Paolo Diacono. Uno scrittore fra tradi-zione longobarda e rinnovamento carolingio. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Cividale del Friuli - Udine, 6-9 maggio 1999, a cura di P. Chiesa, Udine 2000, pp. 75-126. Edd. - in SANCTI GREGORII PAPAE I Opera omnia, IV, Paris 1705, pp. 1-16; MIGNE, PL, 75, coll. 41-59 (tratta dall’ed. precedente); H. GRISAR, Die Gregorbiographie des Paulus Diakonus in ihrer ursprünglichen Gestalt nach italienischen Handschriften, in «Zeitschrift für katholische Theologie» 11 (1887), pp. 162-173; S. TUZZO, Paolo Diacono. Vita sancti Gregorii Magni, Pisa 2002 (cfr. la recens. di P. ORTH, in «Deutsches Archiv» 61 [2005], pp. 679-680). Transl. - Ed. TUZZO; K. KEUFFER, Kniha o sprave pastýřské jakož i Pavla Diákona život vs. Řehoře vel., Prag 1909. Studi: W. STUHLFATH, Gregor I. der Grosse. Sein Leben bis zu seiner Wahl zum Papst nebst einer Unter-suchung der ältesten Viten, Heidelberg 1913; O. LIMONE, La vita di Gregorio Magno dell’Anonimo di Whitby, in «Studi Medievali», n.s., 19, 1 (1978), pp. 37-67; Cl. AZZARA, La figura di Gregorio Magno nell’opera di Paolo Diacono, in Paolo Diacono. Uno scrittore fra tradizione longobarda e rinnovamento carolingio. Atti del Convegno Internazionale di Studi. Cividale del Friuli - Udine, 6-9 maggio 1999, a cura di P. Chiesa, Udine 2000, pp. 29-38; P. CHIESA, Vita Gregorii, in P. CHIESA - Fr. STELLA, Paulus Diaconus, in Te.Tra. 2. La tra-smissione dei testi del Medioevo. Mediaeval Latin Texts and their Transmission, vol. II, a cura di P. Chiesa - L. Castaldi, Firenze 2005, pp. 497-501; A. AMBROSIO, Un frammento di codice in beneventana dalla Certosa di Padula all’Archivio di Stato di Napoli, in «Studi Medievali», n.s., 49,1 (2008), pp. 358-373.

































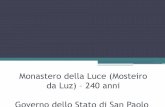







![Le mobilier métallique [de San Paolo, Méria, Haute-Corse]. In : Lechenault M. et al., San Paolo (Méria, Haute-Corse). Document final de Synthèse 2014. Evaluation archéologique,](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63224539078ed8e56c0a5419/le-mobilier-metallique-de-san-paolo-meria-haute-corse-in-lechenault-m.jpg)



