Per un curricolo verticale di riflessione sulla lingua (2012)
Ecclesia de Eucharistia vivit. Riflessione tomista sull'enciclica di Giovanni Paolo II
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Ecclesia de Eucharistia vivit. Riflessione tomista sull'enciclica di Giovanni Paolo II
1
Doctor Angelicus (Köln) 3 (2003) 5-28
Ecclesia de Eucharistia vivit. Introduzione alla riflessione tomista
sull’enciclica di Giovanni Paolo II
Krzysztof Charamsa
Roma
Cristo Gesù ha lasciato per la sua Chiesa il dono dell’Eucaristia nella sera di
quel giovedì che era il giorno ultimo prima della Sua Passione, Morte e Risurrezione
di Salvatore, e assieme il giorno che, col dono grandioso del Pane e del Vino –
essenzialmente – è diventato il primo giorno eucaristico1. «La Chiesa ha ricevuto
l’Eucaristia da Cristo suo Signore non come un dono, pur prezioso fra tanti altri, ma
come il dono per eccellenza, perché dono di se stesso, della sua persona nella sua
santa umanità, nonché della sua opera di salvezza»2.
Il Giovedì Santo che apre il dramma pasquale nell’anno 2003, è stato
festeggiato con la nuova, quattordicesima Lettera enciclica del Santo Padre Giovanni
Paolo II che torna a questa sorgente della vita della Chiesa. Torna alla sua esistenza
eucaristica, al suo fondamento e culmine3, alla fonte del suo essere in Cristo
4. Ci
piace pensare ad un nuovo dono per la Chiesa ricevuto dalle mani del Successore di
Pietro, di cui egli stesso spiega la genesi nel significativo momento di apparizione del
documento: «proclamando l’anno del Rosario (ottobre 2002 – ottobre 2003) ho
voluto porre il mio venticinquesimo anno del pontificato nel segno della
contemplazione di Cristo alla scuola di Maria, ora non posso lasciar passare questo
Giovedì Santo 2003 senza sostare davanti al “volto eucaristico” di Cristo, additando
con nuova forza alla Chiesa la centralità dell’Eucaristia»5.
1 Cf. Eccelsia de Eucaristia (vivit) [citato in poi come EE], 3.
2 EE, 11 b. Cf. EE 13 e 17.
3 Sacrosanctum Concilium, 10.
4 Cf. EE 21-25.
5 EE 7; cf. 59 a. Il Pontefice confermava questa intenzione durante la Messa Crismale, il
17.04.2003, dicendo dell’enciclica: «accoglietela, cari Sacerdoti, come un dono particolare in
occasione del 25° anno del mio ministero petrino» (Osservatore Romano [= OR] 91, 18.04.2003, 7,
n. 4).
Per il nostro commento al primo dono dell’anno dell’anniversario del Pontificato - nella Lettera
apostolica Rosarium Virginis Mariae [= RVM] si veda: Il rosario. Una scuola di preghiera
2
In questa occasione propizia vogliamo accostare – scegliendo tra tante vie
possibili – la via della riflessione e della meditazione in un approccio tomista, che il
Santo Padre sempre predilige. Potremmo in tal modo fissare il mistero quotidiano
della presenza del Dio vicino. Un Dio, che facendosi carne per la nostra salvezza, non
rinuncia ad abitare nel Pane della vita eterna (cf. Gv 6,35-40), «pane vivo» (Gv 6,51):
Dio-Eucaristia.
L’Eucaristia, i luoghi tomisti prediletti da Giovanni Paolo II
Giovanni Paolo II non è solo un grande conoscitore del pensiero di San
Tommaso d’Aquino. Egli ha avuto il coraggio di elaborare una sintesi del tutto
originale del pensiero tomista rapportandolo alle altre correnti contemporanee,
specialmente nel dialogo con la fenomenologia di ispirazione di Roman Ingarden o di
Max Scheler. Il Pontificato presenta – si potrebbe dire – un profondo programma
tomistico6, che il Papa stesso confermava già in principio: «fin dagli inizi del mio
Pontificato non ho lasciato passare occasione propizia senza richiamare la eccelsa
figura di San Tommaso»7. Questa presenza, sia esplicita che discreta, si esprime nella
struttura stessa dell’actus essendi, cioè nella stessa intuizione tomista dell’essere
coronata in una metafisica del reale che permette parlare sia del Dio sia dell’uomo,
non trascurando l’uno, né umiliando l’altro. In questa prospettiva Tommaso è
soprattutto il maestro della verità e della profonda unione tra la verità naturale e
soprannaturale8.
Ma rinvii alla dottrina tomista nel attuale magistero pontificio sono costanti.
Per la prima volta il Papa richiamava una definizione teologica tomista nella sua
prima enciclica Redemptor Hominis (4.03.1979). Parlando della dimensione divina
del mistero della Redenzione, Giovanni Paolo II, lo coglieva nella rivelazione
dell’amore di Dio che si definisce misericordia e così riproponeva la definizione della
misericordia maturata da Tommaso nella Summa Theologiae III, q. 46, a. 1, ad 39. Si
nota poi l’importanza dell’antropologia tomista nell’insegnamento del Papa10
, oppure
l’approccio tomista curato in diverse questioni teologiche, come – per dare un
contemplativa. Riflessioni sulla Lettera apostolica di Giovanni Paolo II Rosarium Virginis Mariae,
LEV, Città del Vaticano 2003. 6 A. LOBATO, «L’attualità di san Tommaso nel pensiero e nell’insegnamento del Santo Padre
Giovanni Paolo II», Doctor Communis 40 (1987) 3-28, qui 5; cf. IDEM, «Juan Pablo II y Santo
Tomás Doctor Humanitatis», in L’uomo via della Chiesa. Studi in onore di Giovanni Paolo II,
Studia Universitatis Sancti Thomae in Urbe 32, Massimo, Milano 1991, 13-32. 7 «Il metodo e la dottrina di San Tommaso in dialogo con la cultura contemporanea», 13.09.1980: ai
partecipanti all’VIII Congresso Tomistico Internazionale, in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, III,
2 (1980) 604-615. 8 Fides et Ratio, 78, cf. 57; si vedano i commenti a questo proposito in M. AGNES, ed., Per una
lettura dell’Enciclica «Fides et Ratio», Quaderni de«L’Osservatore Romano» 45, Città del
Vaticano 1999. 9 Redemptor Hominis, 9 b, nota 63.
10 Cf. Uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore umano, Città Nuova editrice – LEV, Roma –
Città del Vaticano 1985, 266.
3
esempio – la persona dello Spirito Santo e i suoi doni11
, la Chiesa e i sacramenti12
, la
vita religiosa13
e la virtù della carità14
o la missionarietà della Chiesa15
. Il viaggio tra
le catechesi ed i documenti pontifici radicati sul fondamento della teologia tomista
potrebbe essere molto lungo ed esigerebbe uno studio molto più approfondito.
Uno dei luoghi dottrinali di San Tommaso più amati, più prediletti dal
Pontefice è la lectio Santi Thomae Aquinatis de Eucharistia16
. La nuova enciclica di
Giovanni Paolo II, firmata nella Basilica di San Pietro durante la Messa in Cena
Domini, il 17 aprile 200317
, diventa perciò anche l’invito per riflettere più da vicino
su questa preziosa lezione di Eucaristia che ha lasciato l’Aquinate e che Pontefice ha
fatto propria, non solo in quanto l’universale maestro della fede della Chiesa, ma
come il testimone per eccellenza che vuole offrire ai fratelli il suo vissuto eucaristico
alla scuola del Dottore Angelico.
Il Papa già nel primo discorso interamente dedicato al mistero dell’Eucaristia
durante l’udienza generale del 13 giugno 1979, inaugurava il suo magistero
eucaristico proprio con le parole dell’Aquinate18
. Così risuonavano i versetti di
«Pange, lingua, gloriosi / Corporis mysterium / Sanguinisque preziosi / quem in
mundi pretium / fructus ventri generosi / Rex effundit gentium…»19
, sigillando già in
11
Ciclo delle catechesi sullo Spirito Santo in preparazione del Grande Giubileo (28.05 –
14.10.1998), Insegnamenti XXI, 1-2 (1998). Cf. le catechesi sullo Spirito Santo (18.04.1990 –
3.07.1991), Insegnamenti XIII, 1-2 (1990) e XIV, 1-2 (1991). 12
Si vedano p. es. la catechesi del 10.07.1991, Insegnamenti XIV, 2 (1991) 79-83; e le catechesi del
12.02.1992, Insegnamenti XXV, 1 (1992) 281-284; del 18.03.1992, ivi, 629-632; del 25.03.1992,
ivi, 964-969; del 1.04.1992, ivi, 1022-1026; del 15.04.1992, ivi, 1106-1111, e soprattutto
sull’Eucaristia: la catechesi del 8.04.1992, ivi, 1057-1060. Oltre questo si veda: «Lettera al vescovo
di Liège, Mons. Albert Houssiau, in occasione del 750° anniversario della festa del Corpus
Domini», 28.05.1996, Insegnamenti XIX, 1 (1996) 1383-1388. 13
Si veda tra i numerosi discorsi ai religiosi, p. es. del 21.11.1982, Insegnamenti V, 3 (1982) 1366-
1370; le catechesi dedicate alla vita consacrata: del 28.09.1994, Insegnamenti XVII, 2 (1994) 402-
406; del 26.10.1994, ivi, 546-550; del 9.11.1994, ivi, 652-655; del 16.11.1994, ivi, 781-785; del
7.12.1994, ivi, 996-1000; del 11.01.1995, Insegnamenti XVIII, 1 (1995) 69-73; del 22.03.1995, ivi,
567-570, ecc. 14
Cf. Insegnamenti XXII, 2 (1999) 617-619. 15
Cf. Insegnamenti XVIII, 1 (1995) 1181-1184 o 1782-1785. 16
A proposito del ricco patrimonio tomista sull’Eucaristia si veda p. es.: D. BERGER, Thomas von
Aquin und die Liturgie, Editiones thomisticae, Köln 2000, o in sintesi: IDEM, Thomas von Aquin
begegnen, Zeugen des Glaubens, Sankt Urlich Verlag, Köln 2002, 162-165 («Das wichtigste unter
allen Sakramenten: die heilige Eucharistie; cf. STh III, q. 65, a. 3»). Cf. I. BIFFI, Il corpo dato e il
sangue sparso. Profilo di teologia eucaristica, Opuscoli 2, Jaca Book, Milano 1996; S. MARSILI –
A. NOCENT – M. AUGÉ – A.J. CHUPUNGCO, La Liturgia, Eucaristia: teologia e storia della
celebrazione, Anàmnesis: introduzione storico-teologica alla Liturgia 3/2, Marietti, Genova 1991,
101-106, e anche P. GONZÁLEZ GARCÍA, La Eucaristía y la remisión de los pecados en santo Tomas
de Aquino, (Angelicum), Manila 1977. 17
L’enciclica è stata offerta al posto della tradizionale lettera per i sacerdoti per il Giovedì Santo,
cf. EE 7. 18
«L’Eucaristia: sacramento della vicinanza di Dio», Insegnamenti II (1979) 1533-1537. 19
Hymn. Ad I Vesp. In Sollemn. SS.mi Corporis et Sanguinis Christi.
4
principio l’insegnamento pontificio in questo campo con la chiara indicazione di
quella direzione spirituale che desiderava intraprendere. Le parole del Doctor
communis in preghiera davanti al mistero eucaristico erano l’accesso migliore per
iniziare il cammino del suo magistero sul Sacramento20
. Più che le parole rivolte ai
fratelli, erano le parole dell’inno di lode rivolte con i fratelli a Dio stesso. Proprio
questa è la priorità di Giovanni Paolo II nel trattare l’Eucaristia: prima viverla nella
celebrazione di fede e di preghiera, di comunione, poi insegnarla. La dottrina
eucaristica inizia dallo stupore21
, dall’innamoramento e dalla lode del mistero
salvifico del Sacrificio, che si offre in una misteriosa vicinanza di «prossimità» e
«contemporaneità»22
al cristiano e, tramite il cristiano, all’uomo di ogni tempo. Si
offre alla Chiesa e, tramite essa, al mondo e all’universo cosmico intero che è da
salvare – nella persona umana creata da Dio e in ogni frammento della opera creatrice
di Dio, desiderosa di essere presso Dio23
.
Sacramento della Sua vicinanza, secondo san Tommaso d’Aquino
Nell’Eucaristia si offre in modo più eloquente l’espressione di tutta la
vicinanza del Dio cristiano al suo popolo. Tommaso la cantava con i termini di
ispirazione biblica (Dt 4,7): «non est alia natio tam grandis, quae habeat deos
appropinquantes sibi, sicut Deus noster adest nobis»24
. Se l’Eucaristia debba essere
considerata una festa incessante, ciò avviene proprio in quanto una santa
quotidianità25
. La dimensione temporale, che tramite il sacrificio eucaristico santifica
perennemente la vita cristiana è una delle priorità del mistero nella sua grandezza e
nello stesso tempo “piccolezza” del quotidiano. Il pane è spezzato continuamente
sulla sfera della terra. Si pensa che in ogni momento viene celebrata un’Eucaristia,
Giovanni Paolo II nell’omelia della Solennità del «Corpus Domini» del 15.06.1995, parlando del
profondo bisogno del popolo cristiano di manifestare, in modo diverso e più completo, tutto ciò che
l’Eucaristia è per la Chiesa, aggiungeva: «Nelle parole dell’inno famoso san Tommaso d’Aquino ha
espresso in modo eloquente tale bisogno del popolo di Dio. “Pange, lingua!” La lingua degli uomini
deve cantare il mistero dell’Eucaristia! Deve cantarlo non soltanto come mysterium passionis, ma
anche come mysterium gloriae. Da qui prende origine la tradizione delle processioni eucaristiche,
specialmente della processione del Corpus Domini, che costituisce una singolare espressione di
quella viva commozione che prova il credente di fronte al “mysterium” del Corpo e del Sangue del
Signore, di cui la Chiesa vive ogni giorno». 20
Come è noto, San Tommaso ha composto l’intero ufficio per la festa del Corpus Domini che
contiene – oltre l’inno Pange lingua, anche la sequenza Lauda Sion e gli inni Sacris solemniis e
Verbum supernum. Cf. SAN TOMMASO D’AQUINO, Il Corpo e il Sangue del signore. Piccolo trattato
sull’eucaristia, ed. M. BETTETINI, Piemme, Casale Monferrato 2000, 67-91. 21
Cf. EE 5 c – 6. 22
Cf. EE 5 b: Il Papa descrive questa relazione come la vicinanza del Dio del Triduum Paschale e
lo scorrere della storia. 23
Cf. EE 8. 24
Officium SS. Corporis Christi, II Nocturni; cf. Opusc. 57: «non vi è altra nazione così grande che
abbia la Divinità tanto vicina, quanto a noi è presente il nostro Dio» (citato da Giovanni Paolo II,
Insegnamenti II [1979] 1534). 25
Cf. Insegnamenti II (1979) 1533.
5
così dall’ora meravigliosa della Pasqua si compie continuamente il sacrificio del
Salvatore. Esso si inserisce nella vita dei cristiani e tramite loro nella vita del mondo,
santificando ogni ora della storia che così non è più solo uno scorrere del tempo
qualunque, ma diventa in Cristo l’opera costante di salvezza, il vero tempo di Dio-
Uomo.
La vicinanza di Dio nell’Eucaristia non è una prossimità qualsiasi, concepita a
modo solamente umano, e quindi fragile e rinchiusa nei limiti di tempo e di spazio.
Non è una vicinanza che diventa uno sforzo da parte di chi vuole assistere altro, e
spesso, nel cammino umano, richiede la lotta della carità, santa e giusta in un
superamento di se stesso. Dio è vicino in modo molto più semplice e diretto. Egli si
immerge nella strutture del tempo, ma lo sorpassa e domina, lo riporta in ogni istante
alla radice eterna e più originaria della temporalità stessa. Non è una vicinanza
immanentistica e, di conseguenza, segnata dalla parzialità e limitatezza, ma molto di
più. Essa è totalmente universalizzante e direttissima. Essa non è un essere vicino a
qualcuno che si aggiunge arbitrariamente alla vita dell’individuo e della comunità,
per quanto nobile possa essere l’adempimento del dovere di essere prossimi per gli
altri. Non si tratta di una vicinanza aggiuntiva, quasi accidentale, ma essenziale per la
natura di un tempo e una storia che dal momento glorioso della venuta del Figlio
Gesù, non solo comincia ad essere contata in una novità di misurazione, ma
realmente diventa una storia di salvezza, rivolta, nel dono di grazia, verso l’eternità.
La costanza di questa divina vicinanza è la nota specifica dell’Eucaristia. La
sua familiarità riprende ciò che è più connaturale alla persona creata a immagine e
somiglianza di Dio (Gn 1,26). Si potrebbe paragonarla ad una vicinanza
consanguinea che si accoglie come dono ricevendo la vita da Dio nella cooperazione
dell’amore dei genitori. La vicinanza connaturale che esiste tra il figlio e il proprio
padre e la madre, in quanto un valore non acquisito, ma donato nella natura stessa
della trasmissione della vita potrebbe forse aiutare a descrivere la vicinanza di Dio,
molto più perfetta, e come comunione, come un feeling familiare donata e non solo
acquisita ed aggiunta. Il Dio dell’Eucaristia passa nell’organismo della comunità
come un raggio di vita e di mantenimento, di nutrizione, di conservazione, come il
suo sangue. Esso è uno dei trasmettitori diretti della vita che si unisce all’origine
genitrice a quelli che si assomigliano nella figliolanza.
Di fatti, nell’Eucaristia non esiste – simpliciter – niente di imposto, di ordinato
e di obbligatorio a cui bisogna adempiere rischiando il “formalismo” di un rapporto
solo esteriore. Se la vicinanza di Dio è un dono totale di sé, non può essere un peso,
ma – come già nella percezione ancora molto imperfetta da parte del popolo d’Israele
dell’assistenza divina – era considerata la fonte di orgoglio e di sicurezza, di gioia e
di vera importanza della comunità. Anzi, è la divina misura della grandezza del
popolo. «Leggi e norme… le osserverete dunque e metterete in pratica perché quella
sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo
parlare di tutte queste leggi, diranno: Questa grande nazione è il solo popolo saggio e
6
intelligente»26
. Una tale grandezza più che un vanto, è un impegno di figliolanza e di
responsabilità davanti a Dio e al mondo. La sua origine spunta dalla certezza che Dio
ha tanto amato il mondo27
. Il tanto del suo amore è la misura della grandezza sublime
e stupenda avvicinata eucaristicamente28
.
Essa si fonda sulla conoscenza liberatoria. Infatti, il Dio vicino non è un Dio
sconosciuto, astratto, per quanto la sua idea possa essere bella e affascinante per la
ragione umana. Non è un Dio appreso solo con lo sforzo naturale di impararLo e
raggiunto in uno, d’altronde giusto, sforzo di dicibilità (la corretta intelligibilità) del
suo mistero, ma primariamente è il molto di più. È un Dio che si fa conoscere, e per
mezzo della sua conoscenza perfetta, infusa nei cuori con la grazia, riesce ad
abbracciare tutto l’uomo. Egli è Dio sopra di noi, accanto a noi, dentro di noi29
.
L’Eucaristia è il mistero di questa vicinanza per eccellenza. Ciò che non poteva
essere raggiunto nella sua perfezione nell’Antico Testamento, ma veniva già
egregiamente prefigurato e annunciato30
, nel sacrificio di Cristo trova il suo ultimo
significato.
Se il Dio dell’Eucaristia è presente costantemente, riempiendo il tempo della
Chiesa, una tale sua vicinanza deve essere esistenziale, in quanto Egli è vivente e
pure tutto vive solo in quanto partecipa di questa fonte vitale dell’esistenza.
Nell’Eucaristia si arriva al grado più sublime di partecipazione nella vita di Dio,
inglobante tutta la persona nella sua adesione al Signore. Questa viene cibata da Lui,
che Tommaso descriveva nella Summa Contra Gentiles: «sicut autem corporalis vita
materiali alimento indiget, non solum ad quantitatis augmentum, sed etiam ad
naturam corporis sustentandam, ne propter resolutiones continuas dissolvatur et eius
virtus depereat; ita necessarium fuit in spirituali vita spirituale alimentum habere, quo
regenerati et in virtutibus conserventur, et crescant»31
. Il cibo eucaristico risponde al
bisogno costante di essere ricreati e rigenerati nella Redenzione.
26
Dt 4, 5-6, dove parlando della legge e delle norma, si vuole inglobare tutta la vita del popolo nei
suoi momenti salienti e costitutivi della religione d’Israele. Si tratta dunque della condotta umana,
ma quanto più del culto, l’espressione dell’alleanza sigillata da Dio. 27
Gv 3, 16. Cf. Insegnamenti II (1979) 1534. 28
EE 1 b. Come dice il Papa, è la piena manifestazione dell’immenso amore del Signore, che la
Chiesa scopre in Lui – Sacramento dell’Altare. 29
Il Card. J. Ratzinger paragona sapientemente la vicinanza interiore del Signore nella coscienza e
la vicinanza eucaristica, dove la forza della prima permette di sostenere la seconda (Il Dio vicino.
L’eucaristia, cuore della vita cristiana, EP, Milano 2003, 110-111 (or. ted. Gott ist uns nah.
Eucharistie: Mitte des Lebens, Sankt Ulrich Verlag, Augsburg 2001). 30
I segni eucaristici sono abbondantemente sparsi nelle antiche Scritture e possono riassumersi nel
sacrificio di Melchizedek, misterioso sommo sacerdote (Gn 14,18-20; cf. Sal 109 [110], 4). Cf. STh
III, q. 73, a. 6, resp., e anche CCC 1333-1334. Per una sintesi teologica si veda p. es. I. BIFFI,
Eucaristia. La storia e il rito, Jaca Book, Milano 1994, 17-26. 31
SCG IV, 61 (a): «come la vita corporale ha bisogno di un cibo materiale, non solo per la crescita,
ma anche per sostenere la natura del corpo, affinché per le perdite continue non si dissolva e non
perisca la sua virtù; così era necessario un alimento nella vita spirituale, mediante il quale i
rigenerati possano conservarsi e crescere in virtù». Si veda anche STh III, q. 73, a. 1.
In questa Summa la trattazione dell’Eucaristia è ridotta al nocciolo della risposta alle obiezioni e
alla confutazione degli errori riguardo il mistero eucaristico sollevati dagli avversari della fede, cf.
7
Per Tommaso in questa prima necessità sta anche la chiave di comprensione di
una vicinanza spirituale di Dio che prende una forma ben concreta di una cosa
visibile, di un alimento che è dato tramite le specie del cibo di cui comunemente si
servono gli uomini come alimenti corporali (sub speciebus illarum rerum quibus
homines communius ad corporale alimentum utuntur). Così l’unione non è solo
secondo la somiglianza e la virtù, ma è la costante unione sostanziale all’essere che
nutre (alimentum oportet nutrito secundum substantiam coniungi)32. Lo stesso modo
di darsi del Dio eucaristico – che riprende la logica dell’Incarnazione – conferma e
rafforza la vicinanza che è reale se unisce Dio all’uomo e comincia far parte della vita
del credente. Non è una vicinanza solo virtuale, che in ultima analisi rimane a
distanza oggettiva, ma un reale cibarsi dell’Altro, che diventa l’essenza della vita di
chi si nutre. Il realismo della verità dell’Eucaristia è il suo punto forte nel garantire la
vicinanza di Dio, altrimenti essa rimarrebbe solamente simbolica. Il segno
sacramentale che comunica realmente la grazia non si ferma ad un vago contatto
simbolico e figurativo, a somiglianza degli analogici tipi anticotestamentari di
Cristo33
. La dottrina della transustanziazione esprime appieno proprio il desiderio di
una reale vicinanza che Dio vuole comunicare al suo fedele. Non è contraddittoria,
ma la più sublime e più misteriosa (sublimius et secretius) opera della vicinanza
divina34
. Il concreto di uno spazio e di uno tempo legati all’Eucaristia ne attestano la
costanza e la semplicità del donarsi quotidiano, così che conservando l’Eucaristia
nelle chiese si assicura quasi una liturgia perenne compiuta dalla presenza vicina di
Dio che non può non impegnare il cristiano nel tendere sempre di più
all’atteggiamento di lode e di adorazione nel culto eucaristico35
e nella «vita
eucaristica» della Chiesa36
.
IV, 61-69. La dottrina tomista sull’Eucaristia è molto più ampia e per indicare solo i luoghi più
importanti, segnaliamo STh III, qq. 73-83, In Sent. IV, dd. 8-13; In Ioann. c. 6, lect. 6; In I Cor. c.
II, lectt. 4-5; In Matt. c. 26. 32
SCG IV, c. 61 (b-c). Come dice il Papa: «non si tratta di un alimento metaforico» (EE 16), cf. J.
RATZINGER, Il Dio vicino, op. cit., 77-79. 33
Come invece attesta Cristo stesso: la mia carne è veramente cibi, e il mio sangue è veramente
bevanda (Gv 6, 56), questo è il mio corpo (Mt 26, 26) per fermarsi ai due testi citati da San
Tommaso in SCG IV, cc. 61-62. 34
SCG IV, c. 63. Si veda anche EE 15 a. 35
EE 25 e 10 a (cf. CCC 1378), e anche J. RATZINGER, Il Dio vicino, 91 ss. Ricordiamo anche ciò
che precisa Tommaso: «substantia corporis Christi comparatur ad locum illud mediantibus
dimensionibus alienis: ita quod e converso dimensiones propriae corporis Christi comparantur ad
locum illum mediante substantia. Quod est contra rationem corporis locati. Unde nullo modo corpus
Christi est in hoc sacramento localiter» (STh III, q. 76, a. 5).
Per una sintesi sull’Eucaristia come dono degno di adorazione si veda: J. RATZINGER – J. AUER, Il
mistero dell’Eucaristia, Piccola Dogmatica Cattolica 6, Cittadella, Assisi 1989, 380-386 (or. ted.
Kleine Katholische Dogmatik. Allgemeine Sakrementenlehre und das Mysterium der Eucharistie,
Pustet, Regensburg 1972). 36
EE 20 c; 31. L’affermazione concretissima di questa vita eucaristica della Chiesa è la
celebrazione quotidiana del Sacrificio dai sacerdoti raccomandata da Presbiterorum Ordnis [= PO]
13 (che nella devozione anche di san Tommaso presentava il cardine della sua devozione
eucaristica; cf. STh III, q. 80, a. 10, resp. e ad 3). Oggi sempre più ci sono i fedeli che vivono la
8
È, quindi, una vicinanza totale, integra e non spezzata in “parti e pezzi” della
presenza di Dio, che sarebbe a misura della presenza limitata umanamente e
creaturalmente37
. Si tratta di una condiscendenza radicale nella potenza dell’amore
che vince la morte, riconquistando la pienezza della vita. La forza del Dio vicino è il
suo potere ricreante per la pienezza della vita38
.
Per Tommaso l’Eucaristia è, quindi, il Sacramento della Comunione con Lui
che è morto e risorto per noi. La comunione che viene dalla transustanziazione è così
capace di trasfigurare l’esistenza e, conseguentemente, trasformare il mondo39
. La
forza della comunione è la forza dell’amicizia familiare, per così dire, consanguinea
nell’amore della santità. «Maxime proprium amicitiae est convivere amicis, ut
Philosophus dicit, IX Ethica (c. 12, n. 13) et ideo hoc sacramentum est maximae
caritatis signum, et nostrae spei sublevamentum, ex tam familiari coniunctione
Christi ad nos»40
.
L’Aquinate nell’enciclica Ecclesia de Eucharistia
L’Aquinate è ricordato dal Santo Padre nell’enciclica Ecclesia de Eucharistia,
quale «sommo teologo e insieme appassionato cantore di Cristo eucaristico»41
. Se
egli è il vero teologo, la sua dottrina non si ferma alla sola speculazione rigida e
rischiosa di freddezza, ma diventa in sé la vera lode, il cantico spirituale, l’esperienza
già al livello della discorsività del mistero affascinante dell’Eucaristia42
. Seguendo
questo titolo che Giovanni Paolo II riconosce come caratteristico e proprio della
figura del Dottore Angelico, bisogna dire che la trattazione teologica tomista nasce
dalla passione amorosa verso Cristo e così arriva pure e si espande nel mare del
cantico innamorato della sua presenza.
forte spiritualità della comunione eucaristica quotidiana, rendendo le giornate delle comunità
parrocchiali veramente eucaristiche, ma anche se questo da qualche parte non risultasse, sarà il
presbitero ad esprimere la vitalità di quel cuore quotidiano della Chiesa nella celebrazione
dell’Eucaristia «anche quando non è possibile che vi assistano i fedeli» (PO 13, CIC 904). È questo
uno dei cardini della spiritualità della santità possibile e necessaria nel nuovo Millennio (cf. NMI
30, cf. EE 60). 37
SCG IV, c. 64: «Corpus enim Christi per suas proprias dimensiones in uno tantum loco existit:
sed mediantibus dimensionibus panis in ipsum transeuntis in tot locis in quot huiusmodi conversio
fuerit celebrata: non quidem divisum per partes, sed integrum in unoquoque; nam quilibet panis
consecratus in integrum corpus Christi convertitur». 38
«Dio è in esso (Pane e Vino) presente e vicino all’uomo con quella penetrante vicinanza della sua
morte sulla croce, dalla quale è scaturita la potenza della Risurrezione» (Insegnamenti II [1979]
1535). 39
Cf. EE 20 c. Per la dottrina della transustanziazione (transubstantiatio) rimane classica
l’esposizione tomista di STh III, q. 75. 40
STh III, q. 75, a. 1: «particolarmente proprio dell’amicizia è che gli amici convivano, come dice il
filosofo, nel libro nono dell’Etica e perciò questo sacramento è il massimo segno della carità e il
sostegno della nostra speranza a motivo dell’unione tanto familiare di Cristo con noi». 41
EE 62 c. 42
L’esperienza che il Papa vuole rinnovare nella Chiesa; cf. EE 7.
9
Non dimentichiamo che la misteriosa esperienza della visione di San Tommaso
durante la celebrazione della Santa Messa del 6 dicembre 1273, è una sorta del vero
miracolo eucaristico nella sua vita che tocca la soglia dell’eternità43
. Se è il punto di
arrivo per eccellenza del cammino dell’Angelico, segna come una anticipazione il
suo passaggio al cielo, alla presenza diretta di Dio in eterno, bisogna dire che è pure
lo svelarsi della sorgente di tutta la vita del teologo. In un certo senso, è anche il
punto di partenza definitivo; non a caso la prima reazione di Tommaso è quella
volontà decisa di bruciare ciò che sembrava lo sforzo inutile di capire
l’Incomprensibile, ciò che sembrava nella limitatezza togliere l’affascinante lato della
bellezza vera di Colui che si era rivelato così direttamente. È un esperienza che segna
forse per tutti e soprattutto per chi vuole razionalmente sistematizzare la propria
conoscenza di Dio il pericolo di sfuggire la sua grandezza, altezza e profondità,
impossibili da abbracciare se non nella fede umile che tende al convito eterno dei
volti scoperti davanti a Dio.
Se Tommaso è un perenne maestro dell’Eucaristia, lo è ancora di più grazie a
quest’esperienza della visione che apre il suo silenzio degli ultimi mesi di vita, non
gli fa più raggiungere il concilio di Lione, e, sapientemente, corona la Summa
Theologiae. Davanti alla forza della visione, la Summa pare essere come paglia44
, ma
non per questo deve essere bruciata. Piuttosto in Tommaso si era “bruciato” tutto ciò
che era solo limitato nella comprensione del mistero; di fatti egli passa nella pace
all’eternità di Dio e muore presto, il 7 marzo 1274 nell’abbazia cistercense di
Fossanova. Lui già in quel momento raggiungeva la soglia di quel Volto di Dio che il
cristiano desidera vedere. Non bisogna “bruciare” la tappa del cammino che precede
una tale visione e che è richiesta come l’impegno di fede davanti al mistero del Volto
che è eucaristico, che vuole essere compreso, conosciuto, annunciato, come lo ha
fatto Tommaso, cantore della presenza eucaristica e destinatario della visione totale
di ciò che è nascosto nell’umile segno del pane e del vino, nel povero segno dei doni
sacrificali, nel semplice segno eucaristico45
. La grandezza di Dio si raggiunge
attraverso la semplicità dei suoi segni che si piegano alle possibilità delle persone, ma
che non rinunciano alla propria immensità. Dalla priorità di questa esperienza
contemplativa di Tommaso46
, possiamo capire ciò che deve essere purificato nel
nostro accostamento sia all’Eucaristia47
sia – in generale – al mistero di Dio, e cioè la
43
Una tale esperienza è la toccabile conferma della proiezione escatologica verso la comunione con
la Chiesa celeste (cf EE 18-19). L’unione sacramentale tra il cielo e la terra (cf. EE 8) irrompe così
nella visione di gloria. 44
GUGLIELMO DI TOCCO, Historia beati Thomae de Aquino, n. 48, Processus canonisationis, n. 79.
Cf. J.-P. TORRELL, Tommaso d’Aquino. L’uomo e il teologo, Piemme, Casale Monferrato 1994, 324
ss (or. fr. Initiation à saint Thomas d’Aquin. Sa personne et son œuvre, Editions Universitaires –
Cerf, Fribourg – Paris 1993). 45
EE 62 b. 46
Cf. «Un uomo di grande contemplazione», in J.-P. TORRELL, Tommaso d’Aquino, op. cit., 317-
324. Guglielmo Tocco (n. 52) ricorda proprio nell’ambito delle discussioni sull’Eucaristia, che
Tommaso prima di parlarne ai fratelli si recava a sottoporre tutto alla verifica della preghiera
davanti a Cristo Crocifisso. 47
Cf. EE 10 b.
10
tentazione di piegare l’immensità secondo gli schemi e misure puramente umani. Se
Dio rispetta al massimo le capacità del suo interlocutore umano, non significa che
l’uomo abbia davanti uno che è uguale a lui e possa essere trattato senza un continuo
sforzo di innalzamento oltre se stesso nella santità.
In questo senso, Tommaso, come teologo, ma quanto più come il credente che
ha vissuto mistero del cristianesimo, può assicurare una via tra le tante su cui non si
cade nelle riduzioni né nelle strumentalizzazioni48
.
Avviciniamoci, per quanto sarà possibile nei limiti di questo semplice
approccio di lettura, alla presenza della dottrina tomista nell’enciclica Ecclesia de
Eucharistia. Non possiamo studiarla in tutti i suoi particolari, ricchi e capaci di
trasmettere tutto un clima della teologia tomista, la sua struttura interna nell’equilibro
della serena sottomissione a Dio e al suo mistero e, nello stesso tempo, di un
approccio che non fa sfuggire l’importanza di una cura e di una fedeltà alla modalità
con cui Dio si rivela, ciò che viene custodito con massima premura49
.
San Tommaso, nella nuova enciclica, trova una collocazione di particolare
importanza, segnando esplicitamente i punti salienti della dottrina insegnata da
Giovanni Paolo II. Le sue parole chiudono l’enciclica (EE 61-62), dove il Papa ha
voluto ricordare STh III, q. 83, a. 4 c. La sua dottrina è ripresa esattamente al centro
del documento (EE 38 b), dove si cita una delle più belle definizioni tomiste del
Sacramento (STh III, q. 73, a. 3 c). Infine San Tommaso implicitamente apre
l’enciclica (EE 1). Parallelamente alla distribuzione degli argomenti tomisti
all’interno dell’enciclica, si può notare come essi sono anche colti dalla questione
introduttiva e quella conclusiva della parte della Summa dedicata all’Eucaristia (qq.
73-83).
1. Il significativo inizio dell’enciclica è un vero intreccio di dottrina che vive
della Tradizione, si rinnova continuamente, viene compresa sempre meglio e
annunciata al mondo. Si tratta di un maisterstick di un coro consonante
dell’insegnamento della Chiesa racchiuso nella definizione dell’Eucaristia. Dalla
«tradizione ininterrotta»50
dei secoli cristiani si arriva ad una sinfonia di verità
eucaristica colta dalla dottrina del Concilio Vaticano II51
, dove risplende
l’insegnamento di San Tommaso d’Aquino.
48
Cf. EE 61 a. 49
Cf. EE 52 b. 50
EE 61 c. 51
Notiamo con forza a questo riguardo come il Papa lodi la riforma liturgica del Concilio nella sua
vera e stimolante portata: EE 10 a, dove si parla della «crescita interiore della comunità cristiana»,
confermando: «Non c’è dubbio che la riforma liturgica del Concilio abbia portato grandi vantaggi
per una più consapevole, attiva e fruttuosa partecipazione dei fedeli al santo Sacrificio dell’altare».
Non di meno, ricorda più avanti: «Occorre purtroppo lamentare che, soprattutto a partire dagli anni
della riforma liturgica post-conciliare, per un malinteso senso di creatività e di adattamento, non
sono mancati abusi, che sono stati motivo di sofferenza per molti» (EE 52 a).
11
Il Santo Padre apre così la lettera enciclica: «giustamente il Concilio Vaticano
II ha proclamato che il Sacrificio eucaristico è “fonte e apice di tutta la vita
cristiana”52
. “Infatti, nella santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale
della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua e pane vivo che, mediante la sua
carne vivificata dallo Spirito Santo e vivificante, dà vita agli uomini”53
. Perciò lo
sguardo della Chiesa è continuamente rivolto al suo Signore, presente nel Sacramento
dell’Altare, nel quale essa scopre la piena manifestazione del suo immenso amore»54
.
Non può, quindi, sfuggire il fatto che ambedue i luoghi conciliari si nutrono
direttamente dell’insegnamento del Dottore Angelico. La classica definizione della
costituzione dogmatica Lumen gentium 11 riprende STh III, q. 73, a. 3 c55
. Invece il
decreto Presbiterorum Ordinis cita esplicitamente STh III, q. 65, a. 3, ad 156
; e q. 79,
a. 1 c ed ad 157
. La continuità della Tradizione della Chiesa non è solo la prova
dell’insegnamento costante della Chiesa, ma propriamente la conferma sapiente della
sua autenticità di verità.
Questa prima affermazione dogmatica tocca il nucleo della verità esposta
dall’enciclica, e cioè l’unione dell’uomo con Cristo tramite il Sacramento della
Chiesa. La vita di grazia fa incorporare la persona in Cristo, e la grazia eucaristica
dona accrescimento continuo della grazia d’unione con Gesù e il Suo Corpo
mistico58
. Tra i vari aspetti che Tommaso distingue nell’operare della grazia il primo
è proprio quello dell’incorporazione a Cristo da cui scaturiscono gli altri gli effetti
spirituali che richiamano analogicamente quelli del cibo materiale per il corpo oppure
il perfetto inserimento nella Chiesa, come anche la costruzione ed edificazione
continua della sua unità. Tutto ciò avviene come l’effetto della passione redentrice di
Cristo che essa ha prodotto per tutto il mondo e il sacramento produce nel singolo
52
Lumen gentium, 11. Oltre a questo passo dell’enciclica si veda il richiamo di LG 11 in EE 13 b.
cf. CCC 1324. 53
PO, 5; cf. CCC 1324. 54
EE 1 b. 55
Questo testo vedremmo commentato nell’EE 38 b. 56
Si veda PO, nota 16. Tommaso risponde affermativamente alla questione: «utrum sacramentum
Eucharistiae sit potissimum inter sacramenta?» confermando che «hoc sacramentum potissimum et
perfectivum est omnium aliorum» (65,3, sc). Questo risulta per tre ragioni: (1) solo Eucaristia
contiene realmente Cristo in persona; (2) tutti gli altri sacramenti sono ordinati all’Eucaristia come
al loro fine; e (3) tutti vengono completati liturgicamente dalla comunione eucaristica (cf. 65,3,
resp.). 57
Tommaso insegna: «effectus huius sacramenti debet considerari, primo quidam et principaliter,
ex eo quod in hoc sacramento continetur, quod est Christus. Qui sicut, in mundum visibiliter
veniens, contulit mundo vitam gratiae, secundum illud Ioan. 1,17: “Gratia et veritas per Iesum
Christum facta est”; ita, in hominem sacramentaliter veniens, vitam gratiae operatur, secundum
illud Ioan. 6,58: “qui manducat me, vivit propter me”. Unde et Cyrillus dicit [Comment. in Luc.
22,19]: “Vivificativum De Verbum, uniens seipsum propriae carni, fecit ipsam vivificativam.
Decebat ergo eum nostris quodammodo uniri corporibus per sacram eius carnem et pretiosum
sanguinem, quae accipimus in benedictione vivificativi in pane et vino”» (79,1, resp.) e «per hoc
autem sacramentum augetur gratia, et perficitur spiritualis vita, ad hoc quod homo in seipso
perfectus existat per coniunctionem ad Deum» (79,1,ad 1). 58
Cf. DS 1638-1639, e anche CCC 1396.
12
uomo, edificando così la comunità della Chiesa. Esso poi permette il conseguimento
della gloria (adeptio gloriae: III, q. 79, a. 2) in quanto rivolto verso la vita eterna (cf.
Gv 6,52)59
. In sintesi, già il primo articolo annuncia i temi che vengono sviluppati e
insegnati dall’enciclica.
2. Il seguente passo dell’enciclica parla dell’Eucaristia come di «quasi
consumatio spiritualis vitae, et omnium sacramentorum finis»60
e ciò nel contesto del
capitolo 4 del documento dedicato alla comunione ecclesiale operata e manifestata
nell’Eucaristia. Il Papa esorta che proprio una tale «suprema manifestazione della
comunione nella Chiesa, esige di essere celebrata in un contesto di integrità dei
legami anche esterni di comunione»61
, in quanto l’Eucaristia svolge un compito di
priorità costante tra gli altri sacramenti. Essa corona l’economia sacramentale.
Per Tommaso esiste, dunque, su questo punto la differenza tra il Battesimo e
l’Eucaristia. Il Battesimo è «principium spiritualis vitae, et “ianua sacramentorum”».
In questo senso, «ideo perceptio baptismi est necessaria ad inchoandam spiritualem
vitam, perceptio autem Eucharistiae est necessaria ad consummandam ipsam: non ad
hoc quod simpliciter habeatur, sed sufficit eam habere in voto, sicut et finis habetur in
desiderio et intentione». Come osserva Tommaso, riprendendo l’insegnamento di
Agostino, il cristiano diventa partecipe del corpo e del sangue del Signore già nel
momento del battesimo mediante cui diviene membro del corpo di Cristo62
. Il
Battesimo orienta verso l’Eucaristia, iniziando la comunione ecclesiale che si
mantiene in vita tramite il Sacrificio eucaristico.
3. Infine, il Santo Padre conclude con una nota di sapore tomista: «sospinta
dall’amore, la Chiesa si preoccupa di trasmettere alle successive generazioni
cristiane, senza perderne alcun frammento, la fede e la dottrina sul Mistero
eucaristico. Non c’è pericolo di esagerare nella cura di questo Mistero, perché “in
59
Si vedano a questo riguardo anche le catechesi del Papa: «L’Eucaristia, suprema celebrazione
terrena della “gloria”», 27.09.2000, Insegnamenti XXIII, 2 (2000) 477-480, dove dice: «in questa
quotidianità degli alimenti, l’Eucaristia introduce non solo la promessa, ma il “pegno” della gloria
futura: “futurae gloriae nobis pignus datur” (SAN TOMMASO, Officium de festo Corporis Christi)»
(477) e prosegue citando ancora Tommaso (STh III, q. 79, a. 2, ad 1): «questo sacramento non ci
introduce subito nella gloria ma ci dà la forza di giungere alla gloria ed è per questo che è detto
viatico» («L’Eucaristia apre la futuro di Dio», 25.10.2000, Insegnamenti XXIII, 2 [2000] 696-699,
qui 696). 60
STh III, q. 73, a. 3, resp.: «quasi coronamento (coronamento) della vita spirituale e il fine di tutti i
sacramenti»; cf. CCC 1374. 61
EE 38 b. 62
STh III, q. 73, a. 3, ad 1; cf. SANT’AGOSTINO, Epistola ad Bonifacium.
Il Papa insegnava già in una delle sue catechesi sull’Eucaristia (8.04.2000): «l’Angelico Dottore fa
notare che “l’effetto di questo sacramento è l’unità del corpo mistico (la Chiesa), senza la quale non
ci può essere la salvezza. Perciò è necessario ricevere l’Eucaristia, almeno col desiderio (in voto),
per salvarsi” (STh III, q. 73, a. 1, ad 2) In queste parole è l’eco di quanto ha detto Gesù stesso sulla
necessità dell’Eucaristia per la vita cristiana (Gv 6,53-54). Secondo queste parole di Gesù,
l’Eucaristia è pegno della risurrezione futura, ma è già nel tempo fonte di vita eterna»
(Insegnamenti XV, 1 [2000] 1057-1058).
13
questo sacramento si riassume tutto il mistero della nostra salvezza”»63
. C’è una
corrispondenza tra la convinzione di Tommaso e quella del Santo Padre sulla priorità
del mistero di Dio, qui eucaristico, a cui si sottomette la persona umana. Nell’opera di
Tommaso si vede come bisogna curare più la priorità teocentrica del mistero da
quella antropocentrica, per non tradire né una né altra. Per quanto grande sia il nostro
sforzo di premurosa cura nei riguardi del mistero, esso sarà sempre limitato e forse –
in assoluto – insignificante davanti alla grandezza del dono che ci è stato consegnato.
Nello stesso articolo citato sopra, Tommaso nota anche esplicitamente:
«Eucaristia est sacramentum totius ecclesiasticae unitatis. Et ideo specialiter in hoc
sacramento, magis quam in aliis, debet fieri mentio de omnibus quae pertinent ad
salutem totius Ecclesiae»64
. Questo è anche il principale filo conduttore dell’enciclica
da cui nascono i problemi che vi vengono trattati65
. Per l’Aquinate66
, nell’unità della
Chiesa sta l’effetto presente del significato dell’Eucaristia che assume perciò il nome
di comunione67
. Questo significato riguarda anche il passato, in quanto memoriale
della passione del Signore68
ed è chiamato sacrificio69
. Per ultimo assume il
significato che riguarda il futuro, in quanto prefigura la beatitudine divina della vita
eterna, essendo anche il viatico70
.
C’è poi una specialissima ripresa dell’insegnamento di san Tommaso che si
può esprimere con un’altra domanda programmatica che il Papa pone in principio
della lettera: «come non ammirare le esposizioni dottrinali dei Decreti sulla
Santissima Eucaristia e sul Sacrosanto Sacrificio della Messa promulgati dal Concilio
di Trento?» E continua in questa lettura della ricchezza storica della Tradizione che
rappresenta il vero polmone per la vita della comunità della Chiesa: «quelle pagine
(del Concilio di Trento, 1545-1563) hanno guidato nei secoli successivi sia la
teologia sia la catechesi e tuttora sono punto di riferimento dogmatico per il continuo
rinnovamento e per la crescita del Popolo di Dio nella fede e nell’amore
dell’Eucaristia»71
. Come è noto San Tommaso d’Aquino era ispiratore e maestro 63
EE 61 c, citando il passo colto dall’ultima questione dedicata all’Eucaristia (De ritu huius
sacramenti), STh III, q. 83, a. 4, resp.: «in hoc sacramento totum mysterium nostrae salutis
comprehenditur». 64
STh q. 83, a. 4, ad 3: «L’Eucaristia è il sacramento della perfetta unità della Chiesa. Quindi
particolarmente in questo sacramento più che negli altri si deve rammentare tutto ciò che si riferisce
alla salvezza della Chiesa intera»; cf. STh III, q. 67, a. 2, resp.; q. 79, a. 1, resp. 65
Si veda il primo commento all’enciclica del Card. L. Scheffczyk che focalizza bene i problemi
connessi in rapporto all’unità della Chiesa, cf. «Leben der Kirche aus der Eucharistie. Klärende
Worte zu einem zentralen Geheimnis des Glaubens: Die neue Enzyklika von Papst Johannes Paul
II», Tagespost DT Nr.46, 18.04.03. 66
Cf. STh III, q. 73, a. 4, resp. 67
Cf. EE 34 a. 68
Cf. EE 12 c. 69
Cf. EE 12 a-b. 13 a. 70
Cf. EE 62 b. 71
EE 9 a. Si veda anche: «Il 450° anniversario del Concilio: Il discorso del Papa durante l’incontro
di preghiera in Duomo per commemorare il grande evento» – Trento, 30.04.1995, Insegnamenti
XVIII, 1 (1995) 730-735.
14
della maggioranza dei Padri conciliari di Trento, formati alle scuole tomiste di
filosofia e teologia, fiorenti in quel tempo.
La presente enciclica torna a quella fonte della dottrina cattolica diverse volte
nell’insegnamento nutrito principalmente dall’insegnamento del Concilio Vaticano II
con la piena concordanza, continuità e sintonia con il Magistero precedente, segnando
così lo sviluppo della dottrina. Notiamo solo alcuni dei passi riguardanti
l’insegnamento tridentino: in EE 12 b (con la Sessione XXII, Doctrina de SS. Missae
sacrificio, cap. 2); EE 15 a (Sessione XIII, Decretum de SS. Eucaristia, cap. 4); EE
25 a (con la Sessione XIII, Decretum de SS. Eucaristia, can. 4); EE 36 c (con la
sessione XIII, Decretum de SS. Eucaristia, cap. 7 e can. 11). Questi luoghi
magisteriali hanno il loro fondamento speculativo nella Summa Theologiae di
Tommaso che, anche simbolicamente, veniva messa accanto al libro della Sacra
Scrittura nei lavori del Concilio Tridentino. Il testo di Trento che viene ripreso
integralmente nell’enciclica è quello sulla consacrazione del pane e del vino, in cui si
opera la conversione di tutta la sostanza, ciò che «in modo conveniente e appropriato
è chiamato dalla santa Chiesa cattolica transustanziazione»72
. Non c’è dubbio che la
trattazione più approfondita della dottrina della transustanziazione si ha con le
questioni 75-77 della III Pars della Summa tomista.
Il grande merito del Concilio Tridentino è anche la riscoperta del sacrificio
della Messa, superando le incertezze ed i malintesi del tempo precedente.
Nell’Eucaristia si celebra il reale sacrificio di Cristo partendo dalla sua radice
pasquale, ciò che l’enciclica sottolinea egregiamente nella fonte pasquale del
mysterium eucharisticum. Esso si inscrive nel mysterium paschale73
.
Il banchetto del sacrificio che unisce la Chiesa è l’idea portante dell’enciclica74
.
Nel sacrificio sta pure la forza portante del pensiero di Tommaso sull’Eucaristia che
non è da trascurare nella teologia cattolica. Anzi, «la dimensione sacrificale
dell’Eucaristia»75
fa organicamente un tutt’uno con la dimensione della presenza
reale e del banchetto conviviale della Messa, che non riesce esprimere il suo mistero
solamente in una di queste dimensioni76
. Essa ha bisogno di questo coro sinfonico
della ricchezza che nasce nel Sacrificio di Cristo sulla Croce e vince la Morte nel
giorno della Risurrezione, il primo giorno della settimana cristiana, il giorno del
Signore che non può non essere il giorno della Chiesa77
.
Giovanni Paolo II può dunque a nome della Chiesa esclamare: «“Adoro te
devote, latens Deitas”, continueremo a cantare con il Dottore Angelico. Di fronte a
questo mistero di amore, la ragione umana sperimenta tutta la sua finitezza»78
.
72
EE 15 a; cf. DS 1642 e 1652 (can. 2). Cf. CCC 1376. 1413 e per il sintetico commento: J.
RATZINGER – J. AUER, Il mistero dell’Eucaristia, op. cit., 267-282. 73
EE 2 b, cf. 2-5 b. 74
Cf. EE 12-13; 48; 56. 75
EE 56 a. 76
Cf. EE 61 a. 77
EE 41, cf. NMI 36. 78
EE 15 b; cf. 59 b. Cf. CCC 1381. Nell’omelia per la celebrazione della Santa Messa “in Cena
Domini” durante la quale il Papa ha firmato la nuova enciclica, egli esclama: «“Adoro te devote,
15
Bisogna dire che le fonti liturgiche di san Tommaso sono particolarmente amate dal
Papa, come abbiamo avuto già modo di accennare. Esse servono da una sorta di
riassunto, in forma di una esplosione di lode in onore del Dio così grande, e aprono lo
spazio della preghiera che non è staccato né dalla teologia né dall’insegnamento del
Magistero, ma che con entrambi crea una simbiosi vitale. Le preghiere dell’Angelico
possono essere considerate una sorta di ritornello spirituale, intenso e tutto rivolto a
Dio. Esse rafforzano il calore meditativo e – osiamo dire – contemplativo della
dottrina sul mistero.
San Tommaso, come nella grandiosa «Disputa sul Santissimo Sacramento»
(1509) di Raffaello Sanzio, riassuntiva per la storia della devozione e della teologia
eucaristica, risplende nella comunione dei Santi che scrutavano il mistero, così anche
nell’affresco dell’enciclica gli viene riconosciuto il posto di particolare rilievo. Egli
infatti ha ripreso l’insegnamento dei Padri e ha sintetizzato l’insegnamento della
Chiesa sul sacramento in un compendio di perenne validità, pur essendo aperto allo
sviluppo e alla crescita della dottrina e della riformabilità liturgica, sempre però nella
direzione fedele a ciò che Dio rivela nel segno sacramentale dell’Eucaristia.
Il Pontefice insegna la Chiesa dell’Eucaristia
Oltre alla dottrina esposta, ci sono alcune caratteristiche dell’enciclica che ne
costituiscono il suo colore tutto particolare. Il tono pastorale attraversa tutta la lettera
enciclica: esso gli dà una forma accessibile e semplice in modo luminoso, non per
questo riduttiva. Il Pastore supremo della Chiesa parla ad ogni suo fratello e sorella in
Cristo, per i quali è Servo dei servi di Dio e consegna in questa forma solenne, come
il segreto più prezioso, l’insegnamento sull’Eucaristia. Esso conosciuto e in un certo
senso, “bevuto” con il latte genuino della fede che ogni cristiano riceve nel battesimo,
ora viene riproposto per farne sempre rinnovata esperienza. Anzi la domanda del
Papa, una di quelle domande di alto spessore pastorale che si presentano nella lettera,
risuona in tutta la sua estensione: «Come non sentire il bisogno di esortare tutti a
frane sempre rinnovata esperienza?»79
Ecclesia de Eucharistia è un documento
comprensibile per tutti; come l’Eucaristia è il dono per tutti i battezzati, così
l’enciclica vuole essere l’occasione e l’invito alla meditazione a portata di mano di
ciascun battezzato sul mistero che sorpassa le possibilità umane di comprensione80
.
latens Deitas!” Noi Ti adoriamo, o mirabile Sacramento della presenza di Colui che amò i suoi
“sino alla fine”. Noi Ti ringraziamo, o Signore, che nell’Eucaristia edifichi, raduni e vivifichi la
Chiesa. O divina Eucaristia, fiamma dell’amore di Cristo che ardi sull’altare del mondo, fa che la
Chiesa, da Te confortata, sia sempre più sollecita nell’asciugare le lacrime di chi soffre e nel
sostenere gli sforzi di chi anela alla giustizia e alla pace (…) “Adoro te devote, latens Deitas”...
Adoro te… adiva me!» (OR 92, 19.04.2003, 5, n. 5). 79
EE 7. 80
Anche i riferimenti patristici, nella loro ricchezza, sono in maggioranza dei passi colti dalle opere
di indole pastorale e catechetica. Si vedano le belle citazioni in EE 12: SAN GIOVANNI CRISOSTOMO,
Omelie sulla Lettera agli Ebrei, 17, 3; EE 14: SANT’AMBROGIO DI MILANO, De sacramentis, V, 4,
26 (rivolto ai neofiti); SAN CIRILLO DI GERUSALEMME, Catechesi mistagogiche, IV, 6; EE 17:
16
Che richiede la fede da ciascuno81
, perché «davvero l’Eucaristia è mysterium fidei,
mistero che sovrasta i nostri pensieri, e può essere accolto solo nella fede, come
spesso ricordano le catechesi patristiche su questo divino Sacramento»82
.
Lo spessore particolarmente personale, come nella precedente Lettera
apostolica Rosarium Virginis Mariae (16.10.2002)83
, fa di questo insegnamento del
magistero pontificio una vera e propria testimonianza del vissuto. Il realismo
autobiografico è non solo il sostegno della dottrina, la sua esplicazione più profonda,
la conferma storio-salvifica di una verità rivelata, offerta quasi in modo
contemplativo e, come tale, consegnata ad essere custodita, annunciata e celebrata nel
quotidiano. In questo senso la fede non è di fatto una teoria, ma è qualcosa di
estremamente pratico nel vero senso della parola, qualcosa di salvifico, senza di cui il
cristiano viene meno, non ci sarebbe del tutto, non esiste pienamente. L’esistenza
cristiana è zoppa, mancante e debole senza quel riferimento al vissuto della verità di
fede. Qui sta il profondo senso della contemplazione di Cristo a cui il Papa ha
invitato la Chiesa all’inizio del III Millennio. Anche qua non abbiamo davanti agli
occhi una bella teoria, una metafora, qualcosa di astratto, un modo di dire qualcosa di
irrealizzabile o una finzione. Passo dopo passo il Santo Padre guida la Chiesa nella
grande entrata del III Millennio. Ne ha dato le linee guida nella memorabile lettera
apostolica della prima ora del millennio Novo Millennio Ineunte (6.01.2000), a cui ha
offerto il coronamento mariano nella Rosarium Virginis Mariae, e ora apre la Chiesa
al passo successivo della contemplazione da compiere nel fissare la Chiesa del
mysterium eucharisticum84
. Ecclesia de Eucharistia.
SANT’EFREM, Omelia IV per la Settimana Santa; EE 18: SANT’IGNAZIO D’ANTIOCHIA, Lettera agli
Efesini, 20; EE 20: SAN GIOVANNI CRISOSTOMO, Omelie sul Vangelo di Matteo, 50,3-4; EE 23: SAN
GIOVANNI CRISOSTOMO, Omelie sulla I Lettera ai Corinzi, 24,2; Didachè, IX,4; SAN CIPRIANO,
Epistola LXIII, 13; EE 36: SAN GIOVANNI CRISOSTOMO, Omelie su Isaia, 6,3; EE 39:
SANT’IGNAZIO D’ANTIOCHIA, Lettera agli Smirnesi, 8; EE 40: SANT’AGOSTINO D’IPPONA, Sermo
272; ecc. La ricchezza di tali luoghi patristici dovrebbe essere l’invito per la Chiesa a tornare con
nuovo vigore pastorale anche a questi scritti, proprio per vivere meglio l’Eucaristia e tutta la vita
sacramentale dei cristiani. 81
Si tratta di un tema che non solo segna il primo capitolo dell’enciclica: «Mistero della fede» (nn.
11-20), ma passa in tutto il complesso del documento come un filo conduttore, come un suo interno
anelito di nutrimento della dottrina riproposta, cf. EE 2 b; 11 c; 50; 54. Il mistero della fede non può
che diventare la sfida e l’appello e la necessità del mistero comunitario e personale di ciascuno della
fedeltà, di una «grande fedeltà» (cf. EE 52 b), di una fede eucaristica di Maria (cf. EE 55 a). 82
EE 15 a. Cf. CCC 1327. 83
Cf. A. AMATO, «Lettera di presentazione», in C. CHARAMSA, Il rosario, una scuola di preghiera
contemplativa, op. cit., 6; cf. IDEM., «Rosario, la preghiera dal cuore cristologico», OR, 25.01.2003,
1. 84
Cf. EE 6 – sul filo conduttore dei documenti pontifici che guidano i primi anni del III Millennio e
diventano la catena di un grande rinnovamento del quotidiano della Chiesa nella sua altissima
chiamata alla contemplazione. Essa è possibile, raccomandata, necessaria di una fede incessabile! È
una chiamata che riprende perfettamente lo spirito del Concilio Vaticano II e la sfida della nuova
evangelizzazione. La Chiesa di questo Millennio deve essere forte della contemplazione, della
preghiera, dunque della sua identità, nella conoscenza sempre più perfetta di chi è Cristo e di chi è
Ella, sua Sposa, unita misteriosamente nelle nozze eucaristiche, in un’alleanza nuova e perfetta di
una convivenza amorosa e serena. Il Papa in questo cammino è la Guida particolarmente forte, è
17
In modo speciale è da rilevare la semplicità di tutti e tre i documenti di questo
inizio del nuovo Millennio. La semplicità di una dottrina difficile da comprendere,
come quella teologica, mariologica, ecclesiologica e eucaristica. Essa viene offerta a
tutti in un inno di lode a Dio che è semplice, nel«la testimonianza di fede del
Pontefice nella Santissima Eucaristia, in compagnia e a conforto della nostra fede»85
.
La sua scienza non è per i prediletti, essa – particolarmente in questo tempo difficile e
quante volte confuso e infelice – è da riproporre e riprendere urgentemente come una
conoscenza preziosa ed essenziale, affascinante e ricreante per ogni cristiano. La
scientia Dei è semplice in quanto si offre in modo accessibile ad ogni cristiano:
questo suo lato universale, se vogliamo catechetico e pastorale valorizza il Santo
Padre. Ma si tratta di molto di più che di una ripresa pastorale dell’annuncio, per
quanto questa rimane già in sé fondamentale e degna di massima cura. Il Papa svela
le vie di una conoscenza a cui l’accesso nella porta della fede ad ogni credente. Egli
non può entrarvi senza quel continuo essere formato, istruito, e infine, nutrito e
illuminato dalla comprensione sempre più ampia dei misteri della fede. Anche questa
è la contemplazione nella via della conoscenza meditativa. Per così dire, il “mestiere”
del credere, l’esercizio della fede non è riservato ad un ristretto gruppo di
“specialisti”, ma della conoscenza delle cose specialissime della fede deve vivere
ogni credente. Gli ultimi documenti magisteriali segnano questa preziosa linea
dell’annuncio e della professione di fede. Essi offrono la dottrina rinnovata della fede
e la vogliono proporre alla meditazione di tutti. Se i documenti magisteriali da
sempre presentano una forma accessibile per facilitare la lettura da parte dei credenti,
ora lo fanno con un carisma del tutto speciale proprio come le linee guida degli inizi
di un cammino nuovo, rinnovato dalla gioia giubilare e lanciato in un programma
coraggioso di «prendere il largo nel mare della storia con l’entusiasmo della nuova
evangelizzazione»86
.
Come la Chiesa si preoccupa continuamente, perché i suoi figli leggano la
Sacra Scrittura per intera e sappiano nutrire il loro quotidiano, la preghiera e i
momenti di discernimento e di meditazione dalla Parola di Dio, cioè dalla familiarità
con la Bibbia; così bisogna dire che gli ultimi documenti del Magistero diventano
ugualmente la sfida per ogni credente, in quanto facilitano particolarmente la lettura
di tutti con la loro natura di luminosa testimonianza nell’esposizione della dottrina,
ciò svela ancora più a fondo la loro interna esigenza di responsabilità di ciascuno
davanti ai misteri così grandi come quelli dati alla nostra conoscenza di Dio Uno e
Trino, Dio di Gesù Cristo, nato da Maria.
Non bisogna neanche dimenticare che l’Eucaristia stessa è la fonte di
conoscenza di Cristo, la massima fonte di conoscere chi è Lui, come lo hanno ri-
padre e maestro di questi primi passi da bambini del nuovo Millennio. In un società senza padri e
senza maestri egli si carica di un insegnamento e di una pedagogia che nella sua autenticità spesso è
vista come unica di cui si può fidare senza riserve l’uomo di questo nostro secolo. Lo stile della
testimonianza rafforza particolarmente questo impegno prodigioso. 85
EE 59 b. Non si potrebbe forse trovare dedica più bella e più impegnativa di questo documento
pasquale sulla comunione ecclesiale dell’Eucaristia. 86
EE 6.
18
conosciuto e, diremmo, nuovamente e daccapo conosciuto i discepoli di Emmaus (Lc
24,13-35)87
. Anzi, il Papa per primo si sente affiancato al cammino di apertura dei
discepoli di Emmaus del primo giorno di Pasqua di Risurrezione, nel cammino di
apertura che ci accomuna con la loro esperienza paradigmatica. In mezzo
all’Eucaristia gli occhi si aprono alla luce e il cuore alla speranza88
. Si potrebbe dire,
parafrasando l’esperienza del libro di Giobbe, «prima lo conoscevano per sentito dire,
ora lo conosco così come è in verità; ora i miei occhi lo vedono» (cf. Gb 42,5).
Questa particolarissima conoscenza di Dio vicino è la forza dei cristiani, è il loro
privilegio, la capacità che, in un certo senso, coinvolge tanti modi umani di conoscere
e li innalza ad uno stato dello spirito, in cui la persona assimila come suo proprio
tesoro, come l’origine della sua esistenza ciò che ha appreso. È la misteriosa
conoscenza della fede89
nell’Eucaristia, in quanto «supera il nostro intelletto»90
,
prima facendo fallire la conoscenza stessa dei sensi, del visus, del tactus e del
gustus91
.
Le prime riflessioni conclusive sull’enciclica
Chi è la Chiesa dell’Eucaristia? Chi è la Chiesa che si edifica nell’Eucaristia92
?
Essa è unita dall’unica Eucaristia93
e può essere perciò essenzialmente chiamata
«eucaristica»; è la Chiesa della pace dello spirito94
, della forza in mezzo alla prova,
irrobustita continuamente in mezzo al cammino terreno. È una Chiesa che porta in sé
il principio costante del suo essere ed è essa stessa un essere vivo e dinamico, sempre
in crescita95
, un essere che deve nutrirsi continuamente della ricchezza della sua
fonte, che è «ipse Christus»96
. La Chiesa che vive dell’Eucaristia, non potendo di per
sé contenere questa fonte di vita divina97
, l’abbraccia nella totalità del suo mistero di
fede che salva e solo così può dirsi forte della vicinanza del Signore, della speranza
che non delude, dell’amore che vince incomprensione e tradimento98
. Solo così
diventa capace di guardare il suo futuro con coraggio e con fiducia, nella certezza che
87
EE 6 conclude: «Ogni volta che la Chiesa celebra (Eucaristia), i fedeli possono rivivere in
qualche modo l’esperienza dei due discepoli di Emmaus: “si aprirono loro gli occhi e lo
riconobbero”». 88
Cf. EE 59 a, e anche CCC 1405. 89
Su vari modi della conoscenza umana si veda l’insegnamento della Fides et Ratio, p.es. FR 8,
ecc. Cf. R. FISICHELLA, «L’introduzione e guida alla lettura», in Fides et Ratio. I rapporti tra la
fede e ragione, Piemme, Casale Monferrato 1998, 6.-43. 90
EE 53 c. 91
Cf. EE 59 b – dall’inno Adoro te devote. 92
Cf. EE 26. 93
Cf. STh III, q. 73, a. 4, resp. Nell’Eucaristia tutto serve «ad ecclesiasticam unitatem
significandam» (STh III, q. 74, a. 1, ad 1; q. 75, a. 2, ad 3). 94
L’Eucaristia è sacramento di pace, in quanto è sacramento d’unità (STh III, q. 83, a. 4, resp.). 95
Cf. EE 21 a. 96
STh III, q. 73, a. 5, resp. 97
EE 29 a recita che l’Eucaristia è «un dono che supera radicalmente il potere dell’assemblea». 98
Essa è il sacramento della carità, che è il legame perfetto, STh III, q. 73, ad 3.
19
non inciampa il piede di chi si fida del Signore. È questa la Chiesa che dà la felicità
della comunione, offre la forza dello spirito che diventa incisivo nel quotidiano di
ogni cristiano, perché impressa nei cuori e nella memoria dei suoi discepoli99
.
Altrimenti la sua vita rimane fiacca e grigia, debole e immersa nelle correnti varie
delle incertezze del mondo. Altrimenti il cristiano non riesce ad essere il testimone
incisivo ed efficace del deposito della fede, né riesce a trovare la gioia nella sua
appartenenza a Cristo, nel suo essergli conforme nel battesimo e nutrito, cibato,
sostenuto nella comunione dell’Eucaristia.
«La Chiesa (che) vive del Cristo eucaristico»100
può dire dunque – come da
ottobre 2002 meditiamo nei giovedì nella corona del Rosario101
– che l’Eucaristia è
un vero «mistero della luce»102
, che accompagna la Chiesa in ogni giorno del suo
pellegrinaggio sulla terra. L’Eucaristia non è che fa accendere una luce qualsiasi: essa
piuttosto fa espandere la luce costante della comunità, «getta luce sul nostro
cammino»103
, fa diffondere la luminosità del Volto eucaristico del Cristo, come lo
nomina Giovanni Paolo II. Il Volto eucaristico di Cristo dunque comunica la luce per
la Chiesa, regala la serena luce della sua presenza per la Sposa e infonde il raggio
della luminosità della salvezza nei cuori dei fedeli. Solo così il popolo cristiano può
essere la luce del mondo104
, in quanto crede nell’efficacia della preghiera eucaristica,
in unione con Cristo capo e sposo, «al Padre della luce, da cui discende “ogni buon
regalo e ogni dono perfetto” (Gc 1,17)»105
.
Infine, anche la prima figlia della Chiesa, Maria, è donna «eucaristica» con
l’intera sua vita106
. Mulier «eucharistica» è attraverso «la sua fede eucaristica»107
.
Con il sesto e ultimo capitolo dell’enciclica108
, si vede meglio il filo conduttore che ci
porta dalla contemplazione di Cristo nella Novo Millennio Ineunte, passa tramite la
preparazione mariana della Rosarium Virginis Mariae e arriva all’Eucaristia, alla
Ecclesia de Eucharistia. La contemplazione di Cristo è il filo conduttore di un
cammino di perfezione possibile e realizzabile, raccomandato alla Chiesa quest’oggi,
nell’ora dell’inizio del Terzo Millennio. Quindi, il modello per eccellenza di questo
sguardo contemplativo della Chiesa rivolto al suo Signore109
non può che essere
Vergine Maria. Lei con e in mezzo ai Santi di Dio110
, ma lei soprattutto, in quanto
«ha anticipato, nel mistero dell’Incarnazione, anche la fede eucaristica della
99
Cf. STh III, q. 73, a. 5, resp., dove viene citato SANT’AGOSTINO, 1 Responsionum ad Ianuarium,
6. 100
EE 6. 101
Cf. RVM, 21, cf. EE 53 a. 102
EE 62 a. 103
EE 19. 104
EE 22 b, cf. Mt 5,13-16 105
EE 43 b. Sull’azione di grazie e la lode al Padre si veda anche CCC 1359-1361. 106
EE 52 c: «Maria mulier tota sua vita est “eucharistica”». 107
EE 55 a. 108
EE 53-58. 109
Cf. EE 1 b. 110
Cf. EE 62 a: «Santi, grandi interpreti della vera pietà eucaristica», e anche EE 15 c (teologia
dell’Eucaristia); 25 c (adorazione dell’Eucaristia fuori della Messa); 34 b (comunione spirituale).
20
Chiesa»111
. Ella brilla come una maestra della contemplazione112
nella scuola dei
Santi di ogni tempo, dove si apprende non altro che la maestria di Cristo stesso.
Il sublime inno eucaristico che il Papa offre alla Chiesa, guarda con speranza
verso il futuro, ma riprende, come forza del sua cammino, l’insegnamento della
Tradizione bimillennare della Chiesa sulla presenza eucaristica di Cristo nella sua
Chiesa. Se il patrimonio del primo Millennio è segnato nell’enciclica con la ricca
testimonianza dei Padri della Chiesa113
, possiamo dire che il secondo Millennio
sapientemente rappresenta e riassume in essa san Tommaso d’Aquino, che si merita,
tra tanti altri, il titolo del vero Doctor «eucharisticus»114
. Tutti invece si ritrovano nel
modello per eccellenza della vita eucaristica della Chiesa di tutti i tempi, che è Maria
Santissima, “la Chiesa nascente”, in quanto Colei che per prima ha accolto la
presenza reale del Signore – ciò che l’Eucaristia è realmente – «il mistero che
riassume tutte le meraviglie operate da Dio per la nostra salvezza»115
.
Roma, Triduo pasquale A.D. 2003
111
EE 55 c. 112
EE 53 a. 113
Cf. la nostra nota 80. 114
Ricordiamo il giudizio di I. Biffi, che dice «la dottrina eucaristica dell’Angelico rimane (pur
ovvi limiti storici) ancora più ampia e la più geniale che la riflessione teologica cristiana abbia
elaborato, dove tutta la tradizione patristica si riscontra e l’esigenza di “comprensione della fede” si
trova largamente soddisfatta» (Il corpo dato e il sangue sparso, op. cit., 22). 115
GIOVANNI PAOLO II, «La “Statio Orbis” del XLVII Congresso Eucaristico Internazionale»,
25.06.2000, Insegnamenti XXIII, 1 (2000) 1167-1171, qui 1170, dove viene citato SAN TOMMASO
D’AQUINO, De sacramento Eucharistiae, 1.

























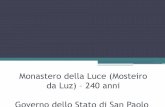


![Paideía e saṁskṛti: qualche spunto di riflessione [Paideía and Saṁskṛti: Some Food for Thought]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63136b455cba183dbf071738/paideia-e-saskti-qualche-spunto-di-riflessione-paideia-and-saskti.jpg)













