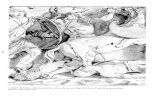Esercizi di stile sul Campidoglio: un disegno inedito di Julien de Parme
Pier Paolo Pasolini poeta fotogrammatico: la luce tra stile e metafora
Transcript of Pier Paolo Pasolini poeta fotogrammatico: la luce tra stile e metafora
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
SCUOLA DI LETTERE E BENI CULTURALI
Corso di laurea in
Lettere Curriculum Moderno
PIER PAOLO PASOLINI “POETA FOTOGRAMMATICO”:LA LUCE TRA STILE E METAFORA
Tesi di laurea in
Letteratura Italiana Contemporanea
Relatore Prof: Marco Antonio Bazzocchi
Presentata da: Francesco della Noce
Sessione seconda
Anno accademico 2012-2013
1
Indice
Introduzione: la variata immagine della luce p.5
Capitolo I: Poliedro di luce: specimina della luce ne Le ceneri di Gramsci,
La religione del mio Tempo, Poesia in forma di rosa. p.8
1.1 Luce atmosferica o di decoro ( A ) p.8
1.1.1 Tra cronachistico e universale p.8
1.1.2 Icasticità e retorica p.9
1.2 Luce Allegorica ( B ) p.11
1.3 Luce Simbolica ( C ) p.12
Capitolo II:La luce come elemento figurativo e poetico:
“Pasolini poeta fotogrammatico” p.14
2.1 Luce trait d'union tra codice figurativo e codice linguistico p.14
2.2 Contrasto e ossimoro p.24
Capitolo III: Le metafore della luce p.29
3.1 La luce tra cinema e poesia p.29
3.2 Pasolini e le polemiche degli anni '60 p.35
3.3 Sotto i riflettori del falso progresso p.39
3.4 La vis allegorica delle lucciole p.41
Capitolo IV: Luce mistica p.48
4.1 La luce del sole p.52
Conclusioni p.56
Apparato Iconografico p.59
Bibliografia p.68
Appendice p.71
2
A Nino e Ninì
Un sincero, profondo, reverenziale
ringraziamento a Maria Occhinegro,
senza il cui aiuto questo lavoro
non avrebbe visto la luce.
3
«Felice il tempo nel quale la volta stellata è la
mappa dei sentieri praticabili e da percorrere, che il
fulgore delle stelle rischiara. Ogni cosa gli è nuova e
tuttavia familiare, ignota come l'avventura e insieme
certezza inalienabile. Il mondo è sconfinato e in pari
tempo come la propria casa, perché il fuoco che arde
nell'anima partecipa dell'essenza delle stelle: come la
luce del fuoco, così' il mondo è nettamente separato
dall'io, epperò mai si fanno per sempre estranei l'uno
all'altro. Perché il fuoco è l'anima di ogni luce e nella
luce si avvolge ogni fuoco.»
György Lukács, Theorie des Romans
4
Introduzione
La variata immagine della luce
Pier Paolo Pasolini è stato soprattutto un poeta, della parola come dell'immagine; e
tra questi due mezzi espressivi sussiste una continua osmosi che dota la già
copiosissima produzione di una ricchezza aggiunta.
Oggetto della presente ricerca è indagare il ruolo che la luce riveste in una parte
della produzione pasoliniana, nello specifico quella poetica, biograficamente compresa
tra il suo arrivo a Roma e l'inizio della sua carriera cinematografica.
Le ceneri di Gramsci, La Religione del mio tempo, Poesia in forma di rosa: opere
scelte per l'alto livello raggiunto dalla produzione poetica che precede l'approdo al
medium cinematografico, giro di boa della formazione intellettuale di un visionario
che nella luce ha individuato il punto di incontro fra dominio linguistico e figurativo,
tra livello estetico e spirituale, tra passione e ideologia.
Sembra che l'autore scriva con la luce sia le immagini cinematografiche che quelle
linguistico-poetiche, così che le altissime occorrenze dell'elemento luminoso nelle
opere, in particolare nelle poesie, sembrano essere il segnale di un'attenzione quasi
ossessiva.
È necessario avanzare una serie di ipotesi che verrà dimostrata nel corso di questo
lavoro, e che già più critici hanno sostenuto in relazione a singoli ambiti dell'opera
pasoliniana ( mi riferisco, in particolare, a Walter Siti1 e Vincenzo Cerami2), ovvero
l'ipotesi che esista un'equivalenza tra il piano figurativo-immaginario e quello
stilistico-espressivo nella produzione letteraria pasoliniana, e ciò è vero in particolar
modo per la poesia, e che sia la luce, pertanto, a far da spola tra l'immagine e la parola
(nella poesia) e tra la parola e l'immagine (nella sceneggiatura) nella tessitura delle
opere, letterarie e cinematografiche.
La luce è « uno degli elementi alla base della sua rappresentazione della realtà»3,
1 W. Siti, Il sole vero e il sole della pellicola, o sull'espressionismo in Pasolini in Rivista di letteratura italiana, VII, 1 , 1989
2 V.Cerami, La trascrizione dello sguardoin Pier Paolo Pasolini, Per il Cinema, a cura di Walter Siti, Mondadori, Milano, 2003
3 Marco Antonio Bazzocchi, I burattini filosofi, Bruno Mondadori, Milano, 2007, p. 12
5
quindi il punto di contatto tra codice figurativo e codice linguistico e, più
generalmente, tra immaginazione e realtà, tra appropriazione del reale e realtà stessa:
«soltanto la luce lascia trasparire per lo sguardo l'oggetto in quanto oggetto visibile, e lascia passare lo
sguardo, che vede, verso un oggetto da vedere. La luce è ciò che lascia passare. Il chiaro è la visibilità (il
visibile), estensibilità, apertura dell'aperto. Con ciò abbiamo determinato l'essenza vera e propria del chiaro: esso
consente alle cose di mostrarsi allo sguardo, di offrire una veduta la vedere, inteso nell'accezione ristretta del
percepire attraverso la vista.»4
E, poiché la realtà, per Pasolini, è oggetto di un amore sacrale, nell'universo
figurativo del poeta la luce arriva ad assumere anche una forte valenza allegorica e
simbolica rispetto al reale di cui il poeta si appropria (soprattutto ne Le Ceneri di
Gramsci) e condivide la medesima natura del sentimento del sacro e della passione ab
joi.
Un oggetto di ricerca così sottile non permette che venga esaurito nel presente
lavoro, tuttavia si è cercato di costituire un'intelaiatura capace di dare un'idea
dell'importanza di tale argomento all'interno della produzione pasoliniana e accogliere
la varietà della luce partendo dall'oggettività delle sue occorrenze.
4 Martin Heidegger, L'essenza della verità, Adelphi, Torino, 2004, p. 50
6
« No, non ero io che contavo, né il
mondo, ma soltanto l'accordo e il
silenzio che fra il mondo e me faceva
nascere l'amore.»
Albert Camus, Nozze
7
Capitolo I
Poliedro di luce: specimina della luce ne Le ceneri di Gramsci, La religione del
mio Tempo, Poesia in forma di rosa.
Davanti alle numerose occorrenze, si è voluto procedere, nell'intenzione di una
filologia del pensiero poetante, a una catalogazione tripartita del minerale poetico, tra
la figuratività, la dirompente critica dell'allegoria e la forza del simbolo. Si vuole qui
presentare una campionatura delle occorrenze più specifiche e pregnanti in cui la luce
è presente, più o meno direttamente, nelle poesie di queste raccolte. 5
1.1. Luce atmosferica o di decoro (A):
In molte poesie la luce contribuisce o a creare un'atmosfera che il poeta vuole
esprimere, o a esaltare figurativamente alcuni elementi pregnanti all'interno del
componimento. Quest'utilizzo della luce risponde a una visualità che rimanda
all'universo figurativo (manieristico e caravaggesco) che Pasolini, tramite le lezioni di
Longhi, ha fatto suo. L'estetica e l'alta figuratività delle poesie sono il fuori (modus
videndi) di un dentro che corrisponde a una certa maniera di vivere e stare nel mondo
(modus vivendi). L'uso qui indagato è quello atmosferico; la luce è finalizzata alla
creazione di un particolare atmosfera che il poeta vuole trasmettere per verba. Si tratta
di una prassi luminosa di superficie, non priva di figure retoriche (vedi infra). In
alcune occorrenze l'intensità della luce fa sì che essa funga da soglia verso un valore
allegorico o simbolico.
1.1.1 Tra cronachistico e universale
In buona parte delle occorrenze, in particolare ne Le Ceneri, il poeta getta il suo
sguardo su luoghi particolari, presentati con un massimo di definizione e avvolti da
5 Si è voluto procedere alla catalogazione delle diverse occorrenze separandole in tre grandi gruppi, che vengono indicati con una lettera (A, B, C) e numeri arabi progressivi. Per una migliore fruibilità del testo, si è preferito porli in Appendice.
8
una visione poetica che li trasfigura in luoghi universali, generali. Il volo del suo
sguardo lungo l'Appennino diventa ipotiposi della frenesia di una vita umile e
marginale, squisitamente popolare. (A1,A 2,A 4, A5,A 7 ) L'insistenza sui luoghi,
presentati attraverso la luce, si inscrive in una ricca tradizione cronachistica presente
all'interno della letteratura italiana. Un esempio per tutti, di uno dei suoi maggiori
esponenti, siano i versi 254-257 de La Ginestra di Giacomo Leopardi, che così
recitano:
«[...] Su l'arenoso dorso, a cui riluce/ Di Capri la marina/ E di Napoli il porto e
Mergellina.»6
Quest'insistenza sul luogo, che viene come illuminato dalla luce dello sguardo del
poeta, che indugia sui frammenti e particolari più poetici, dà al particolarissimo un
valore universale: come per Leopardi Napoli diviene culla di un'umanità che può e
deve unirsi per ergersi e far fronte alla precarietà della sua condizione, così in Pasolini
la toponomastica di una Roma periferica e la vivida descrizione del paesaggio italiano
trasfigurano la periferia in crogiolo di pura vita, di esistenza antropologicamente
differente, di meravigliosa ed eterna autenticità.
Appare qui la centralità della marginalità7, che Pasolini pone al centro delle sue
raccolte poetiche.
1.1.2 Icasticità e retorica
La figuratività del linguaggio poetico, il quale, come si vedrà più avanti, è strettamente
legato alla necessità di espressione (da cui l'espressionismo) di Pasolini e al codice
figurativo che aveva assimilato tramite Longhi, si realizza spesso attraverso ricche
figure retoriche quali l'ipallage8, la sinestesia9 , l'antitesi e l'ossimoro10 e la
personificazione11.
Questa ricchezza retorica deriva da un'attenzione verso la luce che funge da filtro
6 Giacomo Leopardi, La Ginestra in Tutte le opere in poesie, vol. I , a cura di Francesco Flora, ArnoldoMondadori Editore, Milano, 1953, p. 122
7 Marco Antonio Bazzocchi, I burattini filosofi, Bruno Mondadori, Milano, 2007 p.1538 Cfr. A5,A26,A39,A47,A579 Cfr. A7,A9, A10, A11, A13,A17, A23,A24,A25,A42,A5110 Cfr. A6,A11,A46, A47, A6111 Cfr. A16, A58,A63,A65
9
percettivo che fa apparire il poetico nella concretezza del reale: è una particolare
atmosfera (fisica e psichica assieme) che apre a una percezione della realtà come sede
del poetico o del sacro: quest'attenzione si risolve nell'armonia della figura retorica, in
cui la luce è protagonista (come si diceva supra in riferimento al chiaro e alla
percezione).
10
1.2. Luce allegorica (B):
La luce ricorre spesso come elemento allegorico, soprattutto ne Le ceneri di Gramsci,
prima raccolta di respiro civile e nazionale. L'allegoria è una potenza di raffigurazione
differente dal simbolo, giacché se quest'ultimo combina l'eterno e l'istante, l'allegoria
svela la natura e la storia seguendo l'ordine del tempo: trasforma la natura in storia e la
storia in natura. I luoghi su campionati e descritti dal lampo dello sguardo poetico
dell'autore arrivano a caricarsi fino al parossismo e superano la soglia della superficie
figurativa per giungere a caricarsi di un valore metaforico critico e attuale, poiché
l'allegoria serve a dar forma all'individuale in modo tale che esso appaia una metafora
dell'universale: l'allegoria «trasforma il fenomeno in un concetto, il concetto in
un'immagine, ma in modo che il concetto nell'immagine sia da considerare sempre
circoscritto e completo nell'immagine e debba esser dato ed esprimersi attraverso di
essa»12
Il valore metaforico dell'allegoria lo ritroviamo in:
la luce come metafora del falso progresso13
la luce metafora dell'ideale e della Storia come possesso borghese14
la luce metafora dell'ideale della Resistenza e di un futuro di redenzione15
12 Wolfgang Goethe, Massime riflessioni a c. di S. Seidel, Roma, 1983, in Estetica, di Elio Franzini e Maddalena Mazzocut.-Mis, Bruno Mondadori, Milano, 2010, p. 208
13 Cfr. 1,3,4,5,6,714 Cfr. 8, 1115 Cfr. 10,14,15,17,18,20
11
1.3. Luce simbolica (C)
Per comprendere l'importanza del valore del simbolo all'interno della produzione
poetica pasoliniana è opportuno fare dei brevi accenni alla storia della riflessione este-
tica.
Anzitutto, il simbolo, o la messa in atto di una funzione simbolica, è insita nell'e-
spressione delle idee estetiche, nell'atto della creazione artistica e nel suo mondo
espressivo, attraverso una logica che non è riconducibile a forme conoscitive precosti-
tuite16.
Anche attraverso il simbolo è possibile cogliere l'universale nel particolare, di
esprimere l'infinito nel finito, ma a differenza dell'allegoria, proprio perché non è ri-
conducibile a forme conoscitive precostituite (il concetto), esso opera attraverso l'ana-
logia che mette in contatto le cose del mondo cogliendone le intime corrispondenze, e
assurgendo a un livello ideale.
Alla luce di quanto detto, possiamo rilevare che in numerose occorrenze, la luce
viene utilizzata come simbolo: è spesso in relazione a diversi elementi quali la purezza
e la passione, cui si affiancano la vita, la gioia e la creazione.
Questa visione della luce è vicina alla “passione ab joi” che Pasolini poneva alle
radici della sua produzione poetica e alla sua visione epico-religiosa del mondo, vicina
a una vera e propria ierofania dello spirito divino del mondo, che per Pasolini è un
principio arcaico, profondamente umano e del tutto immanente.
16 Elio Franzini e Maddalena Mazzocut.-Mis, Estetica, Bruno Mondadori, Milano, 2010, p. 204
12
«I campi sono più verdi quando si descrivono che nel
loro reale colore verde.»
F. Pessoa, Il libro dell'inquietudine
13
Capitolo II
La luce come elemento figurativo e poetico:
Pasolini “poeta fotogrammatico”
2.1 Luce trait d'union tra codice figurativo e codice linguistico
La sceneggiatura di Mamma Roma (1961) si apre con questa dedica: «a Roberto
Longhi cui sono debitore della mia “fulgurazione figurativa”»17. Longhi, celeberrimo
storico e critico dell'arte, rivestì per Pasolini un ruolo di fondamentale importanza nel-
la formazione umanistica e artistica tanto da influenzare irrevocabilmente il suo im-
maginario. Lo conobbe nella «piccola aula (con banchi molto alti e uno schermo dietro
la cattedra)» di via Zamboni durante il periodo di studi universitario. Pasolini, recen-
sendo, a distanza di molti anni, il volume Da Cimabue a Morandi, parla di Longhi
come di un'apparizione, che assume «i connotati archetipici dell'evento irripetibile»18
È, insomma, indubbio che Pasolini fu debitore nei confronti del suo maestro per
quanto riguarda l'amore che egli nutrì profondamente per la storia dell'arte, e in parti-
colare per i maestri fiorentini, Giotto, Piero della Francesca e Masaccio ma soprattutto
i manieristi Pontormo, Rosso Fiorentino e il Parmigianino e il geniale Caravaggio.
Quel che è importante rilevare è come questo appassionato amore di Pasolini per la
pittura abbia sotterraneamente lavorato fino a diventare per Pasolini un modus videndi.
Alberto Marchesini lo ha dimostrato molto bene nel suo opuscolo, facendo emergere
da un lato l'attrazione “sacrale” di Pasolini verso le opere pittoriche, e dall'altra il suo
modo, inedito e peculiare, di utilizzare la pittura nelle sue opere: egli, attraverso le
“fulgurazioni” di Longhi, arriva a possedere lo sguardo del pittore, non l'opera stessa,
fino a ricavare un modello di alta pregnanza visiva e simbolica.
Esemplare, a tale proposito, il poema Gli affreschi di Piero ad Arezzo (Fig. 9), in
17 Pier Paolo Pasolini, Accattone- Mamma Roma – Ostia,Garzanti, Milano, 2006 p. 24018 A. Marchesini, Longhi e Pasolini: tra “fulgurazione figurativa” e fuga dalla citazione p. 6
14
cui la visione, che compie una vera e propria écfrasis del «sacro muro»19 , ripercorren-
do, attraverso particolari e scorci, è mediata da uno sguardo di secondo grado, il «pio»
sguardo di un operaio, che si proietta interamente nell'opera. Tramite quest'operazio-
ne, l'io autoriale recupera quella verginità e quella purezza di sguardo capace di coglie-
re la divinità della visione, velata dalla sola «luce […] che si spande/ da un sole rac-
chiuso dove fu divino/ l'Uomo, su quell'umile ora dell'Ave», come all'arrivo di quel
«primo raggio di mero sole» che pare tingere il colore del mondo.20 lo sguardo diventa
omogeneo con l'azione della luce che dà la giusta forma e il giusto colore ad ogni cosa,
come insegna Longhi21.
Questa stessa operazione di uno sguardo mediato, era già presente anche nel poe-
metto Picasso, in cui attraverso lo sguardo di un borghese «chiaro nel chiaro vestito»22
l'autore mette a nudo l'Espressione «che si incolla alla cornea e al cuore,/ irrichiesta,
pura, cieca passione»23
Di ogni autore, poi, un aspetto viene privilegiato più di un un altro: dal Pontormo
prende i colori, reinterpretati nel tableau vivant de La Ricotta ( Pànfete, un'altra volta –
a stacco netto – la Deposizione del Pontormo a colori, coi colori che sfolgorano in pie-
no petto...)24 , i costumi da Piero della Francesca25, ma è da Masaccio che egli fa deri-
vare il maggior grado di espressività, riprendendone soprattutto quel particolare uso
della luce che miri a far emergere il corpo nella sua urgenza materiale, a un punto tale
da farlo diventare figura. Allo stesso modo in cui «Masaccio[...]pone l'uomo al centro
della speculazione e costruisce attorno a lui un'intelaiatura prospettica tale da dare ri-
lievo grandissimo alle figure che sono modellate con linee essenziali e si stagliano in
un netto contrapporsi di luci e ombre.»26 , così la sofferente umanità delle borgate è
19 Roberto Longhi, Da Cimabue a Morandi, a cura di Giafranco Contini, Mondadori, Milano, 1973 p. 390 20 Ibid.21 «Distribuisce esso [il primo raggio di mero sole] agli uomini il tono del sesso e della razza, al paese e agli animali i vocaboli dei loro mantelli, ai metalli il forbito, agli eserciti i quarti delle insegne e degli scudi; agli edificî e ai vestimenti le apparenze di abitato involucro, ch’essi sono, del gesto e della vita»R. Longhi, Ibid.
22 Pier Paolo Pasolin, Picasso, in Le Ceneri di Gramsci, Milano, Garzanti, 1957, p. 1823 Id. p. 2024 Pier Paolo Pasolini, Alì dagli occhi azzurri, Milano, Garzanti, 1989 p. 48025 Alberto Marchesini, Op. Cit. ., p. 1926 Stefania Vannucci, Pier Paolo Pasolini: I colori della poesia, Quaderni Pier Paolo Pasolini Associazione
Fondo Pier Paolo Pasolini, Roma p.131
15
presentata nelle sue inquadrature. Ragazzi di vita, prostitute, magnaccia e altri umili
testimoni dell'esistenza condividono il pesto e mesto sguardo degli astanti de «Il tribu-
to della Moneta» o del «San Pietro risana i malati con la propria ombra» (vedi
Fig.2,4,5, 8, 9,10), di chi, sotto il peso di una sopravvivenza suburbana, cela la «grazia
esistenziale degli uomini»27
Scrive Marchesini: «Il chiaroscuro e lo spesso volumetrico,[...] costantemente ri-
cercati nell'inquadratura, vanno pertanto letti come filtri ulteriori fra l'autore il proprio
mondo, altre vie d'accesso alla ricomposizione mitica del suo universo poetico.»28
Lo afferma Pasolini stesso quando, nella preparazione di Accattone, dice di aver
pensato spesso a Masaccio, « non imitandolo per certe inquadrature, ma proprio pen-
sandoci come sostanza, come modo di vedere[il corsivo è nostro] certe facce, certa gra-
vità della materia» o, più in generale, scrivendo che « i riferimenti pittorici erano visti
come fatti stilistici interni: non, accidenti!, come ricostruzione di quadri!».29
L'utilizzo del bianco e nero nei suoi primi film deriva anche e soprattutto dalla sug-
gestione che le diapositive di Longhi, appunto, in bianco e nero, esercitavano sul gio-
vane Pasolini, il quale mirava, attraverso il bianco e nero appunto, di far emergere il
corpo, la materia.
«Quello che io ho in testa come visione, come campo visivo, sono gli affreschi di Masaccio, di Giotto – che
sono i pittori che amo di più, assieme a certi manieristi (per esempio il Pontormo). E non riesco a concepire im-
magini, paesaggi, composizioni di figure al di fuori di questa mia iniziale passione pittorica, trecentesca, che ha
l'uomo come centro di ogni prospettiva. Quindi, quando le mie immagini sono in movimento, sono in movimen-
to un po' come se l'obiettivo si muovesse su loro sopra un quadro; concepisco sempre il fondo come il fondo di
un quadro, […] le figure in campo lungo sono sfondo e le figure in primo piano si muovono in questo sfondo, se-
guite da panoramiche, ripeto, quasi sempre simmetriche, come se io in un quadro, - dove, appunto, le figure non
possono essere che ferme – girassi lo sguardo per vedere meglio i particolari.»30
Prima del “cinema di poesia”, pare esserci in Pasolini una vera “poesia del
cinèma”, in cui lo sguardo affascinato del poeta sui particolari delle diapositive delle
opere d'arte dona movimento all'ombra-luce delle figure. Bellissime, a tale proposito,
27 Pier Paolo Pasolini, L'Alba meridionale, in Poesia in forma di Rosa, Garzanti, Milano, 1963, p. 16528 Alberto Marchesini, Op. Cit. p. 1229 Pier Paolo Pasolini, Le belle bandiere, Roma, Editori Riuniti, 1977 p. 23030 Pier Paolo Pasolini, Accattone- Mamma Roma – Ostia,Garzanti, Milano, 2006 p. 386
16
queste righe di Deleuze:
«La luce diviene visibile quando si scontra con uno schermo nero, ci dice Bergson. Ecco ciò che Böhme ci
dice: Dio è luce, ma anche attraverso essa non si manifesta. Ma in quanto è luce è posseduto da qualcosa che non
si confonde con lui ma che è l'aspetto più profondo in lui. Non è lui, ma è il senza-fondo in lui, e il senza-fondo
in lui è la volontà di manifestarsi. […] il secondo tempo è la collera di dio, cioè dio si opporrà all'opacità pura,
alle tenebre per giungere alla propria manifestazione. La collera di dio è l'atto attraverso il quale dio o la luce in -
nalza le tenebre come condizione della sua manifestazione. In questo momento, e in rapporto alle tenebre che si
oppongono alla luce, si dirà che la luce diventa bianca. […] è il passaggio della luce ad una coppia di opposizio-
ne, il bianco e il nero. Il nero saranno le tenebre allo stato puro , e il bianco sarà la luce in rapporto a queste tene -
bre. Ma per il momento nulla si manifesta; si tratta ancora delle condizioni della manifestazione. Terzo momen-
to: perché qualcosa si manifesta, che cosa occorre? Occorre che le tenebre si schiariscano un poco sotto la luce e
che il bianco si oscuri un poco sotto le tenebre...»31
In Diario al registratore Pasolini dichiara la sua estetica cinematografica: «Io cer-
co la plasticità, soprattutto la plasticità dell'immagine, sulla strada mai dimenticata di
Masaccio: il suo fiero chiaroscuro, il suo bianco e nero – o sulla strada, se volete, degli
arcaici, in uno strano connubio di sottigliezza e di grossezza. Non posso essere impres-
sionistico. Amo lo sfondo, non il paesaggio […] ombre e luci in movimento, sulla fi-
gura e sul paesaggio, la silhouette che danza contro gli sfondi in scorcio – mai frontali
– dei lungofiumi, dei mari increspati, dei boschetti».32
Chiave di lettura che ci accompagnerà per far emergere le ragioni di un certo uso
della luce nelle poesie. Quest'utilizzo plastico della luce, che vede contrapposti luce e
ombra in un continuo gioco di forme e volumi, ha radici in una soluzione stilistica, sul
crinale del rapporto bifronte tra l'immagine e la parola: Vincenzo Cerami, nell'introdu-
zione agli scritti di Pasolini per il cinema, scrive che la sua scrittura «si potrebbe defi -
nire visiva». Pasolini era come un pittore che:
«scriveva con un occhio alla letteratura e l'altro allo schermo, per scavare, rintracciare dentro un linguaggio
bidimensionale, non fatto di pensieri ma di facce, comportamenti e panorami, verità che il cinema, linguistica-
mente, tende a nascondere. Il linguaggio cinematografico lo scopriva mentalmente e o codificava sul copione,
assumendo gli occhi del pittore, attraverso la descrizione assorta e accorata delle inquadrature.» e in questa im-
maginosa verbosità, «alla luce […] è affidata la creazione del clima adatto alla scena. In sceneggiatura l'indica -
31 Gilles Deleuze, Cinema, Mimesis Edizioni, Milano, p. 43 32 Pier Paolo Pasolini, Op. cit. p. 392
17
zione di un colore prefigura una particolare luce, un'atmosfera capace di incidere sul senso dei fatti, o in contra -
sto o in perfetta coincidenza con il tono della sequenza.»33
Immagine e parola sono legate da un rapporto essenziale, nascono dall'intima ne-
cessità d'espressione. E Pasolini lavora l'immagine così come lavora la parola: scrivere
letteratura o cinema non può prescindere dall'applicare delle figure retoriche, dall'evi-
tare il grado zero della lingua. C'è sempre «almeno un'ombra di espressività, che è l'a-
spetto “naturale” dello stile» 34, e pertanto se un'immagine può avere la stessa forza al-
lusiva di una parola (“kinemi” = fonemi nella potenza comunicativa), è perché entram-
be sono frutto di scelte estetiche, fanno parte di un'operazione stilistica35 che le fa rien-
trare all'interno di una logica espressiva volutamente ricercata dall'autore per il suo si-
gnificato stilistico (e quindi politico, cfr. par. 3. 2)
Non pare fuori luogo, a questo punto, postulare una corrispondenza tra il contrasto
figurativo del cinema di Pasolini e il linguaggio poetico se, è vero come è vero, che «i
generi diversi che Pasolini affronta simultaneamente […] costituiscono un unicum ag-
glutinato e compatto» 36, tanto più che lo stesso scrive: «non è qui il caso di fare un'a-
nalisi sull'equivalenza del “sentimento poetico” suscitato da certe sequenze del mio ci-
nema e di quello suscitato da certi passi dei miei volumi di versi. Il tentativo di defini-
re una simile equivalenza non si è mai fatto, se non genericamente, richiamandosi ai
contenuti. Tuttavia credo che non si possa negare che un certo modo di provare qual-
cosa si ripete identico di fronte ad alcuni miei versi e ad alcune mie inquadrature» 37.
I tratti principali della pittura verso cui Pasolini era debitore possono riassumersi,
dunque, nell'accentuata coloritura, nel “chiaroscuro” e nell'antropocentrismo che risal-
ta nei quadri da lui amati, dove al centro si muovono una variegata umanità illuminata
dal lume universale (Piero della Francesca) (Fig. 13)o umili garzoni e prostitute ri-
schiarati dalla drammaticità del lume quotidiano (Caravaggio). (Fig.11 e 12)
33 Vincenzo Cerami, La trascrizione dello sguardo, in Pier Paolo Pasolini, Per il cinema, a cura di Walter Siti Mondadori, Milano, 2003 p.XXIX
34 Pier Paolo Pasolini, Accattone- Mamma Roma – Ostia,Garzanti, Milano, 2006 p. 57 35 Id. p. 6136 Fernando Bandini, Il sogno di una cosa chiamata poesia in Pier Paolo Pasolini, Tutte le poesie a cura di
Walter Siti Mondadori, Milano, 2003 p.XV37 Pier Pasolo Pasolini, Saggi sull'arte e la letteratura, a cura di Walter Siti, Mondadori, Milano, 2003 p.2511
18
Per comprendere la luce nelle poesie di Pasolini sarebbe opportuno servirsi di uno
strumento che prendiamo in prestito da Goethe, quando nella Teoria dei colori parla
del poliedro di luce: «un esempio di chiaroscuro artificiale in cui tutte le specie di luce,
mezzaluce, ombra e riflesso fossero visibili.»38
Questa varietà tonale si esplica anche a livello stilistico:
« Pasolini s'impossessa di svariati linguaggi, ma sulla congerie, sottesa da quella volontà di sublime, domina
soprattuto un linguaggio visivo, attento ai colori e alle peculiarità del paesaggio, alle ore del tempo (mattini e
crepuscoli), una sorta di persistente segnale che ci troviamo all'interno di un discorso poetico. Si tratta spesso di
momenti particolarmente vivaci della poesia pasoliniana, soprattutto quando il poeta si abbandona alla suggestio-
ne di un ricordo commosso dei luoghi.»39
Nelle poesie abbiamo una prevalenza dell'organo della vista sugli altri sensi, il che
determina un alta concentrazione figurativa che si traduce in un linguaggio fortemente
icastico.
E nell'abbondanza di queste descrizioni, risaltano contrasti visivi, come si può ve-
dere in questi esempi: «morta festa / di luci», «abbagliato sotto sbiadite stelle», «anco-
ra più buio, o l'abbaglia // con cieche schiarite», «lume che riverbera», «buio[...]il me-
riggio nel lucore / terreo», «luce nerastra», «pasta di luce sulla pasta dell'ombra viva».40
In altre occorrenze, invece, ritroviamo un diretto richiamo agli artisti verso cui Pa-
solini era debitore: «bruciore / della luna[....]tutto svapora e si fioco / tra colonnati di
caravaggesca polvere», «il gusto del dolce e grande manierismo che tocca col suo ca-
priccio dolcemente robusto // le radici della vita vivente:ed è realismo...»41. Bandini
torna a farci notare che Pasolini è come se compiesse una sorta di écfrasis alla rove-
scia. Partendo da citazioni pittoriche, da strumenti figurativi, ci porta, infatti, alla de-
scrizione dei luoghi e dei paesi42.
La luce, in questo universo figurativo, serve a far emergere anche i colori, «lumi
38 Wolfgang Goethe, La Teoria dei colori, in Opere Vol V., Sansoni, Firenze, 1961 p. 34039 F. Bandini, Op. Cit. p. XXVIII40 Cfr A6,A 8, A14, A17. A30, A32, A61,A 6641 Cfr, A42, A5042 Id. p.XXIX
19
ingialliscono la calda atmosfera», «cuori bianchi dei globi», «grigia luce»; «indorarsi
quieto»; «pasquale albore»;«lume fragrante[...]oleato fulgore», «verdi stesi da un pi-
tocco Corot», «i più bei colori ardevano nel mite, friulano sole»,« si accende l'azzurro
che bianco è quasi», «in superficie / superstiti grisaglie, cappelletti verdi / su casacche
rosso mattone o morello»43. I colori, del resto, non sono altro che una modulazione del-
la luce, della sua intensità: « “La luce cade”. Questo non vuol dire che essa si distrug-
ga, la luce rimane in sé, ma il raggio di luce ne esce in qualche maniera. Esso cade. E
la luce risale. Questi gradi della luce possiamo chiamarli colori. I colori sarebbero del-
le intensità di luce.»44
Cerami torna a spiegarci ( a proposito delle Ceneri di Gramsci, cui verrà data
maggior attenzione più avanti) come lo stile verbale , che fa della ricerca di nuove for-
me espressive la sua cifra, sia legato a uno stile figurativo di riferimento:
«lo sperimentalismo era la via d'uscita per tentare l'impresa del realismo”vero e proprio”, il quale, per evitare
il reperto sociologico e il moralismo ideologico, doveva saldarsi con una soggettività in grado di portare verità
(quindi contraddizione), presentare il mondo con uno sguardo fuorviante perché sensuale. [...]lo sperimentali-
smo, attraverso la mimesi e il plurilinguismo (e l'espressionismo) avrebbe dovuto rendere possibile l'equazione.
Ma un'altra equazione si poneva immediata e drammatica, quella che stringeva nello stesso laccio sperimentali-
smo e manierismo. »45
Lo sperimentalismo, dunque, prima e durante gli articoli di Officina, è inevitabil-
mente influenzato da un retroterra culturale figurativo, che influenza sotterraneamente
la ricerca dello stile, ed è volto a far emergere il contrasto, il chiaroscuro, l'ossimoro
come figura di opposte tensioni, quali anche quelle che animavano il dibattito storico e
culturale dell'Italia contemporanea (popolo e storia).
Questo modo di scrivere poesia ci porta ad avanzare un'altra ipotesi, ovvero che
che Pasolini sia un poeta fotogrammatico. Egli scrive in versi come se stesse (de)scri-
vendo un quadro, attraverso ricche modulazioni di luce e ombre che mettano in risalto
la realtà nella sua materialità, che spesso si carica di un valore allegorico, simbolico e
43 Cfr.A 11,A9,A6,A 21, A25,A41, A46,A48, A5244 Gilles Deleuze, Cinema, Mimesis Edizioni, Milano, p. 2845 Vincenzo Cerami, Le ceneri di Gramsci, in Letteratura Italiana, vol. IV IL novecento I. L'età della Crisi,
Einaudi, Torino 1985 p. 678
20
sacro. In un saggio inedito del 1974, La Luce di Caravaggio, egli sembra parlare indi-
rettamente della propria poetica. Riferendosi alle lezioni di Longhi, infatti, individua
tre elementi di innovazione: un «nuovo profilmico», cioè, un «mondo di mettere da-
vanti al cavalletto nel suo studio: tipi nuovi di persone nel senso sociale e caratteriolo-
gico, tipi nuovi di oggetti, tipi nuovi di paesaggi»46; una nuova luce: drammatica e
quotidiana, in contrapposizione al lume universale; e un diaframma luminoso: un fil-
tro, che Longhi individua nella pittura eseguita con uno specchio, che dona al quadro
un «eccesso di verità».
Longhi, nel saggio del 1952 su Caravaggio, scrive, commentando il San Matteo: «
Nel Caravaggio, invece, è la realtà stessa a venir sopraggiunta dal lume (o dall'ombra)
per “incidenza”; il caso, l'incidente di lume ed ombra diventano causa efficiente della
nuova pittura (o poesia).»47
Dunque è la luce, il lume a far emergere la buia realtà e l'immagine, la materia e il
corpo, in altre parole: il «fotogramma», che è giustamente il momento in cui «l'attimo
di cronaca gli parve emergere, non dico con un rilievo, ma con uno spicco, con un'evi-
denza così memorabile, invariabile, monumentale come, dopo Masaccio, non s'era più
visto.»48. Il fotogramma è l'attimo di massima drammaticità, di maggior pregnanza spi-
rituale ed espressiva che si realizza tramite la luce e la sua opposizione con l'ombra. In
Caravaggio la luce sembra voler legare il divino all'umano, al mondo sofferente dei
poveri. Pasolini fa sua questa lezione , in consonanza allo stile che già aveva matura-
to: uno stile d'opposizione, di contrasto, d'espressione. L'io poetante si appropria del
reale, potremmo dire, attraverso il Caravaggio e il suo modus videndi, riccamente con-
trastato, che vede:
a) la scelta di soggetti umili visti attraverso uno sguardo poetico e sacrale (il pro-
filmico)
b) l'utilizzo di uno stile espressionista (Walter Siti) che deriva da una grande figu-
ratività della poesia
c) il cinema e l'utilizzo della macchina da presa come diaframma luminoso per fis-
46 Pier Paolo Pasolini, Op. cit. p. 267347 Roberto Longhi, Da Cimabue a Morandi, a cura di Giafranco Contini, Mondadori, Milano, 1973 p. 83648 Id., p. 837
21
sare le figure nel loro «eccesso di evidenza»49
Quest'appropriazione del reale, avviene attraverso la messa a fuoco di «un fram-
mento di realtà, [che il poeta] trasfigura e deforma con energia visionaria, ma senza
che si perda il ricordo del caos da cui è emerso – dell'urto con la realtà; il fenomeno
stilistico è carico di rabbia psicologica, tenta di possedere la realtà e si contorce nella
propria impotenza; più che alla serenità di un oggetto, assomiglia a un “gesto” esisten-
ziale.». È la luce l'elemento che dà forma all'espressione, la modella, la disciplina, in
tutta l'energia verbale di cui Siti ha tratto specimina interessanti, a cui rimandiamo per
una più accurata lettura. 50
Interessante a tale riguardo anche l'osservazione di Deleuze sulle monadi che, pur
essendo chiuse e individuali, contengono una luce “sigillata” che crea il bianco ma an-
che l'ombra, il chiaro e l'oscuro, così che da tale contrasto fuoriescano le cose per mez-
zo di ombreggiature e tinte più o meno forti. Come scriveva il critico artistico Desar-
gues, è a quel punto sufficiente rovesciare la prospettiva e mettere «il luminoso al po-
sto dell'occhio, l'opaco al posto dell'oggetto e l'ombra al posto della proiezione»51.
Tale paragone è utile a dimostrare come l'attenzione poetica di Pasolini (e in parti-
colare ciò lo rileviamo nel paragrafo 1.1.1) si soffermi sulla materia che emerge alla
luce dello sguardo del poeta e di come, tramite questa luce, che possiamo assimilare al
sentimento poetico, il reale si riveli in tutta la progressiva gradazione di luce e ombra,
la cui opposizione permette di risolversi nel grado intermedio, nell'incontro variamente
disciplinato dello sguardo col reale, della luce con la tenebra, del chiaro con l'oscuro,
della vita con la morte...nella sfumatura che amplifica e modella il reale proiettandovi
il proprio sentimento.
Il ruolo che, in tal senso, svolge la luce, è quello di fungere da trait d'union tra il
codice linguistico e quello figurativo, ovvero di ponte tra l'universo della parola scritta
in versi e la fase visiva della composizione che viene prima della stesura, il momento
originario di appropriazione del reale, in cui l'io poetico trasferisce la sua adesione
49 Marco Antonio Bazzocchi, I burattini filosofi, Bruno Mondadori, Milano, 2007 p.5650 Walter Siti, Il sole vero e il sole della pellicola, o sull'espressionismo di Pasolini, Rivista di Letteratura
Italiana, VII, 1 1989 pp, 100 e 10151 Gilles Deleuze, Cinema, Mimesis Edizioni, Milano, p. 54
22
emotiva sugli oggetti e sui frammenti del reale che lo circondano, che si caricano per
questo di un valore aggiunto, trasfigurando il frammento particolare in correlativo og-
gettivo universale, il corpo in figura.
Se fare cinema «è una questione di sole »52 ed è come «scrivere su carta che bru-
cia» 53, è altrettanto vero che anche le poesie vengono scritte con la luce, il reale viene
esposto alla luce, al lume figurativo dello sguardo dei pittori che hanno colonizzato
l'immaginario pasoliniano. E con ciò si ottiene quell'effetto di un «eccesso di verità»
della materia del reale trattata nei versi, poiché la poesia fa essere l'ente ancora più
ente 54 attraverso il «diaframma luminoso» del verso o della celluloide, supporto su cui
il poeta incide il proprio sguardo sul mondo.
L'essenza dell'arte, come scrive Heidegger, consiste nel fatto che l'artista possiede
la visione essenziale di ciò che è possibile, e mettendo in opera le «nascoste possibilità
dell'ente», fa sì che gli uomini vedano quell'ente reale in cui essi si aggirano ciecamen-
te55.
È come se l'artista illuminasse il reale, appropriandosene, e lo restituisse filtrato
attraverso la propria percezione in una “visione aumentata” che libera lo sguardo per le
cose del mondo e sovverte l'ordine dato, l'esistente all'interno di una codificata gerar-
chia di valori, per cui l'umile e il basso e la caotica realtà da cui emergono, si innalza-
no fino a giungere a un livello di lirismo e universalità, di verità e sacralità. Come fa
notare Deleuze a proposito del “cinema di poesia” di Pasolini, si ottiene un effetto di «
permutazione del triviale e del nobile» di «comunicazione dell'escrementizio e del bel-
lo»56.
52 Pier Paolo Pasolini, Accattone- Mamma Roma – Ostia,Garzanti, Milano, 2006 p. 392 53 Pier Paolo Pasolini, Essere è naturale? In Empirismo Eretico, Garzanti, Milano, 2000, p. 24554 Martin Heidegger, L'essenza della verità, Adelphi, Torino, p.5455 Id. p. 8856 G. Deleuze, L'immagine-movimento, Ubulibri, Milano, 1984, p. 95
23
2.2 Contrasto e ossimoro
Se, dunque, in pittura abbiamo il chiaroscuro, nel cinema e in fotografia il contra-
sto, in poesia ritroviamo l'ossimoro come figura equivalente di opposizione, «intima
struttura di interno contrasto»57.
L'importanza della figura dell'ossimoro nella produzione di Pasolini è stata lunga-
mente studiata.
Fortini, già nel 1960, ha sottolineato che «l'ispirazione, il moto primo di tutto quel
che Pasolini scrive si fonda sull'antitesi […] rilevabile a tutti i livelli della sua scrittura
[…]; fino alla sua più frequente figura di linguaggio, quella sottospecie dell'oxymoron
[Όξύμωρος], che l'antica retorica chiamava sineciosi [dal greco συνοικέω (convivo) o
συνοικισμός (coabitazione) NdR], e con la quale si affermano, d'uno stesso soggetto,
due contrari.»58 .
L'importanza dell'ossimoro è capitale poiché è la figura che permette di collegare il
modus videndi di Pasolini, poeticizzato nei versi, al suo modus vivendi, cioè a quella
contraddizione che lo animava internamente: il contrasto figurativo dei suoi versi e la
retorica dell'ossimoro acquista un valore antropologico:
«Stare nell'ossimoro per Pasolini vuol dire molto di più che vivere inchiodato alla propria diversità condan -
nandosi alla sua semplice ed infinita ripetizione, ma esaltare e sovrapporre le diverse forme dell'antitesi e della
contraddizione, cercare ed aprirsi a quelle forme con ansia febbrile ed inesausta, vivere una vita lontano da tutti
coloro che vi hanno trovato una casa e di lì giudicano il mondo, anche quando questa casa è quella scomoda e
dolorosa della “diversità”»59
Anche Stefano Agosti, nello specifico della produzione poetica pasoliniana, ha ri-
levato l'importanza della contraddizione:
«Così, per quanto riguarda la dimensione discorsiva ed egocentrica di questa poesia, se ne è potuta determi-
nare supplementariamente la natura specifica, configurabile nei termini di un'incessante contraddizione o antino-
57 G. Barberi Squarotti in Poesia e narrativa del secolo XX Mursia, Milano, 1971
58 Franco Fortini, in La poesia italiana degli ultimi anni, in “Il Menabò”, n. 2., 1960
59 Franco Cassano, Il pensiero Meridiano, Laterza, Bari, 1996 p.114
24
mia [...] fra ragione e passione (o: razionalità e visceralità), storia e natura, umano e sub-umano, sino all'implica-
zione di opposizioni più precisamente ideologiche, quali marxismo e cattolicesimo, o psicologiche, quali perver -
sione e innocenza.»60
Walter Siti sottolinea come anche il suo espressionismo segnali una dicotomia tra
« la realtà davanti al poeta che vuole esprimerla, il quale, quindi, non appartiene a
quella realtà, ne è stato esiliato – e immagina di potervi rientrare forzando (al limite,
annullando) l'espressione. »61
L'espressione nasce appunto dalla volontà di colmare una separazione, di sfondare
un diaframma che separa il poeta dalla realtà, nasce dalla contraddizione del vivere
una realtà ed esserne al contempo separato, sentirsi irrevocabilmente diverso.
Da ciò deduciamo che la cifra stilistica dell'ossimoro e del contrasto corrisponde a
un modo di vivere il mondo che contraddistingue la sua figura di intellettuale e che
proprio per questo ci interessa. Pasolini si iscrisse al PCI nel 1947, diventando presto
segretario della sezione di S. Giovanni e poi tra i fondatori della Federazione provin-
ciale comunista di Pordenone, e fu molto attivo l'operato politico nel suo Friuli. Que-
sto punto di svolta lo troviamo segnato nella produzione letteraria de La scoperta di
Marx de L'usignolo della Chiesa Cattolica. L'inizio dell'attività politica aveva radici
profonde nell'amore per il popolo, per i contadini friulani: «Ciò che mi ha spinto ad es-
sere comunista è stata una lotta di braccianti friulani contro i latifondisti, subito dopo
la guerra. Io fui coi braccianti. Poi lessi Marx e Gramsci»62. Ma il 22 ottobre 1949 vie-
ne denunciato per corruzione di minori e atti osceni in luogo pubblico, il famoso
“scandalo di Ramuscello”, che gli vale l'espulsione dal PCI e la perdita della sua catte-
dra. Costretto a fuggire, nel gennaio dell'anno successivo, a Roma, dove incontra il
sottoproletariato delle borgate romane e dove cresce ancor di più il suo amore passio-
nale, viscerale per il popolo, per la sua allegrezza e “corrotta purezza”. Questo è uno
dei termini del dissidio in cui si trova Pasolini nel secondo dopoguerra, quando la sua
figura di intellettuale inizia a emergere nel panorama italiano, il nuovo e discusso ro-
60 Stefano Agosti, La parola fuori di sé, Manni, San Cesario di Lecce, 2004 p. 61 W. Siti, Op. Cit. p. 10562 Pier Paolo Pasolini, Al lettore nuovo in Pier Pasolo Pasolini, Scritti sull'arte e la letteratura, a cura di Walter
Siti, Mondadori, Milano, 2003 p.2517
25
manzo Ragazzi di vita, proprio negli anni in cui scrive i versi che andranno a compor-
re Le ceneri di Gramsci, dimostra che nel poeta sta maturando l'ideologia, quella
gramsciana e marxista, ma il suo operato è diviso, tra la ragione dell'ideologia e la pas-
sione verso il popolo.
Tale discorso emerge chiaramente in quella che, fra le tante, è una delle più espli-
cative antitesi 63 : Pasolini vive una contraddizione: quella tra «l'ideale che illumina»64,
l'ideologia politica, e le «buie viscere» di un' «estetica passione», che lo attacca attra-
verso «il calore/degli istinti» alla vita proletaria anteriore a qualsiasi ideologia, a qual-
siasi storia, la cui natura e la cui allegria la circonfondono, agli occhi del poeta, di una
«luce poetica»65.
Cerami ha riassunto ciò in queste illuminanti righe:
«Pasolini si guarda attorno, sceglie un'immagine e la fissa con gli occhi della ragione, di chi partecipa alla
millenaria, muta, lotta dei poveri; la stessa immagine, poi, la fissa con sguardo religioso, ingenuo e violentemen-
te sensuale. Così egli finisce per amare visceralmente ciò che la ragione odia e per amare razionalmente ciò che
in realtà odia. Al centro di questo nodo un poeta esule, diseredato dalla storia, diverso dai borghesi e diverso dal
popolo. La contemporaneità delle due immagini contrarie nella stessa immagine spinge il linguaggio verso uno
stile a forti contrasti lessicali, dove la figura retorica della sineciosi (come dire ossimoro) irrompe con frequenza
incontrollata se non proprio compiaciuta. »66
Il problema di Pasolini è quello di essere fatalmente attratto a una condizione di
vita, quella sottoproletaria, archetipica testimonianza millenaria di un'umanità autenti-
ca e primitiva che è sopravvissuta nei secoli, estranea alla Storia, che non ha coscienza
di sé (su questo vi torneremo più avanti); ma su quest'amore pende anche la missione
ideologica di una ricostruzione dell'Italia che porti a compimento gli ideali della resi-
stenza, e qui sorge un problema fondamentale: anzitutto, il possesso della storia, cioè
la cultura che ha portato Pasolini ad essere tale, è, di fatto, un appannaggio borghese.
Egli vive una condizione di privilegio che automaticamente lo squalifica dal poter vi-
63 Cfr. B 9
64 Cfr. B 8
65 Da Le ceneri di Gramsci, in Id., p. 5666 Vincenzo Cerami, Le ceneri di Gramsci, in Letteratura Italiana, vol. IV IL novecento I. L'età della Crisi, Einaudi,
Torino 1985 p.660
26
vere autenticamente la vita popolare da cui è così attratto, relegandolo irreparabilmente
dietro la condizione di diversità. Inoltre, egli è in una posizione polemica verso lo stes-
so Gramsci poiché il suo operare secondo l'ideale cozza con l'impulso viscerale che lo
lega al popolo. Si trova diviso tra l'essere un poeta civile67 che sente profondamente la
missione dell'intellettuale organico (l'ideologia) e l'amore verso un popolo che tradi-
rebbe nella sua purezza se acquisisse coscienza politica (quella che nasce dal borghese
possesso della storia) e la cui condizione è minacciata dall'avanzare del neocapitali-
smo.
Come leggiamo, dunque, nei versi su citati, Pasolini vive una contraddizione in ter-
mini: una vera e propria coincidentia oppositorum.
Esemplari questi versi:
«[...]la via d'uscita//verso l'eterno non è in quest'amore/ voluto e prematuro. Nel restare/dentro l'inferno con
marmorea//volontà di capirlo, è da cercare la salvezza. Una società/ designata a perdersi è fatale //che si perda:
una persona mai»68
La contraddizione, sembra volerci dire Pasolini, va vissuta fino in fondo, jusqu'au
bout, nell'impegno profondo e costante a volerne comprendere le ragioni. Ma soprat-
tutto, la contraddizione va vissuta interamente, col corpo, nostro modo d'essere nel
mondo.
Ecco dunque, che il cerchio si chiude e si ritorna alla luce, ché, come scrive Goe-
the, se figurativamente «Il chiaroscuro fa apparire il corpo come corpo, in quanto luce
ed ombra ci danno la nozione del volume.»69, a livello poetico questo chiaroscuro, che
si realizza in termini linguistici ed esprime una forte polarità, fa emergere l'urgenza fi-
sica del corpo come sede delle opposte tensioni che lo animano in quanto sede del sa-
cro: «Ogni aspetto della realtà è dunque un corpo, possiede l'intensità espressiva (eroti-
ca) di un corpo, è sacro come un corpo».70
67 Alberto Moravia, Pasolini poeta civile in Per conoscere Pasolini, Bulzoni & Teatro Tenda, 1978 Editori,Roma,1978
68 Pier Paolo Pasolini, Picasso in Le ceneri di Gramsci, Garzanti, Milano, p. 2469 Johann Wolgang Goethe, Op. Cit. p. 33970 Marco Antonio Bazzocchi, I burattini filosofi, Bruno Mondadori, Milano, 2007 p.55
27
«– E ora considera anche questo: se colui che è stato li-
berato in questo modo ridiscendesse e si mettesse a se-
dere allo stesso posto, non avrebbe improvvisamente,
venendo dal sole, gli occhi pieni di buio?
–E molto
–E se ora dovesse competere nuovamente, con coloro
che sono sempre rimasti incatenati colà, nell'esprimere
opinioni sulle ombre, mentre ha ancora gli occhi offu-
scati, prima cioè di averli di nuovo adattati al buio, cosa
che richiederebbe un non breve periodo di adattamento,
non sarebbe esposto laggiù al ridicolo e non gli si direb-
be forse che è salito solo per ritornare con gli occhi ro-
vinati, e che dunque non vale assolutamente la pena di
andare su? E non pensi che essi [gli incatenati], se qual-
cuno si adoperasse per liberarli dalle catene e per con-
durli verso l'alto, se potessero afferrarlo e ucciderlo, lo
ucciderebbero veramente?
–Certamente!»
Platone, La Repubblica
28
Capitolo III
Metafore della luce
3.1 La luce tra cinema e poesia
« La luce è monumentale,/forza, forza, approfittiamone, forza/il cinquanta e il carrello a precedere: /(vengo-
no Mamma Roma e suo figlio,/verso la casa nuova, tra ventagli/di case, là dove il sole posa ali/arcaiche: che
sfondi, faccia pure/di questi corpi in moto statue/di legno, figure masaccesche/deteriorate, con guance
bianche/bianche, e occhiaie nere opache/-occhiaie dei tempi delle primule,/delle ciliege,delle prime
invasioni/barbariche negli “ardenti/solicelli italici”[...] sono altari/queste quinte dell'Ina-casa, /in fuga nella Luce
Bullicante/ a Cecafumo.71 »
Questi sono i versi che furono scritti durante le riprese di Mamma Roma. Come si
può notare la luce del sole è la protagonista di questi versi, ed è l'elemento che dà tono
e forma agli attori, rendendoli simili, negli occhi del poeta, sede del sacro e del bello,
a opere d'arte.
Più avanti nella raccolta, nella medesima sezione Poesie mondane (il cui titolo al-
lude all'occasione da cui sono state scritte, ovvero i set de Mamma Roma e La Ricotta),
troviamo questi versi:
« Poi compare Testaccio, in quella luce/ di miele proiettata sulla terra/dall'oltretomba. Forse è scoppiata,/la
Bomba, fuori dalla mia coscienza./ Anzi, è così certamente. E la fine/del Mondo è già accaduta: una cosa/muta,
calata nel controluce del crepuscolo./ombra, chi opera in questa èra. /Ah, sacro Novecento, regione dell'anima /
(in cui l'apocalisse è un vecchio evento!
Il Pontormo/ con un operatore/meticoloso, ha disposto cantoni/di case giallastre, a tagliare/questa luce friabi-
le e molle,/ che dal cielo giallo si fa marrone/impolverato d'oro sul mondo cittadino.../ e come piante senza radi-
ce, case e uomini,/creano solo muti monumenti di luce/e d'ombra, in movimento: perché/la loro morte è nel loro
moto. /vanno, come senza alcuna colonna sonora,/automobili e camion, sotto gli archi,/sull'asfalto, contro il ga-
sometro,/nell'ora, d'oro,di Hiroscima,/dopo vent'anni, sempre più dentro/ in quella loro morte gesticolante: e
io/ritardatario sulla morte, in anticipo/sulla vita vera, bevo l'incubo/della luce come un vino smagliante./nazione
senza speranze! L'apocalisse/esploso fuori dalle coscienze/nella malinconia dell'Italia dei Manieristi,/ha ucciso
tutti: guardateli- ombre/grondanti d'oro nell'oro dell'agonia.» 72
71 Pier Paolo Pasolini, Poesia in forma di rosa, Garzanti, Milano, 1964 p. 1972 Id.p. 25-26
29
Questo poema, che porta in calce la data di composizione (12 giugno 1962), è stata
composto sul set de La Ricotta. Pasolini sente l'urgenza della fine di un mondo, quello
sottoproletario, primitivo, di chi è morto senza coscienza, anzi, si è perduto,incoscien-
te, nella ricerca di divenire proletario o borghese. Il paesaggio viene descritto attraver-
so un linguaggio ricco di effetti cromatici e chiaroscurali. In questo movimento di luce
si accampa un personaggio, Il Pontormo, alter-ego del poeta, del regista-pittore. La
vita delle borgate, popolosa, ricca di vitalità, si dissolve nell'«Apocalisse del Novecen-
to», nella vita delle metropoli. «Gli uomini sono allo sbando, vagano senza meta nelle
metropoli della pazzia. Pasolini identifica il loro moto con la loro stessa morte, quella
morte che egli definisce “gesticolante” e che altro non è che la inutile vita di una mol-
titudine alla ricerca del nulla.»73 . Attraverso luce e movimento, dunque, l'occhio pitto-
rico del regista-poeta compone un ritratto esiziale di quest'ultimo barlume di umanità
che si perde. E la loro morte psichica, “fisica” di persone in carne e ossa corrisponde
alla loro morte “figurativa”: è l'agire dei loro corpi di «fantasmi creati dal rapporto tra
luce e tenebre»74 che li rende figure di una umanità che sta scomparendo. In questa «
abbacinante doratura che avvolge il mondo l'uomo si perde smarrendo le sue stesse ra-
gioni di vita»75.
Gilles Deleuze, in una conferenza sul cinema, scrive a proposito di tale rapporto:
«la luce permette delle decomposizioni e delle composizioni di movimento. La luce è
un mezzo attraverso cui si può estrarre la mobilità pura del movimento, vale a dire il
movimento dal suo mobile o dal suo veicolo.»76. Questo movimento “gesticolante”,
quasi di insetti impazziti, ben si inscrive, inoltre, nella visione del cinema che aveva
Pasolini: nella distinzione tra cinema e film, e nell'identità di cinema e realtà, nel
montaggio come morte necessaria per acquisire senso: «ricordiamo la differenza che
Pasolini teorico pone tra cinema e film: il film è il prodotto morto, ottenuto attraverso
tagli discreti sul continuum, del cinema. Lo stile è una morte infinitamente ripetuta, ma
73 Stefania Vannucci, Op. Cit. p. 9674 Marco Antonio Bazzocchi, L'italia vista dalla luna, Bruno Mondadori, Milano, 2013, p. 4475 Ibid.76 G. Deleuze, Op. Cit. p. 42
30
sarà sempre possibile, attraverso la luce, risalire alla vita che sta al di là dello stile»77.
Sussiste, quindi, in Pasolini, uno stretto rapporto tra la poesia e il cinema, che si ri-
vela nell'immagine scritta in versi carica delle coloriture, delle sfumature e dei contra-
sti della realtà, e che solo la luce permette di rendere sacra.
Questi versi sono esempio della ricchezza figurativa che caratterizza lo stile di Pa-
solini, dal sapore masaccesco, frutto di una sensibilità che ama il gioco degli opposti e
la vivacità cromatica manieristica.
Deleuze, ne La piega, parla di un «nuovo regime della luce», precisando che le fi-
gure dei quadri di Caravaggio e Tintoretto emergono dal fondo scuro e sono delineate
dal loro rivestimento più che dal loro contorno. Così, in Pasolini, i corpi sorgono dal
buio dell'indistinto culturale per emergere in una luce sacrale di resistenza (nel loro es-
sere sensibili all'appello del sacro, come si vedrà più avanti) esistenziale (nella loro
corporeità) al modello omologante.
Come ha intuito Bazzocchi, quest'estetica dell'opposizione diviene viva metafora
in poesia, e assume una valenza antropologica. E Pasolini conferma:«Questa è l'Italia,
e / non è questa l'Italia: insieme / la preistoria e la storia / che in essa sono convivano,
se / la luce è frutto di un buio seme.» 78.
Il legame di opposizione luce-ombra acquisisce un forte valore allegorico: «Luce e
buio non si possono dividere, sono opposti ma legati proprio dal rapporto di opposizio-
ne: la luce della storia (del progresso) nasce dal buio della preistoria. In questa idea di
Pasolini si fondono le suggestioni ideologiche che vengono da Gramsci e da de Marti-
no con un'intuizione espressiva e artistica presente in Longhi»79. Fuor di metafora, nel-
l'Italia del secondo dopoguerra, anni in cui Pasolini scrive questi versi, il sottoproleta-
riato è testimone di un'umanità arcaica, pre-industriale, primitiva che non ha ancora
conosciuto la Storia e il Progresso, ma ne vive al di fuori, come suggerisce de Martino.
Il compito di cui il poeta si sente investito è quello (come abbiamo visto in 2.2, im-
possibile e pertanto fonte di contrasto e dissidio interno per il poeta) gramsciano di
operare da intellettuale organico, di riuscire a realizzare quella letteratura nazional-po-
77 W. Siti, Op. Cit. p. 11878 Pier Paolo Pasolini, L'umile Italia, in Le ceneri di Gramsci, Garzanti, Milano, 1957 p. 3779 Marco Antonio Bazzocchi, Op. Cit. p. 44
31
polare che sfondi la tradizione di una casta (non più quella “libresca e astratta” ma
nella fattispecie quella borghese e impegnata) e arrivi al popolo, al fine di guidarlo ver-
so «l'ideale che illumina», alla formazione di una nuova cultura alternativa.
La visione di Pasolini è, per sua stessa ammissione, epico-religiosa: i personaggi
dei suoi film, come delle sue poesie, sono miserabili che vivono al di fuori di una co-
scienza storica, in particolare borghese. Il loro vivere nella miseria è per lui una carat-
teristica epica. Il loro vivere è puro perché privo di coscienza e quindi essenziale.80
Questa purezza viene assimilata al regno animale, che nel poema è simboleggiato
dal volo delle “umili e pie” rondini. Pasolini, in questi, tra i più intensi versi dell'intera
raccolta, si propone quindi di far vivere, di far sopravvivere quest'umanità nella pro-
pria opera, presentendo l'apocalissi di una trasformazione.
Ed è proprio la luce che permette di fissare nell'eleganza del verso o nell'urgenza
dell'inquadratura la fisicità necessaria del proletariato, prima che scompaia sotto l'inar-
restabile mutazione antropologica: « Il sole romano, in una luce innaturale che sembra
venire da un arcaico passato, accompagna le figure che agiscono sulla pellicola e le
rinchiude in un'atmosfera si eternità, l'unica dove possono sopravvivere alla trasforma-
zione»81.
Le ceneri di Gramsci (Giugno 1957) è ricca di metafore della luce. In essa sono
raccolti poemetti scritti e pubblicati nei sei anni precedenti: a partire, dunque, dall'arri-
vo a Roma, nell'inverno del 1950, con la madre.
Episodio cruciale nella biografia del poeta in cui «Alla luce indistinta dell'alba
senza tempo del mito friulano si sostituiscono le molteplici variazioni luministiche del
mondo della storia, dove la pace lunare della notte e il clamore solare del giorno si al-
ternano, e in cui i frammenti di paradiso si scorgono incastonati in un paesaggio infer-
nale.»82. L'arrivo nella capitale lo catapulta nel mondo « di luce e miseria»83 del sotto-
proletariato delle borgate, dove trascorre i primi anni della sua esperienza romana.
80 Pier Paolo Pasolini, Una visione del mondo epico-religiosa, in Per il Cinema, a cura di Walter Siti, Mondadori, Milano, 2001, p. 2846
81 Marco Antonio Bazzocchi, L'italia vista dalla luna, Bruno Mondadori, Milano, 2013, p. 3482 M. Rizzarelli, Le ceneri di Gramsci: lo sguardo di Pasolini dai cieli alle viscere dell’«umile Italia», in AA.VV.,Un dono in forma di parole, La Spezia, Agorà, 2002, p. 329.
83 Pier Paolo Pasolini, La religione del mio tempo in La religione del mio tempo, Garzanti, Milano, 1961 p. 90
32
L'esperienza interiore di poeta che possiede il privilegio, tipicamente borghese,
della storia e della cultura, immersa nel mondo “preumano” del sottoproletariato, dà
origine a questi undici poemetti, salutati dalla critica con pareri avversi, ma unanime-
mente riconosciuti come una delle più importanti opere poetiche del secondo dopo-
guerra, come rinascita della «poesia civile».84
La raccolta, che non segue l'ordine cronologico di composizione, si apre con la di-
vina e maledetta prospettiva a volo d'uccello sull'Appennino, che porta l' «io poetico
invisibile»85 a compiere un'escursione nello spazio e nel tempo dell'Italia, dalla Luc-
chesia al meridione, dall'alto verso il basso, dai dossi «ebbri, calcinati» alla spuma del-
l'Adriatico.
Qui possiamo apprezzare un primo uso della luce nella poesia Pasoliniana: un uso
altamente figurativo, incline a creare un'atmosfera particolare, ricercata, che il poeta
«vede» e vuole esteticamente trasmettere per verba. La notte in cui dorme l'Italia del
secondo dopoguerra, per analogia metaforizzata nel monumento funebre di Ilaria del
Carretto che Jacopo della Quercia scolpì agli inizi del XV secolo, è rischiarata da una
«muta luna» la cui luce è «tiepida sulla Lucchesia dai prati / troppo umani, cocente
sulle rive / della Versilia», segue la «morta festa / di luci» di Pisa, la «grigia luce della
cattolica, superstite / perfezione» di Lucca e l'aeroporto di Ciampino, «abbagliato sotto
sbiadite stelle» o i «bianchi globi dei bar salaci / delle periferie cittadine».
L'occhio-luna ripercorre l'Italia alla ricerca della vita che brulica ai margini della
storia: il sottoproletariato viene paragonato a un umile esercito «tra le infette marane /
della borgata» in attesa «di farsi cristiano nella cristiana / città», di scendere nella
«luce borghese», di non restare esclusi dalle «vicende / segrete della luce cristiana».
Questo popolo vive sotto «una muta ma inesorabile ipoteca del futuro»86 e non lo «ab-
baglia / la modernità» fintanto che non giunga «la luce / del futuro» a ferirci e far pian-
gere «ciò che muta, anche / per farsi migliore».
Emerge qui una prima metafora che attraversa le raccolte di poesia prese in esame:
la Storia come luce che illumina, anzi, abbaglia, rischiara ferocemente le vicende uma-
84 V. Cerami, Le ceneri di Gramsci, in Letteratura Italiana Le opere. Il novecento, vol. IV, Einaudi, Torino, 1989
85 M. Rizzarelli, op.cit. p. 33286 Alberto Asor Rosa, Op. cit. p. 375
33
ne con tutta la violenza del «succedersi necessario dei secoli».
Il popolo è presentato come «un esercito accampato nell'attesa / di farsi cristiano»
mentre occupa una «marcita distesa d'erba sozza nell'accesa campagna» nella speranza
di «scendere anch'egli nella borghese luce». Ai « fangosi deschi» si oppongono per an-
titesi le «lucide chiese / novecentesche e grattacieli» simboli del potere che avanza e
della sua inarrestabile marcia. 87
87 Cfr. B 1
34
3.2 Pasolini e le polemiche degli anni '60
È a questo punto opportuno fare un rimando all'ideologia e all'operato di Pasolini.
In un momento storico e sociale di forte mutamento, il “miracolo economico” a ca-
vallo tra anni cinquanta e sessanta, (che avrebbero determinato poi la “mutazione an-
tropologica” e la “scomparsa delle lucciole”) determina forti cambiamenti in ambito
economico-sociale (scuola di massa, sviluppo industriale, diffusione dei mass media,
forti correnti migratorie interne) e, di conseguenza, culturale e letterario. Si sviluppa,
tra la fine degli cinquanta e l'inizio degli anni sessanta, un dibattito intenso tra le
“neoavanguardie” letterarie ( dietro riviste quali “Il Verri”; “Marcatré”, “Malebolge”,
“Grammatica”, “Quindici”, “Officina”, “Il Menabò”, “Che fare”...).
Si è delineato, all'interno di questo dibattito, un fronte che ha visto contrapposte
una linea di “neosperimentalismo” legato a storia e ideologia (“Officina”), e radicale
sperimentalismo linguistico non allineato alla posizione ideologica marxista, ma di
matrice anarchica e puramente linguistica, non più letteraria: «usano gli strumenti sov-
vertitori della letteratura per sconvolgere e demistificare la lingua: ma si pongono in
un punto linguistico zero per ridurre a zero la lingua, e quindi i valori. »
Nell'arco di questo panorama, Pasolini si pone, in forte opposizione a quella dei
contemporanei intellettuali del Gruppo '63 (in particolare egli entrò in polemica con
Sanguineti), rivendicando la fiducia nel ruolo ideologico del poeta e il suo impegno
come poeta civile , come intellettuale, con il compito di ricostruire il volto culturale e
letterario dell'Italia del secondo dopoguerra alla luce dell'insegnamento di Gramsci,
Marx e Gobetti.
Da “Officina”, infatti, si auspica un rinnovamento che mira a uno storicismo di
nuovo stampo, che si traduce nel su citato “neosperimentalismo” prosastico e poetico,
e si dimostra fortemente critica nei confronti dell'ermetismo (tacciato di «intimismo al-
l'ombra del potere» (Leonetti ) e del neorealismo, debole movimento sul piano dell'in-
terpretazione e dell'analisi.88
88 Carlo Segre, Clelia Martignoni, Testi Nella Storia Vol. 4, Bruno Mondadori Scolastica, Milano, 1995 p. 55
35
Se il Gruppo 63 si rifà all'insegnamento di Adorno, cercando di realizzare «caos
nell'ordine» del linguaggio, di contestare la realtà della lingua per entrare in contesta-
zione con se stessi o le istituzioni, in una poesia «non rivestita dell'ideologia». Pasoli-
ni, al contrario, rivendica la politicità del suo sperimentalismo, lo stretto rapporto che
lega stile e ideologia, ancora una volta alla luce di una contraddizione:
«le opinioni politiche del mio libro non sono solo opinioni politiche, ma sono, insieme, poetiche; hanno ,
cioè subito quella trasformazione radicale di qualità che è il processo stilistico. [...]L'ideologia di uno scrittore è
la sua coscienza letteraria (articolata in una serie di opinioni, alcune chiare, altre, certo, confuse) che provvede a
fondere in modo stilisticamente irreversibile gli schemi della vera e propria ideologia politica e gli schemi dell'i-
deologia estetica, che spesso hanno due storie non coincidenti.[...]nel mio caso: l'ideologia politica è quella mar-
xista, ma l'ideologia estetica proviene – per quanto poi profondamente modificata – dall'esperienza decadentisti-
ca, e trascina quindi con sé i rottami di una cultura superata: evangelismo, umanitarismo, ecc.. l'ideologia politica
è proiettata verso il futuro, l'ideologia estetica […] contiene il passato. Uno scontro, e insieme, una fusione. In
altre parole, l'ideologia di uno scrittore è la sua ideologia politica […] ma calata in una coscienza in cui si dà il
massimo del particolarismo individualistico, con tutte le sue sopravvivenze e contraddizioni storiche e
concrete».89
Pasolini non teme di rivendicare con forza posizioni il ruolo poetico della contrad-
dizione, nella sua posizione fortemente contrastante con il contesto neoavanguardistico
dell'epoca. E se Calvino, da Il Menabò, parla di “mare dell'oggettività” che sommerge
la nuova produzione creativa, col rischio di far scomparire l'urgente opposizione della
coscienza, dell'io (la ricerca delle avanguardie di un grado zero della lingua) Pasolini,
nelle poesie, più che nei romanzi, fa emergere la presenza della coscienza, arriva a pro-
iettarsi sulla realtà, deformandola e modulandola con lo stile, che è luce, passione e
ideologia.
E la sua posizione viene anche messa in versi nella sezione Nuovi epigrammi:
« […] Solo una forza confusa mi dice che un nuovo tempo /comincia per tutti e ci obbliga ad essere nuovi./ For -
se – per chi ha sentito e si è dato – è l'impegno/ non più a sentire e a darsi, ma a pensare e cercarsi, /se il mondo
comincia a finire d'essere il mondo/ in cui già suoi, siamo nati, prima creduto eterno, / poi fertile oggetto di sto -
89 Pier Paolo Pasolini, La religione del mio tempo in La religione del mio tempo, Garzanti, Milano, 1961 pp.185-186
36
ria: sempre riconosciuto. / Ma anche il tempo della vita è pensare, non vivere, / e poiché il pensare è ora senza
metodo e verbo, /luce e confusione, prefigurazione e fine, /si sta dissolvendo nel mondo anche la pura vita. /
Donchisciotteschi e duri, aggrediamo la nuova lingua/che ancora non conosciamo, che dobbiamo tentare.» 90
Traspare da questi versi il crollo delle certezze legate all'eclissarsi di un mondo tra-
scorso e finito nell'immediato dopoguerra, e l'aprirsi di una nuova epoca, radicalmente
diversa, di ricerca e pensiero, in cui i redattori di “Officina”, destinatari del componi-
mento vengono esortati a una “battaglia” linguistica (e ideologica) per far riemergere
quella “luce di pura vita” che si sta dissolvendo nel fluire caotico e irrazionale di una
società in profonda trasformazione, che vede l'ascesa omologante di una lingua tecni-
co-scientifica.
La luce ritorna anche in una metafora continuata presente nel componimento La
reazione stilistica. La lingua viene presentata come oscura materia che la Ragione ri-
schiara perché venga posseduta come «forma della vita» infinita, nel rifiuto di «unilin-
guismo» e “ purezza” della lingua letteraria piccolo-borghese («La Lingua è oscura /
non limpida – e la Ragione è limpida, / non oscura! Il vostro Stato, la vostra Chiesa, /
vogliono il contrario, con la vostra intesa.»91). La lingua è testimonianza della storia in
quanto realtà infinitamente variegata che non può esser ridotta a uno stile chiuso nel
possesso borghese della lingua, ma deve aprirsi ad accogliere forme di espressività che
contrastino la nuova base tecnologica della lingua italiana92.
Il poeta rivendica la Storia come «realtà irrealizzata», come apertura verso l'ignoto
(«[…] No, la storia / che sarà non è come quella che è stata. / non consente giudizi,
non consente ordini, / è realtà irrealizzata. / E la lingua, s'è frutto dei secoli contraddit-
tori,/contraddittoria –s'è frutto dei primordi / tenebrosi – s'integra, nessuno lo
scordi,/con quello che sarà, e che ancora non è. / E questo suo essere libero mistero,
ricchezza/infinita, ne spezza, /ora, ogni raggiunto limite, ogni forma lecita.93») che ab-
bracci ogni strato della società, soprattutto quello popolare, nel cui linguaggio , non
90 Pier Paolo Pasolini, Ai redattori di Officina da Nuovi epigrammi in La Religione del mio tempo, Garzanti, Milano, 1961, p. 120
91 Pier Paolo Pasolini, La reazione stilistica da Poesie Incivili in Id.92 Pier Paolo Pasolini, Nuove questioni linguistiche In Empirismo Eretico, Garzanti, Milano, 2000, p. 1393 Pier Paolo Pasolini, La reazione stilistica da Poesie Incivili in La Religione del mio tempo, Garzanti, Milano,
1961, p. 120 p. 156
37
ancora investito dal processo di tecnicizzazione, prevale ancora il fine espressivo su
quello comunicativo 94. È qui sottesa una metafora che vede emergere una nuova lin-
gua letteraria (da tentare, da costruire) dal buio dei suoi primordi (la tradizione).
Nel momento di transizione storico-sociale in cui si sono sviluppate le avanguar-
die, che corrisponde a un «vuoto della storia», per Pasolini, il loro compito si è esauri-
to nel momento in cui si prende coscienza della rivoluzione linguistica in atto: il loro
sperimentalismo che tende al grado zero della lingua e che attacca il Significato, porte-
rà alla loro stessa soppressione, alla loro morte: l'incomprensibilità.
Pasolini rivendica, invece, un nuovo fine della lotta del letterato, perché venga rin-
novato il suo «mandato»: esso sarà « l'espressività linguistica, che viene radicalmente
a coincidere con la libertà dell'uomo rispetto alla sua meccanizzazione».95 nella pro-
spettiva di una conoscenza politica approfondita della cause che hanno portato a tale
mutamento linguistico: «mai come oggi il problema della poesia è un problema cultu-
rale, e mai come oggi la letteratura ha richiesto un modo di conoscenza scientifico e
razionale, cioè politico» 96
94 Pier Paolo Pasolini, Nuove questioni linguistiche p. 2295 Id. p. 2396 Id. p. 24
38
3.3 Sotto i riflettori del falso progresso
Alla luce di questa contraddizione feconda che attraversa la poetica pasoliniana,
emerge chiaramente,tra i versi dei poemetti delle Ceneri, l'avanzata inarrestabile della
Storia, dello Sviluppo, all'interno di una linearità cristiana e progressista, lume feroce
della tecnica e dell'alienazione, al di qua della cui soglia, ancora per poco, vive l'uma-
nità superstite.
È ora qui opportuno inserire una metafora che attraversa l'intera opera di Pasolini
negli anni: la Storia è anche e soprattutto la storia del Potere, del suo agire sull'umani-
tà, anche e soprattutto sui suoi corpi, nell'operare trasformazioni irreversibili in nome
della crociata del progresso e dello sviluppo.
Pasolini ha studiato e approfondito molto questo tema come emerge, in particolare,
da Salò. Ma durante gli anni '70, gli anni degli Scritti corsari e delle Lettere luterane,
questo “luminoso sviluppo” della storia dà i suoi effetti attraverso , «la riorganizzazio-
ne e l'omologazione brutalmente totalitaria del mondo»97.
«Questa riorganizzazione è consistita in un cambiamento nel vissuto: il cambia-
mento consiste nel fatto chela vecchia cultura di classe (con le sue divisioni nette: cul-
tura della classe dominata, o popolare, cultura della classe dominante, o borghese, cul-
tura delle éllites), è stata sostituita da una nuova cultura interclassista: che si esprime
attraverso il modo di essere degli italiani, attraverso la loro nuova qualità di vita.»98
Si arriva, insomma, alla Società dello spettacolo che Guy Debord aveva preconiz-
zato meno di un decennio prima: «lo spettacolo, compreso nella sua totalità, è nello
stesso tempo il risultato e il progetto del modo di produzione esistente. Non è un sup-
plemento del mondo reale, il suo sovrapposto ornamento. Esso è il cuore dell'irreali-
smo della società reale. Nell'insieme delle sue forme particolari, informazione o propa-
ganda, pubblicità o consumo diretto dei divertimenti, lo spettacolo costituisce il mo-
dello presente della vita socialmente dominante.»99 a tal punto che «l'alienazione dello
97 Pier Paolo Pasolini, Scritti corsari, Garzanti, Milano, 1975 p. 5098 Id., p. 5799 Guy Debord, La società dello spettacolo,Massari editore, Bolsena, 2002 p. 44,
39
spettatore a vantaggio dell'oggetto contemplato […] si esprime così: più esso contem-
pla meno vive; più accetta di riconoscersi nelle immagini dominanti del bisogno, meno
comprende la propria esistenza e il proprio desiderio. L'esteriorità dello spettacolo, in
rapporto all'uomo agente, si manifesta nel fatto che i suoi gesti non sono più suoi, ma
di un altro che glieli rappresenta. Questo perché lo spettatore non si sente a casa pro-
pria da nessuna parte, perché lo spettacolo è dappertutto. »100
Mentre i sottoproletari vivono in « quella che Chilanti ha chiamato l'età del pane.
Erano cioè consumatori di beni estremamente necessari, ed era questo, forse che ren-
deva estremamente necessaria la loro povera e precaria vita. Mentre è chiaro che i beni
superflui rendono superflua la vita»101, a questo età viene sostituita “l'età dei riflettori”:
«il tipo di uomo o donna che conta, che è moderno, che è da imitare e da realizzare,
non è descritto o decantato: è rappresentato il linguaggio della televisione è per sua na-
tura il linguaggio fisico-mimico, il linguaggio del comportamento.[...] appunto perché
perfettamente pragmatica, la propaganda televisiva rappresenta il momento qualunqui-
stico della nuova ideologia edonistica del consumo: e quindi è enormemente
efficace»102
Questa luce che illumina e rischiara il cammino dell'Italia, non ha, dunque, un va-
lore positivo, non rientra in una visione escatologica verso un paradiso moderno o
un'età di libertà ma, anzi, è una falsa luce, è una luce che è buio, che acceca e fa per-
dere all'uomo la sua dimensione autentica, vera, profonda, arcaica. È qui opportuno
chiamare in causa Georges Didi Hubermann, che a tal proposito ha intuito che, di fatto,
c'è stato un “capovolgimento” dell'inferno dantesco: se in Dante era il paradiso ad es-
sere pura luce, luce empirea e divina e l'inferno, invece, il regno delle ombre e del
buio, «oggi – ci dice Pasolini – viviamo in un inferno di piena luce»103, la luce «“fero-
ce” dei riflettori – del fascismo imperante»104 .
100 Id. p. 53101 Pier Paolo Pasolini, Op. Cit. p. 53102 Id., p. 59103 Georges Didi Huberman, Come le lucciole, Bollati Boringhieri, Torino, 2009 p. 14104 Id.,p. 19
40
3.4 La vis allegorica delle lucciole
In questa continua concatenazione che attraversa il tempo e le opere di Pasolini, la
nuova metafora delle lucciole è particolarmente significativa.
Nel primo febbraio del 1975, a nove mesi esatti dalla sua tragica morte, Pasolini
pubblica sulle colonne del Corriere della Sera il celebre articolo delle lucciole: queste
righe costituiscono una summa del suo pensiero e della sua analisi sull'Italia degli anni
del dopoguerra e della democrazia cristiana.: le lucciole sono scomparse «una decina
di anni fa» (i primi anni sessanta, proprio quelli in cui Pasolini girava Accattone e
Mamma Roma e pubblicava La religione del mio tempo e Poesia in forma di rosa).
Queste lucciole rappresentano valori della società contadina e paleoindustriale, forme
di vita pure e ancestrali, arcaiche: quello che, appunto, Pasolini ha eternato nelle poe-
sie qui oggetto di studio. Ma la scomparsa delle lucciole rappresenta, dunque, per Pa-
solini, l'identificazione di «quello che allora si chiavava “benessere “ con lo “sviluppo”
e che avrebbe dovuto realizzare in Italia per la prima volta pienamente il “genocidio “
di cui nel Manifesto parla Marx.»105, tale genocidio è da identificarsi con la distruzione
e sostituzione di valori nella società italiana « che porta alla “soppressione di larghe
zone della società stessa […] Oggi l'Italia sta vivendo in maniera drammatica per la
prima volta questo fenomeno: larghi strati, che erano rimasti per così dire fuori della
storia -la storia del dominio borghese e della rivoluzione borghese – hanno subito que-
sto genocidio, ossia questa assimilazione al mondo e alla qualità di vita della borghe-
sia”. 106
Il processo di smembramento, di cancellazione identitaria del sottoproletariato e
della cultura arcaica paleoindustriale può essere spiegata istituendo una nuova metafo-
ra. Le falene sono lepidotteri a volo notturno. Per secoli, esse si sono orientate in volo
seguendo i raggi della luna, in un moto rettilineo e inalterato. Alla comparsa dei lam-
pioni e dell'illuminazione pubblica,poiché la luce dei lampioni si diffonde circolarmen-
105 Pier Pasolo Pasolini, L'articolo delle lucciole, in Op. Cit. p. 130106 Pier Paolo Pasolini, Genocidio, in Op. Cit. p. 226
41
te, esse hanno iniziato a volare intorno, attratte da questa fonte luminosa. Salvo, poi,
morire per il calore sprigionato dalle fonti luminose. Allo stesso modo, il sottoproleta-
riato delle borgate romane, ultima reliquia di un'umanità vissuta sotto “la muta luna”,
in una concezione del tempo arcaica, circolare, si è ritrovato in assedio “accampato
nell'attesa / di farsi cristiano” attorno alla “cristiana città” per eccellenza, Roma, in at-
tesa, speranzoso, del suo ingresso nella luce borghese e cristiana, ignaro, tuttavia, del-
la sorte che lo colpirà, nell'olocausto della tecnica e del benessere diffuso, abbacinato
dal fulgore dei riflettori e dallo splendore delle merci.
Le lucciole, al contrario, come scrive Didi Huberman, sono la testimonianza di una
sopravvivenza, di un barlume di contropotere che rischia di scomparire « nell'acce-
cante bagliore dei “feroci” riflettori: i riflettori delle torri di guardia, degli spettacoli
politici, degli stadi di calcio, dei palcoscenici televisivi»107
Questi valori, profondamente umani, sono rappresentati da quest'umanità liminale,
che per quanto «abbandonata al cinismo più vero / e alla più vera passione; al
violento / negarsi e al violento darsi;» resta «nel mistero // chiara, perché pura e corrot-
ta...»: autentica. La ricerca di questi barlumi la possiamo individuare retroattivamente
nel poema d'esordio de Le ceneri di Gramsci, quando, nel suo volo sulla penisola, il
poeta indugia sulle tracce di quei barlumi dove sopravvive quest'umanità fuori della
storia108.
Anche Giuseppe Calabrese, nel suo libro Pasolini e il Sacro, ha sottolineato che
«l'attenzione è sempre rimasta puntata su quel mondo “altro, eredità di una civiltà arcaica, rimasta inassimila -
ta per lungo tempo dalla storia borghese e ancora impregnata dei caratteri di una vita antica, eppure contempora-
nea, dalla quale sarebbe dovuta germinare la possibilità di un diverso “progresso” rispetto allo “sviluppo” del
neocapitalismo.»109
Nonostante l'abiura dalla Trilogia della vita getti una luce funesta sulla visione po-
litica pasoliniana del futuro, è tuttavia d'obbligo avere fiducia nelle lucciole, nelle so-
pravvivenze. Nelle righe finali dell'articolo sul genocidio, Pasolini apre un varco di
107 Georges Didi Huberman, Come le lucciole, Bollati Boringhieri, Torino, 2009 p.21108 Cfr. A 1, 10, 17109 Giuseppe Conte Calabrese, Pasolini e il sacro, Jaca Books, Milano,1994 p.22
42
speranza: «Una visione apocalittica, certamente, la mia. Ma se accanto ad essa e all'an-
goscia che la produce, non vi fosse in me anche un elemento di ottimismo, il pensiero
cioè che esiste la possibilità di lottare contro tutto questo, semplicemente non sarei qui,
tra voi, a parlare.».110
Anche Didi Huberman vede in queste piccole sopravvivenze luminose la metafora
di nuova vita:
« sarebbe questa, in conclusione, l'infinita risorsa delle lucciole: il loro ritirarsi, quando è “forza diagonale” e
non un ripiegarsi su se stesse; la loro comunità clandestina di “scintille di umanità”, quei segnali inviati per inter -
mittenze; la loro essenziale libertà di movimento, la loro facoltà di fare apparire il desiderio come ciò che è indi-
struttibile per eccellenza[....] sta a noi non vedere scomparire le lucciole. Ma per fare ciò dobbiamo acquisire la
libertà di movimento il ritirarsi...che non sia ripiegamento su noi stessi, la facoltà di fare apparire scintille di
umanità, il desiderio indistruttibile. Noi stessi […. ]dobbiamo dunque trasformarci in lucciole e riformare, così,
una comunità del desiderio, una comunità di bagliori, di danze malgrado tutto, di pensieri da trasmetter. Dire sì
nella notte attraversata da bagliori, e non accontentarsi di descrivere il no della luce che ci rende ciechi.»111
Come osserva Asor Rosa, Le ceneri di Gramsci è un'opera in cui Pasolini tenta di
« realizzare un discorso parenetico, a cui non sono estranee le suggestioni della letteratura civile e progressi -
sta, nata dall'antifascismo e dalla Resistenza. Nei momenti di maggiore accensione, cioè quando il poeta si trova
in presenza di attività di vita popolare (sesso, canto, allegria), un tono epico penetra nell'esortazione e nel rim-
provero, e ne costituisce l'asse di opposizione, la variante interna sempre disponibile.»112
e non è un discorso privo di un messaggio positivo di speranza, di salvezza per l'u-
manità del sottoproletariato. La ritroviamo nei versi finali de Il canto popolare, quan-
do, rivolgendosi al «ragazzo del popolo che canti», scrive: «...Nella tua incoscienza è
la coscienza/che in te la storia vuole, questa storia / in cui Uomo non ha più che la vio-
lenza/delle memorie, non la libera memoria[...] / e ormai, forse, altra scelta non ha /
che dare alla sua ansia di giustizia / la forza della tua felicità, / e alla luce di un tempo
che inizia / la luce di chi è ciò che non sa.»113
110 Pier Paolo Pasolini, Genocidio, in Op. cit. p. 229111 Georges Didi Huberman, Come le lucciole, Bollati Boringhieri, Torino, 2009 p.92112 Alberto Asor Rosa, Pasolini in Scrittori e popolo. Il populismo nella letteratura, Einaudi, Torino, 1965. p.
376113 Pier Paolo Pasolini, Il canto popolare.in Le ceneri di Gramsci, Garzanti, Milano, 1957 p. 16
43
Pasolini sembra quindi prospettare un domani in cui alla «luce di un tempo che ini-
zia», ovvero il tempo della rivoluzione borghese, frutto della storia violenta, si sostitui-
sca «la luce di chi è ciò che non sa»114 ovvero di quel vitalismo e allegrezza che con-
traddistinguono il popolo nel suo aspetto più genuino. Come giustamente osserva Ca-
labrese, il sottoproletariato vive il mondo in un modo altro rispetto al modo di vivere
borghese o proletario, in cui «La coincidentia oppositorum di benefico e malefico ap-
pare riflessa nella mentalità e nella cultura del sottoproletariato che la traduce nelle
modalità di comportamenti variabili, senza mediazioni, dall'infimo al nobile, dall'ab-
bietto al dignitoso, dal meschino al generoso, dal basso all'alto, proprio nella perma-
nenza e nell'attraversamento del “basso».115
Proprio per questo, il sottoproletariato ha in sé, in potenza, una carica vitalistica ri-
voluzionaria, è una classe sociale pericolosa per la classe dominante, in quanto porta-
trice di una cultura «diversa e più integralmente umana, non omologata al “valore” e
al potere”».116
Ma proprio poiché varia e variegata, la luce assume anche valori opposti all'interno
della produzione poetica dell'autore. Ne La Religione del mio tempo troviamo spesso
occorrenze in cui l'elemento luminoso è metafora di un futuro positivo, pregno di idea-
li civili e politici: troviamo ciò attestato, in particolare in La resistenza e la sua luce117,
dove, nella rievocazione biografica del periodo della resistenza (il trasferimento a San
Giovanni, l'arruolamento del fratello fra le linee della brigata Osoppo) la ripetizione
epiforica sembra rimandare a un'antifrasi tra il passato periodo della resistenza, in cui
futuro era luminoso e ricco di ideali, e il buio presente, in cui questi ideali di giusti-
zia118 non hanno trovato realizzazione. Quest'opposizione luminoso futuro-buio presen-
te riemerge anche nei versi finali di Comizio, dove il fratello Guido, in una descrizione
quasi cristologica perché martire della resistenza, prova pietà per il nostro futuro, ed è
costretto a «mendicare un po' di luce per questo / mondo rinato in un buio mattino».
114 Pasolini, id., p. 18115 Giuseppe Conte Calabrese, Op. cit. p. 97116 Id.p. 98117 Cfr. B 15118 Cfr. B 16
44
Anche in Pietro II, abbiamo un'immagine simile: durante una partita al Trullo con
dei ragazzi delle borgate si trasforma in una surreale gioco con intellettuali e amici di
Pasolini, che vede i ragazzini trasformarsi in Moravia, Morante, Garboli,
Bertolucci,Carlo Levi, Bassani, Roversi, Leonetti, Gadda, Fortini, Contini... il poema
si chiude con una domanda epigrammatica: «Chi ha detto che il Trullo è una borgata
abbandonata?le grida della quieta partitella, la muta primavera, non è questa la vera
Italia, fuori dalle tenebre?» l'Italia migliore, quella non avviluppata dalle tenebre del-
l'irrazionalismo illuministico, è quella degli intellettuali e dei borgatari, di chi, cioè, è,
pur essendo agli antipodi, al di fuori di questa falsa luce, o se ne chiama fuori: il ragaz-
zino che non ha coscienza di sé né della propria classe all'interno della società e l'intel-
lettuale che, per un moto interno della propria coscienza, la rifiuta. La purezza unisce
gli antipodi.
E andando più avanti, nel poema che dà nome alla raccolta Poesia in forma di
Rosa, Pasolini ci regala versi solari e positivi: «...miliardi di viventi, /una dolce mattina
si desteranno,/ al semplice trionfo delle mille mattine della vita, // con la maglia
riarsa... con l'umido/del primo sudore...felici–essi– / felici! Essi soltanto felici!//essi
soltanto possessori del sole! / lo stesso sole del barbaro/che nel medioevo discese // e
dalle gole dei monti, dalle ombre / della neve si accampò, / sull'erba nera e folta / catti-
va e felice degli argini d'aprile. // Solo chi non è nato, vive! Vive perché vivrà, e tutto
sarà suo, / è suo, fu suo!»119
Questi versi, scritti al ritorno da un viaggio di Pasolini in Africa, permettono di
compiere un volo pindarico sul pensiero di Pasolini, il quale, proprio nel volume Poe-
sia in forma di Rosa si fa profeta della Nuova Preistoria, di questo periodo storico in
cui il neocapitalismo e il consumismo edonista avrebbero determinato, con la “muta-
zione antropologica” conseguente, l'inizio di un diverso periodo storico. Questi versi,
che concludono il poema, sembrano aprire, tuttavia, una prospettiva di liberazione fu-
tura, al di là dell'imminente ingresso in questa nuova epoca. Questa liberazione avvie-
ne sotto il segno del sole, costante di ogni panorama pasoliniano120 ed elemento che ri-
119 Pier Paolo Pasolini, Op. Cit. p. 63120 Marco Antonio Bazzocchi, Pasolini, Bruno Mondadori, Milano, 2002 p. 180
45
corre moltissimo. Nello specifico, il sole, che assurge a simbolo di autenticità121, mette
in collegamento il remoto futuro con il remoto passato, dove un “barbaro” medievale
scende dai monti (forse un'anticipazione sulla figura del cannibale in Porcile): il futuro
diventa luminoso risveglio e riappropriazione del mondo in un momento collettivo di
vita e felicità che non può non collocarsi che in questo rimando a un altrove temporale:
«La “Nuova preistoria”, cioè, si colloca nel punto di trapasso tra l'estremo approdo
della disumanizzazione e alienazione neocapitalistica, l'estinzione di un'intera civiltà, e
l'avvento di una nuova “aurora”; essa riterrà così, ora dell'uno ora dell'altro momento,
pur tendendo a proiettarsi in un luminoso futuro, ormai irraggiungibile per il poeta. »122
121 Cfr. p. 68122 Gian Carlo Ferretti, La “disperata vitalità” di Pasolini, ne La letteratura del Rifiuto, Mursia, Milano 1968 p.122
46
«Così la neve al sol si disigilla;
così al vento ne le foglie levi
si perdea la sentenza di Sibilla.»
Dante, Paradiso, XXXIII
47
Capitolo IV
Luce mistica
La luce intrattiene un rapporto strettamente legato alla sfera della passione e del sa-
cro, sia perché la luce fa emergere ciò che è sacro, sia perché essa è spesso simbolo di
un principio vitale, intimo, e di purezza123. La parola poetica è segno di una manifesta-
zione di energia vitale124
Nel poema A un ragazzo, dedicato al giovane Bernardo Bertolucci, figlio del poeta
Attilio, con cui Pasolini era legato da profonda amicizia, la luce allude a un rapporto di
piena armonia con il mondo, di pieno accordo con la natura 125, di pura genuinità, di
chi guarda alla vita con gli occhi pieni di stupore e curiosità «Noi dovremmo chiedere,
come fai tu, dovremmo / voler sapere col tuo cuore che si ingemma» e che trova rispo-
sta nella poeticità, simboleggiata dalla luce crepuscolare di un tramonto friulano. Ri-
corda un rapporto col mondo mitico, una sorta di vitalismo panico, di compartecipa-
zione alla realtà circostante, proprio come poteva essere il rapporto del poeta col ma-
terno Friuli (che non a caso è più volte presente assieme al doppio filo che lega, negli
occhi del poeta, il giovane Bertolucci al ricordo del fratello Guido) e che Asor Rosa
ha ricordato con questa bella immagine: «Il poeta nasce dunque come voce di natura,
come creatura d'acqua, d'erba e di pioggia.»126. In opposizione a chi vive al di fuori del
mondo della storia, l'ombra che ingombra il petto dei più grandi, di chi sente la vita ve-
nir meno nel suo aspetto poetico e luminoso. Perché la luce è poesia, una poesia inte-
riore che nasce dal buio della vita: «Alle volte è dentro di noi qualcosa / (che tu sai
bene, perché è la poesia) / qualcosa di buio in cui si fa luminosa // la vita: un pianto in-
terno, una nostalgia / gonfia di asciutte, pure lacrime...»127.
È grazie alla poesia, dunque, che la vita acquisisce la sua bellezza e la sua carica
123 Cfr. S 9, 10, 12 e 16
124 Marco Antonio Bazzocchi, I burattini filosofi, Bruno Mondadori, Milano, 2007 p.158125 Cfr. S 14126 Alberto Asor Rosa, Storia Europea della Letteratura Italiana, Einaudi, Torino, 2009, p. 461127 Da La guinea in Poesia in forma di rosa,P.P. Pasolini, Garzanti, Milano, 1963 p. 8
48
vitalistica, per quanto questa si manifesti nella forma di un pianto interno, di una no-
stalgia gonfia di asciutte, pure lacrime: quest'ossimoro (che tradisce anche la spropor-
zione tra la pienezza di sentimento e le parole) ci permette di collegare la luce al mo-
mento di creazione del poeta, ovvero al sentimento primigenio da cui distillano lacri-
me di poesia: la passione ab joi.
Nel componimento Al Sole, interamente attraversato dalla presenza della luce, leg-
giamo l'espressione «lume infinito» («Obbediente, sincero, atterrito, / non dovevo es-
sere buono, ma santo, / non uomo, ma gigante, / non elegante, ma puro, squisito,/dove-
vo cercare un linguaggio, / a esprimere quel mio intimo lume infinito, / che fosse estre-
mo: ingenuo appannaggio dell'agio borghese, dell'antiborghese coraggio»128) che sem-
bra alludere alla “passione”, a quest'energia intima che esprime gioia, un eccesso di
amore per la vita, disinteressato129: un amore che tutto illumina proprio in quanto tale.
E questo sentimento assume le forme dell'immagine, della parola o del verso in virtù di
una separazione, di una lontananza dall'oggetto amato: « nostalgia della vita che au-
menta, accresce l'amore per la vita, un sentimento di esclusione dalla vita che è la con-
dizione per poterla vivere ab joi, cioè nella distanza, nell'allontanamento, nella separa-
zione, perfino nell'esclusione. E se il bello, come l'amore e la gioventù, è ciò che dà
gioia, questo bello non può essere sentito, provato nella carne, patito, se non assumen-
dolo come da sempre già perduto. C'è accrescimento della vita solo là dove la vita pare
svanire: perciò la passione ab joi della vita è la malinconia.»130
Questo amore panico di Pasolini nelle poesie si traduce, come ha scritto Agosti, in
una volontà di dizione totale della realtà (dall'alto al basso, dall'umile all'elevato), di-
zione che avviene per mezzo della luce, la quale unisce la realtà al sentimento: quello
di Pasolini è «un allucinato, infantile amore per la realtà. Religioso in quanto si fonde
in qualche modo, per analogia, con una sorta di immenso feticismo sessuale, lo stesso
inconsulto amore per la realtà...mi fissa davanti ai vari aspetti (un viso, un paesaggio,
un gesto, un oggetto) quasi fossero fermi e isolati nel fluire del tempo; la ragione della
semplificazione.. è il mio modo di vedere la realtà come un'apparizione sacrale. E la
128 Pier Paolo Pasolini, La religione del mio tempo in La religione del mio tempo, Garzanti, Milano, 1961 p. 161129 Cfr. S 6130 Pasolini, gli stili della passione di Raoul Kirchmayr, in Aut Aut 345 Inattualità di Pasolini Gennaio-Marzo 2010 Il saggiatore , Milano 2010 p. 39
49
sacralità è molto semplice; evidentemente il mio sguardo verso le cose del mondo, ver-
so gli oggetti, è uno sguardo non naturale, non laico»131
Più chiaramente ancora Pasolini ne parla chiamando in causa direttamente la luce:
«Io la chiamo sacralità; e la posso in modo schematico ed elementare schematizzare così: la mia incapacità
di vedere nella natura la naturalezza. Ad altri le cose, la realtà, appaiono normali, naturali. Ma a me tutto sembra
investito da una specie di luce importante, particolare, che è appunto meglio definire “sacrale”: e questo determi-
na il mio stile, la mia tecnica.»132
È una dichiarazione di poetica importante che ripropone ancora una volta la luce
come elemento primigenio nell'atto creativo di impossessamento del reale da parte del
poeta, che investe tutta la realtà di questo sacro, luminoso sentimento poetico: Bazzoc-
chi ha giustamente sottolineato che la sacralità del reale, che Pasolini conosce sin dai
primi versi, nasce da una premessa letteraria, la disposizione poetica insita in chi guar-
da fa emergere il sacro, e alla sua base vi è la parola poetica come «segno di un impul-
so originario, manifestazione di energia vitale, soffio e grido insieme»: la parola poeti-
ca è sacralità, capace di unirsi con l'altro elemento sacro che è il corpo.133
Il rapporto della luce col sacro, infatti, è doppiamente confermato dall'occorrenza
simbolica di tale elemento, che induce a intravedere una possibile influenza del misti-
cismo neoplatonico, quasi una sorta di ipostasi: l'anima, o il principio vivificante, è
spesso indicato attraverso sinonimi della luce134 che diviene il simbolo di un centro
pulsionale d'energia, di vita.
In Una luce, poi, si esprime questo afflato divino, questa tensione sacrale verso la
vita, che si oppone al caos e alla disperazione, alla difficoltà di comprendere il mondo
e la storia nella sua illuministica irrazionalità. Al simbolo della luce vengono date le
fattezze di una Donna che riassume in sé la caratteristica di madre e bambina, che vie-
ne spesso indicata attraverso metafore appartenenti al campo semantico della natura
(«[...]nella dolcezza del gelso e della vita // o del sambuco, in ogni alto o misero /segno
131 Walter Siti, Op. cit. p. 98132 Pier Paolo Pasolini, Incontro con Pasolini, Note schedario n. 4, 28 aprile 1969133 Marco Antonio Bazzocchi, I burattini filosofi, Bruno Mondadori, Milano, 2007 p.158134 Cfr. S 2, 6,7,12, 13, 17
50
di vita, in ogni primavera, sarai / tu; in ogni luogo dove un giorno risero, // e di nuovo
ridono, impuri, i vivi, tu darai la purezza...»135) e che la trasfigura in una madre ance-
strale, universale, panica: la presenza della morte e il tempo futuro dei verbi (in oppo-
sizione all'attenzione del poeta verso un passato mitico, trasfigurato) esprimono la ten-
sione verso un ricongiungimento al grembo materno della Natura. E l'importanza della
figura della madre è stata messa in evidenza da Walter Siti quando afferma che la natu-
ra viene concepita come una sostanza divinamente intatta, un territorio incantato
(come si vede anche nella sequenza onirica presente in Il pianto della scavatrice) che
altro non è che il corpo della madre, dilatato e diventato paese.
E la religione è un punto capitale del pensiero di Pasolini: la sua visione del mon-
do, che Calabrese ha più volte ribadito essere immanente, quasi spinoziana o, meglio,
goethiana: in cui la natura è avvertita quale immanente totalità «che nell'esprimersi
mediante molteplici linguaggi mantiene segreto il suo codice primario»136. Essere reli-
giosi significa essere sensibili all'appello del sacro, a questo sentimento che implica
presenza e assenza assieme, presenza in tutto il vario dispiegarsi del reale, assenza
nella conoscenza della sua intima logica e meccanica:
«l'homo religiosus pasoliniano... nel concepire la realtà come sacra tenta di aderirvi mantenendosi aperto alla
rivelazione di quello che essa mostra nascondendosi. E il “misticismo” è per Pasolini la prova della volontà del-
l'uomo di essere tutt'uno con i cicli del cosmo e, nel tentativo di giungere a una totale identificazione con esso, di
aspirare a diventarne parte integrante e condividerne intimamente la sacralità. » 137
La luce è il medium attraverso cui la ierofania ha luogo. È su di essa che il poeta fa
aderire il suo sentimento, aprendo un varco nel mistero del mondo per mostrarne tutta
la sua grande bellezza.
135 Pier Paolo Pasolini, La religione del mio tempo in La religione del mio tempo, Garzanti, Milano, 1961 p. 106136 Calabrese, Op. Cit. p. 112137 Calabrese, Op.Cit. p. 40
51
4.1 La luce del Sole
Il sole è l'elemento luminoso che è più presente nelle poesie di Pasolini, nonché
nella sua cinematografia. Ciò dà a tale elemento una posizione di rilievo primordiale e,
come la luce si declina in variate atmosfere e partecipa di diverse natura, così il Sole e
la sua luce assumono valenze differenti allo stesso tempo positive e negative, sacre e
profane, atmosferiche e simboliche.
All'interno dei panorama cinematografici, il sole è pressoché onnipresente. Nei
campi lunghi e lunghissimi in esterno, la luce del sole è l'elemento su cui l'attenzione
del poeta-regista si posa di più, tanto più che fare cinema è una questione di sole138
perché «[...] solo il sole / imprimendo pellicola può esprimere / in tanto vecchio odio /
un po' di vecchio amore»139. Quest'attenzione verso la luce del sole la ritroviamo,
infatti, nella sezione Poesie Mondane all'interno di Poesia in forma di rosa, quelle
poesie, cioè, che sono state scritte durante le riprese di Mamma Roma e La Ricotta.
Momento di grande sacralità lo ritroviamo nella scena del sogno di Accattone, in
cui, sognando la propria morta, chiede al becchino di scavare la sua fossa nella «luce
radiosa, sconfinata, che evapora nell'azzurro di una estate piena di sole fermo e conso-
lante»140.
Questo episodio può essere letto come la volontà di Accattone di morire e rigene-
rarsi, di accettare la sua fine terrena per entrare in un ciclo cosmico di rinascita, simbo-
leggiato, appunto, dalla luce del sole. Si concretizza così la metafora ispirata alla meta-
fora del chicco di grano che deve morire per dare la vita. È questo, secondo Calabrese,
il modo che i sottoproletariato ha per enunciare il proprio essere depositari del sacro:
«la morte dei protagonisti dei romanzi e dei film di Pasolini è l'unica alternativa che
hanno per enunciare il sacro in una storia che non li riconosce per tale disposizione»141.
138 Cfr. supra n. 150139 Pier Paolo Pasolini, Poesia in forma di Rosa, Garzanti, Milano, 1963 p. 23140 Pier Paolo Pasolini, Accattone- Mamma Roma – Ostia,Garzanti, Milano, 2006 p. 220141 Id.,p. 100
52
La presenza del sole ritorna in più poesie anche all'interno di un'immagine
ricorrente: il sole che risplende sull'orizzonte del materno Friuli e delle povere borgate,
metafora della «luce del futuro», «dell'acerba luce della Resistenza»142, di «Giustizia»143.
Altresì, il sole fa parte del paesaggio delle borgate, ne è un elemento costitutivo. La
sua presenza conferisce a tale ambiente delle connotazioni esotiche e sacrali. I giovani
corpi dei borgatari illuminati dalla luce del solleone vengono poi ricercati da Pasolini
tra l'Africa, l'Asia e il Mediterraneo, tra quelle popolazioni che vivono «a livelli
d'esistenza di sole, in pienezza / e tra baracche e sterri, / prati zeppi di canne e
d'immondezza»144. La presenza del sole collega, infatti, le borgate romane ai paesaggi
del meridione e del Nord Africa (si veda la sezione L'alba meridionale in Poesia in
forma di rosa o La Terra di lavoro, La resistenza e la sua luce...). Il sole, che avvolge
ogni aspetto del reale, gli dona una particolare atmosfera, tale da farla diventare
simbolo di autenticità, un'autenticità sacrale e religiosa, vissuta in un tempo
irrimediabilmente relegato nell'Altrove: il sole diviene simbolo di un tempo passato
sospeso. Da «l'indorarsi quieto del mezzogiorno» che «pareva eternare ogni cosa
all'intorno»145 al sole «ferocemente antico» che posa le sue «antiche ali» 146 con un
biancore «gioiosamente romanico, perdutamente barocco»147 , la luce del sole sembra
riferirsi a una dimensione Urcronica in cui solo lì è possibile l'identificazione di Realtà
e Verità. È una dimensione mitica, in cui il passato remoto sfuma in futuro anteriore: lo
ritroviamo, per esempio, nella metafora citata nel capitolo precedente148 di un
“luminoso futuro di liberazione” dell'umanità.
Il sole del futuro, metafora della liberazione, è lo stesso sole del barbaro che
discese nella civiltà. La figura del barbaro è stata presentata da Bazzocchi come
momento di vivere autentico: punto di fusione tra cultura e natura, Realtà come
142 Pier Paolo Pasolini, Al Sole in La religione del mio tempo, Garzanti, Milano, 1961 p. 106143 La resistenza e la sua luce, in Id. p. 59144 Pier Paolo Pasolini, Al Sole in La religione del mio tempo, Garzanti, Milano, 1961 p. 159145 Cfr. A 20146 Pier Paolo Pasolini, Poesie mondane in Poesia in forma di rosa, Garzanti, Milano, 1963, p.19147 Pier Paolo Pasolini, Le belle bandiere in Op. Cit. p. 107148 Cfr. p. 59
53
circolarità e illimitatezza, non come linearità (spaziale e temporale dei fatti) e storia
(ordine del tempo), quindi illusione e alienazione. 149
Il reale che urta con tutta la sua urgenza lo ritroviamo in molte delle poesie in cui il
poeta mette a nudo se stesso e la propria interiorità. Il sole è anche e soprattutto un
elemento che ha a che fare con la realtà della visione: il sole e la luce sono legati
all'evidenza della verità e all'urto della realtà sulla scrittura150. Ne abbiamo un esempio
in Le belle bandiere, dove alla regressione onirico-interiore si accompagna la presenza
ossessiva, esteriore e surreale del sole (« “ma no! Ma no! È solo un sogno! / la realtà /
è fuori nel sole trionfante, / nei viali e nei caffè vuoti, nella suprema afonia delle dieci
del mattino, / un giorno come tutti gli altri, con la sua croce!”» )151, nella cui luce
prendono forma le esistenze poetiche di amici e familiari che, sotto il biancore del
sole, (un biancore mitologico), vengono trasposti in presenze positive durante una
regressione onirica alla stagione trascorsa delle “belle bandiere”, metonimia per la
stagione degli ideali e delle alte speranze rivoluzionarie.
Il poeta si interroga sulla realtà, che assume i caratteri di «un sogno fatto dentro un
sogno», quella realtà che è diventata un'estensione illimitata del proprio io, del proprio
corpo: «tutto il mondo è il mio corpo insepolto»152. Emerge una tensione panica di
Pasolini a confondersi con il mondo, e la luce è l'elemento che ne suggella l'unione,
che guida l'io alla scoperta del mondo, nel quale vi si riconosce e a cui
contemporaneamente resta estraneo. Il suo è un mondo di «sole e solitudine»153, dove
appunto il sole pare essere l'elemento che costruisce parimenti il mondo della realtà (la
storia e gli ideali) e della fuga dalla realtà (il sogno e le illusioni).
Nella scrittura delle poesie, Pasolini va alla ricerca di quest'atmosfera, anche
esteticamente, sempre cercando di tener fede, attraverso il medium di cui si serve (la
celluloide come il verso), a quell'impressione di autenticità che vuole trasmettere154. La
sua produzione e il suo stile sono improntati a non avere soluzione di continuità tra
149 Marco Antonio Bazzocchi, I burattini filosofi, Bruno Mondadori, Milano, 2007, p. 185150 Marco Antonio Bazzocchi, Pasolini, Bruno Mondadori, Milano, 2002, p.181151 Pier Paolo Pasolini, Ibid. 152 Pier Paolo Pasolini, Le belle bandiere in Poesia in forma di rosa, Garzanti, Milano, 1963 p. 107153 Pier Paolo Pasolini, La persecuzione in Op. Cit.p. 71154 Cfr. A 65
54
l'espressione e il reale, ma anzi egli è sempre teso a cercare di colmare questo
inevitabile scarto con l'espressività (come si è visto nel capitolo secondo). 155 In questo,
il sole assume una presenza ossessiva: se è tramite il sole che il reale viene scritto sulla
carta che brucia della celluloide, egli cerca anche di partecipare verbalmente alla sua
essenza, di trasmetterla nello sperimentalismo del verso.
Infine, se, da una parte, il sole viene percepito come centro positivo di energia
vitale 156 , presenza che tutto osserva e vivifica; dall'altra perde le sue caratteristiche
positive, diventa, metaforicamente, un “buio sole”. Il poeta, deluso e amareggiato
«nell'ombra-luce della storia» che vede il dilagare della «mutazione» e il genocidio di
quell'umanità che tanto amava, è come se ponesse un filtro funereo sul sole, simbolo di
un'ideale da perseguire nell'impegno e nella lotta, che diviene quindi oggetto di una
regressione onirica, di rifiuto del mondo.
155 Cfr. S16156 Cfr. A 23, 24, 25, 33
55
Conclusioni
Sulla base di quanto indagato in questa ricerca, possiamo affermare che la luce
nelle opere di Pasolini, e in particolare quelle poetiche oggetto d'analisi, è presente in
più livelli.
Il primo, che si può definire estetico-fenomenologico, comprende un uso della luce
altamente figurativo, in stretto rapporto con l'immagine. E ciò è vero in quanto
Pasolini è un poeta che pone nell'atto del vedere la radice della propria ispirazione
poetica. La sua attenzione verso il mondo, il suo costante interesse per la realtà che lo
circonda, passa attraverso lo sguardo. E con lo sguardo, che il sentimento filtra, la
realtà arriva ad impressionare l'anima. E dall'anima sgorga la poesia. Non sorprende,
dunque, che in Pasolini la luce sia un elemento pressoché costante, quasi ossessivo,
che attraversa l'intera sua produzione in versi con una vivida e vivace presenza: si è
potuto apprezzare la poliedricità della luce, elemento che esprime la potenza
espressiva delle poesie, generata a sua volta dalla forza espressiva contenuta
nell'immagine, frutto della tensione spirituale che l'ha creata e del rigore creativo che
l'ha determinata.
Questo livello presenta un forte punto di contatto con l'universo figurativo di cui il
poeta diviene erede attraverso le lezioni di storia dell'arte di Longhi, in particolare per
quanto riguarda lo stile espressionista delle raccolte Le ceneri di Gramsci e La
Religione del mio tempo, che ha forti analogie con la pittura masaccesca e
caravaggesca, soprattutto per quanto riguarda i toni “chiaroscurali”, che stimolano la
percettività del lettore/spettatore verso la materialità del mondo e la corporeità
dell'Uomo. Il linguaggio “bifronte” del cinema e delle poesie è unito da questo modus
videndi: l'opposizione di luci e ombre delle lente inquadrature tende a mettere in
evidenza la corporeità degli attori, che spesso condividono l'aura sacrale di alcuni
dipinti ;così come la figuratività del linguaggio tende a far emergere l'urgenza dello
sguardo sul reale. Tale figuratività si esplica attraverso l'uso di figure retoriche quali
56
l'ipotiposi (che diviene spesso écfrasis), l'antitesi e, soprattutto, l'ossimoro. Proprio
l'ossimoro si pone come figura chiave dello stile di Pasolini in quanto rispecchia
l'intimo contrasto interno che anima lo spirito del poeta, il suo modus vivendi: la sua
diversità e la sua atipica posizione nel panorama intellettuale dell'Italia del secondo
dopoguerra ne fa una figura di spicco dotata di uno spirito d'osservazione del tutto
peculiare, capace di far emergere la sacralità del mondo nei suoi aspetti più umili e il
feroce grido di denuncia alla società italiana perché prenda coscienza della deriva
alienante verso cui è diretta.
L'insistenza parossistica sulla luce che illumina il reale, il luogo, l'assolutamente
determinato, fanno sì che il poeta riesca a trasmettere verbalmente un'atmosfera che
raggiunge vette di alta poeticità e, soprattutto, contribuisce a trasfigurare il reale in
universale. La Roma delle borgate, nella sua presenza cronachistica, diviene teatro di
un'umanità liminale, antropologicamente differente, capace di resistenza alla dilagante
mutazione antropologica che investe l'Italia negli anni della produzione poetica
pasoliniana qui analizzata, e che presto ne sancirà la scomparsa.
L 'elemento luminoso nella sua intensità, poi, attraversa la soglia estetico-
fenomenologica per divenire allegoria, secondo livello in cui è presente la luce: la
trasfigurazione del reale in universale rientra in un'architettura metaforica che vede la
luce assumere valori diversi, spesso opposti. In generale, possiamo affermare che la
luce nel suo valore metaforico sta ad indicare un altrove temporale, che sia quello della
Storia, come quello di un tempo sospeso di speranza, già trascorso e di là da venire. Da
una parte occorrono metafore che stanno ad indicare il presente accecato dalla falsa
luce dello Sviluppo alienante, dall'altra la luce è metafora di un tempo di là dal tempo,
urcronico, di redenzione e giustizia, di verità, di umanità autentica. Quel che è
interessante rilevare è come tale visione poetica della società capovolga il sistema
metaforico dantesco: se nella la luce ha sempre assunto un valore positivo di
compartecipazione al divino, all'empireo, come meglio appare nel Paradiso di Dante,
Pasolini capovolge questa metafora per dirci che viviamo in un buio presente,
illuminato da una luce artificiale che è buio. La Storia è, quindi, capovolta nelle sue
57
magnifiche sorti e progressive. E chi assume un valore positivo all'interno di questo
sistema sono le lucciole, barlume nel buio della Storia: i sottoproletari quali testimoni
(impazziti) di una vita pre-industriale in cui l'Uomo è ancora tale, indice di un
genocidio imminente. E sebbene viviamo nel tempo presente, allorché il genocidio sia
già compiuto, Pasolini ci insegna a scrutare nel buio alla ricerca di quei barlumi di
resistenza che tuttora esistono. E il suo disperato grido di vitalità non rinuncia a un
possibile capovolgimento di tale situazione: da La religione del mio tempo a Poesia in
forma di Rosa la luce sta spesso a indicare il superamento della Nuova Preistoria e il
raggiungimento di una nuova Epoca illuminata da un nuovo sole di Giustizia e felicità.
Proprio il Sole unisce il secondo livello con il terzo, in cui i concetti storico-critici
dell'allegoria che sottostanno la metafora della luce sfumano verso la sintesi e l'unità
del simbolo. Questo livello comprende tutte le ricorrenze in cui la luce occorre in
luogo di un principio vitalistico che assume in sé le caratteristiche di purezza e
passione. Quest'aspetto avvicina la presenza della luce a una visione “sacrale” del reale
che mette in collegamento Uomo e Natura. Traspare un afflato religioso laico e
terreno, sotto il segno del Sole, quasi a voler riprendere una certa religiosità solare
tipica della classicità ellenistica e di un pensiero meridiano e archetipico la cui
presenza nell'opera di Pasolini potrebbero essere un interessante oggetto di studi.
In queste pagine conclusive, si è cercato di isolare la presenza della luce in Pasolini
volendola dividere per livelli qualitativi. Tuttavia, è necessario specificare che nella
concretezza retorica del verso vi è commistione e compartecipazione di più livelli,
unificati da e nello stile, unicità del proprio stare-nel-mondo.
58
Apparato Iconografico
59
Figura 1: Fotogramma dal film Mamma Roma «« La luce è monumentale,/forza, forza, approfittiamone, forza/il cinquanta e il carrello a precedere: /vengono Mamma Roma e suo figlio,/verso la casa nuova, tra ventagli/di case, là dove il sole posa ali/arcaiche: che sfondi, faccia pure/di questi corpi in moto statue/di legno,[...]»
Figura 2 Fotogramma dal film Mamma Roma; si noti la somiglianza con Fig. 8«figure masaccesche/deteriorate, con guance bianche/bianche, e occhiaie nere opache/-occhiaie dei tempi delle primule,/delle ciliege,delle prime invasioni/barbariche negli “ardenti/solicelli italici”»
60
Figura 3Fotogramma dal film Mamma Roma «sono altari/queste quinte dell'Ina-casa, /in fuga nella Luce Bullicante/ a Cecafumo.»
Figura 4 Fotogramma dal film Mamma Roma
63
Figura 8: Masaccio, La trinità, Firenze, Santa Maria Novella, particolare
Figura 9: Masaccio, Il tributo della moneta, Firenze, Cappella Brancacci, particolare
64
Figura 10: Masaccio, San Pietro risana i malati con la sua ombra, Firenze, Cappella Brancacci, particolare
65
Figura 12: Caravaggio, Cena in Emmaus, Milano, Pinacoteca di Brera, cm 141 x 175
Figura 11: Caravaggio, La Morte della Vergine, Parigi, Museo del Louvre cm 369 x 245
Bibliografia
Fonti primarie:
Le ceneri di Gramsci, Garzanti, Milano, 1957
Poesia in forma di rosa, Garzanti, Milano, 1964
La religione del mio Tempo, Garzanti, Milano, 1961
Le belle bandiere, Roma, Editori Riuniti, 1977
Alì dagli occhi azzurri, Milano, Garzanti, 1989
Saggi sull'arte e la letteratura, a cura di Walter Siti, Mondadori, Milano, 2003
Empirismo Eretico, Garzanti, Milano, 2000
Per il Cinema, a cura di Walter Siti, Mondadori, Milano, 2001
Accattone- Mamma Roma – Ostia,Garzanti, Milano, 2006
Scritti corsari, Garzanti, Milano, 1975
Fonti secondarie:
Stefano Agosti, La parola fuori di sé, Manni, San Cesario di Lecce, 2004
Alberto Asor Rosa, Pasolini in Scrittori e popolo. Il populismo nella letteratura, Ei-
naudi, Torino, 1965.
Alberto Asor Rosa, Storia Europea della Letteratura Italiana, Einaudi, Torino, 2009
Fernando Bandini, Il sogno di una cosa chiamata poesia in Pier Paolo Pasolini, Tutte
le poesie a cura di Walter Siti Mondadori, Milano, 2003
G. Barberi Squarotti in Poesia e narrativa del secolo XX Mursia, Milano, 1971
Marco Antonio Bazzocchi, I burattini filosofi, Bruno Mondadori, Milano, 2007
Marco Antonio Bazzocchi, L'italia vista dalla luna, Bruno Mondadori, Milano, 2013
Marco Antonio Bazzocchi, Pasolini, Bruno Mondadori, Milano, 2002
Franco Cassano, Il pensiero Meridiano, Laterza, Bari, 1996
Vincenzo Cerami, La trascrizione dello sguardo in Pier Paolo Pasolini, Per il Cinema,
67
a cura di Walter Siti, Mondadori, Milano, 2003
Vincenzo Cerami, Le ceneri di Gramsci, in Letteratura Italiana, vol. IV IL novecento
I. L'età della Crisi, Einaudi, Torino 1985
Giuseppe Conte Calabrese, Pasolini e il sacro, Jaca Books, Milano,1994
Guy Debord, La società dello spettacolo,Massari editore, Bolsena, 2002
Gilles Deleuze, Cinema, Mimesis Edizioni, Milano,2004
Gilles Deleuze, L'immagine-movimento, Ubulibri, Milano, 1984
Georges Didi Huberman, Come le lucciole, Bollati Boringhieri, Torino, 2009
Gian Carlo Ferretti, La “disperata vitalità” di Pasolini, ne La letteratura del Rifiuto,
Mursia, Milano 1968
Franco Fortini, in La poesia italiana degli ultimi anni, in “Il Menabò”, n. 2., 1960
Raoul Kirchmayr Pasolini, gli stili della passione, in Aut Aut 345 Inattualità di Pasoli-
ni Gennaio-Marzo 2010 Il saggiatore , Milano 2010
Walter Siti, Il sole vero e il sole della pellicola, o sull'espressionismo in Pasolini in
Rivista di letteratura italiana, VII, 1 , 1989
Wolfgang Goethe, Massime riflessioni a c. di S. Seidel, Roma, 1983, in Estetica, di
Elio Franzini e Maddalena Mazzocut.-Mis, Bruno Mondadori, Milano, 2010
Wolfgang Goethe, La Teoria dei colori, in Opere Vol V., Sansoni, Firenze, 1961
Martin Heidegger, L'essenza della verità, Adelphi, Torino, 2004
Giacomo Leopardi, Tutte le opere in poesie, vol. I , a cura di Francesco Flora, Arnoldo
Mondadori Editore, Milano, 1953
Roberto Longhi, Da Cimabue a Morandi, a cura di Giafranco Contini, Mondadori,
Milano, 1973
Roberto Longhi, Caravaggio, a cura di Giovanni Previtali, Editori Riuniti, Roma, 2009
Alberto Marchesini, Longhi e Pasolini: tra “fulgurazione figurativa” e fuga dalla
citazione s. e.
Alberto Moravia, Pasolini poeta civile in Per conoscere Pasolini, Bulzoni & Teatro
Tenda Editore, Roma, 1978
M.Rizzarelli, Le ceneri di Gramsci: lo sguardo di Pasolini dai cieli alle viscere
dell’«umile Italia», in AA.VV.,Un dono in forma di parole, La Spezia, Agorà, 2002
68
Carlo Segre, Clelia Martignoni, Testi Nella Storia Vol. 4, Bruno Mondadori Scolastica,
Milano, 1995
Stefania Vannucci, Pier Paolo Pasolini: I colori della poesia, Quaderni Pier Paolo
Pasolini Associazione Fondo Pier Paolo Pasolini, Roma
Strumenti e testi:
AlbertoAsor Rosa Metodo e non metodo (nella critica letteraria), in Letteratura
Italiana Einaudi, Vol. IV L'interpretazione, Torino 1985
Alberto Asor Rosa, Il marxismo e la critica letteraria,,in Letteratura italiana Einaudi,
Vol. IV L'interpretazione, Torino 1985
Cesare Segre,Testo letterario, interpretazione, storia: linee concettuali e categorie
critiche, in Letteratura Italiana Einaudi, Vol. IV
Olivier Reboul, Introduzione alla retorica, Bologna, Il Mulino
Giovanni Beltrami, Gli strumenti della Poesia, Bologna, Il Mulino
Enciclopedia Treccani
69
Appendice
Luce atmosferica o di decoro ( A ):
A1) «...[luce della luna] tiepida sulla lucchesia dai prati // troppo umani, cocente
sulle rive / della Versilia...»157
A2) «E vi si sbianca l'Italia da Pisa/ sparsa sull'Arno in una Morta festa/ di luci, a
Lucca pudica nella grigia/ luce della cattolica, superstite/ sua perfezione...»158
A3) «...Non vi accende/la luna che grigiore, dove azzurri/gli Etruschi dormono...»159
A4) «...Ciampino// abbagliato sotto sbiadite stelle...»160
A5) «...dalla provincia viziosa ai cuori//bianchi dei globi dei bar salaci/delle
periferie cittadine»161
A6) «...sotto le sue palpebre, nel suo/ sonno, incarnata, la terra alla luna / ha un
vergine orgasmo nell'argenteo buio // che sulla frana dell'Appennino sfuma/ scosceso
verso coste dove imperla il Tirreno o l'Adriatico la spuma.»162
A7) «...dove i lumi/ingialliscono la calda atmosfera...»163
A8) «Nelle sere non più torce ma globi/ di luce, e la periferia non pare /altra, non
altri i ragazzi nuovi...»164
A9) «Nel tremito d'oro,domenicale... »165
A10) « [la nazione]... sembra arda/ di popolare gioia, ed è una noia/irreligiosa che
solare si sparge// sui floreali gessi e i gran ventagli/degli scalini.»166
A11) «se le sere ormai fonde/tremano agli ultimi brusii poetici// di mera vita»167
A12) «...un palco sta su essa, coperto di bandiere,/del cui bianco il bruno lume fa//un
sudario...»168
A13) «[….] e si espande da esso iridescente il bitume//sui tuoi Cristi inchiodati tra
157Pier Pasolo Pasolini L'appennino, ne Le ceneri di Gramsci, Garzanti, Milano, 1957, p.3158Ibid.159Id., p.4160Id.,p.6161Id., p.7162Ibid.163Id.,p.8164Da Il canto popolare, in Op.cit.. p.14165Da Picasso, in Id., p. 17166Ibid.167Da Comizio, in Id., p. 16168Id.p.17
70
falde /di luce franata[...]»169
A14) «[...] la trebbia scuote col massiccio brivido/tettoie e stalle, in un ringhio
osannante,/impastato di luce, di sudore umano/...»170
A15) «Non è di maggio questa impura aria / che il buio giardino straniero / fa ancora
più buio, o l'abbaglia // con cieche schiarite […] questo cielo /...»171
A16) «[...] con la luce cerea// che al quartiere in penombra si rapprende. E lo
sommuove. Lo fa più grande, vuoto, intorno, e più lontano, lo riaccende//di una vita
smaniosa[...]»172
A17) «Quanto più è vano//- in questo vuoto della storia, in questa/ronzante pausa in
cui la vita tace -/ ogni ideale, meglio è manifesta//la stupenda, adusta sensualità/ quasi
alessandrina che tutto minia// e impuramente accende, quando qua// nel mondo,
qualcosa crolla, e si trascina/il mondo, nella penombra, rientrando/ in vuote piazze, in
scorate officine...// già si accendono i lumi, costellando / via Zabaglia, via Franklin,
l'intero / Testaccio, disadorno tra il suo grande // lurido monte, i lungoteveri, il nero /
fondale, oltre il fiume, che Monteverde / ammassa o sfuma invisibile sul cielo.//
diademi di lumi che si perdono/smaglianti, e freddi di tristezza/quasi marina...Manca
poco alla cena;/brillano i rari autobus del quartiere, / con grappoli d'operai agli
sportelli,/e gruppi di militari vanno, senza fretta, // verso il monte che cela in mezzo a
sterri / fradici e mucchi secchi di immondizia nell'ombra, rintanate zoccolette // che
aspettano irose sopra la sporcizia /afrodisiaca...»173
A18) «Com'era nuovo nel sole Monteverde Vecchio!»174
A19) « Giunsi nella piazza, accaldato e tremante,/ché gelo e sole insieme il quartiere
accecante//sbiancavano con muta ed estasiata noia./»175
A20) «Anzi,l'indorarsi quieto del mezzogiorno/pareva eternare ogni cosa
all'intorno»,176
169Da Qudri Friulani, p. 45170Id., p.49171Da Le ceneri di Gramsci, in Le ceneri di Gramsci. p. 50172Id., p. 60173Id., p.62174Da Recit, in Id., p.64175Ibid.176Id., p. 65
71
A21) « Tutto Monteverde tremava di martelli / da assolati cantieri ad assolati sterri //
ma era solo un fervore di gente umiliata: / era solo la pace che una città occupata
//spande nella sua luce come un tempo pura, / rassegnata a esser vinta, a brulicare
oscura // meridionali voci, risa di vecchia gente / hanno allora un clamore che la storia
non sente://dove guizza più vivo uno straccio, uno sguardo, / lì più morta al sole la
natura riarde.//»177
A22) « ed ecco la mia casa, nella luce marina/di via Fonteiana in cuore alla
mattina.»178
A23) «...e con quanta dolcezza nella mia stanza cola/l'olio dardeggiante dello svenato
sole!»179
A24) « o sole che inondi d'un pasquale albore / la mia povera stanza, e mi bruci sul
cuore,» 180
A25) «...ecco lì, dietro il lume fragrante del sole / tra sterri e impalcature, l'oleato
fulgore // d'una periferia nuda come un inferno...»181
A26) «Ecco nel calore incantato//della notte che piena quaggiù/tra le curve del fiume
e le sopite/visioni della città sparsa di luci,//echeggia ancora di mille vite...»182
A27) «...una luna morente nel silenzio,/ che di lei vive, sbianca tra violenti/ardori che
miseramente sulla terra//muta di vita, coi bei viali, le vecchie/viuzze, senza dar luce
abbagliano/e, in tutto il mondo, le riflette//lassù un po' di calda nuvolaglia...»183
A28) «...uomini e ragazzi se ne tornano a casa/-sotto festoni di luci ormai sole-/verso
i loro vicoli...»184
A29) «...Ecco Villa Pamphili, e nel lume // che tranquillo riverbera / sui nuovi muri,
la via dove abito. Presso la mia casa, su un'erba // ridotta a un'oscura bava...»185
A30) «...poi, piano, rinasce, nella luce violenta, /tra i palazzi accecati, nuovo, uguale,
urlo che solo chi è morente, //nell'ultimo istante,può gettare/in questo sole che crudele
177Id., p.66178Ibid.179Id., p.67180Id., p.68181Id., p.69182 Da Il pianto della scavatrice, in Id.,. p. 70183Id., p.72184Id., p. 73185Id., p.78
72
ancora splende/già addolcito da un po' di aria di mare...» 186
A31) «...buio è quasi il meriggio nel lucore/terreo del coppedè vivace...»187
A32) «...giace// schermato il sole come in un velo/ di grassi, di carta carbone, /di
polvere alzata dagli urti sul nero// fondo dei tricicli...»188
A33) « scolorato il sole fa più intensa// la sua luce, e ogni strada, ogni piazza/ quasi in
silenzio brulica al frastuono/ d'una gente...»189
A34) «...E ti perdi allora in questa luce/ che rade, con la pioggia, d'improvviso/zolle
di salvia rossa, case sudice...»190
A35) «...Il sole/lungo le volte così puro riarde/ dal non visto orizzonte...»191
A36) «...fiati di fiamma dalla vetrata a ponente/tingono la parete, che quegli occhi
scrutano intimoriti...»p.11192
A37) «...eppure/ è così pio il suo ammirare, ai fiotti/del lume diurno, le figure/che un
altro lume soffia nello spazio...».p.11193
A38) «...E quella pura/luce che tutto vela/ di toni di pulviscolo: ed è bufera/è
strage....»194
A39) «...vedere le strade dei quartieri tranquilli, via Morgagni,Piazza Bologna, con
agli alberi /gialli di luce senza vita, pezzi di mura, /vecchie villette, palazzine nuove,/ il
caos della città, nel bianco / sole mattutino, stanca e oscura...»195
A40) «...Ora sfuriate di sole, su praterie di grotte/ e cave, naturale barocco, con
verdi/stesi da un pitocco Corot; ora soffi d'oro/ sulle piste dove con deliziose groppe
marrone/corrono i cavalli, cavalcati da ragazzi/ che sembrano ancor più giovani, e non
sanno/ che luce è nel mondo introno a loro...»196
A41) «...sotto, le Terme di Caracalla al bruciore/della luna spalancano l'immoto/bruno
dei prati senza erbe, dei pesti/rovi: tutto svapora e si fa fioco/tra colonnati di
186Id., p.89187 Una polemica in versi, Id.,p. 91188Ibid.189Ibid. 190Da Terra di Lavoro in Id., p. 105191 Da La ricchezza, ne La religione del mio Tempo, Garzanti, Milano, 1961 p.11192Ibid.193Ibid.194Ibid.195Id., p. 25196Id., p.27
73
caravaggesca polvere, /e ventagli di magnesio,/che il cerchietto della luna
campestre/scolpisce in fumate iridescenti...» 197
A42) «...Imbocco San Michele, tra muraglie /basse, quasi di casematte,
piazze7granulose su cui la luna abbaglia/come su decrepita ghiaia, terrazze/ dove
occheggia un garofano...»198/p. 48
A43) «...nella piazzetta/sotto casa, sostano, intorno al caffè/già vuoto, o più in là tra le
carrette/o i camion ruggini fin file inanimate/dove più arde la luna, e i
vicoletti,/sboccando, sono più bui. - o illuminati/appena per svegliare, di sbieco,/ in
una pietra leggera e disossata/come spugna...»199
A44) «...era un mattino in cui sognava ignara/nei rósi orizzonti una luce di mare.//
ogni filo d'erba come cresciuto a stento/era un filo di quello splendore opaco e
immenso...»200
A45) «...era ormai quasi estate, e i più bei colori/ardevano nel mite, friulano sole. // il
grano giù alto era una bandiera /stesa sulla terra, e il vento la muoveva//fra le tenere
luci, riapparse a ricolmare /di festa antica l'aria tra i monti e il mare...»201
A46) «...il sole, il colore del cielo, la nemica//dolcezza , che l'aria rabbuiata/da
redivive nubi, ridà alle cose, tutto accade come a una passata//ora del mio esistere:
misteriose mattine di Bologna o di Casarsa, /doloranti e perfette come rose...»202
A47) «...l'ossessione è perduta, è divenuta/odorante fantasma che si stende/in giorni
di luce grande e muta, // quando così debile si accende/l'azzurro che bianco è quasi,
a/ai rumori dispersi si rapprende//l'assurdo silenzio di stasi naturali, e agli odori dei
pranzi,/ dei lavori, si mischiano randagi// soffi di bosco, sepolti nei canti/più ombrosi o
più assolati/delle prime colline- o stanchi// moti quasi di altre età, ora beati /in questa
che vuole nuovo amore. ...»203
A48) «...questi due che per quartieri sparsi/di luce e miseria, vanno abbracciati/ lieti
197Id., p. 43198Id., p.48199Id., p.49200 Da A un ragazzo, in Id.,. p. 69201 Id. p. 71202 Da La religione del mio tempo, p. 76203Id.,p.78
74
paganamente dei loro passi...»204
A49) «...ah bosco, deterso dentro, sotto i forti/ profili del fogliame, che si
spezzano,/riprendono il motivo d'una pittura rustica/ma raffinata – il Garutti? Il
Collezza?// non Correggio, forse: ma di certo il gusto del dolce e grande manierismo
che tocca col suo capriccio dolcemente robusto//le radici della vita vivente: ed è
realismo... sotto i caldi castagni, poi, nel vuoto/che vi si scava in mezzo, come un
crisma, / odora una pioggia cotta al sole, poco: /un ricordo della disorientata
infanzia...»205
A50) «Una coltre di primule. Pecore/controluce (metta, metta, Tonino,/il cinquanta,
non abbia paura/che la luce sfondi- facciamo/questo carrello contro natura!). L'erba
fredda tiepida, gialla tenera/, vecchia nuova – sull'Aqua Santa. / pecore e pastore, un
pezzo/ di Masaccio/ provi col settantacinque, /e carrello fino al primo piano./
Primavera medioevale206...»
A51) «...prati convessi e immensi, in panoramica,/mostrano gruppi degni di
Mizoguchi/ l'erbetta – cresciuta dalla maledetta/ intossicante luce d'aprile, luce/per
puzzolenti pastori – sotto,/sfondo universale: in superficie/superstiti grisaglie,
cappelletti verdi/ su casacche rosso mattone o morello,/ lucenti utilitarie, pittoreschi/
gruppi al gioco della palla...»207
A52) «La luce è monumentale,/forza, forza, approfittiamone, forza/il cinquanta e il
carrello a precedere: /vengono Mamma Roma e suo figlio,/verso la casa nuova, tra
ventagli/di case, là dove il sole posa ali/arcaiche: ce sfondi, faccia pure/di questi corpi
in moto statue/di legno, figure masaccesche /deteriorate, con guance bianche/bianche,
e occhiaie nere opache/-occhiaie dei tempi delle primule,/delle ciliege,delle prime
invasioni/barbariche negli “ardenti/solicelli italici”... sono altari/queste quinte dell'Ina-
casa, /in fuga nella Luce Bullicante/ a Cecafumo.»208
A53) «...la città era lucida, /e tremavano fanali, in quel lucore/ di facile effetto umido,
204Id., p.90205Da La Guinea in Poesia in forma di rosa, p.9206 Da Poesie mondane, in Id., p. 17207Id., p.18208Id.,p.19
75
pesante/ più pesante dell'odore stesso dei tigli/ compressi, sprofondati nell'aria...»209
A54) «...tornavo per la Via Portuense. Lasciai/(lucido nello stordimento della
festa/degli altri, nemica, senza luce, mai//per me – rifiuto anche ciò che mi resta,),/ la
macchina, nel sole dominato dalla sera.»210
A55) «...ma – camminando controluce – scorsi, il sole, /oscurarsi, sui bambini e i
giovinetti/che giocavano, lungo il muro, nel calore...»211
A56) «...sotto un ammasso/ di cavalcavia e cantieri, ecco laggiù/morte, le mareggiate
di luci/della Città in cui la Storia non ha vita.»212
A57) «...era l'inizio del giorno, pochi istanti fa, /una luce vecchia, morente...»213
A58) «Il sole, il sole. Come già in fondo a Marzo,/nei meandri d'Aprile. […] file di
bar e macellerie con sola cliente la luce-/ e un altro versante del quartiere, con la luce
di striscio-/una strada in salita...»214
A59) «...E dentro un cortile tagliato/dalla luce come in un caravaggesco senza neri,
Longhi, / la Banti, con Gadda e Bassani. Roversi e Leonetti...»215
A60) «...C'è una nuvola fatta di bagliore arancione. È come un'isola con intorno il
bordo della marea//- un filo di luce nerastra, ecc. ecc. è gonfia di montagne, un sacco
arancione, di luce, pieno di pannocchie, ecc. – o patate, o ossa animali! – [...]io e lei
siamo lì, che lottiamo, come figure di un pittore del Cinquecento Nero (tanto per non
cambiare, per restare coerente coi sublimi traslati della mia testa storica!) siamo lì,
abbrancati come una mantide che fa l'amore con un passerotto e, visti da lontano, sui
pendii del fuoco arancione, glaciale di quella nube alla periferia di Roma, si potrebbe
essere incerti se è coito, sonno o duello all'ultimo sangue. Finché resta – e resta a
lungo – la luce su quella montagna di luce d'aranci, /su quell'ombrella
spumeggiante..»216
A61) «...frammento di un pezzo di cielo,/in un mondo concluso, rigorosamente
209Id.,p.21210Da La persecuzione in Id.,. p.64211Id., p. 65212 Da Pietro II in Id.,. p. 75213Ibid. 214Id., p. 79215Ibid216Da Una disperata vitalità, in Id., p. 91
76
composto,/di luci, di stelle e luna, e il nero della nuvola,/come , il mondo, non fosse
che un cumulo/ di scintillanti frantumi, di casuali rifiuti,/spazzati da un
cataclisma...»217
A62) «...più giù, in fondo alla Tuscolana, oltre Cinecittà, c'è un prato,/tutto pelato,
con lievi ondulazioni, un piccolo /deserto, con una fila di piloni, una centrale/ elettrica,
in fondo, dai globi di luce smagliante e morta:/(sotto un pilone senza luci, /nel centro
di quel prato...»218
A63) «...il biancore del sole, su tutto, /come un fantasma che la storia/preme sulle
palpebre...»219
A64) «… e quelle/quelle antiche montagne/color di paglia, coi muri del
medioevo/come paglia più scura, nella schiuma/ secca che fa, della luce, il
pancinor,/con profili di visi masacceschi neri,/controluce, su fondali castamente
ardenti...»220
A65) «...il sole, il sole vero, il sole ferocemente antico,/ -sui dorsi d'elefante dei
castelli barbarici,/sulle casupole del Meridione – o il sole/ della pellicola, pastoso
sgranato, grigio,/biancore da macero, e controtipato, controtipato/-il sole sublime che
sta nella memoria/con altrettanta fisicità che nell'ora /in cui è alto, e va nel cielo,
verso/interminabili tramonti di paesi miseri. [...]un biancore di calve viva, alto,/-
imbiancamento dopo una pestilenza/che vuol dir quindi salute, e gioiosi/mattini,
formicolanti meriggi – è il sole/che mette pasta di luce sulla pasta dell'ombra viva,
alonando, in fili/ di bianchezza suprema, o coprendo/il bianco ardente il bianco
ardente/d'una parete porosa come la pasta del pane/superficie di medioevo
popolare/»221
217Id. p. 92218id. p.93219Da Le belle bandiere in Id.,p. 106220 Da Israele in Id., p. 173221Da Israele in op. cit. p. 169-170
77
Luce allegorica ( B ):
B1) «Un esercito accampato nell'attesa/ di farsi cristiano nella cristiana/città, occupa
una marcita distesa/d'erba sozza nell'accesa campagna:/scendere anch'egli dentro la
borghese / luce spera aspettando una umana/abitazione, esso sardo o pugliese,/dentro
un porcile il fangoso desco/in villaggi ciechi tra lucide chiese/novecentesche e
grattacieli....»222
B2) «....e contro gli sfondi/del suo paesaggio, non più scarnisce/ in luce di intelletto
– che non nasconde// la buia materia- una mano che unisce a Dio il povero rione.
Quaggiù/tutto è preumano, e umanamente gioisce,// contro il riso del volgare fu/ ed è
inutile ogni parola/di redenzione: splende nella più//ardente indifferenza dei
colori/seicenteschi, quasi che al sole/o all'ombra non bastasse che la sola//sfrontata
presenza, di stracci, d'ori,/con negli occhi l'incallito riso/dei bassi digiuni
d'amore....»223
B3) «...ragazzi romanzi sotto le palpebre/chiuse cantano nel cuore della specie/dei
poveri rimasta sempre barbara// a tempi originari, esclusa alle vicende/segrete della
luce cristiana,/ al succedersi necessario dei secoli://e fanno dell'Italia un loro
possesso, /ironici, in un dialettale riso/ che non città o provincia ma
ossesso//poggio,rione,tiene in sé inciso,/se ognuno chiuso nel calore del sesso,/sua sola
misura, vive tra una gente//abbandonata al cinismo più vero/e alla più vera passione; al
violento/negarsi e al violento darsi; nel mistero/chiara, perché pura e corrotta...//»224
B4) «Improvviso il mille novecento/cinquanta due passa sull'Italia: solo il popolo ne
ha un sentimento/vero: mai tolto al tempo, non l'abbaglia/ la modernità, benché sempre
il più/moderno sia esso, il popolo, spanto/in borghi, in rioni, con gioventù sempre
nuove – nuove al vecchio canto – / a ripetere ingenuo quello che fu...»225
B5) «...Nella tua incoscienza è la coscienza/che in te la storia vuole, questa storia/in
cui Uomo non ha più che la violenza/delle memorie, non la libera memoria[...]/e
ormai, forse, altra scelta non ha/ che dare alla sua ansia di giustizia/la forza della tua
222 Da L'appennino Le ceneri di Gramsci, P.P. Pasolini, Garzanti, Milano, 1957, p.9223Id. p.11224Ibid.225 Da Il canto popolare in Id., p. 13
78
felicità, / e alla luce di un tempo che inizia / la luce di chi è ciò che non sa.»226
B6) «Dove meglio capire, intera, la natura che deve farsi / nazione, l'ombra che
s'avvera/ nella chiarezza? Ah dolci intarsi/ che nella vellutata sera/ della Venezia, della
Lombardia,/–terrorizzata quasi nella/troppa ebbrezza, nella pazzia/che troppo la
trascina– pia/la rondine intreccia sulla terra. // più è sacro dov'è più animale/il mondo:
ma senta tradire/la poeticità, l'originaria/forza, a noi tocca esaurire/il suo mistero in
bene e in male/ umano. Questo è l'Italia, e/non è questa l'Italia: insieme/la preistoria e
la storia/che in essa sono convivano, se/ la luce è frutto di un buio seme...»227
B7) «...ed è lui, il troppo onesto,// il troppo puro, che deve andare a capo
chino?/Mendicare un po' di luce per questo/ mondo rinato in un oscuro mattino?»228
B8) «...già con la tua magra mano/ delineavi l'ideale che illumina.»229
B9) «Non dico l'individuo, il fenomeno/ dell'ardore sensuale e sentimentale... / altri
vizi esso ha, altro è il nome// e la fatalità del suo peccare../ ma in esso impastati quali
comuni, / prenatali vizi, e quale//oggettivo peccato! Non sono immuni gli interni e
esterni atti, che lo fanno incarnato alla vita, da nessuna//delle religioni che nella vita
stanno, /ipoteca di morte, istituite / a ingannare la luce, a dar luce all'inganno. »
B10) «...vivo nel non volere / del tramontato dopoguerra: amando/ il mondo che odio
– nella sua miseria//sprezzante e perso- per un oscuro scandalo/ della coscienza...//Lo
scandalo del contraddirmi, dell'essere/ con te e contro te; con te nel cuore, / in luce,
contro te nelle buie viscere; // del mio paterno stato traditore/ - nel pensiero, in
un'ombra d'azione- / mi so ad esso attaccato nel calore// degli istinti, dell'estetica
passione; / attratto da una vita proletaria/ a te anteriore, è per me religione// la sua
allegria, non la millenaria/sua lotta: la sua natura, non la sua/ coscienza; è la forza
originaria// dell'uomo, che nell'atto s'è perduta, / a darle l'ebbrezza della nostalgia,/ una
luce poetica: ed altro più // io non so dirne che non sia / giusto ma non sincero,
astratto/ amore, non accorante simpatia...»230
B11) «...ma come io possiedo la storia,/ essa mi possiede; ne sono illuminato:// ma a
226 Id. p. 16227 Da L'umile Italia in Id., p. 37228 Da Comizio in id.,. p.31229 Da Le ceneri di Gramsci, in Id., p. 56230Id. p.56
79
che serve la luce? »231
B12) «...La luce/ del futuro non cessa un solo istante// di ferirci: è qui, che brucia/ in
ogni nostro atto quotidiano,/ angoscia anche nella fiducia// che ci dà vita, nell'impeto
gobettiano/ verso questi operai, che muti innalzano, /nel rione dell'altro fronte umano,//
il loro rosso straccio di speranza.»232
B13) «La luce che piove su queste anime/è quella, ancora, del vecchio meridione,/
l'anima di questa terra è il vecchio fango.»233
B14) «Così giunsi ai gironi della Resistenza / senza saperne nulla se non lo stile: fu
stile tutta luce, memorabile coscienza/ di sole.[..]Fuggimmo con le masserizie su un
carro/da Casarsa a un villaggio perduto/ tra rogge e viti: ed era pura luce. / Mio fratello
partì, in un mattino muto / di marzo, su un treno, clandestino, / la pistola in un libro: ed
era pura luce. / Visse a lungo sui monti, che albeggiavano / quasi paradisiaci nel tetro
azzurrino / del piano friulano: ed era pura luce. / Nella soffitta del casolare mia madre /
guardava sempre perdutamente quei monti, / già conscia del destino: ed era pura luce. /
Coi pochi contadini intorno / vivevo una gloriosa vita di perseguitato / dagli atroci
editti: ed era pura luce. / Venne il giorno della morte / e della libertà, il mondo
martoriato/ si riconobbe nuovo nella luce... // quella luce era speranza di giustizia:/ non
sapevo quale: la Giustizia. /la luce è sempre uguale ad altra luce. / poi variò: da luce
diventò incerta alba/un'alba che cresceva, si allargava, / sopra i campi friulani, sulle
rogge / illuminava i braccianti che lottavano. / così l'alba nascente fu una luce /fuori
dall'eternità dello stile... / nella storia la giustizia fu coscienza/d'una umana divisione di
ricchezza,/ e la speranza ebbe nuova luce.»234
B15) «...Ricordo, di quei tempi, solo la tua luce, / alta, sopra le perdute / radure del
Friuli, sopra una gente senza/speranza: risplendevi puro, / sempre, eri l'acerba luce
della Resistenza./ In un tempo che mai al mondo fu più scuro / eri l'acerba luce del
futuro.»235
B16) «...Non so perché trafitto / da tante lacrime sogguardo / quel gruppo di ragazzi
231Ibid.232Da Il pianto della scavatrice in Id.,. p. 90233Da La terra di lavoro in Id., p.104234La resistenza e la sua luce in La ricchezza ne La religione del mio tempo, pp.58-59235Da Al sole in Id.,. p. 106
80
allontanarsi/nell'acre luce di una Roma ignota, / la Roma appena affiorata dalla
morte,/superstite con tutta la stupenda/gioia di biancheggiare nella luce: piena del suo
immediato destino/d'un dopoguerra epico, degli anni / brevi e degni d'un'intera
esistenza./li vedo allontanarsi: ed è ben chiaro / che, adolescenti, prendono la
strada/della speranza, in mezzo alle macerie / assorbite da un biancore ch'è vita/quasi
sessuale, sacra nelle sue miserie. / E il loro allontanarsi nella luce/ mi fa ora
raggricciare di pianto: / perché? Perché non c'era luce / nel loro futuro. Perché c'era
questo / stanco ricadere, questa oscurità. / sono adulti, ora: hanno vissuto / quel loro
sgomentante dopoguerra / (di corruzione assorbita dalla luce, / e sono intorno a me,
poveri uomini/a cui ogni martirio è stato inutile, / servi del tempo, in questi giorni/in
cui si desta il doloroso stupore / di sapere che tutta quella luce, / per cui vivemmo, fu
soltanto un sogno / ingiustificato, inoggettivo, fonte / ora di solitarie, vergognose,
lacrime.»236
B17) «...Il Pontormo / con un operatore / meticoloso, ha disposto cantoni / di case
giallastre, a tagliare/questa luce friabile e molle,/ che dal cielo giallo si fa
marrone/impolverato d'oro sul mondo cittadino.../ e come piante senza radice, case e
uomini,/creano solo muti monumenti di luce/e d'ombra, in movimento: perché/la loro
morte è nel loro moto. /vanno, come senza alcuna colonna sonora,/automobili e
camion, sotto gli archi,/sull'asfalto, contro il gasometro,/nell'ora, d'oro,di Hiroscima,
(/dopo vent'anni, sempre più dentro/ in quella loro morte gesticolante: e io/ritardatario
sulla morte, in anticipo/sulla vita vera, bevo l'incubo/della luce come un vino
smagliante./nazione senza speranze! L'apocalisse/esploso fuori dalle coscienze/nella
malinconia dell'Italia dei Manieristi,/ha ucciso tutti: guardateli- ombre/grondanti d'oro
nell'oro dell'agonia.»237
B18) «...miliardi di viventi, /una dolce mattina si desteranno,/ al semplice trionfo
delle mille mattine della vita,// con la maglia riarsa... con l'umido/del primo
sudore...felici-essi-/felici! Essi soltanto felici!//essi soltanto possessori del sole! /lo
stesso sole del barbaro/che nel medioevo discese//e dalle gole dei monti, dalle
236Da Lacrime in op.cit. p. 60-61237Da Poesie Mondane in Poesia in forma di rosa pp.25-26
81
ombre /della neve si accampò,/sull'erba nera e folta ma /cattiva e felice degli argini
d'aprile.// solo chi non è nato, vive! Vive perché vivrà, e tutto sarà suo,/è suo, fu
suo!»238
B19) «...Avete voluto avere un poeta in questo banco/lustrato dai calzoni di tanti
poveri cristi?/ va bene, godetevelo. La giustizia/diventa cieca voce di rondini, agli
scioperi/della Poesia. E non perché, la Poesia, abbia diritto/ di delirare su un po' di
azzurro, su un misero sublime/giorno che nasce con la malinconia della morte. /Ma
perché la poesia è giustizia. Giustizia che cresce/in libertà, nei soli dell'anima, dove si
compiono /in pace le nascite dei giorni, le origini e le fini/delle religioni, egli atti di
cultura/sono anche atti di barbarie,/e chi giudica è sempre innocente.»239
B20) «...Dilagò la nevrosi, attraverso la ferita- e la morte venne allora dalla vita, dai
regni che si estendono oltre la sua ombra, dove c'è soltanto luce la stupenda luce del
futuro. “Ciò che hai saputo, hai saputo: il resto non lo saprai.”...»240
238Da Poesia in forma di rosa in Id. p. 63239Da Pietro II in Id.,. p. 76240Da Una disperata vitalità p. 91
82
Luce mistica ( C ) :
C1) «….Muti/decenni, di un secolo ancor verde, /e bruciato dalla rabbia
dell'azione/non trascinante ad altro che a disperdere//nel suo fuoco ogni luce di
Passione...»241
C2) «...mi sospingo come / disincarnato in mezzo a questa fiera // d'ombre[...]e qui
urla soltanto la borghese// impotenza a trascendere la specie,/la confusione della fede
che / l'esalta, e disperatamente cresce / nell'uomo che non sa che luce ha in sé»242
C3) «...ha dolorosa e accesa, // nel sorriso, la luce con cui vide, /oscuro partigiano,
non ventenne/ancora, come era da decidere/con vera dignità, con furia indenne/d'odio,
la nuova nostra storia: e un'ombra,/in quei poveri occhi, umiliante e solenne...//egli
chiede pietà, con quel suo modesto, /tremendo sguardo, non per il suo destino, / ma per
il nostro... »243
C4) «...invece è la passion / mite, virile, che rischiara / il mondo in una luce
senza/impurezze, che al mondo dà le care / civili piazzette, dove ignare/rondini scatena
l'innocenza[...]borghi del settentrione, dove / dal ragazzo con fierezza / e allegra umiltà
nasce il giovane, / e vive la sua giovinezza / da vero adulto, benché piova / il suo
occhio chiaro e la sua bionda/testa luce infantile: ma è / quell'infanzia solo
gioconda/onestà: egli nella sua fonda / vita il mondo matura con sé»244
C5) «...un'anima in me, che non era solo mia, / una piccola anima in quel mondo
sconfinato, / cresceva, nutrita dall'allegria // di chi amava, anche se non riamato. / e
tutto si illuminava, a questo amore. / forse ancora di ragazzo, eroicamente, // e però
maturato dall'esperienza che nasceva ai piedi della storia... »245
C6) «...e in questa // maturità che per essere nascente / era ancora amore, tutto era /
per divenire chiaro-era, // chiaro! Quel borgo nudo al vento, / non romano, non
meridionale, / non operaio, era la vita// nella sua luce più attuale: vita, e luce della vita,
piena/ nel caos non ancora proletario // come la vuole il rozzo giornale / della cellulare,
241 Da Picasso in Le ceneri di Gramsci, p.25242 Da Comizio in id., p. 27-29243 Id., p. 31244 Da L'umile italia in Id., pp. 32-33245 Da Il pianto della scavatrice in Id., p. 73
83
l'ultimo / sventolio del rotocalco: osso // dell'esistenza quotidiana, /pura, per essere fin
troppo / prossima, assoluta per essere // fin troppo miseramente umana. »246
C7) «...i pochi amici che venivano / da me, nelle mattine o nelle sere // dimenticate
sul Penitenziario, / mi videro dentro una luce viva: / mite, violento rivoluzionario// nel
cuore e nella lingua. Un uomo fioriva.»247
C8) «Cammino per una strada che avanza// tra i primi prati primaverili, sfatti/ in una
luce di paradiso[...]io grido di gioia, così ferito / in fondo ai polmoni da quell'aria// che
come un tepore o una luce/ respiro guardando la vallata...»248
C9) «...E proprio in quel sopore // è la luce...in quella incoscienza/d'infante,
d'animale o ingenuo libertino/è la purezza...»249
C10) «...È una luce / - a certo non meno soave/ di quella, ma suprema – che si
spande / da un sole racchiuso dove fu divino/ l'Uomo, su quell'umile ora dell'Ave.// che
si spande, più bassa / sull'ora del primo sonno, della / notte, che acerba e senza stelle
Costantino/circonda, sconfinando dalla terra / il cui tepore è magico silenzio...»250
C11) «...sì che questi chiari momenti / d'oscuro amore, abbandonati, / non si perdano,
nel mondo, in cui rimane / persa nella sua purezza / la luce delle gesta quotidiane.»251
C12) «...così nuovo alla luce di questi mesi nuovi / che tornano su Roma, e che noi
altrove// ancorati a una luce d'altri tempi / sembrano portarti da inutili venti/[...]al
giusto momento, ci lasci, ritorni/alla segreta luce dei tuoi primi giorni: // alla luce che
certo tu non puoi dire né, noi, ricordare, una luce d'aprile // in cui la coscienza con le
sue gemme sfiora / solo la vita, non la storia ancora. // [...]vuoi SAPERE. Non hai
domanda su un oggetto / su cui non c'è risposta; che trama solo in petto. // la risposta,
se c'è, è nella pura / aria del crepuscolo, accesa sulle mura // del Vascello, lungo le
palazzine / assiepate nel cuore del sole che declina.// »252
C13) «...chiedendo di sapere tu ci vuoi indietro, / legati a quel dolore che ancora
oscura il petto. // ci toglie questa luce che a te splende intera, / ch'è della nuova
246 id., p. 77247 Id ,p.81248 Id. ,p. 82-85249 Id., p. 87250 Da Gli affreschi di Piero ad Arezzo in La ricchezza ne La religione del mio tempo, pp.12-13251 Id p. 17252 Da A un ragazzo in Id.,p. 65-67
84
gioventù ogni sera[...]L'ombra che ci invecchia fosse astratta coscienza, / voce che
contraddice la vitale presenza!»253
C14) «...pur sopravvivendo, in una lunga appendice / di inesausta, inesauribile
passione / - che quasi in un altro tempo ha la radice - // so che una luce, nel caos, di
religione, / una luce di bene, mi redime/ il troppo amore nella disperazione.. // è una
povera donna, mite, fine, che non ha quasi coraggio di essere, / e se ne sta nell'ombra,
come una bambina, // coi suoi radi capelli, le sue vesti dimesse,»254
C15) «...e di nuovo ridono, impuri, i vivi, tu darai/la purezza, l'unico giudizio che ci
avanza, /ed è tremendo, e dolce: ché non c'è mai// disperazione senza un po' di
speranza.»255
C16) «No, non a noi: tu manchi ma a loro, che pure vivono a livelli/d'esistenza di
sole, in pienezza,/ e tra baracche e sterri,/ prati zeppi di canne e d'immondezza/sentono
in questa disorientata brezza, /con altro cuore il tuo non esserci.[...]nel tuo buio, sole/si
compie ancora una volta l'ingiustizia: per essi, che son senza/ vestiti e casa, per me,
che soffro mistica/degradazione. Causale coincidenza/confusione d'incoscienza e di
coscienza. // [...]all'ombra di una nuova lotta, e ai sordidi/inviti del nuovo capitale, già
padrone/un'altra volta, e disposto al perdono...[...]obbediente, sincero, atterrito, /non
dovevo essere buono, ma santo,/ non uomo, ma gigante, / non elegante, ma puro,
squisito./Dovevo cercare un linguaggio,/ a esprimere quel mio intimo lume infinito,/
che fosse estremo: ingenuo appannaggio/ dell'agio borghese, dell'antiborghese
coraggio.// ho saputo, eccome ho saputo!,/ ventenne, capire quale era il sentimento/ più
forte in quel luminoso caos/ di ogni sentimento:/la libertà. »256
C17) «...Mentre ognuno con fede ricattatoria/era pieno della luce della sua scelta,/ io
continuavo per la strada incerta/della conoscenza, nell'ombra-luce della
storia./intransigenza e dolore/erano sola garanzia di qualche vittoria,/e proprio dentro
la tua luce di sole/ fatto simbolo, serbavo il tuo furore[...]Tu splendi sopra un sogno,
/buio sole: chi vuole non sapere,/ vuole sognare...»257
253 Id., p. 70-71254 Da Una luce in Id., p. 103255 Id., p. 106256 Al sole in Id.,p. 159-161257 Id. p. 162-163
85
C18) «...vengo da te e torno a te,/ sentimento nato con la luce, col caldo,/battezzato
quando il vagito era gioia,/riconosciuto in Pier Paolo/ all'origine di una smaniosa
epopea: ho camminato alla luce della storia,/ ma sempre, il mio essere fu eroico,/sotto
il tuo dominio, intimo pensiero./si coagulava nella tua scia di luce/nelle atroci
sfiducie/della tua fiamma, ogni atto vero/del mondo, di quella/storia: e in essa si
verificava intero,/vi perdeva la vita per riaverla: /e la vita era reale solo se bella...»258
C19) «Alle volte è dentro di noi qualcosa / (che tu sai bene, perché è la poesia) /
qualcosa di buio in cui si fa luminosa // la vita: un pianto interno, una nostalgia /
gonfia di asciutte, pure lacrime...»259
C20) «...e così, ecco questa mattina in cui non spero / che nella luce.. / Sì, nella luce
che disossa/con la sua felicità primaverile/le giornate di questa mia Canossa. // eccomi
nel chiarore di un vecchio aprile, / a confessarmi, inginocchiato, / fino in fondo,fino a
morire. //ci pensi questa luce a darmi fiat, / a reggere il filo con la sua
biondezza/fragrante, su un mondo, come la morte, rinato.//poi...ah. Nel sole è la mia
sola lietezza../quei corpi, coi calzoni dell'estate,/un po' lisi nel grembo...»260
C21) «...come un cieco: a cui sarà sfuggita,/ nella morte, una cosa che coincide / con
la vita stessa, - luce seguita//senza speranza, e che a tutti sorride,(/invece, come la cosa
più semplice del mondo – una cosa che non potrà mai condividere. //morirà senza aver
conosciuto il profondo/senso d'esser uomo, nato a una sola/vita cui nulla, nell'eterno,
corrisponde // ...dentro i ventri delle madri, nascono figli ciechi/-pieni di desiderio di
luce-sbilenchi // –pieni d'istinti lieti: e attraversano la vita nel buio e la vergogna ….
gli altri dicono sempre che non bisogna // essergli di peso. Ed essi obbediscono. Si
tinge/così tutta la loro vita di un colore diverso. / e il mondo – il mondo innocente! – li
respinge...»261
C22) «....il biancore del sole, su tutto, / come un fantasma chela storia/preme sulle
palpebre // [...]di colpo i miei amici poeti, / che condividono come me il brutto
biancore/ di questi Anni Sessanta/uomini e donne, appena un po' più anziani/ o più
giovani – sono là, nel sole.[...]la realtà/ è fuori, nel sole trionfante, / nei viali e nei caffè
258 Da Frammento alla morte in Id., p. 164259 Da La guinea in Poesia in forma di rosa, Garzanti, Milano, 1963 p. 8260 Da La realtà in Id.,p. 36261 Id., p. 44-45
86
vuoti, / nella suprema afonia delle dieci del mattino ,/ un giorno come tutti gli altri, con
al sua croce!»[...]il mio amico dal mento di papa, il mio / amico dall'occhio
marroncino... i / miei cari amici del Nord / fondati su affinità elettive dolci come la
vita / -sono là, nel sole. // Anche Elsa, col suo biondo dolore, / lei,- destriero ferito,
caduto, / sanguinante- è là. 262
C23) «...marmo, cera, o calce, /nelle palpebre, agli angoli degli occhi: / il biancore
gioiosamente romanico, / perdutamente barocco, del sole nel sonno.[...] // di quel
biancore fu il sole vero, / di quel biancore furono i muri delle fabbriche, / di quel
biancore / fu la stessa polvere»263
C24) «...vide l'infinita capacità di obbedire / e l'infinita capacità di ribellarsi: / la
chiamo a sé ,e operò su lei / - che lo guardava fiduciosa / come un agnello guarda il
suo giusto carnefice- / la consacrazione a rovescio, mentre / nel suo sguardo cadeva/la
luce, e saliva un'ombra di pietà. // « tu scenderai nel mondo, / e sarai candido e gentile,
equilibrato e fedele, /avrai un'infinita capacità di obbedire e un'infinita capacità di
ribellarti, / sarai puro. / perciò ti maledico.» // »264
262 Da Le belle bandiere in Id., p. 107263 Id., p. 108264 Da una disperata vitalità in Id., p. 129
87