Tesi di dottorato: Politiche pubbliche e occupazione. L’apprendistato: luci e ombre di una...
Transcript of Tesi di dottorato: Politiche pubbliche e occupazione. L’apprendistato: luci e ombre di una...
DOT T ORAT O IN
“SIST EMI SOCIALI E ANALISI DELLE POLIT ICHE PUBBLICHE”
Politiche pubbliche e occupazione . L’appre ndis tato: luci e ombre di una politica inte grata .
Ste fania Capogna
Tutor: Prof. Luciano Benadusi Co-Tutor: Prof.ssa Tatiana Pipan
2 2
RIN GRAZIAMEN T I
Il lavoro e la r ifle s s ione che hanno condotto a lla re a lizzazione di que s ta ope ra s ono il frutto di un’inte ns a a tt ività di r ice rca pe r la quale inte ndo r ingraziare vivame nte tutti coloro che , pe r amic izia , hanno s os te nuto il mio cammino a volte ince r to. In par ticolar modo de s ide ro r ingraziare Luciano Be nadus i pe r ave r la fiducia e l’a tte nzione r iconos c iutami in ogni fas e de l lavoro e grazie a lle quali mi è s ta to pos s ibile raggiunge re que s to diffic ile tr aguardo. Ma un r ingraziame nto s ince ro è r ivolto anche a tutt i coloro che , le gge ndo le ve rs ioni pre ce de nti de l lavoro, s ono dive nuti par te c ipi de l mio s forzo forne ndomi utilis s imi s ugge r ime nti e c r it iche cos truttive . Pe r que s to contr ibuto, dunque , de s ide ro r ivolge re un r ingraziame nto a Paolo Botta , a Lia Fas s ar i, a Dome nico Lipar i, a T atiana P ipan, a Gius e ppe Ricotta e ad As s unta Vite r it t i. De s ide ro r ingraziare , inoltre , anche l’Age nzia Lazio lavoro pe r la dis ponibilità e l’inte re s s e che ha s e mpre manife s ta to ve rs o que s to lavoro e pe r il s os te gno fornitomi lungo tutto il pe r iodo di pe rmane nza s ul campo.
3 3
De dico que s to lav oro .. .. ..
ai m ie i ge nitori che ne lla loro nuov a condiz ione s pirituale s e nto ancora più intim am e nte v ic ini. A loro offro inte ram e nte il lav oro s v olto con tutte le fatiche e le gioie che que s to ha com portato e pe r il quale s are bbe ro s tati e s tre m am e nte orgoglios i. A lle m ie f iglie che con i loro s orris i e con i loro capricc i m i hanno aiutata ad us c ire dalla s offe re nza de l “dis tacco” pe rm e tte ndom i di ripe rcorre re i pas s i più be lli de l rapporto inte s s uto con i m ie i ge nitori. A d A nna e Pe ppe che con la loro dis ponibilità e la loro v ic inanza quotidiana, cos tante , dis cre ta e dis inte re s s ata, m i hanno pe rm e s s o di raggiunge re que s to àm bito traguardo che altrim e nti s are bbe rim as to irragiungibile . A m io m arito al quale s i de v e inte ram e nte la re aliz zaz ione di que s to lav oro, pe r av e rm i s os te nuta e incoraggiata ne i m om e nti più dif f ic ili de l cam m ino, e pe r av e r s opportato paz ie nte m e nte i m ie i brus chi pas s aggi dall’e cc itaz ione all’abbattim e nto che ins e guiv ano il f luire il rif luire de lle ide e . Gr a z ie p e r e s s e r m i s t a t o s e m p r e a c c a nt o c o n le t ue a f f e t t uo s e c r i t ic he e p e r a v e r s t r a v o l t o o g ni m ia p r o s p e t t iv a . Graz ie , s ince ram e nte , a tutti v oi.
4 4
INDICE
P OLIT ICHE P U BBLICHE E OCCU P AZION E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 L’AP P REN DIS T AT O: S U CCES S I E FALLIMEN T I DI U N A
P OLIT ICA IN T EGRAT A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Pre me s s a ........................................................................................................... 7 CAP IT OLO U N O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 IL P ROBLEMA DI RICERCA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 AP P REN DIS T AT O E FORMAZION E ES T ERN A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 Il cambiame nto ipotizzato ............................................................................... 15 Dalla le gge 25/1955 alla L. 196/97: pre s uppos ti te or ici e mode llo
e conomico- organizzativo ......................................................................... 17 Line e di analis i e quadro te or ico me todologico ............................................. 24 Re s e arch’s points ............................................................................................ 28 CAP IT OLO DU E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 S OCIET A’ DELLA CON OS CEN ZA, MERCAT O DEL LAVORO . . . . . . . 3 1 E S IS T EMI EDU CAT IVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 Il cambiame nto di paradigma .......................................................................... 31 Dal fordis mo al pos t- fordis mo ....................................................................... 33 La formazione pos t- indus tr iale ...................................................................... 37 Formazione pos t- indus tr iale e or ie ntame nto: una nuova funzione .............. 41 Life long le arning, e ducazione continua e s ocie tà de lla conos ce nza ........... 46 Come cambia il conce tto di appre ndime nto ................................................... 48 La te or ia de lle r is ors e umane e il conce tto di compe te nza .......................... 53 Una nuova re lazione tra e ducazione e s ocie ta’ pos t- fordis ta ...................... 57 Le te or ie clas s iche ......................................................................................... 57 Quali implicazioni pe r il s is te ma e ducativo e formativo ................................ 59 CAP IT OLO T RE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 IL RAP P ORT O T RA P OLICIES E “S IS T EMI” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 Il cambiame nto de lle politiche formative e occupazionali ............................ 67 Ricos truzione de l dibattito .............................................................................. 72 Il tra ino de l Fondo s ociale e urope o e la nuova programmazione ................. 76 Un rapido confronto tra organis mi s ovranzionali .......................................... 78 Come s i configurano oggi le politiche inte grate in Europa e in Ita lia ........... 88 Sviluppi de lla conce r tazione ......................................................................... 92 Il dibattito in Ita lia ......................................................................................... 95 Par te nar iato e politica di coe s ione : ve rs o le politiche inte grate ? .......... 101 Il conce tto di re te applicato alla pubblica amminis trazione ...................... 105 Cons ide razioni conclus ive ............................................................................ 107 Il “s is te ma inte grato”: conce zioni a confronto ............................................ 108 L’inte grazione ne l pe ns ie ro pe dagogico e ps icologico: i r is volti pe r la
didattica ................................................................................................... 110 L’inte grazione ne l pe ns ie ro s ociologico ...................................................... 113
5 5
L’alte rnanza s cuola- lavoro: una via pe r l’inte grazione ............................... 119 I dive rs i mode lli de ll’alte rnanza s cuola- lavoro ......................................... 124 La formazione pe r appre ndis ti ..................................................................... 129 La tutors hip come garanzia di qualità ....................................................... 132 Ce r tificazione de lle compe te nze e qualità de lla ce r tificazione ................. 136 CAP IT OLO QU AT T RO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 2 L’AP P REN DIS T AT O IN IT ALIA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 2 U N A P ROS P ET T IVA COMP ARAT A, S T ORICA E QU AN T IT AT IVA1 4 2 Pros pe ttiva comparata .................................................................................. 142 Dive rs i s e ntie r i tra s cuola e lavoro ............................................................. 142 Appre ntice s chip Country: Ge rmania ........................................................... 145 School- Bas e d Vocational Country: Francia, Inghilte r ra ............................. 150 Ge ne ral e ducation countr ie s : Spagna .......................................................... 155 Mixe d pathway countr ie s : Olanda, Danimarca, Lus s e mburgo .................... 157 La via ita liana ................................................................................................ 158 Il nuovo impuls o dato dalla r iforma: uno s guardo ai dati nazionali ............ 160 Cr itic ita’ e proble mi ape r ti ........................................................................... 170 CAP IT OLO CIN QU E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 4 AN ALIS I DI U N P ROCES S O DI “T RADU ZION E”: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 4 L’AP P REN DIS T AT O N EL LAZIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 4 Dati s trutturali de l conte s to ......................................................................... 174 Le dive rs e fas i de lla “traduzione ”: il s ignificato confe r ito al conce tto di
inte grazione ............................................................................................. 178 Il proce s s o di inte grazione e di coordiname nto ......................................... 185 La que s tione de lle compe te nze organizzative ............................................. 192 Inte grazione e qualità de lle re lazioni ........................................................... 196 Dive rs e configurazioni di inte grazione ........................................................ 202 Diffe re nti live lli di inte grazione .................................................................... 207 Le pratiche profe s s ionali de gli a ttor i ........................................................... 212 Il punto di vis ta de i de s tinatar i : azie nde e appre ndis ti .............................. 213 L’appre ndis tato come politica formativa ...................................................... 216 CON CLU S ION I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 0 BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 9 DOCU MEN T I U FFICIALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 1
6 6
INDICE DEI GRAFICI
Gra f ic o 1 : Parabola de l contra tto di appre ndis ta to da l 1980 a l 1998 p.157
Gra f ic o 2 : Dis tr ibuzione re gionale appre ndis ti da l 1997 a l 1999 p 158
Gra f ic o 3 ; Ripar tizione appre ndis ti pe r t ipologia di impre s a
da l 1996 a l 1999 p. 159
Gra f ic o 4 : Appre ndis ti pre vis ti e is cr it t i ne lle pr ime
s pe r ime ntazioni nazionali p. 160
Gra f ic o 5 : T as s i di abbandono p. 160
Gra f ic o 6 : Appre ndis ti occupati ne lle var ie re gioni ita liane ,
ds tinti pe r ge ne re , anno 2001 p. 162
Gra f ic o 7 : Dis tr ibuzione appre ndis ti ne lle re gioni ita liane p. 163
Gra f ic o 8 : Dis tr ibuzione re gionale de lle r is ors e impe gnate ne lle
a tt ività formative e ne lle a tt ività colle gate a ll’appre ndis ta to p. 165
Gra f ic o 9 : Gli appre ndis ti ne l Lazio da l 1997 a l 1999 p. 170
Gra f ic o 1 0 : Sttor i più s ignifica tivi pe r il te s s uto e conomico lazia le p. 172
Gra f ic o 1 1 : Suddivis ione pe r ge ne re e d e tà de gli appre ndis ti ne l Lazio p. 172
Gra f ic o 1 2 : T itolo di s tudio de gli appre ndis ti ne lle azie nde de l Lazio p. 173
Gra f ic o 1 3 : Dura ta in me s i de l contra tto di appre ndis ta to ne l Lazio p. 174
7 7
P OLIT ICHE P U BBLICHE E OCCU P AZION E.
L’AP P REN DIS T AT O: LU CI E OMBRE DI U N A P OLIT ICA IN T EGRAT A
Pre me s s a Dire che il me rcato de l lavoro s i è andato tras formando, as s ume ndo caratte r is tiche e connotati dive rs i dal pas s ato, è un luogo comune pe rché il r is ultato di ta le e voluzione è s otto gli occhi di tutti. Ci troviamo di fronte ad un cambiame nto impone nte dovuto alla mondializzazione de l me rcato, a lla globalizzazione de ll’e conomia e alla accre s ciuta pos s ibilità di impone nti s pe culazioni finanziar ie che provocano note voli turbole nze al me rcato e , di r ifle s s o, a ll’occupazione . L’avve nto de lle nuove te cnologie , inoltre , ha modificato la s te s s a organizzazione de l lavoro, mutandone radicalme nte proce s s i e conte nuti de l lavoro. Il nos tro pae s e , a l par i di a ltr i, s ubis ce que s ta for te de s tabilizzazione e conomica e d occupazionale contraddis tinta , a ltre s ì, da uno s viluppo dis tor to. Infatti, il Nord è attivo e d indus tr ia lizzato, con zone par ticolarme nte vivaci e s e ttor i in cui l’offe r ta di lavoro non r ie s ce a copr ire la r ichie s ta; me ntre il Sud è s e mi- paralizzato, caratte r izzato da ve r i e propr i de s e r ti produttivi, da un’altis s ima dis occupazione giovanile e da un’ipe r trofia de lle amminis trazioni locali.1 Al te mpo s te s s o, il cambiame nto de lla s truttura de mografica (aume nto de ll’indice di ve cchiaia , r iduzione de ll’indice di natalità) (Pe tilli, 1993), il prolungame nto de ll’ite r formativo (che r itarda s e mpre più l’e ntrata ne l mondo di lavoro) e l'a llungame nto de lla vita me dia (che cos tr inge a r itardarne s e mpre più l’us cita), hanno contr ibuito ad alte rare il modo s te s s o di inte nde re e vive re il lavoro. Le r ice rche de gli ultimi anni hanno me s s o in e vide nza che il lavoro vie ne vis s uto non più in te rmini s trume ntali be ns ì ne ll’ottica di una più intima s oddis fazione : di qui, la me s s a in atto di una s e r ie di s trate gie pe rs onali ne lla s ce lta de ll’occupazione (Cavalli, De Lillo, 1993; Cavalli, De Lillo e Buzzi 1997), complicata anche dal fatto che la te nde nza attuale è que lla di r iconos ce rs i in molte plici ide ntità, di cons e gue nza, una s ce lta anticipata o de finitiva vie ne pe rce pita come re s tr ittiva (Botta , 1995). T utti que s ti cambiame nti hanno avuto una note vole r ipe rcus s ione s ul s is te ma formativo, il quale ve rs a ormai da anni in una cr is i, da tutti r iconos ciuta , i cui connotati pos s ono e s s e re cos ì r ias s unti: un alto cos to s ociale ; una profonda dis affe zione de i giovani ve rs o la s cuola che non è più cons ide rata né s trume nto di promozione s ociale né chiave di acce s s o al me rcato de l lavoro; uno s cars o live llo di qualità s ia de gli appre ndime nti, cui cons e gue un alto live llo de gli abbandoni e dis occupazione giovanile , s ia
1 Per un approfondimento sui problemi e gli squilibri che caratterizzano l'attuale mercato del lavoro in Italia e in Europa si rimanda al prezioso contributo di Reyneri (1996).
8 8
de i conte nuti profe s s ionalizzanti. Infine , una cre s ce nte auto- re fe re nzialità de l s is te ma e ducativo e una s e mpre più marcata lontananza conte nutis tica dal me rcato re ale , in s pe cial modo, ne gli indir izzi te cnici che dovre bbe ro e s s e re caratte r izzati da un for te grado di innovazione .
La r ifle s s ione inte rnazionale s u que s te proble matiche s ta por tando ad una r ivis itazione de l conce tto di appre ndime nto e de lle tradizionali modalità di tras mis s ione de l s ape re contraddis tinte da un pe r iodo di formazione iniziale prope de utico all’e ntrata ne l me rcato de l lavoro, e da una fas e attiva - pre s s oché inalte rata - che accompagna il s ogge tto fino al pe ns ioname nto. Già a par tire dagli anni ’702, anche s e in te mpi e in modi dive rs i a ll’inte rno de lla Comunità Europe a, s i s ono avviate le pr ime r ifle s s ioni e s pe r ime ntazioni s u pe rcors i a lte rnati tra s cuola e lavoro (Bocca, 1984). Dopo circa 30 anni il dibattito s e mbra e s s e re quanto mai di a ttualità e ormai maturo de i contr ibuti e di tutte le e s pe r ie nze e le comparazioni condotte ne i dive rs i Pae s i. Le te nde nze attuali pos s ono e s s e re r ias s unte ne llo s forzo de ll’Unione Europe a volto a dare un as s e tto unitar io alle politiche formative –ne l r is pe tto de lle dive rs ità de i Pae s i me mbri – in vis ta di una migliore compe tizione ne l me rcato globale e di una re ale libe ra circolazione de i lavorator i e de lle conos ce nze s ul te r r itor io comunitar io, a l fine di garantire un ade guato s viluppo te cnologico. Que s ta impos tazione conduce a cons ide rare la ne ce s s ità di una manute nzione continua de i s ape r i de l lav oratore de lla conos ce nza (Bute ra, 2000) che non pos s ono e s s e re acquis iti una volta pe r s e mpre , ma che de vono e s s e re aggiornati e migliorati lungo tutto l’arco de lla vita , a fronte de lla rapida obs ole s ce nza a cui s ape r i e compe te nze s ono de s tinati ne ll’e ra pos t- mode rna. Soluzione ine vitabile a que s ta comple s s a proble matica s e mbra e s s e re la s trate gia de ll’alte rnanza te or ico- pratica che s i dis tingue in formazione continua pe r gli adulti e formazione iniziale de i giovani che , s e condo la re ce nte normativa, può re alizzars i a ttrave rs o quattro canali is tituzionali: appre ndis tato, tirocinio (o s tage ), IFT S, s cuola- FP. In re altà, e s is te un quinto canale , non formale ma molto diffus o, che vie ne individuato dalle re ce nti r ice rche OECD (2000) e IST AT (2001), ne l doppio ruolo di s tude nte lavoratore . Que s t’ultima modalità di a lte rnanza, s e ppure non s e mpre r ie s ce a garantire un valido live llo di coe re nza tra il mome nto te or ico e que llo ope rativo, s i r ive la quanto mai pre zios a ne ll’acquis izione , ad e s e mpio, de lle compe te nze tras ve rs ali (di cui s i par le rà diffus ame nte più avanti).
L’impor tante cambiame nto, qui appe na tratte ggiato, è s tato avviato dall’alle ntars i de i vincoli de l me rcato prote tto e dalle tras formazioni che hanno inve s tito il s e ttore produttivo. Si as s is te , da una par te , ad un
2 In questi anni si è registrato un cambiamento di paradigma che ha visto tramontare la visione positiva della scuola fondata su una favorevole congiuntura economica, il notevole sviluppo tecnologico, il crescente aumento della domanda formativa ecc., in vista di una visione negativa volta a cogliere: l’alto costo sociale dell’istruzione, l’auto-perpetuazione di un sistema fondato sulla divisione di classe, l’ineguaglianza delle opportunità ecc.. Per un approfondimento si consiglia la lettura di: Benadusi (1984; 1993).
9 9
proce s s o s otte r rane o e d inar re s tabile di modificazione de gli as s e tti di pote re e di me rcato che ne l s e ttore e conomico s ono s fociati ne ll’affe rmazione di forme re ticolar i tipiche de ll’impre s a ape r ta , de i dis tre tti indus tr iali e cc. (Moro, 1998); e , dall’altra , a l te ntativo di ade guare a que s to cambiame nto anche la tradizionale pubblica amminis trazione (P.A.) che in tutti gli s ta ti occide ntali s ta conos ce ndo un profondo r ipe ns ame nto s ulla s cor ta di due logiche e s s e nziali, que lla de lla f is s ione e que lla de lla fus ione .3 La P.A. ormai da qualche anno s ta approntando un note vole s forzo di r is trutturazione organizzativa che conduce da un mode llo burocratico ad un mode llo a re te s ulla s cia di quanto gia è avve nuto in campo e conomico- produttivo. A s os tanziare que s to cambiame nto c’è, a lla bas e , un mutame nto di valor i, di re tor iche , di s trume nti e cc. che ve ngono ve icolati a ttrave rs o il nuovo manage r ialis mo4, a l fine di gove rnare que s ta difficile trans izione . Sulle bas i di ta li pre me s s e s i os s e rva che il conce tto di “politica inte grata” s i va s e mpre più affe rmando ne l dibattito inte rnazionale , s ia come moda s ia come nuova re tor ica di gove rno locale , s ulla s cia di una cre s ce nte inade guate zza de lle politiche macroe conomiche o di s e ttore 5. Anche in Ita lia s i comincia a par lare da qualche anno di politiche inte grate , in par ticolar modo, grazie alla s pinta comunitar ia che , ve ros imilme nte , grazie ad un pr incipio di coe re nza intr ins e co al s is te ma di programmazione ad albe ro s pinge ve rs o una maggiore inte grazione di dive rs i s e ttor i di policy E’ in que s to filone che s i può collocare la nuova s tagione di s trume nti di programmazione var iame nte noti come : accordi di programma, accordi di s e ttore , patti d’are a e cc. (Bobbio, 2000) che s i is pirano, appunto, a lla logica ne goziale e alla par te cipazione re s pons abile di tutti gli a ttor i (s ulle politiche inte grate s i ve da il III capitolo de l pre s e nte te s to). Ne llo s pe cifico, s i inte nde con il te rmine “politica inte grata” que gli inte rve nti di policy fondati s u una vis ione s is te mica di conte s to e caratte r izzati da una pratica multia ttore or ie ntata ad una programmazione inte grata (a tutti i live lli e non s olo in te rmini e conomici); e , c ioè, capace di far conve rge re s u un unico obie ttivo/ inte rve nto s e ttor i di policy dive rs i ma concomitanti, a l fine di ottimizzare gli e ffe tti de ll’inte rve nto s te s s o. In
3 Come spiega Fedele (1998) la logica della fissione tende alla creazione di agenzie quasi autonome, mentre quella della fusione favorisce la fusione di preesistenti unità amministrative al fine di semplificare la complessità organizzativa. Entrambe queste logiche rispondono ad un tentativo di ottimizzazione delle risorse in una situazione caratterizzata da una pressante crisi fiscale e alla necessità di un maggiore coordinamento tra diversi ambiti istituzionali in una situazione di crescente complessità. 4 Si parla di managerializzazione della pubblica amministrazione, riferendosi a quell’insieme di concetti e tecniche che auspicano il funzionamentoe delle amministrazioni attraverso gli stessi principi gestionali delle aziende private, al fine di ottenere maggiori livelli di efficacia, efficienza ed economicità. L’Italia si è ispirata al paradigma del New Public Managment che ha contraddistinto le riforme dei paesi di tradizione anglosassone nel periodo dei governi Tatcher e Reagan (anni ’80) avviando una serie di riforme, a partire dagli anni ’90, volte a ristrutturare la pubblica amministrazione. 5 Nel nuovo quadro monetario europeo i tassi di cambio e di interesse sono sempre meno suscettibili di manipolazione da parte delle amministrazioni nazionali e le svalutazioni competitive sono improponibili. Per questo motivo, oggi, tali politiche non sono facilmente attuabili e aprono dei margini di incertezza cui è necessario trovare risposta attraverso altri strumenti di gestione che puntano sempre più verso la crescente integrazione di competenze, discipline, attori, livelli di governo ecc. (Quaderni Formez, 2002, n. 6).
10 10
que s to s e ns o, le politiche inte grate , e la pre dis pos izione di proge tti inte grati, hanno l’ambizione di fonde re approcci, politiche , compe te nze e s ape r i dis ciplinar i dive rs i, pe r compe ns are la parzialità de ll’azione programmator ia che , come l’e s pe r ie nza ins e gna, non può contare s u una razionalità s inottica. Sulla bas e di que s ta pre me s s a, il conce tto di “politica inte grata” vie ne oggi da più par ti r ipre s o come s trume nto di ge s tione de lla comple s s ità e as s ociato a dive rs e proble matiche come , ad e s e mpio, que lle de i s is te mi inte grati (inte nde ndo alte rnanza s cuola- lavoro), e que lle re lative all’inte grazione inte r - organizzativa e /o inte r - is tituzionale (inte nde ndo con que s to la ne ce s s ità di un raccordo maggiore tra s is te mi, is tituzioni, organizzazioni e cc.), s i accompagna, dunque , a l nuovo mode llo a re te de lla pubblica amminis trazione . L’aus picio ins ito in que s to nuovo modo di pe ns are gli s trume nti di policie s cons is te ne l ge s tire in manie ra più e fficace e coe re nte proble mi comple s s i –come que lli le gati ad nuovo w e lfare , a l te r r itor io, a lla diffic ile conne s s ione tra s is te ma formativo-e ducativo e s is te ma e conomico e cc.- e /o proce s s i ar ticolati.
Lo s copo di que s ta r ice rca è que llo di te ntare la compre ns ione de l conce tto di “politica inte grata”: da dove nas ce , come s i s viluppa, che s facce ttature vie ne ad as s ume re , che s e ns o gli s i a ttr ibuis ce oggi. Il conce tto di inte grazione è tornato alla r ibalta s ulla s pinta de lle pre s s ioni e de i mutame nti avviati con il proce s s o di globalizzazione che , abbatte ndo ogni confine s pazio- te mporale , c i imme tte in un conte s to caratte r izzato da una compe tizione s e mpre più acuta in ogni campo e in ogni s e ttore , dal pullulare di a ttor i, dalla framme ntazione de lle conos ce nze e de lle compe te nze . Al te mpo s te s s o, s i inte nde compre nde re s e la nuova r iforma de ll’appre ndis tato (L. 196/97), può e s s e re ins cr itta in que s to nuovo e non me glio de finito s trume nto di policy rappre s e ntando un avanzame nto anche r is pe tto alla s tagione de lle politiche attive . L’obie ttivo è que llo di ve r ificare che cos a contraddis tingue una politica inte grata . Se nz’altro que s ta ha e ffe tti dire tti e d e vide nti s ullo s tato di a ttuazione che s i manife s ta e s s e nzialme nte ne lla r ice rca di line e di coordiname nto or izzontale e ve r ticale , ma è inte re s s ante compre nde re s e , e in che modo, incide ad un live llo macro (de cis ionale /proge ttuale ), ad un live llo me s o (s trutture di imple me ntazione ) e ad un live llo micro (ne lle pratiche de gli a ttor i). In altr i te rmini, s i vuole capire s e s i re gis tra una re ale contaminazione di s e ttor i di policy tradizionalme nte dis tinti che concorrono s u obie ttivi comuni (politiche de l lavoro, de lla formazione , s ociali, de llo s viluppo te r r itor iale ) pe r ve r ificare , quindi, s e , e come , avvie ne , a que s to live llo, un proce s s o di appre ndime nto organizzativo che conduce alla re alizzazione di nuovi s trume nti pe r la ge s tione di diffe re nti proble mi. Gli s viluppi, s ia te or ici che e mpir ici, hanno ancora poco cons ide rato que s to filone di analis i e gli as pe tti comple s s i ad e s s o conne s s i. L’obie ttivo di que s ta r ice rca è volto a compre nde re que s to nuovo e ancor poco de finito
11 11
filone di policy a l fine di valutare s e , e fino a che punto, s i re gis tra la ambita inte grazione . L’ipote s i di fondo è che la ne ce s s ità di ge s tire fe nome ni s e mpre più comple s s i abbia modificato s e ns ibilme nte la re altà e le pratiche de gli a ttor i (ad un live llo me s o e ad un live llo micro) me ntre ancora poco r ie s ce ad incide re ad un live llo macro, de cis ionale -proge ttuale , ove s i s conta pr incipalme nte la difficoltà di abbandonare , o modificare , s trume nti noti e be n te or izzati da un punto di vis ta e conomico e giur idico, pe r las ciare s pazio a s trume nti nuovi che chiamano in caus a nuove e più comple s s e dime ns ioni come , ad e s e mpio que lla s ocio- culturale e intimo- s ogge ttiva.
Me ntre alcuni s tudi s ono s tati s volti s ui patti te r r itor iali pe r e vide nziare i fa ttor i di s ucce s s o di que s to par ticolare tipo di policy , fondata s ul pr incipio de ll’accordo e s plicito, ancora poco è s tato fatto re lativame nte alle nuove politiche de l lavoro che pre ve dono una for te inte grazione con i s is te mi e ducativo- formativi. E’ pe r que s to motivo che il focus di que s to lavoro s i conce ntre rà s ul nuovo appre ndis tato il quale pre ve de s ia una for te inte rconne s s ione tra mome nto formativo e mome nto lavorativo, s ia una inte ns a coope razione tra attor i dive rs i.
La s ce lta de ll’appre ndis tato è motivata dal fatto che , s e condo noi, que s t’ultimo, s i pre s ta molto be ne a cons ide rare il proble ma de ll’inte grazione pe r due ordini di fattor i. Innanzitutto, pe rché s i tra tta di un is tituto molto antico che già ne lla pre ce de nte ve rs ione (le gge 25/1955) pre ve de va que s to contatto tra mome nto te or ico e mome nto pratico-ope rativo, anticipando, di fatto, la que s tione de ll’inte grazione . Gli a ltr i provve dime nti (s tage , FP- s cuola, IFT S e cc.), a l contrar io, s ono tutti di re ce nte promulgazione . In s e condo luogo, pe rché l’is tituto de ll’appre ndis tato r iunis ce , in ragione de l pr incipio di a lte rnanza s cuola-lavoro, s e ttor i di policy molto difformi tra loro: politiche occupazionali (pe r la que s tione de lle conve nie nze ), politiche e ducativo- formative (pe r la par te di formazione te or ica), politiche pe r l’or ie ntame nto (pe r il ruolo di me diazione - archiviazione s volto dai nuovi s e rvizi pe r l’impie go), politiche pe r lo s viluppo locale (pe r quanto r iguarda l’attivazione di re ti e par te nar iati locali), politiche s ociali (pe r le cate gor ie s vantaggiate , in que s to cas o, i giovani in obbligo formativo). E il nos tro inte re s s e s i ins inua propr io in que s to s pazio proble matico cre ato dalla ne ce s s ità di s tabilire nuove forme di raccordo tra que s ti s e ttor i. Infatti, dare un caratte re s is te mico e di re te alle politiche attive de l lavoro cos tituis ce una condizione pre liminare pe r il loro s ucce s s o.
E’ ampiame nte diffus a ormai la cons ape vole zza che l’affiname nto de lla s trate gia di inte rve nto comporti uno s viluppo ne l te ntativo di intre cciare le attività di formazione profe s s ionale con i s e rvizi pe r l’impie go e con le mis ure di politica attiva de l lavoro. Nonos tante non s iano tuttora chiar i i ne s s i tra s viluppo e conomico, s os te gno all’occupazione e formazione
12 12
(Zucche tti, 2001), s e mbra utile te ntare uno s forzo inte rpre tativo in ta l s e ns o. Que s to pe rché tutte le più impor tanti is tituzioni politico- e conomiche s opranazionali te ndono a cons ide rare s trate gica la formazione de lle r is ors e umane pe r il contr ibuto che può ar re care alla cos truzione de lla r icche zza di un Pae s e , e , in vir tù di c iò, guardano al s is te ma duale te de s co (capitolo quattro) come mode llo, pur ne lla cons ape vole zza che ne s s un s is te ma e ducativo può e s s e re tras fe r ito da un conte s to all’altro pe rché frutto di una pre cis a e voluzione s tor ico- s ociale e d e conomica.
Il nos tro s i configura come un lavoro di r ice rca a fini de s cr ittivo-inte rpre tativi, a que s to s copo, accanto alla me todologia di tipo s tatis tico quantita tivo volta alla r icos truzione de l conte s to in cui ope r iamo6, la me todologia d’indagine s i è avvals a de lla cos truzione di gr iglie di inte rvis ta s e mis trutturate che , par te ndo da te matiche ge ne rali, s ono s tate , via via , focalizzate s ulle dime ns ioni più r ile vanti me s s e in luce dagli s te s s i inte rvis tati. Pur tuttavia , r ite nuto ormai s upe rato l’approccio top- dow n, s e condo il quale la conformità alla norma as s icura una buona r ius cita de ll’inte rve nto, r ite niamo impor tante , in fas e di valutazione de gli out-come s , r ifarci agli obie ttivi pre fis s ati dai policy mak e rs , pur s e nza r inunziare ad un’analis i goal fre e de i r is ultati, a tte nta , quindi, anche agli e ffe tti impre vis ti provocati dall’inte rve nto me de s imo (Stame , 1998). Pe r favor ire una conos ce nza a tutto campo de l nos tro ogge tto di s tudio, a par tire dagli a ttor i, dalle loro motivazioni, dalle loro logiche e cc., e re alizzare un’atte nta e minuzios a analis i di proce s s o s i inte nde pr ivile giare un approccio fe nome nologico e pre nde re in pre s tito alcuni s trume nti de lla migliore tradizione e tnografica da applicare allo s tudio de lle politiche pubbliche (os s e rvazione par te cipante , os s e rvazione non par te cipante , diar io di bordo, inte rvis te ). L’analis i di proce s s o ha te s o a r icos truire lo s ce nar io in cui s i s viluppa l’imple me ntazione , il frame s ocio- e conomico-burocratico, il re ticolo di a ttor i e le re lazioni e s is te nti tra loro.
Il lavoro s i ar ticola ne l s e gue nte modo. Ne l pr imo capitolo s i è ce rcato di me tte re a fuoco il proble ma di r ice rca e d il frame te or ico me todologico di r ife r ime nto por tando alla luce gli e le me nti di novità che caratte r izzano la s ocie tà de ll’informazione e de lla conos ce nza e come que s ti hanno profondame nte cambiato tutti gli e quilibr i, i rappor ti e i s is te mi di re lazione a noi noti; gli e s iti di ta le cambiame nto manife s tano e ffe tti e s tre mame nte impor tanti anche pe r i s is te mi formativi, minandone alla radice il tradizionale impianto tradizionalme nte autore fe re nziale e s pinge ndo ve rs o un proce s s o di inte grazione de i s is te mi e ducativo- formativo e occupazionale che s i traduce in mome nti di a lte rnanza te or ico- pratica, e l’appre ndis tato rappre s e nta il più ambito mode llo di r ife r ime nto. Si è ce rcato, dunque , di s pie gare come s i è modificato l’impianto te or ico di
6 A questo proposito si è fatto ricorso tanto ai dati secondari forniti dall’ISFOL attraverso i monitoraggi nazionali: Rapporto sull’apprendistato, 1999; Rapporto sull’apprendistato, 2000; Il nuovo apprendistato, 2001, quanto a quelli regionali forniti dall’Agenzia Lazio Lavoro.
13 13
r ife r ime nto che is pira le due dive rs e le ggi (L. 25/55 e L. 196/97) in re lazione alle profonde modificazioni de l conte s to di r ife r ime nto, pe r por tare alla luce , infine , i re s e arch points che hanno guidato tutto il lavoro di r ice rca s ul campo.
Ne l s e condo capitolo, inve ce , s i è ce rcato di me tte re a fuoco le cons e gue nze che que s ta trans izione ha s ull’inte ro s is te ma e ducativo-formativo, ope rando, dappr ima, una bre ve r icos truzione de l cambiame nto di paradigma che s otte nde alla nuova vis ione de l mondo ne lla s ocie tà pos t-mode rna, caratte r izzata da un nuovo modo di inte nde re e di vive re il lavoro in ogni s uo as pe tto. E, in s e condo luogo, ope rando una r icos truzione de lle te or ie che , in que s ti anni, s i s ono avvice ndate ne l dar conto de l rappor to tra s is te ma e ducativo e s is te ma produttivo, pe r conce ntrare l’atte nzione s u alcuni te mi ce ntrali ne l nuovo dibattito: or ie ntame nto, r is ors e umane , compe te nza e cc.. Ne l te rzo capitolo, s i è r ite nuto oppor tuno te ntare una r icos truzione s ia de l dibattito che ruota attorno al conce tto di politiche inte grate - ce rcando di me tte re in e vide nza cos a s i inte nde e come s i s ia affe rmato in Italia ta le dibattito all’atte nzione de i politic i e de gli s cie nziati s ociali- s ia il modo in cui vie ne conce pito il nuovo “s is te ma inte grato” - contraddis tinto da una for te inte rconne s s ione tra formazione - s cuola- lavoro allo s copo di cos truire una re ale e coe re nte alte rnanza tra mome nto formativo te or ico e mome nto formativo pratico- ope rativo. Infine , ne l quar to capitolo s i è ope rata tanto un’analis i s tor ica e comparata de ll’appre ndis tato face ndo r ife r ime nto ad una clas s ificazione e laborata dall’OECD (2000) s ulla bas e de lla ce ntralità de l conce tto di pathw ay (s e ntie ro), quanto una le ttura quantita tiva volta ad e vide nziare la parabola de lla r iforma in atto in Ita lia ; tutto ciò, a l fine di me tte re a fuoco le cr itic ità e i proble mi ancora ir r is olti. Pe r conclude re , ne l quinto capitolo, s i pre s e ntano gli e s iti de lla r ice rca e mpir ica s volta ne l Lazio allo s copo di ve r ificare come s i è s viluppato in que s ta re gione il proce s s o di tras lazione e il te ntativo di cos truire un s is te ma contraddis tinto da for ti inte rconne s s ioni inte rne . La s ce lta de l campo è s tata de ttata s ia dalla par ticolare dis ponibilità de gli a ttor i locali ne i r iguardi de ll’inte rve nto di r ice rca, s ia dal fatto che il proge tto ide ato pe r attivare il nuovo quadro inte rorganizzativo ha r ice vuto il pre mio “Re gionando” al Forum de lla P.A 2002, come uno de i miglior i proge tti pe r azioni di s is te ma. E la pos s ibilità di pote r os s e rvare da vicino il dive nire di un proce s s o re ale che nas ce va s otto i miglior i aus pici s i pre se ntava come un campo di r ice rca par ticolarme nte inte re s s ante .
15 15
PRIMA PART E
CAPITOLO UNO IL PROBLEMA DI RICERCA:
APPRENDIST AT O E FORMAZIONE EST ERNA
Il c ambiame nto ipo tizzato Il s is te ma formativo ita liano attrave rs a un mome nto di grande tras formazione che va ne lla dire zione di una maggiore autonomia r is pe tto al gove rno ce ntrale e de lla promozione di parte ne rs hip a l fine di fornire r is pos te più ade guate e mirate alle diffe re nziate e s ige nze de i te s s uti s ocio- e conomici locali. In altre parole , il me rcato de l lavoro e il s is te ma e ducativo ita liano, s ulla s cia de lle indicazioni comunitar ie , s ono indotti a pe rcorre re la via de ll’inte grazione e de lla fle s s ibilità. All’or igine di que s to mutame nto vi è una s e r ie di r iforme varate a par tire dalla s e conda me tà de gli anni ’90 di cui le più impor tanti s ono te s e a: ♦ introdurre nuovi is tituti di “fle s s ibilità controllata” e “s ovve nzioni al me rcato” pe r favor ire una r ipre s a e conomica e d occupazionale (Le gge 196 de l 24.06.1997, e s ucce s s iva Le gge Biagi, apr ile 2003); ♦ r iorganizzare l’inte ro as s e tto formativo al fine di accorciare il gap r is pe tto al me rcato de l lavoro e ai più avanzati s is te mi e ducativi e urope i e , infine , favor ire un’inte grazione tra pe rcors i dive rs i (s cuola di bas e e formazione profe s s ionale ) e s is te ma e conomico; ♦ cre are un s is te ma di accompagname nto (or ie ntame nto) alla formazione e al lavoro attrave rs o il pote nziame nto de i s e rvizi pe r l’impie go; ♦ favor ire il proce s s o di de ce ntrame nto con il pas s aggio alle Re gioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in mate r ia di politiche attive pe r il lavoro, pe r incoraggiare azioni di s viluppo a live llo locale (L. 59/97, De cre to attuativo n. 469 de l 27.12.1997). Que s to comple s s o te ntativo di “r is trutturare ” l’inte ro as s e tto e ducativo-formativo- lavorativo, nonché le re lazioni e s is te nti tra i dive rs i s ottos is te mi, è s tato pe rs e guito attrave rs o nume ros i inte rve nti. Que llo che inte re s s a l’ambito di s tudio qui indagato s i r ife r is ce alla r iforma de ll’appre ndis tato (le gge 196/97) volta a re cupe rare e valor izzare la formazione e s te rna pe r gli appre ndis ti pe r pre parare lavorator i che me glio s iano in grado di r is ponde re alle nuove r ichie s te di un me rcato de l lavoro contraddis tinto da for ti innovazioni. Lo s tudio di que s ta r iforma s i re nde par ticolarme nte inte re s s ante pe rché s i pre s e nta come l’e s ito de i profondi mutame nti che hanno inve s tito la s ocie tà mode rna ne l pas s aggio da un s is te ma organizzativo tipicame nte tay lor- fordis ta, ad uno pos t- fordis ta e pos t- tay loris ta (come s i potrà me glio os s e rvare ne l s e condo capitolo).
16 16
Que s to pas s aggio s i caratte r izza pe r una radicale tras formazione de l lavoro in te rmini di conte nuti, di proce s s i, di re lazioni, con r ipe rcus s ioni e vide nti s ul lavoratore cui s ono r ichie s te conos ce nze /compe te nze e abilità s e mpre maggior i. Come è noto, è propr io in vir tù di ta li tras formazioni che s i è s viluppato, ne gli ultimi ve nti anni, tutto un dibattito, s ia a live llo s cie ntifico che politico, re lativo alla s ocie tà de lla conos ce nza, al life long le arning , a lla te or ia de lle r is ors e umane , al “s is te ma inte grato” di formazione lavoro e cc.. In que s ta pros pe ttiva, s ono mutati e vide nte me nte anche i modi di conce pire e formare le qualifiche profe s s ionali, pr ima tra tutte propr io que lla de ll’appre ndis ta . Paralle lame nte , s i è s viluppato un inte ns o confronto s ia a live llo s ovranazionale che , s ucce s s ivame nte , a live llo nazionale , volto ad individuare nuovi s trume nti di policy e di gov e rnance più idone i a ge s tire proble mi comple s s i come que lli che inve s tono la s ocie tà mode rna e , in par ticolare , le politiche occupazionali. Come s i e s amine rà ne l capitolo tre , infatti, s i è ve nuta affe rmando, anche s e in manie ra ancora ince r ta e d ambigua, una te nde nza che s os pinge ve rs o il te ntativo di favor ire l’inte grazione di s e ttor i di policy pr ima dis tinti propr io pe r ge s tire le conne s s ioni tra inte rve nti, mate r ie , dime ns ioni dive rs e de lla s te s s a mate r ia , live lli e cc.. Di qui, il te rmine (non me glio de finito) di politiche inte grate , le quali dovre bbe ro s e rvire a far dialogare me glio s is te mi che , di fatto, ne lla continge nza quotidiana, vivono un continuo incontro- s contro. Un inte rve nto “inte grato” s u que s te conne s s ioni, s u que s ti s nodi proble matici, s e pos s ibile , por te re bbe una migliore s oluzione de i proble mi e d una r iduzione de i cos ti s ociali (Donolo, 2002). La r iforma de ll’appre ndis tato, come s i avrà modo di os s e rvare , r ie ntra propr io in que s to filone di inte rve nti in quanto è frutto di una inte ns a s tagione di conce r tazione volta a favor ire un proce s s o di inte grazione tra formazione - lavoro attrave rs o il s is te ma de ll’alte rnanza te or ico- ope rativa. E’ inte re s s ante e vide nziare , inoltre , che , in vir tù de i noti proce s s i di is omorfis mo7 s i as s is te (come s i potrà analizzare ne l IV capitolo) a live llo inte rnazionale , nonos tante le pe culiar ità che contraddis tinguono ogni s ingolo pae s e , a un proce s s o di conve rge nza ve rs o que s to te ntativo di inte grazione inte rs is te mica s os pinto, dall’alto, dalle indicazioni comunitar ie che agis cono da ve ttore normativo e , dal bas s o, dalla te nde za de l le gis latore ad e mulare e s pe r ie nze di s ucce s s o. Ed, in que s to cas o, nonos tante tutte le pos s ibili cr itiche , il s is te ma te de s co duale (ve di capitolo 4 de l pre s e nte te s to) re s ta ancora un punto di r ife r ime nto s aldo s e non altro pe r i buoni r is ultati che fornis ce , tanto in te rmini di a lta qualificazione de gli ope rai, quanto in te rmini di dis occupazione , s oprattutto que lla giovanile .
7 Sono Meyer e Rowan a parlare di isomorfismo riferendosi al crescente conformarsi delle organizzazioni all’ambiente istituzionale circostante. Le organizzazioni operano in contesti altamente istituzionalizzati che stabiliscono regole e criteri di comportamento cui le stesse organizzazioni devono attenersi. Di conseguenza, questa pressione alla conformità conduce ad un isomorfismo tra organizzazione e ambiente. Per un approfondimento si veda Meyer e Rowan (1977).
17 17
Dalla le g g e 2 5 / 1 9 5 5 alla L. 1 9 6 / 9 7 : pre s uppos ti te oric i e mode llo e c onomic o - organizzativo
Il varo de lla Le gge 196/97 può e s s e re le tto come e s ito di un proce s s o multi- dime ns ionale che s e mbra e s s e re s timolato dalle pre s s ioni e s e rcitate da:8 ♦Par ti Sociali in re lazione alla ne ce s s ità da par te de l Gove rno di pre nde re pos izioni for ti e s ignificative pe r combatte re la piaga de lla dis occupazione , s oprattutto giovanile 9; ♦Unione Europe a che s tabilis ce le line e di inte rve nto comuni che i s ingoli pae s i de vono r is pe ttare pe r quanto conce rne le politiche pe r il lavoro e que lle formative 10 ; ♦progre s s ivo s ce mare de lle r is ors e finanziar ie de s tinate all’attività r icorre nte in vis ta di un incre me nto de lle attività a bando FSE che ora vie ne me s s o in cr is i dal pros s imo allargame nto de lla Unione Europe a che s arà caratte r izzato da una re vis ione de i cr ite r i di dis tr ibuzione finanziar ia; ♦e s ige nza di favor ire un maggior raccordo con la re altà produttiva locale ; ♦ne ce s s ità di giunge re ad un ge ne ralizzato migliorame nto e ampliame nto di s e rvizi formativi qualificati s u tutto il te r r itor io ne lla logica de l life long le arning . Profondi cambiame nti s ono alla bas e de ll’impianto te or ico e conomico che s otte nde alla ide azione de lle due le ggi re lative all’appre ndis tato: la pr ima de l 1955 e la s e conda de l 1997.
L’impianto te or ico che is pira la L. 25/55 è fondato s u una re lazione funzionale e line are tra e ducazione e lavoro e da un impianto e conomico produttivo tipicame nte fordis ta- taylor is ta caratte r izzato da un ambie nte s tabile , chius o, prote tto. Richiamando una clas s ificazione ope rata da Lipar i (2002) que s ta fas e può e s s e re de finita “mode rnis mo”. Il pr incipio e conomico che is pira que s ta vis ione è que llo de lla razionalità s inottica, as s oluta , che pre ve de la mas s ima pre ve dibilità e il miglior rappor to cos to/be ne fici. E’ e vide nte che la cornice macros ociale che or ie nta que s te conce zioni è di tipo funzionalis ta . In una vis ione di que s to tipo il s ogge tto è cons ide rato pe rfe ttame nte adattabile al s is te ma, s i pre s e nta alla s tre gua
8 Chiaramente la descrizione svolta relativamente alle origini di questo intervento di policy non vuole essere esaustiva ma limitarsi a dimostrare l’area problematica che gravita attorno alla questione. 9 Non bisogna dimenticare che la disoccupazione giovanile è parte della disoccupazione strutturale. In altri termini, essa ha radici profonde all’interno della trasformazione delle condizioni di produzione; nel fenomeno di ineguale distribuzione dei posti di formazione e di lavoro; nell’ampliamento degli accessi al la lavoro anche a gruppi sociali tradizionalmente marginali. 10 Ogni anno le singole nazioni devono presentare all’Unione Europea il piano d’azione per l’occupazione, denominato “National Action Plan”. I quattro pilastri su cui la Comunità intende agire e ai quali tutti gli interventi di riforma nazionali devono ispirarsi sono: migliorare l’occupabilità, sviluppare l’imprenditorialità, incoraggiare l’adattabilità delle imprese e dei loro lavoratori, sviluppare politiche per le pari opportunità (Conferenza sull’occupazione del Lussemburgo 1999).
18 18
de lla macchina, una s or ta di prote s i de lla s te s s a: il lavoro de ll’uomo è s tre ttame nte pre de finito e s tandardizzato. Se condo que s ta ottica vige il cr ite r io de lla mans ione parce llizzata; è la de finizione minuzios a de lla proce dura a guidare il proce s s o. Si tratta , dunque , di un mode llo me ccanicis tico de lla re altà organizzata . In un s is te ma s iffatto, l’is tituto de ll’appre ndis tato (L. 25/55), in coe re nza con l’impianto te or ico che lo is pira , cons ide ra il giovane appre ndis ta un s ogge tto da s ocializzare al lavoro attrave rs o l’imitazione de l “mas tro”. T utto il s ape re è conce ntrato ne ll’e s pe r ie nza pratico- ope rativa de ll’ope raio anziano e s olo a lui s pe tta il compito di iniziare l’appre ndis ta al me s tie re : non s e rve altro. Al giovane non è r ichie s ta alcuna par ticolare abilità o conos ce nza te or ica.
Nonos tante il tumultuos o s viluppo e conomico che ha contras s e gnato gli anni ’50- ’60, in que s to pe r iodo, s i re s ta ancora all’inte rno di un impianto fondato s u una re lazione line are tra domanda e offe r ta di lavoro, anche s e qualcos a comincia a cambiare . In que s ta s e conda fas e , che r icorre ndo alla me de s ima clas s ificazione può e s s e re de finita “ne o- mode rnis mo”, la r ichie s ta di manodope ra s pe cializzata comincia a far intrave de re la ne ce s s ità di valutare le pe rs one pe r que llo che s anno fare . Entra in gioco la s ogge ttività de ll’individuo, s alta la re gola de lla pe r fe tta adattabilità e inte rcambiabilità tra le pe rs one . Il lavoro cambia, chie de nuove conos ce nze . Non e s is te più la s icure zza de r ivante dalla pre s cr izione de lla mans ione e de lla proce dura. E’ in que s to s pazio di te mpo che s i affe rmano “vis ioni pe dagogiche più atte nte a promuove re capacità di adattame nto alle var iabilità de l s is te ma e de ll’ambie nte (logica de ll’adattame nto attivo e formazione al ruolo)” (ibide m). Ne lla nuova configurazione , l’inte grazione vie ne garantita dalla s pe cializzazione funzionale de l ruolo. Il controllo, in que s to cas o, è dato dalle norme e dai valor i che s i adde ns ano attorno al ruolo s te s s o: il mode llo di r ife r ime nto è que llo organicis tico, is pirato ancora all’adattame nto funzionale .
Con gli anni ’80, inve ce , s i rompono i ve cchi e quilibr i, s alta la logica funzionalis ta , c las s ica e line are alla bas e di que s ti mode lli. Il cambiame nto, ovviame nte , è de ttato dal s os te nuto mutame nto de llo s ce nar io e conomico-politico: dall’affe rmazione di un me rcato ape r to e ins tabile , dallo s viluppo te cnologico, dalla compe tizione s e mpre più s e r rata , dalla s colar izzazione di mas s a, dall’affe rmazione di v alori pos t- mate rialis ti e cc. (Ingle har t, 1983). Si comincia ad affe rmare la vis ione di un’organizzazione come s is te ma culturale (Morgan, 1997) ove gioca in manie ra de te rminante la s ogge ttività de ll’individuo come por tatore di cultura e is tanze propr ie . Ne lla nuova vis ione , il conce tto di ruolo pe rde la s ua vale nza pre s cr ittiva e s i ins e r is ce in una cornice re lazionale , ove l’azione è dotata di s e ns o e or ie ntata in te rmini valor iali. E’ la dime ns ione culturale , dunque , a giocare un ruolo de te rminante . In que s ta fas e , de finita dall’autore “pos t-mode rnis mo”, la cornice macros ociologica di r ife r ime nto divie ne
19 19
l’inte razionis mo s imbolico, s i diffondono “pros pe ttive pe dagogiche capaci di promuove re forme nuove di cons ape vole zza de lla re altà organizzata , e capacità di r ifle s s ione s ull’e s pe r ie nza (logica de ll’appre ndime nto)” (ibide m). Me ntre ne lle pr ime due pros pe ttive –e s oprattutto ne lla pr ima – il proble ma ce ntrale è ne ll’ordine de l s is te ma, ne lla te rza vis ione divie ne l’e quilibr io de l s is te ma me de s imo: dunque , muta l’obie ttivo. L’is tituto de ll’appre ndis tato ha attrave rs ato inde nne tutti que s ti cambiame nti, vive ndo un pe r iodo di ampia e s pans ione , s ia ne l s e ttore indus tr iale che in que llo ar tigianale , fino ai pr imi anni ’80, mome nto dopo il quale ha conos ciuto una parabola dis ce nde nte (come s i avrà modo di os s e rvare ne l quar to capitolo).
Si è dovuti giunge re al 1997, con la L. 196, pr ima che l’impianto ge ne rale de ll’is tituto de ll’appre ndis tato ve nis s e r ivis to. Que s ti anni s ono s tati s e gnati da una radicale me tamorfos i che ha modificato comple tame nte i pr incipi te or ici is pirator i de lla s ocie tà mode rna. In que s ta fas e , che potre mmo de finire “s e conda mode rnità”, è s alta ta de finitivame nte la re lazione funzionale e line are tra e ducazione e lavoro che un te mpo ave va or ie ntato i s is te mi e ducativi e lavorativi apre ndo, cos ì, una s e r ie di cr itic ità che dive nta ne ce s s ar io inte rpre tare e ge s tire .11 Come tutti s anno, infatti, è cambiato ulte r iorme nte il s is te ma e conomico mondiale , s i è affe rmato un me rcato e s tre mame nte dinamico, ape r to e fle s s ibile , pe r lo più votato ad un mode llo pos t- fordis ta e pos t- tay loris ta, e cos tre tto all’inte rno di una razionalità limitata che non cons e nte il raggiungime nto de l miglior rappor to cos ti/be ne fici, be ns ì de lla s oluzione più acce ttabile (Simon, 1969). Un me rcato ove l’organizzazione , come in un ipe r te s to, s e mbra ave r pe rs o i s uoi confini in quanto que s ti mutano continuame nte a s e conda de l punto di os s e rvazione pre s ce lto. In un conte s to s iffatto, l’organizzazione divie ne “logos de l cambiame nto” ovve ro un continuo flus s o in dive nire (Morgan, 1997). Anche la cornice macros ociale di r ife r ime nto, abbandonata l’ottica funzionalis ta , s i is pira ad una le ttura inte razionis ta de lla s ocie tà: la s ocie tà vie ne inte s a, s e condo que s ta vis ione , come cos truz ione s ociale . Una s inte s i de l ragioname nto fin qui s volto può e s s e re r ipropos ta attrave rs o lo s che ma s e gue nte (s che ma n. 1) volto a me tte re in e vide nza: cornice te or ica, mode llo di r ife r ime nto, logica, modo di conce pire il s ogge tto e pr incipio inte grativo che s otte ndono a que s te vis ioni.
11 Ed è proprio in quest’area problematica, infatti, che si colloca la nascita di tutte quelle agenzie di intermediazione publico-privata affermatesi negli ultimi 5 anni in Italia (CILO, COL, centri per l’impiego, agenzie interinali, collocamento privato ecc.), e tutti gli interventi volti a favorire un progressivo avvicinameno dei sistemi scuola-formazione-lavoro, allo scopo di ridurre la complessità della transizione scuola-lavoro e proteggere dalla crescente precarizzazione del lavoro medesimo caratterizzato oggi da numerosi passaggi.
20 20
S c he ma n. 1 :
RAZION ALIT A’ AS S OLU T A F U N ZION ALIS MO
RAZION ALIT A’ LIMIT AT A-IN T ERAZION IS MO
MODERN IS MO ordine
Mod. me ccanic is tico:
inte rcambiabilità adattame nto pas s ivo
uom o- m acchina
N EO- MODERN IS MO ordine
M. organic is tico:
s pe cia lizzazione adattame nto funzionale
uom o- funz ionale
P OS T -MODERN IS MO
e quilibrio Mode llo cultura le :
s ogge ttività
appre ndime nto
uom o- cons ape v ole
s e c o nda MODERN IT A’
cam biam e nto Mode llo de ll’ipe r te s to:
inte r - s ogge ttività
adattame nto ne gozia le uom o- ris ors a rate gica
Inte graz ione data dalla
proce dura/m ans ione
Inte graz ione data dalla pre s criz ione de l ruolo
Inte graz ione data dal ruolo (az ione dotata di
s e ns o/condiv is ione de lla re altà)
Inte graz ione data dalla de finiz ione de lle
com pe te nze
Fonte : nos tra e laborazione da Lipar i 2002
In un comple s s o di e le me nti cos ì de line ato s alta comple tame nte la vis ione di un s ogge tto pe rfe ttame nte adattabile e inte rcambiabile all’inte rno de ll’organizzazione , vie ne me no, altre s ì, la vis ione s ocio- te cnica propr ia de ll’approccio s is te mico e s i affe rma que lla di un uomo conce pito come r is ors a s trate gica in vir tù de lle s ue conos ce nze e de lle s ue pote nzialità cre ative : le s ole in grado di garantire il confronto e la s opravvive nza ne ll’e conomia globale . In mancanza di proce dure s tandard che garantis cono l’organizzazione de l lavoro, e in una s ituazione di e le vata comple s s ità e dinamicità, che s i traduce in care nza di informazioni e ne ce s s ità di adattame nto continuo, s i s e nte il bis ogno, a tutti i live lli e d in tutti i s e ttor i, di individuare un nuovo “ce ntro di gravità” attrave rs o il quale razionalizzare e r iorganizzare i s is te mi e le re lazioni tra di e s s i. Si affe rmano, dunque , due pas s par tou conce ttuali a ttorno ai quali s i te nta di r iorganizzare il dibattito s ia a live llo macro- s is te mico, s ia a live llo micro: ne lle pratiche de gli a ttor i. Que s ti pas s partou conce ttuali capaci di ope rare come “ce ntr i di gravità”, a ttivando forze ce ntr ipe te , s ono:
♦ il conce tto di inte grazione che attrave rs a tutta la s ociologia s in dai prodromi de lla dis ciplina ma che trova oggi nuova forza in dive rs e de clinazioni quali: ne tw ork , re te , par te nar iato, accordi di programma, accordi di s e ttore , conce r tazione , protocolli di inte s a e cc.. T utte que s te modalità rappre s e ntano le vie attrave rs o le quali è pos s ibile , ne ll’attuale s ocie tà, pe rs e guire un te ntativo di inte grazione , a tutti i live lli di gove rno, pe r favor ire un maggior coordiname nto tra s e ttor i, pe rs one e organizzazioni, inte rve nti e cc.;
♦ il conce tto di compe te nza (che s arà affrontato ne l pros s imo capitolo) che rappre s e nta un s upe rame nto r is pe tto a que llo di ruolo. Il conce tto di
21 21
compe te nza è un ogge tto inte rs is te mico, tras ve rs ale , e ntrato ne l le s s ico quotidiano di tutti gli a ttor i a i diffe re nti live lli, e a ttrave rs o il quale ognuno te nta un r ipe ns ame nto de l propr io as s e tto. Sulla s cor ta de l nuovo conce tto di compe te nza s i è avviata una nuova comunicazione tra i diffe re nti s ogge tti che contr ibuis ce a de line are una r innovata de finizione de lla mis s ion di c ias cuno ne l nuovo s is te ma globale .
Il proce s s o di cambiame nto avviato con la L. 196/97 è caratte r izzato da una note vole comple s s ità in quanto, come acce nnato, s i ins e r is ce ne l quadro di un dis e gno is tituzionale più vas to accompagnato, da una par te , dal s os te nuto proce s s o di de ce ntrame nto che confe r is ce nuovi pote r i a lle re gioni e agli e nti locali e che , in vis ta de lla de v olution, re nde ancor più ince r to lo s viluppo di que s ta te nde nza; e , dall’altra , dalla r iforma de i s e rvizi pe r l’impie go che ve de ne l ruolo de i nuovi ce ntr i pe r l’impie go l’attore piv ot ,: la ce rnie ra e il collante de lla comple s s a re te tratte ggiata dalla r iforma de l nuovo appre ndis tato (come s i e vince dalla figura 1).
Fig . n. 1 : Ma ppa de g li a t to ri e de l le re la z io ni de f inite da lla L. 1 9 6 / 9 7
.
Fonte : nos tra e laborazione La difficoltà che accompagna que s to cambiame nto is tituzionale dipe nde dal fatto che proce de a dive rs i live lli di profondità e in diffe re nti s fe re . Innanzitutto, agis ce s ulle compe te nze de gli a ttor i de lle quali s i r ichie de non s olo la r ide finizione ma anche , e s oprattutto, il pote nziame nto. In s e condo luogo, incide s ulla re vis ione de i piani organizzativi a ttrave rs o una r imodular izzazione de i dis cors i inte rni e de l rappor to di ogni s ingola
Stato
Regione - Province C.O.L./C.I.L.O Scuola-FP-imprese
As. categoria/OO.SS. Ispe. Lavoro/INPS/ASL/medico Famiglie/ragazzi
Centro per l’impiego
22 22
organizzazione con il s is te ma più ampio (tras formazione ruolo CFP, e nti locali, as s ociazioni dator iali o s indacali e cc.). E, infine , produce nuovi ogge tti (norme , de cre ti, mode lli, proge tti e cc.) intorno ai quali s i de vono ar ticolare i proce s s i de ll’organizzare ne l nuovo quadro is tituzionale . Que s to inarre s tabile proce s s o, dunque , conduce all’affe rmazione di nuovi linguaggi, di nuove vis ioni, di nuove s trate gie che faticos ame nte , ma progre s s ivame nte , vanno affe rmandos i ne lla pras s i quotidiana come , ad e s e mpio, i conce tti di: ne tw ork , programmazione , co- proge ttazione , co-ge s tione , conce r tazione e cc.. Sinte ticame nte s i può affe rmare che la r iforma s i ar ticola s u tre as s i fondame ntali a ttorno ai quali ruota tutta l’innovazione : • la r ivalutazione e l’obbligator ie tà de lla formazione e s te rna all’azie nda e inte s a come ins e gname nto comple me ntare ; • l’inte grazione tra s is te ma formativo- s colas tico- occupazionale ne ll’ottica de l life long le arning; • il conce tto di compe te nza. Da ciò de r iva, dunque , un cambiame nto profondo ne lle re lazioni e ne i flus s i di comunicazione che caratte r izza il nuovo s is te ma dive nuto di grande comple s s ità e di diffic ile ge s tione . Il raggiungime nto de gli obie ttivi de s ignati da que s to comple s s o inte rve nto di r iforma implica, a ll’inte rno de i s is te mi, l’introduzione di for ti innovazioni le quali s i pongono s u tre live lli. Ad un pr imo live llo –macro- abbiamo il te ntativo di r idis e gnare l’inte ro as s e tto de l s is te ma che , s ulla bas e de lla re ce nte normativa, s i compone di dive rs i s ub- s is te mi tra loro inte grati e comunicanti. Ad un live llo inte rme dio –me s o- abbiamo la r is trutturazione de i dive rs i s otto- s is te mi (e ducativo, formativo, produttivo) in re lazione al nuovo conte s to di r ife r ime nto12 . Il te rzo, infine , a live llo micro, s i r ive rs a dire ttame nte s ulle pratiche quotidiane de gli a ttor i r ichie de ndo un adattame nto13 ne i modi di lavorare , di re lazionars i e cc.. Que s ta dis tinzione , utile a live llo e ur is tico, è quanto mai diffic ile da s tabilire ne lla pratica pe rché, come ins e gnano la le tte ratura manage r iale e di s cie nza di amminis trazione de gli ultimi 20 anni, l’ambie nte inte rno e que llo e s te rno, il live llo macro e que llo micro, s i compe ne trano, dando vita a confini s e mpre più labili e mobili a s e conda de l punto di os s e rvazione che
12 I cambiamenti che caratterizzano questo rinnovato contesto sono sintetizzabili in: una maggiore promozione e un maggior coordinamento tra formazione teorica e formazione pratica; il riassetto delle nuove agenzie formative fondato sul principio della flessibilità organizzativa e del servizio; l’innalzamento dell’obbligo scolastico al 18° anno di età; la rivalutazione dell’apprendistato e della formazione professionale; il nuovo assetto fondato sull’autonomia scolastica e la possibilità di promuovere sperimentazioni locali; il passaggio da un sistema di finanziamento a pioggia ad uno basato su progetti e uno spostamento crescente verso le fonti comunitarie; la diversificazione delle fonti di finanziamento; l’introduzione del principio di qualità nella formazione; l’apertura al contesto e al mercato; l’avvio di una progressiva integrazione tra sistemi formativi diversi; l’individuazione di figure di coordinamento intermedio definite figure di sistema o di processo; l’avvio di un dialogo con la controparte economica al fine di trovare strategie di collaborazione; l’avvio di strategie di riorganizzazione interna, di azione e di apprendimento; l’interpretazione e l’interiorizzazione del cambiamento. 13 L’ottica cognitivista, infatti, insegna che al livello micro le istituzioni si costruiscono e si rinnovano continuamente attraverso i processi di interazione.
23 23
s i as s ume 14 e , s oprattutto, or iginando un infinito circolo di azioni e re troazioni in un fe e dback continuo dove l’una influe nza l’altra . L’innovazione os s e rvata, dunque , come ogni attività di policie s , implica l’introduzione di for ti e le me nti di cambiame nto. Il de ce ntrame nto, da una par te , inve s te la r iorganizzazione e la re golazione de lle re lazioni de ll’inte ro me rcato de l lavoro; dall’altra re nde ne ce s s ar ia la r iorganizzazione inte rna de lle is tituzioni a cui ve ngono de mandati que s ti pote r i, in r ife r ime nto ai conte s ti in cui ope rano (Re gioni, Provincia , Comuni, Enti locali). Il nos tro inte re s s e s i ins inua in que s to proce s s o di inte grazione tra s is te ma formativo e s is te ma e conomico, a l fine di r icos truire il dibattito nazionale e d inte rnazionale , i dis e gni di inte rve nto me s s i in atto dai dive rs i a ttor i in gioco, i policy le gacy che hanno pe s ato s ull’inte ra r iforma, e ve ntuali re s is te nze o s trate gie di azione me s s e in atto dai dive rs i a ttor i, pe rcors i di appre ndime nto locali, par te nar iati, s tili di le ade rs hip e me rge nti, adattame nto alle line e guida de lla UE, conflittualità e cc. 15 .
14 Anche se in questa sede non è il caso di soffermarci su questo argomento ci sembra opportuno sottolineare la complessità della relazione tra ambiente e sistemi organizzati, la quale è stata ampiamente studiata nell’ambito della sociologia dell’organizzazione. Soltanto per citarne alcune possiamo ricordare le ricerche di Pugh (1969) e Hickson (1969) che non riescono a liberarsi di una visione statica; quelle di Burns e Stalker (1961) che presentano due modelli di adattamento all’ambiente: ”meccanico” e ”organico”; Emery e Trist (1965) che distinguono quattro tipi di ambiente: ”calmo e disperso”, ”calmo e compatto”, ”perturbato e reattivo” ”turbolento”; Lawrence e Lorsch (1969) che studiano la differenziazione e l'integrazione organizzativa. II merito di queste ricerche è quello di portare alla luce che l'ambiente non si presenta come un campo unificato ed omogeneo, bensì è costituito da una molteplicità di campi frazionati che trasmettono messaggi fluttuanti, ambigui e, spesso, contraddittori Per un approfondimento circa la complessa relazione tra organizzazione-ambiente si consiglia la lettura della suggestiva antologia prodotta da Stefano Zan (1988) il quale ha operato una circostanziata ricostruzione dei filoni di analisi emergenti che hanno completamente modificato il modo di concepire e studiare l’organizzazione. Solo a titolo di citazione tali filoni possono essere sintetizzati in: analisi longitudinale, analisi interorganizzativa, economia organizzativa, cultura e apprendimento organizzativo, decisioni ambiguità e logiche di azione organizzativa. 15 Per una migliore comprensione di questa complessa problematica è opportuno rifarsi ai contributi della letteratura manageriale e di scienza dell’amministrazione che evidenziano come il cambiamento sia sempre un processo costruito su ”innesti”, a questo proposito sono particolarmente utili anche i contributi teorici apportati dal Neoistituzionalismo, che riconosce alle istituzioni una sorta di autonomia rispetto alle forze sociali e politiche, grazie alla loro capacita di definire valori, norme, ruoli, identità: ”...le istituzioni forniscono ordine politico e influenzano cambiamento...” (March, Olsen, 1989, p. 11). Il mutamento ipotizzato - e sperato dai decisori- infatti, si scontra con le logiche interne alle organizzazioni medesime, le quali, reinterpretando il cambiamento, gli attribuiscono nuovi e diversi significati, immettendo nel processo stesso delle disfunzioni. In altre parole, la volontà iniziale viene ad alterarsi, si assiste ad una trasformazione nella fase di messa in opera, dovuta a logiche e interessi interni sui quali gli esecutori possono far valere il loro potere (Hogwood, Gunn, 1984). Infatti, nell’agire, più che nel decidere, si riscontra una sorta di paralisi burocratica tutta interna agli apparati amministrativi e viziata da accomodamenti locali. Non bisogna trascurare, a questo proposito, nemmeno la componente cognitivo-simbolica degli operatori coinvolti nel cambiamento, il livello di permeabilità culturale del sistema, poiché alcune resistenze possono derivare anche da una chiara contrapposizione tra i valori promossi e quelli istituzionalizzati e sedimentati in seno all’organizzazione (D’Albergo, Vaselli, 1997). Questa sorta di inerzia organizzativa, largamente confermata dalla ricerca empirica degli ultimi venti anni, porta ad abbandonare una logica top-down, fondata sul primato della gerarchia, per sposare una visione più realistica che restituisce alla base tutta la sua vitalità, in special modo con le policies per il decentramento. Inoltre, con i movimenti neoconservatori che si sono sviluppati a partire dalla crisi economica che negli anni ’70 ha investito tutti i paesi occidentali si è affermato un importante filone di idee che spinge verso lo smantellamento dello Stato sociale e la riduzione del peso gestionale che questo comporta (Ferrera, 1993; Meny Thoenig, 1991). Sulla scia della crisi del Welfare State e dell’insoddisfazione generale è venuta maturando 1’idea che i governi locali siano più efficienti e rispondenti alle esigenze territoriali. Secondo questa prospettiva la dimensione ristretta di governo sembra essere in grado di assicurare una maggiore partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica. Molta della letteratura scientifica di cui possiamo avvalerci si è concentrata proprio sull’implementazione del decentramento e delle relative distorsioni o problematiche che questo comporta, evidenziando tipologie diverse di governo: modello clientelare, modello economico, modello Welfare State (Goldsmith, 1991). Poiché anni di ricerca empirica hanno messo in luce lo spettacolare sfasamento che si verifica tra teoria e pratica, in merito alle politiche per il decentramento (Mayntz, 1979), al nostro scopo è importante analizzare come questo è stato attualizzato nel nostro paese e, pur senza rifarne la
24 24
Il quadro te or ico di r ife r ime nto, dunque , s i pre s e nta r icco e d ar ticolato, iniziando dalla nuova pros pe ttiva di analis i de line ata dalla te or ia de lla tras lazione (Callon, 1986, 1991 Latour , 1997, 1998) fino a giunge re alle ultime più re ce nti te or ie de lle organizzazioni fondate s ulle re lazioni inte r roganizzative (Be ns on, 1988; We ick, 1976) le s trate gie di azione (Crozie r e Fr ie dbe r , 1977; Fr ie dbe rg 1994) la re lazione con il conte s to di r ife r ime nto e l’appre ndime nto organizzativo e is tituzionale (Agryr is , e Shon, 1998; Nonaka, 1991, 1994, 1997; Be nne t e Howle tt, 1992; Hall, 1993; May, 1992).
Line e di analis i e quadro te oric o me todo log ic o La de libe razione di una policy non s i ve r ifica dall’oggi al domani ma è frutto di un proce s s o che ne l cors o de l te mpo ne ha s e gnato la maturazione 16 . Pe r que s to motivo, s i è r ite nuto ne ce s s ar io compie re uno s forzo di r icos truzione de l conte s to in cui s i è s viluppata la Le gge 196 e , a l te mpo s te s s o, r is alire a tutti i pre ce de nti provve dime nti che pos s ono e s s e re collocati in que s to filone (Patto pe r il lavoro de l 24.09.96, D.L. n. 469/97, Patto s ociale de l 1998, Libro bianco 2000, Mas te r Plan, e cc.), pe r analizzare il c lima in cui s i è ve nuta e volve ndo la s ce lta in que s tione e s e guirne il proce s s o di “traduzione ”17 . Lo s forzo pr ior itar io, dunque , è que llo di proce de re paralle lame nte s u tre dis tinti live lli di analis i. Ad un live llo macro r icos truire il frame a ll’inte rno de l quale l’inte rve nto s i e volve e , s ucce s s ivame nte , os s e rvare il modo in cui ve ngono a dialogare i dive rs i s is te mi. Ad un live llo me s o indagare s ulle s trate gie me s s e in atto dalle s trutture di imple me ntazione locale , s ul tipo di le ade rs hip affe rmatas i e s ulle compe te nze ne ce s s ar ie alla re alizzazione
storia, vedere come vi si innesta il Decreto Legislativo n. 469 del 23.12.97 che stabilisce il conferimento di funzioni e competenze alle Regioni e agli Enti Locali in materia di lavoro. 16 La complessità dell’oggetto di studio rende necessario suddividere, a livello puramente teorico, il campo di osservazione in tre distinti piani tra loro correlati. A questo scopo, può essere utile ricorrere ad un escamotage largamente in uso nello studio delle policies, quello di considerare la politica pubblica come un sistema d’azione, così da distinguere sistema di attori, attività e processo. Parlare di sistema di attori pone in evidenza il fatto che l’autorità di governo, seppure può essere considerata l’attore principale, non è il solo, ma si muove in stretta interdipendenza con altri attori, quali possono essere i gruppi di pressione, i cittadini, i burocrati ecc., tra i quali si innesca una comunicazione circolare che non è mai definitiva perché grazie al feedback che si instaura tra le parti si assiste ad una continua riformulazione dei problemi e delle aspettative. Con il termine attività si intendono quell’insieme di atti e non atti di risposte concrete e risposte simboliche ( Edelman, 1976) che costituiscono la policy. Il rischio che si corre guardando alle attività consiste nel tralasciare ciò che non si vede, ciò su cui non si è intervenuto esplicitamente, ciò su cui non si è deliberato e che, per questo motivo, più facilmente può restare nell’ombra. In ultima istanza, dobbiamo considerare il processo inscindibile dal contenuto. Il processo è l’insieme delle azioni che contraddistinguono il divenire di un evento. Processo e contenuto, infatti, sono due facce della stessa medaglia. 17 Si ritiene utile sottolineare che in una fase iniziale non si era minimamente considerata la possibilità di utilizzare la teoria della traslazione per tentare una interpretazione degli esiti di questo intervento. Ma la vicinanza al campo e il contatto con gli attori ha condotto in maniera del tutto naturale ad adottare questa prospettiva interpretativa che si è rivelata particolarmente preziosa per analizzare la complessità degli effetti che si sviluppano a livello locale nel tentativo di implementare un intervento legislativo calato dall’alto.
25 25
de lla “traduzione ” pre vis ta . Al live llo micro, inve ce , s i è te s o ad analizzare le modalità di r is pos ta de gli a ttor i colle ttivi e individuali e r icos truire il ne tw ork che s i vie ne a de line are attorno al proble ma pre s o in e s ame , in che modo que s ti a ttor i inte ragis cono, qual è il loro pe s o ne l cors o di ta le proce s s o, quali re s is te nze e dis tors ioni me ttono in atto, che ge ne re di conflitti individuali o colle ttivi s i cre ano attorno alla pos ta in gioco, cos a s ignifichi pe r i dive rs i a ttor i in te rmini di cos ti, di s ucce s s i, di as pe ttative e di pros pe ttive e cc. (Hirs chman 1975). La r ice rca qui pre s e ntata s i colloca ne l filone te or ico me todologico de ll’analis i de lle politiche pubbliche in un approccio che s i propone di le gge re , in chiave de s cr ittivo- inte rpre tativa, la parabola di que s to proce s s o di “traduzione ” re lativo alla r iforma de ll’appre ndis tato che ruota attorno al conce tto di inte grazione . Come s i cons tate rà ne i pros s imi capitoli, la que s tione de ll’inte grazione de i s is te mi e ducativo- formativi e d occupazionali r is ale alla fine de gli anni ’70 e l’Unione Europe a ha s volto un ruolo pre mine nte pe r l’affe rmazione di ta le dibattito che s i vie ne ad incontrare con il cambiame nto de l paradigma lavor is tico che va dal fordis mo a l pos t- fordis mo . Pe r affrontare corre ttame nte ta le proble ma di r ice rca occorre te ne re pre s e nte il caratte re multilive llo che contraddis tingue le politiche formative e lavorative . Infatti, s i ha a che fare con un are a di policy che può e s s e re s inte tizzata , c itando Be nadus i e Se rpie r i (2000), ne lla formula de lle 4 P.
• La macro politica che s i pre s e nta come un tre nd s is te mico che s catur is ce dai policy ne tw ork (o dai policy community ) di s e ttore nazionali e d inte rnazionali e , a cas cata , te nde a coinvolge re molte plici a ttor i is tituzionali e non18 . • La politics (inte nde ndo con que s to te rmine la politica in s e ns o s tre tto) che s i de cide ne lle are ne s pe cificatame nte de dicate , quali i par titi, il Gove rno, il Par lame nto, le Re gioni, e cc.. • La me s o politica di imple me ntazione che inte re s s a i live lli amminis trativi inte rme di che ope rano s ul te r r itor io. • La micro politica che ha come luogo di r ife r ime nto la fitta re te di re lazioni che inve s te i de s tinatar i dire tti e indire tti de l cambiame nto e che trova come fondame nto e mpir ico e normativo la fle s s ibilizzazione de l me rcato de l lavoro.
18 E’ possibile distinguere, infatti, un dibattito scientifico con più voci e più livelli: a livello sovranazionale distinguiamo le pressioni esercitate da vettori cognitivi (ad esempio l’OCSE) e normativi (CEE/Ue); a livello nazionale – sia parlamentare che governativo – ci troviamo di fronte alla trasformazione in leggi nazionali delle indicazioni e dei vincoli indotti dalla partecipazione ad un mercato unico e frutto di una politica negoziata introdotta in Italia con il primo accordo del 1993; a livello regionale, possiamo ricordare la ormai famosa L. 59/97 sul decentramento ed il correlato decreto attuativo 469/97 che ha conferito poteri e competenze alle Regioni in materia di politiche attive del lavoro, accompagnandosi all’abolizione del collocamento e alla nascita dei servizi per l’impiego trasformando equilibri e relazioni a livello locale.
26 26
T utto ciò, s i r ive rs a con grande difficoltà s ulle s trutture pe r ife r iche de lla P.A. che , nonos tante gli immani inve s time nti di r iorganizzazione in te rmini s trutturali, dotazionali, te cnologici e formativi (pe r la r iqualificazione de gli ope rator i), de ve fare i conti con un cambiame nto culturale tra i propr i adde tti che incontra re s is te nze e ambiguità. La r iforma de ll’appre ndis tato, grazie al nuovo as s e tto normativo, impone una for te inte rconne s s ione tra lavoro e formazione e , in vir tù di c iò, chiama in caus a una nuova re te , una pluralità di a ttor i, che pre ce de nte me nte non dialogavano tra loro e che , ne gli ultimi cinque anni, hanno s ubito, a colpi di de cre ti, profonde modificazioni in te rmini di conte nuti, re lazioni e modalità di lavoro. E’ propr io que s ta nuova s piccata ne ce s s ità di coordiname nto che pe me tte di inte r rogars i s ul fatto che que s ta pos s a e s s e re cons ide rata una “politica inte grata” (come s arà pre s e ntata ne l te rzo capitolo); s e nza cons ide rare , inoltre , che tale r iforma è frutto di un accordo di s e ttore de r ivante da un inte ns o pe r iodo di dialogo ne goziale tra pubblica amminis trazione e par ti s ociali. Sulla bas e di que s te pre me s s e è pos s ibile as s e r ire che il proce s s o di cambiame nto analizzato s i configura con un as pe tto bifronte . Da una par te come politica multiliv e llo che , trans itando da un piano all’altro vie ne modificandos i acquis e ndo nuovi e dive rs i s ignificati. Pe r que s to motivo, è pos s ibile ipotizzare non s olo dive rs i live lli di motivazione tra i funzionar i in ope ra ma, poiché la s te s s a policy s i ins inua ne l proce s s o di de ce ntrame nto avviato (L. Bas s anini, 59/97) è pos s ibile s upporre anche dive rs e de clinazioni de lla me de s ima le gge a live llo re gionale , con te mpi, modi e inte rpre tazioni diffe re nti. In que s ta ottica, la te or ia de lla tras lazione s i pre s e nta come un’alle ata pre zios a. Gli s tudi s ull’imple me ntazione , infatti, hanno dimos trato i limiti de lla te or ia de lla diffus ione (Roge rs , 1972) che individua il cambiame nto ne ll’e ne rgia che s i dipana a cas cata dai macro ai micro conte s ti. Una logica di que s to tipo –top dow n- e s clude a pr ior i quals ias i pos s ibilità di adattame nto e tiche ttandola come : dis tors ione , re s is te nza, inade mpie nza e r iconos ce ndo una pr ior ità al ve r tice . Al contrar io, la te or ia de lla tras lazione pe rme tte di s pos tare l’atte nzione dai cambiame nti a lla loro conte s tualizzazione , e cioè alla loro mate r ializzazione organizzativa. In que s to modo, la r iforma de ll’appre ndis tato può e s s e re cons ide rata come un proce s s o di traduz ione (ne lla doppia acce zione linguis tica e ge ome tr ica) de ll’ide a di inte grazione tra s is te mi e ducativo-formativo- produttivo, in nuove pratiche organizzative , didattiche , lavorative , is tituzionali e inte r - organizzative .19 Que s to pas s aggio implica la
19 “Traslare, ovvero tradurre in pratica, è la metafora che ci consente di proporre un modello analitico di indagine per guardare tanto ai processi interpretativi, quanto ai processi sociali e materiali che fanno viaggiare il sapere da un posto ad un altro, da un soggetto ad un altro, da una comunità ad un'altra e che lo concretizzano in una pratica situata entro uno specifico contesto organizzativo. […] [Nella teoria della traslazione ci si propone di] analizzare una riforma come espressione di un contesto globale che trasferisce conoscenza per il cambiamento attraverso un linguaggio specialistico e che questo nuovo sapere viene tradotto e acquista significato in contesti d’uso locali e che per essere trasportato da un luogo all’altro si avvale di intermediari, ossia di traduttori umani e di artefatti materiali, linguistici e comportamentali che operano la traslazione dal globale al locale e viceversa “(Landri, 2002, p. 171).
27 27
r iorganizzazione di re ticoli, te s ti, s trume nti, a ttor i che ne l linguaggio de lla te or ia de lla tras lazione ve ngono de finiti inte rme diari e c ioè attori umani e non umani che contr ibuis cono al le nto proce s s o di is tituzionalizzazione . Infatti, la r iforma de ll’appre ndis tato implica una cr is i di r iconos cime nto all’inte rno de lle organizzazioni (is tituzionali e non) re lativame nte agli e le me nti di novità: lo s gravio contr ibutivo vincolato alla formazione e s te rna, il tutor azie ndale , il tutor formativo, il tutor de l ce ntro pe r l’impie go, la ce r tificazione , la te cnologia, il flus s o di re lazioni e cc.. A que s to propos ito s i s viluppa un flus s o di tras fe r ime nto, di tras lazione de i s ape r i, de lle me todologie , de lla s trume ntazione volti a r ide finire – e a s tabilizzare - que llo che vie ne da molti de finito il “nuovo s is te ma inte grato”. Ed è propr io la r ice rca di que s te inte rconne s s ioni a rappre s e ntare il s e condo focus d’indagine , pe r ce rcare di compre nde re il modo in cui s i pe rs e gue l’inte graz ione inte rs is te mica, il raccordo e il coordiname nto inte r - amminis trativo20 . Infatti, il s ucce s s o de ll’inte rve nto, come è facile immaginare , dis ce nde dalla capacità di dialogo e di coordiname nto che que s te s trutture s ono in grado di avviare . Ne lle pagine che s e guono s i ce rca di r icos truire la r iforma de ll’appre ndis tato, a ll’inte rno de l più e s te s o quadro re lativo alle politiche inte grate , pe r compre nde re in quale dire zione s i s ono mos s i gli s forzi ne ce s s ar i a lla traduzione de lla r iforma s te s s a che pone , pr ior itar iame nte , un diffic ile proble ma di coordiname nto tra s is te mi e s e ttor i di policy tradizionalme nte dis tinti. A que s to s copo, è par ticolarme nte impor tante r icos truire l’actor ne t che s i è ve nuto a cre are attorno a que s to inte rve nto e quali a lle anze , quali compe te nze , quali logiche di azione , quali s trate gie organizzative , di volta in volta , hanno giocato a favore , o contro, que s to te ntativo di inte grazione inte rs is te mica. L’azione che ne cons e gue dà vita ad un re ticolo che può e s s e re r icos truito s olo e mpir icame nte e che ne l cas o nos tro ogge tto di s tudio può e s s e re fatto in manie ra age vole s e gue ndo il proge tto “una re te di s por te lli pe r l’appre ndis tato” pe ns ato e re alizzato dalla Re gione Lazio allo s copo di “cos truire ” un ne tw ork s tabile e dialogante –una s or ta di s truttura di imple me ntaz ione (Hje rn e Potte rn, 1981)- tra gli a ttor i e i s is te mi coinvolti ne ll’inte rve nto. Come è noto, tuttavia , accanto al conte s to d’az ione di tipo formale s i s viluppa un conte s to d’az ione concre to (Crozie r e Fr ie dbe rg, 1978) più fluido, inde finito, ove s i de finis cono la pe r tine nza de i proble mi, le re gole de l gioco, le pos te in gioco attorno alle quali gli a ttor i pos s ono mobilitars i. Ed è propr io l’analis i de lle modalità e de lle fas i a ttrave rs o cui que s to s is te ma d’az ione concre to vie ne a s viluppars i, ad affe rmars i e ad organizzars i a
20 Come evidenzia Mayntz (1979), infatti, si pone un problema di coordinamento tra i vari organi esecutivi abituati a lavorare a compartimenti stagni, poiché la gestione di uno spezzone di politica, affidata ad organi differenti, senza l’individuazione di un unico centro di responsabilità, è cosa quanto mai complessa.
28 28
live llo locale che pe me tte di analizzare i me ccanis mi di colle game nto (Mintze be rg, 1983) pre s ce lti pe r incoraggiare l’adattame nto re ciproco tra gli a ttor i coinvolti.
Re s e arc h’s po ints
I que s iti che potre bbe ro s catur ire da que s ta bre ve r ifle s s ione s ono s e nza dubbio molte plici ma la line a di analis i de lla nos tra r ice rca di tipo de s cr ittivo- inte rpre tativa inte nde muove rs i lungo due fondame ntali dire ttr ic i: P r o c e s s o d i t r a d uz io ne : la Comunità Europe a par lando di “politiche attive ”, “politiche inte grate ”, “politiche comple s s e ”, “s trate gie comunitar ie ” ha s e gnato una nuova s tagione di policie s . Le indicazioni s ull’occupazione e s ulla formazione fornite dalla Comunità e urope a s e mbrano collocars i in que s to nuovo filone di inte rve nti. L’inte re s s e di que s ta r ice rca, dunque , s i conce ntra s ulla compre ns ione di que s to proce s s o di traduzione che , a cas cata , implica l’adozione di s oluzioni e inte rpre tazioni a ta li que s iti: ♦ che s ignificati vie ne ad as s ume re il conce tto di inte grazione ne l pas s aggio da un piano all’altro? ♦ quali s ono le tappe che punte ggiano il dive nire di que s to inte rve nto? ♦ s i può par lare di una più mode rna e matura s tagione di policie s , me glio de finite come “politiche inte grate ” o s iamo di fronte all’utilizzo di e tiche tte nuove , di politiche s imboliche , s e nza s os tanziali cambiame nti ne gli s trume nti di policy ? L’ipote s i di par te nza è che manchi una e ffe ttiva “politica di rafforzame nto” de l dialogo tra le dive rs e par ti e que s to s e mbra pos s a e s s e re le tto: ne lla re s is te nza de lle impre s e a mandare i giovani in formazione e s te rna, ne llo s cars o valore che i giovani attr ibuis cono a ta le formazione , ne lla difficoltà che incontrano a dialogare tra loro le nume ros e age nzie di s viluppo s or te in que s ti anni, a var i live lli e in var i s e ttor i, pe r favor ire la cos truzione de lla re te (age nzie de l lavoro re gionali, age nzie di s viluppo te r r itor iale , e cc.). E’ cur ios o, infatti, che s trutture che nas cono pe r cos truire la re te non r ie s cano e s s e s te s s e a cos tituirs i come ne tw ork di s viluppo.
P r o c e s s o d i int e g r a z io ne : l’appre ndis tato è una de lle quattro gambe attrave rs o cui s i e roga formazione in alte rnanza ne ll’ambito de lla formazione iniziale . Come già de tto, il pr incipio s u cui s i bas a que s to inte rve nto è que llo de ll’inte grazione inte r e d intra- s is te ma. Cons ide rata la
29 29
s cars a e laborazione te or ica finora s viluppata nonos tante il fior ire di que s ta nuova modalità di inte rve nto pubblico, fondato s ulla ne goziazione , s i r itie ne utile te ntare uno s tudio circos tanziato de l fe nome no pe r capire quali fa ttor i influe nzano lo s viluppo e i r is ultati di que s ti accordi e fino a che punto s ono re alme nte capaci di produre inte grazione . Occorre in s inte s i trovare una r is pos ta alle s e gue nti domande .
♦ Quali condizioni favor is cono l’affe rmars i di un mode llo inte grativo che rappre s e nta il fondame nto di que s te politiche ?
♦ Che ge ne re di vice nde ne goziali accompagnano la s te s ura de gli accordi?
♦ L’accordo (in que s to cas o a live llo re gionale pe r la cos truzione di una re te e uno s por te llo pe r l’appre ndis tato) vie ne r is pe ttato? In che mis ura, è capace di produrre r is ultati s oddis face nti?
♦ Que s to cambiame nto fino a che punto inve s te il manage me nt , il live llo de cis ionale - proge ttuale ? ♦ Come s i ope ra que s ta e ve ntuale inte grazione di s e ttor i di policy dive rs i? ♦ Quali s e ttor i di policy s ono coinvolti s u que s to proble ma s pe cifico? ♦ Quale tipo di re lazione , comunicazione , proce s s o de cis ionale s i s tabilis ce tra que s ti s e ttor i a i tavoli de cis ionali? ♦ Quale ge ne re di vincoli/ limiti re s is te nze è pos s ibile r is contrare ? ♦ Quali fa ttor i favor is cono l’incontro di que s ti dive rs i s e ttor i di policy in te rmini di: fa ttor i politic i; s ocio- e conomici; le gis lativi; culturali e cc.? ♦ Quali gius tificazioni s i è s oliti por tare ? ♦ Quali s oluzioni pre valgono? ♦ Si può r is contrare una dive rs a s ituazione ai tavoli re gionali piuttos to che a que lli nazionali? ♦ E’ s tato individuato e cre ato un ce ntro, o più ce ntr i, di raccordo allo s copo di armonizzare i dive rs i inte re s s i in campo, al fine di re alizzare l’inte grazione aus picata? ♦ All’inte rno di que s ti nuovi rappor ti inte r- oganizzativi pre vale la dife s a de lle propr ie compe te nze o s i as s is te ad una politica di rafforzame nto de ll’inte grazione ? ♦ Si può individuare una continuità tra il piano normativo e que llo ope rativo o è pos s ibile e vide nziare de i buchi più o me no inte nzionali ne l proce s s o di a ttuazione ? ♦ Le par ti dator iali che inte re s s e hanno, s e ce l’hanno, ad as s ume re un ruolo attivo ne lla formazione ? ♦ Quale è l’impatto che me tte in atto que s ta policy a live llo locale ? ♦ Quali diffe re nze a live llo locale s i pos s ono e vide nziare in te rmini di: caratte r is tiche de l programma, compor tame nto de gli e s e cutor i e re azione de i de s tinatar i? ♦ Quali dive rs e de clinazioni as s ume a live llo re gionale e /o provinciale l’imple me ntazione di que s ta comple s s a r iforma?
30 30
♦ T ale inte grazione s i concre tizza in una coe re nza tra gli obie ttivi formativi te or ici e que lli pratic i? ♦ E’ pos s ibile ve r ificare a live llo locale un’armonizzazione de l rappor to tra me rcato de l lavoro e offe r ta formativa? ♦ Si confe rma come s trume nto di acquis izione di compe te nza r iconos ciute , r iconos cibili e ce r tificabili? ♦ Si confe rma come valida via di acce s s o al me rcato de l lavoro? E’ pos s ibile dis tingue re la s ua validità pe r s e ttor i o qualifiche dive rs e ? ♦ La conce r tazione produce cambiame nti ne lla s fe ra cognitiva de i s ogge tti locali, ne i compor tame nti e ne lle re alizzazioni concre te ?
La pre s e nza e la qualità di que s ti e le me nti pos s ono informare s ulla qualità de l cambiame nto. Ne l pr imo cas o s i tratta di ve r ificare fino a che punto s i modificano le cate gor ie inte rpre tative de i s ogge tti locali e valutare il grado di cons e ns o s ogge ttivo al me todo conce r tativo, l’ade s ione ad una vis ione s is te mica de l te r r itor io, la capacità di mis urare cos ti e be ne fici conne s s i a ll’azione colle ttiva al fine di individuare gli ambiti in cui la coope razione divie ne pos s ibile e vantaggios a. Ne l s e condo cas o s i tra tta di ve r ificare s e , e in che mis ura, e ve ntuali modifiche de lla s fe ra cognitiva s i s ono tradotte in azioni concre te .
A que s to s copo è ne ce s s ar ia una analis i approfondita de lle dive rs e fas i di vita de lla re alizzazione di una re te inte grata di s e rvizi pe r l’appre ndis tato e , in par ticolare , de lla fas e di conce r tazione pe r capire il grado di mobilitazione de i dive rs i a ttor i; la natura e l’inte ns ità de l loro coinvolgime nto; l’e s is te nza di s trate gie di coope razione o condotte oppor tunis tiche ; il modo in cui s i modifica la re te de i rappor ti fra s ogge tti locali in te rmini di s truttura, e s te ns ione , de ns ità; l’e s is te nza di protocolli di inte s a fondati s u accordi e d e ffe ttiva dis ponibilità a re alizzar li; fa ttor i cr itic i e cc.. Pre s umibilme nte , la r ice rca qui pre s e ntata non è in grado di fornire r is pos te ade guate pe r cias cuna di que s te domande ma anche una ulte r iore proble matizzazione rappre s e nta un vantaggio pe r il dibattito più ge ne rale .
31 31
CAPIT OLO DUE
SOCIETA’ DELLA CONOSCENZA, MERCATO DEL LAVORO E SISTEMI EDUCATIVI
Il c ambiame nto di paradigma Ne ll’ultimo ve nte nnio de l s e colo appe na tras cors o s i s ono radicati ne lla s ocie tà de i mutame nti di s traordinar ia impor tanza, ta li da avviare una trans izione che pe r la s ua por tata e comple s s ità è s tata paragonata ad una nuova r ivoluzione indus tr iale . T ale trans izione s e gna il pas s aggio ve rs o una nuova forma di s ocie tà che , s e ppure ancora non chiarame nte de finita , las cia intrave de re la dire zione as s unta e vie ne ormai comune me nte de nominata s ocie tà de ll’informazione e de lla conos ce nza.
Il dibattito ne l mondo politico, accade mico e s cie ntifico, s ia a live llo nazionale che inte rnazionale , è quanto mai infuocato e ve r te attorno agli s ce nar i che la nuova s ocie tà las cia pre figurare chiamando in caus a ogni ambito di vita: dalla r iorganizzazione de l lavoro e de i proce s s i produttivi, a lla formazione e al dir itto di c ittadinanza, dalla compe titività all’innovazione , a lla r ide finizione de lle re lazioni pr ivate e de i micromondi affe ttivi e cc.. Pos s ono e s s e re individuati dive rs i filoni inte rpre tativi che comune me nte ve ngono de finiti: apocalittic i, ottimis ti e re alis tic i e che pos s ono e s s e re r icondotti, utilizzando una nota clas s ificazione , a quattro s ce nar i. Il pr imo è que llo de llo s v iluppo s e nza occupaz ione dove il s is te ma produttivo, pur continuando a cre s ce re , non as s icura il pie no impie go. T ale ipote s i s i fonda s u quanto ve r ificatos i in molti pae s i occide ntali ne gli ultimi anni dove s i è as s is tito a fas i di s viluppo impor tanti accompagnate da alti tas s i di dis occupazione . Il s e condo è que llo de lla s ocie tà de l te mpo libe ro , dove tutti hanno un impie go che occupa una porzione r idotta de l te mpo in modo da dis tr ibuire in manie ra e qua il poco lavoro dis ponibile . Il te rzo s ce nar io ipotizza la s ocie tà de l v olontariato , dove vie ne r iconos ciuta pie na dignità ai lavor i s volti ne l s ociale e ne l s e rvizio alla pe rs ona. Il quar to s ce nar io, infine , ipotizza il ritorno al pie no impie go . L’as s unto di bas e di que s t’ultima ipote s i è che , ne l lungo pe r iodo, dopo una fas e di cr is i de ll’occupazione dovuta all’avve nto de lle nuove te cnologie , le nos tre e conomie me ttano in atto un ade guame nto avviando un aume nto de lla produttività, de llo s viluppo e de ll’occupazione . Que s t’ultimo s ce nar io è que llo che ha r ice vuto s os te gno dall’OECD (Organizzazione inte rnazionale pe r la coope razione e lo s viluppo e conomico), nonché dalla Comunità Europe a. Que s ta profonda tras formazione pre nde le mos s e dall’inar re s tabile proce s s o di globalizzazione che può e s s e re de finito, tra i tanti modi
32 32
pos s ibili, come uno s viluppo e conomico che cre a tras formazioni a tutti i live lli coinvolge ndo, in pr imo luogo, i s ingoli individui. All’inte rno di ta le te nde nza pos s ono e s s e re individuati, da una par te , me ccanis mi di conve rge nza plane tar ia e , dall’altra , “me ccanis mi di diffe re nziazione e d e s pans ione de lla cos cie nza de i s ingoli” (ISFOL, 2001/c, p. 20).
Se condo Ulr ick Be ck (2000, p. 39), ad e s e mpio, pe r globalizzazione s i inte nde la pe rdita di confine de ll’agire quotidiano ne lle dive rs e dime ns ioni de ll’e conomia, de ll’informazione , de ll’e cologia, de lla te cnica, de i conflitti trans culturali e de lla s ocie tà civile ” Se condo l’autore , de naro, te cnologie , me rci, informazioni e d inquiname nto annullano ogni confine e ogni dis tanza. I capis aldi di que s to proce s s o plane tar io pos s ono e s s e re cos ì s inte tizzati, s e nza alcuna pre te s a di e s aus tività: pas s aggio graduale da un’e conomia di s cala ad un’e conomia bas ata s ulla fle s s ibilità; te rziar izzazione de i proce s s i; avve nto de lle nuove te cnologie de ll’informazione ; inte rnazionalizzazione de i proce s s i; e me rs ione di un nuovo conce tto che va s otto il nome di qualità totale 21 . L’ins ie me di que s ti e le me nti s ta de te rminando que llo che vie ne comune me nte de finito il pas s aggio da un as s e tto indus tr iale de ll’e conomia ad un as s e tto pos t- indus tr iale . Il pr imo è bas ato s u: una conce zione quantita tiva de lla cre s cita (otte ne re di più dal più); s ul volume de lla produzione ; s u un’impos tazione de l lavoro e de ll’organizzazione che può e s s e re de finita line are , ge rarchica, a tomis tica, dualis tica e manipolativa. Il s e condo, al contrar io, s i fonda: s ulla qualità e inte ns ità de llo s viluppo (otte ne re di più dal me no); s ul valore de lla produzione ; s ulla natura s imbolica, inte rattiva, conte s tuale , par te cipativa, autonoma e inte lle ttuale de ll’attività occupazionale e de lla s ua s trutturazione . Que s to mutame nto ha por tato all’affe rmazione di una s truttura e conomica bas ata s u azie nde piccole , fle s s ibili, dinamiche 22 , capaci di produrre una vas ta gamma di be ni s pe s s o anche s olo immate r iali, s imbolici. In que s to nuovo mode llo il lavoro te nde a fe mminilizzars i non s olo pe rchè s i as s is te ad un acce s s o s e mpre più mas s iccio de lle donne anche a profe s s ioni pre ce de nte me nte dichiarate out ma pe rchè s i affe rma un nuovo modo di lavorare bas ato s u forme coope rative , di re lazione , di re te . T utte que s te tras formazioni hanno de te rminato una modificazione ne lla domanda e ne lla produzione di be ni e , di cons e gue nza, ne i me rcati di
21 Il concetto di qualità totale è venuto alla ribalta nel dibattito del management negli ultimi 20-30 anni per influenza del Total Qualità Management (TMQ). Tale approccio nasce in Giappone e si sviluppa in seguito anche negli Stati Uniti e in Europa, fonda la sua filosofia sull’idea della client satisfaction e della customer satisfaction e rinvia sia alla nozione di “qualità realizzata” che può, tuttavia, non essere percepita, sia alla dimensione soggettiva ed oggettiva della qualità. Nel terzo capitolo si cercherà di considerare le implicazioni del concetto di qualità totale applicato alla formazione. 22 Miles e Snow hanno individuato una configurazione emergente definita organizzazione minimale e carriere senza confine ove viene meno la struttura gerarchica in ragione di una spiccata ricerca al coordinamento tra professionisti autonomi. Per un approfondimento si consulti: Bonazzi (2002).
33 33
lavoro de i var i pae s i a s e conda de lla loro pos izione ne lla nuova e conomia globale (Bute ra, 1989).
Dal fordismo al pos t- fordismo
In te mpo di globalizzazione , pe r compre nde re be ne i convuls i mutame nti is tituzionali e normativi che s i s tanno re alizzando ne l nos tro pae s e , è ne ce s s ar io alzare lo s guardo e d analizzare la trans izione che la s ocie tà mode rna s ta attrave rs ando ne l pas s aggio da una s ocie tà fordis ta ad una pos t- fordis ta . Que s to proce s s o di tras formazione che condiziona tutti i cambiame nti in atto può e s s e re cos ì s inte tizzato (pur s e nza alcuna pre te s a di e s aus tività): s viluppo de lla s ocie tà pos t- indus tr iale e de lla conos ce nza, inte rnazionalizzazione de gli s cambi, profondi cambiame nti a live llo valor iale con affe rmazione di valor i di tipo pos t- mate r ialis ta (Ingle har t, 1983), ince s s ante s viluppo de lle te cnologie te le matiche e d informatiche , multiculturalis mo, immigrazione , s viluppo de lle r is ors e umane come fattore compe titivo e d, infine , affe rmars i di nuove profe s s ioni e compe te nze . Chiarame nte , come in ogni cambiame nto anche ne lla s ituazione attuale convivono e le me nti de l nuovo e d e le me nti de l ve cchio s is te ma, con e ffe tti, ta lora, di confus ione e d ince r te zza. L’autore s inte tizza in manie ra molto e fficace la contrappos izione tra que s ti due s is te mi e vide nziando come il ve cchio s is te ma fordis ta s i s ia affe rmato in un conte s to fatto da me rcati nazionali prote tti e dalla produzione di mas s a di prodotti s tandardizzati. Que s to mode llo di s viluppo pre s uppone va una bas s a profe s s ionalità de lla manodope ra e s alar i prote tti, un’organizzazione ge rarchica e burocratica de l lavoro, contraddis tinto da mans ioni parce llizzate e r ipe titive . In que s to s ite ma il pote re e ra caratte r izzato da una r igida divis ione tra mome nto de cis ionale e mome nto e s e cutivo oltre che dall’e s is te nza di un for te conflitto tra le par ti in caus a 23 . Al contrar io, l’attuale s ituazione è caratte r izzata da te nde nze che s pingono ve rs o una de s trutturazione /r is trutturazione de ll’attore .24
23 Gli elementi che caratterizzano tale sistema possono essere così sinteticamente riportati: “tecnicità e specialismo“ (la scienza, risulta sostanzialmente separata dalla tecnologia); “modesto sviluppo delle professioni” (lavoratore massificato, limitato numero di tecnici, scarsa richiesta di figure intermedie o di altro livello); “uomo parcellizzato” (privato della possibilità di una visione complessiva del proprio lavoro e della partecipazione all’intero processo produttivo);.”formazione di base” (alfabetizzazione di base, educazione morale e civica, addestramento elementare sul lavoro e scarsa attenzione per la formazione professionale). 24 E’ questa una tensione che si presenta per certi versi ambigua e contraddittoria e può essere sintetizzata nelle seguenti dimensioni: “unicità dell’uomo” (superamento delle vecchie forme di alienazione legate ad una funzione meramente esecutiva di compiti parcellizzati); “velocizzazione dei processi di adattamento” (che si traduce nella capacità di attuare un approccio globale ai problemi in tempi assai brevi, contrariamente ai lunghi tempi delle culture classiche); “velocizzazione dell’utilizzazione del bagaglio culturale” (capacità di fare sintesi e di elaborare conclusioni e decisioni in tempi rapidi); “soggettività” (tendenza ad enfatizzare il valore della personalità e della psicologia); “diffusione dei processi” (che riguardano un numero crescente di soggetti); “multiproblematicità” (che si traduce nella necessità di affrontare una miriade di problemi da risolvere in tempi brevi); “gestione della complessità” (l’uomo contemporaneo ha di fronte un mondo complesso, che deve riuscire a semplificare attraverso precise scelte).
34 34
Dopo la cr is i de gli anni ’70 tutte le e conomie occide ntali hanno s ubito una profonda tras formazione in dire zione de ll’affe rmazione di un nuovo mode llo di s viluppo che r is ulta caratte r izzato da un’impor tante cre s cita de lle attività te rziar ie r is pe tto a que lle indus tr ia li e agr icole (che , a l contrar io, te ndono a contrars i progre s s ivame nte ), dal ruolo cre s ce nte as s unto dalla produzione , dis tr ibuzione e dal cons umo di informazione in tutti i proce s s i e conomici, dalla progre s s iva affe rmazione de lle caratte r is tiche intangibili de i prodotti e de i s e rvizi (qualità, te mpe s tività, s e rvizio, or ie ntame nto al c lie nte e cc.) r is pe tto al più tradizionale vantaggio compe titivo. T ale mode llo di s viluppo s i trova ad ope rare , come acce nnato, in un ambie nte profondame nte mutato r is pe tto al pas s ato s otto dive rs i punti di vis ta e caratte r izzato da una cre s ce nte globalizzazione de i me rcati e de lle produzioni (grazie anche alla cre azione di grandi are e e conomiche inte grate a live llo contine ntale , a ll’affe rmazione di c ircuiti finanziar i globali e alla mas s iccia diffus ione di re ti te le matiche ); matur ità de ll’apparato indus tr iale ; e le vato live llo di cons umo a tutti i live lli de lla s tratificazione s ociale ; prolungame nto de lla vita me dia de lla popolazione ; contrazione de lle nas cite ; giov anilis mo; s colar izzazione di mas s a; ince s s ante s viluppo e diffus ione de gli s trume nti di comunicazione di mas s a e de lle te cnologie informatiche ; par te cipazione cre s ce nte de lle donne al lavoro; acce le razione de l progre s s o te cnico e organizzativo.
Un ambie nte cos ì profondame nte mutato, come ins e gna la s ociologia de ll’organizzazione de gli ultimi ve nti anni,25 non pote va non ave re e ffe tti dire tti s ull’apparato produttivo.
25 Il filone di studi rappresentato dalle logiche d’azione interorganizzativa è uno dei più ricchi degli ultimi venti anni, ma la ricerca empirica e la teoria che su di essa si fonda mostra due principali carenze. Innanzitutto, si verifica una sorta di confusione e sovrapposizione concettuale. In seconda istanza, si è registrata una scarsa attenzione alla macrostruttura salvo alcune eccezioni riconducibili ai lavori di Crozier (1977) e Zald (1970). La relazione interorganizzativa si è rivelata un fenomeno molto complesso che si svolge a diversi livelli e si presta molto bene ad analizzare il reticolo di attori e le relazioni che intercorrono tra loro nel nuovo quadro normativo. Tra i contributi più interessanti si può ricordare quello fornito da Benson (1988) che ha proposto un quadro teorico capace di ricomprendere le diversificate proposte metodologiche maturate in questo filone. Il network interorganizzativo viene concepito dall’autore come un’arena politica dove, fissate le regole del gioco, le singole organizzazioni operano sia per acquisire subito il massimo dei benefici possibili per creare, nel medio-lungo periodo, le condizioni che consentano una modificazione a loro favore delle regole del gioco. A questo scopo, ogni organizzazione mette a punto delle strategie capaci di tenere conto non solo delle dinamiche interne alla rete ma anche di quelle connesse ai rapporti che ogni singola organizzazione intrattiene con il contesto socio-politico nel quale è inserito il network. Nel caso della riforma dell’apprendistato, ad esempio, possiamo distinguere l’uso combinato di due differenti strategie. Una strategia manipolativa, attuata dall’attore principale (lo Stato), volta a modificare i vincoli connessi al flusso di risorse. E una strategia cooperativa, fondata sulla concertazione tra le parti, ove ognuna abbandona le situazioni apprezzate in cambio di concessioni da parte di altri. Benson sottolinea che il successo di questa strategia si fonda sulla capacità di scambio delle singole organizzazioni. In altri termini, tutti i partner debbono avere qualcosa da scambiare, devono avere almeno una minima capacità di negoziazione, pena il fallimento di tali strategie. Ma molto importante è anche il contributo di Hjern e Potter (1981) relativo al concetto di struttura di implementazione. Tale concetto si presenta come uno strumento di analisi particolarmente adatto in un contesto caratterizzato da alta densità e interconnessione tra organizzazioni pubbliche e private perché l’intervento pubblico, nelle moderne democrazie contemporanee, non viene realizzato né dai tradizionali apparati burocratici statali né, tanto meno, dal mercato; bensì da gruppi di organizzazioni multilaterali alcune delle quali attengono al mercato e altre alla burocrazia. Il vantaggio di questa categoria di analisi consiste nel fatto che consente di considerare simultaneamente entrambe queste realtà. I programmi poi vengono messi in atto da un insieme di risorse dedicate all’interno delle medesime organizzazioni che vanno a costituire la struttura di implementazione, cioè sottoinsiemi di membri appartenenti a queste organizzazioni che considerano il programma il loro interesse primario, strumentalmente più importante. Per questi attori una
35 35
Ne l gove rno di que s to diffic ile mome nto di trans izione un ruolo de te rminante lo ha as s unto la politica di coe s ione e conomica e s ociale de lla Comunità e urope a che s i e s plica attrave rs o i fondi s trutturali in bas e al pr incipio di s us s idiar ie tà26 . T ale impos tazione pre s uppone una framme ntazione di re s pons abilità politiche e ge s tionali in ambito pubblico: pe r que s to motivo il pr incipio di s us s idiar ie tà r imanda ad attività re ticolar i. In vir tù di c iò, le re lazioni inte r is tituzionali e d inte rorganizzative de bbono bas ars i s ulla partne rs hip ne goziale e s ulla par ificazione de l rappor to tra a ttor i de cis ionali e d attuator i, a diffe re nza di quanto avvie ne ne lle tradizionali politiche di tipo burocratico dove le re lazioni multile v e l e inte rorganizzative s i bas ano s u pr incipi ge rarchici.
Pe r l’Ita lia , uniformars i a lle politiche e urope e s ignifica s ovve r tire le logiche burocratiche che da s e mpre caratte r izzano il nos tro pae s e . Se ppure la s trada da fare è ancora molta è dove ros o s ottoline are che la via intrapre s a è s e nz’altro s ignificativa e può e s s e re r ias s unta in: influe nza de lle le ggi, ne l s e ns o che s i ve de un rappor to tra promulgazione de lle le ggi e loro r icaduta s ulla s ocie tà; ve locità di imple me ntazione ; politica de lla conce r tazione (par te nar iati, contratti d’are a, patti te r r itor iali e cc., tutto allo s copo di favor ire la dime ns ione locale ); programmazione e valutazione che s ono s tati s e mpre e s trane i alle politiche di imple me ntazione ita liana (Botta , 1998).
Con gli anni ’80, s i as s is te , ne l nos tro pae s e , a l cons olidame nto di una duplice te nde nza. Da una par te , s i affe rma la grande impre s a, gove rnata da un nucle o di manodope ra r is tre tto e caratte r izzato da e le vate profe s s ionalità, chiamato a r iorganizzare l’impre s a s e gue ndo il mode llo pos t- fordis ta: produzione s ne lla , fabbr ica cor ta , outs ourcing , impre s a- re te , qualità, fle s s ibilità e cc.. Dall’altra , e s plode il fe nome no de lla s pe cializzazione fle s s ibile , incarnato ne i dis tre tti indus tr iali (s e gue un approfondime nto ne i paragrafi s ucce s s ivi) ne lle piccole o piccolis s ime impre s e te cnologicame nte all’avanguardia (Fondazione Brodolini, 1998). T ale proce s s o di tras formazione , ine vitabilme nte , s i r ipe rcuote , dappr ima,
struttura di implementazione rappresenta una struttura amministrativa attraverso la quale intraprendere azioni finalizzate. Le principali differenze che distinguono il modo di procedere tra l’organizzazione e la struttura di implementazione consiste nel fatto che quest’ultima: ha una struttura meno formale e minori rapporti di autorità; le strutture sociali sono più dinamiche e mutevoli; le decisioni riguardanti la partecipazione ad un programma sono basate vagamente sul consenso e sul negoziato; è per lo più frutto di un’auto-selezione piuttosto che il risultato di una scelta gerarchica. Ma in questa seppur approssimativa panoramica non si può non ricordare anche il contributo di Weick (1976) relativamente alle caratteristiche che contraddistinguono i noti sistemi a legame debole. 26 Il principio di sussidiarietà stabilisce che le decisioni in ambito politico debbono essere di competenza delle istanze di potere più direttamente interessate ai problemi da risolvere. Questo presuppone una redistribuzione delle responsabilità nei differenti ambiti di policy tra livelli e strutture di governo e tra organizzazioni sia pubbliche che private, superando, in questo modo, la tradizionale visione stato-centrica. Il principio di sussidiarietà viene definito nel Trattato della Ue (art. 3b) nel seguente modo: “Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità, interviene secondo il principio della sussidiarietà, soltanto e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono, dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario”.
36 36
s ul me rcato de lle profe s s ioni e , in via indire tta , s ul me rcato de lla formazione . Riface ndos i a i dati de lla r ice rca condotta dal s is te ma SIPRO27 è pos s ibile individuare tre grandi e le me nti di tras formazione caratte r izzati tanto da as pe tti pos itivi, quanto da e le me nti ne gativi.
Il pr imo fattore da cons ide rare è que llo de lla “progre s s iva, rapida ‘de s tandardizzazione ’ de lla pos izione profe s s ionale [ …] . Nume ros e mans ioni tradizionalme nte s volte ne lla modalità de l lavoro dipe nde nte s tandard (a te mpo pie no e inde te rminato) ve ngono s volte da pos izioni profe s s ionali a tipiche o formalme nte autonome ” (T ronti, 2001, p. 5). Il s e condo e le me nto cons is te ne llo s pos tame nto de lle as s unzioni ve rs o le profe s s ioni più qualificate , “l’occupazione aume nta s e ns ibilme nte ne lle profe s s ioni ‘ad alta inte ns ità di capitale umano’ e s i r iduce ne lle altre ” (ivi, p. 8). Infine , il te rzo compone nte cons is te ne ll’ups k illing de gli occupati: cre s ce in modo cons is te nte l’occupazione pe r i lavorator i con i titoli di s tudio più e le vati (diploma e laure a); me ntre s i r iduce que lla pe r i lavorator i con una bas s a s colar izzazione . Que s to cambiame nto non può e s s e re e s e nte da r is chi. Infatti, a s e guito de lla s ituazione de s cr itta , s i as s is te al manife s tars i di una quar ta condizione proble matica s inte ticame nte de finita polar izzazione de l me rcato de l lavoro. In altr i te rmini, da una par te s i hanno s ogge tti a ltame nte s colar izzati che ve dono aume ntare le loro oppor tunità occupazionali, dall’altra , s i hanno pe rs one con una bas s a s colar izzazione che affrontano lunghi pe r iodi di inattività.28
In un conte s to in cui s i inde bolis ce s e mpre più il dominio de l rappor to di lavoro a te mpo inde te rminato il lavoratore , quando anche s i trova in una pos izione di s ubordinazione r is pe tto all’impre s a, è s pinto ad as s ume re s u di s é una quota cre s ce nte di re s pons abilità e di innovazione . Gli e le me nti che caratte r izzano la profe s s ionalità ne lla s ocie tà mode rna pos s ono e s s e re cos ì s inte tizzati: fle s s ibilità, autocontrollo de lla qualità de i prodotti e de i proce s s i, capacità di lavorare in gruppo e pe r proge tti, capacità di innovare e di ge s tire il propr io auto- appre ndime nto e cc.. Que s to s pos tame nto di re s pons abilità e di profe s s ionalità s ull’individuo re nde ne ce s s ar io il r ipe ns ame nto de ll’inte ro s is te ma e ducativo. La formazione de l lav oratore de lla conos ce nza non può più limitars i a lla tras mis s ione di abilità te cnico-produttive ma ne ce s s ità di capacità di re lazione e di controllo che lo s os te ngano ne lla ge s tione de lle propr ie r is ors e . T ale ne ce s s ità “re nde
27 Per un approfondimento del sistema delle professioni può essere utile la ricerca effettuata dal sistema SIPRO “Sistema per la previsione dell’occupazione per Professioni” intitolata Un modello per la previsione della domanda di lavoro e di professioni su base settoriale (Tronti, 1999). 28 Questo effetto è causato dal fatto che i nuovi modelli produttivi si caratterizzano per un’intensa selezione dei lavoratori. Dunque, i più giovani e scolarizzati, sono in grado di governare l’innovazione e sono più disponibili ad accettare forme di lavoro flessibile (destandardizzato), mentre i più anziani e meno scolarizzati hanno difficoltà a rimanere nel mercato del lavoro e una volta usciti dal circuito lavorativo stentano a rientrarvi o, addirittura, abbandonano la ricerca di un nuovo lavoro. Per un approfondimento sul problema della polarizzazione si consulti: Gregg, Wadsworth, 1996.
37 37
improrogabile una r ivis itazione e d una re inte rpre tazone de lle forme s tor iche di tras mis s ione de lla conos ce nza, quale ad e s e mpio l’appre ndis tato, che s ape vano combinare la pre parazione te cnica con que l rappor to pe rs onale che s olo può garantire la tras mis s ione de lle abilità individuali di vita e di re lazione ” (ibide m, p. 19).
La formazione pos t- indus triale Se condo re ce nti analis i la valor izzazione de lla formazione pe r lo s viluppo, la qualificazione e la tute la de ll’occupazione , pas s a attrave rs o s trume nti di tipo le gis lativo e d amminis trativo che ne gli ultimi anni s i s ono mos s i ne ll’ambito di tre pr incipali are e di inte rve nto quali: il coinvolgime nto de lle par ti s ociali ne l proce s s o de cis ionale ; il rafforzame nto de l dialogo inte r is tituzionale tra i s ogge tti inte re s s ati (Minis te ro de l Lavoro, Minis te ro de lla Pubblica Is truzione , MURST e Re gioni);29 il progre s s ivo alle s time nto di una s e r ie di s e rvizi de s tinati a copr ire fabbis ogni formativi non s oddis fatti dall’offe r ta corre nte .
L’Accordo de l ’96, dal quale pre nde l’avvio la r iforma ogge tto d’e s ame , chiar is ce una s e r ie di que s tioni che hanno caratte r izzato il dibattito di que s ti anni. Pr imo tra tutti que llo re lativo all’inte grazione de ll’offe r ta formativa che può e s s e re attuata , progre s s ivame nte , s olo in un clima di fle s s ibilità bas ato s u un s is te ma di s tandard formativi condivis i, unità formative capitalizzabili e cre diti formativi. Affinché que s to s i re alizzi è ne ce s s ar io, pur ne l r is pe tto de l pr incipio di de ce ntrame nto, r is e rvare al “ce ntro” “la funzione di re nde re omoge ne e le pras s i ce r tificative e concre tame nte pos s ibili s ia il mutuo r iconos cime nto de i s is te mi formativi e de lle compe te nze , s ia la cre azione de lle pas s e re lle e de i r ie ntr i tra s is te mi” (Vittore , 1998, p. 248).
Ne ll’ambito di una più ampia r ifle s s ione te or ica, le dime ns ioni de lla formazione pos t- indus tr iale pos s ono e s s e re r icavate dall’analis i di quattro te nde nze che , a live llo, s ociale , culturale e d e conomico, s tanno profondame nte modificando la natura de lle attività umane : cre s cita e s pone nziale de lla comple s s ità de lle re lazioni fra le pe rs one , i gruppi, le organizzazioni, le is tituzioni, le a ttività e conomiche e s cie ntifiche ; accre s ciuta impor tanza de lla logica de ll’innovazione a s capito de lla logica de lla razionalizzazione come fattore trainante de llo s viluppo s ociale e d e conomico; s confitta de lle conce zioni me ccanicis tiche e quantita tive de lle
29 Infatti, per l’implementazione di questo processo di riforma (che prende l’avvio con il Patto per il lavoro del 1996) è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un nucleo comprendente: MURST, Ministro del Lavoro, della Pubblica Istruzione, dell’Industria e Conferenza dei Presidenti delle Regioni, e momenti di concertazione con le parti sociali, allo scopo di realizzare un raccordo costante con le dinamiche sociali e del mondo economico.
38 38
organizzazioni umane , contro un’accre s ciuta impor tanza de l fattore re lazionale ; moto ve rs o la libe r tà da par te de gli individui e alle ntame nto de i tradizionali me ccanis mi di cos tr izione . Ne de r iva l’atte nzione cre s ce nte as s unta pe r la r is ors a umana e la ce ntralità r iconos ciuta all’individuo, che de ve e s s e re e ducato alla pluralità de i mode lli razionali, formato al s e ns o di re s pons abilità e alla ge s tione de lla comple s s ità che de r iva dall’ampliars i de i margini di s ce lta (Crozie r , 1993).
I te or ici de lla formazione pos t- indus tr iale s ottoline ano l’e s ige nza di formare individui “in grado di rappor tars i a lla comple s s ità, di ave re quadr i di r ife r ime nto organizzativo ar ticolati in cui ins e r ire la propr ia attività s pe cifica, di convive re con l’ince r te zza e l’inde te rminate zza de lle re altà organizzative e con la turbole nza de ll’ambie nte ” (Bos s oli e Montobbio, in Moro, 1998 , p. 65). Il fa tto è che la s ocie tà pos t- fordis ta è attrave rs ata da molte s pinte contrappos te e l’innalzame nto ge ne ralizzato de i live lli di is truzione , la proge ttazione e re alizzazione di nuovi pe rcors i formativi s ono s olo una de lle opzioni pos s ibili s pe cialme nte in un conte s to dove vie ne s e mpre più r ivalutata la dime ns ione de ce ntrata e te r r itor iale . Se condo alcuni os s e rvator i, ta li s pinte contrappos te s i pos s ono r ias s ume re in tre alte rnative : a) in un me rcato de l lavoro molto s e gme ntato e uno continuo; b) ne lla mancata prote zione de i s ogge tti più de boli s ul piano culturale e profe s s ionale e la s ce lta di inve s tire r is ors e pe r un proce s s o di aggiorname nto profe s s ionale ge ne ralizzato; c) in un profe s s ionis mo diffus o e l’ins orge re di nuove polar izzazioni fra pochi s upe rqualificati e s upe r-impe gnati e altr i s ottoqualificati e re le gati ne i bad jobs o condannati a lla dis occupazione . Il r is chio che incombe s u que s to nuovo s ce nar io è que llo di una nuova ingius tizia s ociale , o dis uguaglianza, che pas s a attrave rs o le capacità e le pote nzialità de gli a ttor i locali di a ttivare re ti di coope razione . In un mondo fatto di innovazione e di libe r tà “non è s ufficie nte ins e gnare ad appre nde re , occorre anche ins e gnare a r is olve re nuovi proble mi e s oprattutto a por li. Que s ta filos ofia de ve e s s e re alla bas e de l r innovame nto de i conte nuti e de i me todi [ …] ne lle nos tre s ocie tà la formazione è dive ntata troppo impor tante pe r e s s e re las ciata ai s oli formator i. La cos truzione de ll’avve nire e s ige che s i inve s ta in nuovi mode lli di formazione , e laborati s oltanto con la collaborazione di e s pe r ti e di r ice rcator i e , s oprattutto, che s i r ichie da il te mpo di pe rs e ve rare in uno s forzo continuo di s pe r ime ntazione e di valutazione ” (Crozie r , 1993, pp. 120- 125).
Pe r quanto attie ne al proble ma de ll’inte grazione di diffe re nti s e ttor i “una volta r iconos ciuta l’e s ige nza di un’inte grazione tra i s is te mi (s cuola, formazione profe s s ionale , mondo de l lavoro), bis ogna de cide re quale tipo di inte grazione de bba e s s e re por tata avanti: s e e s s a de bba e s s e re ope rata
39 39
s olo tra s is te mi o anche tra logiche e me ntalità, in altr i te rmini tra diffe re nti culture . Ne l pr imo cas o la s e parazione tra i s is te mi re s ta fondame ntale , ne l s e condo s i potre bbe pe ns are ad un unico s is te ma ar ticolato al s uo inte rno. Inoltre , va s tabilito s e l’inte grazione dovre bbe avve nire anche s ul piano te or ico, pe dagogico, didattico e formativo oppure s oltanto in re lazione ad as pe tti s pe cifici, di volta in volta de cis i a ttrave rs o una valutazione politica” (Botta , 1998, 14). Fors e , andre bbe s viluppata un’inte grazione tra tutti i s e ttor i (s cuola, formazione profe s s ionale , mondo de l lavoro) tanto attrave rs o una logica s is te mica, quanto attrave rs o una logica di conve rge nza me todologica e conte nutis tica, che può r is olve rs i o in un’ide ntificazione all’inte rno di un unico macro- s is te ma, oppure in una s tre tta inte r re lazione tra s ub- s is te mi s e parati.
Come s i è già avuto modo di r ile vare , durante gli anni ’90, s ono e me rs e nuove forme di organizzazione de l lavoro. Ciò s ignifica che anche l’approccio al training30 de ve mutare e d ade guars i a lle nuove condizioni di lavoro. A tal propos ito, è s tato oppor tuname nte os s e rvato: “que llo di cui la formazione ha bis ogno è fors e qualche cos a di più che non la pura inte grazione de gli s trume nti pe r conos ce re , ragionare , de cide re , e laborare s trate gie e valutare i r is ultati, e de lle capacità ne ce s s ar ie ad us ar li, ma piuttos to la individuazione di c iò che è comune a tutti que i dive rs i compiti che ve ngono s volti in ogni attività umana, di que lla compe te nza ge ne rale che li accomuna [ …] pe r cos truire s u di e s s a un ce ntro di lavoro in cui c ias cun compito è s uppor tato da uno s trume nto ade guato e d inte grato con gli a ltr i” (De Miche lis , 1993, p. 138). Ne lle e conomie mode rne , infatti, la compe titività de gli age nti e conomici è le gata alla loro capacità di appre nde re dal propr io ope rare tras formando l’appre ndime nto in un proce s s o di accumulazione de lla conos ce nza e di migliorame nto continuo de lle propr ie pratiche produttive (Lundvall, 1996).
L’innovazione s pazza via le conos ce nze acquis ite , acce le ra la cre azione e la dis truzione de lle impre s e , de lle occupazioni e de lle profe s s ioni. Il nuovo obie ttivo, dunque , è que llo de lla manute nzione e promozione de lla profe s s ionalità de i lavorator i lungo l’inte ro arco de lla loro vita attiva, quale unico s trume nto di garanzia contro un’innovazione travolge nte . In vir tù di c iò, le politiche de l lavoro s ono s ogge tte ad uno s pos tame nto di finalità: s i pas s a dalla propos izione di obie ttivi s os tanzialme nte re dis tr ibutivi come , ad e s e mpio, que lli a s os te gno de l re ddito e a prote zione de ll’occupazione ; a obie ttivi di s os te gno all’accumulazione e allo s viluppo continuo de l capitale umano. Da qualunque par te lo s i voglia guardare , que s to ince s s ante
30 Le nuove sfide orientate al training possono essere riassunte sinteticamente in questo modo: a) l’annullamento delle differenze rigide fra ruoli manageriali e ruoli subordinati e la competitività dei nuovi contesti organizzativi richiedono che tutti i membri di un organizzazione, a qualsiasi livello, partecipino alla risoluzione dei problemi. In virtù di ciò, non è sufficiente insegnare tecniche specifiche da adottare ma è necessario preparare gli studenti alla pianificazione di tecniche che possono rivelarsi efficaci in situazioni diverse; b) il contenuto intellettuale dei lavori non verrà potenziato soltanto da fattori di pianificazione o controllo bensì anche dal controllo dei processi e dei risultati; c) l’insegnamento deve essere caratterizzato da un approccio critico e aperto (Balaton, 1993).
40 40
proce s s o pone nuovi inte r rogativi a lle s ocie tà mode rne e , in par ticolar modo, ai tradizionali s is te mi formativi. Lo s trume nto di gove rno di que s to pas s aggio appare e s s e re pe r tutti, e a tutti i live lli, un maggiore inve s time nto ne lle r is ors e umane e pre cis ame nte ne ll’individuazione di nuove s trate gie formative che s i fondino s u un ade guato e quilibr io tra formazione di bas e e formazione s pe cialis tica31 .
I macros copici cambiame nti in atto r ichie dono al s ogge tto una cre s ce nte capacità di gove rno, di re lazione , di autonomia e me ttono in cr is i la tradizionale archite ttura di tras mis s ione de l s ape re , bas ata s u r igide dis tinzioni te mporali de l c iclo di vita , con una fas e di pre parazione prope de utica all’e ntrata ne l c iclo produttivo; una fas e ce ntrale in cui s i concre tizza la vita attiva; e , infine , il mome nto de lla quie s ce nza. Pe r que s to motivo, a ll’attuale s is te ma formativo s i r ichie de di fornire una s olida bas e formativa contro il r is chio di facile de pe r ibilità de lle compe te nze , comple tata da una buona formazione s pe cifica. Un altro obie ttivo s trate gico cons is te ne l me tte re il s ogge tto in grado di ope rare una r iduzione de lla comple s s ità ne ll’accumulo di s ape re o me glio un s is te ma di
31 Alcuni aspetti di questa più generale trasformazione, di seguito elencati, incidono in maniera particolarmente significativa sul sistema formativo (Scanagatta, 1998). Flessibilità e trasformazioni del sistema economico: il mercato del lavoro si presenta sempre più incerto e flessibile e le aspettative dei giovani, tendono a collegarsi sempre più a queste trasformazioni. E’ difficile scegliere a priori ciò che si farà, le scelte formative “vengono fatte più scommettendo sul futuro che sulle garanzie offerte dall’esperienza del passato.” Questo non significa che viene meno il ruolo formativo della scuola anzi “più aumenta la flessibilità del lavoro e maggiori sono le attese di formazione, sia nel senso del consolidamento delle basi educative come nella direzione delle diversificazioni formative che si adattano al variare delle richieste del mercato.” (Ivi, p. 75). Il punto critico sta proprio nel difficile rapporto tra questi due elementi: una buona educazione di base, che preservi dal rischio di rapida obsolescenza formativa, e sulla quale si possano innestare integrazioni successive, e flessibilità intra ed extrascolastica. E’ proprio a questa esigenza che risponde la sempre maggiore diffusione di tirocini e stage come anche la recente rivoluzione dell’apprendistato. Innovazione tecnologica e diffusione degli strumenti multimediali: l’introduzione di nuovi strumenti di comunicazione non ha un effetto immediato e diretto sul sistema scuola; come per tutti gli strumenti, la sua efficacia dipende dall’utilizzo che ne viene fatto. Nella società dell’informazione la comunicazione sta sviluppando nuove strade e il sistema formativo deve fare i conti con essa. Il primo significativo elemento di differenza rispetto al passato è rappresentato da un più ampio accesso all’informazione da parte di una massa crescente di persone prima escluse. Ma un cambiamento ancora più importante e problematico sta, a nostro avviso, nel fatto che si sviluppano, in questo modo, una molteplicità di linguaggi (giornalistico, virtuale, televisivo, telematico, ecc.) che per una corretta interpretazione richiedono di essere adeguatamente decodificati, de-contestualizzati e ri-contestualizzati, pena una sorta di confusione nel soggetto fruitore che non possiede le necessarie meta-competenze capaci di renderlo protagonista critico di fronte a questa varietà di codici senza che ne rimanga stordito o disorientato. Il compito della scuola non è solo quello di trasmettere al discente una sommatoria di diversi linguaggi comunicativi, bensì quello di fornire queste meta-competenze che lo mettano al riparo da cattive interpretazioni di senso: “l’aumento quantitativo di informazione produce una crescita globale della popolazione, ma non permette di essere facilmente usufruito da coloro che vogliono conseguire qualità formative superiori a quelle di massa.” (Ivi, 77). Capacita’ di innovazione: nel mondo post-moderno l’innovazione viaggia a ritmi sostenuti e si presenta come chiave di volta per sopravvivere nell’agguerrito mercato globale, ma “ la flessibilità dei modi di pensare e delle conoscenze non sempre cresce alla pari con le sole innovazioni economiche e tecnologiche; i soggetti infatti sono tanto più in grado di cambiare, quanto più hanno strumenti consolidati per gestire le conoscenze, sono cioè frequentemente inerziali senza che questo sia un difetto; nelle popolazioni dove non c’è questa inerzia culturale vi sono anche grandi difficoltà alla modernizzazione.”
(ivi, 78). Per ovviare a questa difficoltà è necessario favorire il consolidamento delle strutture formative di base per fornire al soggetto gli strumenti più adatti a diventare auto-imprenditore del proprio adattamento culturale. Tipologia di lavoro e nuovi processi di automazione: con lo sviluppo dei processi di automazione cambia il modo di lavorare. Il lavoro sporco è sicuramente ridimensionato ma cresce un’area di lavoro in cui l’abilità delle mani non può prescindere da un certo tipo di conoscenze. La fatica fisica cede il posto ad una fatica intellettuale di governo dei processi; si tratta, cioè, sempre più di una manualità pensata, che implica fatica, stress, competizione (Accornero, 1997). A questo processo è connessa la nascita di una miriade di nuove professioni che modificano profondamente il mercato del lavoro senza che questo comporti una garanzia contro il drammatico fenomeno della disoccupazione.
41 41
pe rce zione s e le ttiva che ope r i una r iduzione funzionale all’ottimizzazione de lla formazione . Le nuove pros pe ttive che s i profilano ne l campo de lla formazione r ichie dono al s ogge tto la ne ce s s ità di gove rnare i propr i pe rcors i formativi ge s te ndo un as s e mblaggio pe rs onalizzato di r is ors e : “appre nde re e d e s e rcitare le propr ie abilità dive ntano ne ce s s ar iame nte due as pe tti de llo s te s s o proge tto formativo.” (Scanagatta , 1998, p. 83). Gli a ttor i pr incipali di que s to nuovo s is te ma s ono tre : s cuola, lavoro e s ogge tto. Que s t’ultimo, dunque , de ve e s s e re me s s o in grado di ottimizzare l’e s pe r ie nza formativa, as s ume ndo un ruolo di gove rno de i proce s s i e una cultura de ll’auto-formazione e de ll’auto- or ie ntame nto. Se s i acce tta l’as s unto che ne lla s ocie tà mode rna la s ocializzazione dura tutta la vita bis ogna ne ce s s ar iame nte porre il s ogge tto ne lle condizioni di ge s tire le r is ors e a lui dis ponibili.
Formazione pos t- indus triale e orientamento: una nuova funzione
A nos tro avvis o, la r ifle s s ione ope rata da Bruno Maggi (1997)32 - che , s e ppure con de lle var ianti, r icorda que lla s viluppata da Lipar i - s ull’e voluzione de l conce tto di formazione e le dive rs e acce zioni che que s to può as s ume re a s e conda de l s is te ma s ociale di r ife r ime nto, s i r ive lano e s tre mame nte utili a compre nde re lo s forzo di r is trutturazione cui s ono s ottopos ti, un po’ ovunque , i s is te mi e ducativo- formativi, a l fine di garantire agli individui una migliore occupabilità. Maggi te nta di compre nde re il conce tto di formazione alla luce di que llo di s is te ma s ociale r iface ndos i alle tre fondame ntali pos izioni r intracciabili ne lle s cie nze s ociali. In una pr ima acce zione , il s is te ma è conce pito come e ntità pre de finita r is pe tto agli a ttor i: i s ogge tti, pur move ndos i all’inte rno de l s is te ma, non ne alte rano l’ide ntità poiché que s ta è indipe nde nte dall’ide ntità de gli individui s te s s i.
32 Secondo l’autore, se si considera un sistema sociale ove i ruoli sono formalmente prescritti e immutabili la formazione si riduce ad un addestramento a mansioni, a competenze e responsabilità rigidamente designate. Al contrario, se si considera un sistema caratterizzato da ruoli mutevoli e adattabili alla funzionalità complessiva del sistema medesimo si ha una formazione a ruoli dove le prescrizioni e le aspettative dello stesso si incontrano con le attese e le motivazioni dei soggetti. In entrambi i casi, tuttavia, la formazione comporta un adattamento di questi ultimi ad un sistema predeterminato. Diversamente, in un sistema sociale dove i ruoli non sono predefiniti ma sono il prodotto dell’interazione tra gli attori, la formazione diviene uno strumento per sostenere le strategie soggettive. Infine, se si considera il sistema sociale in termini di processo si avrà un sistema che non si presenta nè come entità concreta, nè un insieme di ruoli (prescritti o assunti) ma è il “processo di azioni e di decisioni intenzionalmente orientate […]. La formazione [in questo caso] non è uno strumento di adattamento né di opposizione al sistema, è invece strumento per le scelte d’azione, per le scelte di svolgimento, e anche per le scelte di obiettivi e di valori. Poiché il processo non è predeterminato né inevitabilmente coartante, bensì intenzionalmente disegnato e continuamente plasmato e modificato” (Maggi, 1997, p. 9).
42 42
In una s e conda acce zione i te rmini s ono rove s ciati: il s is te ma s i pre s e nta ancora come un’e ntità concre ta che s i de finis ce , tuttavia , in bas e al configurars i de lle inte razioni tra gli a ttor i. Sono i s ogge tti che producono il s is te ma. Pe r que s to motivo que s t’ultimo è s e mpre cangiante e r iconos cibile s olame nte a pos te r ior i s e condo il s ignificato attr ibuitogli dai s ogge tti me de s imi. La diffe re nza s ta ne l fatto che ne l pr imo cas o è il s is te ma ad e s s e re pre dominante , ne l s e condo, inve ce , è l’attore , ma pur s e mpre ne l quadro di un s is te ma ogge ttivo, inte s o come e ntità s e parata e pre cos tituita r is pe tto agli a ttor i. Ne lla te rza acce zione , a l contrar io, il s is te ma s i r iconos ce ne l cors o de lle azioni inte nzionate e re ciprocame nte or ie ntate , dunque , non è un e ntità tras ce nde nte o ogge ttivata r is pe tto agli a ttor i, be ns ì, è il frutto de l “proce s s o di azioni dotate di s e ns o, dire tte a s copi e valor i. Dal s is te ma non è s e parabile il s ogge tto; l’azione individuale e l’azione s ociale non s ono divis e ” (ibide m, 12).
La pr ima conce zione è le gata a due dis tinte var ianti: una vis ione me ccanicis tica e una vis ione organicis tica de lla re altà s ociale , caratte r izzate , tuttavia , da una comune as ce nde nza filos ofica, que lla di s tampo pos itivis tico (s truttural- funzionalis mo), ove il de te rminis mo as s oluto s upe ra la s ogge ttività. La s e conda conce zione , che vi s i oppone , ne ga che il s is te ma s ociale s ia ide ntificabile come s is te ma naturale , pos tulando, inve ce , che s ia un cos trutto s ociale . In que s to filone s i re gis tra , chiarame nte , l’influe nza de lla fe nome nologia e de ll’inte razionis mo s imbolico. La te rza conce zione , infine , è le gata alle r ifle s s ioni di Max We be r di inizio s e colo s ull’ogge tto e s ul me todo de lle s cie nze s ociali e te nde a s upe rare la contrappos izione tra le due te s i pre ce de nti. In que s ta ottica, la re altà s ociale non è più ogge ttiva, o s ogge ttiva, be ns ì re lazionale . Il s is te ma di re lazioni non trova fondame nto in un ordine e s te rno e naturale ma è in s é dotato di s e ns o, e s ogge tto a tras formazioni continue . Da que s ta clas s ificazione l’autore fa dis ce nde re quattro dive rs i modi di inte nde re la formazione a s e conda de l s is te ma cui s i fa r ife r ime nto (e che r icorda la clas s ificazione pre s e ntata ne l pr imo capitolo). Ne lla logica de l s is te ma me ccanico s i as s ume che il s is te ma pos s a e s s e re dis e gnato e re alizzato in modo da mas s imizzare e fficacia e d e fficie nza de l s is te ma s te s s o33 . Ne lla logica de l s is te ma organico la formazione è dire tta ad attivare , e s altare , guidare le motivazioni e le atte s e de i s ogge tti, è s timolo al cambiame nto. E’ in que s to filone di pe ns ie ro che s i affe rma e s i diffonde la
33 Si pensi, ad esempio, ai principi del taylorismo o del fordismo e all’educazione scolastica degli stati totalitari ove programmi e contenuti discendono direttamente, senza possibilità di modifiche, dai principi informatori del sistema. E’ questo un sistema rigido e predeterminato che non lascia spazio al soggetto considerato come discente passivo, tabula rasa.
43 43
formazione e xtras colas tica, dove l’appre ndime nto, r ivolto alla re s pons abilizzazione e alla ge s tione de l ruolo, pre nde le dis tanze dall’appre ndime nto pe r affiancame nto e imitazione . In que s to nuovo e quilibr io s i ins inua un bis ogno di fle s s ibilità e ufunzionale , ne l s e ns o che s i r ichie de alle par ti non di e s s e re as s olutame nte s tabili e invar iabili ma adattabili. L’atte nzione s i s pos ta , quindi, dalla r igida pre s cr izione de lle mans ioni all’as s unzione di ruolo che può e s s e re var iame nte inte rpre tato e s volto ne l r is pe tto de ll’e quilibr io de l s is te ma. La logica de ll’attore e de l s is te ma concre to s i bas a s ull’as s unto che la re altà s ia una cos truzione s ociale : il s is te ma è prodotto dalle inte razioni tra i s ogge tti. L’attore divie ne pre dominante , s i affe rma, a que s to punto, la s ogge ttività. In que s ta ottica, la formazione s i propone come or ie ntame nto non dire ttivo, volto a s e ns ibilizzare , s viluppare , pote nziare e d affinare la capacità di compre ns ione de i fe nome ni che caratte r izzano la re altà s ociale . Me ntre ne lla logica de l s is te ma me ccanico s i te nde al cambiame nto de l s ogge tto ve rs o il ruolo, e ne lla logica de l s is te ma organico s i te nde all’adattame nto de l ruolo ve rs o una maggiore funzionalità de l s is te ma. Ne lla logica de ll’attore , a l contrar io, s i te nde al cambiame nto de lle re lazioni inte rpe rs onali e , dunque , de l s is te ma s te s s o. Infine , la formazione ne lla logica de ll’az ione e de l s is te ma come proce s s o pre s uppone un proce s s o s ociale conce pito come s ucce s s ione di azioni e de cis ioni dotate di s e ns o e or ie ntate a s copi e valor i. In que s ta logica, l’attore è ins cindibile s ia dall’azione che dal proce s s o me de s imo e , a l te mpo s te s s o, ce ntrale pe rché è chiamato ad agire e proge ttare l’azione me de s ima. Il proce s s o non è inte s o come e ntità ogge ttivata , os s e rvabile dall’e s te rno; l’os s e rvazione , in que s to cas o, può avve nire s olo dall’inte rno. Il proce s s o non e s is te né pr ima de i s ogge tti, né dopo i s ogge tti e le loro azioni, be ns ì s i ide ntifica con la proce s s ualità, con il dive nire de lle azioni s te s s e . La formazione è conce pita in manie ra as s olutame nte dive rs a r is pe tto a pr ima, pe rché diffe re nte è il modo di conce pire il s is te ma. Cadono, infatti, le dis tinzioni tra aula e adde s trame nto, aula e formazione . La formazione divie ne s viluppo e al conte mpo aus ilio al proge tto di vita e al s uo s volgime nto. Pe r favor ire un chiar ime nto de lle cons ide razioni finora e s pos te è utile fornire una rappre s e ntazione grafica che s inte tizzi le quattro dive rs e logiche che , s e condo l’autore , gove rnano la formazione in re lazione alla conce zione de l s is te ma cui s i is pirano e le as ce nde nze filos ofiche che hanno de te rminato tali rappre s e ntazioni (s che ma n. 2).
44 44
S c he ma n. 2
Fonte : nos tra e laborazione da Maggi, 1997. A nos tro avvis o, è pos s ibile conne tte re que s te cons ide razioni a lle dive rs e fas i che hanno contraddis tinto lo s viluppo de lla s ocie tà ne l pas s aggio da un’as s e tto di tipo contadino ad uno mode rno. Infatti, in que s to pas s aggio, s i as s is te anche ad una progre s s iva tras formazione s ia de l s is te ma s colas tico s ia di que llo profe s s ionale a caus a de lle s pinte che prove ngono da un mutame nto s e mpre più impe tuos o. Se condo una r ifle s s ione ope rata da De Mauro (1997) - il quale s i è is pirato, tra gli a ltr i, anche a T offle r e Mole s - è pos s ibile dis tingue re tre fas i di e voluzione de l s is te ma e ducativo. Ne lle s ocie tà contadine gli uomini e rano a dire tto contatto con la natura dalla quale trae vano s os te ntame nto e r icche zza grazie alle te cniche di lavoro acquis ite ne i s e coli e tramandate in modo e fficie nte dal re ticolo familiare e ambie ntale . Era que s ta una s ocie tà or ie ntata al pas s ato. Le s ocie tà indus tr iali, a l contrar io, hanno modificato il loro rappor to con la natura e l’ambie nte i quali s i s ono tras formati in una fonte utile , s e mplice me nte , a ll’approvvigioname nto di mate r ie pr ime . In que s to nuovo conte s to le is tituzioni s colas tiche hanno progre s s ivame nte s os tituito le botte ghe familiar i fino a caus arne l’e s tinzione , in quanto que s te ultime non e rano più in grado di fornire un'ade guata conos ce nza. Il vor ticos o s viluppo de ll’ultimo ve nte nnio ha cre ato bas i produttive e s ociali di tipo radicalme nte nuovo. La conos ce nza de lle e s pe r ie nze de l pas s ato e il controllo de lle te cniche produttive non bas tano più a garantire la s opravvive nza de lla s ocie tà e de i s uoi individui s e non s i accompagnano a una capacità diffus a di conos ce re , pre ve de re , capire le innovazioni che s tanno pe r produrs i. La s ocie tà mode rna è tutta proie tta ta ve rs o il futuro34 .
34 Anche la Ribolzi (1998/bis), del resto, -ispirandosi anch’essa a Toffler- giunge ad affermare che, analogamente a quanto è successo per lo sviluppo della tecnologia, anche per i sistemi scolastici si può parlare di tre distinte fasi. La prima fase, che anticipa la scuola di massa, è caratterizzata dall’espansione della scolarità che si estende gradualmente anche alle classi lavoratrici. In questo stadio, l’educazione serve a distinguere i gruppi sociali attraverso canali formativi separati, allo scopo di fornire ogni gruppo di un’appropriata socializzazione e del minimo di conoscenze necessarie all’interno di un mercato del lavoro ampiamente riproduttivo. In questo modo, si verifica un grande spreco di talenti, in particolare, tra le fasce meno abbienti. La seconda fase (’50-‘60), invece, segna il passaggio da un’educazione basata su quello che Dewey chiama “dogma feudale della predestinazione” ad un’educazione fondata sul merito e sull’achievement. In questo particolare momento storico, allo sviluppo economico corrisponde un ampliamento dell’istruzione poiché aumenta il numero delle posizioni qualificate che richiedono personale con alti livelli di scolarità. Il peso delle caratteristiche ascritte è in questo periodo ri-equilibrato dai requisiti acquisiti, ed è proprio in questo clima che si sviluppano le teorie meritocratiche. La terza fase, infine, vede la nascita dell’ideologia
Positivismo Costruzionismo Sistema predeterminato Sistema non predeterminato Sistema
meccanicistico Sistema
organicistico Sistema relazionale “Sistema
processuale” Logica del sistema meccanico: rigidità
Logica del sistema organico: flessibilità funzionale
Logica dell’attore e del sistema concreto: soggettività
Logica dell’azione e del “sistema come processo”: processualità
Struttural-funzionalismo
-Fenomenologia -Interazionismo simbolico -costruzione sociale della realtà
45 45
Se gue ndo que s ta via inte rpre tativa, il pr imo mode llo te or izzato da Maggi (logica de l s is te ma me ccanico) s i conne tte re bbe alla pr ima fas e de l s is te ma formativo ita liano, fondame ntalme nte caratte r izzata da acce s s i limitati (s cuola d’élite ), ins e r ita in un conte s to s ocio- e conomico pre vale nte me nte agr icolo, dove alla maggioranza de lle pe rs one e ra appe na r ichie s to di s ape r le gge re e s cr ive re (compe te nze di bas e ), pe r as s ume re il ruolo as cr ittivame nte pre s cr itto. Il s e condo mode llo (logica de l s is te ma organico), inve ce , a iuta a compre nde re la s e conda fas e vis s uta dalla s cuola, que lla di mas s a, in cui una porzione s e mpre più ampia di popolazione acce de ad una formazione s upe r iore , ne lla s pe ranza di acquis ire pos izioni miglior i r is pe tto ai ge nitor i. E’ que s ta una fas e caratte r izzata da un conte s to s ocio- e conomico molto pos itivo, contras s e gnato da una rapida indus tr ializzazione , dove l’acquis izione di ruoli è s ogge tta alla padronanza di ce r te compe te nze te cnico- s pe cifiche (e d è all’apice di que s to mode llo che nas ce e trova la s ua for tuna l’impianto duale de ll’appre ndis tato te de s co). Il te rzo mode llo (logica de ll’attore e de l s is te ma concre to) s e mbra r ifle tte re la te rza fas e , che s i dis tingue pe r un rapido proce s s o di te rziar izzazione , le gato a cambiame nti s trutturali ne l modo di organizzare e ge s tire il lavoro. In que s ta fas e , dunque , il s ogge tto pre nde cos cie nza de lla propr ia e s pe r ie nza pe r me zzo de lla formazione . La formazione non è più tras mis s ione dogmatica di nozioni e pre s cr izioni, ma s timolo al cambiame nto de l s ogge tto all’inte rno di un s is te ma fle s s ibile . E’ in que s ta logica, ve ros imilme nte , che s i comincia a de line are , anche s e in modo ancora impre cis o, la funzione di or ie ntame nto. Il quar to mode llo, infine , (logica de ll’azione e de l “s is te ma come proce s s o”), s e mbra il più utile ne ll’inte rpre tazione de lla fas e attuale , caratte r izzata da una rapida te cnologizzazione de l lavoro, de i proce s s i e de i s e rvizi in ogni ambito di vita , con una cons e gue nte alte razione de i conce tti s paz io- te mpo, v icino- lontano, e d una frantumazione de i punti di r ife r ime nto. In un quadro s iffatto la formazione divie ne un ipe rte s to dove il pe rcors o formativo non è mai finito, né univoco, ma può avve nire attrave rs o infinite modalità. La me tafora de ll’ipe r te s to è utile a rappre s e ntare que s ta vis ione dinamica de l pe rcors o formativo, dove il s ogge tto divie ne protagonis ta e re s pons abile de lla via pre s ce lta . Inoltre , è utile a rappre s e ntare un s is te ma ape r to dove s ono pos s ibili infiniti contatti e s oluzioni diffe re nti. E come ne ll’ipe r te s to divie ne s trate gica la conos ce nza de i gius ti canali di r ice rca, cos ì pe r muove rs i ne l s is te ma ape r to de ll’is truzione , il s ogge tto ha bis ogno di me ta- compe te nze molto s viluppate pe r rice rcare , acce de re , s e le z ionare , de codificare e inte rpre tare
parentocratica, contraddistinta non dalla quantità di educazione ricevuta, ma dalle basi sociali su cui è organizzata la selezione, con il rischio che le politiche scolastiche non solo confermino, ma accrescano le disuguaglianze. Questa fase prende le mosse dal fallimento del duplice obiettivo uguaglianza delle opportunità–efficienza economica delle riforme educative degli anni ’60 e della scuola di massa. Il nuovo clima di sfiducia verso le effettive pari opportunità e il mutamento nella domanda di formazione favoriscono, in questo clima, la rivalutazione della qualificazione informale e dell’apprendimento sul lavoro.
46 46
le informazioni e non può e s s e re las ciato s olo di fronte alla ne ce s s ità di cos truire ta li me ta- compe te nze . In un mondo che r iconos ce il pr incipio e il valore de lla formazione in te rmini di “capitale ” individuale e s ociale (Cole man, 1988) s u cui inve s tire pe r garantire lo s viluppo e conomico e l’acce s s o alla s ocie tà ne l me rcato globale , le re s pons abilità non pos s ono r icade re unicame nte s ull’individuo, altr ime nti, s i r ipropone un s is te ma incapace di s upe rare le dis uguaglianze , ove il dis agio e l’e s clus ione pas s a pe r vie più s ottili, ambigue e s imboliche . L’avviciname nto de i s is te mi e ducativo- formativi e d occupazionale , a tutt’oggi, avvie ne in manie ra dis ordinata e , s pe s s o, non formalizzata (s i pe ns i, ad e s e mpio agli s tude nti lavorator i). Divie ne impor tante , a llora trovare i link che pe rme ttano l’aggancio tra s is te mi dive rs i. A nos tro, avvis o que s ti link non s ono e s pr imibili s olo attrave rs o il tanto atte s o s trume nto de lla ce r tificazione e de ll’alte rnanza s cuola- lavoro ma anche , e in manie ra s ignificativa, a ttrave rs o i nuovi s e rvizi pe r l’impie go che dovre bbe ro s volge re s e rvizi di accoglie nza, informazione , or ie ntame nto, tutorato e matching (a ttrave rs o la cos tituzione di appos ite banche dati, di un’anagrafe re gionale e de l canale di appre ndis tato). T ali s e rvizi, infatti, rappre s e ntano il collo di bottiglia ove conve rgono tutte le politiche occupazionali, formative e giovanili che , us ando un conce tto caro a Luhmann (1984), pos s ono as s olve re al ruolo di age nz ie s pe cializzate di confine . Life long le arning , e duc azione c ontinua e s oc ie tà de lla c onos c e nza Dalle cons ide razioni fin qui s volte tras pare in manie ra molto for te l’ide a di e ducazione pe rmane nte /e ducazione continua: la logica de l life long le arning s e mbra l’unica in grado di garantire al s ogge tto una manute nzione e d un migliorame nto de lle conos ce nze - compe te nze , dunque de lla s ua occupabilità. Come ha dimos trato l’OCSE (1998) in una re ce nte pubblicazione , infatti, le conos ce nze - compe te nze inutilizzate de pe r is cono rapidame nte . Ne l nuovo conte s to in cui l’occupabilità de ll’individuo (imme diata e futura) divie ne s trate gica pe r acce de re e re s tare ne l me rcato de l lavoro è ne ce s s ar io r ivolge re la gius ta atte nzione al proble ma de ll’e ducazione de gli adulti che non può e s s e re cons ide rata né “un s is te ma né un s e ttore e ducativo, [ ma, piuttos to,] un pr incipio s ul quale s i fonda l’organizzazione globale di un s is te ma e pe r tanto l’e laborazione di ognuna de lle s ue par ti.” (T homas , 1977, p. 96). L’e ducazione r icorre nte può allora “s volge re una duplice funzione : in te rmini compe ns ator i, come s is te ma di oppor tunità pe r chi de s ide ra us ufruire di una s e conda pos s ibilità di e ducazione (drop- out , adulti pr ivi di una idone a formazione di bas e ); in te rmini di e ducazione pe rmane nte , come s viluppo di pos s ibilità e ducative lungo tutto il cors o de lla vita . [ …] bis ogna
47 47
s tudiare il modo di inte rconne tte re maggiorme nte lavoro e formazione is tituzionale , s ì da re cupe rare ne lla pr ima s ia la pos itività ins ita ne lle e s pe r ie nze lavorative , s ia l’as s ie me di conos ce nze e capacità- abilità ge ne rali indis pe ns abili pe r s opravvive re ne l mondo de l lavoro [ …] non può dars i un mode llo di e ducazione r icorre nte s e nza una pre via pre parazione de gli ute nti a ttrave rs o forme di e ducazione di bas e atte a fornire gli e le me nti ge ne rali di formazione , as s ie me alle nozioni e ai conce tti pratici fondame ntali” (Bocca, 1992, p. 23). Altr i conce ntrano la loro atte nzione s ulla dime ns ione lavorativa as s e re ndo che l’aute ntica e ducazione de lla pe rs ona adulta non può non ope rare anche attrave rs o la dime ns ione de l lavoro. E’ impos s ibile “s e parare l’uomo in s é e l’uomo come produttore . [ …] la forzata de pr ivazione produttiva ne gli anni de lla pr ima giove ntù ope ra s icurame nte come inibizione al pie no s viluppo inte lle ttuale e d e motivo” (Manacorda, in Bocca 1992, p. 82). L’adulto s i caratte r izza pe r e s s e re re s pons abile de lla s ua auto- e ducazione . La s cuola de ve s ape r r is ponde re a que s ta e s ige nza con proge tti s pe cifici e or iginali co- ge s tibili con i s uoi ute nti. Cos ì come non è più pe ns abile una propos ta formativa imme diatame nte finalizzata a s bocchi occupazionali pe r il pre adole s ce nte , non è più pos s ibile proporre all’adulto s oluzioni pre confe zionate e te s e s olame nte a lla r iqualificazione di un me s tie re o al re cupe ro di una s colar izzazione adole s ce nziale . Non bis ogna dime nticare che la s cuola rappre s e nta s olo una de lle vie de ll’e ducazione . E’ propr io a que s to propos ito che Bocca s ottoline a che “il rappor to e ducazione - lavoro [ …] non s i può porre e s clus ivame nte in te rmini di gius tappos izione o di s e mplice accos tame nto di diffe re nti s fe re di a ttività: ma il lavoro as s ume un ruolo non tras curabile in chiave formativa, coinvolge ndo in s é , con il s uo or iginars i da un atto me ntale , che s i traduce in proce s s i compor tame ntali razionalme nte guidati e s e le zionati in vis ta di un fine .” (ivi, p. 83). Incalza ancora l’autore , bis ogna por tare la formazione dove e s is te l’informazione e l’azione produttiva. Non appare più s os te nibile una s ituazione di appre ndime nto “che s ia pr iva de lla pos s ibilità di tradurre ope rativame nte ciò che s i acquis is ce , e de lla pos s ibilità di fus ione s tre tta fra r ice rca e d appre ndime nto. [ …] non è ne ce s s ar io inte rve nire con una radicale de s colar izzazione , quanto fare de lla s cuola un ce ntro di appre ndime nto fruibile attrave rs o molte plici vie che coinvolgano le diffe re nti age nzie formative pre s e nti s ul te r r itor io, e fruibile in quals ias i pe r iodo ne l cors o de lla vita” (ivi, p. 13). Come e me rge da que s te cons ide razioni, la life long le arning (appre ndime nto lungo tutta la vita) tie ne conto di as pe tti che vanno al di là de lla tradizionale re lazione e ducativa che avvie ne in conte s ti e ducativi come l’aula (s cuola, FP, unive rs ità) e s i or ie nta ve rs o l’appre ndime nto in una logica molto dive rs a. Se condo una vis ione oggi ampliame nte condivis a
48 48
l’e ducazione formale è s olo una par te de i proce s s i e ducativi più e s te s i che s i ins cr ivono ne lla logica de ll’appre ndime nto lungo tutta la vita . Si s ta s viluppando un s is te ma paralle lo a que llo e ducativo, in qualche mis ura e s te rno e pe r altr i as pe tti inte rno. In tale s is te ma conve rgono tutte le forme di e ducaz ione non formale e que lle di appre ndime nto non formale . In que s te forme di e ducaz ione non formale s ono r icompre s e tutte que lle attività e ducative organizzate che pos s ono ave re luogo s ia de ntro che fuor i le is tituzioni e ducative e inte re s s are pe rs one di tutte le e tà. Me ntre pe r appre ndime nto non formale - che l’UNESCO clas s ifica come life long le arning – ci s i r ife r is ce a tutte le attività e ducative caratte r izzate da un bas s o live llo di organizzazione e che pos s ono e s s e re s volte s ia in modo individuale che in gruppo in un conte s to di lavoro. Que s to aiuta ad accorciare le dis tanze tra ambie nte di lavoro e d ambie nte e ducativo e a modificare il modo s te s s o di inte nde re il conte s to organizzativo che dive nta uno s pazio di appre ndime nto tanto che vi pos s ono e s s e re inte rve nti re alizzati dire ttame nte ne i luoghi di lavoro (pe ns iamo, ad e s e mpio, a i contratti di lavoro a caus a mis ta o ne lle te nde nze più re ce nte alle diffe re nziate iniziative volte a diffonde re l’alte rnanza s cuola- lavoro). Ne lla logica de l life long le arning il modo di inte nde re il conce tto s te s s o di appre ndime nto, come s i avrà modo di cons tatare ne l pros s imo paragrafo, è molto più comple s s o e apre nuovi s pazi di r ifle s s ione .
Come cambia il conce tto di apprendimento
Sulla s cia de lle cons ide razioni s inora s volte , è pos s ibile s pie gare l’affe rmars i de l conce tto di e conomia de ll’appre ndime nto . L’e conomia pos t- indus tr iale è e s s e nzialme nte un’e conomia di s e rvizi la cui pe culiar ità è data dal moltiplicars i de lle forme organizzative che dive ntano s e mpre più ape r te e fle s s ibili. Ulte r iore caratte r is tica di una e conomia di que s to tipo è data dal fatto che pre vale , in ogni compar to, il nume ro de gli adde tti a l s e ttore de ll’informazione (information e conomy ). In altr i te rmini, pre valgono ruoli e occupazioni in cui il tra ttame nto de ll’informazione è pre vale nte r is pe tto ad altr i s e gme nti di a ttività: s e mplificando, s i pos s ono chiamare lav oratori de ll’informaz ione (uomini de l marke ting, ins e gnanti, re por te r , e cc.). E’ in que s to quadro che s i ve ngono ad affe rmare due filoni di ide e che trovano il loro fondame nto ne l ruolo giocato dalla informazione ne lla s ocie tà mode rna. Il pr imo è que llo le gato alla ne w e conomy , c ioè la conce zione s e condo cui l’informazione è cons ide rata l’as pe tto più r ile vante , il be ne più impor tante , dal punto di vis ta e conomico e s ociale , con e ffe tti s traordinar iame nte innovativi. T ale conce zione è corre lata al fior ire di inte rne t.
49 49
Il s e condo è que llo de lla le arning e conomy che , par te ndo da un punto di vis ta molto s imile a que llo de lla information e conomy , s ottoline a il fa tto che la gran par te de i s e ttor i - e lo s te s s o s e ttore manifattur ie ro- s ono dominati in larga par te da as pe tti informativi e che il me rcato de l lavoro è contraddis tinto da occupazioni che hanno s e mpre più a che fare con l’informazione s te s s a. T uttavia l’e s s e nza de lla le arning e conomy (Lundvall, 1996) s ta ne l modo in cui s i conce ttualizza l’informazione . Se condo que s ta vis ione , infatti, que s t’ultima ge ne ra appre ndime nto, in altr i te rmini pe rme tte di s viluppare proce s s i di appre ndime nto, i quali s ono alla bas e de lla nos tra e conomia e de lla nos tra s ocie tà. Si può cons tatare , dunque , come il conce tto s te s s o di appre ndime nto s i vie ne dilatando. Ris pe tto alla logica de l life long le arning que s to s ignifica ins e gnare alle pe rs one anche in conte s ti dive rs i dall’aula tradizionalme nte inte s a, oppure las ciare che le pe rs one appre ndano ne i loro luoghi di lavoro. Pe r que s ta via , la conos ce nza e s ce dal chius o de i domini accade mici pe r e ntrare ne l vivo de i s is te mi di produzione . Manue l Cas te lls (1999) de finis ce que s to tipo di s ocie tà –dove il valore aggiunto è dato dalla informazione bas ata s ulla conos ce nza (Know le dge Bas e Information)- informaz ionale , globale e re ticolare ; me ntre Lundvall (1994) s i e s pr ime addir ittura in te rmini di Globalis ing Le arning Economy (e conomia de ll’appre ndime nto). In que s ta logica, s i ins cr ive il pas s aggio da un ide ale e ducazionalis ta di appre ndime nto (come avvie ne in aula) all’appre ndime nto, come conce tto, che inve s te l’e conomia e la s ocie tà inte ra . In que s to modo, le pe rformance di individui, impre s e , te r r itor i e pae s i ve ngono ad e s s e re le gate alla contrappos izione tra conos ce nza codificata (o e s plicita) e conos ce nza tacita35 . T utto que s to dis cors o è impor tante pe r compre nde re pe rché s i par la oggi di e conomia de ll’appre ndime nto e pe r quale motivo que s t’ultimo vie ne a r icopr ire un’impor tanza s trate gica pe r gli individui, pe r l’impre s a e pe r la s ocie tà. L’e le me nto più impor tante di que s to dis cors o è il fa tto di r ius cire ad e vide nziare gli as pe tti che s inora e rano s tati tras curati dall’analis i e conomica e dall’analis i s ociale : lo s viluppo non è s olo que llo de i proce s s i produttivi, di informazione o de lle ide e . Il ve ro s alto è dato dal fatto che s i cons ide ra alla s te s s a s tre gua la conos ce nza e s plicita e que lla tacita . Que s to as pe tto è pre s o in cons ide razione ne lle te or ie de lla le arning e conomy in cui vie ne r iconos ciuto un valore fondame ntale alla conos ce nza tacita . Pe r tanto, le pe rformance che r ie s cono a re alizzare le pe rs one , le impre s e , i te r r itor i r iguardano l’appre ndime nto inte s o come s ommator ia di capacità, conos ce nze codificate e conos ce nze tacite , capacità di cre are e
35 Per favorire un chiarimento del discorso può essere utile una precisazione terminologica: si intende con conoscenza codificata quella veicolata dall’informazione in forma esplicita; mentre si intende con conoscenza tacita quella basata su skill individuali, su regole implicite, su consuetudini operative e interpretative. In altri termini la conoscenza implicita è incorporata (embbeded) racchiusa in qualcosa, come la mente, le skills, le modalità sociali di relazione. Possono esistere 4 tipi distinti di conoscenza: know-what (sapere cosa); know why (sapere perché); know how (conoscenza tacita integrata nelle competenze); know who ( conoscenze sociali, anch’essa tacia e legata a delle relazioni). Le prime due si possono racchiudere nella conoscenza esplicita, le seconde in quella tacita. In questa ottica, l’apprendistato è il processo attraverso il quale il mastro mostra come si fanno determinate cose, senza spiegarle: l’apprendistato è una forma estremizzata di trasferimento di conoscenza tacita.
50 50
s cambiare conos ce nze di var io tipo. Ne ll’e ra de lla globalizzazone , tutto s i tras fe r is ce rapidame nte , me ntre il k now how incorporato ne l lavoro s i tras me tte a bas s a ve locità. L’as pe tto pr incipale le gato alla le arning e conomy , dunque , è dato dal fatto che aiuta a compre nde re e s attame nte cos a s ignifichi appre ndime nto dal punto di vis ta s ociale e d e conomico. Appre ndime nto inte s o non come tras mis s ione o acquis izione di conos ce nze ma come appre ndime nto ad un us o compe te nte de lle conos ce nze e capacità di s ape r continuame nte inte grare conos ce nze tacite e d e s plicite . Nonaka (1991)36 affe rma che ci s ono due dime ns ioni fondame ntali de ll’organizzazione : una e pis te mologica – os s ia la dime ns ione in cui s i r iproduce la conos ce nza, que lla codificata e que lla tacita – e d una ontologica – in cui c i s ono i s ogge tti di que s ta conos ce nza, s ia individuali che colle ttivi. Se condo que s ta le ttura, dunque , l’impre s a è conce pita come il luogo de lla re alizzazione e de lla continua inte grazione de lle diffe re nti conos ce nze . La r iforma de ll’appre ndis tato, con il vincolo de lla formazione e s te rna obbligator ia , s e mbra r is ponde re propr io a que s ta logica volta a favor ire lo s viluppo e l’inte grazione s ia di conos ce nze te or iche che di que lle ope rative , ma anche di conte s ti organizzativi favore voli a lla cre azione di conos ce nze di tipo individuale come vuole , appunto, la le arning e conomy . Spos tando il live llo di r ifle s s ione , r is ulta par ticolarme nte inte re s s ante r iproporre alcune cons ide razioni maturate in un s e ttore di s tudi e di r ice rche di are a antropologica, s ociologica e ps icologica che ha te ntato di analizzare la pre s tazione cognitiva in dive rs e s ituazioni pratiche . Il r is contro di que s te r ice rche ha dimos trato, infatti, che e s is tono quattro tipi di a ttività cognitive r is pe ttivame nte ne lla s cuola e ne ll’e xtras cuola. Que s te attività pos s ono e s s e re s inte ticame nte r ias s unte in que s to modo. ►Cognizione individuale a s cuola contro cognizione condivis a fuor i. La forma dominante di appre ndime nto e pre s tazione ne lla s cuola è di tipo
individuale , contrar iame nte a quanto avvie ne in ambiti e xtra- s colas tici dove la cognizione , l’e s pe r ie nza e anche il s ucce s s o pe rs onale s ono condivis i s ocialme nte . ►Attività me ntale pura a s cuola contro manipolazione de gli s trume nti a ll’e s te rno Ne lla s cuola s i valor izza il pe ns ie ro puro s e nza l’aus ilio di s trume nti
mate r iali e cognitivi. Inve rs ame nte la maggior par te de lle attività s volte al di fuor i fanno ampio r icors o a s trume nti e te cnologie s ofis ticate . L’utilizzo
36 Nonaka individua quattro fasi di riproduzione della conoscenza che possono essere rappresentate come una spirale che intreccia ed integra continuamente tra loro conoscenza tacita ed esplicita. Le quattro fasi sono: la socializzazione è il luogo di scambio delle diverse conoscenze tacite, per antonomasia l’apprendistato (tacita-tacita); l’esternalizzazione è il processo di espressione della conoscenza tacita attraverso concetti espliciti come metafore, analogie (tacita-esplicita); la combinazione consente la sistematizzazione dei concetti in un sistema di conoscenze (esplicita-esplicita); l’interiorizzazione è il processo in cui si formano le competenze, in cui avviene l’apprendimento (esplicita-tacita).
51 51
de gli s trume nti è un modo pe r accre s ce re le capacità te cnico- profe s s ionali de lle pe rs one .
►Manipolazione di s imboli a s cuola contro il ragioname nto conte s tualizzato fuor i de lla s cuola L’appre ndime nto s colas tico s i bas a fondame ntalme nte s u s imboli e s u re gole pre fis s ate ma conce ntrars i s olo s u s imboli dis taccati dai conte s ti re ali può cre are difficoltà al proce s s o di appre ndime nto. Al contrar io, le attività di pe ns ie ro e xtra- s colas tiche s ono for te me nte conte s tualizzate , as s umono un s ignificato in re lazione ai r is ultati che s i è in grado di cons e guire in una pre cis a circos tanza. In altre parole , le azioni trovano fondame nto ne lla logica de lle s ituazioni re alme nte vis s ute .
►Appre ndime nto di pr incipi ge ne rali a s cuola, contro compe te nze s pe cifiche r ichie s te dall’e s te rno. Il compito de lla s cuola è que llo di tras me tte re pr incipi te or ici ge ne rali e utilizzabili in diffe re nti conte s ti. La ragione di c iò s ta ne l fatto che , ta li pr incipi, rappre s e ntano una garanzia di tras fe r ibilità. In e ffe tti le pe rs one più s colar izzate hanno maggior i capacità di de codificare e inte rpre tare le s ituazioni e ce rcare s oluzioni alte rnative ai proble mi che incontrano. Pe r e s s e re ve rame nte compe te nti, pe rò, bis ogna e s s e re in grado di s viluppare forme di conos ce nza ade guate alle s ituazioni te ne ndo pre s e nte che l’appre ndime nto s pe cifico in s ituazione può e s s e re limitativo pe rchè quando gli as pe tti familiar i var iano il s ogge tto de ve e s s e re in grado di trovare nuove r is pos te . Gli individui non s colar izzati incontrano maggior i difficoltà a r is ponde re te mpe s tivame nte a que s ti nuovi s timoli.
Se condo que s te r ice rche , oltre ai dive rs i limiti de ll’appre ndime nto s colas tico s i pos s ono cons ide rare anche que lli de ll’adde s trame nto profe s s ionale s ul pos to di lavoro, poiché que s to tipo di appre ndime nto s i bas a s ulla combinazione di tre fattor i che Lave (1988) chiama: os s e rvazione , as s is te nza e pratica. Ne lla pr ima fas e il s ocializzando s i limita ad os s e rvare il mas tro, ne lla s e conda fas e inizia a s pe r ime ntare il lavoro s otto la guida de ll’e s pe r to, infine , ne ll’ultima fas e , l’e s pe r to r iduce gradualme nte il s uo inte rve nto. Que s ta forma di adde s trame nto, tuttavia , può andare be ne s olo in pe r iodi caratte r izzati da le nti cambiame nti ne lla s truttura te cnologica e s ociale de l lavoro. T utto que s to non s us s is te più, le mode rne condizioni e conomiche r ichie dono un’e ducazione finalizzata ad aiutare le pe rs one a s viluppare capacità di appre ndime nto anche quando non s ia dis ponibile un’e ducazione ottimale . La convinzione che s i s ta radicando in manie ra s e mpre più capillare , dunque , è che “la s cuola dovre bbe conce ntrare i s uoi s forzi ne l pre parare le pe rs one ad e s s e re capaci di imparare in modo adattivo, cos ì che pos s ano ave re pre s tazioni e fficaci quando le s ituazioni s ono impre ve dibili e il compito r ichie de de i cambiame nti. Ci s i può as pe ttare di r ius cire in que s to inte nto s olo tramite
52 52
line e di r ice rca dive rs ificate s ull’appre ndime nto in conte s ti s colas tici e d e xtra- s colas tici [ …] finchè la s cuola s i conce ntra pr incipalme nte s u forme individuali di compe te nza, s ulla pre s tazione in as s e nza di s trume nti e s u capacità de conte s tualizzate , e ducare le pe rs one ad imparare be ne unicame nte ne ll’ambie nte s colas tico può non e s s e re s ufficie nte pe r aiutar le a s viluppare s olide pos s ibilità di appre ndime nto fuor i de lla s cuola.” (Re s nick, 1995, pp. 76- 78)37 .
Es is te ne lla nos tra tradizione culturale una s e parazione ne tta tra pe ns ie ro te or ico e pe ns ie ro pratico. Se parazione che r is ale ad Aris tote le . Que s ta dis tinzione caratte r izza profondame nte tutte le conce zioni de lle pratiche e ducative e formative , s e condo le quali e s is te una conos ce nza te or ica e un pe ns ie ro as tratto che pos s ono e s s e re adattati e tras fe r iti a i dive rs i conte s ti di applicazione . Dunque , da una par te , il lavoro inte lle ttuale e , dall’altra , il lavoro manuale ; da una par te mome nti de dicati a ll’appre ndime nto e , dall’altra , e s pe r ie nza di quanto appre s o (ivi). Sulla bas e di quanto e me rs o, è pos s ibile as s e r ire che la cr is i de i mode rni s is te mi e ducativi induce ve rs o la ne ce s s ità di ope rare un s upe rame nto de lla tradizionale dis tinzione tra conos ce nza e d e s pe r ie nza, pe ns ie ro te or ico e pe ns ie ro pratico38 . Pe r conclude re , s i può dire che anche l’e nfas i pos ta s ul te ma de lle compe te nze , come s i os s e rve rà ne l pros s imo paragrafo, trova le s ue radici ne lla natura de i cambiame nti che hanno inve s tito le impre s e e la s ocie tà civile . La capacità di s viluppo s os te nibile di un s is te ma, s ia e s s o impre s a, comunità locale o pae s e , s i e s pr ime , dunque , ne lla capacità di gove rnare cons ape volme nte la cre azione , la diffus ione e la capitalizzazione de lla conos ce nza s e condo l’acce zione propos ta da Nonaka (1994): “dy namic human proce s s jus tify ing pe rs onal be lie f as part of an as piration for the truth”; me ntre l’informazione è un s us s e guirs i di me s s aggi, la
37 Questi autori, analizzando alcuni programmi che permettono di insegnare capacità di pensiero, capacità di apprendimento e abilità cognitive di alto livello hanno individuato gli elementi ricorrenti che caratterizzano i programmi medesimi. Secondo le loro valutazioni “…la maggior parte dei programmi efficaci hanno lineamenti caratteristici delle prestazioni cognitive extrascolastiche: comprendono lavoro intellettuale socialmente condiviso e sono organizzati intorno alla realizzazione comune di compiti, in modo tale che gli elementi delle capacità assumano significato all’interno dell’intero contesto. […]. molti dei programmi contengono elementi di apprendistato, ovvero rendono espliciti processi solitamente nascosti, e incoraggiano osservazioni e commenti da parte degli studenti. […] Infine, i programmi di maggior successo sono organizzati intorno a particolari ambiti di conoscenza e interpretazione – materie, per capirci – piuttosto che abilità generali. Il trattamento della materia è concepito per impegnare gli studenti nel processo di costruzione e interpretazione del significato.” (Resnick, 1995, p. 79). 38 Esiste un importante filone di ricerche il quale dimostra che c’è un nesso molto preciso tra attività pratiche e attività cognitive. Senza entrare nello specifico di tali ricerche è utile ricordare le conclusioni tratte da Scribner nel suo studio sulle relazioni esistenti tra pensiero pratico e contesto lavorativo reale relativamente ad alcune dimensioni dell’apprendimento. Definizione dei problemi: il pensiero pratico esperto non è solo soluzione di problemi ma anche definizione in modo innovativo e flessibile dello spazio problematico in cui si opera; soluzioni flessibili: il pensiero pratico esperto è caratterizzato da un alto grado di flessibilità, lo stesso problema può essere risolto in diversi modi; integrazione dell’ambiente nel sistema di soluzione di problemi: il pensiero pratico esperto incorpora e utilizza tutti gli elementi dell’ambiente in cui si opera e utilizza tutte le risorse sociali, simboliche e materiali di cui si dispone, per estendere le proprie capacità di definizione-soluzione del problema in modo sempre nuovo e diverso; ottimizzazione strategica dello sforzo: il pensiero pratico esperto tende sempre a risparmiare energia fisica o cognitiva nella risoluzione dei problemi. E’ questa una meta-strategia che permette di ricorrere all’utilizzo di modi sempre diversi e flessibili di soluzione; dipendenza da conoscenze specifiche e particolari: il pensiero pratico usa conoscenze specifiche per lo svolgimento delle sue attività, dipende, quindi, dal contesto (Scribner, 1995).
53 53
conos ce nza, formata dal flus s o di informazioni, è ancorata alla vis ione e ai valor i di chi la pos s ie de .
La teoria de lle risorse umane e il conce tto di competenza
In vir tù de lle profonde modificazioni di cui s i è ce rcato di re nde re conto è oppor tuno r iconos ce re che ne gli ultimi die ci anni è profondame nte mutato anche il modo in cui un’organizzazione pe ns a e ge s tis ce il s uo pe rs onale . Fino a die ci anni or s ono s i s e ntiva par lare di Amminis trazione de l pe rs onale inte nde ndo l’ins ie me di ade mpime nti cui è te nuto un e nte ne ll’applicazione de lla normativa s ul rappor to di impie go. Oggi, a l contrar io, s i è affe rmata una più mode rna conce zione di ge s tione de l pe rs onale , con la quale s i inte nde la concre ta azione di dire zione , impuls o, motivazione e controllo con cui una organizzazione utilizza al me glio le r is ors e umane di cui dis pone . In altr i te rmini, lo s copo è que llo di utilizzare il pe rs onale , a quals ias i live llo de lla s cala ge rarchica “pe r raggiunge re gli obie ttivi is tituzionali e s trate gici (e fficacia) s e condo un cr ite r io di e conomicità (e fficie nza) (Cos ta , De Mar tino, 1985, p. 134)39 . Infatti, come s i è già avuto modo di compre nde re ne l pr imo capitolo il conce tto di r is ors a umana ha s ubito ne l te mpo una e voluzione che ha condotto, di volta in volta , a ll’as s unzione di nuovi s ignificati o all’affe rmazione di vis ioni contrappos te a s e conda de lla pros pe ttiva te or ica di r ife r ime nto40 .
Ne lla conce zione più tradizionale la r is ors a umana è conce pita come un fattore da pianificare all’inte rno di un quadro pre formato. E’ que s ta la r is ors a che attie ne alla tradizionale organizzazione di tipo tay lor- fordis ta caratte r izzata dalla r igida parce llizzazione de i compiti, ide ata e controllata dal s ape re inge gne r is tico attrave rs o lo s tudio s cie ntifico de l lavoro bas ato s ulla mis urazione de i te mpi e l’os s e rvazione de i me todi, a l fine di de finire la mans ione . Ma vi s ono anche altr i fa ttor i da te ne re pre s e nti pe r garantire una buona ge s tione de l pe rs onale s e condo T aylor : la s e le zione e l’adde s trame nto s cie ntifico de lla manodope ra; la cordiale collaborazione tra dir ige nti e manodope ra, la r is trutturazione de ll’apparato produttivo. Par ticolarme nte inte re s s ante , a l nos tro dis cors o è il pr imo di que s ti che r is ponde alla logica di collocare l’uomo gius to al pos to gius to, a l fine di ottimizzare il rappor to biunivoco tra doti s ogge ttive de l lavoratore e caratte r is tiche de lla pre s tazione di lavoro. La one be s t w ay pos tulata da
39 Per un approfondimento su questa tematica si può consultare, tra gli altri, Weiss 1983; Ruozi, 1984; Manzolini, 1984. 40 Una buona sintesi di come si è evoluto nel tempo l’approccio alle risorse umane è fornito senz’altro da Bonazzi (2002).
54 54
T aylor , dunque , affe rma il pr imato as s oluto de ll’organizzazione d’impre s a s u ogni compone nte s ociale che vi lavora. Già a par tire dagli anni ’30, tuttavia , s i s viluppano altre pros pe ttive di analis i che modificano il modo di inte nde re e ge s tire la r is ors a umana in impre s a. In que s ta fas e e ntra in gioco il fa ttore umano (le motivazioni, i bis ogni), vie ne as s unta quindi la dime ns ione ps icologica de ll’uomo. E’ in que s to pe r iodo che s i s viluppa – tra le a ltre - la s cuola de lle Re lazioni umane s otto la guida di Elton Mayo, che ins is te s ulla ne ce s s ità di adottare una vis ione comple ta de l rappor to uomo- azie nda, a l fine di favor ire la cre azione di un abie nte di lavoro s ocialme nte grade vole e armonico. Pur e s s e ndo ancora ne lla pros pe ttiva de lla pianificazione – dove il collante de lla vita organizzativa s ono il comando, il controllo, le norme - cambiano le e x pe rtis e di r ife r ime nto in quanto s i comincia ad affe rmare la figura de llo ps icologo azie ndale chiamato a conte ne re e ge s tire le ans ie , le ne vros i, i conflitti che s i pos s ono s cate nare s ul lavoro. Con gli anni ’50 s i as s is te ad un ulte r iore s viluppo te or ico che por ta all’affe rmazione de ll’approccio s is te mico (in e ffe tti s i pos s ono r is contrare var i filoni tutti a ttine nti a que s to approccio) s e condo il quale l’organizzazione può e s s e re conce pita alla s tre gua di un organis mo vive nte , gove rnata da un pr incipio di adattabilità e s tabilità inte rna. In que s ta vis ione , s i as s ume il pr incipio de ll’e quilibr io r ice rcato attrave rs o un proce s s o di adattame nto continuo e re ciproco: s i tra tta , dunque , di s is te mi in movime nto (Luhmann, 1984). Con gli anni ’70- ’80 s i as s is te al fior ire di nume ros e te or ie in ambito organizzativo che por tano all’affe rmazione di nuove vis ioni e di nuovi conce tti anche ne l campo de lla ge s tione de lle r is ors e umane . Si vie ne ad affe rmare la vis ione di una r is ors a umana inte s a come r is ors a s trate gica. (Crozie r , 1977), que s ta pros pe ttiva introduce una que s tione che e ra r imas ta s ino ad ora in ombra: la r is ors a umana è una compone nte attiva, s ottopos ta a proce s s i di ne goziazione s trate gica. Se condo que s ta le ttura, l’impre s a vie ne ad e s s e re cons ide rata un attore s ociale non s olo e conomico. Si e s ce , dunque , da una vis ione purame nte s ocio- te cnica e s i introduce una compone nte s ociale : “umana” caratte r izzata dalla cons ape vole zza che le pe rs one de ntro le organizzazioni hanno cognizioni, re s pons abilità, acquis is cono ruoli. E’ in que s ti anni che s i s viluppa una dime ns ione s ociologica de gli s tudi organizzativi che pre ce de nte me nte ave vano inte re s s ato s olo uomini di azie nda, e conomis ti e ps icologi; s i affe rma, altre s ì, il conce tto di compe te nza. Con il te rmine compe te nza s i a llude ad un re pe r tor io is tituzionale e cognitivo, un re fe re ntie l ge ne r ico (Jobe r t, 1995; Mulle r 1995) che viaggia da un s e ttore all’altro, da un conte s to all’altro, acquis e ndo, di volta in volta , s ignificati diffe re nti. Il te rmine compe te nza è e me rs o più o me no conte mporane ame nte in campi dis ciplinar i dive rs i (ps icologia, s cie nze cognitive , s ociologia, e conomia, manage me nt e cc.), in or igine s i è ins e diato
55 55
ne lle pratiche di ge s tione de lle r is ors e umane , poi ha fatto la s ua compars a ne l s is te ma di formazione profe s s ionale che cos tituis ce una s or ta di ce rnie ra tra il mondo de l lavoro e que llo de ll’is truzione e acquis ta connotati for te me nte marcati dall’ide a de ll’inte grazione inte r - s is te mica. Ne lla formazione profe s s ionale la compe te nza “dive nta un cos trutto curr icolare onnicompre ns ivo, che as s orbe que lli tradizionali di abilità e di conos ce nza e te nde a pre nde re il s opravve nto s ullo s te s s o conce tto- guida di figura o profilo profe s s ionale , s e non addir ittura a s os tituir lo” (Be nadus i, 2002). Le ntame nte il conce tto di compe te nza è s tato adottato anche in ambito s colas tico anche s e non s e nza difficoltà. Ma que llo che inte re s s a qui è dimos trare , appunto, la capacità di raccordare s ogge tti e mondi dive rs i as s unta da que s to te rmine . Alla for tuna che accompagna il te rmine compe te nze , tuttavia , non corr is ponde una diffus a tras pare nza de l s ignificato che a tale te rmine attr ibuis ce chi lo utilizza. Infatti, è pos s ibile r iunire in tre ampie cate gor ie i mode lli conce ttuali a cui il te rmine “compe te nze ” può e s s e re r icondotto: c ias cuno di que s ti mode lli non e s clude l’altro41 , be ns ì s uppor ta fas i dive rs e de l proce s s o di formazione (Infe lis e , 1994). Inoltre , s us s is te un nutr ito dibattito inte rnazionale s ul te ma de lle compe te nze tanto che in molti Pae s i vi è un accordo di fondo e is tituzionalizzato s u quali de bbano e s s e re le compe te nze - abilità s ocialme nte r iconos ciute pe r un buon ins e r ime nto ne l lavoro42 . Vis ta la comple s s ità de lla trattazione (che pe r quanto inte re s s ate s pos te re bbe il fuoco di analis i) c i limite re mo a r icos truire una bre vis s ima panoramica de gli approcci oggi r ite nuti più inte re s s anti.
41 Secondo il modello processuale il sistema delle competenze è costituto dal processo seguito per formarle. A tale proposito i processi possono essere molto diversi in relazione al soggetto e alla sua storia anche se nulla esclude che possono condurre a risultati identici. Per questo motivo, la logica dell’apprendimento lungo tutta la vita e della formazione continua porta a porre l’accento sulla necessità di rendere accessibile, trasparente e aperto il sistema che porta all’acquisizione delle competenze stesse. Ed è in questa logica, dunque, che si inserisce tutto il dibattito oggi in auge sulla certificazione delle competenze ed il riconoscimento dei crediti formativi (che verrà affrontato meglio nel prossimo capitolo). Il modello delle competenze fondato sugli input, invece, definisce caratteristice, attributi, tratti della personalità necessari per i raggiungimento di precisi livelli di prestazione. In questa logica le competenze vengono concepite come potenziale (Boyatzis, 1982). Infine, il modello delle competenze come output concepisce la competenza medesima come capacità dimostrata di integrare e usare conoscenze, abilità e attitudini in modo coerente con l’obiettivo-risultato atteso. Questa concezione prescinde dal processo seguito e dai tratti individuali e pone l’accento sulle capability (abilità) del soggetto di integrare le risorse disponibili per otttenere gli standard di prestazione stabiliti. E’ questo il riferimento teorico-concettuale che ispira il modello britannico noto come standard of competence (Mansfield e Mitchell, 1996). 42 In Gran Bretagna vengono individuati 5 livelli di competenza: comunicazione, tecnologia dell’informazione, applicazione di numeri, lavorare con altri, migliorare il proprio apprendimento e la propria prestazione. In Francia vengono individuati tre ordini di competenza all’interno di una macro area legata alle competenze trasversali: competenze di ordine intellettuale e metodologico, competenze di ordine personale e sociale, competenze di ordine comunicazionale e ventidue livelli di competenze generiche. In Germania, più semplicemente, vengono evidenziate solo tre macro aree di competenza: capacità di base di tipo caratteriale, capacità orientate al lavoro, capacità sociali. Oltreoceano i termini della questione si ampliano perché sia gli Stati Uniti che il Canada allargano le considerazioni anche alle abilità. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il programma SCANS (Secretary’s Commission on Achiving Necessary Skills, 1990), evidenzia cinque aree di competenza: risorse, capacità interpersonali, gestione delle informazioni, sistemi e uso delle tecnologie); e tre aree fondamentali di abilità: abilità di base, abilità di pensiero e qualità personali. In Canada vengono evidenziate tre macro-aree di abilità: abilità accademiche, abilità di gestione personale, abilità di lavorare in gruppo; e dodici livelli di competenze essenziali. In Italia non esiste ancora un approccio istituzionalizzato e socialmente condiviso legato alle abilità-competenze richieste dal mondo del lavoro ma si sta affermando il modello dell’ISFOL, il quale individua tre grandi macro aree: competenze di base, competenze trasversali, competenze tecnico-specifiche, all’interno delle quali enucleare delle aree di competenza più specifiche.
56 56
Gli as pe tti innovativi più r ile vanti de ttati dall’approccio pe r compe te nze s ono, fors e , più di tipo culturale - organizzativo che di tipo te cnico (Camuffo, 1996). Infatti, ta le approccio pur vole ndo rappre s e ntare un e le me nto di rottura r is pe tto a que llo bas ato s ui job , finis ce pe r cos tituirne , di fatto, il comple me nto e la continuazione logica, s pos tando l’e nfas i da un approccio re lazionale ogge ttivo ad uno s ogge ttivo ne lle politiche di ge s tione de lle r is ors e umane (Cos ta , 1997). Cons ide rando gli as pe tti di novità di una ge s tione de lle r is ors e umane fondata s ul conce tto di compe te nza gli ope rator i e gli s tudios i s i s ono conce ntrati s u alcuni as pe tti proble matici de ll’approccio e de i re lativi mode lli di ge s tione . Allo s tato attuale il dibattito s cie ntifico- manage r iale ruota attorno ad alcuni te mi di par ticolare inte re s s e . • L’approccio top dow n o bottom up cons ide rato più corre tto e d e fficace da utilizzare 43 . • La de finizione di compe te nza cons ide rata e , ne llo s pe cifico, la que s tione le gata alla ne ce s s ità- oppor tunità di as s ociare e le me nti di conos ce nza e s plicitabile e codificale ad as pe tti r iguardanti le caratte r is tiche ps icologiche 44 . • La tipologia di s trume nti e me todologie da utilizzare ne ll’individuazione de lle compe te nze : approcci s cie ntific i r igoros i o condivis i e le gittimati?45 • La applicabilità de ll’approccio pe r compe te nze a tutti i s is te mi di ge s tione de lle r is ors e umane 46 . • La pos s ibilità di utilizzare dizionar i di compe te nza ge ne r ici o s pe cifici47 . • La tipologia di funzioni o di azie nde in cui pote r applicare tale nuovo mode llo48 .
Ad ulte r iore dimos trazione de lla comple s s ità che ruota attorno al conce tto di compe te nze s i può r icordare che , in le tte ratura , gli s tudi che s i occupano di compe te nze s i ar ticolano s os tanzialme nte lungo due filoni s viluppatis i indipe nde nte me nte : a) que llo raz ionale - s trate gico- s is te mico che fonda la s ua atte nzione s ulle core compe te ncie s azie ndali (dove s i collocano l’approccio top dow n e que llo raz ionale s trate gico); b) e que llo ps icologico- culturale - indiv iduale che pone la s ua atte nzione s ulle compe te nze individuali (ove s i collocano, inve ce , l’approccio bottom up e que llo indiv iduale ps icologico).49 Il proble ma che s i pone ai mode rni s is te mi formativi, re lativame nte alla comple s s a que s tione de lle compe te nze , è que llo di tras fe r ire ai giovani que s to ampio e s e mpre più ar ticolato bagaglio di s ape r i te or ico- pratici, in
43 A questo dibattito contribuiscono, tra gli altri, autori quali: Bartoli, Bellocci, pero, Boccalari, Camuffo e Meger. 44 Gli autori di riferimento in questo caso sono: Boccalari, Bresciani, Camuffo, Cocco, Paletti e Goleman. 45 Per un approfondimento sul tema si rimanda a Kochanski. 46 Interessanti i contributi proposti su questo tema da Bartoli, Camuffo, Laweler. 47 Si veda su questo tema Raelin e Cooledge. 48 Per un approfondimento sull’argomento si consulti Camuffo, Cro e Negrin. 49 Per un approfondimento sugli elementi di differenza che distinguono questi approcci si veda Camuffo (2000, n. 178).
57 57
modo che s iano s pe ndibili s ul me rcato de l lavoro. Ma, a que s to propos ito, uno de i proble mi più impor tanti cons is te ne l fatto che il s is te ma formativo-e ducativo non s e mbra e s s e re in grado di forgiare i giovani, s oprattutto, pe r quanto r iguarda la macro are a de lle compe te nze tras ve rs ali. E que s to è molto pre occupante s e s i cons ide ra che ne ll’attuale conte s to, ta li compe te nze as s umono un’impor tanza s trate gica vis ta la nuova dime ns ione re lazionale , comple s s a e mute vole , che caratte r izza i proce s s i di lavoro. Il proble ma che s i pone all’atte nzione de l dibattito s cie ntifico e de gli ope rator i de l s e ttore , dunque , può e s s e re pos to in que s ti te rmini: r ice rcare me todi te or icame nte corre tti e programmi didattico- formativi e fficaci pe r l’acquis izione ge ne ralizzata di ta li abilità (Chiar i, 2000). La r iforma de ll’appre ndis tato, quindi, (ins ie me agli a ltr i s trume nti di a lte rnanza s cuola- lavoro) s i ins inua in que s to te ntativo di de finizione di un mode llo formativo capace di imme tte re i giovani in conte s ti di appre ndime nto prote tti, che s appiano favor ire , da una par te , l’acquis izione di conos ce nze te or iche e s ape r i codificati e is tituzionalizzati; dall’altra , l’e s e rcizio di un compor tame nto agito che pos s a dive nire , via via , s e mpre più e fficace e raffinato, grazie al proce s s o di s ocializzazione al ruolo e alla compe te nza me de s ima. Bis ogna r icordare , infatti, che le compe te nze non s ono un dato ogge ttivo, ma s ono il frutto di un proce s s o s ociale che s i cos truis ce , che ha bis ogno di e s s e re s cope r to, e che ne ce s s ita , a ltre s ì, di r iconos cime nto, di cons ape vole zza, di autonomia e di re s pons abilità. Una nuo va re lazio ne tra e duc azio ne e s o c ie ta’ po s t- fo rdis ta
Le teorie class iche
La cr is i de i s is te mi e ducativi s i trova da anni al ce ntro de lla r ifle s s ione inte rnazionale e dive rs e s ono le vis ioni che in que s ti anni s i s ono alte rnate ne l te ntativo di inte rpre tare que s to dis agio.50 A que s to propos ito s i può dire che la r ifle s s ione s ociologica re lativame nte al rappor to tra e ducazione e s viluppo ne lla s ocie tà mode rna proce de a corre nte alte rnata las ciando intrave de re il s us s e guirs i di fas i di ottimis mo e di fas i di pe s s imis mo, accompagnante , r is pe ttivame nte , da proge ttualità o cr itic ità (Be nadus i, 1993). Ne gli anni ’60 s i è as s is tito ad una grandis s ima e s te ns ione de lla s colar izzazione in tutte le s ocie tà indus tr iali gius tificata e s s e nzialme nte da due motivazioni: una di ordine e conomico e una di ordine s ociale . Pe r
50 Si fa riferimento, in particolar modo, alla teoria della de-qualificazione (Braverman, 1974); a quella della sovra-qualificazione che prende le mosse dal lavoro di Daniel Bell (1974), e, infine, a quella della polarizzazione (Touraine, 1993).
58 58
quanto r iguarda il motivo di ordine s ociale , s i r ite ne va che una ge ne ralizzata diffus ione di e le vati live lli culturali avre bbe prodotto un migliorame nto de lla qualità de lla vita; me ntre , pe r quanto attie ne alle caus e di ordine e conomico, s i r ite ne va che un aume nto ge ne ralizzato de lla cultura di bas e avre bbe avuto e s iti pos itivi s ul s is te ma produttivo e s ullo s viluppo e conomico. Que s ta convinzione trova il s uo fondame nto in que lla che vie ne de finita la te oria de l capitale umano che introduce pe r la pr ima volta un’e s te ns ione de l conce tto propr io de gli e conomis ti c las s ici.51
Con gli anni ’70 e le pre s s ioni impos te da una acuta cr is i e conomica, que s te ce r te zze ve ngono me s s e in dis cus s ione e s i s viluppano atte ggiame nti cr itic i ve rs o la s cuola che non vie ne più vis ta come s trume nto di promozione s ociale be ns ì come me zzo di auto- pe rpe tuazione de lle dis uguaglianze . In contrappos izione a que s ta impos tazione e dulcorata de l rappor to tra s is te ma e ducativo e s is te ma produttivo s i s viluppano due te or ie conflittualis te : que lla de lla corris ponde nza (te or ie marxis te de lla r iproduzione ) e que lla cre de nz ialis ta (ne o- we be r iana) 52 . Que s te te or ie , tuttavia , s i s ono r ive late incomple te e inade guate a dar conto de lla comple s s ità de l rappor to tra is truzione e produzione . La te or ia de l capitale umano punta, ad e s e mpio, e cce s s ivame nte s ulla qualificazione in rappor to al proce s s o lavorativo, s ottovalutando la s pe cificità s tor ica de l proce s s o in cui s i è ve nuta ad affe rmare la valor izzazione capitalis tica; me ntre le altre te or ie non cons ide rano in modo s ufficie nte la funzione e conomica de l s is te ma e ducativo che s i re alizza ne l formare capacità concre te pe r l’attività lavorativa (Fis che r , 1998), né cons ide rano s ufficie nte me nte le s pinte individuali por tate avanti dal s ogge tto che las ciano s e mpre ape r te de lle vie di fuga e di profonda re alizzazione pe rs onale . Se nza e ntrare ne llo s pe cifico di que s to dibattito largame nte rappre s e ntato ne lla le tte ratura s cie ntifica pre me qui r icordare , la s cars a inte grazione inte r - dis ciplinare che fino ad oggi ha caratte r izzato il rappor to fra s ociologi de ll’e ducazione e s ociologi o e conomis ti de l lavoro
51 Secondo la teoria del capitale umano (Schultz, 1961), l’educazione è in grado di aumentare la produttività del lavoro: per questo motivo le spese in istruzione rappresentano un investimento. La crescita di tale capitale realizzata nel secondo dopoguerra dai paesi industrializzati ne spiega il successo economico. Il punto debole di questa lettura è insito nel postulato di partenza secondo il quale “l’individuo più istruito è più produttivo”. Lavori recenti, mettono in evidenza l’elemento di criticità costituito dalla effettiva valorizzazione del capitale umano, che rappresenta il punto in cui la conoscenza, intesa come bene di consumo, si trasforma in fattore di sviluppo. “La crescita, infatti, oltre a dipendere dalla quantità di capitale e lavoro impiegati nonché dalla qualità di quest’ultimo è condizionata dagli elementi relazionali che collegano tra loro gli agenti economici […] questo nuovo filone di ricerca spiega la crescita economica sulla base della funzionalità della struttura relazionale che gli agenti economici sono in grado di costruire tra loro. Per un approfondimento di questo dibattito si veda: Putnam (1993); Tronti (1997); Zamagni (1998). 52 Secondo la teoria della corrispondenza il sistema educativo non ha il compito di trasmettere conoscenze e capacità utili nel sistema produttivo ma quello di formare modelli di comportamento adeguati all’organizzazione capitalistica del lavoro. Si tratta, dunque, di una corrispondenza differenziata nel senso che, ai livelli bassi dell’educazione, la formazione è volta alla sottomissione mentre ai livelli superiori premia la creatività e l’autonomia. (Bowles e Gintis, 1979). Secondo la teoria credenzialista, invece, i titoli sono delle credenziali per presentarsi sul lavoro e rappresentano un meccanismo di filtro che etichetta le persone in base al numero di prove che sono riuscite a superare. Per Collins la scuola non ha il compito di fornire conoscenze bensì quello di insegnare un linguaggio, dei modi di fare. In questa ottica i contenuti lasciano il posto ad uno stile di vita in quanto la vera preparazione si realizza on the job. L’autore giunge a fare una distinzione tra lavoro produttivo, che non necessita di credenziali educative, e lavoro politico, al quale si accede, invece, grazie alle credenziali (Collins, 1979). Per un approfondimento delle teorie sociologiche dell’educazione si consulti: Benadusi (1984).
59 59
ne lla r ice rca di chiavi di le ttura s ufficie nte me nte e s plicative re lativame nte alla diffic ile conne s s ione fra e ducazione e lavoro. Que s to ha por tato all’affe rmazione di te or ie o for te me nte ide ologiche , o fondate s u ge ne r iche as s unzioni, a ttorno al s is te ma e ducativo vis to come s e mplice r ifle s s o de l mondo produttivo.
In que s ti anni l’as s e tto e conomico mondiale , con il pas s aggio dal fordis mo al pos t- fordis mo, è cambiato profondame nte : s i as s is te ad un ince s s ante proce s s o di globalizzazione e di s viluppo de lle nuove te cnologie , a ll’affe rmars i di una s ocie tà s e mpre più comple s s a e police ntr ica, a lla tras formazione de i modi e de i proce s s i di produzione , ad un e le vatis s imo grado di compe tizione . Pur e s s e ndos i inde bolita la fiducia ne ll’e ducazione come me zzo di tras formazione de lla s ocie tà e come s trume nto di mobilità s ociale pe rmane , ciò nondime no, un for te cons e ns o, a live llo inte rnazionale , ne l cons ide rare l’is truzione la chiave di volta de l s ucce s s o individuale ne lla nuova s ocie tà de lla conos ce nza.
Le tras formazioni appe na citate hanno incis o profondame nte s ulle caratte r is tiche de l lavoro e s ulle r ichie s te di formazione da par te de l mondo impre nditor iale , il quale è s e mpre più or ie ntato ve rs o una formazione ge ne rale di bas e di tipo s colas tico che s i cos tituis ca come zoccolo duro s ufficie nte e ne ce s s ar io a re ce pire e inte rpre tare le informazioni utili a l lavoro. In altre parole , non s i r ichie dono più s oltanto compe te nze s pe cialis tiche , s e ttor iali, s tre ttame nte ope rative , ma anche , e s oprattutto, compe te nze tras ve rs ali che hanno una compone nte s ia di tipo cognitivo che di tipo s ociale - re lazionale . Il mondo impre nditor iale s e mpre più or ie nta le s ue s ce lte in bas e alle capacità s ociali- re lazionali, a lla fle s s ibilità funzionale , a lla capacità di lavorare in gruppo, alla capacità di auto- coinvolge rs i e s os te ne re gli obie ttivi azie ndali. Quali implicazioni ha tutto que s to pe r il s is te ma e ducativo- formativo?
Quali implicazioni per il s is tema educativo e formativo
Oggi s i as s is te ad una s or ta di contaminazione tra ambiti dis ciplinar i dive rs i, ad un nuovo dialogo, a lla r ice rca di un linguaggio inte rdis ciplinare che pe rme tta di dar conto de l comple s s o rappor to tra s is te ma e ducativo, s is te ma produttivo e s is te ma s ociale . Lo s forzo profus o va ne ll’ottica di s upe rare le tture parziali e ide ologizzate con l’individuazione di nuove le nti multi- dis ciplinar i. Non una s ommator ia de lle dive rs e inte rpre tazioni s e ttor iali ma il frutto di un re ale punto di incontro, ne ll’ottica di un comune ar r icchime nto in te rmini di compre ns ione pe r il gove rno de lla trans izione in atto. Grazie anche a que s to più maturo approccio, a lle r ifle s s ioni e alle
60 60
s pe r ime ntazioni che ne l cors o di que s ti anni s ono s tate nume ros e e s ignificative , s i è affe rmato un nuovo modo di pe ns are alla formazione . Un modo che non conce pis ce più la s e parazione fra te mpo di formazione e que llo applicativo. Le compone nti di que s ta tras formazione s ono dive rs e ma gli e le me nti che più di a ltr i s e mbrano de gni di nota s ono, s e condo re ce nti e laborazioni: la rapidità de i cambiame nti, la comple s s ità e la f le s s ibilità53 . Que s to nuovo s ce nar io e conomico- produttivo, bas ato s ul dinamis mo , la f le s s ibilità e la comple s s ità, combinato all’affe rmazione de l conce tto di qualità totale por ta all’affe rmazione di una tipologia di lavoratore nuova, pone ndo la ge s tione de lle r is ors e umane di fronte a due pros pe ttive . La pr ima, è que lla di bas are la propr ia organizzazione s ulla figura de l dipe nde nte us a e ge tta; la s e conda è que lla di s pinge re ve rs o l’affe rmazione di una figura profe s s ionalizzata , compatibile con una pluralità di impie ghi, in grado di ge s tire in modo autonomo tutti gli s car ti di conos ce nza e d e s s e re cos ì s e mpre aggiornato e r icollocabile ne l mute vole me rcato de l lavoro, a l fine di s tabilire con le innovazioni un rappor to non pas s ivo e s ubalte rno ma attivo e cre ativo. Il cambiame nto non è s olo a live llo te cnologico. Ciò che vie ne a modificars i profondame nte è l’inte ro impianto alla bas e de l mondo produttivo che tras forma radicalme nte s ia i proce s s i s ia l’organizzazione de l lavoro face ndo e me rge re ruoli e profe s s ioni comple tame nte dive rs i dal pas s ato. In tutti i pae s i indus tr iali i s is te mi s colas tici s i s ono adattati con difficoltà a que s to mutame nto de lla domanda ma in Ita lia , in par ticolare , s ono e me rs e profonde contraddizioni dovute in par te all’e re ditato impianto ge ntiliano54 che ha re s is tito, pre s s oché intatto, pe r de ce nni ne lla nos tra s cuola e , in par te , a l r itardo de l le gis latore che non ha s aputo, o non ha voluto, affrontare la que s tione ne i te mpi e ne i modi dovuti.55
53 Secondo alcuni osservatori tali fattori possono essere così definiti: “rapidità dei cambiamenti: la velocità con la quale cambiano strumenti, concetti e modalità di lavoro richiede una continua evoluzione delle competenze di chi lavora. Ciò comporta una trasformazione continua; non è più pensabile che la formazione iniziale risponda a tutte le esigenze evolutive nell’arco della vita professionale di un individuo; complessità: la sempre più sofisticata struttura dei modi di produrre e di amministrare, la complessità dei linguaggi e dei saperi fanno sì che l’inserimento sia nella vita produttiva che nella vita civile richieda sempre più conoscenze e abilità, cioè cicli di studio più lunghi e costosi. […]; flessibilità: è entrata in crisi l’organizzazione tradizionale del lavoro e della produzione, quella, per intendersi, basata sulla parcellizzazione del lavoro e sulle economie di scala” (Brigida, Degli Esposti, Lombardo 1992, p. 2). 54 Dopo la riforma della scuola media inferiore si è dovuto attendere fino alle riforme approntate sul finire degli anni ’90 (autonomia scolastica e riordino dei cicli) il nostro sistema educativo ha mantenuto, a parte piccoli aggiustamenti, l’architettura organizzativa progettata con la Riforma Gentile nel 1925. Con la Riforma Casati, all’indomani dell’unità d’Italia, la scuola si è presentata come il mezzo più idoneo per diffondere il senso dell’unità nazionale e la legittimazione del potere politico. In sintonia con le idee progressiste di matrice socialista si tese, così, ad incoraggiare il proseguimento degli studi anche per le classi meno agiate. Il sistema produttivo dell’epoca, però, era ancora essenzialmente basato sul lavoro manuale, di conseguenza, il mercato del lavoro risultava fortemente squilibrato a causa di una sovrabbondante offerta di lavoro intellettuale. La Riforma Gentile fu lo strumento utilizzato dal Regime fascista per riequilibrare questa situazione, con lo scopo dichiarato di limitare l’accesso ai livelli di formazione superiore. La soluzione individuata a questo scopo fu: introduzione di esami interni a carattere fortemente selettivo; creazione di scuole “vicolo cieco” che non consentivano l’accesso ai livelli superiori; distinzione gerarchica fra cultura “classica” e cultura “tecnica”. 55 Per un approfondimento del dibattito che ha caratterizzato per lunghi anni l’arena politica italiana in merito alla possibilità di una riforma del sistema scolastico si consulti: Benadusi (1988).
61 61
Con le r iforme de gli anni ’60- ’70 de lla s cuola me dia unica e con la libe ralizzazione de gli acce s s i, infatti, s i è raggiunto il me r ite vole obie ttivo di re alizzare la s colar izzazione di mas s a, ma ciò ha me s s o in luce alcuni limiti inte rni a l s is te ma, come l’e le vato tas s o di dis pe rs ione s colas tica e la diffus ione s e mpre più impor tante di a ttività formative collate rali; que s to fatto dimos tra che e s is te uno s car to tra le e s ige nze e s pre s s e dall’ute nza e le caratte r is tiche de i s e rvizi offe r ti.
In que s to modificato s ce nar io tra le tras formazioni più impor tanti e de gne di nota , bis ogna r icordare anche que lla che ha caratte r izzato la produzione e r iproduzione de lla cultura contraddis tinta , oggi, da s pinte contrappos te e non s e mpre coe re nti56 . Il r is ultato di que s to proce s s o di comple s s ificazione de lla s ocie tà s i può le gge re ne l fatto che , me ntre ne l pas s ato il live llo culturale de lle pe rs one coincide va con il loro grado di s colar izzazione , a ttualme nte , que s to, r is ulta e s s e re il frutto di un proce s s o dis continuo e dive rs ificato dove la s cuola vie ne a s volge re un pe s o r ile vante , tuttavia , s e nza e s s e re più de te ntr ice di un ruolo pr ivile giato.
Alla luce di tutto ciò, oggi più che mai, s i s e nte il bis ogno di r idis e gnare l’inte ro pe rcors o formativo al fine di r icondurre in un’archite ttura unica il var ie gato intre ccio di s timoli che prove ngono da fonti dive rs e . In que s ta nuova archite ttura, la s cuola non può né s ovrappors i né s os tituirs i a que s ti nuovi s timoli, bis ogna modificare l’approccio di par te nza in modo da tras formare il tradizionale s is te ma s cuola- ce ntr ico in un s is te ma più ar ticolato e fle s s ibile che ponga al ce ntro de ll’atte nzione il s ogge tto e i s uoi bis ogni formativi. Molto utile è s tato, a que s to s copo, il contr ibuto de i s ociologi de l lavoro pe r r ifle tte re s ulle nuove finalità che la formazione de ve as s olve re ne lla s ocie tà mode rna. Se condo De Mas i (1998) pe r e s e mpio, s i dovre bbe aus picare una formazione totale , inte nde ndo con que s ta de finizione una formazione in grado di pre parare conte mporane ame nte al lavoro, a llo s tudio e al te mpo libe ro, “pe rchè la vita di un adulto che s volge attività inte lle ttuali è ormai l’ine s tr icabile ‘ins ie me ’ di que s te tre forme comple me ntar i di umana vitalità”. Se condo l’autore , gli s quilibr i che contras s e gnano la s ocie tà mode rna pos s ono e s s e re corre tti a ttrave rs o un inte rve nto globale che inve s te tre dime ns ioni, tra loro collate rali, de lla vita s ociale : a live llo s ociale , a ttrave rs o una r idis tr ibuzione de l lavoro, de lla r icche zza, de l s ape re e de l pote re ; a live llo
56 La produzione culturale, oggi, è caratterizzata dalla complessificazione di alucne dimensioni come di seguito evidenziato: quantità, la società di oggi è enormemente più ricca di stimoli e di occasioni di sviluppo personale. Eventuali ostacoli alla crescita personale non sono da ravvisarsi nella scarsità delle occasioni ma semmai nella loro pletoricità; luoghi di produzione, nel passato la produzione di cultura riconosciuta spettava al mondo accademico-scientifico, oggi questo primato è venuto meno e la cultura si produce in un contesto molto più ampio che ingloba anche ambienti tradizionalmente ritenuti spuri (consumi, lavoro, sindacato ecc.); mezzi di comunicazione, un tempo anche la diffusione della cultura era affidata in modo quasi esclusivo alla parola orale e scritta. Oggi, al contrario, tale diffusione passa attraverso una grande varietà di strumenti mediali di vecchia e nuova generazione; agenzie fornitrici di cultura, un tempo l’intero sistema informativo faceva capo al mondo accademico, alla scuola, alla pubblicistica convenzionale. Oggi, al contrario, si sono affermate altre agenzie produttrici di informazione quali il mondo aziendale, le organizzazioni sindacali, le associazioni, la ricerca non accademica ecc..
62 62
azie ndale attrave rs o la dras tica r iduzione de ll’orar io di lavoro, la de s trutturazione de l te mpo e de llo s pazio (te le lavoro e cc.), la rapida fe mminilizzazione , l’e liminazione de lla burocrazia a favore de lla cre atività, l’a ttr ibuzione di s e ns o ad ogni mans ione , la s os tituzione de l controllo con la motivazione ; a live llo individuale attrave rs o il coinvolgime nto in attività formative di tutte le figure profe s s ionali ad ogni live llo de lla ge rarchia che aiutino il s ogge tto a r i- formars i a l lavoro dime ns ionandone il ruolo e la durata , abituars i a ve nde re r is ultati e non te mpo, acquis ire la capacità ne ce s s ar ie pe r ve nde re r is ultati ad alto valore aggiunto e proge ttare il propr io e d altrui futuro, ibr idare lavoro, s tudio e te mpo libe ro, formars i a ll’ozio cre ativo attrave rs o la cre s cita culturale , raffinare il propr io s e ns o e s te tico, te nde re ad una qualità s e mpre più alta de l propr io lavoro in funzione di una qualità s e mpre più alta de lla propr ia vita .
Gli s timoli, o fors e le provocazioni, che de r ivano da un impianto di que s to tipo s ono nume ros i e non facilme nte re alizzabili, tanto più ne l bre ve pe r iodo. Ma, da quanto e me rge , s e mbra ve nirci incontro l’ide a, ormai da anni dibattuta , e s os te nuta con forza anche dagli organis mi inte rnazionali, di un pe rcors o formativo inte grato tra s cuola e lavoro. Un pe rcors o di que s to tipo può e s s e re de finito come “l’alte rnars i di mome nti e d e s pe r ie nze dive rs e in funzione de i r is ultati formativi [ …] quals ias i a ttività può e ntrare a far par te di un pe rcors o formativo, purchè s iano r is pe ttate alcune condizioni fondame ntali: finalizzazione : ogni attività formativa r is ulta poco ge s tibile s e non s i pone obie ttivi pre cis i e ve r ificabili; olis mo: (pr incipio di ar ticolazione par ti- tutto) s upe rame nto di un mode llo di formazione cos tituito da par ti dis tinte e s e parate ; è fondame ntale che i var i e le me nti de l pe rcors o trovino un colle game nto organico, a maggior ragione s e s i tra tta di e le me nti e te roge ne i; conte s tualis mo: s upe rame nto di un mode llo di s ogge tto indiffe re nziato. Occorre , in par ticolare , abbandonare il mode llo ve te ro- indus tr iale de l prodotto s e r iale che de ve e s s e re ugualme nte valido pe r tutti. Il pe rcors o formativo ha un caratte re e s s e nzialme nte pe rs onale , anche s e ampiame nte r iconducibile a mode lli.” (Br igida, De gli Es pos ti, Lombardo, 1992, pp. 5- 6). Sulla s cor ta di que s te cons ide razioni s i pos s ono inte rpre tare anche le tras formazioni che hanno inve s tito ne l cors o de gli ultimi tre nta anni il mondo de lla formazione (tradizionalme nte inte s o) e che s i ce rche rà ora di s inte tizzare bre ve me nte r ipe rcorre ndo – attrave rs o i contr ibuti di Lipar i (1980), Iacci e Moroni (1995) le tappe s alie nti di que s to cambiame nto.
Si è ce rcato di por tare alla luce , ne lle pagine pre ce de nti, come l’or igine s tor ica de lla s cuola s ia le gata ad e s ige nze s pe cifiche di autor iproduzione e di dominio de lle clas s i dominanti e come , in vir tù di que s ta pe culiar ità, ne r is ultino e s trane i, pe r un lungo pe r iodo s tor ico, gli s trati infe r ior i de lla s ocie tà: c ioè, le clas s i marginalizzate dalla divis ione s ociale de l lavoro e
63 63
dal tipo di rappor ti di produzioni vige nti ne lla s ocie tà ad un ruolo lavorativo manuale e ad una pos izione di totale s ubalte rnità. Que s to caratte re or iginar io de ll’is tituzione s colatica la oppone al lavoro produttivo in modo che “la s cuola s i pone di fronte al lavoro come non- lavoro e il lavoro s i pone di fronte alla s cuola come non- s cuola” (Manacorda, 1971). T ale vis ione è r imas ta inalte rata ne l cors o de gli anni anche s e è ve nuta as s ume ndo, via via , conte nuti e forme dive rs e , più ade re nti a i tipi di organizzazione de l lavoro e de gli is tituti giur idico formali di volta in volta affe rmatis i. De l re s to la s cis s ione tra lavoro manuale e lavoro inte lle ttuale è ancora profondame nte radicata ne ll’immaginar io colle ttivo e , molto s pe s s o, le s ce lte di s tudio ope rate dai giovani ve ngono profondame nte influe nzate da tale conce zione . Pe r que s ta via , la formazione de s tinata alle clas s i dominanti s i re alizza all’inte rno de lle is tituzioni e ducative , me ntre alle clas s i s ubalte rne è de s tinato un tipo di formazione che avvie ne dire ttame nte s ul lavoro e ad e s s o è r igidame nte finalizzata . Come s i è ce rcato di s pie gare , tuttavia , il modo di produzione capitalis tico ne ce s s ita di un e norme bacino di forza lavoro da ins e r ire ne lla fabbr ica, pe r que s to motivo incide s u un progre s s ivo ampliame nto de gli s pazi di is truzione formale de s tinati a lla clas s e de i produttor i. A s os te ne re que s to proce s s o di a llargame nto de lla s cuola 57 anche agli s trati infe r ior i, incidono le forme giur idico- is tituzionali affe rmate s i ne lle s ocie tà capitalis tiche che s ono is pirati a i pr incipi di uguagliaza de i c ittadini. Cos ì, con l’affe rmars i de l capitalis mo, nas cono e s i diffondono in Europa le s trutture di ins e gname nto profe s s ionale la cui pe culiar ità è l’e s te ns ione come mome nto s e parato e dis tinto r is pe tto al mondo s cuola, di forme e le me ntar i di is truzione le gate alla loro utilizzabilità e d applicazione alla produzione capitalis tica. Que s to proce s s o è s os te nuto dal fatto che dalle or igini de l capitalis mo mode rno (Ve r te cchi, 1973) s i è avviato un proce s s o di s os tanziale de qualificazione de l lavoro manuale . La me ccanizzazione de lla produzione e la cons e gue nte framme ntazione de lle funzioni ha prodotto un re gre s s o - pe r quanto conce rne le pos s ibilità formative corre late al lavoro produttivo - r is pe tto alla s ituazione diffus a in molti pae s i e urope i tra il XVII e il XVIII s e colo. Lo s viluppo de l capitalis mo ha s os pinto la s cis s ione de l lavoro ve rs o una s e mpre più ampia razionalizzazione produttiva de te rminando que lla che in te rmini marxiani s i de finis ce alie nazione dal lavoro. In conclus ione , s i può as s e r ire che l’e s ige nza di avviare s trutture formative dire ttame nte or ie ntate alla pre parazione di lavorator i pe r lo s volgime nto di funzioni e s e cutive s i è pos to s oprattutto in re lazione all’alte rars i de gli e quilibr i produttivi pre ce de nti. T uttavia , è oppor tuno s ottoline are l’e ffe tto pe rve rs o che de r iva da que s to modo di inte nde re e di praticare la formazione . Infatti, s e pe r un ve rs o, in que s to modo, s i avviano all’is truzione larghi s trati di lavorator i che pos s ono allargare le propr ie bas i culturali e ampliare le
57 Scuola aperta tutti, come si è osservato nelle pagine precedenti, non significa concreta opportunità di raggiungere i massimi livelli di sapere formale racchiuso nei sistemi educativi, ma significa, ancora una volta, rigida separazione tra lavoro intellettuale e lavoro manuale.
64 64
occas ioni di appropr iazione dire tta de lla conos ce nza te cnica; pe r l’altro ve rs o, la conquis ta de ll’acce s s o all’is truzione , caratte r izzandos i in te rmini di e s as pe rata e d unidime ns ionale s pe cializzazione finalizzata al lavoro manuale , divie ne caus a di una ulte r iore e s propr iazione de l lavoratore manuale e de lle s ue s us ce ttibilità di s viluppo umano e culturale . Pe r que s ta via , accanto alla s cuola profe s s ionalizzante –inte s a come cinghia di tras mis s ione pe r il lavoro in fabbr ica – s i cr is tallizza la s cuola dis inte re s s ata alla pratica de l lavoro produttivo e de s tinata a formare la clas s e dominante , cos ì s i affe rma la tradizionale frantumazione de l s ape re che tr ionfa ne lla s cis s ione tra te or ia e pratica58 . Que s to modo di conce pire la formazione unitame nte al mode llo organizzativo (taylor- fordis ta) che ne ha s e gnato la ge ne s i hanno prodotto uno s trano fe nome no ne l mondo de lla formazione : una s os tanziale dicotomia tra formazione profe s s ionale e formazione manage r iale (Iacci, Moroni, 1995), ne lla quale , c iò nondime no, è pos s ibile r intracciare alcuni s e gni di cambiame nto. Le pr ime s cuole di adde s trame nto de gli anni ’50 s i s ono s viluppate come cons e gue nza dire tta de lla ipe r- s pe cializzazione funzionale e de lla parce llizzazione de l lavoro: e rano que s te le s cuole de ll’adde s trame nto te cnico- taylor is tico caratte r izzate da e cce s s iva s pe cializzazione e piatta concre te zza. I pirmi anni ’70, inve ce , ve dono affe rmars i una nuova vis ione de lla propr ie tà indus tr iale “vis ta come fonte di tutti i mali” (ivi). Si as s is te , in que s ti anni, a l for te s viluppo de lla formazione autoce ntrata , culturale e manage r iale in chiave motivazionale . E que s to tipo di formazione alta , manage r iale , ps icos ociale è caratte r izzata , s pe s s o, da e cce s s ivi live lli di de -s pe cializzazione . Ciò non toglie che in que gli anni ve ngano divulgati mode lli validis s imi. La s tor ia di que s ti anni, dunque , pe r un ve rs o o pe r l’altro te s timoniano di due mondi non comunicanti “con figure , s colar izzazioni, linguaggi, culture , abitudini e valor i, ma anche s trume nti e pras s i formative profondame nte dive rs i” (ivi). Ma le vice nde di que s ti ultimi ve nti anni hanno me s s o in e vide nza che i capis aldi s u cui poggiano le radici di que s ti compor tame nti s ono in rapidis s imo rove s ciame nto: l’organizzazione de lla produzione che ave va cre ato parce llizzazione e r igidità (favore ndo l’autonomizzazione e la chius ura de l s e gme nto de ll’adde s trame nto te cnico) s ta e volve ndo rapidame nte ne l s uo contrar io s pinge ndo ve rs o un cre s ce nte bis ogno di fle s s ibilità, inte grazione s is te mica, pe rce zione de lle inte rconne s s ioni, vis ione globale ; a l te mpo s te s s o, anche la vis ione di una formazione autorce ntrata or ie ntata a s k ill compor tame ntali e a mome nti culturali di s ocializzazione s ta rapidame nte de clinando por tando alla luce nuovi s pazi di inte rve nto.
A par tire dagli anni ’80, e in mis ura via via cre s ce nte , l’influe nza de ll’innovazione te cnologica s ui proce s s i produttivi e l’innovazione
58 Questa è la distintiva peculiarità che contraddistinte le istituzioni educativo-formative in tutte le società capitalistiche ove le differenziazioni sono costituite da sfumature formali e tecnico organizzative che variano da paese a paese in virtù della specifica connotazione storica, sociale e culturale che in ognuno di essi ha assunto il modello capitalistico.
65 65
organizzativa ne i re par ti e ne lle figure profe s s ionali por ta a te s s e re re lazioni s e mpre più s tre tte tra proce s s i organizzativi e formazione . E que s to pe rchè il pas s aggio da macchine s e mplice me nte az ionate a macchine controllate dall’uomo por ta con s é un de clino de l s ape r fare purame nte manuale - e s e cutivo a favore di un s ape re te cnico che implica la conos ce nza de lle logiche e la capacità di inte rve nire s ul proce s s o s te s s o. Dunque , è ne ce s s ar io pas s are da una cultura de ll’azione r ipe titiva ad una cultura de lla conos ce nza de i mode lli tradotti in pratica. Que s to impor tante cambiame nto di pros pe ttiva conduce ve rs o la r ice rca di un nuovo modo di inte nde re la formazione conce pita , ora , come for te me nte inte grata con le politiche organizzative e di s viluppo. Alla formazione “ancora impigliata ne l dualis mo fra adde s trame nto e formazione manage r iale , s i impone un ‘s alto ge ne razionale ’ s oprattutto ne lla s trume ntazione e ne lle me todologie ” (ibide m). E’ pos s ibile dis tingue re anche in Ita lia , dunque , tre diffe re nti fas i di e voluzione de l s is te ma formazione che hanno s e guito l’ite r di s viluppo appe na de line ato.
1. Ne l s e condo dopogue rra s i s ono rapidame nte diffus e s ul te r r itor io le s cuole di adde s trame nto is pirate , appunto, a ll’adde s trame nto all’azione r ipe titiva. T ale logica di formazione re s is te fino a tutti gli anni ’70 59 nonos tante i buoni inte nti pos ti ne ll’alta formazione .
2. Con i pr imi anni ’80 comincia ad andare in cr is i que s to colle game nto funzionale , s i manife s ta una cre s ce nte r ichie s ta - dappr ima implicita ma, via via , s e mpre più e s plicita e s trutturata - di una maggiore formazione te or ica (s e mpre più diffus a domanda di formazione pos t- diploma, cre s ce nte r ie ntro ne l s is te ma e ducativo anche da par te s ogge tti già avviati a l lavoro, cre s ce nte domanda di formazione prove nie nte da s ogge tti colle ttivi pe r faciliare proce s s i di r iconve rs ione e r iqualificazione le gati a ll’innovazione te cnologica e cc.) volta a r icongiunge re la s cis s ione tra s ape re e s ape r fare . E’ in que s ta fas e , e vide nte me nte , che ci s i confronta con la cre s ce nte ine guate zza de lla logica adde s trativa innanzi alle nuove e s ige nze pos te dal s is te ma produttivo e d e conomico.
3. Sul finire de gli anni ’90, infine , s i as s is te , ad un te ntativo e vide nte e s trutturato di r iqualificare e r ilanciare la formazione profe s s ionale (par ificazione r is pe tto agli a ltr i indir izzi di s cuola pos t- obbligo, r iforma de ll’appre ndis tato, tras formazione da CFP in age nzie formative , proce s s o di accre ditame nto de lle s trutture e cc.) a l fine di ade guar la alle nuove e s ige nze pos te dalle re altà produttive locali s e condo la logica de lla formaz ione inte grale e lungo tutto la vita che r ichie de al s ogge tto: inte r funzionalità, monitoraggio, cre atività, autonomia, par te cipazione re s pons abile .
59 Bisogna ricordare che il 1972 segna una svolta significativa in quanto in tale anno viene sancita normativamente, per essere attuata gradualmente negli anni successivi, la regionalizzazione dell’intera struttura della formazione professionale. Un’altra tappa fondamentale di questo processo di evoluzione è dato dalla emanazione della legge quadro sulla FP che ha fissato in via definitiva alcune fondamentali competenze regionali sulle residue competenze dello Stato, sulle finalità della formazione professionale e sui suoi raccordi con le strutture educative ordinarie (Lipari, 1980).
66 66
Anche la r iforma de ll’appre ndis tato s i ins e r is ce ne lla line a di s viluppo appe na tracciata (e che non ha alcuna pre te s a di e s aus tività) in quanto è ormai s otto gli occhi di tutti che il me ro affiancame nto al “mas tro” non è as s olutame nte in grado di garantire una r icompos izione de l s ape re , de l s ape r fare e de l s ape r e s s e re , in quanto il raggiungime nto de l s ucce s s o azie ndale oggi r ichie de di affrontare : dime ns ioni cognitiv e (s che mi logici, s imboli, mappe conce ttuali), dime ns ioni te cniche (funzioname nto e gove rno di macchie , impianti, proce dure , s is te mi informativi e , infine , dime ns ioni re laz ionali- comunicativ e (ge s tione di pe rs one , cambiame nto di cultura, di a tte ggiame nto, di profe s s ionalità e di approccio al lavoro), a lle quali corr is pondono le tre macro- are e di compe te nze da formare attrave rs o la formazione e s te rna pre vis ta dalla r iforma.
67 67
CAPITOLO TRE IL RAPPORTO TRA POLICIES E “SISTEMI”
Il c ambiame nto de lle po litic he formative e oc c upazionali A que s to punto de lla dis s e r tazione può e s s e re utile ope rare una analis i s tor ica de l modo in cui i conce tti di inte graz ione e di alte rnanza s cuola-lav oro s i s ono is tituzionalizzati a ll’inte rno de lle politiche pubbliche in ambito e ducativo e d occupazionale . In molti Pae s i e urope i, in que s ti anni, s i è ce rcato di fronte ggiare i danni caus ati dalla cr is i e dalle r is trutturazioni indus tr iali a ttrave rs o ammortizzator i s ociali (pre pe ns ioname nti, s os te gno al re ddito e cc.)60 . Pe r quanto r iguarda il proble ma de lla dis occupazione giovanile , inve ce , s i è fatto r icors o ad una grande var ie tà di s trume nti che hanno come comun de nominatore “la ne ce s s ità di unire i pe rcors i di qualificazione ai bis ogni e s pre s s i dalla domanda di lavoro alla fle s s ibilità de i rappor ti di lavoro” (Bulgare lli, 1992, p. 98), come , ad e s e mpio, contratti a te mpo de te rminato, par t- time , s alar io minimo di ingre s s o, fle s s ibilizzazione cre s ce nte e cc.. Ris pe tto agli anni ’70 e al pre vale re di mis ure garantis te , te nde nti a prote gge re il rappor to di lavoro s tabile e a te mpo pie no, le politiche pe r il lavoro e manate con gli anni ’80 s i contraddis tinguono pe r l’introduzione di mis ure promozionali e s e le ttive diffe re nziate . Si è as s is tito, un po’ ovunque , ad una for te acce le razione e incre me nto de lla s pe s a s ul piano de lle politiche formative . Sulla s cia de lle r ifle s s ioni che ale ggiano in campo inte rnazionale e , in par ticolar modo, ad ope ra de gli organis mi s ovra-nazionali, s i è ve nuta affe rmando una s ignificativa s e ns ibilità da par te de l le gis latore r is pe tto ai proble mi de lla formazione . I motivi di que s ta accre s ciuta atte nzione pos s ono e s s e re r icondotti a tre caus e pr incipali: e cce de nza de lla forza lavoro occupata ne i s e ttor i e ne lle impre s e indus tr iali in cr is i e in r is trutturazione (a cavallo tra gli anni ’70 e gli anni ’80); aume nto de lla dis occupazione giovanile in tutta Europa; for te dis occupazione adulta (pe rs one oltre i 25 anni) di lunga durata dovuta tanto al ralle ntame nto de lla domanda, quanto all’acce s s o al lavoro di larghe fas ce di pe rs one pr ima e s clus e (come , ad e s e mpio, le donne ) e , a l conte mpo, l’affe rmars i de ll’e me rge nza fas ce de boli (anni ’80).
Con gli anni ’90, s i as s is te ad una nuova inve rs ione di te nde nza frutto, da una par te , de lla s favore vole congiuntura e conomica che ha inve s tito gli
60 I provvedimenti finalizzati a combattere la disoccupazione adulta sono stati caratterizzati per lo più da azioni di incentivazione delle assunzioni. Solo marginalmente si è fatto ricorso a percorsi di formazione. Le vie perseguite possono essere sostanzialmente così riassunte: sussidi marginali all’occupazione, ovvero incentivi economici alle imprese che assumevano; creazione di lavoro nel settore pubblico; creazione di attività socialmente utili; incentivi di natura finanziaria per la creazione di lavoro autonomo.
68 68
Stati occide ntali e , dall’altra , de lla pre s s ante cr is i fis cale che attanaglia le amminis trazioni pubbliche cos tr inge ndole ad una ge s tione più cauta de lla s pe s a pubblica61 e a ll’adozione di nuovi pr incipi di gov e rnance 62 . Pe r gran par te de gli anni ’90, tutti i dis pos itivi di s pe s a e di inte rve nto largame nte utilizzati ne l de ce nnio pre ce de nte , s ubis cono un for te r idime ns ioname nto, e ve ngono mante nuti s olo pe r s os te ne re targe t di pe rs one r igidame nte s e le zionate in bas e a condizioni di r is chio e di marginalità (fas ce de boli, cate gor ie s vantaggiate e cc.). Già in que s to pe r iodo s i as s is te ad una ne tta r iduzione di tutte le mis ure a s os te gno de l re ddito e di cre azione di lavoro, me ntre aume ntano gli inte rve nti di tipo formativo.63
Pe r il de ce nnio appe na iniziato s e mbrano confe rmars i e r inforzars i a lcune te nde nze già de line ate s i ne gli ultimi anni ’90. A fronte di un me rcato de l lavoro profondame nte mutato, l’OCSE raccomanda di continuare s ulla via de lla fle s s ibilizzazione anche pe rché, gran par te de ll’incre me nto de ll’occupazione re gis trato ne gli ultimi tre anni è de r ivato dalle forme de l lavoro atipico che hanno introdotto s trume nti di fle s s ibilità (non s e mpre controllata) ne l me rcato (contratti a te rmine , par t- time , inte r inale , collaborazioni coordinate e continuative , a ltre forme di pre s tazioni profe s s ionali).64
La te nde nza diffus a ne i mode rni gove rni occide ntali è que lla di a ttuare una politica de l w e lfare to w ork – o We lfare attiv o - , c ioè un re gime r is tre tto di s us s idi e mis ure attive de l lavoro bas ato s u un nuovo pr incipio: que llo de ll’as s is te nza in cambio de ll’as s unzione di un impe gno formativo65 o lavorativo di pubblica utilità.
61 Con gli anni ’80 si afferma nelle società occidentali una nuovo modo di guardare ai problemi amministrativi. Quello che comunemente viene definito il New Public Management. Questa definizione riunisce diverse, e a volte contraddittorie, tecniche di gestione della cosa pubblica, ispirandosi al managerialismo di stampo americano e alla teoria dell’organizzazione classica. Sotto questa spinta, negli ultimi venti anni, un po’ ovunque, i paesi occidentali hanno proceduto ad una sorta di ristrutturazione della pubblica amministrazione attraverso: la privatizzazione, l’attenzione al cittadino come cliente, il decentramento, la pianificazione ed il management strategico, la promozione di ambienti competitivi, l’introduzione di strumenti di misurazione e di controllo, la flessibilità nella gestione delle organizzazioni pubbliche, la gestione del personale basata su incentivi, la separazione tra politica e amministrazione, l’introduzione dei concetti di efficacia, efficienza, qualità; la diffusione di tecnologie informatiche ecc. (D’Albergo, 2002). 62 Il concetto di governance si è diffuso recentemente in contrapposizione a quello di government e fa riferimento alle modalità e agli effetti dell’attività di governo piuttosto che all’assetto istituzionale dello stesso. Nello specifico, il concetto pone attenzione alle relazioni e alle dinamiche tra i diversi attori sociali che intervengono nel campo d’azione delle policy e non solo al ruolo del Governo centrale come tradizionalmente è stato inteso nella scienza politica. Elementi fondamentali nei processi di governance sono il decentramento istituzionale e la sussidiarietà che danno vita a dinamiche di governo reticolari piuttosto che piramidali o gerarchiche. 63 Questa tendenza è giustificata dal fatto che gli interventi a favore dei giovani che hanno fornito i risultati migliori nel breve e nel medio periodo sono quelli che “hanno impedito a coloro che non proseguono gli studi di presentarsi sul mercato del lavoro senza qualificazione. Ci si riferisce in particolare all’esperienza inglese secondo la quale a tutti i sedicenni che hanno terminato gli studi viene offerto un ciclo biennale di qualificazione certificata e in alternanza, presso imprese e centri di formazione sia pubblici che privati. Il vantaggio di questo espediente si può leggere sia nel breve periodo: allontanamento dei giovani dalle liste di disoccupazione; sia nel medio periodo: maggiore probabilità di accedere ad un lavoro qualificato una volta terminato il percorso formativo (Bulgarelli A. 1992, p. 98). 64 A livello settoriale continua a calare il lavoro nel settore agricolo e nel settore industriale mentre cresce quello autonomo, il terziario e le professioni legate alla new-economy (Rapporto ISFOL 2000/b). 65 Alla base di questo tentativo di ridisegnare interamente le strategie e gli interventi delle politiche formative sta la preoccupazione legata alla “ carenza di forza lavoro qualificata, in possesso di competenze e capacità tali da gestire e sviluppare cambiamento e innovazione costante” (Besozzi, 1998, p. 98). Le pressioni operate da un mercato del lavoro
69 69
Pe r We lfare attiv o può inte nde rs i “un s is te ma ne l quale lo s tato non s i limiti a tute lare i s ogge tti de boli (politiche s ociali di as s is te nza ve rs o i dis occupati e gli inabili, oltre che ve rs o coloro che s ono pe r de finizione fuor i de l me rcato de l lavoro come giovani in e tà s colare o pe ns ionati), ma promuova la capacità de i s ogge tti ne lla r ice rca de lle occas ioni di occupazione e di ins e r ime nto s ociale ” (Stame , 1998/bis , p. 260). Lo Stato, c ioè, non agis ce come s ogge tto unico ma s i pone come animatore di un ins ie me di politiche che r iguardano altr i s ogge tti a ltre ttanto attivi, a l fine di promuove re occas ioni di s viluppo e di utilizzazione de lle r is ors e umane . Il conce tto di w e lfare attiv o66 può e s s e re le tto anche con un’altra acce zione , que lla di “ins ie me di mis ure che te ndono ad un’attività pos itiva, a un r is ultato, che può e s s e re dire tto (aume nto di ‘occupazione ’) o indire tto (favor ire l’occupabilità67 )” (ivi, p. 261). L’ide a di w e lfare attiv o me tte al ce ntro de ll’atte nzione l’occupazione e s pinge a trovare s ine rgie tra politiche indus tr iali, politiche de lla formazione e politiche occupazionali, s upe rando, in que s to modo, due antiche dis tinzioni: a) la dis tinzione tra politiche de l lavoro e politiche s ociali, s e condo la quale le pr ime r iguardano i rappor ti tra impre nditor i e lavorator i, me ntre le s e conde r iguardano le pre s tazioni offe r te dallo Stato. Ne lla vis ione mode rna, le is tituzioni de vono guardare a un comple s s o di a ttività ove s ia le pre s tazioni s ociali che que lle pe r il lavoro ve ngono offe r te da un mix pubblico- pr ivato volto a promuove re l’occupabilità, cons ide rata “una de lle più appre zzate condizioni di be ne s s e re .” (Ivi); b) la dis tinzione tra politiche indus tr iali e politiche de l lavoro, e ntro cui s i colloche re bbe anche la formazione . Se condo que s ta dis tinzione , de lle politiche indus tr iali s i occupa lo Stato (minis te ro de ll’indus tr ia), me ntre de lle s e conde s i occupano gli e nti locali. Ne lla logica attuale s i r itie ne impos s ibile s e parare la formazione dalle politiche pe r l’occupazione e da que lle pe r gli ins e diame nti indus tr iali.
In un conte s to caratte r izzato da note vole turbole nza innovativa, come que llo le gato alla ne w - e conomy , dove la conos ce nza r is ulta un fattore s trate gico pe r la s opravvive nza, la ve ra dis cr iminazione non s ta tra chi pe rce pis ce o non pe rce pis ce un re ddito, be ns ì tra chi è ne lla pote nziale
sempre più flessibile e dalla economia post-industriale, caratterizzata dalla globalizzazione dei mercati, la ristrutturazione continua, la necessità di gestire e produrre continua innovazione al fine di fronteggiare una competizione sempre più aggressiva, l’affermazione di un orientamento alla qualità totale, pongono nuovi problemi al sistema educativo tradizionale costringendolo a trovare nuove risposte. Mantenere posizioni di privilegio all’interno di questo mercato travagliato non dipende soltanto dalla “creazione e dall’applicazione di nuove conoscenze per innovare il prodotto e il processo produttivo, ma anche dalla maggior flessibilità e rapidità rispetto alla concorrenza.” (ivi, p. 99) 66 Il welfare attivo di cui stiamo parlando ha mosso i suoi primi passi in Italia con l’avvio della concertazione tra le parti sociali con i documenti programmatici dell’accordo sullo stato sociale (settembre 1996) sfociato nelle misure adottate con il Pacchetto Treu (L. 196/97), e le successive misure attuative, il tutto inserito nella programmazione comunitaria. Questo nuovo sistema ha ridisegnato in maniera significativa i rapporti tra le parti sociali. 67 Una rivisiatazione del concetto di occupabilità è stata fornita da Gazier (2001), il quale asserisce che il problema del moderno mercato del lavoro non è solo trovare un’occupazione ma mantenere un alto livello di occupabilità lungo tutto il corso della vita, caratterizzata ormai da numerose transizioni.
70 70
condizione di far lo o no. Que s to fatto de te rmina uno s pos tame nto di a tte nzione da un s e mplice r is arcime nto pas s ivo, a fronte di un mancato re ddito (i tradizionali s us s idi di dis occupazione ), a ll’e rogazione di un’offe r ta formativa che as s icur i conos ce nze e compe te nze . Il pas s aggio dal conce tto di occupazione a que llo di occupabilità “modifica s ignificativame nte le analis i de i r is ultati e de gli impatti de i cors i di formazione , fino a ie r i ce ntrate s ugli e s iti occupazionali e non s u altre dime ns ioni di outcome , quali le condizioni di lavoro, la re mune razione , la s tabilità, le pros pe ttive di car r ie ra o di e voluzione profe s s ionale ” (Franchi e Palumbo, 2000, p. 10).
Dive rs i provve dime nti ne gli ultimi anni hanno introdotto ne l s is te ma ita liano (s ulla s cia di quanto avvie ne in altr i pae s i e urope i) una conce zione plurale e d inte grata de l s is te ma formativo, a l cui inte rno dovre bbe ro ope rare con par i dignità s cuola s e condar ia , unive rs ità, formazione profe s s ionale e impre s e . T ale cambiame nto me tte in cr is i i tradizionali s is te mi di valutazione e ce r tificazione s e gme ntati e non coordinati e re nde più comple s s a l’imputazione di s ucce s s o o fallime nto de lle politiche volte a promuove r lo.68 Se condo Franchi e Palumbo, la valutazione de lle politiche attive de l lavoro in Ita lia , è re s a più difficile dal fatto che “le politiche occupazionali s ono tuttora dis organiche , a live llo s ia ve r ticale che or izzontale , os s ia in te rmini di coordiname nto tra inte rve nti di live llo comunitar io, nazionale e re gionale [ …] e di inte grazione tra inte rve nti pre vis ti da fonti normative dive rs e a favore de lle s te s s e cate gor ie di be ne ficiar i” (ivi, 11).
L’ambito di una politica muta ne l cors o de l te mpo in re lazione all’e voluzione de llo s ce nar io s ocio e conomico e de i nuovi bis ogni s ociali e me rge nti. Pe r quanto r iguarda le politiche formative e d occupazionali, la fas e attuale è contras s e gnata da impor tanti cambiame nti: la fine de l monopolio pubblico de l s is te ma di collocame nto, l’avvio di un s is te ma di or ie ntame nto (ancora s pe r ime ntale ), il tras fe r ime nto di compe te nze dallo Stato ai live lli de ce ntrati (Re gioni e province ), lo s viluppo di re ti e par te nar iati locali69 , la promozione di forme di a lte rnanza s cuola- lavoro di var io tipo. T utto ciò, a l fine di favor ire l’inte grazione tra s is te ma e ducativo- formativo e s is te ma occupazionale e gove rnare me glio i mome nti di trans izione da un s is te ma all’altro. Un ulte r iore fattore di cambiame nto è rappre s e ntato dal nuovo or ie ntame nto as s unto dal Fondo Sociale Europe o che de finis ce pe r il pe r iodo 2000- 2006 le line e di utilizzo de i fondi comunitar i pone ndo par ticolare e nfas i a lla cos truzione di nuovi s e rvizi pe r il lavoro e
68 Riguardo alla difficoltà di fare corrette valutazioni su policy di questo tipo dobbiamo ricordare che si tende a rilevare gli aspetti più facili da misurare e non necessariamente quelli più importanti; nella formazione, il gradimento piuttosto che l’apprendimento, l’apprendimento piuttosto che il cambiamento. 69 Il partenariato, o partenrship, presuppone l’esigenza di coinvolgere tutti gli attori interessati alle azioni promosse dalla Ue. Da ciò deriva una concertazione e una costante collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, allo scopo di salvaguardarne l’efficacia (ISFOL, 1998).
71 71
all’adozione di un approccio pre ve ntivo pe r affrontare i proble mi conne s s i a lla dis occupazione . In pas s ato, ta li fondi e rano de s tinati e s clus ivame nte ad attività formative e ad azioni di as s is te nza te cnica o di accompagname nto. L’ampliame nto de i campi di inte rve nto de l Fondo Sociale Europe o as s e gna un ruolo di pr imo piano alle politiche de l lavoro. In que s t’ottica, i s e rvizi pe r il lavoro de vono dive ntare il pe rno de lle politiche attive . Se condo gli autor i, tuttavia , pe r favor ire que s to pas s aggio è ne ce s s ar ia una r ifle s s ione s u tre que s tioni fondame ntali: il rappor to tra s e rvizi pe r il lavoro e s trume nti di politiche attive 70 ; il ruolo de lla formazione all’inte rno de lle politiche de l lavoro71 ; il rappor to tra politiche de l lavoro e politiche pe r lo s viluppo locale 72 . Que s te r ifle s s ioni s ono bas ilar i pe r “traguardare ” con s ucce s s o l’inte grazione tra s is te mi e ducativo- formativo e d occupazionale poiché, come affe rma già Jallade s ul finire de gli anni ’70, i pe rcors i di a lte rnanza s cuola- lavoro s i ins e r is cono ad un croce via di inte rve nti s ulle politiche formative , occupazionali e giovanili. Alle quali, s e condo que s te ultime r ifle s s ioni, andre bbe ro aggiunte anche le politiche pe r lo s viluppo locale , que lle indus tr iali e que lle s ociali. Jallade (1980) anticipa la que s tione de lle politiche inte grate me tte ndo in e vide nza come l’inte grazione tra s is te mi e ducativo- formativo e occupazionale non può pre s cinde re da un dis e gno di policy comple s s o e inte rs e ttor iale . Un inte rve nto di policy dive nta più diffic ile e me no e fficace s e la s ua ge s tione è affidata a is tituzioni diffe re nti chiamate a gove rnarne ognuna uno s pe cifico s pe zzone , poiché s i ve r ificano tutta una s e r ie di proble mi inte rorganizzativi le gati a lla de te nzione de lle informazioni, a lla comunicazione , a lla qualità de lle re lazioni, a l controllo de lle r is ors e che pe s ano ne gativame nte s ul buon e s ito de ll’inte rve nto.
70 E’ doveroso puntualizzare che le politiche attive non sono possibili senza un sistema efficace di servizi per il lavoro. E, al contempo, un sistema di servizi non può essere efficace se non è integrato con politiche del lavoro in grado di promuovere opportunità di contatto con il mondo del lavoro e offrire alle imprese convenienze volte all’inserimento dei soggetti deboli. 71 E’ opinione comune ormai che la formazione deve superare il rischio di autoreferenzialità che l’ha caratterizzata fino ad oggi avviando un crescente processo di integrazione tra sistemi diversi (FP, Università, scuola, imprese), fino a giungere alla realizzazione di percorsi formativi personalizzati e integrati con azioni di servizio e tutoraggio, finalizzate ad accompagnare il soggetto nella costruzione del proprio progetto di vita personale e professionale. 72 In merito alla dimensione locale, bisogna considerare che una gran parte delle esperienze fondano sulla programmazione negoziata l’obiettivo di indurre processi di crescita ponendo una forte enfasi sulla fertilizzazione del contesto attraverso innesti di idee innovative correlate all’ingresso di nuove leve imprenditoriali. Franchi e Palumbo, asseriscono che le politiche per la formazione assumono come riferimento il soggetto proponendosi di rafforzare la sua dote di capitale umano per renderlo più competitivo, le politiche per lo sviluppo locale assumono come riferimento un intero territorio agendo sulle convenienze e sui sistemi di relazione in grado di produrre circoli virtuosi di sviluppo, infine, le politiche occupazionali assumono a riferimento due soggetti e la loro relazione: le imprese e i lavoratori.
72 72
Ricos truzione de l dibattito
Anni ’60- ‘70
Attorno alla me tà de gli anni ’60 il dibattito inte rnazionale ruota attorno al conce tto di cr is i, giacchè è pos s ibile ravvis are inte re s s anti moniti da par te de gli organis mi s ovra- nazionali volti a me tte re in luce la cr is i de l s is te ma s colas tico e occupazionale . Già ne l 1967 la Confe re nza Inte rnazionale s ulla cr is i mondiale de ll’e ducazione me tte va in luce come s i s te s s e pre nde ndo cos cie nza “de lla s cars a produttività de l s is te ma s colas tico tradizionale . Il cos tante aume nto de i cos ti, addir ittura con un andame nto be n s upe r iore a que llo inflativo, in as s e nza di r is ultati tangibili s ul piano de ll’incre me nto de l prodotto nazionale lordo avre bbe , pr ima o poi, condotto i politic i a mutare le propr ie convinzioni s ull’utilità s ociale de lla s cuola” (Bocca, 1984, p. 10). Circa die ci anni dopo comincia a pe ne trare ne l le s s ico politico e s cie ntifico il conce tto di e ducazione pe rmane nte . Con la pubblicazione de l Rappor to Faure s i può le gge re : “l’e ducazione dovrà e s s e re globale e pe rmane nte s e vuole davve ro formare que s t’uomo inte grale il cui avve nto appare ne ce s s ar io [ …] . Non s i tratta più di acquis tare , in modo puntuale , conos ce nze de finitive , ma di pre parars i ad e laborare , lungo tutto il cors o de lla vita , un s ape re in cos tante e voluzione : e pe rciò s i tra tta di appre nde re ad e s s e re ” (Faure , 1976, p. 9). T ale or ie ntame nto trova gius tificazione ne l fatto che “la cr is i de ll’is tituzione s colas tica appare unive rs alme nte acce ttata s ia s ul piano e conomico che su que llo pe dagogico. La formazione s colas tica non appare [ più] in grado né di cos tituire un age nte pe r la cre s cita pe rs onale né di as s icurare un’e guaglianza di pos s ibilità pe r tutti coloro che vi acce dono.” (Rappor to Rand, 1977, p. 10).
La s oluzione che già ne gli anni ’70 comincia a de line ars i è propr io que lla di un nuovo pe rcors o formativo bas ato s ull’alte rnanza s cuola- lavoro, s os te nuta dal fatto che , s e condo una dichiarazione de l Cons iglio e urope o (1980, n. 4, p. 5), ta le s trume nto s i pone anche come una mis ura capace di migliorare la s ituazione de ll’occupazione . Già in que s ti anni è for te la convinzione che l’alte rnanza s cuola- lavoro potre bbe “r ive s tire una tr iplice funzione : aume ntare le pos s ibilità occupazionali de i giovani; rafforzare le loro motivazioni profe s s ionali contr ibue ndo a chiar ire le s ce lte ope rate e d a r idurre la s us s e gue nte e cce s s iva mobilità lavorativa; indurre una migliore adattabilità al mutame nto otte nibile da chi abbia s e guito una formazione te or ico- pratica in alte rnanza.” (Jallade , 1980, p. 5). L’as pe tto r ile vante , comunque , re s ta le gato alla impos s ibilità, da par te de lla s ola alte rnanza, di
73 73
r is olve re la s ituazione occupazionale giovanile 73 in as s e nza di una ar ticolata politica formativo- e conomico- produttiva.74
A nni ‘80 E’ ne i pr imi anni ’80 che s e mbra affacciars i pe r la pr ima volta una nuova s tagione di policie s 75 (non me glio de finita come la s tagione de lle politiche inte grate ) pe r r icompar ire con de cis ione circa die ci anni dopo, quando, ne l maggio de l 1982, il Cons iglio de lle Comunità s ottoline a la “ne ce s s ità di ins e r ire le politiche formative ne l conte s to ge ne rale de lla s trate gia contro la dis occupazione ” (Gaz. Uff. CC. EE., 1982). In que s to pe r iodo la Comunità, a ttrave rs o le s ue commis s ioni, appare impe gnata s u molte plici fronti che vanno dalla de line azione de lle mis ure pe r la “r iduzione e r iorganizzazione de l te mpo di lavoro”(CC. EE., 10- 12.1982); a ll’e nucle azione de lle forme di impie go “pe r i giovani dotati di idone a formazione profe s s ionale ” (CC. EE., 10- 14.1982); a lla pre parazione de lla popolazione all’avve nto de lle nuove te cnologie (CC. EE.M 3- 6.1982). Con la Commis s ione Ke rr s i cominciano ad introdurre due nuovi conce tti, que llo di qualità de ll’is truz ione e que llo di re s pons abilità de l s ogge tto . Il rappor to prodotto da tale commis s ione , infatti, s ottoline a la ne ce s s ità di produrre un’e voluzione “ne ll’acce s s ibilità, ne lla qualità e ne lla par te cipazione re s pons abile de i s ingoli s ia alla propr ia e ducazione che al lavoro. Se appare fondame ntale in campo lavorativo ‘la capacità de ll’individuo di capire e di adattars i a i cambiame nti e conomici e te cnici’ [ …] . T re , [ s ono] dunque , i piani di inte rve nto pos s ibili: tras formare l’organizzazione lavorativa pe rché que s ta r ifle tta le as pirazioni fondame ntali de l capitale umano is truito; offr ire ambiti di ulte r iore is truzione ai già lavorator i; individuare s bocchi re ali dalla s cuola al lavoro e vice ve rs a.” (Bocca, 1998 , p. 152).
73 La disoccupazione giovanile è parte della disoccupazione strutturale, essa ha radici profonde all’interno della trasformazione delle condizioni di produzione; nel fenomeno di ineguale distribuzione dei posti di formazione e di lavoro; nell’ampliamento degli accessi al la lavoro anche a gruppi sociali tradizionalmente marginali. 74 Per quanto riguarda l’Italia, il 1976 ha rappresentato un anno chiave per il programma di azione comune. Nel febbraio dello stesso anno il Consiglio dei Ministri decide di affidare ad un Comitato per l’istruzione lo studio di due aspetti di fondo del sistema formativo professionale: a) le misure da adottare per la preparazione dei giovani al lavoro e per facilitare la loro transizione fra studio e vita attiva, onde diminuire le forme di disoccupazione giovanile; b) la delineazione di insegnamenti complementari per giovani lavoratori e disoccupati, onde favorire le possibilità di occupazione (Gazz. Uff. CC.EE, 19/2/76). Le soluzioni offerte dal Comitato si collocano su tre distinti piani: rafforzamento dei rapporti scuola-lavoro; ricerca di intense collaborazioni nel campo dei programmi integrati di istruzione e formazione professionale, fra scuola, formazione professionale e occupazione; integrazione nel lavoro dei giovani culturalmente più deboli e dei laureati che costituiscono le due fasce più difficili per l’occupazione. Con lo studio elaborato dal Comitato per l’istruzione si presenta per la prima volta sulla scena il concetto di integrazione che viene assumendo diverse declinazioni. Nella sua prima accezione (rafforzamento dei rapporti scuola-lavoro) il tema resta ancora implicito e non viene chiarito come tale rafforzamento debba avvenire. Nella seconda accezione, si comincia a parlare di programmi integrati tra istruzione e formazione professionale e tra istruzione, formazione professionale e mondo del lavoro; anche in questo caso, tuttavia, non vengono individuate delle strategie di azione operative, per le quali dovremo aspettare la fine degli anni ’90 con il Pacchetto Treu (Legge 196/1997). 75 Ci riferiamo alla moderna tendenza, affermatasi in seno alla Comunità europea, a parlare di policies integrate o complesse o strategie di azione. Tutti concetti che pongono in essere la questione di una più stretta integrazione-collaborazione tra settori di intervento tradizionalmente distinti e che solleva la sempre più sentita questione della valutazione, dell’efficacia e dell’efficienza.
74 74
Succe s s ivame nte con la Ris oluzione de l Cons iglio de l 22 dice mbre 1986, s ono s tate indicate alcune line e di azione dalla Comunità e urope a, poi r ipre s e con ins is te nza ne l cors o de l de ce nnio s ucce s s ivo.76 Gli e le me nti r icorre nti che hanno caratte r izzato que s te r ifle s s ioni pos s ono e s s e re r icondotti e s s e nzialme nte a tre s olle citazioni fondame ntali: s viluppare il dialogo tra le par ti s ociali a live llo e urope o; favor ire il confronto comunitar io in mate r ia di occupazione ; valor izzare la dime ns ione locale ne lla ge s tione de i proble mi de l lavoro e de ll’occupazione . A nni ‘90 Alcuni de gli e le me nti che hanno caratte r izzato la r ifle s s ione e le line e di inte rve nto de gli anni ’80, s ono s tati r ipre s i anche ne l de ce nnio s ucce s s ivo pone ndos i a lla bas e de i nuovi or ie ntame nti. T ali line e di r ifle s s ione pos s ono e s s e re cos ì r ias s unte : promozione de l dialogo s ociale e de lla circolazione de lle informazioni s u tutto il te r r itor io comunitar io in mate r ia di politiche attive ; valor izzazione de lla dime ns ione locale ;77 introduzione de lla dime ns ione valutativa ne lle politiche de l lavoro.
Anche s e i fondame nti te or ici che is pirano l’azione de lla Comunità e urope a ne gli anni ’90 s ono fondame ntalme nte gli s te s s i, bis ogna cons ide rare che il quadro e conomico a par tire dagli anni 1992/93 muta profondame nte pone ndo nuove s fide all’inte rve nto pubblico in mate r ia di me rcato de l lavoro e r ichie de ndo l’adozione di s trate gie comple tame nte nuove . Il pr imo s ignificativo cambio di rotta è r inve nibile ne l Protocollo di Maas tr icht. In ta le protocollo, infatti, l’ar t. 117, pur confe rmando l’obie ttivo comunitar io de l pie no s viluppo de lle r is ors e umane , a tto a cons e ntire un e le vato e duraturo live llo occupazionale , è accompagnato da un s ucce s s ivo ar ticolo (118) in cui s i indica la ne ce s s ità di s pe cifici s trume nti di inte rve nto: la Comunità è chiamata a s os te ne re e comple tare l’azione de gli Stati me mbri attrave rs o dire ttive in mate r ia di inte grazione de lle pe rs one e s clus e dal me rcato de l lavoro e contr ibuti in favore de ll’occupazione . L’ar t. 118 cons ide ra anche la pos s ibilità di avviare e s pe r ie nze di contrattazione colle ttiva a live llo e urope o.
La te nde nza più attuale fa re gis trare una cre s ce nte atte nzione ve rs o la que s tione de ll’inte grazione e conomica e s ociale e il r iconos cime nto re ciproco fra gli s tati me mbri pe r quanto conce rne titoli e qualifiche profe s s ionali, a l fine di favor ire la libe ra circolazione de lle conos ce nze e de i lavorator i. Il quadro di inte rve nto, quindi, è caratte r izzato dalla
76 Tali linee di azione si basano su quattro obiettivi fondamentali: promozione di nuove attività di impresa e crescita dell’occupazione con particolare attenzione alle piccole e medie imprese; miglioramento del funzionamento dei mercati del lavoro attraverso una progressiva flessibilizzazione delle forme di accesso, misure di orientamento e incoraggiamento della mobilità; investimento nella formazione delle risorse umane; sostegno ai disoccupati di lunga durata. 77 E’ sulla scia di questi stimoli che si sviluppano a partire dagli anni ’80 tutte quelle iniziative locali per l’impiego fondate sulla cooperazione fra singoli, gruppi, parti sociali, istituzioni locali ecc.. Tali esperienze saranno seguite negli anni successivi da programmi di job creation, job creation employment-oriented e job creation autonomy- oriented.
75 75
ne ce s s ità di ope rare mutame nti s trutturali de l s is te ma e conomico e produttivo, di favor ire la cre s cita e conomica, di fle s s ibilizzare il me rcato de l lavoro e , infine , di promuove re una più s tre tta collaborazione (inte grazione ) tra i live lli nazionale , re gionale e locale e tra i dive rs i a ttor i.
In que s to s ce nar io, la s trate gia de lla formazione de lle r is ors e umane as s ume un ruolo de cis ivo. Uno de i più impor tanti docume nti comunitar i in mate r ia di innovazione de i proce s s i e de i s is te mi formativi è il Me morandum s ulla formazione profe s s ionale pe r gli anni ’90. In ta le docume nto s ono e vide nziate tre que s tioni de te rminanti pe r la formazione : il valore de lla formazione de lle r is ors e umane come forza cre ativa; la ne ce s s ità di cos truire un me rcato de lle qualifiche e de lla formazione ; l’impor tanza de lla formazione pe rmane nte . La Comunità, dunque , s i pone un obie ttivo nuovo: que llo di favor ire il coordiname nto de lle diffe re nti politiche di formazione , produce ndo una s e mpre maggiore os mos i tra i diffe re nti s is te mi: “coordiname nto de lle politiche , conve rge nza de lle iniziative e coope razione trans nazionale ” (Zucche tti, 2001, 219).
Un ulte r iore pas s o avanti vie ne fatto con la Raccomandazione de l Cons iglio de l 30 giugno 1993 ove vie ne r iaffe rmato il ruolo di promozione , s timolo e coordiname nto de lla Comunità e urope a. Le novità di r ilie vo r is ie dono ne l fatto che la que s tione de ll’is truzione vie ne ins e r ita de ntro le politiche comunitar ie pe r la promozione de lle r is ors e umane e , a l conte mpo, vie ne collocata de ntro al quadro de lla coope razione s is te matica tra s is te mi e ducativo- formativo e s is te mi produttivi e urope i con una s pe cifica atte nzione ai bis ogni di innovazione e s viluppo de l te s s uto indus tr iale e produttivo. Vie ne introdotta in manie ra for te l’ottica de l police ntr is mo de l s is te ma formativo che impone un inte rve nto di coordiname nto, colle game nto, inte grazione . Anche la r iforma de i Fondi s trutturali (come s i os s e rve rà me glio ne l pros s imo paragrafo) s i ins e r is ce in que s ta politica di promozione de lla coe s ione e conomica e s ociale .
In que s ti ve nti anni di s tor ia che s i è ce rcato di pe rcorre re rapidame nte , e s e nza alcuna pre te s a di e s aus tività, ne l te ntativo di tracciare la trama di que s to dibattito, la s ocie tà è profondame nte mutata . Da quanto e me rge , in quals ias i s e gme nto di vita , da que llo e conomico a que llo produttivo-organizzativo, da que llo finanziar io a que llo de lle re lazioni inte rnazionali, dalla s fe ra pubblica a que lla pr ivata , nulla è più uguale a pr ima. L’archite ttura e ducativo- formativa, a l contrar io, s i pre s e nta come una de lle poche s trutture che s i è maggiorme nte cons e rvata ne l te mpo: l’as s e fondame ntalme nte umanis tico- tras mis s ivo de i conte nuti pre de finiti rappre s e nta ancora oggi il s uppor to di un s is te ma che nonos tante s i s ia ape r to alla s colar izzazione di mas s a non s i è las ciato tras formare . Anche la cre azione di molte plici canali di formazione profe s s ionale e te cnica rappre s e nta un e le me nto di cons e rvazione de ll’as s e tto tradizionale ,
76 76
s e condo la logica bas ata s ulla r igida s cis s ione tra un pr ima te or ico-acquis itivo e un dopo ope rativo e pratico (Drucke r , 1978).
Il traino de l Fondo sociale europeo e la nuova programmazione
Un ruolo di s traordinar ia impor tanza è s tato s volto dal Fondo s ociale e urope o, il quale s i è r ive lato un valido s trume nto di acquis izione , confronto e diffus ione di una cultura de ll’inte grazione tra i dive rs i a ttor i de lle politiche formative e de l lavoro. Da quando la politica di coe s ione ha as s unto for te impor tanza ne ll’Unione , i fondi s trutturali, de s tinati a cre are le s trutture e i pre s uppos ti pe r uno s viluppo più rapido e marcato, hanno s ubito modifiche te s e a prolungarne la durata e pote nziarne gli e ffe tti. La pr ima impos tazione organica r is ale al pe r iodo 88/93, a lla quale è s e guita la programmazione 94/99. In que s te programmazioni s ono s tati dappr ima s tabiliti (1988) e poi aggiornati (1993) i pre s uppos ti giur idici de i fondi e i re lativi obie ttivi. L’Age nda 2000 ha rappre s e ntato una note vole e voluzione ne gli obie ttivi, ne i conte nuti e ne ll’organizzazione de i fondi, anche s e non ha modificato i fondi propr iame nte de tti che s ono r imas ti immutati: il fondo Sociale Europe o (FSE), il fondo Europe o di Sviluppo Re gionale (FERS), il Fondo Europe o di Or ie ntame nto e di Garanzia de ll’Agr icoltura (FEOGA) e , infine , lo Strume nto Finanziar io di Or ie ntame nto de lla Pe s ca (SFOP).
Dopo un lungo dibattito s viluppatos i ne gli organis mi e urope i (Par lame nto, Commis s ione , Comitato e urope o di Be r lino) ne l marzo 1999 s ono s tate approvate de finitivame nte le line e tracciate dalla commis s ione pe r l’impos tazione de i fondi pe r il nuovo pe r iodo 2000- 2006. Re ce nte me nte è s tato e manato dal Cons iglio de ll’Unione Europe a il re golame nto – e le s ue dis pos izioni attuative – de i fondi s trutturali pe r la programmazione ne l pe r iodo 2000- 2006. Que s ta iniziativa inte nde por tare a te rmine il proce s s o di r iforma de lle pr incipali politiche e urope e di coe s ione e conomica e s ociale attrave rs o una r iduzione de l nume ro de gli obie ttivi pr ior itar i che s ono pas s ati da s e tte a tre .78 Il FSE, infatti, rappre s e nta il pr incipale s trume nto finanziar io e urope o pe r lo s viluppo de lle r is ors e umane e pe rs e gue due obie ttivi. Da una par te mira a far cre s ce re le oppor tunità di occupazione s ul me rcato inte rno. Dall’altra , mira al rafforzame nto de lla coe s ione e conomica e s ociale r iduce ndo gli s quilibr i tra le re gioni e gli Stati. Ciò avvie ne s os te ne ndo le politiche nazionali e re gionali de lle zone più de boli e , s oprattutto, appoggiando le politiche
78 L’Obiettivo 1 promuove lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo. L’Obiettivo 2 è destinato a sostenere la riconversione economica e sociale delle zone che devono affrontare problemi strutturali. L’Obiettivo 3 offre un sostegno all’adeguamento e all’ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione. Ed è proprio all’interno di quest’ultimo obiettivo che si gioca la strategia europea per l’occupazione. Il nuovo regolamento dei Fondi strutturali è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 26.06.1999.
77 77
occupazionali de i pae s i me mbri79 . La politica comunitar ia di coe s ione s ociale e d e conomica s i fonda e s s e nzialme nte s ul principio di s us s idiarità, e s plicita to ne ll’ar ticolo 3B de l me de s imo tratta to: “ne i s e ttor i che non s ono di s ua e s clus iva compe te nza la Comunità inte rvie ne , s e condo il pr incipio di s us s idiar ie tà, s oltanto e ne lla mis ura in cui gli obie ttivi de ll’azione pre vis ta non pos s ono e s s e re s ufficie nte me nte re alizzati dagli Stati me mbri e pos s ono dunque , a motivo de lle dime ns ioni e de gli e ffe tti de ll’azione in que s tione , e s s e re re alizzati me glio a live llo comunitar io”. In s inte s i, s ono quattro i te mi tras ve rs ali che fondano tale pr incipio e s ono: il par te nar iato (ve di oltre ) la programmazione 80 , l’addizionalità81 e la conce ntrazione 82 . Riguardo alla nuova programmazione il Fondo Sociale Europe o ne l pe r iodo 2000- 2006 rappre s e nta uno de gli s trume nti di s os te gno de lla s trate gia e urope a pe r l’occupazione e conce ntra i s uoi inte rve nti s ull’ade guame nto e s ull’ammode rname nto de lle politiche occupazionali e s ull’inte grazione s ociale ne l me rcato de l lavoro. Sono cinque i s e ttor i di inte rve nto in cui s i ar ticola la nuova programmazione FSE: politiche attive de l me rcato de l lavoro volte a pre ve nire e combatte re la dis occupazione , lotta all’e s clus ione s ociale , s viluppo de i s is te mi di formazione profe s s ionale e de lla formazione lungo tutto l’arco de lla vita , adattabilità de lla forza lavoro e de lle impre s e ai mutame nti de l me rcato de l lavoro, azioni pos itive pe r le donne . All’inte rno di ta li s e ttor i s ono s tati individuati, inoltre , tre campi or izzontali di inte rve nto: iniziative locali pe r l’occupazione , dime ns ione s ociale e de l me rcato de l lavoro ne lla s ocie tà de ll’informazione , par i oppor tunità tra uomini e donne .83
79 Nell’art. 123 del Trattato dell’Unione europea, infatti, si può leggere: “…per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell’ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che ha l’obiettivo di promuovere all’interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l’adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale.” 80 Il processo di programmazione non è definito nei dettagli dai Regolamenti. Possiamo dire, comunque, che esso presuppone una dettagliata analisi della realtà su cui si vuole intervenire, definisce obiettivi e strategie, predispone strumenti di monitoraggio, prevede azioni di correzione attraverso una attenta valutazione in itinere. 81 In base a questo principio i Fondi strutturali non devono essere sostitutivi alle risorse nazionali ma devono aggiungersi a queste per aumentare l’efficacia degli interventi. Nell’art. 123 del Trattato dell’Unione europea, infatti, si può leggere: “per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell’ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che ha l’obiettivo di promuovere all’interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l’adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale.” 82 In base a questo principio le risorse comunitarie, per raggiungere l’obiettivo della coesione economica e sociale, debbono essere concentrate in aree di particolare disagio, al fine di annullare i divari esistenti rispetto alle regioni più sviluppate. Secondo uno studio del Parlamento europeo il 45% delle risorse del Fondo sociale europeo è stato concentrato nelle aree più povere, con un incremento nel tempo. 83 Tra i principi essenziali di questa riforma vi è quello della concentrazione degli obiettivi di intervento comunitario al fine di trasformare gli interventi in diversi strumenti di sviluppo delle politiche comunitarie. Gli obiettivi prioritari assegnati ai fondi strutturali sono così riassumibili: promozione delle regioni in ritardo di sviluppo (ob. 1); riconversione delle aree gravemente colpite dal declino industriale (ob. 2); lotta contro la disoccupazione di lunga durata (ob. 3); facilitazione dell’inserimento professionale dei giovani (ob. 4); incentivazione dello sviluppo nelle zone rurali (Ob. 5). (IASM, 1990). La cosa più importante da ricordare, però, è il principio ispiratore di tale riforma che si fonda sulla compartecipazione, ovvero concertazione stretta fra Commissione delle Comunità europee, Stato membro e autorità locali (nazionali, regionali o locali). La compartecipazione si fonda sul principio di sussidiarietà, secondo il quale l’azione strutturale comunitaria deve essere complementare alle iniziative locali, in un quadro di forti
78 78
Le politiche de l lavoro s ono s tate caratte r izzate , fino alla fine de gli anni ’70, da una s os tanziale ce ntralizzazione , a lla quale , ne l cors o de l de ce nnio s ucce s s ivo, ha fatto s e guito una cre s ce nte impor tanza de gli e nti locali e d, in par ticolare , de lle re gioni84 , a s e guito di que llo che vie ne de finito, da Zucche tti (2001), s fondame nto de lle compe te nze . La dime ns ione locale è ve nuta affe rmandos i di par i pas s o con l’impors i di un me rcato de lla formazione pluralis tico e de l cambiame nto de i proce s s i e conomici e lavorativi che hanno di fatto favor ito il r ipe ns ame nto de lle forme di re golazione s ociale . Lo s pos tame nto cre s ce nte ve rs o la dime ns ione locale ha por tato, a ltre s ì, a ll’affe rmars i di nuove s trate gie di gov e rnance che chiamano in caus a in manie ra s e mpre più mas s iccia e d e s plicita la ne ce s s ità di r icorre re a modalità inte grate e par te cipate di de cis ione e di ge s tione .
Anche in Ita lia , ne l cors o de gli anni ’80 s i è re gis trata una cre s ce nte valor izzazione de lla dime ns ione locale ne lle politiche de l lavoro s ia ne lla r ifle s s ione s cie ntifica s ia come line a di inte rve nto de i s ogge tti pubblici. Da qualche anno, tuttavia , s i as s is te ad un proce s s o di r i- ce ntralizzazione de lle politiche de l lavoro che conduce ad una s or ta di ambivale nza tra ce ntralizzazione e live llo locale e che può e s s e re caratte r izzato anche da un ce r to conflitto pe r la de te nzione di ambiti di compe te nza conquis tati s ul campo.
Un rapido confronto tra organismi sovranzionali
Anche dai rappor ti de lla Banca Mondiale , a par tire dagli anni ’90, s i e vince l’accre s ciuta cons ape vole zza de llo s tre tto le game e s is te nte fra inve s time nti ne lle r is ors e umane e cre s cita de lla produttività de l lavoro e de l be ne s s e re e conomico. In ta li rappor ti ve ngono individuati anche i canali a ttrave rs o cui l’e ducazione influe nza la produttività. Una pe rs ona più is truita è in grado di compre nde re le nuove informazioni in modo più ve loce e di applicare nuovi proce s s i di lavoro in modo più e fficace e corre tto, il che , in un conte s to caratte r izzato da una cre s ce nte innovazione te cnologica, rappre s e nta un vantaggio compe titivo. L’e ducazione s viluppa abilità che hanno un e ffe tto impor tante s ulle capacità impre nditor iali de i s ogge tti come , ad e s e mpio, la capacità di as s ume re r is chi ponde rati, il s e ns o di re s pons abilità, la capacità organizzativa e di pianificazione de l lungo pe r iodo, la ge s tione de lle r is ors e umane e cc.. “Accre s ce re le abilità
interdipendenze tra le azioni promosse e tra gli attori economici e sociali coinvolti. (Commissione delle Comunità europee, 1992, 1993, 1994). Per un approfondimento si consulti il sito di Europa lavoro, sito ufficiale del FSE in Italia. 84 E’ proprio nell’ottica della prospettiva locale che la Comunità europea, in questi anni, ha fortemente investito sulla dimensione territoriale dello sviluppo favorendo la diffusione di interventi - come, ad esempio, LEDA (Local Employment Development Action), mirati a rafforzare l’approccio locale e rendere più stretti i legami tra programmi locali e sovra-locali.
79 79
e le capacità de i lavorator i è la chiave de llo s viluppo e conomico in un’e conomia globale s e mpre più inte grata e globale ” (Moro, 1998, p. 12). Bis ogna te ne r pre s e nte , nondime no, che la formazione da s ola non può inne s care proce s s i di s viluppo: “è ne ce s s ar ia la cons ape vole zza cr itica de i s uoi limiti s ottoline ando che la comple me ntar ie tà fra politiche macroe conomiche , inve s time nti fis ici e inve s time nti in capitale umano è valida in quals ias i dire zione la s i le gga” (ivi, p. 16). In altr i te rmini, è impor tante che ci s ia un e ffe ttivo utilizzo de l capitale umano (ne ll’acce zione pr ima te matizzata) formato e che tale capitale s ia ade guato dal punto di vis ta qualita tivo e quantita tivo al conte s to locale . L’inve s time nto in capitale umano r is chia di e s s e re improduttivo s e le abilità acquis ite a s cuola non s ono que lle r ichie s te dal me rcato (vis ta la rapida de pe r ibilità de lle compe te nze ), o s e l’e ducazione di alto live llo è promos s a a s capito de lla s colar izzazione pr imar ia , s e condar ia e profe s s ionale . E’ impor tante e vide nziare che , a l par i de lla Banca Mondiale (che conce ntra la s ua are a di inte re s s e s ui pae s i de l T e rzo Mondo), il s ottile e impor tante le game tra formazione e s viluppo è s ottoline ato anche dal libro bianco di De lors (1993), ove vie ne individuato il proble ma ce ntrale che pre occupa il ve cchio contine nte , que llo de lla dis occupazione 85 . Ne l libro di De lors tras pare la cons ape vole zza che la cre s cita e conomica non è più l’unica s oluzione alla dis occupazione , me ntre s i affe rma la ne ce s s ità di re alizzare le politiche attive de l lavoro86 e l’appre ndime nto lungo tutto l’arco de lla vita (CC. EE, 1993). Que s ta cons ide razione è il frutto di una analis i congiunturale s e condo la quale “la r icche zza de lle Nazioni appare s e mpre più fondata s ulla cre azione e l’impie go produttivo de lle conos ce nze e , in que s to campo, vie ne r iconos ciuto un indubbio vantaggio compe titivo ai Pae s i de lla comunità. Ciò non s ignifica cre de re , come ha fatto tanta cattiva le tte ratura, ne lla marginalità de ll’impre s a indus tr iale a vantaggio de l mitico ‘te rziar io’. E’ s e mpre l’indus tr ia manifattur ie ra al ce ntro de l s is te ma e conomico, s olo che gli e le me nti de te rminanti pe r la s ua compe titività s i s ono s pos tati dai cos ti dire tti de i fattor i di produzioni a var iabili di s is te ma come l’e fficie nza de ll’organizzazione , la capacità di migliorame nto continuo, lo s fruttame nto indus tr iale de lla r ice rca e s viluppo, la compe titività de lle infras trutture di s e rvizio, la qualità de lla formazione , l’as s unzione di re s pons abilità pe r gli e ffe tti s ociali de lle s trate gie
85 In tale libro si distingue tra disoccupazione congiunturale, strutturale e tecnologica. La prima deriva dal rallentamento ciclico della crescita economica. La seconda deriva dalla modificazioni che intervengono nei sistemi economici come, ad esempio, l’alto costo del lavoro, la divisione internazionale del lavoro, la rigidità delle strutture occupazionali e le politiche del lavoro. Infine, l’ultima è legata all’affermarsi di nuove tecnologie che consentono un risparmio della manodopera impiegata nei processi lavorativi (Commissione delle Comunità europee, 1993, p. 16). 86 Sinteticamente possiamo distinguere le politiche del lavoro in passive e attive. Le prime, più tradizionali, tendono a garantire il posto di lavoro e proteggere i disoccupati. Le seconde hanno come obiettivo l’inserimento delle persone nel mercato del lavoro e consistono in interventi quali la diffusione di forme contrattuali più flessibili di quella a tempo indeterminato, le incentivazioni alle imprese per nuove assunzioni, la promozione di imprenditorialità, l’addestramento professionale, il recupero al lavoro dei disoccupati di lunga durata.
80 80
indus tr iali, ad e s e mpio ne l campo de lla tute la de ll’ambie nte ” (ibide m, p. 66). Le propos te di r iforma de i s is te mi e urope i di is truzione e formazione profe s s ionale s e guono le s te s s e s ce lte s trate giche pre s e nti ne i docume nti de lla Banca Mondiale e pos s ono e s s e re cos ì s inte tizzate : lotta alla dis occupazione che as s icur i a tutti una s olida formazione di bas e inte grata con la formazione profe s s ionale e la formazione on the job (appre ndis tato e tirocinio); s viluppo e s is te matizzazione de lla formazione continua e pe rmane nte ne ce s s ar ia pe r as s icurare alle azie nde un’ade guata capacità compe titiva. Il te ma de ll’inte grazione tra s is te ma di is truzione , s is te ma profe s s ionale e mondo de l lavoro ha acquis tato, dunque , ne gli ultimi anni, una cre s ce nte impor tanza a live llo comunitar io. Le te matiche e me rge nti re lative alle impor tanti tras formazioni s ociali che hanno inte re s s ato il mondo de ll’is truzione , de lla formazione e de l lavoro hanno radicato a live llo e urope o la convinzione de lla ne ce s s ità di avvicinare e d ar r icchire re ciprocame nte formazione ge ne rale , formazione profe s s ionale e me rcato de l lavoro. L’obie ttivo pr incipale cons is te ne l favor ire un s is te ma ar ticolato di oppor tunità capace di r is ponde re tanto ai molte plici bis ogni e d or ie ntame nti de ll’ute nza, a cui la formazione s i r ivolge , quanto alle e s ige nze di s viluppo e conomico e occupazionali. Que s ti te mi s ono s tati ampliame nte affrontati dalla Commis s ione Europe a pe r tracciare le line e di indir izzo e i pr incipi guida pe r l’azione che s ono s tati, in par te , tradotti in inte rve nti de l Fondo s ociale e urope o. A live llo e urope o è pos s ibile citare tre docume nti, tra i molti prodotti, che s ono dive nuti un fondame ntale punto di r ife r ime nto pe r ogni s tato me mbro e rappre s e ntano, ad oggi, il più s e r io impe gno de ll’Europa ne l pe rs e guire politiche formative - occupazionali innovative . Il pr imo di que s ti libr i (De lors , 1993) propone de lle r iforme s trutturali pe r i s is te mi formativo- occupazionale vis ti ne l loro ins ie me (is truzione , formazione , me rcato de l lavoro, organizzazione de l lavoro, politiche de l lavoro e cc.) volte ad affrontare , in modo par ticolare , il proble ma de lla dis occupazione e il calo de lla cre s cita e conomica ne l ve cchio contine nte . De lle nume ros e propos te e indicazioni che s i pos s ono le gge re ne l docume nto r is ultano di par ticolare inte re s s e que lle conte nute ne l IV capitolo, de dicate all’occupazione le quali, s e ppure non lo dichiarano e s plicitame nte , pre s uppongono un più s tre tto raccordo tra s is te ma formativo e mondo de l lavoro. Il pr incipio fondame ntale e s pre s s o ne ll’e le nco de lle r iforme da attuare è “la valor izzazione de l capitale umano pe r tutta la durata de lla vita attiva, par te ndo dall’is truzione di bas e e avvale ndos i de lla formazione iniziale pe r ins e r irvi poi la formazione
81 81
continua”. In que s t’ottica, l’obie ttivo più impor tante da raggiunge re dive nta que llo di “garantire conte mporane ame nte una s olida formazione di bas e , di live llo s ufficie nte , e il colle game nto tra la formazione s colas tica e la vita attiva [ …] [ attrave rs o] formule di appre ndis tato e di tirocinio pre s s o le impre s e ” (ivi).
Ne l Libro Bianco de lla Comunità Europe a, inve ce , è pos s ibile ravvis are una doppia acce zione de l te rmine is truzione , quando troviamo s cr itto: “cons ide rare l’e ducazione e la formazione in re lazione con la que s tione de ll’impie go non vuol dire che l’e ducazione e la formazione s i r iducano ad una offe r ta di qualificazione . L’e ducazione e la formazione hanno come funzione e s s e nziale l’inte grazione s ociale e lo s viluppo pe rs onale , a ttrave rs o la condivis ione de i valor i comuni, la tras mis s ione di un patr imonio culturale e l’appre ndis tato de ll’autonomia” (Commis s ione Comunità Europe a, 1994, p. 4). Si affe rma, in que s to modo, la volontà de ll’Unione di cre are nuove s ine rgie tra mondo e conomico e mondo e ducativo, a l fine di fornire r is pos te alte rnative e radicali a lla profonda cr is i che ha inve s tito tanto il tradizionale mode llo di formazione , quanto l’attuale conce zione de l rappor to tra s is te ma e ducativo e s is te ma produttivo, s oprattutto, in pre s e nza di una congiuntura e conomica ne gativa e di un for te r itardo de lla nos tra capacità te cnologica s ul me rcato globale . Il docume nto de lla Cre s s on, in continuità con il pre ce de nte docume nto De lors , s ottoline a la dime ns ione pe rs onale e il valore culturale de lla formazione in un conte s to s ocio- e conomico profondame nte mutato a caus a di tre fattor i pr incipali: l’avve nto de lla s ocie tà de ll’informazione , l’e s te ns ione a live llo mondiale de gli s cambi e il rapidis s imo progre s s o s cie ntifico e te cnologico. L’avve nto de l me rcato globale e de lle nuove te cnologie , s e da una par te cos tituis ce una grande oppor tunità di s viluppo individuale e s ociale , dall’altra , caus a profonde modificazioni ne i s is te mi conos citivi e lavorativi, aume ntando l’ince r te zza e il r is chio di e s clus ione s ociale . Come s i può le gge re ne l docume nto, ta le ince r te zza de ve e s s e re combattuta pr ima di tutto a live llo individuale : “la s ocie tà de l futuro s arà quindi una s ocie tà che s aprà inve s tire ne ll’inte llige nza, una s ocie tà in cui s i ins e gna e s i appre nde , in cui c ias cun individuo potrà cos truire la propr ia qualifica. In altr i te rmini una s ocie tà conos citiva”.(ivi, p. 5). E, ancora “s ia le nuove pos s ibilità offe r te dagli individui che lo s te s s o clima d’ince r te zza chie dono a cias cuno uno s forzo di adattame nto, in par ticolare pe r cos tituire da s é le propr ie qualifiche , raccoglie ndo e r icompone ndo conos ce nze e le me ntar i acquis ite in var ie s e di” (Commis s ione Europe a, 1996, p. 16). In que s ta pros pe ttiva, acquis is cono un’impor tanza s e mpre maggiore le capacità pro- attive individuali di or ie ntame nto e di r i-or ie ntame nto, oltre alle conos ce nze pos s e dute . La Cre s s on ne l s uo rappor to indica anche de lle line e guida capaci di favor ire lo s viluppo de ll’autonomia pe rs onale , de lla cultura ge ne rale e de lle capacità profe s s ionali pe r un migliore adattame nto all’e voluzione de l me rcato de l
82 82
lavoro. T ali indicazioni pos s ono e s s e re r ias s unte in due punti fondame ntali: il pos s e s s o di una s olida cultura di bas e s u cui fondare le nuove compe te nze e lo s viluppo de ll’attitudine al lavoro, fondata s ull’acquis izione di compe te nze me todologiche che cons e ntano all’individuo di imparare ad imparare . Que s te indicazioni pre s uppongono la cre azione , s ul piano s trutturale , di un s is te ma fle s s ibile e ape r to che incoraggi la formazione continua 87 .
I conce tti chiave de l dibattito s cie ntifico ruotano, dunque , a ttorno a que lli di compe te nza e di s is te ma fle s s ibile all’inte rno de l quale r icondurre lo s te s s o conce tto di inte graz ione come anche que llo de i cre diti formativ i e de lla ce rtif icaz ione de lle compe te nze . Alla bas e di que s to s is te ma fle s s ibile , s i re gis tra il pas s aggio dalla ce ntralità de i titoli di s tudio alla ce ntralità de lle compe te nze ce r tificate attrave rs o un s is te ma di accre ditame nto affidabile e unificato a live llo e urope o, indipe nde nte me nte dal fatto che s iano s tate acquis ite all’inte rno di un s is te ma e ducativo formale oppure in conte s ti informali: “i proce s s i e ducativi e di formazione più e fficie nti s ono que lli che funzionano tramite colle game nto in re te . Si può trattare di re ti is tituzionali (is tituti d’is truzione e di formazione che coope rano con le famiglie o con le impre s e ) o re ti di conos ce nze informali, come que lle che oggi s i s viluppano rapidame nte (unive rs ità popolar i, colle gi coope rativi e cc.)” (Ibide m, p. 34- 35). E ancora, “oggi l’adattame nto e il migliorame nto de i s is te mi di is truzione e di formazione de vono e s s e re rafforzati ne l conte s to de i par te nar iati: ne s s una is truzione e in par ticolare ne s s un tipo di s cuola o d’impre s a può pre te nde re da s ola di s viluppare le compe te nze ne ce s s ar ie all’attitudine al lavoro” (Ivi p. 40). Se ppure ancora non s i introduce e s plicitame nte il conce tto di inte graz ione , ogni indicazione r iconduce alla ne ce s s ità di que s ta comple s s a contaminazione inte r - s e ttor iale e inte r - is tituzionale . Un ulte r iore r ife r ime nto – s e ppure implicito- al s is te ma formativo inte grato, s i può trovare ne lla s e conda par te de l docume nto Cre s s on, que lla che inte re s s a la de s cr izione de gli obie ttivi ge ne rali88 pe r il raggiungime nto de lla s ocie tà conos citiva. T uttavia , l’avviciname nto fra s cuola e impre s e è re alizzabile s olo s ulla bas e di tre pre condizioni: • ape rtura de ll’is truz ione al mondo de l lav oro . Se nza limitare le finalità de ll’is truzione volte a cre are condizioni favore voli pe r l’occupazione , la s cuola de ve ope rare uno s forzo di compre ns ione de l mondo de l lavoro e
87 Come si può leggere nel documento in esame: “L’attitudine di un individuo al lavoro, la sua autonomia, la sua capacità di adattamento sono legate al modo in cui saprà combinare queste varie conoscenze e farle evolvere. L’individuo diventa il protagonista e l’artefice principale delle proprie qualifiche: egli è capace di combinare le competenze trasmesse dalle istituzioni formali con le competenze acquisite grazie alla sua pratica professionale e alle sue iniziative personali in materia di formazione. E’ dunque diversificando le offerte educative e le loro interconnessioni, moltiplicando le esperienze professionali, aprendo tutte le possibilità di mobilità che gli si permetterà di costruire e sviluppare la propria attitudine al lavoro e di avere una maggiore padronanza del suo iter professionale” (ivi p. 32). 88 Gli obiettivi in questione sono cinque: incoraggiare l’acquisizione di buone conoscenze, avvicinare la scuola all’impresa, lottare contro l’esclusione, promuovere la conoscenza di tre lingue comunitarie, porre su un piano di parità gli investimenti materiali e gli investimenti nella formazione.
83 83
de lle impre s e e s viluppare maggiore atte nzione ai cambiame nti che attrave rs ano le attività di produzione ; • coinv olgime nto de ll’impre s a ne llo s forzo formativ o de i s uoi dipe nde nti, nonché più in ge ne rale , de i giov ani e de gli adulti. La formazione non può e s s e re conce pita s oltanto come uno s trume nto pe r fornire manodope ra qualificata alle impre s e ; que s te ultime de vono r iconos ce re la loro par te di re s pons abilità in quanto age nzie di formazione ; • s v iluppo de lla coope raz ione fra is tituti d’is truz ione e impre s e . “La s cuola e l’impre s a s ono luoghi di acquis izione di conos ce nze comple me ntar i che è ne ce s s ar io ravvicinare ” (ivi, p. 60) Il te ma de ll’ade guame nto de i proce s s i e ducativo- formativi a i cambiame nti e conomici, s ociali e te cnologici è affrontato anche dal te rzo di que s ti docume nti. T ale docume nto me tte in r is alto il cos tante aume nto de lla domanda di qualificazione da par te de l s is te ma e conomico e vide nziando, altre s ì, che il r itmo pre s s ante de lle tras formazioni e de l progre s s o te cnologico induce profondi cambiame nti ne l mondo de l lavoro e , di cons e gue nza, non è più pos s ibile pe ns are che i s is te mi e ducativi formino le pe rs one pe r un lavoro s tabile . Es s i s ono chiamati a formare individui cre ativi e innovativi, capaci di capire il cambiame nto adattandovis i. Ancora una volta pur non trovando r ife r ime nti e s pliciti a l conce tto di inte grazione , ne l Rappor to s i può le gge re “i s is te mi e ducativi de bbono e s s e re abbas tanza fle s s ibili da te ne r conto de lle diffe re nze individuali ne ll’organizzare moduli di s tudio, ne l cre are pas s aggi tra i cors i e , come già affe rmato, ne llo s tabilire ordiname nti pe r un pos s ibile r itorno all’e ducazione formale dopo pe r iodi di te mpo tras cors i ne l lavoro” (ivi, p. 121). Dalle cons ide razioni s in qui s volte s i e vince l’impor tanza che la Comunità as s e gna alla logica de lla life long e ducation che grazie ad un s is te ma fle s s ibile , bas ato s ul me todo de lla ce r tificazione de lle compe te nze , pos s a favor ire il mante nime nto e il migliorame nto de ll’occupabilità de lle pe rs one . Da quanto è e me rs o i conce tti guida de l cambiame nto s ono: coope razione , re te , fle s s ibilità, dialogo, me ntre il te rmine “inte grazione ” continua ad e s s e re implicito anche s e tutto r ipor ta a que s ta ne ce s s ar ia compe ne trazione tra i s is te mi e ducativo- formativo e d e conomico. E’ come s e la Comunità e urope a non ave s s e voluto, o potuto, fornire indicazioni s tr inge nti, las ciando a ogni s tato me mbro, in vir tù de lla pror ia s ovranità nazionale e de lle s pe cificità locali, il compito di r ie mpire di conte nuto e di s e ns o lo s te s s o conce tto di inte grazione individuando s trate gie propr ie . E’ ancor più s ignificativo, quindi, che , nonos tante que s ta libe r tà e le profonde diffe re nze s ocio- e conomiche e amminis trativo- burocratiche di que s ti pae s i, tutte le r ice rche più re ce nti facciano re gis trare de lle s ignificative conve rge nze in te rmini di te nde nze e s trate gie adottate dagli s ta ti me mbri. Nonos tante que s ta fondame ntale conve rge nza è pos s ibile dis tingue re , c iò
84 84
nondime no, ne lle s trate gie pe r il r ilancio de ll’occupazione addottate dal le gis latore , due dis tinti mode lli che r is pe cchiano le due are e s tor ico-culturali (già abbondante me nte individuate e rappre s e ntate dagli s tudi comparativi di We lfare )89 e che s ono il frutto, a llo s te s s o te mpo, de i dive rs i condizioname nti s tor ici che ne hanno influe nzato lo s viluppo:
♣ il mode llo fle s s ibile che pre vale ne i pae s i di are a anglos as s one e che s i configura come un s is te ma libe r is ta in grado di as s orbire automaticame nte gli s quilibr i a ttrave rs o la fle s s ibilità ne i live lli s alar iali, la mobilità de l lavoro, forme fle s s ibili di impie go e di organizzazione ; ♣ il mode llo rigido che pre vale ne lla maggior par te de i pae s i de ll’are a e uro dove c’è una maggiore atte nzione alla cons e rvazione de l pos to di lavoro, una maggiore garanzia de ll’anzianità di s e rvizio, maggior i vincoli pe r le impre s e e cc.. I mode lli in que s tione s ono que llo de ll’OCSE e que llo de lla Ue che , pur incontrandos i s u molti as pe tti –pr ior itar iame nte que llo de lla r ice rca di una maggiore fle s s ibilità de l me rcato de l lavoro – mante ngono una diffe re nza s os tanziale . Pe r quanto conce rne il pr imo mode llo, l’OCSE, ne l 1992, ha avviato un proge tto volto ad ide ntificare , da una par te , le caus e de lla cr is i che dagli anni ’90 ha inve s tito il me rcato de l lavoro de i pae s i affe re nti a que s ta are a e , in par ticolare , di que lli e urope i; dall’altra a r ice rcare pos s ibili corre ttivi pe r r ilanciare l’occupazione . Sono s tate individuate , a ttrave rs o que s to lavoro, die ci guide line 90 di inte rve nto de finite job s trate gy che r iguardano mis ure di caratte re s trutturale mirate a favor ire la libe ra concorre nza ne i me rcati, inte rve nti finalizzati a migliorare le capacità di adattame nto de lla forza lavoro attrave rs o r iforme de l s is te ma s colas tico e pote nziame nto de lla formazione profe s s ionale . Le raccomandazioni OCSE s i ar ticolano in tre grandi policy are a (e s ono s uddivis e s e condo tre live lli di s pe cificità: ge ne rale , inte rme dio e s pe cifico): que lle re lative al me rcato de l lavoro, que lle re lative alla formazione e all’e ducazione e , infine , que lle conce rne nti il bus ine s s e nvironme nt.91 In s inte s i, l’e le me nto caratte r izzante la s trate gia
89 Un approfondimento dei temi legati ai due diversi modelli di Welfare sarebbe senz’altro interessante ma troppo impegnativo e ci distoglierebbe dall’argomento da noi trattato si preferisce rimandare, dunque a: Alber, 1982; Briggs, 1961; Carrier, Kendal, 1973: Flora, Heidenheimer, 1981; Ferrera, 1993; Fedele, 1998. 90 Queste dieci guideline possono essere così sinteticamente definite: adottare politiche macroeconomiche volte ad incoraggiare la crescita economica e mantenere la stabilità dell’inflazione; sostenere la creazione e la diffusione del progresso tecnico; incrementare la flessibilità dell’orario di lavoro; eliminare gli impedimenti alla creazione e all’espansione delle imprese; rimuovere i vincoli che limitano la capacità dei salari e del costo del lavoro di riflettere tanto le condizioni dell’offerta di lavoro individuale, quanto quelle delle economie locali; rivedere i regimi di protezione dell’impiego che limitano l’espansione dell’occupazione; promuovere le politiche attive del lavoro; migliorare gli skills della forza lavoro attraverso le riforme del sistema educativo-formativo; rivedere i regimi di sostegno alla disoccupazione affinché siano garantiti gli obiettivi di equità e solidarietà sociale oltre a un buon funzionamento del mercato del lavoro; rafforzare la concorrenza nei mercati dei prodotti e dei servizi. 91 Politiche per il mercato del lavoro, come: sussidi alla disoccupazione, schemi di pensionamento, sussidi di invalidità (riduzioni di livello e durata, rafforzamento delle condizioni di eleggibilità, controllo degli altri schemi che disincentivano l’occupazione), imposte sul lavoro (riduzione del cuneo fiscale, riduzione dell’incidenza sulle retribuzioni basse), regimi di protezione dell’impiego (deregolamentazione, riduzione dei vincoli sul lavoro permanente, lavoro temporaneo, orario di lavoro e part-time), meccanismi di formazione del salario
85 85
OCSE, di is pirazione libe r is ta , guarda alla de re golame ntazione de i me rcati come alla naturale r ice tta di politica e conomica pe r la cre s cita e pe r il r ilancio (Rappor to ISFOL 2000/b).
Se facciamo un raffronto tra le jobs s trate gy de ll’OCSE e le line e guida de i Pae s i e urope i è pos s ibile r is contrare impor tanti punti di contatto. Come già de tto, anche la Comunità Europe a attrave rs o gli ormai noti quattro pilas tr i (occupabilità, impre nditor ialità, adattabilità de i lavorator i e de lle impre s e , par i oppor tunità), ha imboccato la via de lla fle s s ibilità e de lla mobilità de i lavorator i. Il già citato libro Bianco di De lors , pur r iconos ce ndo le pote nzialità de lle nuove te cnologie de ll’informazione e de lla comunicazione , congiuntame nte all’impor tanza de lla de re golame ntazione de l me rcato de l lavoro, s ottoline a, tuttavia , una diffe re nza s os tanziale r is pe tto alle jobs s trate gy de ll’OCSE. T ale diffe re nza è le gata al rappor to comple me ntare e s is te nte tra s viluppo te cnologico e de mocrazia s ociale che caratte r izza tradizionalme nte l’impos tazione de lle politiche e conomiche ne i Pae s i de ll’Unione e urope a. Me ntre il mode llo OCSE è fondato s ul pr incipio che i me ccanis mi concorre nziali s ono de te rminanti pe r s tabilire e quilibr i ‘e fficie nti’ de l me rcato, l’approccio de ll’Unione e urope a r iconos ce la ne ce s s ità di un dis e gno globale che poggi s ulle politiche pe r la concorre nza, ma che introduca (rafforzi) me ccanis mi s ociali che pre s e rvino l’e quità. Que s to diffe re nte or ie ntame nto te nde a s alvaguardare il pr incipio di s olidar ie tà che is pira la maggioranza de i pae s i de ll’are a e uro. Nonos tante que s ta fondame ntale diffe re nza, comunque , vi s ono punti di contatto e s tre mame nte s ignificativi che pos s ono e s s e re le tti propr io ne ll’impor tanza as s e gnata da e ntrambi i mode lli a lla formazione de lle r is ors e umane , s ia come r is ors a individuale pe r migliorare l’occupabilità de i s ogge tti, s ia come be ne s ociale e colle ttivo pe r favor ire l’innovazione , s trate gico fattore di compe titività ne l me rcato globale . In vir tù di c iò, s i as s is te ad un ge ne rale r ipe ns ame nto de ll’inte ra archite ttura formativa volto a favor ire più s tre tte e coe re nti conne s s ioni con il me rcato de l lavoro. In e ntrambi i cas i, s i guardano lavoro e formazione ne ll’ottica de ll’e ducation, come un s is te ma unico che abbraccia l’inte ro arco de lla vita e ogni s pazio e s pe r ie nziale , compone ndos i di dive rs i s ottos is te mi in s tre tta corre lazione tra loro e che non pos s ono e s s e re più cons ide rati s e paratame nte . E’ s ulla bas e di que s ta pre me s s a che la UE (Unione Europe a), ha as s unto un ruolo attivo e propos itivo pe r il gove rno di que s ta trans izione che , a nos tro avvis o, può e s s e re dis tinto in due fas i.
(decentralizzazione, aumento della flessibilità nei salari, riforma del salario minimo), politiche attive del mercato del lavoro (miglioramento targeting, sviluppo dei servizi pubblici per l’impiego); politiche per l’educazione e la formazione quali: educazione di base: (innalzamento della qualità e della durata), educazione superiore (educazione secondaria, formazione professionale, collegamento con il mondo delle imprese, career guidance e business orientation), educazione universitaria (riduzione della durata, miglioramento della qualità e delle iscrizioni); politiche per il business environment, e cioè quell’insieme di interventi a sostegno dell’impresa e del mercato quali: diffusione tecnologia e Knowledeg base, facilitazione del business start-up, concorrenza (aspetti generali, settori specifici, riduzione dell’intervento pubblico e sussidi in settori specifici), ristrutturazione delle imprese pubbliche ed estensione della privatizzazione, sviluppo del mercato dei capitali di rischio ecc.. Per un approfondimento si rinvia a ISFOL, 2000/b.
86 86
La pr ima fas e , che può e s s e re de finita di avvio, va dal 1993 al 199592 , e d è caratte r izzata da un s ignificativo s forzo da par te de lla Comunità volto a produrre s timoli comuni di r ifle s s ione . In que s to pe r iodo infatti s i re gis tra la produzione di a lcuni docume nti che s ono dive nuti di grande valore pe r tutta la Comunità 93 . La s e conda fas e 94 è que lla che va dal 1996 al 2000, ne lla quale i cambiame nti s ociali, e conomici e profe s s ionali dive ngono più ne tti e de finiti e pe r i quali s i te nta di adottare s trate gie di gove rno pas s ando cos ì dal piano de i propos iti a que llo de lle azioni. Le s trate gie individuate s ono ince ntrate s ui s e gue nti s e ttor i: s viluppo di una cultura d’impre s a, promozione de lla r iorganizzazione e de ll’adattabilità pe r s fruttare il pie no pote nziale de lle nuove te cnologie , rafforzame nto de lla qualificazione e de l live llo di conos ce nza de lle te cniche e le me ntar i. Ne l 1996, infatti, la Comunità Europa pubblica il Libro ve rde intitolato “V iv e re e lav orare ne lla s ocie tà de ll’informaz ione : priorità alla dime ns ione umana”95 ne l quale , pe r la pr ima volta , s i e vide nzia la ne ce s s ità di produrre politiche inte grate che coinvolgano dive rs i ambiti gove rnativi. Come è facile immaginare , lo “s pauracchio” di una re ce s s ione e conomica indir izza pe s ante me nte gli obie ttivi formativi di cui te ne r conto ne lla de finizione s te s s a de lle forme e de l conte nuto de ll’appre ndime nto. Succe s s ivame nte , con il Docume nto di programmazione e conomico-
92 Qualche tentativo è stato rintracciato, come abbiamo visto, anche negli anni precedenti, ma il 1993 con la pubblicazione del libro bianco apre una stagione di intensi sforzi da parte della comunità europea, a sostegno della diffusione di elementi di riflessione, fonti di finanziamento, e diffusione di best practices che andranno moltiplicandosi nel corso degli anni. 93 Si possono ricordare tra i più importanti: Il libro Bianco “Crescita, Competitività, Occupazione. Le sfide e le via da percorrere per entrare nel XXI secolo”(1993), con il quale si è cercato di mettere in luce il mutamento che ha investito i sistemi di produzione e di organizzazione del lavoro, nonché le nuove tendenze del consumo; il rapporto Bangemann, relativo all’incontro di Bruxelles del dicembre 1993 (ISFOL, 1994); il Piano di azione: la via europea verso la società dell’informazione, pubblicato anch’esso nel 1994; il libro bianco della Cresson, Insegnare e apprendere. Verso la società cognitiva (1995), che affronta il problema delle riforme strutturali relative al sistema occupazionale; l’Istituzione, nel 1995, di un FORUM, costituito da 128 membri provenienti da cinque diversi settori di attività (utilizzatori di nuove tecnologie; gruppi sociali; fornitori di contenuti e di servizi informativi; operatori di rete; istituzioni), al fine di favorire un dibattito permanente relativamente alle sfide poste dalla Società dell’informazione. Le riflessioni di questo Forum si articolano sui seguenti temi: impatto sull’economia e sull’occupazione; valori sociali e democratici fondamentali nella “comunità virtuale”; impatto sui servizi pubblici; istruzione, formazione e apprendimento nella società dell’informazione; dimensione culturale e futuro dei mezzi di informazione; sviluppo sostenibile, tecnologie e infrastrutture. I testi integrali della produzione del Forum sono disponibili sul sito Internet: www.ispo.cec.be/infoforum/>. 94 I momenti più salienti di questa seconda fase possono essere così riassunti: il 6.5.96: Il Consiglio dei Ministri dell’istruzione adotta su proposta della Commissione una Risoluzione relativa ai software multimediali nei settori dell’istruzione e della formazione; il 22.9.97: la stessa Commissione presenta una nuova Risoluzione per l’istruzione, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e per la formazione degli insegnanti di domani. Questi due documenti insieme contribuiscono ad esprimere una presa di coscienza su queste problematiche a livello europeo e, soprattutto, a delineare un primo quadro generale di una comune strategia politica. Nel 1999 il Consiglio europeo tenutosi a Colonia afferma che L’Europa deve essere un leader nella società dell’informazione e che tutte le scuole devono essere collegate nel più breve tempo possibile a Internet, infine nel Marzo 2000 il Consiglio europeo straordinario tenutosi a Lisbona (COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE, 2000) ritiene di dover ulteriormente accelerare questo processo affinché tutti i giovani di Europa siano in grado di utilizzare gli strumenti dell’era digitale pena la stessa capacità competitiva del vecchio continente. 95 Le sfide proposte dal documento consistono in: ottimizzare il quadro normativo; rafforzare le risorse umane; attribuire responsabilità e poteri a livello locale. In un ottica di più ampio respiro si propone anche di: approfondire il dialogo politico con le istituzioni europee e gli Stati membri; concentrare il dialogo sociale tra datori di lavoro e sindacati; stimolare il dialogo civile in particolare con le organizzazioni non governative. Per un approfondimento si veda: COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE, Libro verde “Vivere e lavorare nella società dell’informazione: priorità alla dimensione umana (1996).
87 87
finanziar ia 2000- 2004 s i e nunciano tre impor tanti inte rve nti di r iforma da pe rs e guire : re vis ione e razionalizzazione de i rappor ti di lavoro a caus a mis ta (r iconos ce ndo il contratto di appre ndis tato come una via pr ivile giata di ins e r ime nto de i giovani ne l me rcato de l lavoro); s os te gno a s ogge tti di diffic ile ins e r ime nto o re ins e r ime nto lavorativo (dis occupati di lunga durata e cc.); r iordino de lle mis ure di s os te gno al re ddito. Ne llo s te s s o docume nto è s tata dichiarata dalla Comunità e urope a la volontà di mante ne re alto l’impe gno pe r fronte ggiare le s fide prove nie nti dalla nuova Socie tà de lla Conos ce nza. I lavor i de l Cons iglio, in que s ta fas e , s e gnano in manie ra s ignificativa l’or ie ntame nto de lla politica e de ll’azione de ll’Unione e urope a. Ne lle conclus ioni de l 30.10.2000, infatti, s i può le gge re : “il buon e s ito de lla trans izione ad un’e conomia e una s ocie tà bas ate s ulla conos ce nza de ve e s s e re accompagnato da un or ie ntame nto ve rs o l’is truzione e la formazione pe rmane nte .”96 I s is te mi e urope i di is truzione e formazione s i trovano al ce ntro di radicali tras formazioni, e s s i dovranno ade guars i rapidame nte . Anche il Cons iglio e urope o di Fe ira te nde a rafforzare que s ta vis ione pronunciandos i ne l s e gue nte modo “gli Stati me mbri, il Cons iglio e la Commis s ione [ …] , cias cuno ne lle r is pe ttive are e di compe te nza [ s i de ve impe gnare ] ad individuare s trate gie coe re nti e mis ure pratiche al fine di favor ire la formazione pe rmane nte pe r tutti” (Conclus ioni de l Cons iglio e urope o di Fe ira , paragrafo 33). In bas e a ta le obie ttivo, ne gli inte nti de lla Commis s ione , la nozione di is truzione e formazione pe rmane nte de ve dive ntare il pr incipio informatore de ll’offe r ta e de lla domanda di quals ias i conte s to di appre ndime nto97 . Come s i e vince dal già cita to Me morandum de lla Commis s ione e urope a, “la re alizzazione de ll’is truzione e de lla formazione pe rmane nte rappre s e nta una pr ior ità mas s ima pe r l’Unione e urope a” pe rché oggi viviamo in un mondo s ocialme nte , politicame nte e d e conomicame nte più comple s s o e l’is truzione rappre s e nta il re quis ito e s s e nziale pe r compre nde re le s fide de lla mode rnità e d affrontar le , garante ndo a tutti la promozione di una
96 COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE, Memorandum di lavoro dei servizi della Commissione, (2000). 97 A questo scopo, nelle risoluzioni del già citato Consiglio di Lisbona si possono trovare delle chiare indicazioni volte tanto a fornire il quadro di un dibattito, quanto a chiarire le priorità di azione sulle quali intervenire: “garantire un accesso universale e permanente alle azioni d’istruzione e formazione per consentire l’acquisizione o l’aggiornamento delle competenze necessarie ad una partecipazione attiva ai progressi della società della conoscenza; assicurare una crescita visibile dell’investimento nelle risorse umane per rendere prioritaria la più importante risorsa dell’Europa – la sua gente; sviluppare contesti e metodi efficaci d’insegnamento e di apprendimento per un offerta ininterrotta d’istruzione e di formazione lungo l’intero arco della vita e in tutti i suoi aspetti; migliorare considerevolmente il modo in cui sono valutati e giudicati la partecipazione e i risultati delle azioni di formazione, in particolare nel quadro dell’apprendimento formale e informale; garantire a tutti un facile accesso ad informazioni e ad un orientamento di qualità sulle opportunità d’istruzione e formazione in tutta l’Europa e durante tutta la vita; offrire opportunità di formazione permanente il più possibile vicine agli utenti della formazione, nell’ambito delle loro comunità e con il sostegno, qualora opportuno, di infrastrutture basate sulle TIC (Tecnologie informatiche). Inoltre, nel Memorandum, è possibile distinguere tre diverse categorie fondamentali di apprendimento di cui è necessario tener conto per realizzare la continuità dell’apprendimento lungo l’intero arco della vita: apprendimento formale che si svolge negli istituti d’istruzione e di formazione e porta all’ottenimento di diplomi e di qualifiche riconosciute; apprendimento non formale che si svolge al di fuori delle principali strutture d’istruzione e di formazione e di solito non porta a certificati ufficiali, ad esempio, attività svolte sul lavoro o in associazioni di varia ispirazione, apprendimento informale acquisito nella vita quotidiana, non necessariamente intenzionale e per questo, spesso, non riconosciuto nemmeno dal soggetto che ne è portatore (ivi).
88 88
cittadinanza attiva e la promozione de ll’occupabilità. De l re s to, è unanime il r iconos cime nto de lla ne ce s s ità di pre parars i a l cambiame nto, di acquis ire , c ioè, la capacità di compre nde re quando è ora di cambiare pe r adattars i a i mutame nti incors o con un atte ggiame nto pos itivo e cre ativo. Pe r il cons e guime nto di que s to obie ttivo, s i aus pica una più s tre tta conne s s ione e d inte grazione fra is truzione di bas e , formazione profe s s ionale e mome nto ope rativo, a que s to s copo un ruolo fondame ntale è r iconos ciuto alle as s ociazioni di cate gor ia . T ale proce s s o dovre bbe e s s e re accompagnato da politiche finanziar ie che s coraggino la dis occupazione (attrave rs o una ge s tione più r igida de i s us s idi di dis occupazione ), a favore de l lavoro. Un’e s ige nza unive rs alme nte avve r tita è que lla di as s is te re in modo e fficace i giovani ne l pas s aggio dalla s cuola alla vita attiva e , a l conte mpo, combatte re l’incre me nto di occupazione in attività a bas s a qualificazione e re tr ibuzione r idotta (bad jobs ) che cre ano circoli vizios i dai quali è poi diffic ile us cire . Il s ucce s s o di ta li obie ttivi, tuttavia , dipe nde e s clus ivame nte dalla cons ape vole zza, da par te di tutti gli a ttor i in gioco (Stati me mbri, is tituzioni e urope e , par ti s ociali, impre s e ), de lle loro re s pons abilità e dalla volontà di dialogare ne ll’ottica di un inte re s s e comune . Infine , la te rza fas e , tutt’ora in cors o, è caratte r izzata da un mome nto di r ifle s s ione s ulle cos e fatte e s u que lle da fare , in pre s e nza de lla difficile congiuntura e conomica che ha colpito tutte le s ocie tà occide ntali e de l s ignificativo s pos tame nto a de s tra di a lcuni gove rni che s tanno ope rando un s ignificativo r ipe ns ame nto de lla pratica ne goziale avviata ne gli ultimi anni a fronte di un mas s iccio s pos tame nto ve rs o la pe r ife r ia .
Come s i configurano oggi le politiche integrate in Europa e in Italia
Se condo alcuni os s e rvator i, le politiche pubbliche s ono andate più avanti r is pe tto alla cos truzione di nuovi mode lli te or ici, as s ume ndo a r ife r ime nto ciò che que s ti ancora non as s icurano, e cioè la pos s ibilità di r iprodurre ar tific ialme nte – attivando e controllando le ne ce s s ar ie condizioni – un proce s s o che s i è prodotto s pontane ame nte . (Quade rni FORMEZ, 2002, n. 6). Come già de tto, è da anni che il dibattito pubblico e l’or ie ntame nto de i de cis or i, s ia a live llo nazionale che comunitar io, s pinge ve rs o il conce tto di inte grazione . La cos a che balza agli occhi è che tale conce tto re s ta s e mpre implicito. In ne s s un docume nto ufficiale s i trova mai una e s e mplificazione di cos a s i de bba inte nde re pe r inte grazione e come s i de bba re alizzare . E’ e vide nte che la Comunità e urope a ha te ntato di las ciare ampi s pazi di manovra agli s ta ti me mbri s u come re alizzare que s to proce s s o. E, infatti, ad un ce r to punto, in tutte le de mocrazie e urope e , pe r ope ra di un proce s s o di traduzione (Latour , 1998) e di una naturale te nde nza mime tica,
89 89
s i introduce la pratica de lla conce r tazione che va s otto il nome di politiche ne goziate . E’ e vide nte che le politiche ne goziate non r icoprono tutto il campo de lle politiche inte grate ma in par te vi s i s ovrappongono come s i ce rca di e vide nziare ne lla raffigurazione grafica s ottos tante .
Ed è que s to ambito di s ovrappos izione che s i vuole analizzare pe r compre nde re , da una par te , come avvie ne que s to proce s s o di tras lazione e , dall’altra , come vie ne imple me ntata l’inte grazione .
Ne gli ultimi die ci anni, s i è as s is tito all’e s plos ione di un gran nume ro di inte rve nti di policy me glio noti come patti te r r itor iali, accordi di s e ttore , programmazione ne goziata , che s i fondano s ulla logica ne goziale e s ul dialogo s ociale . Le caus e di ta le e s plos ione , come s e mpre , vanno r ice rcate in una molte plicità di fattor i quali: la cr is i e conomica de i pr imi anni ’90; il tracollo de l s is te ma fondato s ulle impre s e pubbliche ; il fa llime nto de lle tradizionali politiche di ince ntivazione ; l’e me rge nza de i conti pubblici; il progre s s ivo diffonde rs i di una vis ione fe de ralis ta de llo Stato; la r iorganizzazione s trutturale de lla pubblica amminis trazione avviata dai gove rni te cnici di Amato e Ciampi (1992- 1993); il proce s s o di inte grazione comunitar io accompagnato dalla diffus ione di nuovi s is te mi di finanziame nto bas ati s u una for te coe re nza inte rna e s ulla compar te cipazione di molte plici a ttor i a lla re alizzazione di proge tti comuni; lo s forzo comunitar io a s os te gno de lla promozione de ll’e ducazione continua e de lla valor izzazione de lla dime ns ione locale . La conce zione alla bas e di ta le impianto s i r ias s ume ne l te ntativo di “favor ire lo s viluppo attrave rs o inte rve nti che s timolino, con ince ntivi finanziar i e con s e rvizi, gli a ttor i locali (pubblici e pr ivati) a coope rare pe r me tte re a punto proge tti inte grati di s viluppo locale da s ottoporre a proce dime nti di valutazione . [ …] L’as s unto cruciale che guida il dis e gno is tituzionale de lle nuove politiche [ …] è che obie ttivi di s viluppo locale non pos s ono e s s e re cons e guiti s e nza una mobilitazione e una re s pons abilizzazione de i s ogge tti locali s te s s i, che dis pongono di r is ors e di informazione e di cons e ns o indis pe ns abili”. (T r igilia , 2001, p. 360).
Le nuove politiche ne goziali, dunque , puntano s ulla coope razione e s ull’accordo tra i dive rs i inte re s s i pubblici e pr ivati, in modo da produrre e far c ircolare informazioni e cons e ns o pe r azioni più r icche e d e fficaci a
Politiche Integrate
Politiche
negoziali
90 90
s os te gno de llo s viluppo. T ali politiche non s i ide ntificano con un s e mplice de ce ntrame nto di compe te nze e di r is ors e , ma s i bas ano s u nuovi rappor ti inte rgove rnativi tra ce ntro e pe r ife r ia . In altr i te rmini, non ci s i affida s olame nte alle capacità di automobilitazione de gli a ttor i (is tituzionali e non), ma i live lli is tituzionali s upe r ior i (UE s tato ce ntrale , re gioni) mante ngono un ruolo impor tante in te rmini di offe r ta di oppor tunità e di valutazione .
Contrar iame nte a quanto avve niva pe r le politiche di s viluppo via ince ntivi98 , le nuove politiche mirano a influe nzare pos itivame nte gli e le me nti di conte s to is tituzionale . La programmazione ne goziata s e mbra e s s e re uno s trume nto in grado di incide re s ui proce s s i di s viluppo locale influe nzando la dotazione di r is ors e s ociali de i te r r itor i. La novità de lla programmazione ne goziata s ta ne lla capacità di cons ide rare l’impor tanza de l le game e s is te nte tra s viluppo locale , appre ndime nto e cre s cita di conos ce nze s pe cializzate . Le game , que s to, che può e s s e re s viluppato s olo attrave rs o la cre azione di re ti tra gli a ttor i locali pubblici e pr ivati (T r igilia , 1999). Me ntre pr ima l’e fficacia di una politica e ra le gata s olo a ragioni e conomiche come , ad e s e mpio, le politiche macroe conomiche 99 (che r is ultano, oggi, in mancanza di me rcati prote tti, me no incis ive che in pas s ato) o le politiche di s e ttore (che hanno, pe rò, una vis ione parziale de lla re altà), e ntrano in gioco fattor i e dime ns ioni dive rs i come la fiducia , il capitale s ociale 100 , la qualità de lle re lazioni, la cultura, la capacità di coope rare e di s viluppare appre ndime nto e compe te nze di s is te ma e cc.. E’ s u que s ta s cia che s i s ta affe rmando, s e ppure in modo ambiguo e ancora poco s tudiato da un punto di vis ta te or ico, un modo nuovo di inte nde re l’inte rve nto di policy fondato s u una vis ione s is te mica di conte s to. Il conce tto alla bas e di que s to cambiame nto è antico quanto la s ociologia e d è appunto il conce tto di inte grazione che , a quanto pare , rappre s e nta il nucle o di tutte le r ifle s s ioni finora s volte . T ale nozione , da una par te , ce rca di inglobare ne l tradizionale dis e gno di policy nuove dime ns ioni, a ttine nti a lla s fe ra s ogge ttiva e s ocio culturale , in modo da le gare ince ntivi e facilitazioni ad un cambiame nto di conte s to che pos s a tradurs i in attivazione di c ircoli vir tuos i. Dall’altra , s e mbra e s s e re il ne ce s s ar io contraltare all’attuale s pinta globalizzante che por ta ad un continuo abbattime nto de i confini, ad un aume nto de lla comple s s ità a tutti i live lli e d
98 Si distinguono due generazioni di politiche di sviluppo: quelle mirate alla costruzione di infrastrutture e quelle basate su incentivi individuali al capitale e al lavoro che utilizzano la leva fiscale e la fiscalizzazione degli oneri sociali. (Cersosimo, 2001). Il limite oramai riconosciuto di queste politiche è stato quello di non riuscire ad influenzare positivamente gli elementi di contesto istituzionale. 99 A causa del mercato globale, i tassi di cambio e di interesse sono sempre meno suscettibili di manipolazione da parte delle amministrazioni nazionali, inoltre, le svalutazioni competitive, nel nuovo quadro monetario europeo, sono divenute improponibili per questo motivo, oggi, tali politiche si rivelano inadeguate innanzi alla crescente complessità. 100 Quando si parla di capitale sociale si devono considerare diverse tipologie di tale capitale: universale,, quando strutture di governance, conoscenze e relazioni assumono forma astratta, slegata da specifici contesti territoriali o aziendali; territoriale, quando strutture di governcance, conoscenze erelazioni sono embedded in uno specifico territorio; aziendale, quando le strutture di governace, le conoscenze e le relazioni sono firm specific, ossia radicate nel contesto di esperienza della singola azienda,indipendentemente dal fatto che sia localizzata inn uno specifico territorio o sia invece multilocalizzata (Quaderni Formez, 2002, n. 2).
91 91
in tutti i s e ttor i, accompagnato, tuttavia , da una cre s ce nte diffe re nziazione . T ale fe nome no s i può le gge re ne lla ormai radicata te nde nza ad ope rare s ce lte pubbliche in bas e al ne goziato condotto in forma bi- o plur i-la te rale 101 . Si tratta , quindi, di una te nde nza re ce nte e d in rapida e s pans ione che accomuna tutte le de mocrazie mode rne e che può e s s e re le tta propr io come r is pos ta a que s ta cre s ce nte r ice rca di coordiname nto a tutti i live lli. E s ono propr io le e s pe r ie nze s tranie re che hanno contr ibuito allo s viluppo de lla contrattazione pubblica in Ita lia . I pr incipali mode lli di r ife r ime nto che è pos s ibile r intracciare s ono due , abbas tanza difformi tra loro. Pe r un ve rs o, l’influe nza de lla culture of contract s viluppata in Gran Bre tagna ad ope ra de i gove rni cons e rvator i e volta al de ce ntrame nto de i s e rvizi s e condo il mode llo de ll’e nabling gov e rnme nt . Pe r l’altro, la fitta re te di pratiche contrattuali s viluppatas i in Francia a s e guito de lla déce ntralis ation avviata con i pr imi anni ’80 (Bobbio, 2000). De ve far r ifle tte re che pae s i come la Gran Bre tagna e la Francia, che vantano tradizioni politico- amminis trative profondame nte dive rs e , abbiano avviato e ntrambi la s volta contrattuale de i pote r i pubblici. Ciò che accomuna que s te pratiche , molto dive rs e fra loro, è il fa tto che “la s ce lta pubblica as s ume la ve s te di un accordo e s plicito, re datto in forma s cr itta , in cui le par ti dichiarano pubblicame nte di approvare un proge tto o una line a di inte rve nto, o s i as s umono pubblicame nte impe gni re ciproci, me tte ndo propr ie r is ors e (non ne ce s s ar iame nte finanziar ie ) a dis pos izione di un azione comune di cui concordano te mpi e modalità” (ivi, p. 112). Se condo Luigi Bobbio que s ta te nde nza a le gare s ce lte pubbliche ad accordi formalme nte s tila ti r is ponde “ad una logica più comple s s a de lla contrattazione tra inte re s s i pubblici e pr ivati già de finiti e x- ante che s i incontrano e de finis cono gli obblighi re ciproci a ttrave rs o il patto. La ratio di fondo de lle nuove politiche è che attrave rs o lo s trume nto de l patto i s ogge tti coinvolti s iano s timolati a r ide finire le loro ide ntità e , quindi, gli inte re s s i che s u di e s s e s i fondano, in modo da impe gnars i in azioni più r is chios e e innovative . In altre parole , a ttrave rs o l’inte razione r ipe tuta e la conce r tazione pos s ono s viluppars i fiducia e re ti di re lazioni che aiutano l’innovazione e conomica e ‘allungano la vis ta’ de gli a ttor i” (ivi).
Il nocciolo di que s ti proce s s i di coope razione s ta ne l te ntativo di s timolare proce s s i di appre ndime nto colle ttivo attrave rs o la par te cipazione e il monitoraggio (le arning by le arning). E’ chiaro che in que s ta pros pe ttiva è più diffic ile raggiunge re de lle de cis ioni, pe rché non vale la logica de lla maggioranza ma que lla de l cons e ns o. Ma propr io pe r que s to motivo tali politiche pos s ono e s s e re più r icche e lungimiranti e tute lare gli inte re s s i de gli a ttor i coinvolti con un minor pe s o ne goziale . Nondime no, è dove ros o s ottoline are che que s ta via , molto ambizios a e difficile da s os te ne re , r is ulta
101 Secondo un’analisi operata da Luigi Bobbio (2000), tali accordi possono assumere denominazioni diverse e vengono conclusi in: contratti (di programma, di area, di quartiere); accordi ( di programma, di programma quadro, volontari, contrattuali); convenzioni (di svariata natura); patti (sociali, territoriali, di settore ecc.); protocolli di intesa o intese (di vario genere tra cui quelle istituzionali di programma).
92 92
ampiame nte cr iticata s ia dalla cultura s tatalis ta che da que lla libe r is ta . Ne lla cultura s tatalis ta , infatti, s i te me che la contrattualizzazione de lle politiche pos s a favor ire una te nde nza che por ta a non de cide re s e condo l’inte re s s e pubblico e l’atte ndibilità s cie ntifica de i dati, ma s ulla bas e di inte re s s i par ticolar i o di pre s s ioni da par te de lle var ie lobbie s . La cultura libe r is ta , inve ce , guarda con s os pe tto le inte razioni s ociali che pos s ono condizionare le attività e conomiche , poiché s ono vis te come fonte di dis tors ione de ll’e fficie nza de l me rcato attrave rs o coalizioni collus ive . In altre parole , “gli s tatalis ti contrappongono alla logica de ll’accordo que lla de ll’inte rve nto di tipo dir igis ta de llo s tato, nutr ito de lla fiducia ne lla razionalità s inottico- programmator ia . I libe r is ti traggono inve ce dalla loro cr itica cons e gue nze oppos te . La s fiducia ne ll’inte rve nto pubblico por ta a s os te ne re un ampliame nto de lle s ce lte las ciate al me rcato” (T r igilia , 2001, p. 362.) Ne s s una di que s te cr itiche , tuttavia , r ie s ce a r is olve re in modo e fficace i proble mi poc’anzi r ichiamati, da qui la s pinta ve rs o l’us o cre s ce nte di accordi di dive rs a natura che s i e s plicitano ne lla conce r tazione .
Sv iluppi de lla concertazione Il conce tto di conce r tazione può e s s e re de finito come “l’accordo formalizzato (cioè non s oltanto implicito o tacito) s u obie ttivi concordati da attor i i cui inte re s s i s ono tradizionalme nte e /o pote nzialme nte dive rs i e /o contras tanti. I due tipi più noti e r icorre nti di coope razione e di conce r tazione s ono que llo tra attor i pubblici e pr ivati, e que llo tra as s ociazioni impre nditor iali e s indacati” (Pichie r r i, 2001, p. 237). Con il te rmine conce r tazione s i de s igna una te nde nza s e mpre più diffus a ve rs o pratiche ne goziali e par te nar iati, caratte r izzati dall’individuazione di obie ttivi da raggiunge re o di compor tame nti da te ne re e ntro ce r ti te mpi, con ce r te modalità e s ulla bas e di r is ors e a ciò de dicate ; il tutto e s plicitame nte formalizzato in accordi pubblici. Que s to tipo di re golazione e conomica, fondata s ulla coope razione , di pe r s é non è una novità: vi s ono molti cas i di s ucce s s o, s i pe ns i a i dis tre tti indus tr iali, ove gli a ttor i r iconos cono l’e s is te nza di valor i condivis i e di inte re s s i comuni. Pe r que s ta via la re golazione avvie ne attrave rs o forme di gov e rnance piuttos to che di gov e rnme nt . Da un punto di vis ta pre ttame nte organizzativo, la re te divie ne , in ta le conte s to, lo s trume nto caratte r is tico de ll’azione colle ttiva s trutturata s ia pe r la de finizione de gli obie ttivi che pe r l’imple me ntazione de gli s te s s i.
Le pr ime iniziative di coope razione formalizzata ne lla re golazione de lle e conomie locali s i cominciano a diffonde re ne i dive rs i pae s i e urope i con gli
93 93
anni ’70. Ne gli anni ’80 acquis is cono una maggiore vis ibilità a caus a di una cre s ce nte diffus ione . Gli anni ’90 s ancis cono que s to proce s s o di is tituzionalizzazione re s os i e vide nte ne l moltiplicars i de i patti s ociali. La conce r tazione locale s e mbra e s s e re il nuovo modo le gittimo di re golazione de i s is te mi e conomici locali; s i comincia cos ì a dis tingue re le dive rs e tipologie di patti. L’influe nza de lla Ce e /Ue è s tata de cis iva ne l promuove re e ge ne ralizzare que s to proce s s o di is tituzionalizzazione . Una de lle motivazioni addotte è s tata que lla de lla ge ne ralizzazione de lle good practice s . Que s ta influe nza s i è pos itivame nte combinata con l’inte re s s e de i s ogge tti locali più de boli ad otte ne re le gittimazione e r is ors e , e dis pos ti, pe r que s to, a s pos are a pie no titolo la nuova te nde nza. La conce r tazione può re alizzars i a dive rs i live lli: locale , nazionale e e urope o102 . In que s ti anni, la diffus ione maggiore s i è avuta in te rmini di contrattazione de ce ntrata , diffus a, mole colare e s u te mi s e ttor iali. Lo s viluppo di que s to proce s s o, in te rmini di pratiche contrattuali e ffe ttivame nte pe rs e guite dalle amminis trazioni, in Ita lia , non è s tato ancora s tudiato s ufficie nte me nte 103 .
L’introduzione di ta li s trume nti contrattuali è avve nuta in modo incre me ntale e confus o. Il fa tto che il fe nome no s ia r ius cito a diffonde rs i anche in as s e nza di un dis e gno e s plicito è il s e gno e vide nte che r is ponde ad e s ige nze profonde .104
102 La diffusione di una contrattazione pubblica ed esplicita in Europa ha una storia ormai radicata nelle arene neo-corporative e si esplicita attraverso i patti triangolari conclusi a livello nazionale tra governo, sindacati e padronato. Tale negoziazione dà luogo ad accordi formali che impongono a tutti gli altri soggetti (parlamento compreso) scelte fondamentali di politica economica: tassazione, investimenti pubblici, misure per l’occupazione, pensioni ecc.. I patti neocorporativi sono accordi centralizzati, conclusi a livello nazionale, sottoscritti da un numero ristretto di grandi organizzatori su argomenti generali. A questo livello, negli accordi tripartiti, la materia è quella della contrattazione collettiva. Al contrario, l’ambito territoriale locale-sub-nazionale può essere molto variabile: può trattarsi di regioni, province, città, distretti, reti provvisorie ecc.; la materia degli accordi può essere più ampia., a livello locale l’oggetto della concertazione può assumere varia natura; il numero degli attori coinvolti tende ad essere maggiore e a inglobare soggetti organizzativi di diversa natura; i soggetti coinvolti concordano sin dall’inizio sui progetti da promuovere, la negoziazione riguarda, in questo caso, le priorità e la gestione delle risorse. Pichierri tenta una classificazione dei tipi di concertazione locale più ricorrenti che, in questa sede, ci limitiamo ad elencare rimandando per un approfondimento all’autore: partenariato pubblico/privato e pubblico/pubblico; relazioni industriali regionalizzate; distretti industriali di seconda generazione; pianificazione strategica urbana; progetti finanziati da programmi europei; patti territoriali. 103 Una maggiore chiarezza si riscontra in termini normativi. I giuristi, infatti, sono concordi nel fissare l’inizio del nuovo corso contrattuale nella seconda metà degli anni ’80 (D’Auria, 1998; Pellizzer e Zanetti 1999). Anche se ci sono dei precedenti (Ferrara, 1993), è in quegli anni che si è verificata un’improvvisa accelerazione. 104 Nel tentativo di ricostruire questo processo Bobbio (2000) individua tre diverse fasi. I FASE. L’Avvio: La prima fase risale al periodo che va dal 1985 al 1990. In questo periodo, vi sono alcune leggi di settore che autorizzano alcuni tipi di amministrazioni pubbliche a stipulare tra loro accordi di programma, su imitazione dei contrats de plan introdotti dal decentramento in Francia. I primi settori coinvolti in questa novità sono stati: i progetti di trasporto integrato nelle aree metropolitane (1985), l’intervento straordinario per il Mezzogiorno (1986), la tutela dell’ambiente (1989) la ricerca scientifica (1989) gli interventi per Roma capitale (1990). Ciò che accomuna tutte queste esperienze, diversissime tra loro, è l’esigenza di superare, attraverso la concertazione, impasses decisionali. Ci si rende conto che mettere tutti gli attori coinvolti attorno ad un tavolo è l’unico mezzo per sbloccare processi decisionali lunghi e difficili, la concertazione diviene, dunque, uno strumento di semplificazione decisionale. E’ su questa scia che nasce, nel 1986 il Contratto di programma ad opera del CIPI (Comitato interministeriale per la programmazione industriale) e nel 1987, la Conferenza dei servizi. Il contratto di programma consiste in una stipula tra Stato e grandi gruppi industriali per la realizzazione di azioni integrate. Il primo e principale beneficiario di questa innovazione è stata la FIAT per lo stabilimento di Melfi. La conferenza dei servizi, invece, prevede l’accordo unanime tra più amministrazioni competenti con l’effetto di sostituire qualsiasi atto di autorizzazione, approvazione o parere. E’ con la lege del 1989 sulle opere infrastrutturale per i mondiali di calcio che la conferenza dei servizi assume la massima notorietà. II FASE. Il consolidamento: Tra il 1990 e il 1994 si assiste ad una forte e generalizzata diffusione di questi strumenti. Per questo motivo la consideriamo la fase del consolidamento. I due principali strumenti contrattuali
94 94
Come s i e vince da que s ta bre ve r icos truzione de l fe nome no, tutti gli s forzi conducono ve rs o un te ntativo di inte grazione . Pe r que s ta via , ta le nozione , s e ppure mai e s plicitata in manie ra chiara e de finitiva, è e ntrata in manie ra s ignificativa ne l vocabolar io de lle pubbliche amminis trazioni. Quals ias i proble ma di policy , in s pe cial modo s e comple s s o, in line a te or ica, chie de di e s s e re affrontato attrave rs o la pre dis pos izione di proge tti inte grati che hanno l’ambizione di fonde re approcci, politiche , compe te nze le gali e s ape r i dis ciplinar i dive rs i. Que s ta var iopinta tipologia di contratti e accordi, da una par te , è una r is pos ta a l bis ogno di inte grazione che vie ne dal bas s o; dall’altra , una moda e una nuova re tor ica che nas cono da un bis ogno di fondo: que llo di s upe rare il divar io tra natura comple s s a de i proble mi e d e cce s s iva s pe cializzazione (vis ione parziale e limitata) de lle s ingole politiche pubbliche .
Se condo Bobbio (2000, p. 134), la contrattazione è la r is pos ta , quas i obbligata “alla cre s ce nte framme ntazione de gli apparati pubblici, s ia lungo l’as s e ce ntro- pe r ife r ia e s ia in re lazione ai proce s s i di s pe cializzazione funzionale .” La contrattualizzazione de lle politiche rappre s e nta una via di me zzo tra s tato e me rcato: ”è’ un modo pe r r is olve re i proble mi pubblici s e nza fare r icors o all’autor ità o alla le gge , né agli automatis mi de l me rcato ma, piuttos to, a ttrave rs o l’aggius tame nto cons ape vole de gli inte re s s i de gli a ttor i in gioco e la r ice rca de l cons e ns o s u obie ttivi e s trume nti comuni” (ivi, p. 135).
In un ancora re ce nte pas s ato la ne ce s s ità di far par te cipare inte re s s i dive rs i ad una de cis ione pubblica, ve niva r is olto, s ul piano is tituzionale , a ttrave rs o un’altra s trada: que lla de ll’inte grazione organizzativa o corporativa. In altr i te rmini, s i is tituivano organi cons ultivi pe rmane nti (colle gi, cons igli e cc.) ove s e de vano i rappre s e ntanti de gli inte re s s i con il compito di fornire il propr io pare re s ulle s ce lte pe rs e guite dall’e nte pubblico. Pe r que s ta via gli inte re s s i ve nivano inglobati o inte grati a ll’inte rno de lla s te s s a amminis trazione as s ume ndo un ruolo pe rmane nte e
introdotti nel periodo precedente assumono una portata generale a disposizione di tutte la amministrazioni in qualsiasi circostanza. Di particolare rilievo, in questa fase, è la legge di riforma delle autonomie locali (legge 142/1990) e quella sul procedimento amministrativo (legge 241/1990): si tratta, in entrambi i casi, di strumenti contrattuali destinati a regolare i rapporti tra amministrazioni pubbliche. La legge sul procedimento amministrativo (art. 14) specifica che anche i rapporti con i privati possono essere affrontati in modo consensuale mediante accordi che sostituiscono provvedimenti (art. 11). La decisione finale scaturisce da un accordo tra le parti. La differenza fondamentale è che con l’accordo di programma le amministrazioni assumono impegni reciproci, mentre, con la conferenza dei servizi esse si limitano a dare il proprio assenso per un intervento specifico. III FASE. L’espansione: La terza fase prende le mosse nel 1995 con la nascita di una nuova generazione di figure contrattuali etichettate con l’espressione programmazione negoziata. Sempre secondo Bobbio, l’evento che apre la strada a questa nuova fase è la fine dell’intervento straordinario per il Mezzogiorno. Il brusco arresto di uno degli strumenti più importanti della politica di sviluppo per le aree depresse impone un ripensamento complessivo delle leve di sviluppo e la ricerca di soluzioni alternative. E’ da questo momento di incertezza che prende le mosse la proposta elaborata dal CNEL, nella figura di Giuseppe De Rita (1998), che propone di sostituire il tradizionale intervento statalistico, top-down, con la promozione dello sviluppo dal basso, concordato a livello locale. Nasce così l’idea dei patti territoriali che il CNEL si incarica di promuovere. La legge 662/1996, di accompagnamento alla finanziaria del 1997, tenta una classificazione di questi diversi tipi di programmazione negoziata e ne elenca cinque diversi tipi: intesa istituzionale di programma; accordo di programma quadro; patto territoriale; contratto di programma; contratto di area (concordato per la prima volta nel patto sociale del 1996 tra governo e sindacati).
95 95
una ve s te ufficiale . La diffus ione di tavoli e /o accordi mos tra che s i è ape r ta un’altra via de finita , dall’autore , pluralis tica. Infatti, con la r iforma Cas s e s e (l. 357/93) s i è te s o a s os tituire gli organi colle giali con la convocazione di confe re nze de i s e rvizi.
Se nza vole r ide ologizzare que s ta nuova s tagione di policy , le s cars e r ice rche finora s volte e conce ntrate , in par ticolar modo s ui patti te r r itor iali, c i informano s ulle ambiguità ins ite in ta li accordi, i quali s pe s s o s ono s olo il frutto di a tti formali che non hanno e s iti re ali; s pe s s o, manca una pianificazione s e le ttiva, o un’ide a guida (Riccone 1998; Ros s i 1999). Le implicazioni che tali s viluppi pos s ono ave re s ono ancora poco chiare e las ciano ir r is olte alcune que s tioni di fondo. Come r icorda ancora Bobbio: il pr incipio de l contratto è in conflitto con il pr incipio de lla ge rarchia; la logica de l contratto è vis ta con s os pe tto dai s os te nitor i de lle logiche te cnico- s cie ntifiche pe rché condurre bbe a de cis ioni me no s agge e compromis s or ie ; s i apre il conflitto tra la re gola de lla maggioranza (propr ia de lle de mocrazie ) e que lla de ll’unanimità (propr ia de gli accordi); e ntra in cr is i il pr incipio de ll’impe rs onalità di we be r iana me moria, poiché gli accordi s i bas ano s u re lazioni for te me nte pe rs onalizzate ; s i pone la que s tione de lla re s pons abilità. A chi vie ne adde bitata la re s pons abilità di una de cis ione frutto di un tor tuos o patte ggiame nto?
Da un re ce nte s tudio s ullo s tato de i patti te r r itor iali in Ita lia (T r igilia , 2001) r is ulta che : non s e mbra incide re in manie ra s ignificativa la s ituazione s ocio- e conomica di par te nza (re ddito, grado di indus tr ializzazione , occupazione ); a l contrar io, s e mbra r ile vante , ma non de cis ivo, il pe s o de l capitale s ociale pre e s is te nte , mis urato dalla diffus ione di e s pe r ie nze coope rative e di un te s s uto fiduciar io che le ga gli a ttor i locali; un ruolo impor tante s e mbra e s s e re giocato dai fattor i che incidono s ulla qualità de lle inte razioni tra gli a ttor i (divie ne importante , dunque , il ruolo de lla le ade rs hip is tituzionale e la qualità de lla conce r tazione ) e dalle s ce lte organizzative ope rate ne lla fas e di re alizzazione “che non is olano la fas e de lla ge s tione , re alizzata attrave rs o appos ite s ocie tà, dai s ogge tti che hanno par te cipato attivame nte alla fas e di conce r tazione iniziale .” (Ce rs os imo e Wolle b, 2001).
Il dibattito in Italia
E’ in cors o anche in Ita lia un r ipe ns ame nto circa ruoli e compiti che le politiche de vono s volge re in que s ti s e ttor i. Ad e s e mpio, Colas anto (1996) te nta un s upe rame nto de lla conce zione clas s ica che ve de le politiche de l
96 96
lavoro e de ll’occupazione come un ambito s pe cialis tico inte rno alla re golazione de l s otto- s is te ma e conomico e s e parate dal più ampio campo de lle politiche s ociali. Se condo l’autore , ta li politiche rappre s e ntano uno s trume nto cruciale pe r l’e dificazione di un nuovo s is te ma di w e lfare , non s olo pe r combatte re il drammatico flage llo de lla dis occupazione , ma anche pe r introdurre una s e r ie di e le me nti innovativi r is pe tto alla tradizionale conce zione de lle politiche s ociali come , ad e s e mpio: pe rs onalizzazione de gli inte rve nti, r ice rca di s oluzioni locali e mirate , coinvolgime nto di una pluralità di a ttor i in una logica di raccordo e di programmazione ne goziata , a ttivazione e re s pons abilizzazione de i be ne ficiar i, promozione e non as s is te nza de l s ogge tto. Anche s e condo Paci (1997), que s to raccordo tra politiche s ociali e politiche di gove rno de l me rcato de l lavoro conduce ad un nuovo s is te ma di w e lfare de lle opportunità in luogo de l tradizionale w e lfare de lla prote z ione pas s iv a ormai re taggio di un pas s ato che non può tornare . I capis aldi di que s to nuovo s is te ma di we lfare ve ngono r intracciati ne ll’is truzione , ne lla formazione profe s s ionale e ne lle politiche attive de l lavoro e de ll’occupazione , a l fine di favor ire ne i s ogge tti l’acquis izione de lle compe te nze ne ce s s ar ie pe r ins e r irs i ne l me rcato de l lavoro, pe r r imane rvi e d, e ve ntualme nte , pe r r ie ntrarvi. De lla s te s s a ide a è anche Gidde ns (1999) che indica come via da pe rs e guire que lla de ll’inve s time nto in capitale umano in s os tituzione de i s os te gni e conomici dire tti agli individui. La te nde nza mode rna, dunque , è que lla di favor ire politiche s ociali a ttive , capaci di re s pons abilizzare i be ne ficiar i in modo da s os te ne r li ne llo s forzo di e mancipazione dalla dipe nde nza as s is te nziale . In que s ta logica, s e condo Gidde ns , le politiche de l lavoro s i pre s e ntano come il luogo de lla s pe r ime ntazione di que s ta nuova te nde nza.
Da molto te mpo ci s i è accor ti che occorrono s trume nti più raffinati pe r promuove re l’incontro tra domanda e offe r ta di lavoro che s pe s s o, a llo s tato attuale , non r ie s cono ne ppure a comunicare e s cambiars i ade guate informazioni s ulle r is pe ttive dis ponibilità e d e s ige nze . Dopo ave r te ntato pe r anni di r is olve re la care nza di occupazione age ndo ke yne s ianame nte s ul ve rs ante de lla domanda, s i è s cope r ta l’impor tanza di inte rve nire s u que llo de ll’offe r ta e s ui dis pos itivi a tti a favor ire il matching tra i due (Fre y, 1996). Dunque , oggi,
“anziché inte rve nire pre s s oché e s c lus ivame nte s ul ve rs ante de lla domanda di lavoro, a l fine di aume ntare la capacità de l s is te ma e conomico di ‘produr re ’ occupazione , s i ce rca di ope rare anche s ul ve rs ante de ll’offe r ta , migliorandone la qualificazione e la capacità di a tt ivazione s ul me rca to de l lavoro. Anziché re golare da l ce ntro, a ttr ave rs o la le gis lazione nazionale , c i s i or ie nta ve rs o una maggiore va lor izzazione de lla dime ns ione re gionale e loca le . Anziché conce ntrare s ulle is tituzioni pubbliche (e in modo par ticolare s ullo Sta to) il compito di incre me ntare l’occupazione , s i punta a coinvolge re una plura lità di a ttor i, da lle as s ociazioni di
97 97
cate gor ia a lle is t ituzioni formative , da lle forze s oc ia li a lle s ingole impre s e , fino a lle e s pre s s ioni organizza te de l ‘te rzo s e ttore ’. Anziché pre s cr ive re da ll’a lto, s i ope ra in dire zione de lla conce r tazione e de l r accordo tra i dive rs i pote nzia li a ttor i e s trume nti de lle polit iche de l lavoro e de ll’occupazione . Anziché ‘collocare ’ de i s ogge tti vis ti come titolar i di dir it t i, ma non di capacità di inizia tiva , s i pre fe r is ce ‘promuove re ’ l’incontro tra domanda e offe r ta , a l limite anche l’impre nditor ia lità de i ce rca tor i di occupazione . Anziché pre ve de re norme prote ttive unive rs a lis tiche , s i pr ivile giano inte rve nti s e le tt ivi e mira ti s u s pe c ifiche s ituazioni” (Ambros ini, 2001, 49).
Un as pe tto di cui è ne ce s s ar io te ne r conto è lo s tato di de bole zza che caratte r izza la s ituazione ita liana, s oprattutto al confronto con altre re altà e urope e . Es is tono dive rs i e le me nti che gravano s ul nos tro s is te ma, ma pe r quanto ci r iguarda tre s ono di par ticolare impor tanza: dis inte grazione de lle funzioni, affidate a compe te nze is tituzionali dive rs e e non inte grate e pe r que s to, s pe s s o, in conflitto; approccio organizzativo ancora pre vale nte me nte burocratico, con ins ufficie nti capacità promozionali e s cars e compe te nze profe s s ionali; limitato coinvolgime nto de i s ogge tti s ociali localme nte inte re s s ati (Re yne r i, 1996).
Que s ti tre fattor i pos s ono e s s e re r ias s unti ne lla que s tione de lla dis tr ibuzione de i pote r i e de lle compe te nze tra lo s tato e d altr i live lli di gove rno che , come già de tto, danno vita a conflittualità.
In una pros pe ttiva s ociologica, da te mpo s i è affe rmata l’ipote s i di uno s viluppo bas ato s ulla dime ns ione locale che cons e nta la r ivalutazione de lla s pe cificità locale e di tutte le s ue r is ors e mate r iali e immate r iali. E’ s u que s ta s cia che vie ne s e mpre più r ivalutato il ruolo de i s ogge tti is tituzionali locali come attor i e promotor i di s viluppo.
Le politiche de l lavoro s e mbrano or ie ntate ad abbracciare que s to nuovo paradigma e a configurars i come “un mix di azioni s e mpre più radicate ne l live llo locale , r is pe tto al quale l’inte rve nto da par te de i gove rni ce ntrali as s ume come obie ttivi limitati la de finizione de gli ambiti di azione e gli inte rve nti compe ns ativi dire tti ad e vitare il r is chio di un’acce ntuazione de lla re gionalizzazione de gli s quilibr i pre e s is te nti” (Colas anto, 1993, p. 126)
Sulla s cia de lle cons ide razioni finora s volte è pos s ibile individuare quattro nuove te nde nze , ormai in via di cons olidame nto, che s tanno modificando le politiche de l lavoro: il pas s aggio da politiche re golative (burocratiche , garantis te e as s is te nziali) a politiche promozionali; lo s viluppo de lla politica de l lavoro caratte r izzata s e mpre più da un’ampia gamma di inte rve nti bas ati s u s e le ttività e diffe re nziazione e la molte plicità de gli s trume nti; l’a tte nzione cre s ce nte alla dime ns ione locale ; la cre s ce nte mobilitazione di
98 98
r is ors e , da par te de lla pubblica amminis trazione , a tutti i live lli (Zucche tti, 2001).
Inoltre , bis ogna cons ide rare un par ticolare e ffe tto de lle politiche attive de l lavoro in re lazione alla dime ns ione te r r itor iale . T ali politiche , infatti, producono r is ultati convince nti dove e s is te un me rcato de l lavoro dinamico, ove le impre s e ce rcano lavorator i s e nza r ius cire a trovar li e i lavorator i non s anno come e ntrare in contatto con le pre zios e informazioni circa le r ichie s te de lla domanda. In un s iffatto conte s to la me diazione de i s e rvizi pe r l’impie go s i r ive la par ticolarme nte utile in quanto contr ibuis ce ad ampliare la circolazione de lle informazioni re nde ndole più tras pare nti e , a l conte mpo, ope ra una corre zione parziale de lla re golazione informale e pe rs onalis tica de ll’incontro tra domanda e offe r ta di lavoro. Si pe ns i, ad e s e mpio, a ll’impor tanza de lle re ti familiar i o amicali che cons e ntono di conos ce re “la pe rs ona gius ta”. Al contrar io, laddove la domanda di lavoro è s cars a, que s to ge ne re di inte rve nti pe rde gran par te de lla s ua e fficacia , me ntre s e rvire bbe ro azioni di s viluppo e conomico. A que s to propos ito, a lcuni autor i, s os te ngono l’azione pro- ciclica de lle politiche attive : ta li politiche producono gli e ffe tti miglior i ne lle fas i di cre s cita e conomica. Il loro s ucce s s o, inoltre , potre bbe dis ce nde re propr io dal fatto che agis cono ins ie me ad una s e r ie di a ltre politiche pubbliche e condizioni is tituzionali (Es ping- Ande rs e n, Re gini, 1998).
In que s to conte s to, la formazione vie ne a rappre s e ntare un tas s e llo fondame ntale . Ai s is te mi e ducativi e formativi s pe tta il compito di pre parare le r is ors e umane de s tinate ad alime ntare la capacità di innovare , pe rs e guire e le vati s tandard di qualità, r ice rcare una compe titività compatibile con altr i live lli di produzione s ociale . In un s is te ma in cui il lavoro non è più cons ide rato come s icuro e s tabile “la formazione e ntra ne l s is te ma de i dir itti di c ittadinanza” (Colas anto, 1996, p. 15).
Il dile mma de i mode rni s is te mi di formazione cons is te ne ll’ade guame nto de lla formazione ai bis ogni de l me rcato de l lavoro e , di cons e gue nza, ne lla ne ce s s ità di inte rpre tare i cambiame nti de l s is te ma produttivo pe r appre s tare r ipos te coe re nti, s ia in te rmini qualita tivi che in te rmini quantita tivi, da par te de l s is te ma e ducativo. Chiarame nte non ci può e s s e re a live llo s trutturale una pie na corr is ponde nza tra que s ti s is te mi poiché hanno te mpi dive rs i. Il proble ma, dunque , s ta ne l te ntare di r is olve re que s to gap. Dopo il fa llime nto de lle politiche di pianificazione s ociale s i s ta te ntando la via de lla fle s s ibilità s olle citando, da una par te , le impre s e alla loro par te di re s pons abilità e , dall’altra , r iproge ttando il mode llo s colas tico- formativo attrave rs o la modular izzazione e l’attivazione di re ti locali105 . E que s to pe rché il te rmine : politiche attive “ha avuto ne l re ce nte
105 Secondo Moro (1998, p. 27), infatti, “la rapidità del cambiamento tecnologico, ma anche il disarticolarsi dei progetti di vita personali, fanno sì che non si persegua tanto un perfetto adeguamento dell’istruzione ai bisogni produttivi, quanto che si progettino dei sistemi formativi che consentano dei percorsi flessibili con periodi di
99 99
pas s ato una grande for tuna, ma che fors e oggi non appare più s ufficie nte me nte pre gnante e s ignificativo” (Franchi, Palumbo, 2000, p. 26). In bas e a quando de tto, pe r politiche inte grate –in que s ta s e de - s i inte ndono que gli inte rve nti pubblici che hanno lo s copo di coordinare tra di loro politiche , a ttor i s ociali e dinamiche che inte ragis cono in uno s pe cifico conte s to o are a proble matica. Come r icorda Donolo (2002, p. 91) ci troviamo ad e s plorare un ins ie me di politiche finora poco indagate ne i loro pre s uppos ti e ne i loro pos s ibili e s iti. L’autore par te dall’as s unto che una inte grazione s ia aus picabile e pos s ibile pe r r is ponde re ai molti dile mmi pos ti dallo s viluppo conte mporane o. Due s ono i pe rcors i di inte grazione da pe rs e guire : “e ffe tti d’inte grazione s ono de s ide rabili come valore aggiunto ad impatti s e ttor iali e parziali di politiche in atto. Inoltre , s ono r ite nuti indis pe ns abili ne i cas i in cui (fors e s e mpre più fre que nti), s e non c’è inte grazione de gli e ffe tti de lle policie s , non è pos s ibile e vitare danni, r is chi e cos ti s ociali anche gravi.” Come s i è avuto modo di os s e rvare , l’inte grazione de lle politiche è s tata s olle citata , in modo più o me no e s plicito, dall’Unione Europe a; s i r itie ne , infatti che s olo que s te s iano in grado di raggiunge re obie ttivi comple s s i in s pe cial modo ne l campo de l w e lfare , de ll’ambie nte e de llo s viluppo locale . Ne i fatti, inve ce , le politiche s ono, tuttora, pe r lo più framme ntate (divis ioni tra mate r ie , compe te nze , live lli, a ttor i pubblici e pr ivati e cc.) e , s pe s s o, la loro inte grazione non ha come obie ttivo un maggior coordiname nto de gli impatti ma, ad e s e mpio, la r iduzione de i cos ti di s e rvizio, la razionalizzane de lle organizzazione , la r iduzione de gli s pre chi e cc.. Ma l’inte grazione che s i ottie ne guardando ai cos ti –e quindi ai me zzi – è dive rs a da que lla che s i potre bbe otte ne re guardando ai fini. Incalza ancora l’autore : “due fattor i s i muovono in s e ns o oppos to: a) la logica de l profe s s ionis mo che alime nta te matizzazioni più s pe cifiche e d ar ticolate e quindi produce una cre s ce nte diffe re nziazione de ll’offe r ta; b) l’applicazione de l pr incipio di s us s idiar ie tà ne ll’ambito di più ampie r iforme amminis trative : e s s o r idis e gna la divis ione de l lavoro tra live lli di gove rno, s trutture di gove rno, inte razioni tra attor i pubblici e pr ivati, face ndo e volve re l’inte ro s is te ma de lle politiche ve rs o s trutture re ticolar i. Naturalme nte gli s te s s i fattor i e proce s s i che producono diffe re nziazione e quindi anche framme ntazione , a ttivano r is ors e pe r l’inte grazione . Es s a è infatti inconce pibile s e nza live lli più avanzati di profe s s ionis mo e di ne tw ork ing” (ivi, p. 92).
Se condo que s ta impos tazione , l’inte grazione de lle politiche è le gata all’ide a di una pos s ibile vis ione e te matizzazione inte grata de lle mate r ie le quali s ono tipicame nte comple s s e , ar ticolate e , a volte , caratte r izzate da as pe tti inconciliabili. Non s olo, a s e guito de lla fas e de re golativa che ha attrave rs ato tutti i pae s i occide ntali e de ll’inde bolime nto di forme
alternanza fra scuola e lavoro. Ciò al fine sia di dotare gli individui di un bagaglio culturale che li metta in grado di comprendere e gestire l’innovazione sia di rendere il sistema formativo in grado di rispondere ai bisogni, sempre più diffusi, di riprogettare la propria esistenza anche in età adulta, cambiando attività o passando dal lavoro dipendente a quello autonomo e imprenditoriale”.
100 100
s tatoce ntr iche , l’affe rmazione di un punto di vis ta inte grato s e mbra ancor più diffic ile e comple s s a. Occorre te ne r pre s e nte , tuttavia , che le politiche nazionali o trans nazionali ope rano e ntro il quadro is tituzionale de lla Comunità Europe a, e d alcuni pr incipi affe rmati con vigore ne lle politiche comunitar ie por tano a cons ide rare l’inte grazione il fine pr ior itar io di tutti gli inte rve nti di policy . Infatti, l’Unione te nde ad e s s e re pre s e nte ne i proce s s i di gov e rnance e ne i proce s s i di inte grazione s oprattutto in due forme . In quanto forza tutti gli a ttor i ad ope rare s e condo una logica di proge tto e di r is ultato; di e s plicitazione de gli s copi e di loro ade guata de finizione ; di calcolo de i me zzi; di valutazione de gli impatti e di e s te rnalità. In quanto propone alcuni pr incipi guida de ll’azione amminis trativa e d e conomica che hanno valore cos tituzionale e che de vono or ie ntare la proge ttualità e d l’as s unzione de lle re s pons abilità106 .
La UE ope ra, quindi, una s ignificativa pre s s ione affinché le politiche nazionali producano e ffe tti di inte grazione attrave rs o dive rs e vie : s olle citando proce s s i di appre ndime nto e incitando lo s viluppo, la cre s cita , l’innovazione e la dis s e minazione di buone pratiche . Sulla bae di que s te cons ide razioni, l’Europa de ve e s s e re conce pita “non tanto come aggiunta di un live llo [ di gove rno] ge rarchico, s ia pure de lle fonti normative quanto, piuttos to, come tors ione de l gove rnme nt ve rs o forme di gove rnance guidate da pr incipi cos tituzionali e da s ape r i te cnici. Es s e s ono or ie ntate s e mpre più alla coope razione tras ve rs ale tra attor i di tipo dive rs o, tra live lli di compe te nza, tra s e ttor i di a ttività. La pr imazia di que s ta impos tazione ope ra ce r to attrave rs o il condizioname nto de lle e rogazioni finanziar ie e quindi de gli ince ntivi, ma i s uoi e ffe tti più intr ins e ci s ono da r itrovare ne l mutame nto innovativo de lle culture organizzative e profe s s ionali, e quindi dagli s pazi ape r ti pe r pratiche coope rative , finalizzate all’inte grazione de i me zzi e de i r is ultati” (ivi, p. 97).
Se condo que s ta de s cr izione , le politiche inte grate mirano a produrre , in par te pe r via attiva, e in par te pe r impatti indire tti, e ffe tti di inte grazione s ulle mate r ie trattate ; me ntre s i te me che le politiche non inte grate finis cano pe r produrre e ffe tti pe rve rs i las ciando fuor i controllo var iabili cruciali. In vir tù di c iò, “s i può inte nde re la domanda di inte grazione come un’e s ige nza ine re nte alla natura de i proble mi di gove rnance , non solo te r r itor iale , che abbiamo di fronte ; come una norma cos titutiva de r ivante
106 Tra tali responsabilità possiamo citare: la coesione sociale e territoriale che si traduce nel tentativo di compensare gli squilibri e le marginalità prodotte dalla crescita economica; le pari opportunità che non si traducono solo nell’equità delle prospettive professionali tra i sessi, ma chiamano in causa il potenziamento delle capacità umane, la valorizzazione del capitale umano, la valorizzazione delle capabilities (Sen, 2000). Dunque, nell’accezione più moderna e completa, pari opportunità rinvia a sviluppo locale e sviluppo sostenibile. Infine, l’ultimo elemento di responsabilità da richiamare è quello della sostenibilità che è forse il criterio più difficile da definire e ha a che fare intrinsecamente con le questioni e i dilemmi dell’integrazione. La dimensione della sostenibilità implica per le politiche nazionali: esigenze di coesione sociale, processi di devoluzione secondo il principio di sussidiarietà, obblighi di ecocompatibilità, prudenza e self-control riguardo al patrimonio dei beni comuni nel rispetto delle future generazioni. Per un approfondimento di questi temi si rimanda ai testi di Donolo: Verso Sud; e Disordine. Sociologia e politiche delle regolazioni (2001/; 2001/b).
101 101
dai cr ite r i ope rativi de ll’unificazione e urope a; come un’acquis izione , pe r quanto ancora incomple ta , di dis cipline dive rs e , di a ttor i is tituzionali, di e s pre s s ioni de lla s ocie tà civile ” (ivi,. p. 98).
Se ppure in pre s e nza di e le me nti di confus ione e ambiguità tipici di ogni mome nto di trans izione , s e mbre re bbe che , con le politiche inte grate , s i de line i la te nde nza ve rs o un avanzame nto de lle più tradizionali politiche attive . Ambiguità che , in ambito di politiche pubbliche , divie ne ancora più e vide nte ipoichè inve s te s e ttor i di compe te nza e /o di pote re che alte rano e quilibr i pre e s is te nti. Pe r un’ade guata compre ns ione di ta le innovativo s trume nto di gove rno è ne ce s s ar io r icordare che tali politiche , pe r e s s e re corre ttame nte imple me ntate , pre s uppongono configurazioni organizzative a re te , da qui l’impor tanza di affrontare conce tti quali ne twork, par te nar iato, re lazioni inte rorganizzative , e cc..
Partenariato e politica di coes ione: ve rso le politiche integrate?
Quando s i par la di par te nar iato locale s i inte nde comune me nte :
“…un accordo contra tto da dive rs i s ogge tti appar te ne nti ad un da to te r r itor io, fina lizza to a raggiunge re obie ttivi di inte re s s e comune ne l campo de llo s viluppo e conomico e de lla c re s c ita occupazionale [ …] . Pe r de finizione , il par te nar ia to r iunis ce de lle pe rs one e de lle organizzazioni prove nie nti da ambie nti diffe re nti, s ottopos te a pre s s ioni dive rs e che dife ndono inte re s s i ta lvolta diffic ilme nte compatibili, s e non addir it tura contras tanti. In pr inc ipio, [ …] il loro unico comune de nominatore è l’appar te ne nza ad uno s te s s o te r r itor io. Pe r tanto, la loro s ituazione di par te nza compor ta che le pos s ibilità di fra inte ndime nti e di mome nti di dis accordo pos s ano e s s e re nume ros e : e cco a llora che occor re una re a le volontà comune e , conte mporane ame nte , una ne ce s s ar ia a tte nzione a lle forme di comunicazione e d un ce r to grado di pre dis pos izione ve rs o modalità di azione s uffic ie nte me nte fle s s ibili e c re a tive ” (Gilli, 1999, p. 40).
T ale de finizione e voca il conce tto s te s s o di patto, largame nte diffus o anche a live llo politico pe r promuove re proge tti is pirati ad una logica ne goziale che coinvolgano la quas i totalità de lle par ti is tituzionali e s ociali chiamate in caus a. Il te rmine patto vie ne utilizzato anche pe r la pos itività di s ignificati che r ichiama: lavorare in s ocie tà, amicizia , a lle anza, complicità, prome s s a, s cambio. Ciò che caratte r izza un patto è il pe rs e guime nto di un obie ttivo che vincola, o dovre bbe vincolare , più o me no indis s olubilme nte , tutti i contrae nti fino al s uo comple to raggiungime nto; la compone nte de llo s cambio e de lla re ciprocità de finis ce l’or izzonte de l pe rcors o. Data
102 102
l’impor tanza che tale s trume nto vie ne as s ume ndo ne ll’attuale mome nto di trans izione anche la Comunità e urope a 107 ha r ite nuto oppor tuno s pe cificare alcuni pr incipi guida che caratte r izzano un ve ro e propr io patto (o coalizione ) pe r l’occupazione e lo s viluppo locale e che s i ravvis ano ne lla proge ttazione e innovazione te r r itor iale 108 , ne lla inte grazione de gli inte rve nti109 , ne l par te nar iato110 e ne lla s os te nibilità111 . In vir tù di que s te cons ide razioni s i può affe rmare che il Patto o il par te nar iato s e mbrano pre s e ntars i come de gli utili s trume nti pe r gove rnare in te mpi di globalizzazione il pas s aggio dal locale al globale . Diana Gilli s ottoline a che :
“ne gli ult imi anni la s tra te gia de llo ‘s viluppo loca le ’ s i è andata intre cc iando s e mpre più con que lla de l lavoro in par te nar ia to. Ciò avvie ne ovunque , tanto che oggi non e s is tono pra ticame nte inizia tive di s viluppo loca le che non pre ve dono par te nar ia to e vice ve rs a . [ …] La cos truzione di una par tne rs hip loca le s ignifica innanzitutto un’as s unzione di r e s pons abilità e d una note vole quantità di lavoro. A s ua volta , c iò s ignifica che ogni s ingolo individuo e d ogni organizzazione che vi ade r is ce s i impe gna dire ttame nte , s i as s ume de i r is chi, r ice rca e condivide de gli obie ttivi comuni. Non s i tr a tta s olo di s e de rs i intorno ad un tavolo e colloquiare amiche volme nte : occor re oltre a lla buona volontà e d a lla capacità di s pe r ime ntare pe rcors i innovativi comuni, anche me tte re mano ad una buona dos e di r is or s e (umane , immate r ia li, informative , e s pe re nzia li e d e conomiche )” (ivi, p. 47- 48).
Sulla bas e de lle e s pe r ie nze finora s volte l’autr ice te nta di me tte re in e vide nza alcuni vantaggi che può appor tare un Patto te r r itor iale pe r l’occupazione : far e me rge re e rafforzare clas s i dir ige nti locali; produrre una cultura de lla re s pons abilità; mobilitare r is ors e locali nas cos te ; far le va s ui s ape r i locali; favor ire la coe s ione s ociale ; s copr ire o r is copr ire re altà te r r itor iali; favor ire l’e me rs ione de l lavoro s omme rs o; rafforzare il ruolo e
107 Ci si riferisce alla documentazione prodotta in occasione del seminario Local development and territorial employment pacts, tenutosi a Roma il 4-6 maggio 1997 presso il Cnel. 108 La progettazione di un Patto per lo sviluppo deve nascere “dall’analisi approfondita del territorio nel suo insieme, delle sue risorse, delle potenzialità, delle difficoltà ed ostacoli che si frappongono allo sviluppo dell’area. Quando si parla di progettazione si fa riferimento alla costruzione di un percorso che promuove modalità di intervento totalmente nuove. Pertanto, i soggetti locali si accordano su una lista di obiettivi (interventi) concreti e dettagliati, che presentano tutti un certo grado di innovazione, da raggiungere attraverso un percorso programmato e con strumenti condivisi. In altri termini, mediante un confronto continuo tra i diversi attori e facendo leva sulle risorse locali (umane, economiche e finanziarie), si cerca di realizzare una serie di interventi che rispondano a bisogni locali non soddisfatti.” (ivi, 38). 109 L’integrazione degli interventi riguarda, soprattutto, le misure programmate e gli obiettivi. Questi ultimi sono il frutto della concertazione, ossia “quel processo di discussione, negoziazione e decisione al quale partecipano tutti i partner del Patto.” (ivi) Lo scopo primario di un Patto territoriale è quello di combinare interessi economici e sociali diversi all’interno di una determinata area in modo da renderli interdipendenti. Questo può avvenire solo se tutti i progetti di sviluppo di un territorio sono collegati fra loro. Da ciò discende l’importanza di una coerente ed unitaria integrazione fra le diverse razionalità di cui sono portatori gli attori coinvolti, nonché l’insieme dei diversi progetti sottostanti ad esse. 110 Per partenariato si intende il riconoscimento formale di un patto, un interesse comune, per la crescita e lo sviluppo della comunità e del suo tessuto socio-economico. Esso implica la volontà di collaborare e di trovare una convergenza di interessi, ossia la condivisione di obiettivi: in questo senso il partenariato è la garanzia degli impegni reciproci presi da tutti i sottoscrittori del Patto, i quali aderiscono ad un programma di lavoro molto articolato e dettagliato in cui sono specificati i diversi ruoli individuali e/o collettivi e i percorsi di attuazione che ciascuno dovrà osservare. 111 Per sostenibilità si intende il principio secondo cui un progetto, una volta avviato, è in grado di trovare in se stesso le risorse per andare avanti in modo autonomo.
103 103
il radicame nto ne l te r r itor io de lle forze s ociali; coinvolge re i pr ivati ne gli obie ttivi comuni de llo s viluppo; favor ire e facilitare l’e me rge re di nuove r is ors e ; incide re s os tanzialme nte s ulla qualità de lla vita di un de te rminato te r r itor io; e s s e re motore di uno s viluppo nuovo, a tte nto alla re altà locale e ne l r is pe tto de ll’ambie nte 112 . Ogni par te nar iato di s viluppo locale è il r is ultato di un proce s s o s pontane o di conce r tazione tra s ogge tti che ide ntificano un obie ttivo comune in r is pos ta a proble mi pe culiar i de l te r r itor io. La mis s ione de l par te nar iato, quindi, è s tre ttame nte le gata alle caratte r is tiche de l conte s to in cui inte nde inte rve nire . L’impatto de i par te nar iati locali s i s os tanzia ne i proce s s i di e laborazione de lle politiche e ne lla loro re alizzazione a live llo locale . E’ molto difficile , tuttavia , valutare l’impatto di un’iniziativa di s viluppo locale in un de te rminato conte s to te r r itor iale : gli indicator i fis ici, infatti, pe r quanto nume ros i e comple s s i, non cons e ntono di r ile vare la por tata de lle innovazioni tras fe r ite s tabilme nte s ul te r r itor io, che s i concre tizzano s otto forma di prodotti e s e rvizi ma anche di proce s s i e re lazioni. Affinchè le innovazioni appor tate dall’iniziativa di s viluppo pos s ano e s s e re tras fe r ite s ul te r r itor io, è ne ce s s ar io che il proge tto abbia raggiunto gli obie ttivi pre fis s ati e che i r is ultati s iano s tati condivis i con tutti gli a ttor i locali inte re s s ati.
Un e le me nto e s tre mame nte impor tante è que llo de lla re s pons abilizzazione de gli a ttor i coinvolti ne l par te nar iato. La re s pons abilizzazione appare un e le me nto impor tante come r is pos ta ai proble mi di re s is te nza al cambiame nto che s i ve r ificano, s oprattutto, da par te di ope rator i di s e rvizi pubblici coinvolti in proge tti di r iqualificazione o r ide finizione de l propr io lavoro e funzionar i di e nti chiamati, pe r e s ige nze proge ttuali, a ge s tire s e rvizi innovativi o a modificare profondame nte il propr io modo di lavorare . Il lavoro in par te nar iato e la ge s tione par te cipativa di un’iniziativa di s viluppo locale r ichie dono un ce r to adattame nto, dal punto di vis ta organizzativo, di tutte le s trutture che s ce lgono di farne par te . Infatti, ogni
112 Poichè il patto, o partenariato, si fonda su un obiettivo e un progetto comune è possibile considerare come riferimento utile l’approccio integrato alla programmazione e gestione di programmi complessi, noto a livello internazionale come Projet Cycle Management (PCM), il quale distingue il ciclo di vita di un progetto in sei fasi. Tale approccio definisce anche il ruolo dei soggetti interessati in relazione alle diverse fasi del progetto medesimo. Secondo tale approccio la macro programmazione deve essere realizzata dai decisori politici nel corso della prima fase e dà l’avvio al processo di macroprogettazione; mentre gli attori chiave e i beneficiari intervengono con un ruolo centrale nella fase di progettazione in senso stretto per identificare i problemi che essi vivono e definire i corrispettivi obiettivi progettuali e la logica di intervento. Infine, gli esperti, i tecnici e i consulenti intervengono essenzialmente nelle fasi di progettazione esecutiva e realizzazione del progetto, in quanto è sulla base delle loro competenze ed expertise che viene definita la fattibilità dell’intervento. Nel passaggio dalla fase di progettazione a quella di attuazione, occorre avviare un processo di valutazione dei punti di forza e di debolezza della proposta per decidere quali sono le migliori azioni da intraprendere: tale valutazione si basa essenzialmente su tre criteri: rilevanza, fattibilità e sostenibilità. La rilevanza del progetto indica la misura in cui gli obiettivi progettuali influiscono su problemi reali e importanti che interessano i destinatari dell’intervento o, più in generale, la società. E’ questo un criterio centrale nella valutazione in quanto impedisce che vengano messi a punto e attuati progetti che non siano indirizzati alla risoluzione di problemi reali per i destinatari degli interventi e per la società; mentre la fattibilità del progetto misura la possibilità che venga effettivamente realizzato ciò che è stato deciso, ossia che vengano effettivamente raggiunti gli obiettivi previsti se i mezzi necessari saranno resi disponibili. La sostenibilità, invece, indica in quale misura i benefici rivolti ai destinatari delle azioni e realizzati mediante il progetto possono continuare a rinnovarsi dopo l’interruzione dell’azione di sostegno.
104 104
organis mo è dotato di un propr io patr imonio di proce dure e di re lazioni pre e s is te nti che pos s ono s ubire s e ns ibili modifiche in s e guito alle e s ige nze ge s tionali e s trate giche de l par te nar iato locale . Pe r adattars i a lle modalità di lavoro tipiche de lla par tne rs hip, la capacità di appre ndime nto de gli organis mi coinvolti ne l par te nar iato di s viluppo locale cos tituis ce un impor tante fattore di cre s cita pe r gli organis mi s te s s i, in quanto favor is ce la r iorganizzazione di a lcune s trutture e di proce s s i inte rni. Ma non s olo: la promozione di azioni finalizzate allo s viluppo de l te r r itor io è anche un’ope razione culturale , in quanto s i propone di aume ntare le compe te nze de lle pe rs one alle quali è dire tta , a l di là de gli s te re otipi culturali e de i pre giudizi (ISFOL, 2001/a)113 .
Ne gli ultimi anni s i è ve nuta affe rmando ne l dibattito politico e d e conomico la cons ape vole zza che la conce ntrazione te r r itor iale di s pe cializzazioni produttive non cos tituis ce un’e cce zione , be ns ì rappre s e nta il nuovo punto di e quilibr io ne lla contrappos izione locale - globale . Si è affe rmata l’ide a che i dis tre tti indus triali pos s ano rappre s e ntare una de lle vie di us cita dal vicolo cie co de lla produzione di mas s a. Il dis tre tto indus tr iale s e mbra e s s e re una tipica forma di organizzazione e conomica e s ociale de lla produzione pos tfordis ta . Il loro s ucce s s o dipe nde dalla capacità di mante ne re attivi i proce s s i di cambiame nto e di innovazione 114 . Una re ce nte r ice rca (Colas anto, 1996), me tte in e vide nza come , al di là de lle s pe cificità nazionali, s i r is contra in tutte le re altà e s aminate , la r ice rca attiva di “una maggiore inte grazione tra la molte plicità de gli inte rve nti re alizzati s ia s oprattutto un ‘avviciname nto’ de ll’inte rve nto e de l live llo de ll’inte rve nto ai s ogge tti che s i vogliono raggiunge re , e s pe cificame nte ai s ogge tti in ce rca di occupazione : live llo locale , pe rs onalizzazione de ll’inte rve nto, logica promozionale s ono pe r tanto i paradigmi di inte rve nto pr ivile giati. T ale r ice rca di inte grazione avvie ne re lativame nte a tre ambiti: un’inte grazione di tipo or izzontale tra gli ambiti de l lavoro e que lli de lla formazione profe s s ionale ; un’inte grazione ancora or izzontale , a i dive rs i live lli te r r itor iali, tra le ar ticolazioni de l Minis te ro de l Lavoro e que lle de ll’ANPE; e , infine , un’inte grazione di tipo ve r ticale tra i
113 E’ proprio a seguito di questa nuova modalità di risposta alla gestione del territorio che sembrano nascere e svilupparsi, in alcuni contesti in particolare, i distretti industriali che costituiscono una risposta locale ai processi di internalizzazione dei mercati. I distretti industriali sono definiti come modelli di organizzazione produttiva e sociale in cui l’elemento ‘territorio’ gioca un ruolo rilevante. Alcuni studiosi hanno tentato di spiegare i fattori che hanno generato e consolidato nel tempo i vantaggi competitivi dei distretti industriali. Tali fattori possono sinteticamente essere riassunti nel seguente modo: tendenza a raggiungere efficienza e competenza attraverso la specializzazione; rapido e facile accesso a tutta la gamma delle specializzazioni nella catena produttiva; disponibilità di elevate competenze tecniche locali; atmosfera industriale che permette una rapida diffusione delle idee; mix efficace di cooperazione e competizione; cultura imprenditoriale diffusa. 114 I distretti si stanno profilando come sistemi cognitivi a tre livelli: saperi empirici, tecnologie della comunicazione, codici astratti. Il dispositivo autopoietico dei distretti si concentra sulla riproduzione dell’identità come fattore di stabilizzazione organizzativa interna. Seleziona dall’esterno gli stimoli congeniali, elaborandoli attraverso il filtro di tre forme istituzionali di autoregolazione: le interazioni di mercato, i governi intermedi di rappresentanza, le grandi-medie imprese. Secondo la legge nazionale n. 317/91 che ha riconosciuto in Italia i distretti industriali questi sono definiti come sistemi produttivi geograficamente caratterizzati da un alto numero di unità produttive impegnate con differenti modalità nella realizzazione di un prodotto omogeneo (Rullani, 1999).
105 105
dive rs i live lli is tituzionali che hanno compe te nza in mate r ia di politiche de l lavoro.
Altr i autor i s os te ngono la te s i s e condo cui in vir tù de i profondi mutame nti che hanno inve s tito gli s ce nar i e conomico- s ociali s tanno e me rge ndo, anche s e a fatica, a fondame nto de lle politiche de l lavoro, nuovi paradigmi bas ati s u tre conce tti chiave : la promozionalità, te s a a favor ire l’incontro tra domanda e offe r ta di lavoro; la diffe re nz iaz ione , che ha por tato a s viluppare una s e r ie ampia di s trume nti di inte rve nto; l’inte graz ione ne ce s s ar ia pe r e vitare la framme ntazione de lle azioni e de lle r is ors e impie gate e la concorre nzialità de i molte plici a ttor i coinvolti a i dive rs i live lli. In vir tù di c iò, l’inte grazione de ve e s s e re r ice rcata s u tre dive rs i piani: tra i var i inte rve nti di politica de l lavoro promos s i dallo s te s s o s ogge tto; tra le mis ure di politica de l lavoro e que lle di politica e conomica, indus tr iale e te r r itor iale attivate ai var i live lli di re s pons abilità, ivi compre s a que lla pe r la formazione ; tra le politiche programmate dai s ogge tti pubblici a live llo ce ntrale e que llo promos s e dai s ogge tti ope ranti in ambito locale (Zucche tti, 2001).
Il conce tto di re te applicato alla pubblica amminis trazione Il conce tto di re te , s ia ne ll’ambito de lla s ociologia de lle organizzazioni che in que llo de lla s cie nza politica s i affe rma in contrappos izione al tradizionale mode llo ge rarchico- burocratico applicato tanto alle organizzazioni quanto alla re golazione de ll’azione pubblica. In campo organizzativo, la caratte r is tica pr imar ia de lla cos idde tta s ocie tà pos t- indus triale può e s s e re le tta ne lla cr is i de l mode llo tay lor- fordis ta che ha condotto, a fronte de lla cre s ce nte comple s s ità e de lla maggiore s ofis ticazione de i me rcati e de i proce s s i organizzativi (con re lativo aume nto de i cos ti di ge s tione ), a ll’affe rmazione di mode lli più fle s s ibili e a lla e s te rnalizzazione di dive rs e funzioni, dando vita ad una molte plicità di re ticoli organizzativi.
In campo politico- burocratico s i as s is te ad un proce s s o s imile . I tradizionali mode lli di re golazione s tanno le ntame nte las ciando il pas s o a nuovi mode lli bas ati s u re lazioni inte r is tituzionali e inte rorganizzative (gov e rnance ), fondati s ulla parte ne rs hip (o par te nar iato). Al te mpo s te s s o, s i ve r ifica l’affe rmars i di proce s s i di policy tipicame nte bottom- up e a ll’e s te rnalizzazione di funzioni pubbliche ve rs o il me rcato e il te rzo s e ttore . In vir tù di c iò, gli obie ttivi cui mira la cos truzione di una re te (o policy ne tw ork ) s ono dive rs i e s tre ttame nte inte rconne s s i tra di loro, pe r citarne alcuni: la migliore diffus ione de lle informazioni; lo s cambio di ide e , k now - how e pras s i s pe r ime ntate in altr i conte s ti, a l fine di favor ire l’appre ndime nto e l’acquis izione di innovazioni e conomiche , s ociali,
106 106
organizzative e cc.; la promozione di un proge tto, un cambiame nto e cc.; lo s timolo alla collaborazione e alla r ice rca di s oluzioni comuni. La re te è , quindi, uno s trume nto di cre s cita che tramite la circolazione di ide e age vola proce s s i di appre ndime nto. Il conce tto di ne tw ork è dive ntato di moda di re ce nte in un gran nume ro di dis cipline . T ale te rmine s e mbra e s s e re dive ntato il nuovo paradigma pe r l’archite ttura de lla comple s s ità; “la re golazione mode rna è caratte r izzata da s is te mi de cis ionali in cui la diffe re nziazione te r r itor iale e funzionale s compone la capacità di r is olve re e fficace me nte i proble mi in una s e r ie di s ottos is te mi di a ttor i con compiti s pe cializzati e compe te nze e r is ors e limitate ” (Borze l, 1998). Se condo le più re ce nti r ifle s s ioni maturate in s e no alle te or ie inte rorganizzative il r is ultato di que s ta te nde nza “ è un’inte rdipe nde nza funzionale fra attor i pubblici e pr ivati a ll’inte rno de l proce s s o di policy- making. I gove rni s ono dive ntati s e mpre più dipe nde nti dalla coope razione e dalla congiunta mobilitazione de lle r is ors e de gli a ttor i che contr ibuis cono alla de finizione e all’e fficacia de lle politiche , ma che s i trovano al di fuor i de l loro controllo ge rarchico. Que s ti cambiame nti hanno favor ito l’e me rge re di policy ne tw ork s come nuova forma di re golazione , dive rs a dalle due forme tradizionali (ge rarchia e me rcato), che pe rme tte ai gove rni di mobilizzare le r is ors e politiche in s ituazioni in cui ta li r is ors e s ono for te me nte dis pe rs e fra attor i pubblici e pr ivati (Mar in e Mayntz 1991, Le Galès 1995).
Il policy ne tw ork s compre nde tutti gli a ttor i a var io titolo coinvolti ne lla formulazione e re alizzazione di una politica in uno s pe cifico s e ttore . E’ caratte r izzato da inte razioni pe r lo più informali tra attor i pubblici e pr ivati con inte re s s i dis tinti ma inte rdipe nde nti, i quali ce rcano di r is olve re i proble mi di azione colle ttiva ad un live llo ce ntrale e non ge rarchico. In altr i te rmini que s te re ti rappre s e ntano il r is ultato di una mutata re lazione fra s tato e s ocie tà. Non e s is te più una pre cis a s e parazione tra i due te rmini de l proce s s o. Non è ancora chiaro s e le re ti cos tituis cano una nuova forma di re golazione o s e rappre s e ntino una forma ibr ida che s i colloca in un punto all’inte rno de l continuum che ve de ge rarchia e me rcato ai due e s tre mi oppos ti (Williams on 1985). Alcuni autor i, tuttavia , non mancano di e vide nziare che i policy ne tw ork s s i dis tinguono come tipo di s truttura s ociale qualita tivame nte dive rs a in quanto caratte r izzata dalla combinazione di e le me nti che appar te ngono alle due forme di re golazione fondame ntali: l’e s is te nza di una pluralità di a ttor i, tipica de l me rcato; la capacità di pe rs e guire obie ttivi pre s tabiliti a ttrave rs o un’azione coordinata , tipico de lla ge rarchia (Mar in e Maynts , 1991).
Alcuni s tudios i te ndono, al contrar io, a cons ide rare i policy ne tw ork s una s pe cifica forma di re golazione . Se condo Ke nis e Schne ide r (1991) le s ocie tà mode rne s ono contraddis tinte da una diffe re nziazione funzionale e da s ottos is te mi s ociali autonomi. L’affe rmars i di que s ti s ottos is te mi s i colle ga all’as ce nde nza di organizzazioni formali che cos tituis cono re lazioni
107 107
inte rorganizzative con altre organizzazioni dalle quali dipe ndono le propr ie r is ors e . Le organizzazioni dis pongono di r is ors e impor tanti, pe r que s to motivo s ono dive nute s e mpre più impor tanti pe r la formulazione e la re alizzazione de lle politiche pubbliche . In ta le conte s to s trutturale i policy ne tw ork s s i pre s e ntano come una s oluzione ai proble mi di coordiname nto tipici de lle s ocie tà mode rne . Quando il coordiname nto ge rarchico dive nta me no praticabile ne lle inte razioni fra s e ttor i, confini organizzativi e nazionali, gli a ttor i te ndono ad affidars i a l coordiname nto or izzontale autonomo all’inte rno di ne tworks che pos s ono s e rvire come e quivale nti funzionali de lla ge rarchia (Scharpf, 1993).
Considerazioni conclus ive
Ris ulta a que s to punto e vide nte che la pubblica amminis trazione , in ogni de mocrazia mode rna, s ta affrontando un impor tante proce s s o di r is trutturazione che inve s te ogni ambito di inte rve nto. Come è già avve nuto ne l s e ttore e conomico- produttivo, anche in que s to s e ttore , cambia il lavoro, i s uoi conte nuti e le pre s tazioni ad e s s o le gate , le pre s s ioni ope rate dall’ambie nte , le fonti da cui a ttinge re r is ors e , i rappor ti di pote re e le re lazioni s te s s e tra gli a ttor i. Gli inte re s s i de lle var ie par ti in caus a non s ono più ins e r iti s tabilme nte de ntro la s truttura amminis trativa, ma dialogano con e s s a da fuor i, di volta in volta , s e condo le circos tanze , ove le dive rs e par ti s ottos cr ivono ve r i e propr i contratti e s i as s umono impe gni pubblici. Pe r mutuare un te rmine dal me rcato potre mmo dire che s i as s is te ad un proce s s o di e s te rnalizzazione e di formalizzazione , dove i par tne r ve ngono individuati in que s to s is te ma ibr ido tra s tato e me rcato. Il cambiame nto inve s te anche i rappor ti tra le amminis trazioni pubbliche . Es s e s ono s e mpre più s pinte a trattare re lazioni re ciproche , da par i a par i, a l di fuor i di rappor ti ge rarchici e s e mpre più in un’ottica di re te . Si r is contra , come è avve nuto già pe r il me rcato, la te nde nza s e mpre più marcata alla s pe cializzazione , il mak e or buy , il de ce ntrame nto, la concorre nza, e cc.. Si va cos ì de line ando un nuovo mode llo organizzativo e produttivo che incide profondame nte anche ne lle pratiche quotidiane de gli a ttor i modificando le re lazioni, il lavoro, gli as s e tti ge rarchici.
All’inte rno di que s to proce s s o ancora le nto e confus o, s i s ta progre s s ivame nte affe rmando il me todo conce r tativo, de l quale , tuttavia , non s i è ancora compre s o fino a che punto abbia cambiato il nos tro modo di ope rare e tanto me no s i è r ius citi a r icompre nde r lo all’inte rno di un mode llo te or ico più ampio. Lo s viluppo a tutti i live lli e d in tutti i s e ttor i de lla contrattazione r ichie de compe te nze re lazionali tradizionalme nte poco pre s e nti ne lle nos tre amminis trazioni pubbliche . Lo s viluppo de lla contrattazione ne goziale e de i proge tti inte grati s ta modificando anche il nos tro vocabolar io. Se mpre più s i par la di a ttività di accompagname nto,
108 108
animazione , a ttivazione , facilitazione , par te cipazione . Il cambiame nto, tuttavia , non è s olo le s s icale pe rché s palanca gli or izzonti a profes s ionalità e compe te nze nuove pr ima mai cons ide rate in s e no all’amminis trazione pubblica. Da qui fors e il pe s o cre s ce nte che ve ngono ad as s ume re e s pe r ti e cons ule nti a var io titolo coinvolti in ta li proce s s i. E’ ne ce s s ar io dis tingue re , nondime no, che l’inte grazione s i gioca a diffe re nti live lli e in diffe re nti modi. Innanzitutto, s i può dis tingue re il live llo macro, ove s i trova il ne tw ork nazionale che gove rna la fas e de cis ionale , a ttie ne alla fas e proge ttuale ne lla quale s i s tabilis cono le line e guida, gli obie ttivi, i cr ite r i di valutazione de lla re te e de l proge tto (chiare zza de gli obie ttivi, coe re nza intr ins e ca al proge tto, congruità de lla par tne rs hip e cc.). In s e condo luogo, s i individua la dime ns ione te r r itor iale , dunque , il live llo me s o dove s i s viluppa il ne tw ork locale che attie ne alla fas e di imple me ntazione e chiama in caus a l’e s is te nza di is tituzioni inte rme die che favor is cono i proce s s i di me s s a in re te , le forme di re lazione inte rorganizzativa, la s e ns ibilità e l’ampie zza de l tavolo de cis ionale locale (capacità di include re altr i a ttor i, cos truzione di un os s e rvator io, a tte nzione ai fe e dback e cc.). E’ a que s to live llo che , in que s ti anni, s i è moltiplicata l’is tituzione di age nzie di s viluppo volte a gove rnare una s trate gia e d una compe te nza di s is te ma a l fine di far dialogare gli a ttor i te r r itor iali e favor ire la cos tituzione di una re te capace di dars i obie ttivi comuni e d ottimizzare r is ors e in vir tù di inte re s s i comuni. E’ s ignificativo che in nume ros i s e ttor i di policy s i s ia re gis trato uno s pontane o prolife rare di que s te age nzie , s e gno anche de lla volontà di incide re in manie ra concre ta s ulle var iabili di conte s to. Ma la cos a che las cia pe rple s s i è la difficoltà di que s te s trutture , nate pe r cos truire ne twork (age nzie di s viluppo locale , age nzie re gionali de l lavoro, age nzie pe r l’e rogazione de lle politiche s ociali) a cos tituirs i e s s e s te s s e come re te . Infatti, s e da un lato le politiche comunitar ie e nazionali hanno s timolato la nas cita a e lo s viluppo di nuovi attor i locali; dall’altro non pare abbiano fatto abbas tanza pe r favor ire la cos truzione de lla re te , ce lo dimos tra il fa tto che e s is tono s ul te r r itor io un gran nume ro di a ttor i di s is te ma che non dialogano tra loro.
Infine , è pos s ibile cons ide rare il live llo micro che attie ne alle pratiche quotidiane de gli a ttor i, e d è caratte r izzato dall’affe rmars i s e mpre più mas s iccio di figure di coordiname nto, dall’individuazione di ce ntr i di re s pons abilità, di re fe re nti intra e d inte rorganizzativi, in r is pos ta de lla cre s ce nte e s pans ione di re ti, par te nar iati, e s pe r ie nze di co- proge ttazione che s i può re gis trare ormai ad ogni live llo te r r itor iale e d in ogni s e ttore e che modifica profondame nte le pratiche de gli a ttor i.
Il “s is te ma inte grato”: c onc e zioni a c onfronto
109 109
In vir tù de lle cons ide razioni finora s volte è e vide nte che l’inte grazione tra i s is te mi di is truzione , formazione profe s s ionale e me rcato de l lavoro rappre s e nta l’as s e attorno al quale s i gioca, oggi, il r innovame nto de ll’inte ro s is te ma e ducativo- formativo. Guardando agli inte rve nti di r iforma de gli ultimi cinque anni ci s i può re nde re facilme nte conto come s i s ia giunti ad un mome nto cardine di pas s aggio dalle te or izzazioni a l piano ope rativo. Dal 1996 ad oggi, infatti, s i è as s is tito ad una acce le razione da par te de l le gis latore (Accordo di luglio de l 1999, Patto pe r il lavoro de l 1996, Le gge Bas s anini 59/97, Riordino de i cicli de l ’97, Pacche tto T re u de l ’97, Riforma Biagi), ne l te ntativo di favor ire in un te mpo ragione vole un alline ame nto con le indicazioni che ci pe rve ngono dalla Ue . Ne ll’ambito de lla nos tra r ifle s s ione un ruolo di par ticolare impor tanza è giocato dalla L. 196/97 che ha ge ttato le bas i pe r favor ire que s to proce s s o di inte grazione tra s is te mi e ducativo- formativo e d occupazionale attrave rs o gli ar ticoli: 15, 16 e 18, r is pe ttivame nte : appre ndis tato, formazione profe s s ionale e tirocini. Si tra tta ora di cos truire un ins ie me di oppor tunità formative fruibili in dive rs i pe r iodi de lla vita , in una logica non più line are ma circolare , inte grate appunto, in modo che s iano funzionali ad una domanda e conomica e s ociale in continua e voluzione .
In una ge ne r ica acce zione linguis tica con il te rmine inte grazione s i indica il fa tto di “re nde re inte ro, pie no, pe rfe tto ciò che è incomple to o ins ufficie nte a un de te rminato s copo, aggiunge ndo quanto è ne ce s s ar io o s upple ndo al dife tto con me zzi oppor tuni” (Enciclope dia T re ccani, 1987, p. 910). In un’acce zione e conomica, inve ce , s i inte nde con inte grazione “coordiname nto, fus ione , conce ntrazione di impre s e , che s i può ope rare s ia tra impre s e che s volgono la s te s s a fas e di lavorazione , al fine di r idurre i cos ti o di dominare il me rcato (inte graz ione orizzontale o late rale ), s ia tra impre s e che s volgono fas i s ucce s s ive de lla lavorazione di uno s te s s o prodotto, pe r dare vita a un s olo comple s s o e conomico e re alizzare cos ì una più e fficie nte e conve nie nte organizzazione de l c iclo produttivo (inte graz ione v e rticale )” (ivi p. 910). Come s i e vide nzia dallo s che ma che s e gue (s che ma n. 3), r is ale ndo più indie tro, a ll’e timo de lla parola , s i s copre che il te rmine inte grazione de r iva dal la tino inte gratio- onis . La bas e e vide nte me nte de r iva dal ge nitivo inte gre da cui traggono or igine i te rmini “inte gra” e “inte grum” volti a s ignificare : inte gro, inte ro, non diminuito in alcuna s ua par te , intatto; me ntre “inte grationis ” as s ume il s e ns o di re inte grazione , r innovame nto, r is tabilime nto. In un’acce zione più matura, il conce tto vie ne ad include re il s ignificato di ins e rzione , incorporazione , as s imilazione . Si as s is te , dunque , ad una s or ta di e s te ns ione s e mantica de l s ignificato attr ibuito al te rmine , che vie ne , via via , pe rde ndo la r igidità iniziale ins ita ne lla vis ione di inte ro, pe r accoglie re s oluzioni più fle s s ibili, a lte rnative ne lle quali è la s ce lta s ogge ttiva a r icos truire l’inte re zza. In que s to s e ns o è pos s ibile ve de re un proce s s o e volutivo de l te rmine che va di par i pas s o con la le nta ma
110 110
progre s s iva affe rmazione di una vis ione de l s is te ma s ociale dinamico e proce s s uale . L’acce zione più s tr inge nte , infatti, que lla che ci re s tituis ce un’e ntità intatta e non alte rata , s e mbra corr is ponde re alla vis ione di un s is te ma pre de te rminato, ogge ttivato, dove il tutto è de finito a pr ior i. Al contrar io, il s ignificato corre lato al te rmine latino inte grationis , e vocando parole tipo: r innovame nto e r is tabilime nto, las cia intrave de re una ce r ta dinamicità, propr ia di un s is te ma re lazionale che , s e ppur ancora pre de te rminato, las cia e me rge re la s ogge ttività. S c he ma n. 3 : e v o luz io ne de l c o nc e t to d i inte g ra z io ne Sis te ma pre de te rminato: me ccanic is tico Inte gre : inta tto, puro, non a lte ra to Sis te ma pre de te rminato: organic is tico Inte gra tionis : r innovame nto, r is tabilime nto Sis te ma non pre de te rminato: re lazionale Inte grazione : as s imilazione , incorporazione Sis te ma non pre de te rminta to: proce s s uale Inte grazione : co- proge ttazione , coge s tione
Fonte : nos tra e laborazione s u analis i s e mantica de l te rmine Ne ll’us o più mode rno de l te rmine , con l’allargame nto de ll’e s te ns ione s e mantica a parole quali: incorporazione e as s imilazione , vie ne e vocata la dime ns ione dinamica e inte rs ogge ttiva capace di cos truire nuovi ordini di s is te ma e di dare s e ns o all’azione concre ta che in que s ta ottica non è più pre de rminata be ns ì frutto de lla cos truzione s ociale . Attualme nte , come s i avrà modo di os s e rvare , il s ignificato di inte grazione vie ne ad include re conce tti quali: coproge ttazione , coge s tione , par te cipazione attiva e re s pons abile chiamando, cos ì, in caus a la dime ns ione proce s s uale e s ituazionale de ll’e ve nto. Que s to nuovo ordine di cos e è caratte r izzato da uno s forzo continuo de l s ogge tto volto a re s tituire inte re zza al s is te ma s e mpre fugge vole e cangiante , comple tame nte de s trutturato, ove l’unico s e ns o è s tabilito dall’e volve rs i de l proce s s o e la compre ns ione può e s s e re s olo inte rna al proce s s o me de s imo: proce s s o e s ogge tto, in que s to frange nte , dive ngono ins cindibili.
L’integrazione ne l pens iero pedagogico e ps icologico: i risvolti per la didattica
Anche ne ll’ambito de lla pe dagogia s i te nta , da anni, una r ifle s s ione circa il nuovo ruolo che la s cuola dovre bbe s volge re ne lla s ocie tà mode rna. Già in De we y l’e ducazione fondata s ull’e s pe r ie nza è ne ce s s ar ia all’uomo pe r adattars i a ll’ambie nte che gli è a ttorno. L’e ducazione e la s ocializzazione pos s ono avve nire in manie ra indire tta , tramite la vita e la formazione diffus a, o indire tta e formale , in modo par ticolare attrave rs o la s cuola.115
115 Tra i seguaci di Dewey, presumibilmente, quello che più si è soffermato sul problema dell’integrazione tra momento teorico e momento operativo è Carleton Washburne (anch’egli di orientamento progressista), che cercò di introdurre nella scuola pubblica le idee dell’attivismo, in cui le capacità e le differenze individuali venissero valorizzate. Con il testo Le scuole di Winnetka egli documenta la sua esperienza auspicando l’affermazione di un’idea di apprendimento basata su unità di lavoro progressive, secondo un ‘programma di sviluppo’ fondato su una
111 111
La pr ima inte rpre tazione de l te rmine inte grazione in ambito pe dagogico ha una vale nza molto r iduttiva, s chiacciata s u una s or ta di prolungame nto de l te mpo s colas tico, in vir tù de lle r innovate e s ige nze di una s ocie tà in cambiame nto. Da un lato, i ge nitor i s ono coinvolti s e mpre più in impe gni al di fuor i de lla famiglia; dall’altro, la moltiplicazione quantita tiva e qualita tiva de i me zzi di comunicazione ne lla s ocie tà conte mporane a accre s ce a dis mis ura le pos s ibilità e ducative (e dis e ducative ) de lla vita e xtras colas tica. T utto ciò, pone gli e ducator i di fronte ad una pre s a di cos cie nza di c iò che accade al di fuor i de lle mura s colas tiche e di fronte alla ne ce s s ità di azzardare nuove s oluzioni. Infatti, s ulla s cia di que s te s pinte innovative , già a par tire dagli anni ’70- ’80, s i s viluppano molte plici s pe r ime ntazioni volte a prolungare il te mpo s colas tico attrave rs o attiv ità inte grativ e (inte rs cuola, dopos cuola, a ttività cre ative e culturali, colonie e s tive , campi s cuola, vis ite in luoghi di lavoro, s tage e s tivi e d inve rnali e cc.), e s tre mame nte gradite e anche , ta lora, s olle citate dai giovani. Si tra tta , tuttavia , di un s e mplice prolungame nto de l te mpo s cuola in attività comple me ntar i pome r idiane . Non pas s a troppo te mpo che i s os te nitor i di que s ta propos ta innovativa cominciano ad e vide nziare le pote nzialità di una s iffatta innovazione : l’inte grazione , pe r e s s e re ta le , non può r is olve rs i in una me ra e s te ns ione quantita tiva ma de ve re alizzars i a ttrave rs o un s alto di qualità e un’ape r tura all’ambie nte circos tante naturale e s ociale . Se condo Lae ng, l’inte grazione può avve nire s olo attrave rs o il s upe rame nto de ll’oppos izione s cuola- non s cuola. La s cuola può cre s ce re s olo apre ndos i a l mondo e alla vita , acce ttando nuove forme di corre s pons abilità e di autoge s tione “non pe r pe rde re s e s te s s a, ma pe r r itrovars i e r itrovare la propr ia vocazione ” (Lae ng, 1995, p. 135). Attualme nte anche in ambito pe dagogico il conce tto di inte grazione as s ume nuove colorazioni e s i pre s e nta in tutta la s ua comple s s ità. Ad e s e mpio, s e condo alcuni os s e rvator i, pe r re alizzare un s is te ma formativo inte grato è ne ce s s ar io tras formare in r is ors a que llo che s i pre s e nta come un proble ma: la moltiplicazione de i ruoli a ll’inte rno de l panorama formativo, l’e s plos ione di nuove oppor tunità culturali, la nas cita di un ve ro e propr io ‘me rcato’ de ll’e ducazione . In que s t’ottica, un s is te ma inte grato de ve s upe rare le dime ns ioni r is tre tte de llo s colas tico pe r as s ume re que lle più ge ne rali, de l formativo, r ifiutando, al conte mpo, “l’ipote s i ne o- libe r is tica di un s e mplice allargame nto de i luoghi de ll’e ducazione pe r fars i car ico de lla ne ce s s ità di un’inte grazione razionale e de mocratica de lle r is ors e formative pre s e nti (o da attivare ) ne l te r r itor io” (Frabboni, Gue rra, Scurati, 1999, p. 96). Una e ffe ttiva e coe re nte attuazione di un s iffatto s is te ma r ichie de radicali cambiame nti ne l s is te ma s colas tico e un profondo
concezione sperimentale della pratica educativa. (Massa, 1990). In tale visione possiamo riscontrare quasi un’anticipazione dei dibattiti attuali fondati su: individuazione dei percorsi, patto formativo, responsabilizzazione del soggetto, recupero della valenza formativa del fare pratico ecc..
112 112
proce s s o di maturazione s u alme no tre dis tinti live lli: que llo s trutturale , que llo culturale e que llo funzionale 116 .
Le r ifle s s ioni fin qui s volte ci conducono ine vitabilme nte ad un’altra que s tione r ite nuta di e s tre ma attualità e d impor tanza, que lla de ll’e ducazione pe rmane nte , largame nte calde ggiata dalla comunità e urope a e , di cons e gue nza, dal le gis latore ita liano. L’e ducazione lungo tutta la vita s i pone come ir r inunciabile cornice proge ttuale di quals ivoglia r iforma de l s is te ma formativo che poggi s u que llo che vie ne de finito un “s is te ma pubblico unitar io e inte grato”. Se condo Frabboni (1990, p. 25), un “s is te ma formativo pubblico (is tituzionalme nte compre ns ivo de l piane ta non s tatale dis ponibile a ‘patti’ di garanzia nazionale s ugli s tandard quantitativi e qualita tivi de i propr i mode lli s colas tic i autonomi, unitar io (capace di valor izzare , ins ie me , le ide ntità e le diffe re nze de lle molte plici contrade s colas tiche ) e inte grato (in grado di promuove re re ciprocità e inte rconne s s ione culturale tra la s cuola e le age nzie inte nzionalme nte formativa de ll’e xtras cuola: famiglia , e nti locali, as s ociazionis mo, chie s e , mondo de l lavoro) pe rs e gue il traguardo/me ta di una s cuola e fficie nte , e fficace e d e qua”. Pe r giunge re , quindi, ad un mode llo formativo inte grato occorre proge ttare e condurre in por to, in te mpi bre vi, un mode llo formativo caratte r izzato dall’inte rconne s s ione / inte grazione de i molte plici luoghi de ll’e ducazione is tituzionali e culturali.
Sul piano is tituzionale appare urge nte il r ichiamo alle age nzie inte nzionalme nte formative (s is te ma formale e s is te ma non formale ) a s tabilire un’alle anza pe dagogica pe r arginare il me rcato de lla formazione a pagame nto che pe r s ua natura è ins tabile .
Sul piano culturale , tutte le age nzie inte nzionalme nte formative s ono chiamate a r idis e gnare il propr io mode llo pe dagogico e ducativo e culturale affinché l’inte grazione s i affe rmi come una fe de razione dotata di molte plici luoghi e ducativi ove ad ognuno s ia r iconos ciuta la propr ia s pe cificità formativa in ordine ai dive rs i fini e ducativi. La s cuola pe rs e gue finalità pr ior itar iame nte cognitive e di s ocializzazione ; la famiglia que lle e tiche e d affe ttive ; gli e nti locali la promozione - organizzazione de lle e s pe r ie nze e s pre s s ivo- cre ative ; l’as s ociazionis mo l’atte nzione alla qualità formativa de lle e s pe r ie nze aggre gative ; e d, infine , il mondo de l lavoro la diffus ione de i valor i s ociali e c ivili di collaborazione , impe gno e s olidar ie tà; me ntre alle chie s e s pe tta la dime ns ione de lla fe de e de lla tras ce nde nza. Que lla qui pre s e ntata è la vis ione di una s cuola capace di s tipulare una re lazione
116 Sul piano strutturale, le agenzie formative extrascolastiche devono assumere la consapevolezza di appartenere al sistema educativo, anche se, chiaramente, questa è una scelta che non deriva solo da loro ma, in primo luogo, da chi detiene la responsabilità di definire le politiche formative nazionali. A livello culturale il problema è quello di individuare il proprio oggetto formativo, precisarne gli strumenti di ricerca, specificarne i linguaggi in nodo da mettere in trasparenza il potenziale significato formativo di ogni singola agenzia. Infine, sul piano funzionale è necessario garantire uno standard minimo, omogeneo, di qualità pedagogica e didattica che consenta il pieno riconoscimento da parte del sistema pubblico di formazione, tutelando, al contempo, i cittadini.
113 113
cos tante e proficua con il te r r itor io. In vir tù di c iò, quali dovre bbe ro e s s e re i mode lli e le pratiche di inte grazione longitudinale (tra i gradi de l s is te ma s colas tico) e tras ve rs ale (tra i dive rs i luoghi de lla formazione )?
Ne l pr imo cas o s i dovre bbe pe rs e guire la via de ll’unitar ie tà e de lla continuità, me ntre , ne l s e condo cas o, s i dovre bbe “r ifondare ” i r is pe ttivi mode lli pe dagogici in modo da s os te ne re l’ur to di un s is te ma informale (cultura diffus a di me rcato) s e mpre più pe rvas ivo e omologante . Una politica unitar ia e d inte grata de l s is te ma formativo s e mbra e s s e re la s ola in grado di moltiplicare e dis s e minare s ul te r r itor io una re te de lle offe r te quale obie ttivo de ll’inte grazione e de ll’inte rconne s s ione tra le age nzie inte nzionalme nte formative .
L’integrazione ne l pens iero sociologico
In te rmini più pre ttame nte s ociologici s i dice inte grazione “..l’a tto o il proce s s o con cui una parte de lla re altà s ociale vie ne re s tituita o de s tinata a que lla re altà s te s s a da cui s i e ra s e parata o a cui te nde pe r e s ige nza di cre s cita o pe r cre atività culturale [ …] ne l pr imo cas o l’inte grazione s i configura come proce s s o organico , ne l s e condo come proce s s o organizzativ o .” (De marchi, Elle na, Catar inus s i, 1987, p 1056). Que llo di inte grazione in s ociologia è un conce tto for te poiché incrocia ve r ticalme nte tutti gli as pe tti s trutturali de lla re altà s ociale dall’individuo all’ambie nte , pas s ando pe r la famiglia , il gruppo, l’organizzazione , e cc.. L’intuizione de lla natura inte grata de lla s ocie tà è già pre s e nte in Comte –e ancor più chiarame nte in Durkhe im – ne l quale il conce tto di inte grazione è vis to in un’acce zione for te . Infatti, e gli as s e r is ce che “ un quals ias i s is te ma s ociale cos tituito da pochi oppure da milioni di uomini, ha come pre cis o obie ttivo que llo di dir ige re ve rs o un fine ge ne rale di a ttività tutte le forze par ticolar i. Giacchè non vi è s ocie tà s e non là ove s i e s e rcita un’azione ge ne rale e combinata” (Ivi, p. 1057). Il conce tto di inte grazione pre s uppone l’e te roge ne ità de lle par ti che s ono in re lazione tra di loro, dunque , s i pre s e nta parzialme nte come s inonimo di inte rdipe nde nza pe rché in un s is te ma inte grato ogni mutame nto re gis trato s u una de lle s ingole par ti compor ta molte plici var iazioni anche s ulle altre , contrar iame nte a quanto avvie ne in un s is te ma non inte grato. T rovare il gius to live llo di inte grazione s i pre s e nta come un’ope razione quanto mai comple s s a. L’impos s ibilità di dir ime re una volta pe r tutte il magma de l s is te ma s ociale individuando le var iabili in gioco, l’ins ufficie nza e la parzialità de lle informazioni di fatto non pe rme ttono di “s tabilire il
114 114
caratte re pre de te rminabile de lle forme in cui l’inte grazione può manife s tars i” (ivi, p. 1057); pe r que s to motivo il piano s ocio- s trutturale e il piano s ocio- culturale r is ultano cos ì s fas ati tra loro da r ichie de re re vis ioni inte grative s u nuove bas i. Ne ll’opinione di Ogburn que s to ritardo culturale s i re gis tra quando un s is te ma non avve r te te mpe s tivame nte le modificaz ioni s trutturali di una s ocie tà attardandos i s u mode lli s e mpre me no e fficaci. T utto que s to contr ibuis ce a chiar ire il caratte re dinamico de ll’inte grazione . L’inte rdipe nde nza tra le par ti non è mai s tagnante né automatica. Le vy jr . me tte in luce anche le ambiguità e le dis funzioni che pos s ono accompagnare un proce s s o di inte grazione de fine ndolo come “pos itivo e cos truttivo proce s s o di adattame nto e ufunzionale ad una s truttura concre ta” che non s i s ottrae a s oluzioni di continuità e a s quilibr i, pe r que s to motivo vi s ono s trutture che pur e s s e ndo inte grative “hanno anche as pe tti non inte grativi, c ioè il loro ope rare dà luogo anche a dis funzioni.” (ibide m, 1958). In alcuni s tudios i l’us o de l te rmine inte grazione r ive la una “conce zione naturalis tico- organica de lla totalità s ociale e de lle s ue inte rne ar ticolazioni, in altr i e s pr ime una dinamica produttiva di s is te mi culturali” (ivi, p. 1058). Con la te or ia s truttural- funzionalis ta di Pars ons , dopo il s uo avviciname nto alla cibe rne tica e alla te or ia de i s is te mi, s i re gis tra uno s pos tame nto r is pe tto all’organicis mo clas s ico ne l s e ns o che vie ne s ottoline ata la ne ce s s ità funzionale de ll’inte grazione , r iconos ce ndo in e s s a una molte plicità di modi e di durata . In un’acce zione me no s tr inge nte , inve ce , l’inte grazione di, o fra , par ti dive rs e dipe nde dal modo in cui s trume nti o valor i di bas e ve ngono condivis i a ll’inte rno de l s is te ma me de s imo pe r fini aggre gativi. Al contrar io, gli s te s s i s trume nti non us ati in modo corre tto pos s ono e s s e re caus a di cr is i e /o dis gre gazione . Sotto il profilo antropologico di matr ice funzionalis ta l’inte grazione è “fatta pr incipalme nte di adattame nto re ciproco e di inte rdipe nde nza funzionale de gli s che mi di compor tame nto” (ivi, p. 1059). Utile , pe r s upe rare la r igidità di que s te vis ioni, c i s e mbra il contr ibuto di Linton che par la di inte grazione come “mutuo adattame nto che s i ve r ifica fra gli e le me nti culturali. Es s a pre s e nta s ia as pe tti dinamici che as pe tti s tatici: con l’e s pre s s ione proce s s o di inte graz ione noi inte ndiamo lo s viluppo progre s s ivo di un adattame nto s e mpre più pe rfe tto fra i var i e le me nti che cos tituis cono la totalità de lla cultura; con l’e s pre s s ione grado di inte graz ione noi inte ndiamo s e mplice me nte l’e s te ns ione de gli adattame nti già ve r ificatis i ad un dato punto de l continuum culturale ” (ivi, 1060). Studiare cr iticame nte l’inte grazione s ignifica conos ce re di volta in volta “l’ide alità che confe r is ce o può confe r ire coe re nza e d amalgama alle div e rs e par ti inte grate o da inte grare . Se da un lato, dunque , è imme diata la cons tatazione de ll’as pe tto funz ionale de l proce s s o – ciò che cons e nte ,
115 115
appunto, l’e s is te nza di un ins ie me s ociale e te roge ne o – dall’altro, non r is ulta altre ttanto s e mplice s pie gare le caus e e le condiz ioni de l proce s s o s te s s o” (ivi). A que s to punto de lla nos tra trattazione , può e s s e re utile ope rare un’analis i de l conce tto di s is te ma117 . Come è noto ne lle s ue ultime ve rs ioni, la te or ia ge ne rale de i s is te mi, ha tratta to anche il conce tto di s is te ma comple s s o che s e mbra applicabile al nuovo modo di conce pire un s is te ma inte grato tra formazione e lavoro. Se condo Morin (1993), infatti, s i può par lare di s is te ma comple s s o quando s i r is contrano: un ‘ampia quantità di inte razioni e di inte r fe re nze tra un nume ro cons ide re vole di unità e d e le me nti; un e le vato grado di ince r te zza al s uo inte rno (cas ualità e inde te rminate zza de gli e ve nti e de lle azioni). Il conce tto di s is te ma comple s s o vie ne tratta to, tuttavia , anche da Luhmann (1990) attrave rs o una nuova le nte conce ttuale , que lla di doppia continge nza: va cons ide rato continge nte ciò che non è né ne ce s s ar io né impos s ibile , c iò che , di cons e gue nza, può e s s e re cos ì come e ffe ttivame nte è (e ra , s arà), ma è pos s ibile anche dive rs ame nte . In altr i te rmini la doppia continge nza e s pr ime l’alto grado di ince r te zza cui ogni s truttura s is te mica è s ottopos ta , nonché la ne ce s s ità di un’azione limitativa e s e le ttiva de lle pos s ibili re lazioni attivabili a ll’inte rno de l me de s imo s is te ma. Applicare tutto que s to dis cors o al nuovo s is te ma inte grato s ignifica, innanzitutto, s tabilire quali e le me nti di que s to s is te ma comple s s o (s cuola, F.P., impre s e , Unive rs ità e cc.) far inte ragire tra loro e vitando, pur ne l r is pe tto de ll’autonomia inte rna ad ogni s ubs is te ma, di dar vita ad e s pe r ie nze non s trutturate e cas uali. In s e condo luogo, ope rare una r ifle s s ione s ulle re lazioni pos s ibili e ide ntificare de lle re gole condivis e pe r il gove rno de ll’ince r te zza. Luhmann ha e laborato, inoltre , anche il conce tto di confine s is te mico . Se condo l’autore , i s is te mi hanno de i confini. Dunque , il confine s is te mico ha una duplice funzione : que lla di s e parare e colle gare fra loro il s is te ma e l’ambie nte . L’autore puntualizza che un confine s e para gli e le me nti ma non ne ce s s ar iame nte le re lazioni. In altr i te rmini, s e para gli e ve nti, ma las cia pas s are gli e ffe tti caus ali. Grazie ai confini i s is te mi pos s ono s imultane ame nte apr irs i e chiude rs i s e parando le inte rdipe nde nze
117 La Teoria generale dei sistemi (General System Theory), fondata da L. Von Bertalanffy già negli anni ’20, comincia ad affermarsi solo attorno alla metà degli anni ’60. Uno dei problemi non ancora risolti nella teoria dei sistemi è la stessa definizione di sistema. Fintanto che ci rifacciamo alla definizione generale fornita da Hall e Fagen, secondo i quali un sistema è un insieme di oggetti e di relazioni tra questi oggetti e tra i loro attributi, si può trovare sufficiente accordo, ma non appena si tenta di precisare la tipologia di relazioni tra gli elementi del sistema medesimo ci si imbatte in una molteplicità di definizioni. Innanzitutto è possibile distinguere tra sistema chiuso e sistema aperto. Nel primo tipo di sistema lo scambio di elementi e di energia con l’ambiente è di limitata portata ed estensione nel tempo. Nel tempo, o di fronte a intrusioni ambientali improvvise e consistenti, i sistemi chiusi come tali vengono distrutti, senza lasciare successori. Al contrario, il sistema aperto si caratterizza per i seguenti elementi: lo scambio periodico di elementi e di energia con l’ambiente; la capacità di far rimanere stabile o di far decrescere la propria entropia. Dunque, “lo stato di equilibrio è unicamente determinato dai parametri del sistema. Secondo Berrien (1968), i sistemi aperti sono quelli che accettano input (stimoli, energia, informazione ecc.) e rispondono ad essi, mentre i sistemi chiusi funzionano esclusivamente al loro interno. Dunque, il sistema aperto è un sistema la cui esistenza e la cui struttura dipendono dal continuo scambio di risorse con l’ambiente.
116 116
inte rne da que lle fra s is te ma e d ambie nte e me tte ndo e ntrambe in re lazione fra loro. Pe r s volge re que s ta funzione di s e parazione -colle game nto i confini pos s ono e s s e re diffe re nziati fino a cos tituire is tituzioni s pe cifiche che as s olvono a que s ta pre cis a funzione attrave rs o pre s tazioni s e le ttive . La s e le ttività di ta li is tituzioni r iduce s ia la comple s s ità e s te rna che la comple s s ità inte rna al s is te ma. L’inte grazione tra s is te ma e ducativo- formativo e s is te ma e conomico può avve nire s oltanto grazie alla cos tituzione di s e rv iz i s pe cializzati di confine che conos cano ade guatame nte i dive rs i s ubs is te mi e s iano capaci di ge s tire i rappor ti con loro, a l fine di individuare proble mi, te nde nze , e proporre s trate gie ade guate pe r farvi fronte . Se condo quanto indicato da Luhmann, ta li s e rvizi di confine de vono ope rare una funzione di s e parazione /colle game nto tra le dive rs e re altà e favor ire il pas s aggio de gli e ffe tti caus ali de s ide rabili dai dive rs i s ub- s is te mi, ope rando, cos ì, un ruolo di filtro e s tabiliz zaz ione . Quindi, re quis ito pr incipale de l proce s s o di cos tituzione di un s is te ma è, oltre alla ide ntificazione de gli e le me nti propr i de l s is te ma me de s imo, la de te rminazione de i confini. I confini s is te mici de limitano s e mpre r is pe tto ad un ambie nte , ma i re quis iti che tale de limitazione de ve s oddis fare var iano a s e conda che il s is te ma s ia obbligato a dis tingue re al propr io inte rno e ve ntuali s ub- s is te mi con i loro re lativi ambie nti, o s e de bba dis porre i propr i confini te ne ndo conto di ta le dis tinzione . I re ce nti inte rve nti di policy analizzati s i muovono, in line a te or ica, ve rs o una migliore de finizione de l s is te ma comple s s o che dovre bbe s e guire ad un proce s s o di inte grazione fra s otto- s is te mi e ducativo- formativo e d e conomico. A nos tro avvis o, la r iforma de i nuovi s e rvizi pe r l’impie go potre bbe r is ponde re alla logica de lle “age nzie di confine s pe cializzate ” s pie gate da Luhmann ve ne ndo a s volge re , da una par te , un impor tante ruolo di filtro e di conne s s ione s ul duplice ve rs ante domanda- offe r ta; e , dall’altra , rappre s e ntando il nodo ce ntrale de l ne tw ork a l quale tutti gli a ttor i, coinvolti ne ll’imple me ntazione de lla r iforma (de ll’appre ndis tato), de vono conve rge re . Ed è que s to uno de i modi pe r s trutturare s e mpre più i de boli le gami che fino ad oggi hanno caratte r izzato que s te re lazioni. Zuccon (1995) che ha s tudiato il conce tto di s is te ma e il conce tto di inte grazione affe rma che il s is te ma formativo inte grato può e s s e re conce pito come un s is te ma ape r to, imme rs o in un ambie nte 118 molto più
118 Gli studi e le ricerche sull’ambiente e sulla sua capacità di influenza sono stati numerosi e significativi nella Sociologia delle organizzazioni e pur senza ripetere una rassegna di questi studi che ci porterebbe fuori tema ci preme ricordare come nel corso degli ultimi trenta anni si sia profondamente modificato il modo di intendere il rapporto organizzazione-ambiente. Fino agli anni ’70, appunto, si identificava con l’ambiente tutto quello che esisteva al di là dei confini dell’organizzazione e con il quale la stessa interagiva prelevando risorse e cedendo i propri output. Dominava, dunque, una visione deterministica secondo la quale le caratteristiche dell’ambiente avevano la forza di incidere sugli assetti strutturale e comportamentali delle organizzazioni. Negli anni successivi si registra un superamento di questa idea volto ad affermare: la capacità di un comportamento strategico e la funzione
117 117
comple s s o quale può e s s e re la s ocie tà e pos to in re lazione con a ltr i s is te mi face nti par te de ll’ambie nte s te s s o. L’autore individua quattro s is te mi: que llo e conomico le gato alla produzione , que llo politico che raccoglie tutte le is tituzioni dotate di autor ità ne l campo de lla is truzione -formazione , que llo culturale dove s i producono s ignificati, s imboli, valor i norme e cc., e , infine , que llo individuale che r iguarda la s fe ra de lle as pirazioni e de i bis ogni de lle pe rs one nonché la loro domanda di is truzione e formazione . Se condo l’autore tutti que s ti s is te mi s ono s is te mi ape r ti in continuo rappor to di s cambio, l’e ne rgia che e s s i s i s cambiano de finis ce i loro rappor ti di informazione , di inte razione , di s cambio e di controllo. Ne cons e gue che il s is te ma che ci troviamo a s tudiare s i pre s e nta come una comple s s ità organizzata: non è s ufficie nte che tra que s ti s ottos is te mi s i s tabilis cano collaborazioni più o me no improvvis ate e cas uali, fondate s e mplice me nte s u accordi e conve nzioni, che danno vita a forme di inte graz ione de bole , è ne ce s s ar io, a l contrar io, giunge re a de lle forme di inte graz ione forte , bas ate s u re gole di s is te ma. In altr i te rmini, pe r garantire un rappor to di s cambio tra le par ti de l s is te ma – s e nza che ne s s uno de i s ub- s is te mi ne s ia pe nalizzato- è ne ce s s ar io individuare de lle re gole di compos iz ione e organizzaz ione e de lle re gole di inte raz ione con l’ambie nte e s te rno119 . Sulla s cor ta di que s te r ifle s s ioni l’autore conclude affe rmando che ne l nos tro pae s e s i può r iconos ce re s olo un s is te ma incomple to, non gove rnato da una le gge quadro ge ne rale , s e nza un organis mo di coordiname nto de lle politiche formative , accus ato di is olame nto ne i confronti de lla s ocie tà civile e de lle is tituzioni. Il s is te ma e ducativo di is truzione e formazione che s i è affe rmato ne l nos tro pae s e a s e guito de lle re ce nti r iforme che ne hanno modificato comple tame nte l’as s e tto120 pre s e nta alcune caratte r is tiche : è duale poiché pre ve de al s uo inte rno un s is te ma di is truzione e d unive rs itar io e d un s is te ma di formazione profe s s ionale ; è ape r to grazie al pr incipio di dis tinzione tra s ogge tto di pianificazione - programmazione e s ogge tto e rogatore ; è pluralis tico poiché pos s ono concorre re a s volge re compiti e rogativi tutti i s ogge tti che pre s e ntino i re quis iti ne ce s s ar i; è continuo poiché introduce un pe rcors o di continuità tra live lli iniziali, inte rme di e
dell’attivazione che porta alla costruzione della realtà con la quale l’organizzazione interagisce. Per un approfondimento si veda: Crozier e Friedberg (1978); Thompson (1994) e Zan (1988). 119 Secondo l’autore, per quanto concerne le regole di composizione si può parlare di sistema formativo integrato solo nel caso in cui ci sia la tendenza a renderlo intero o completo, supplendo a quanto manca o aggiungendo ciò che è utile o necessario; mentre, per quanto concerne le regole di organizzazione si può parlare di sistema formativo integrato solo nel caso in cui esso sia composto da elementi che, pur avendo una funzione autonoma relativamente libera e flessibile, agiscono come un solo elemento, in quanto coordinati da un unico organo di programma. Infine, per quanto attiene alle regole di interazione si può parlare di sistema formativo integrato solo nel caso in cui sia inserito correttamente e proficuamente nella totalità ‘sociale’. 120 Riforma dell’istruzione (elevazione dell’obbligo scolastico, autonomia scolastica, la riforma dei cicli è stata bloccata dal nuovo governo); la riforma della formazione professionale (l. 196/97), la normativa in materia di nuovi servizi per l’impiego; la normativa in materia di decentramento agli enti locali; l’art. 68 della l. 144/99 che introduce l’obbligo di formazione.
118 118
s upe r ior i oltre che pre ve de re una formazione pe r tutto il cors o de lla vita; è inte grato poiché s i s viluppano azioni in forma coope rativa tra i dive rs i s ogge tti de l s is te ma oltre ad azioni di s is te ma che cons e ntono proce s s i inte grativi121 . In conclus ione s i può as s e r ire che il pas s aggio dall’inte grazione de i s is te mi al “s is te ma inte grato” de s igna la cos truzione di un ins ie me organico di r is ors e di appre ndime nto fruibili s e condo pe rcors i fle s s ibili e individualizzati. Par lare di inte grazione oggi s ignifica re alizzare forme s trutturate di inte razione tra i dive rs i a ttor i e s ogge tti coinvolti, s ia pubblici che pr ivati, formali o informali; inte razione te s a a modificare la qualità, le finalità, le tipologie e le s trutture s te s s e de gli inte rve nti formativi (Billi, 2000). La cos truzione di un s is te ma s iffatto s i gioca s u molte plici dime ns ioni: politico, s ociale , e conomico, de l lavoro e formativo. Allo s te s s o te mpo la cos truzione di un s is te ma cos ì de te rminato, da una par te , affonda le s ue radici ne lle impone nti tras formazioni s ociali e d e conomiche de gli ultimi de ce nni; dall’altra , s i pone come pre condizione pe r s os te ne re lo s viluppo futuro.
Oggi quando s i par la di inte grazione di s is te ma s i inte nde “archite ttura s tandard e proce dure atti ne l comple s s o a configurare un ins ie me organico di opzioni di appre ndime nto comune e d inte grato fra is truzione , formazione profe s s ionale e lavoro, componibili dai s ingoli individui in pe rcors i coe re nti pe r conte nuti e modalità di fruizione con i bis ogni di s viluppo propr i e de l s is te ma e conomico.” (ISFOL, 1998/a, p. 67) Ma pe r por tare a re gime un s is te ma cos ì conce pito è ne ce s s ar ia la cos truzione di s tandard e cr ite r i condivis i, os s ia di protocolli comuni ai var i s ub- s is te mi che cons e ntano la me s s a in tras pare nza de lle compe te nze pos s e dute e , di cons e gue nza, la ce r tificazione e il r iconos cime nto de i cre diti individuali, a l fine di garantirne l’e ffe ttiva s pe ndibilità all’inte rno de l s is te ma allargato e s u tutto il te r r itor io comunitar io.
La que s tione de l pas s aggio dall’inte grazione de i s is te mi al “s is te ma inte grato” s i è pos ta all’atte nzione de i policy tak e rs e de gli s tudios i con una s traordinar ia r ile vanza. La cons ape vole zza de lla ne ce s s ità di que s to proce s s o s e mbra e s s e re pe ne trata anche ne l linguaggio de i policy mak e rs i quali, s ia a live llo nazionale che inte rnazionale , par lano ormai di politiche inte grate pe r affrontare , ge s tire e r is olve re proble matiche comple s s e come que lle le gate alle grandi que s tioni occupazionali e formative . Pur s e nza e s s e re in grado di dare una chiara de finizione di politica inte grata , vis ta la
121 Le relazioni fra i diversi sub-sistemi finora si sono sviluppate sulla base di alcune strategie così sintetizzabili: informazione tra i soggetti; comunicazione, conoscenza e confronto; delineazione di intese; scambio e cooperazione; programmazione; misure di accompagnamento. Le modalità attraverso cui si sono organizzate tali interconnessioni, dunque, si possono riassumere nel seguente modo: dispositivi di analisi, certificazione e riconoscimento dei crediti formativi; dispositivi di gestione delle passerelle tra scuola, fp, e lavoro; modelli, reti e sistemi di orientamento; procedure di intesa e cooperazione in tema di pianificazione delle attività in relazione al territorio di riferimento; creazione di reti locali e di centri servizi territoriali (Zuccon , 1998).
119 119
s ua re lativame nte re ce nte compars a ne l dibattito s cie ntifico, pos s iamo dire che s i s tanno affe rmando due dime ns ioni e s s e nziali e as s olutame nte innovative r is pe tto al tradizionale modo di inte nde re l’inte rve nto di policy :
• la dime ns ione inte r is tituzionale con la quale s i cos truis ce l’inte grazione ve r ticale ; • la dime ns ione inte rs e ttor iale pe r la r ice rca de ll’inte grazione or izzontale . In vir tù di ta le cambiame nto s i va de line ando in manie ra s e mpre più marcata tutto un ambito di profili, compe te nze e abilità volte al coordiname nto, a lla cos truzione di re ti, a lla proge ttazione e cc.. La s te s s a affe rmazione di un s is te ma di ce r tificazione , pre s umibilme nte , dipe nde dal grado e dall’ampie zza de ll’inte grazione che s i r ie s ce a cos truire all’inte rno di dive rs i s e ttor i di policy (politiche occupazionali, formative , giovanili, pe r lo s viluppo te r r itor iale ). La cre azione di un ve ro s is te ma di formazione inte grato s i fonda, infatti, s ulla me s s a a punto di un proce s s o di ce r tificazione valido e tras pare nte che s i intre ccia , in una par ticolar is s ima tr iangolazione dinamica, con la que s tione de i cre diti formativi e de lle compe te nze .
L’alternanza scuola- lavoro: una v ia per l’integrazione
Prima di introdurre il proble ma de ll’alte rnanza s cuola- lavoro è oppor tuno s pe cificare che l’inte grazione non r iguarda s oltanto que s to as pe tto ma, al contrar io, dovre bbe inve s tire tutto il s is te ma ai dive rs i live lli come , ad e s e mpio, inte grazione tra i dive rs i tipi di s cuola e con la FP e le impre s e , ma ancor di più con il te r r itor io attrave rs o le re ti e d il par te nar iato.
Ne llo s pe cifico, il conce tto di inte grazione tra s is te ma e ducativo- formativo e s is te ma e conomico, oggi, ha as s unto una connotazione nuova. Ne l pas s ato, l’inte grazione e ra vis ta come una forma di par te nar iato tra s cuola, formazione profe s s ionale e azie nde , appare ndo que s ta come una s trate gia innovativa pe r il migliorame nto de l s is te ma formativo. Si pre ve de vano mome nti di s cambio (s tage ) o altre forme di raccordo, ma il nucle o por tante de lle iniziative re alizzate in cias cun s ottos is te ma re s tava invar iato ne lla s os tanza e ne lle finalità. Attualme nte , s i s ta affe rmando una acce zione de l s ignificato di inte grazione di più ampio re s piro che s i concre tizza in forme di co- proge ttazione e co- ge s tione de gli inte rve nti formativi me s s i in atto in quals ias i de lle tipologie di a lte rnanza s cuola-lavoro pos s ibili (FP- s cuola, appre ndis tato, tirocinio, IFT S). Ora, un
120 120
proce s s o formativo di a lte rnanza s tudio- lavoro122 è ta le s e s i fonda s u un rappor to organico tra i due mome nti formativi, in modo da e vitare ogni r iducibilità de ll’uno all’altro e ogni s ommator ia che finire bbe pe r e s s e re e s trane a e occas ionale . Ciò è pos s ibile s olo ne ll’ottica di pre cis i e comuni obie ttivi didattic i, capaci di de te rminare il campo di s ignificati e ntro cui e ntrambi i mome nti r is ultano e s s e re comple me ntar i. E’ s olo la corre tta inte r re lazione tra i te rmini: s cuola- lavoro, che attr ibuis ce ad e ntrambi un s ignificato s pe cifico e puntuale . Pe rché s i abbia que s ta corre tta inte grazione occorre che l’e s pe r ie nza de ll’alte rnanza s ia s trutturata in bas e a pre cis e finalità pe dagogiche .123
Poiché ne s s una age nzia formativa da s ola è in grado di far fronte alle pre s s anti e dive rs ificate r ichie s te che pe rve ngono da par te de lla s ocie tà comple s s a e de l mondo produttivo l’unica s oluzione plaus ibile è la cre azione di un “s is te ma inte grato” caratte r izzato dalla collaborazione s pe cialis tica di dive rs i s ogge tti.
”Un s is te ma inte gra to de ve ave re la capacità di r is ponde re a bis ogni cara tte r izza ti da un’e s tre ma plas tic ità e di fa rvi fronte combinando ne l modo migliore le r is ors e dis ponibili, e te ne ndo conto de i vincoli: non e s is te un ‘modo migliore ’ va lido s e mpre e in ogni luogo [ pe r ] qualificare le pe rs one , poiché tutti gli e le me nti in gioco s i tr as formano, e il s is te ma formativo de ve pos s e de re capacità di diagnos i, di s inte s i, di innovazione , pe r pote r s upe rare la s e parazione fra mome nto formativo e mome nto applica tivo, a ttuando una s ine rgia in cui s cuola , formazione profe s s ionale e d e s pe r ie nza di lavoro s i combinano in un proge tto formativo inte gra to, a par tir e da una formazione di t ipo s colas tico ne ce s s ar ia ma non s uffic ie nte , a
122 Si dovrebbe definire alternanza ogni situazione lavorativa che permetta al lavoratore di dedicare almeno il 20% del proprio tempo di lavoro ad un’attività di formazione in un istituzione specializzata e, inversamente, ad ogni programma di formazione che lasci spazio all’esperienza acquisita sul posto di lavoro, fino alla concorrenza del 20% del tempo totale. 123 Tali finalità implicano l’individuazione di obiettivi formativi centrati sullo studente. L’individuazione di tali obiettivi è il primo e indispensabile passo dell’intera azione progettuale Per la progettazione di un percorso formativo in alternanza può essere utile tenere presente alcuni fattori essenziali a garantire la riuscita dell’esperienza. Per quanto concerne i fini dell’alternanza si possono distinguere: obiettivi formativi generali, che possono essere di orientamento, socializzazione al lavoro, verifica dell’apprendimento, rimotivazione allo studio, conoscenza dell’organizzazione del lavoro, pratica professionale; oppure obiettivi disciplinari; obiettivi pluridisciplinari; obiettivi particolari. Per quanto riguarda la contestuazzazione dell’alternanza bisogna considerare: fasi e tempi, collocazione didattica, destinatari, modalità di prestazione lavorativa. Infine, per quanto attiene alla tipologia dell’alternanza possiamo distinguere diversi stili che pur essendo dotati di indubbio valore didattico non possono essere ricondotti nella pratica dell’alternanza, così come si è cercato di esplicitarla, perché uno dei due elementi essenziali (studio o lavoro) risulta presente nell’esperienza solo in forma ridotta o mediata. Tali esperienze sono riconducibili a: visite guidate, stage osservativi, lavoro simulato, lavoro in conto terzi, tutte circostanze in cui l’esperienza di lavoro si realizza solo in termini di osservazione o constatazione esterna. Là dove, invece, si verifica una simulazione in ambiente protetto, o un’esperienza mediata dalla struttura scolastica, possiamo parlare di alternanza vera e propria perchè l’esperienza ci consente di “stabilire rapporti più articolati e complessi tra ‘studio’ e ‘lavoro’ [grazie a] soluzioni che comportano un inserimento lavorativo nelle strutture aziendali del soggetto fruitore del percorso di alternanza.” In altri termini si tratta di percorsi integrati che prevedono momenti teorici e momenti lavorativi intercalati tra questi distinguiamo l’apprendistato e il tirocinio che può essere estivo o invernale. Secondo Bocca e Palombo, invece, gli obiettivi dell’alternanza sono principalmente sei: orientamento,verifica delle attitudini e degli interessi, facilitazione della transizione scuola-lavoro, riscontro delle nozioni apprese, conoscenza dei meccanismi di funzionamento delle imprese, aggiornamento della formazione di base, sperimentazione dei profili professionali emergenti. Per un approfondimento della progettazione di percorsi di alternanza “scuola- lavoro” si consulti Brigida, Degli Esposti e Lombardo (1992) oppure Di Nubila, Fabbri e Margotta (1999).
121 121
qualunque live llo, pe r acquis ire una qualificazione compiuta . [ …] Le s tra te gie di appre ndime nto in a lte rnanza non favor is cono s olo l’e s e cuzione de i compiti, ma anche la capacità di tr adur re nuove conos ce nze in compor tame nti ade guati: da l punto di vis ta s ogge ttivo, il lavora tore e ntra in pos s e s s o di un ins ie me codifica to di abilità e conos ce nze de finito compe te nza e s pe r ta , in cui la formazione inizia le ha s ubito ne l concre to de lle s ituazioni di lavoro una s e r ie di tr as formazioni, s u cui influis ce la modalità di organizzazione de l lavoro s te s s o. La qualità de lle pre s tazioni de r iva da lla capacità di combinare le r is ors e cognitive e le e s pe r ie nze in proce s s i di azione ade guati. [ …] un live llo di s colar izzazione di bas e più e s te s o o più e le vato non r is olve da s olo il proble ma, da l mome nto che le r is ors e cognitive acquis ite ne lla s cuola non hanno que s to cara tte re s inte tico, come non lo ha la pra tica da s ola , pe rché non cons e nte di pre nde re de c is ioni s tra te giche comple s s ive , ma s olo di cos truire s oluzioni volta pe r volta .” (Ribolzi, 1998, p. 68- 69).
Ne lla cos truzione di un proge tto di inte grazione bis ogna te ne re pre s e nti due dis tinzioni: la pr ima è tra de ntro e fuor i, c ioè ne lla s cuola o s ul pos to di lavoro. Anche s e l’impre s a ‘compra’ dalla s cuola, oltre alla formazione di bas e , qualche tipo di qualificazione , divie ne s e mpre più chiaro che l’acquis izione de gli s kills avvie ne fondame ntalme nte de ntro l’impre s a, in s pe cial modo pe r le compe te nze pe r cui la via più logica di cons e guime nto è il le arning by doing . La s e conda dis tinzione è fra ge ne rale e s pe cifico: la qualificazione ge ne rale accre s ce la produttività marginale de i qualificati e s attame nte ne lla s te s s a mis ura ne lle impre s e formatr ici e ne lle altre impre s e , me ntre la qualificazione s pe cifica conduce s oltanto all’acquis izione de lle compe te nze s pe ndibili a ll’inte rno de ll’impre s a me de s ima e non tras fe r ibili a ltrove : que s to prote gge , tuttavia , le impre s e formatr ici dal poaching (fur to di mano d’ope ra qualificata) che s pe s s o agis ce come fre no all’inve s time nto in formazione . Il s is te ma formativo police ntr ico- inte grato è caratte r izzato da una dis continuità inte rna alle e s pe r ie nze formative e lavorative , poiché s i s viluppa ne ll’alte rnanza tra pe r iodi di formazione e pe r iodi di lavoro. Nondime no, è pos s ibile trovare una nuova continuità cos truita dal s ogge tto e dalle age nzie pre pos te . Due s e mbrano e s s e re i pre s uppos ti pe r la re alizzazione di un s iffatto s is te ma inte grato: in pr imo luogo, la caduta de i r igidi s te ccati tra i dive rs i ambiti di e s pe r ie nza lavorativa o formativa e la re ciproca pe rme abilità tra le var ie modalità di acquis izione di conos ce nze e compe te nze ; in s e conda is tanza, il r iconos cime nto di una par i dignità e ducativa de i pe rcors i e ducativi e s te rni a lla s cuola. Que llo che s i profila è un s is te ma di formazione continua r ivolto a tutta la popolazione , a pre s cinde re da e tà, pos izione ne l me rcato de l lavoro e ruolo profe s s ionale r icope r to.
Alla bas e di que s to mutame nto c’è un cambiame nto di paradigma che por ta ad abbandonare la vis ione clas s ica s e condo la quale “compito de llo Stato è di occupars i de ll’e ducazione e de lla formazione iniziale de i c ittadini e de i
122 122
s e gme nti di popolazione più s vantaggiati e compito de lle impre s e è di formare i propr i adde tti a i propr i obie ttivi produttivi” (Bulgare lli, 1998, p. 100). Il nuovo obie ttivo, dunque , è la cos truzione di una polifonia formativa, di una re te di oppor tunità formative che fondi il propr io s ucce s s o s ulla ce r tificazione di qualità e s ulle dinamiche de llo s viluppo de l me rcato a me dio te rmine .
Da quanto e me rge , il dibattito non è as s olutame nte cos a re ce nte . Già a cavallo de gli anni ’60 e ’70 in autor i come Ce s are o, Barbagli e d altr i, è pos s ibile ravvis are il chiaro e proble matico r ife r ime nto allo s collame nto tra is tituzioni e ducative e me rcato de l lavoro. Ne l cors o di que s ti anni s i è pre s o progre s s ivame nte cos cie nza de ll’e s aur irs i de l mode llo s cuolace ntr ico e de ll’affe rmars i di un nuovo mode llo bas ato s u una pluralità di age nzie formative che r idime ns ionano e r icollocano il ruolo e le funzioni de ll’is tituzione s colas tica e , s oprattutto, ne r ide finis cono i compiti in ordine all’acquis izione di e le me nti di profe s s ionalizzazione . Ma propr io lo s trutturars i di una re altà formativa police ntr ica, a ll’inte rno de lla quale s i s viluppano pe rcors i diffe re nziati di is truzione e formazione , s pe s s o intre cciati con e s pe r ie nze di lavoro, r ichie de , a l conte mpo .che s iano s tabiliti ne s s i di inte rdipe nde nza tra i var i ambiti formativi e non e che s iano me s s e a punto s ine rgie pe r de finire le re ciproche as pe ttative , e s oprattutto compiti e re s pons abilità” (Be s ozzi, 1998, p. 18).
Un s is te ma formativo police ntr ico e diffe re nziano non può non e s s e re quindi, conte mporane ame nte , un s is te ma inte grato. Pe rché i s is te mi formativi s i r innovino r is ponde ndo alle s fide de lla nuova s ocie tà de lla conos ce nza è ne ce s s ar io te ne re conto di tre dive rs i e le me nti tra loro comple me ntar i.
Rappor to s cuola- impre s a: la s cuola e l’impre s a s ono e ntrambi luoghi di acquis izione di conos ce nze tra loro comple me ntar i, il rafforzame nto de lle inte rconne s s ioni tra que s ti due dive rs i ambiti di vita può e s s e re vantaggios o pe r e ntrambi. Pe rché tale avviciname nto avve nga è ne ce s s ar io che le par ti s ociali vi s iano pie name nte coinvolte e che la s cuola te nga conto di fattor i quali la compre ns ione de l mondo de l lavoro, la conos ce nza de lle impre s e e la pe rce zione de i cambiame nti che influe nzano le attività produttive . La formazione , pe rò, non può e s s e re conce pita s oltanto come un me zzo pe r fornire manodope ra qualificata alle impre s e , le quali hanno una loro par te di re s pons abilità ne ll’agire formativo. Il rafforzame nto di ta li inte rconne s s ioni r ichie de lo s viluppo di s trume nti idone i quali l’appre ndis tato (CC. EE., 1997) adatto a tutti i live lli di qualificazione . Re lazione tra: s truzione , formazione - lavoro e cultura te cnologica: il te ma de ll’is truzione a dis tanza è molto s e ntito dall’Unione Europe a che inte nde favor ire la diffus ione di que s to s trume nto, pe rché la Socie tà de lla conos ce nza pe r e s s e re ta le de ve e s s e re pr ima di tutto “la s ocie tà de ll’appre ndime nto pe rmane nte ”. L’appre ndime nto durante tutto l’arco
123 123
de lla vita è e s s e nziale pe r favor ire la par te cipazione attiva de i c ittadini, pe r combatte re la dis occupazione , pe r rafforzare la compe titività, pe r favor ire l’innovazione e cc.. La s ocie tà de ll’informazione cons e nte di mutare profondame nte le re lazioni tra lavorator i e dator i di lavoro come te s timonia il s e mpre più diffus o r icors o al te le lavoro. Lavorare ne lla s ocie tà de ll’informazione : il lavoro di oggi r ichie de manodope ra fle s s ibile , adattabile e polivale nte . L’occupazione è me no s tabile che in pas s ato e chie de r iadattame nti continui. Un nume ro cre s ce nte di pe rs one lavora in ambiti le gati a ll’informazione , a lle conos ce nze e fa us o di s trume nti e s e rvizi tipici de lla s ocie tà de ll’informazione . In pros pe ttiva que s to può favor ire l’abbattime nto di vincoli le gati a lla dis abilità, a l te mpo e d allo s pazio.
Un s is te ma cos ì configurato non è facile da re alizzars i dall’oggi al domani anche s e cons ide r iamo che la via intrapre s a, pre s umibilme nte , è oggi giunta ad un punto di non r itorno. Sicurame nte bis ogna fare ancora molto, tanto a live llo comunitar io, quanto a live llo nazionale , s ia s ul piano normativo che s u que llo ope rativo pe r cos truire un e ffe ttivo e d e fficace s is te ma inte grato di formazione - lavoro che pos s a dare garanzia di omoge ne ità e d e le vati s tandard di compe te nza in ogni angolo de lla Comunità e urope a. Bis ogna cons ide rare che “ci s ono logiche e re gole inte rne al me rcato de l lavoro e al s is te ma di is truzione che r is pondono a s copi s pe cifici di c ias cuna re altà, che , pe r que s to, pos s ono r is ultare re ciprocame nte e s trane e : il me rcato de l lavoro fa r ife r ime nto a proce s s i produttivi e a obie ttivi di ottimizzazione de lle r is ors e mate r iali e umane , me ntre il s is te ma is truzione , dal canto s uo, e labora la domanda di formazione non s olo come or ie ntame nto all’acquis izione di un be ne inte s o come inve s time nto, pe r l’acquis izione di re ddito, r icche zza o pre s tigio [ …] be ns ì anche come valore in s é , capitale culturale e s ociale ‘immate r iale ’ che re alizza capacità di e s e rcizio de i dir itti di c ittadinanza” (Be s ozzi, 1998, p. 16).
Nonos tante l’ampio dibattito s viluppatos i anche in Ita lia a par tire dagli anni ’80, e nonos tante le note voli conve rge nze di que s ti anni s ulla que s tione de l police ntr is mo formativo e de ll’alte rnanza, non e s is te ancora un dis e gno organico di utilizzazione de l lavoro e de lla cultura che in e s s o s i e s pr ime ai fini formativi. De l re s to, bis ogna te ne r conto che : “non tutte le azie nde s ono conte s ti formativi; non tutti i pos ti di lavoro s ono ‘pos ti di e s pe r ie nza’; non tutti i lavorator i s ono tutor ; non tutte le e s pe r ie nze di a lte rnanza hanno s ucce s s o: è ne ce s s ar ia un’accurata pre parazione de gli s tude nti, de i doce nti e de i tutor azie ndali, s e condo un mode llo di e s pe r ie nza formativa programmato, te or icame nte fondato e s ogge tto a valutazione e monitoraggio. [ …] ciò che contraddis tingue il valore formativo di un pos to di lavoro è l’alte rnanza di compiti di vale nza dive rs a,
124 124
la qualità di contatti s ociali e di forme di lavoro in coope razione , la pos s ibilità di de cis ioni autonome , la guida di ope rator i compe te nti. Le impre s e dovranno, quindi, in coope razione con le tradizionali age nzie formative (s cuole e unive rs ità) formare i propr i formator i azie ndali, i propr i coordinator i, tutor , animator i di a lte rnanza, dire ttor i di formazioni, capaci di inte ragire e collaborare con i doce nti de lle s cuole s ui s ingoli proge tti di s tage ” (Chiar i, 1996, p. 107). Que s ta è la s fida più grande lanciata al mondo impre nditor iale e pos t- indus tr iale ancora troppo le gato alla logica de lla produzione e all’impianto ge rarchico. E’ ne ce s s ar io che s i faccia uno s forzo pe r s pos tare il bar ice ntro ge s tionale de l mondo impre nditor iale s ulle r is ors e umane e s ulla cultura de lla par te cipazione e de lla collaborazione .
I div e rs i m ode lli de ll’alte rnanza s cuola- lav oro Es is te un comple s s o s is te ma di inte razioni fra formazione e lavoro dove l’as pe tto me todologico e que llo pe dagogico ve ngono a collocars i lungo un continuum i cui e s tre mi corr is pondono a due s ituazioni is tituzionali pre cis e che pos s ono e s s e re de finite , s e condo Char te r (in Bocca, 1984, p. 53), r is pe ttivame nte : ”fals a alte rnanza” e “alte rnanza copulativa”. La pr ima corr is ponde ad “una re ale s ituazione di contraffazione poiché in e s s a, di fatto, l’ins e gnante non tie ne conto de lle e s pe r ie nze e ffe ttuate dagli a llie vi in ambito e xtra- s colas tico, in quanto le cons ide ra come s cars ame nte incide nti a ll’inte rno di una dime ns ione didattica di tipo normativo e tras mis s ivo [ ...] [ me ntre , la s e conda, è caratte r izzata da] un’atte nzione pe dagogica par ticolare onde attivare s trume nti pe r as s icurare continuità formativa attrave rs o la dime ns ione de lla dis continuità di e s pe r ie nze ”. Moure t (ivi, p. 52- 53), r iface ndos i agli s tudi, compiuti te mpo addie tro, da Girod De L’Ain, individua - pur s e nza s tabilire tra loro un ordine di pre fe re nza - tre mode lli che pos s ono inte rve nire in un s is te ma di a lte rnanza s cuola- lavoro:
- il mode llo pe dagogico “pe r il quale appare r ile vante s ia l’os s e rvazione dire tta de lla re altà profe s s ionale che il s ucce de rs i di te or ia e pratica in uno s tre tto le game di ar r icchime nto fra ce ntro formativo e ambito di lavoro. [ …] s i pr ivile gia quindi l’impos tazione pe r proble mi attrave rs o l’analis i induttiva de lla re altà concre ta al fine di r icavarne le conos ce nze , capacità e cc. Il r is chio potre bbe qui cons is te re ne l las ciars i pre nde re troppo la mano da forme s pe cialis tiche , radicate s e mpre più ne lla s pe cificità de i s ingoli luoghi di lavoro a de tr ime nto de lla formazione ge ne rale e te or ica;”
- il mode llo s ocio- pe dagogico, che “punta inve ce s ugli as pe tti motivazionali, ne i confronti de lla formazione profe s s ionale e de l lavoro, de r ivanti dal trovars i in s ituazioni concre te . In que s to mode llo l’e nfas i s i
125 125
s pos ta s ulla cre s cita ps icologica de i giovani onde favor ire un pre coce pas s aggio ad una dime ns ione di vita adulta caratte r izzata da re s pons abilizzazione , inte grazione ne l lavoro, autocontrollo, autonomia pe rs onale e cc. Il r is chio conne s s o a que s to mode llo cons is te ne lla acr itica acce ttazione de lla re altà e conomica e produttiva le cui implicite s ce lte ide ologiche potre bbe ro e s s e re s pos ate dai giovani s e nza s ufficie nte r ifle s s ione ”;
- il mode llo s ocio- e conomico pe r il quale l’alte rnanza cos tituis ce “una forma e fficace di rappor to fra formazione e d occupazione s ul piano de ll’ins e r ime nto profe s s ionale [ …] Ciò non nas conde la pos s ibile fuga ve rs o forme di ipe r- s pe cializzazione che finire bbe ro di nuovo pe r s acr ificare le e s ige nza di polivale nza profe s s ionale e di formazione ge ne rale de lla pe rs ona.”
Schwar tz (1993), inve ce , s i s offe rma s ulle dive rs e s ituazioni che pos s ono ve r ificars i ne lla cos truzione di e s pe r ie nze di a lte rnanza. A s uo avvis o, “ad un e s tre mo vi è il pre dominio de lla logica tras mis s iva in una s cuola chius a s u di s é [ …] . All’oppos to s i pone inve ce l’ins e r ime nto totale de gli s tude nti ne lla re altà produttiva, in una logica totalme nte ‘di produzione ’ e pr iva di inte razioni con altre logiche diffe re nti”; que s to comporta il r is chio de ll’indis ciplinar ità, in altr i te rmini “una forma di c ircolazione s e lvaggia di conos ce nze attrave rs o l’attività produttiva [ …] . I due live lli inte rme di s ono s tabiliti a ttrave rs o il confronto de lla logica s colas tica tras mis s iva con que lla azie ndale , di tipo produttivo: ne e me rge l’ipote s i di ingre s s o ne lla s cuola di te cnici azie ndali, oppure la par te cipazione di ins e gnanti a lle e s pe r ie nze de gli s tude nti in re altà produttive (que s te ipote s i paiono più or ie ntabili a ll’inte rno de ll’alte rnanza ‘as s ociativa’, a par tire dalla ‘quas i a lte rnanza’, fino a giunge re as s ai vicino all’alte rnanza ‘re ale ’ attrave rs o la cre azione di pos ti di lavoro ‘prote tti’ in cui il lavoro non s i r iduca a me ra s imulazione di mans ioni produttive e , ne l conte mpo, non s ia troppo faticos o, pur de te rminando l’acquis izione di conos ce nze te or iche e d ope rative ). Se condo Paul Sante lman (1991, p. 107- 110) è pos s ibile dis tingue re , inve ce , tre dive rs e conce zioni di a lte rnanza più o me no comple me ntar i:
“- la s ituation de trav ail v ie nt illus tre r l’appre ntis s age théorique (tras mis s ion du s av oir profe s s ionne l); - la s ituation de trav ail s e rt à s tructure r l’appre ndis s age thèorique ; - la s ituation de trav ail pe rme t la prodution de s outils de tras mis s ion du s av oir thèorique ». Que s te tre dive rs e opzioni s tabilis cono diffe re nti tipi di re lazione fra gli a ttor i de ll’alte rnanza: giovane , e nte di formazione e impre s a. E’ de ntro que s ta re lazione che l’innovazione può e ve ntualme nte pre nde re forma s e s i
126 126
bas a s u ve re compe te nze pe dagogiche e me todi e fficaci. Uno s che ma innovativo da s olo non è s ufficie nte a produrre de i r is ultati qualita tivame nte s upe r ior i r is pe tto ai me todi clas s ici. Un e nte di formazione “e s t tout à fait capable de conce v oir ‘par écrit’ de l cons tructions pédagogique s ambitie us e s , il ne pos s éde ra pas obligatoire me nt le s formate urs capable s d’as s ure r la réalis ation de s obje ctifs décrits ». Dunque , s i avranno tre dive rs i modi di condurre l’alte rnanza: alte rnance s éparée , alte rnance intégrée e alte rnance cogérée . Ne l pr imo cas o s i tra tta “d’un dév e loppe me nt du mode d’appre ndis s age clas s ique (formation iniz iale ) qui cons is te à s urdéte rmine r l’utilis ation du ‘cas pratique ’ comme moy e n de conçétis ation de l l’e ns e igne me nt. Le formate ur re s te le décide ur de s obje ctifs de la formation e t le maitre …. de la cons truction de l’e ns e igne me nt théorico- pratique .» Ne l s e condo cas o il formatore analizza la s ituazione de l lavoro pe r organizzare le modalità de l s uo ins e gname nto. Dunque , l’impre s a “…intègre la logique théorique qui découle de l’e mploi e n cos titution e t le formate ur contribue à la formalis ation pédagogique du proce s s us ». Infine , ne ll’ultimo cas o s i ve r ifica una s or ta di “cogéré par le s tagiaire e t le formate ur” che implica un’organizzazione de ll’ins e gname nto inte grato e pre ve de una progre s s ione armonios a tra la conos ce nza pratica de l me s tie re ins e gnato e la s trutturazione cognitiva de lla conos ce nza. Que s to tipo di s ituazione implica una “cohés ion s tructure lle ” tra e nte di formazione e impre s a. Pe r Mar ine lla Giovine (1994, pp. 68- 79), inve ce , una ulte r iore clas s ificazione può e s s e re fatta te ne ndo conto de l tipo di ins e r ime nto pre vis to ne l pe rcors o s colas tico, pe r l’attività pratica. In que s to cas o s i avre bbe ro due tipologie fondame ntali, e molto dive rs e tra loro, di a lte rnanza: “l’alte rnanza inte s a come s e que nza formativa in azie nda ins e r ita ne ll’ambito di un pe rcors o di tipo s colas tico e d a cui i s ogge tti par te cipano mante ne ndo la propr ia condizione di s tude nti; l’a lte rnanza ‘s otto contratto di lavoro’ finalizzata al cons e guime nto di una qualificazione attrave rs o l’e s pe r ie nza lavorativa in azie nda, inte grata , in ge ne re , da moduli più o me no cons is te nti di formazione te or ica.” Ne lla maggior par te de i pae s i e s is tono e ntrambe le tipologie di a lte rnanza ma ne gli ultimi anni s i è as s is tito allo s viluppars i de lle s e que nze formative in azie nda piuttos to che al pote nziame nto de lle var ie forme contrattuali de finibili ‘a caus a mis ta’124 . Ne gli anni ’90, l’impuls o de lla Comunità –s os te nuto da un movime nto ge ne rale di ide e a favore de l s is te ma duale te de s co e dal te ntativo in var i pae s i di imitar lo – ha mirato a pote nziare l’is tituto de ll’appre ndis tato, il quale rappre s e nta il mode llo di formazione on the job più diffus o e affonda
121Per contratti a causa mista si intendono quelli che prevedono l’obbligo della formazione cone il CFL e l’apprendistato.
127 127
le s ue or igini ne lle botte ghe ar tigiane . T ale s forzo trova or igine ne l te ntativo di favor ire un maggior coordiname nto fra adde s trame nto in impre s a e formazione volta alla cre s cita pe rs onale de i giovani.
Pe r quanto r iguarda le e s pe r ie nze di a lte rnanza che caratte r izzano la Comunità Europe a s i pos s ono individuare a lcuni e le me nti comuni: le game s tre tto fra pratica di a lte rnanza e formazione profe s s ionale a live llo s e condar io e s upe r iore me ntre gli a ltr i ordini di s cuola, là dove hanno maturato un inte re s s e s pe cifico ve rs o que s ta modalità, lo hanno fatto attrave rs o inte rve nti s poradici e non is tituzionalizzati; s tre tto le game , s e bbe ne non e s cus ivo, tra alte rnanza e appre ndis tato (Comunicazione de lla Commis s ione al Cons iglio de lle Comunità, 1979).
Nonos tante la pre s e nza di que s ta conve rge nza è pos s ibile de line are una note vole dive rs ità di ipote s i di a lte rnanza fra i var i Pae s i a s e conda de l ruolo formativo attr ibuito alle impre s e e al tipo di inte rve nto re alizzato in que s to campo da par te de llo Stato. T ale dive rs ità, s imilme nte a quanto rappre s e ntato dalla Giovine , s i e s pr ime attrave rs o un continuum che ve de ai due e s tre mi i s e gue nti mode lli: pre vale nte inte rve nto azie ndale , ove lo Stato as s ume una funzione di vigilanza e tute la de lla s us s is te nza di un proge tto formativo da par te de i luoghi di lavoro [ appre ndis tato] ; pre vale nte inte rve nto s tatale , me ntre agli ambie nti e conomico- produttivi è las ciata una minore re s pons abilità dire tta in campo formativo s e que nze formative in alte rnanza. In ge ne re , ne i Pae s i comunitar i gli indir izzi s colas tic i di tipo profe s s ionale s ono inte rvallati da s e que nze formative in alte rnanza più o me no lunghe all’inte rno de lle impre s e , a l fine di acquis ire conos ce nze inte grative de lla formazione te or ica. Si pos s ono, tuttavia , re gis trare de lle diffe re nze , a ll’inte rno de i dive rs i pae s i in te rmini di obie ttivi. In s inte s i, le finalità pr incipali che s i inte nde pe rs e guire con que s ta modalità s ono le s e gue nti: re nde re le compe te nze de gli a llie vi cons one alle e s ige nze de l s is te ma produttivo; facilitare l’or ie ntame nto profe s s ionale ; re nde re le me todologie formative più dinamiche e coinvolge nti; conte ne re la s pe s a de lle s trutture s colas tiche ”, non s olo pe r ovviare alla care nza di attre zzature ma anche pe r favor ire una contrazione de lle voci di s pe s a ivi compre s a que lla pe r i doce nti; me tte re in contatto i giovani con le impre s e in modo da facilitare i loro s ucce s s ivi s bocchi occupazionali.
Anche il c ita to Rappor to De lors (punto 7.2) s i e s pr ime pos itivame nte r iguardo al s is te ma de ll’alte rnanza s cuola- lavoro aus picando una s or ta di s trate gia comunitar ia fondata s ul pr incipio de l dual s y s te m: • “la trans izione dal s is te ma e ducativo al lavoro dovre bbe e s s e re age volata grazie ad una formaz ione più pratica e a ll’appre ndis tato, nonché
128 128
garante ndo un live llo minimo più alto pr ima de ll’abbandono de i s is te mi e ducativi s te s s i;
• l’ins e gname nto potre bbe e s s e re razionalizzato pre ve de ndo formazioni a caratte re ge ne rale me no lunghe e ve ne ndo più incontro alle ne ce s s ità de l me rcato, c ioè promove ndo la formazione profe s s ionale come alte rnativa all’Unive rs ità;
• dovre bbe e s s e re garantito un più e fficace coordiname nto fra le azioni de lle var ie amminis trazioni e de i var i organi ave nti re s pons abilità in mate r ia di formazione e di me rcato de l lavoro.”
Al fine di favor ire la mobilità s ul me rcato e urope o de ll’occupazione e l’affe rmars i di qualifiche e s tandard r iconos ciuti a ll’inte rno de ll’Unione , la Came ra di Coble nza ha avviato un “programma di qualificazioni ad ane llo” che cons e nte agli appre ndis ti di s volge re alcuni mome nti de lla loro s pe cializzazione in azie nda pre s s o par tne r s tranie r i e cons e guire , cos ì, diplomi ge ne ralme nte r iconos ciuti. (Wilbe r t, 1994).
T ra gli as pe tti pos itivi a ttr ibuiti a l’is tituto de ll’alte rnanza è de gno di nota que llo re lativo alla r imotivazione allo s tudio. Come s os tie ne infatti Be s ozzi (1998), “l’appre ndime nto in s ituazione di lavoro è par ticolarme nte utile pe r i giovani che hanno s offe r to uno s cacco s colas tico: l’ins e r ime nto lavorativo è r imotivante pe rché cons e nte di colle gare le nozioni s colas tiche al loro utilizzo pratico, compor ta un s alar io, che è gratificante , e s i bas a s u modalità dive rs e di tras mis s ione de l s ape re , che alcuni ps icologi chiamano ‘l’e ffe tto frate llo maggiore ’”
Non mancano, tuttavia , anche de lle pe rple s s ità. Par ticolarme nte inte re s s ante è la s inte s i de l Libro ve rde s ulla politica s ociale e urope a (1994, p. 10) dove s i può le gge re : “il s is te ma tr ila te rale de llo Stato, de l s indacato e de lle azie nde , be nché s os te nuto dai gove rni e dalle par ti s ociali di que i pae s i ove e s s o è corre ttame nte praticato, è r ite nuto da altr i, tra ttandos i di un mode llo s tudiato pre cipuame nte pe r un conte s to indus tr iale me no valido pe r il futuro, quando è probabile che la cre azione di nuovi pos ti di lavoro s i ve r ifichi piuttos to ne l s e ttore de i s e rvizi, s ogge tti ad un’e voluzione rapida e cos tante , e in nuovi s e ttor i, come que llo de lle e ne rgie alte rnative .”
E’ probabile che s i pos s ano aggiunge re anche altr i ambiti di s viluppo quali que llo de lle te cnologie informatiche e te le matiche dove s i lavora pre vale nte me nte pe r proge tti, o que llo de i lavor i inte lle ttuali che , grazie alle nuove te cnologie , pos s ono e s s e re s volti in propr io attrave rs o nuove le modalità di lavoro fle s s ibile (collaborazioni profe s s ionali, collaborazioni d’ope ra, e cc.). Se s i cons ide ra che tali r ifle s s ioni s ono argome nto di
129 129
dibattito ne gli s te s s i pae s i dove l’appre ndis tato ha fatto s tor ia (s i pe ns i a lla Ge rmania) è inquie tante pe ns are che tutti gli s forzi vadano ve rs o un mode llo che pe r alcuni ve rs i appare s upe rato dato il progre s s ivo inde bolime nto de l s e ttore indus tr iale e , in par ticolar modo, de lla manifattura, a l quale fa s e guito un de clino molto e vide nte de ll’occupazione indus tr iale , le gato, in par ticolare , a ll’inve s time nto in te cnologie avanzate (T ronti, 2001).
La formazione per apprendis ti
Come già s ottoline ato le s fide pos te dal mondo de lla produzione alle s oglie de l te rzo mille nnio mutano lo s ce nar io ne l quale la formazione profe s s ionale è chiamata ad ope rare . In que s to modificato conte s to, le azioni formative de vono ne ce s s ar iame nte as s icurare il raggiungime nto di s tandard di qualità, ta li da garantire una r is pos ta e fficace ai bis ogni profe s s ionali e s pre s s i dal me rcato de l lavoro s e nza tras curare que lle che s ono le as pirazioni de i lavorator i.
La r ile vanza anche quantitativa che gli inve s time nti in formazione vanno as s ume ndo in tutti gli ambiti di a ttività, fa s ì che vi s ia una cre s ce nte atte nzione ne i confronti de ll’e laborazione di s trate gie proge ttuali me todologicame nte fondate , nonché de lla valutazione e de l monitoraggio de i dis pos itivi di azione formativa or iginati dalle me de s ime s trate gie . La qualità de l proce s s o formativo, in que s ta pros pe ttiva, vie ne conce pito come il r is ultato de lla me s s a in ope ra de gli as pe tti qualita tivi ins iti ne gli e le me nti che compongono il s e rvizio s te s s o. Pe r produrre qualità ne lla formazione 125 , s e condo que s ta acce zione , è ne ce s s ar io che s i r is pe tti un pr incipio di qualità ne lle s e gue nti compone nti de l proce s s o formativo: ne lle compone nti hard de lla formazione (te cnologia formativa in s e ns o ampio); ne ll’organizzazione ; ne l s is te ma di e rogazione ; ne l modo in cui s i cos truis ce e s i ge s tis ce il mome nto re lazionale . In ge ne rale , tutti gli s tudi nazionali par lano di un cambiame nto da par te de lle impre s e ne i confronti de lla formazione profe s s ionale , s ia di que lla
125 In questa ottica realizzare interventi di qualità significa: porre il cliente al centro delle attenzioni; caratterizzare in termini di competenze la qualità del servizio erogato; gestire e presidiare la qualità dell’intero processo di formazione; riconoscere che l’acquisizione e la messa in opera delle competenze sono il risultato di una co-produzione, che mette in relazione contesti e attori; realizzare modalità strutturate di misurazione (Montedoro, 2000). La ricerca della qualità richiede, dunque, un approccio multidimensionale ed una vigilanza costante della coerenza di un insieme di azioni. Infatti, l’atto pedagogico non può essere concepito come un atto isolato. La qualità della formazione professionale è il risultato di una serie concatenata di iniziative che vanno dall’analisi dei fabbisogni formativi, allo sviluppo dei curricola e dell’organizzazione della formazione fino alla valutazione dei risultati (Pavan 1998).
130 130
pe rmane nte , s ia di que lla iniziale . Es s a as s ume un ruolo s trate gico ai fini de lla re alizzazione de gli obie ttivi e conomici de ll’impre s a e , di cons e gue nza, non vie ne più offe r ta o acquis ita come una pre s tazione s ubordinata , be ns ì inclus a ne lla pianificazione de ll’impre s a s te s s a. Ma anche alla luce di que s te r ifle s s ioni r is ulta diffic ile de finire in manie ra univoca il conce tto di qualità applicata alla formazione . Es s a dipe nde da dive rs i fattor i quali la natura s te s s a de i prodotti o de i s e rvizi, il conte s to in cui e s s i ve ngono forniti, le as pe ttative di ute nti o fruitor i: è , in pratica, un conce tto re lativo e plur idime ns ionale . La r ice rca de lla qualità ne lla formazione 126 de ve condurre ad una cre s ce nte e fficacia e ad una razionalizzazione de ll’ins ie me de i proce s s i s te s s i di formazione e ciò r iguarda, s oprattutto, l’a tto pe dagogico de ll’ins e gname nto e de ll’appre ndime nto propr iame nte de tto. In que s to conte s to, r ice rcare , s tudiare e valutare la qualità pe dagogica de lla formazione s ignifica cons ide rare l’ins ie me de lle condizioni (cr ite r i, modalità, vis ioni, s trate gie , r is ors e , proce s s i) utili pe r favor ire uno s viluppo de ll’appre ndime nto de l s ogge tto, cons ide rato come protagonis ta de l propr io pe rcors o formativo e come de te ntore de l dir itto all’acce s s o alle compe te nze ne ce s s ar ie pe r as s ume re ruoli profe s s ionali e di c ittadinanza ne lla s ocie tà e ne l mondo de l lavoro. L’ottica de lla qualità ne i s is te mi formativi in rappor to al proce s s o di ins e gname nto- appre ndime nto, pone a fondame nto la capacità di ge s tire ne l modo me no s ogge ttivo pos s ibile e più pos s ibile ogge ttivo i var i proce s s i di un s is te ma formativo. “Da un lato, occorre lavorare al fine di r idurre il più pos s ibile l’inte r fe re nza che la s ogge ttività introduce ne llo s viluppo di a lcuni fe nome ni e , dall’altro, s ull’individuazione di indicator i che cons e ntono di introdurre cr ite r i di mis urabilità de i fe nome ni s te s s i” (Ce ntro ELIS, 1990, p. 94). E’ comunque fondame ntale s ottoline are che le pe rce zioni de ll’ute nte circa la qualità di un s e rvizio, e , quindi, anche de lla formazione , de r ivano s e mpre
126 Come sottolineano alcuni osservatori, con il passaggio delle organizzazioni, dei settori e delle attività da una fase all’altra della qualità, le concezioni e le caratteristiche della qualità tendono a cambiare. Possono dunque essere essere messe a confronto alcune opinioni di tipo tradizionale sul concetto di qualità, da altre attualmente ricorrenti: opinioni tradizionali sulla qualità: la qualità è un concetto assoluto, in un prodotto o in un servizio predomina una certa caratteristica della qualità, la qualità è definita dal consumatore, l’attenzione è concentrata sulla qualità del prodotto, la qualità è garantita tramite il controllo finale della produzione, gli standard e le norme riguardanti la qualità sono stabili, esiste un apposito reparto o servizio per la qualità; opinioni correnti sulla qualità: la qualità è un concetto relativo, molti fattori contribuiscono alla percezione della qualità, il punto di partenza per la definizione della qualità sono le necessità degli utenti, i servizi forniti insieme al prodotto diventano un fattore essenziale per la qualità, l’intero processo di sviluppo viene sottoposto a monitoraggio e ad un miglioramento sistematico, i requisiti della qualità tendono ad aumentare, ognuno contribuisce alla qualità. Nel corso dell’ultimo secolo, nell’industria, l’approccio predominante alla qualità è passato attraverso cinque fasi distinte, e precisamente: “padronanza del mestiere: la qualità dipende unicamente dalle capacità dell’individuo, il quale fornisce i suoi prodotti direttamente al cliente; controllo: poiché le aziende e le richieste diventano sempre più complesse, la preoccupazione prevalente in fatto di qualità diventa l’individuazione della non qualità tramite i controlli; assicurazione di qualità: l’attenzione si sposta verso il controllo dei processi e la prevenzione; miglioramento costante della qualità e Total quality Management: la qualità diventa un approccio gestionale volto ad un costante miglioramento; innovazione: l’organizzazione ha acquisito capacità innovative.” Queste tendenze sono, in larga misura, applicabili anche ai settori dei servizi, compresa la formazione (la quale è essenzialmente un’attività di servizi) che è ancora prevalentemente nella fase del controllo e si sta spostando verso l’assicurazione di qualità (Pavan Woolfe, 1998).
131 131
da un cos tante confronto tra le s ue as pe ttative e l’e s pe r ie nza e ffe ttiva127 . Par te ndo da que s to pre s uppos to e me rge l’impor tanza di r ice rcare e de finire non tanto, e non s olo, la qualità de lla e ne lla formazione , quanto la qualità pe dagogica128 de ll’offe r ta formativa me de s ima. L’innalzame nto comple s s ivo de l live llo di qualità può e s s e re otte nuto attrave rs o la valor izzazione de lla dime ns ione pe dagogico- didattica de i s e rvizi formativi. La qualità pe dagogica può e s s e re de finita come il prodotto de ll’azione formativa finalizzata a produrre uno s viluppo de ll’appre ndime nto in un conte s to di ins e gname nto inte nzionalme nte pre dis pos to che abbia come s uo pre s uppos to la ce ntralità de ll’individuo. L’individuo, in que s to s e ns o, vie ne conce pito come s ogge tto attivo al quale va r iconos ciuto il dir itto di acce s s o alle compe te nze come condizione di c ittadinanza, oltre che re quis ito cardine pe r l’acce s s o al lavoro. La qualità pe dagogica, dunque , vie ne inte s a come r ice rca de lla s pe cificità de l valore aggiunto de lla qualità applicata alla formazione e vis ta come inte razione , re lazione , tras formazione , s viluppo di compe te nze , a tte ggiame nti, conos ce nze de i c lie nti finali. Il fondame nto ge ne rale che s i colloca alla bas e de ll’atte nzione al dibattito s ulla qualità ne ll’is truzione e ne lla formazione è la cons e gue nza logica de llo s viluppo e de l cambiame nto de i s is te mi di is truzione e formazione che , a s ua volta , de r iva dalle nuove as pe ttative de lla s ocie tà. Oggi, raccoglie re la s fida de lla qualità è una pre me s s a impre s cindibile pe r pas s are alla s ucce s s iva fas e de ll’innovazione de l s is te ma e ducativo che
127 Le questioni che emergono rispetto la qualità della formazione, intesa come servizio, rispecchiano i tradizionali quesiti della pedagogia della formazione professionale e pretendono una risposta adeguata per ciascuna delle seguenti domande: Il contenuto della formazione è adeguato agli obiettivi? Il metodo didattico è adeguato agli obiettivi e ai partecipanti? Il luogo di apprendimento o la combinazione di luoghi di apprendimento sono adeguati? Il metodo seguito dagli insegnanti corrisponde agli obiettivi? L’impiego dei supporti di apprendimento non personalizzati è adeguato agli obiettivi e risponde alle esigenze dei partecipanti? 128 La qualità pedagogica può essere definita come il prodotto dell’azione formativa finalizzata a produrre uno sviluppo dell’apprendimento in un contesto di insegnamento intenzionalmente predisposto che abbia come suo presupposto la centralità dell’individuo, inteso come soggetto attivo a cui riconoscere il diritto dell’accesso alle competenze come condizione di cittadinanza, oltre che requisito cardine per l’accesso al lavoro. Le motivazioni che spingono verso la crescente richiesta di qualità sia nell’istruzione che nella formazione professionale sono molteplici, tra le più importanti si può ricordare: l’ampia scelta e gli alti livelli di qualità dei prodotti e dei servizi attualmente disponibili nei paesi industrializzati fanno aumentare le aspettative degli individui e rendono maggiormente critici circa le prestazioni di cattiva qualità in qualsiasi campo, compreso quello dell’istruzione e della formazione; la vasta disponibilità di confronto nella società fa aumentare il desiderio di cambiamento, flessibilità e personalizzazione delle scelte. Nel campo dell’istruzione e della formazione questa tendenza si manifesta attraverso le sempre più diversificate e sofisticate richieste di qualificazione; analogamente alla maggior parte di altri servizi pubblici, gli istituti pubblici di istruzione e di formazione sono sempre più sollecitati a diventare pubblicamente responsabili per quello che fanno e a dimostrare la capacità di erogare un servizio di qualità; nel contesto relativamente stabile del passato, la qualità di istruzione e di nformazione poteva dipendere quasi esclusivamente dalle capacità personali di insegnanti e formatori. In un contesto in rapida evoluzione, invece, caratterizzato dalla richiesta esterna di performance più complesse, dalla crescente differenziazione dei prodotti formativi e da un maggior coinvolgimento del cliente, queste sole capacità non bastano più a garantire la qualità dell’offerta formativa; la maggiore varietà e complessità dei servizi di istruzione e di formazione esige dei meccanismi atti a garantire una migliore trasparenza nella qualità offerta medesima; infine, dobbiamo riconoscere sia che il feedback tra qualità della formazione e sistema economico ha subito una significativa dilatazione temporale; sia che la qualità e l’innovazione dei sistemi d’istruzione e formazione possono svilupparsi meglio in presenza di un’economia fiorente. Come si evince, mentre alcuni di tali fattori sono endogeni alle strutture formative stesse, la maggior parte di essi sono esogeni. Ciò significa che i sistemi di istruzione e formazione sono sempre più interconnessi con il resto della società e sono, quindi, soggetti a pressioni e tendenze complesse. Per loro stessa natura, tali fattori richiedono una gestione migliore e più strategica da parte dei fornitori di istruzione e formazione; essi richiedono, cioè, l’impegno, l’entusiasmo e la collaborazione di tutti i componenti dell’organizzazione: in altre parole, un approccio di gestione della qualità totale.
132 132
de ve fondars i, pre vale nte me nte , s ulla qualità e s ulla capacità innovativa de i fornitor i di is truzione e formazione . La qualità de lle attività formative - s ia ne lla formazione iniziale che in que lla continua- dipe nde non s olo dalle as pe ttative de l me rcato de l lavoro ma anche da que lle de gli ute nti: ge nitor i/a lunni e dipe nde nti. E’ pos s ibile as s e r ire che la produzione di qualità de l s e rvizio in un quals ias i ce ntro di formazione profe s s ionale , dipe nde da tre macro- var iabili: le r is ors e umane , le te cnologie , l’organizzazione . T ralas ciando tutto il dibattito s ulla qualità ne lla formazione - che in que s to cas o ci por te re bbe fuor i te ma - s i può as s e r ire che i conce tti r ite nuti capaci di r ile vare la pre s e nza di una qualità de lle azioni applicabili a i proge tti di formazione s ono: l’or ie ntame nto de i proce s s i; la corre tta me s s a a fuoco de ll’ute nte ; l’as s icurazione di qualità de i proce s s i inte rni; la ve r ifica cos tante de llo s viluppo de lla qualità de lle azioni (ISFOL, 1999/a).
Ne lle e s pe r ie nze di a lte rnanza la valutazione vie ne e ffe ttuata attrave rs o un tipo par ticolare di pratica che è l’appre ndime nto. Valutare gli appre ndime nti s ignifica ve r ificare quali r is ultati, in te rmini di mutame nto, ha prodotto ne i s ogge tti un inte rve nto formativo. L’analis i valutativa de ll’appre ndime nto e , più in ge ne rale , de lla formazione , vie ne a de line ars i come inve s time nto non mate r iale de lle impre s e . Una proble matica s tre ttame nte conne s s a alla valutazione de lla formazione in impre s a è ins ita ne l s uo non pote r pre s cinde re da cons ide razioni r iguardanti anche le motivazioni e la dis ponibilità de gli individui inte re s s ati dal proce s s o formativo. La formazione , s e condo que s ta logica, cos tituis ce , un co-inve s time nto che implica s imultane ame nte le pe rs one che s i formano e que lle che de te rminano la me s s a in pratica de lle loro capacità. La valutazione di tipo e conomico de lla formazione par te da un as s unto: che s i de s ide r i non tanto ‘s pe nde re ’ quanto ‘inve s tire ’.
La tutors hip com e garanz ia di qualità Gli s trume nti utilizzati pe r l’alte rnanza, quali l’appre ndis tato e i tirocini, non cos tituis cono di pe r s é de gli s trume nti di appre ndime nto. L’ins e r ime nto in azie nda dive nta un’occas ione pr ivile giata pe r la ve r ifica e lo s viluppo de lle compe te nze appre s e in aula e pe r l’acquis izione di nuove compe te nze s olo s e l’age nzia formativa che organizza cors i di formazione pe r appre ndis ti o s tagis ti pre dis pone le condizioni affinché l’incontro tra dis ce nte e azie nda os pitante s ia non s olo pos itivo ma anche proficuo. Pe r tras formare la pe rmane nza in azie nda in una re lazione formativa, s i dovre bbe re alizzare
133 133
un pe rcors o ar ticolato in dis tinte unità: pre parazione de ll’appre ndis ta/ tirocinante ; pe rmane nza in azie nda; as s is te nza e monitoraggio all’azione formativa; r ie ntr i in formazione ; valutazione finale . Gli a ttor i che , in un mode llo ide ale , contr ibuis cono a de te rminare il s ucce s s o de l proge tto formativo s ono molte plici e hanno compiti e ruoli diffe re nti: s ono pre s e nti i re s pons abili de l cors o, i coordinator i e i tutor .
In par ticolare , è l’azione de l tutor azie ndale 129 (pos izione di colle game nto) che r ive s te un ruolo de te rminante all’inte rno di un proge tto di a lte rnanza. La s ce lta e la nomina de l tutor azie ndale hanno un’impor tanza fondame ntale , dal mome nto che il s uo ruolo è cruciale pe r la qualità de ll’e s pe r ie nza che il giovane potrà re alizzare . La de s ignazione di ta le figura non dovre bbe cons is te re in un me ro ade mpime nto burocratico, pe rché è lui che dovre bbe accoglie re il giovane e s os te ne r lo ne ll’inte ro pe rcors o di appre ndime nto s ul luogo di lavoro. Il pr incipale compito de l tutor130 è que llo formativo, in bas e al quale dovre bbe s volge re “funzioni is truttive , e ducative , dis ciplinar i od organizzative pe r incar ico o de le ga di colui che ne ha il mandato re s pons abile ” (Di Nubilia , Fabbr i e Margiotta , 1999).
Il ruolo de l tutor, dunque , s i gius tifica come re s pons abile di un s is te ma di azioni e mine nte me nte prote s e ad as s icurare : approfondime nto e pe rs onalizzazione de gli appre ndime nti; incre me nto de ll’e fficacia didattica e formativa de i cors i; progre s s iva e s plicitazione de gli obie ttivi re ali pe rs e guibili ne lla dime ns ione di s tudio, di re lazione e di or ie ntame nto.
129 Le caratteristiche che qualificano un buon tutor aziendale possono essere così riassunte: possesso di una significativa esperienza professionale, buone capacità comunicative e relazionali, capacità di tradurre in compiti gradualmente più complessi gli obiettivi del progetto tenendo conto delle caratteristiche dei discenti; capacità di affiancare all’acquisizione delle competenze tecniche la crescita graduale dell’autonomia; disponibilità a seguire stabilmente e fino alla fine il giovane aiutandolo a superare le difficoltà e valorizzandone i successi. Nel Repertorio delle Professioni pubblicato dall’Isfol, il tutor viene definito come una figura professionale che deve essere in grado di sottrarre ad una prospettiva esclusivamente formale i diversi momenti formativi, associando ad essi una valenza pedagogica fondamentale. In tale prospettiva, la preparazione del tutor deve essere, nello stesso tempo, ampia e specialistica, nell’ambito formativo nel quale svolge la sua funzione. Le sue competenze riguardano i processi di apprendimento, di valutazione, di gestione e di dinamiche di gruppo. Un qualsiasi progetto di formazione si deve organizzare allo scopo di assicurare il più alto indice possibile di personalizzazione delle offerte culturali e formative fruite; requisito essenziale per assicurare efficacia alle azioni formative è la predisposizione di un sistema di supporto che non sottovaluti il fattore umano. 130 Il termine tutor ha origini antichissime e racchiude in sé significati e funzioni molteplici. Nell’accezione dominante il termine si ispira alla lingua inglese ma è di origine latina. Deriva, infatti, dal verbo “tueri” che significa proteggere, difendere, custodire ed era il termine giuridico normalmente usato per indicare la cura, l’attenzione prestate a individui deboli fisicamente e socialmente. E’ tuttavia con l’avvento della Rivoluzione industriale che il termine si apre a realtà molteplici e non più semplicemente codificabili come mero completamento dell’istruzione di tipo formale. E’ poi nel corso degli anni 80 che si sviluppa intorno al termine tutor un’area semantica specifica: si inizia a porre l’accento sulle funzioni, i fini e le modalità correlate piuttosto che sulla singola persona deputata ad esercitarlo per competenze proprie della professione. Il tutore della formazione assume l’esistenza di una figura professionale autonoma per il tutoraggio con la caratteristica di essere “persona diversa dall’insegnante titolare, incaricata di seguire lo sviluppo della formazione dei giovani”. Il profilo del tutor perde, così, le connotazioni originarie e si trasforma in una figura indispensabile e strategica per l’effettiva realizzazione degli scopi formativi di qualsiasi programma educativo; in generale, la funzione di tutoraggio acquista carattere di necessità e di appartenenza alla natura stessa di qualsiasi rapporto educativo e formativo al punto da giustificare l’esistenza di un ruolo professionale autonomo e specifico. Questo brevissimo excursus del termine tutor non è solo testimonianza dell’estensione del suo uso e della crescente complessità del suo ruolo, ma sta a sottolineare anche l’importanza di un nuovo paradigma pedagogico che pone al suo centro il soggetto in apprendimento e tutte le problematiche a lui inerenti.
134 134
Il ruolo de l tutor, tuttavia , racchiude in s é una par ticolare comple s s ità in quanto r ichie de non s olo conos ce nze mirate e d approfondite ma anche compe te nze e d abilità che de vono e s s e re propr ie de lla pe rs ona che r icopre ta le funzione (conos ce nze e compe te nze multidis ciplinar i, dis ponibilità a fars i car ico di re s pons abilità burocratiche e pe rs onali ne l rappor to con il giovane , ape r tura al dialogo e alla ne goziazione tra i var i s ogge tti che animano la formazione profe s s ionale ). Pe r quanto l’Is fol dia indicazioni di quale s ia il pe rcors o formativo pe r dive ntare tutor mancano ancora ad oggi, tuttavia , de finizioni univoche de i re quis iti r ichie s ti in ingre s s o pe r que s ta figura profe s s ionale . Ne lla re altà chiunque può s volge re ta le profe s s ione , anche s e non pos s ie de i re quis iti r ichie s ti, normalme nte la s ce lta di ta le figura vie ne fatta in bas e a cr ite r i pe rs onali o di dis ponibilità. Es s e re tutor, in molte s ituazioni, non corr is ponde a una profe s s ione s pe cifica, ma s olame nte ad una mans ione s volta da una pe rs ona r ite nuta idone a. Pe r quanto r iguarda l’appre ndis tato, pos s ono r icopr ire que s to ruolo didattico- organizzativo s ia un lavoratore s ce lto dall’azie nda, s ia lo s te s s o titolare , s oprattutto, s e s i tratta di un’organizzazione di mode s te dime ns ioni. Pe r tutti que s ti motivi, dunque , s are bbe più coe re nte de finire la tutors hip come una funzione s volta da un individuo e non da una figura profe s s ionale s pe cifica, poiché chi s i dichiara tale , ne lla maggior par te de i cas i, non ha alcuna compe te nza dis tintintiva: non s i ha quas i mai la garanzia che coloro i quali s ono chiamati tutor, pos s ie dano le conos ce nze ne ce s s ar ie pe r e s s e r lo131 . Que s ta proble maticità va colle gata , in par te , a lla confus ione te rminologica, ma non s olo, che inve s te l’ambito de lla formazione profe s s ionale e i s ogge tti che ne s ono protagonis ti. Il nuovo mode llo formativo de ll’appre ndis tato trova un e le me nto di profonda innovazione e di s is te maticità ne ll’introduzione de lla figura de l tutor azie ndale . T ale figura profe s s ionale , in pae s i come Francia , Danimarca, Ge rmania e Aus tr ia , dove e s is te una lunga e s pe r ie nza s ull’appre ndis tato, è uno de i cardini de l s is te ma formativo attuale . Il s uo ruolo r ive s te un’impor tanza cre s ce nte ne ll’ambito de lle nuove pras s i formative cos idde tte duali, che abbinano la formazione all’attività lavorativa ve ra e propr ia , a l fine di otte ne re qualifiche il più pos s ibile r is ponde nti a lle e s ige nze de l me rcato de l lavoro. La funzione tutor iale in
131 Il primario ruolo del tutor è quello di favorire l’inserimento del giovane nell’ambiente di lavoro e di garantire lo svolgimento del programma di formazione concordato con il C.F.P. Egli facilita il passaggio “dal banco d’aula al banco di fabbrica”. E’ auspicabile che si rechi nel Centro prima che inizia lo stage, per conoscere gli allievi e farsi conoscere; deve concordare con i docenti d’aula le modalità delle griglie di osservazione e la relazione finale sui processi di apprendimento e sui livelli di soddisfazione, motivazione ed interesse degli stagisti. Egli possiede, inoltre capacità organizzative, di gestione e di comunicazione, in particolare con riferimento alle relazioni interpersonali; conosce la metodologia di gestione didattica e del lavoro e possiede conoscenze specifiche legate al corso e all’attività dell’azienda; le sue funzioni possono così essere sinteticamente riassunte: orientare, assistere i processi di assimilazione e di personalizzazione dell’apprendimento, rimuovere eventuali ostacoli che possono pesare sul processo di apprendimento, presidiare il contratto formativo, alimentare e monitorare la tensione formatrice del programma d’azione. (Di Nubila, 1999, p. 134).
135 135
ambito organizzativo cos tituis ce l’inte r faccia con l’azie nda pe r favor ire iniziative di formazione continua e d as s icurare valore formativo al lavoro.
La nuova dis ciplina de ll’is tituto de ll’appre ndis tato cos tituis ce il pr imo e s e mpio in cui la figura de l tutor vie ne e s plicitame nte pre vis ta e in qualche mis ura normata. In que s t’ambito la funzione di tutore è is tituita “al f ine di as s icurare il ne ce s s ario raccordo tra l’appre ndime nto s ul lav oro e la formaz ione e s te rna”. 132 Al fine di cre are un re ale colle game nto tra que s ti due mome nti, l’ar t. 16 de lla le gge 196/97 is tituis ce la figura de l tutor azie ndale , os s ia di un lavoratore de ll’impre s a che ha il compito di curare il colle game nto tra pe rcors o formativo in azie nda e que llo e xtra- azie ndale . Ne l de cre to 22/2000, r iguardante il tutore azie ndale pe r l’appre ndis tato, s ono de finiti il ruolo, le funzioni e le compe te nze . L’ar t. 4 de l s udde tto De cre to re cita che : “i s ogge tti che os pitano i tirocinanti indicano il re s pons abile azie ndale all’ins e r ime nto de i tirocinanti, cui fare r ife r ime nto”. Si de finis ce , cos ì, la figura de l tutor azie ndale , come un re s pons abile de ll’ins e r ime nto all’inte rno de ll’azie nda, individuata pr ima che l’appre ndis ta ar r ivi in azie nda, che ha rappor ti con il tutor re s pons abile didattico-organizzativo de ll’is tituto s colas tico e /o de l ce ntro di formazione profe s s ionale con il quale è s tata s tipulata la conve nzione , il cui nome de ve appar ire ne l proge tto formativo (Cacciani, 2000). Il tutor azie ndale de ve pors i ne i confronti de ll’appre ndis ta come punto di raccordo tra lavoro e formazione , punto di r ife r ime nto pr ivile giato a cui l’alunno potrà r ivolge rs i pe r tutta la durata de ll’attività formativa. L’allie vo, in que s to modo, è guidato e d accompagnato lungo tutto il proce s s o di inte grazione ne lla s truttura azie ndale dal tutor pre s e nte in azie nda che r ive s te un ruolo ins os tituibile ne l rappor to tra formator i e formandi, conos ce ndo in modo approfondito le proble matiche conne s s e alle attività lavorative e le e s ige nze de l propr io s e ttore di lavoro. Gli s trume nti che pos s ie de il tutor azie ndale s ono cos tituiti dalle compe te nze , s ia di tipo comunicativo che re lazionale , che e gli de ve pos s e de re pe r accoglie re , guidare e d aiutare il giovane ne l de licato pe rcors o di a lte rnanza e d ins e r ime nto lavorativo. Il tutor azie ndale , inoltre , è in continua inte razione con tutti gli a ttor i coinvolti in un quals ias i proge tto formativo e d è propr io pe r que s to motivo che de ve accre s ce re e pote nziare la propr ia capacità di lavorare in gruppo e di manife s tare una le ade rs hip non s olo fle s s ibile ma anche s timolante e propos itiva. Egli s i pre s e nta come una figura di me diazione , come inte rpre te me tafor ico tra le compe te nze che l’alunno ha acquis ito ne l cors o de lla formazione ve ra e propr ia e le compe te nze ne ce s s ar ie pe r s volge re una data attività lavorativa. Il rappor to che s i vie ne ad ins taurare tra il tutor azie ndale e l’alunno è di fondame ntale impor tanza e de licate zza; e s s o s i configura come una re lazione di tipo par te cipativo: il tutor non s i porrà mai
132 Decreto del Ministero del Lavoro dell’8 Aprile 1998 applicativo dell’art.4 legge 24 giugno 1997 n° 196
136 136
frontalme nte , ma a fianco de ll’appre ndis ta , pronto ad inte rve nire con modalità dive rs e a s e conda de lle circos tanze , qualora s i r is contr ino ince r te zze o r itardi ne ll’appre ndime nto. Pe r re nde re il tutor una figura valida, capace di ins taurare con il tirocinante un rappor to proficuo, a ll’inte rno de ll’azie nda, s i dovre bbe s viluppare un rappor to e un clima di s uppor to all’appre ndime nto, dove il conce tto di appre ndime nto continuo vie ne cons ide rato un valore e un obie ttivo condivis o. Al contrar io, s e que s to non avvie ne , il ruolo de l tutor non avre bbe più s e ns o. Il mondo de ll’azie nda, infatti, pe r s ua natura, non è un luogo pe ns ato e proge ttato pe r e s pe r ie nze di tipo e ducativo, pe r que s to motivo, la figura de l tutor azie ndale può e s s e re par ticolarme nte e fficace ne l me diare tra le e s ige nze produttive de ll’azie nda e le ne ce s s ità di cre s cita e di maturazione de ll’allie vo. Que s ta figura profe s s ionale può aiutare il giovane a: affrontare i proble mi re lazionali, ovve ro le incompre ns ioni con i colle ghi, le incompatibilità di caratte re ; s upe rare la paura di s bagliare e di fronte ggiare s ituazioni nuove e s conos ciute ; tras fe r ire in un conte s to ope rativo le conos ce nze che ha acquis ito ne l cors o de lla formazione te or ica. Il tutor de ve ave r pre s e nte che ne ll’attività di appre ndime nto l’allie vo è coinvolto globalme nte , poiché i proce s s i cognitivi, affe ttivi, e motivi e re lazionali s ono tra loro s tre ttame nte colle gati. Se condo quanto e me rge , dunque , è e vide nte che le funzioni che s pe ttano al tutor azie ndale s ono molte plici e comple s s e e d inte rve ngono in ogni fas e de l proce s s o formativo.
Ce rtificaz ione de lle com pe te nze e qualità de lla ce rtificaz ione Come s i è os s e rvato, ne i provve dime nti le gis lativi e ne i pr incipali accordi s ocio–is tituzionali de gli ultimi anni, s ono s tati propos ti impor tanti cambiame nti pe r il s is te ma di is truzione e formazione de l nos tro pae s e . T ali innovazioni r iguardano, oltre al te ma de ll’inte grazione tra s is te mi, la ce rtif icaz ione de lle compe te nze 133 e d il r iconos cime nto de i cre diti formativ i134 .
133 La certificazione rappresenta la formalizzazione di una valutazione, con tale termine ci si riferisce ad un atto, i cui effetti hanno un valore ufficiale, espresso da un’autorità, volto a garantire le acquisizioni maturate da un soggetto al termine di uno specifico percorso e/o esperienza. I principali problemi legati alla certificazione sono relativi a: modalità di accertamento (prove da sostenere); elaborazione degli standard e dei modelli di riferimento di professionalità da accertare; individuazione dei soggetti abilitati ad operare la certificazione. In altri termini, certificare un credito significa che un soggetto, a ciò abilitato, riconosce “ufficialmente” il possesso di una competenza, spendibile per il proseguimento di un percorso formativo. Per certificazione si intende la valutazione di un oggetto, sulla base di un determinato standard, la quale produce un attestato pubblico di conformità con la norma. Solitamente la certificazione è di competenza di un organismo autorizzato che è indipendente dall’ oggetto ed in generale anche dagli utenti dell’oggetto. Nel campo dell’istruzione e della formazione esistono quattro categorie principali di oggetti che potrebbero essere certificati: l’erogatore della formazione o l’istituto scolastico; il formatore, il docente, il tutore; il programma dei corsi; le competenze acquisite dal corsista/studente. Ma è necessario sottolineare che un sistema soddisfacente di certificazione funziona soltanto se sono disponibili standard di formazione chiari ed obiettivi di apprendimento ben definiti. Un certificato possiede un certo valore soltanto se fornisce una chiara indicazione delle competenze ottenute mediante la formazione e, in particolare, della capacità di svolgere determinati compiti. La certificazione comporta un processo formale di esame dell’apprendista e, nel ciclo di vita di un qualsiasi
137 137
L’accordo pe r il lavoro, s ottos cr itto da gove rno e par ti s ociali ne l s e tte mbre de l 1996, ha individuat, fra i s uoi punti nodali, la de finizione di un s is te ma di ce r tificazione quale s trume nto idone o a confe r ire unitar ie tà e vis ibilità a i pe rcors i formativi di ogni pe rs ona lungo tutto l’arco de lla vita nonché a promuove re il r iconos cime nto de i cre diti formativi comunque maturati e d a docume ntare le compe te nze e ffe ttivame nte acquis ite . T ale accordo diffe re nzia i pe rcors i formativi pos t- obbligo e i pe rcors i formativi pos t- diploma (l’appre ndis tato è r iconducibile a e ntrambi i s e gme nti) e s ottoline a la ne ce s s ità, pe r quanto r iguarda l’appre ndis tato, de lla ce r tificazione de lle attività formative ai fini de ll’utilizzo de i cre diti formativi a ll’inte rno de ll’inte ro s is te ma. La valor izzazione de i pe rcors i profe s s ionali e formativi individuali e , quindi, la pos s ibilità di capitalizzare i r is ultati, anche parziali che , via via , i s ogge tti acquis is cono ne l cors o de lla loro e s pe r ie nza implica, dal punto di vis ta me todologico, che i dive rs i s ub-s is te mi formativi e l’e s pe r ie nza di lavoro, s iano ar ticolati in s e gme nti (unità) s ingolarme nte ce r tificabili e re ciprocame nte r iconos cibili.
Ne l 1997 e ne l 1998 la le gge 196/97 (ar ticoli 16- 17- 18), e d i r is pe ttivi de cre ti applicativi, hanno s viluppato ulte r iorme nte i conte nuti de l “Accordo pe r il lavoro” pe r ciò che attie ne alle mis ure a s os te gno de ll’occupazione e , s ignificativame nte , a lla formazione profe s s ionale . Il de cre to attuativo de ll’8 apr ile 1998 re lativo all’ar ticolo 16 de lla s udde tta le gge , r ichiama l’e s ige nza di promuove re attività di formazione modulare e di valor izzare le acquis izioni maturate che , purché de bitame nte ce r tificate , pos s ono ave re valore di cre dito ne ll’ambito de l s is te ma formativo, cons e nte ndo, in via di pr incipio, il r ie ntro ne l s is te ma s colas tico-profe s s ionale 135 . Il De cre to Minis te r iale de l 20 maggio 1999 n.179, inoltre , individua i conte nuti de lla formazione pe r gli appre ndis ti (punti a) e b) de ll’ar ticolo 2 de cre to 8 apr ile 1998 , de fine ndo gli obie ttivi pe r i pe rcors i di appre ndis tato. Sudde tti obie ttivi, cos tituis cono un punto di par te nza
intervento formativo, questo processo di valutazione si colloca con maggior enfasi alla fine dell’intervento stesso. Per effettuare tali valutazioni, si applicano gli stessi principi in uso nel sistema scolastico, quali: pertinenza (rispetto agli obiettivi della formazione); copertura sufficiente, allo scopo di garantire che il corsista abbia la padronanza di tutti i settori fondamentali; affidabilità e coerenza del processo di valutazione; riservatezza. 134 Il credito formativo è un valore attribuito ad un segmento di formazione (modulo, unità capitalizzabile, corso di studi, annualità accademica, ecc.) o ad un’esperienza personale ( di studio, lavoro, tirocinio o volontariato, individuale o collettiva, formale o informale) capitalizzabile e spendibile in uno o più sistemi e percorsi, in vista del conseguimento di attestati, diplomi, certificazioni, oppure in vista di rientri in formazione o nella scuola, come competenza individualmente già acquisita. Possiamo distinguere tra: “crediti interni” ad uno specifico percorso formativo come, ad esempio, quello universitario; “crediti esterni” esigibili nel passaggio da un sub-sistema all’altro; “ crediti relativi” spendibili all’interno di alcuni circoli virtuosi derivanti da accordi di sistema, accordi interistituzionali ecc.; “crediti nazionali” validi su tutto il territorio nazionale e in qualsiasi sistema. Possiamo specificare, inoltre, che il contenuto del credito varia a seconda che si provenga dal circuito formativo o da quello lavorativo. 135 L’articolo 5 di tale decreto definisce una duplice responsabilità nelle funzioni di certificazione: la responsabilità della Regione, garante della certificazione dei risultati acquisiti nel percorso formativo (“La Regione regolamenta le modalità di certificazione dei risultati dell’attività formativa svolta, secondo quanto previsto dall’art.17, della legge 24 giugno 1997, n.196.”); la responsabilità del datore di lavoro, garante della attestazione delle competenze acquisite sul lavoro. (“Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all’ impiego. Copia dell’ attestato consegnato al lavoratore”).
138 138
fondame ntale ai fini de lla de finizione di cr ite r i e modalità di ce r tificazione s ia pe r l’e s plicita de finizione de i conte nuti e compe te nze de i pe rcors i, s ia pe r l’individuazione di cr ite r i ge ne rali a cui la ce r tificazione può far r ife r ime nto (obie ttivi e modular ità), s ia , infine , pe r la r ibadita ne ce s s ità di pe rs onalizzazione de i pe rcors i che por ta il te ma de lla ce r tificazione a confrontars i con proble matiche nuove re lative alla r iconos cibilità de lle conos ce nze e compe te nze e ffe ttivame nte acquis ite dagli individui. Anche il de cre to minis te r iale 28 fe bbraio 2000136 (dis pos izioni re lative alle e s pe r ie nze profe s s ionali r ichie s te pe r lo s volgime nto de lle funzioni di tutore azie ndale ai s e ns i de ll’ar ticolo 16 de lla le gge 196/97) offre s punti inte re s s anti in te ma di ce r tificazione . Come s i e vince , il mome nto de lla ce r tificazione non può pre s cinde re dalla valor izzazione de ll’e s pe r ie nza di appre ndis tato a par tire dall’inte grazione r ichie s ta tra le iniziative formative e s te rne all’azie nda e la formazione s ul luogo di lavoro. Se condar iame nte le modalità di ve r ifica e di ce r tificazione non s ono ince ntrate s olame nte s ui mome nti formativi e s te rni a ll’azie nda, ma de vono e s s e re , inve ce , funzionali a lla valor izzazione de l pe rcors o di or ie ntame nto in alte rnanza. E’ impor tante r icordare , oltre a ciò, che , con la Le gge 17 maggio 1999, n. 144. (Mis ure in mate r ia di inve s time nti, de le ga al Gove rno pe r il r iordino de gli ince ntivi a ll’occupazione e de lla normativa che dis ciplina l’INAIL, nonché dis pos izioni pe r il r iordino de gli e nti pre vide nziali –pubblicata ne lla Gazz. Uff. 22 maggio 1999, n. 118), s i s tabilis cono (o s i r ibadis cono), tra gli a ltr i, tre e le me nti fondame ntali: ♣ l’ogge tto di ce r tificazione pe r il r iconos cime nto de i cre diti tra i diffe re nti pe rcors i in cui è pos s ibile as s olve re l’obbligo di fre que nza (is truzione s colas tica, formazione profe s s ionale di compe te nza re gionale , appre ndis tato) è cos tituito dalle compe te nze ; ♣ i cr ite r i pe r il r iconos cime nto de i cre diti formativi e la ce r tificazione de lle compe te nze de vono e s s e re coordinati e d inte grati, c ioè vi de vono e s s e re e le me nti di tras pare nza e r iconos cibilità tra i tre s e gme nti chiamati in caus a: s cuola, formazione profe s s ionale e appre ndis tato; ♣ l’appre ndis tato s volto ne i pe rcors i pos t- obbligo, e comunque pr ima de i 18 anni, as s ume un caratte re e s s e nzialme nte formativo cos titue ndo, con par i dignità, uno de i tre pe rcors i pos s ibili, pe r l’as s olvime nto de ll’obbligo formativo. Ulte r ior i innovazioni, inoltre , s ono conte nute ne lla le gge che ha is tituito l’autonomia de gli is tituti s colas tici (le gge 59/97 s ul c . d. “fe de ralis mo amminis trativo”), nonché ne l De cre to Le gis lativo 112/98 dove s i a ttr ibuis ce allo Stato il compito di individuare gli s tandard de lle qualifiche profe s s ionali, de i cre diti formativi e le loro modalità di ce r tificazione in
136 L’articolo 1 del suddetto decreto recita: Il tutore aziendale per l’apprendistato ha il compito di affiancare il giovane durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative e di favorire l’integrazione tra le iniziative formative esterne all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro. Il tutore collabora, altresì, con la struttura di formazione esterna all’azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza. Infine, il tutore esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione da parte del datore di lavoro.
139 139
coe re nza con quanto s tabilito ne lla le gge 196/97. Le innovazioni le gis lative fin ora r icordate e la le ttura de gli accordi tra Gove rno e Par ti Sociali cons e ntono di de finire quattro compone nti ge ne rali s u cui fondare le modalità e gli s trume nti di ce r tificazione pe r i pe rcors i di appre ndis tato: i mome nti de lla ce rtif icaz ione 137 , l’ogge tto di ce rtif icaz ione cos tituito dalle compe te nze 138 , il cre dito formativ o139 e la trilate ralità de l contratto140 (ISFOL, 1999).
137 E’ possibile focalizzare, attraverso l’analisi del decreto dell’8 Aprile del 1998, quattro momenti dove è necessario certificare le competenze acquisite dagli apprendisti: nei casi di riassunzione presso altro datore di lavoro con lo stesso profilo professionale o per gli apprendisti in possesso di un titolo di studio post-obbligo o di un attestato di qualifica professionale; nel caso di riassunzione a coloro che abbiano già svolto attività formative: relativamente ai contenuti trasversali è possibile riconoscere crediti in ingresso purché tali acquisizioni siano verificabili o debitamente certificate. Allo stesso modo, per i possessori di un titolo di studio post–obbligo o di un attestato di qualifica professionale, è possibile riconoscere crediti di ingresso, anche e soprattutto attraverso prassi di negoziazione e bilancio iniziali. (art.3 decreto 8/04/1998); nei casi in cui si interrompe il rapporto di apprendistato prima della scadenza prevista o, in futuro, nei casi di percorsi integrati scuola–fp–apprendistato, con particolare riferimento all’obbligo formativo. In questo caso, è necessario predisporre modalità e strumenti di certificazione di crediti formativi spendibili nell’ambito del sistema formativo integrato. (art.2 decreto 8/04/1998); durante la certificazione finale. Il decreto sopra citato prevede un doppio canale di certificazione finale: la certificazione dei risultati delle attività formative i cui criteri sono regolamentati dalle regioni secondo quanto previsto dall’art. 17 della legge 24/6/1997, n.196; e l’attestazione, da parte del datore di lavoro che documenta le competenze professionali acquisite dal lavoratore anche in base alle valutazioni del tutor aziendale. 138 Il principio delle competenze come base per la certificazione viene sottolineato dalla legge 196 del 97 e dai suoi decreti applicativi. Le competenze come oggetto di certificazione possono essere utilizzate, sia per il riconoscimento di crediti formativi sia per la certificazione finale; questo anche nella prospettiva di una ricomposizione ex post delle competenze in figure professionali di riferimento. Le competenze rappresentano la migliore garanzia di trasparenza delle certificazioni tra formazione e lavoro ma costituiscono anche la categoria fondamentale di progettazione dei percorsi formativi dove l’apprendimento avviene, simultaneamente, sul luogo di lavoro e nei momenti di formazione. La categoria delle competenze può, quindi, agevolare quanto riportato nel decreto dell’8/04/1998 dove si afferma la necessità di definire, per i percorsi di apprendistato, contenuti formativi connessi, complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi. 139 Grande valore, viene attribuito all’apprendimento, nei percorsi di apprendistato, riconoscibile come credito formativo. Il credito formativo costituisce il tipo ed il livello di competenze già acquisite da una persona attraverso le proprie esperienze lavorative o formative, valutabili, certificabili e spendibili in ulteriori percorsi formativi e di carriera professionale. Poiché non è più il corso l’unità di misura degli apprendimenti appare indispensabile avere una precisa traccia del lavoro fatto, onde certificarne il valore. E’ importante, dunque, che le esperienze fatte siano documentabili e certificabili, attraverso le unità formative capitalizzabili in un apposito libretto formativo dell’utente. Le unità didattiche capitalizzabili sono delle unità-tipo di formazione finalizzate al raggiungimento di determinate competenze professionali e costituiscono uno strumento utile per aiutare il docente nell’articolazione dei contenuti della disciplina, predisporre un progetto formativo personalizzato, facilitare l’osservazione da parte del tutor, l’autovalutazione degli utenti e la discussione tra i membri del gruppo sul raggiungimento o meno degli obiettivi. Il libretto formativo, invece, è uno strumento ufficiale, istituzionalmente riconosciuto, e con regole chiare di utilizzo, che permette di documentare le competenze via, via acquisite dal soggetto ed utilizzabili in qualità di credito formativo. Sino a quando non viene formalmente definita una modalità comune di utilizzo di questo strumento, singole amministrazioni o organizzazioni possono predisporre ad uso interno propri modelli di libretti formativi. La categoria di riferimento per la certificazione dei crediti è costituita dalle competenze. Tale valore se, da una parte, impone lo sviluppo e la garanzia di standard qualitativi nella formazione in apprendistato più alti di quelli attuali, dall’altra, richiede sistemi di verifica e dispositivi di certificazione non riconducibili agli strumenti attualmente utilizzati. La modalità di valutazione per il riconoscimento dei crediti formativi dovrà, quindi, essere più sofisticata sia sul piano dei processi e delle procedure, sia su quello delle dotazioni metodologiche e dei dispositivi. E’ necessario, inoltre, considerare che un sistema di crediti formativi per essere pienamente agibile, e per garantire la reale spendibilità delle acquisizioni che gli individui maturano via, via nei loro percorsi di apprendimento, deve essere realizzato nell’ambito di un confronto allargato che vede coinvolti tutti gli attori della formazione professionale, della scuola e dello stesso apprendistato. 140 Nell’accordo per il lavoro, sottoscritto da governo e parti sociali nel settembre del 1996, si afferma che il passaggio nodale della riforma dell’apprendistato è costituito dalla trilateralità del contratto che impegna giovane, impresa e struttura formativa fin dalla fase iniziale. Tale principio trova vaghi riferimenti nel decreto dell’8/04/’98. Il decreto ministeriale 20 maggio 1999, n. 179 nell’art. 1 comma 2, prevede che nelle attività formative per apprendisti il primo modulo deve essere dedicato all’accoglienza, alla valutazione del livello di ingresso dell’apprendista e alla definizione del Patto formativo tra l’apprendista e la struttura formativa. Manca, nel testo, il ruolo dell’azienda nella definizione del patto formativo in parte recuperato nel decreto ministeriale 28 febbraio 2000, sulle funzioni del tutor aziendale, in cui è esplicitamente prevista una attività di integrazione tra le iniziative formative e formazione sul luogo di lavoro, e di raccordo con la stessa struttura di formazione allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza.
140 140
Il te ma de lla ce r tificazione nas ce dall’e s ige nza di a tte s tare gli e s iti formativi, non in te rmini ge ne rali, ma in r ife r ime nto a s pe cifiche abilità e compe te nze acquis ite dai s ogge tti in formazione . Non a cas o il conce tto di ce r tificazione nas ce ne ll’ambito de lla formazione profe s s ionale pe r l’e s ige nza di r ilas ciare atte s tati di qualifica profe s s ionale dal conte nuto chiaro e d univoco, e quindi più s pe ndibili s ul me rcato de l lavoro. La pluralità di age nzie formative (pubbliche e pr ivate ), la diffe re nziazione te r r itor iale , ha re s o più acuto, ne l campo de lla formazione profe s s ionale , il proble ma de i cr ite r i di r ife r ime nto a comuni s tandard formativi, dando vita ad azioni di r ice rca e d ai pr imi provve dime nti amminis trativi.
L’obie ttivo di s trutturare un s is te ma formativo inte grato me tte ndo in s tre tto colle game nto la s cuola, la formazione profe s s ionale , il mondo de l lavoro, è funzionale all’e le vame nto de lla qualità ne i pe rcors i formativi in mate r ia di appre ndis tato. Pe r la cos truzione di que s to s is te ma è, tuttavia , ne ce s s ar io de finire dis pos itivi utili pe r la valor izzazione e la cumulabilità di tutte que lle e s pe r ie nze che l’individuo fa ne i diffe re nti pe rcors i formativi o lavorativi. Es s i pe rme tte re bbe ro l’inte grazione inte rdis ciplinare di tutte que lle abilità e compe te nze te or iche o e s pe re nziali acquis ite ne i dive rs i conte s ti formativi o lavorativi, age volando e ve ntuali inte r ruzioni o r ipre s e de gli s tudi, favore ndo, cos ì, un e ffe ttivo raccordo tra mondo formativo, lavorativo e formazione continua. L’e s ige nza di affrontare e di normare in modo ge ne ralizzato (pe r tutti i s ogge tti che s i occupano di Formazione Profe s s ionale a finanziame nto pubblico) la proble matica de lla qualità de gli organis mi oltre che que lla de lla valutazione de l s e rvizio- prodotto, r ichie de uno s forzo di individuazione di una pluralità di s trume nti e tra que s ti, pur ne lla loro dive rs ità, vi r ie ntrano la ce r tificazione de l s is te ma di qualità de gli organis mi formativi s e condo le norme UNI EN ISO 9000141 e
Il patto formativo iniziale, costruito sulla base del principio della trilateralità, risulta importante al fine di avviare un processo negoziale tra i tre attori coinvolti, per stabilire un piano formativo unitario alla necessaria integrazione tra formazione e lavoro, nonché gli obiettivi del percorso di apprendimento in termini di competenze e le successive modalità di verifica e certificazione. Da questo punto di vista, la trilateralità può essere una semplificazione delle prassi di verifica e certificazione delle competenze e dei crediti formativi, oltre che un valido aiuto per le valutazioni del tutore aziendale e l’attestazione finale del datore di lavoro. 141 ISO 9000 è il termine con cui si indica comunemente una famiglia di standard internazionali per l’assicurazione di qualità in seno alle aziende. La sua origine risale allo sviluppo degli standard di fabbricazione nell’industria militare americana agli inizi degli anni 50, cui hanno fatto successivamente seguito norme analoghe in altri campi. Benché inizialmente le norme ISO 9000 siano state concepite esclusivamente per i rapporti contrattuali tra fornitore e cliente, soprattutto nel settore produttivo, molte aziende si sono ben presto interessate ad esse, poiché la natura generica di queste specifiche rende tali norme applicabili a quasi tutti i tipi di azienda, anche a quelle senza fini di lucro. L’ ISO 9000 è divenuto, dunque, il punto di riferimento de facto di qualunque tipo di organizzazione per la ricerca della qualità. I requisiti ISO non riguardano qualità peculiari di prodotti o servizi ma, piuttosto, aspetti della gestione, dell’organizzazione e dei processi: un prodotto o un servizio non può avere una certificazione ISO 9000, mentre può averla l’organizzazione che lo fornisce. Nel suo insieme, l’ISO 9000 è fortemente orientato ai processi, con particolare attenzione alla pianificazione, alla documentazione e al controllo. I principi distintivi di tali norme possono essere così sintetizzati: l’organizzazione deve perseguire obiettivi chiari per quanto concerne la qualità; esistono accordi chiari tra tutti gli interessati; l’organizzazione possiede le risorse per raggiungere il livello di qualità richiesto; l’organizzazione definisce autonomamente quali siano i processi e le risorse necessari per la qualità; tutti i processi ed i sistemi sono sotto controllo, e sono oggetto di valutazioni e modifiche ove necessario; tutto ciò che serve per garantire la qualità è documentato; le registrazioni della qualità consentono una verifica ed una “dimostrazione” dell’assicurazione di qualità.
141 141
l’accre ditame nto. T ali norme hanno un impatto e s tre mame nte r ile vante s ul me rcato de lla formazione favore ndo l’informazione e le condizioni de l dialogo e de ll’inte razione tra fornitor i e c lie nti142 . Il conce tto che s ta alla bas e de lle norme di as s icuraz ione di qualità143 è que llo di as s icurare ne l te mpo al c lie nte che il prodotto/s e rvizio offe r to abbia caratte r is tiche de finite s e condo de te rminati s tandard qualita tivi e che la s truttura e rogatr ice agis ca s e condo modalità chiare e conformi a s pe cifiche de finite . Alla luce de lle cons ide razioni s inora s volte , dunque , è pos s ibile compre nde re i motivi pe r cui s i è ce rcato di “r ipe ns are ” e “r ivitalizzare ” que s to is tituto, s ulla bas e de i cambiame nti e conomici, te cnologici e produttivi che hanno inve s tito le s ocie tà mode rne modificando profondame nte il modo di lavorare . Ed è pe r me glio compre nde re le cr itic ità e i nodi proble matici che affliggono que s to par ticolare contratto mis to che , ne l pros s imo capitolo, ce rche re mo di ope rare una r icos truzione de ll’appre ndis tato in una tr iplice pros pe ttiva: comparativa, s tor ica e quantita tiva.
142 Le motivazioni che spingono gli organismi di formazione a certificarsi possono essere così riassunte: motivazioni di tipo commerciale: di fronte ad un’offerta multipla, il possesso della certificazione rappresenta un valore aggiunto importante; motivazioni di tipo strutturale: la possibilità di essere oggetto di interventi numerosi e diversificati e la disponibilità di strumenti di diffusione delle metodiche di assicurazione della qualità permettono di chiarire i ruoli di ciascuno, gli ambiti di intervento, le finalità del proprio lavoro; motivazioni di impresa: una migliore organizzazione consente di diminuire i costi di intervento e, di conseguenza, di aumentare la propria competitività, inoltre, la formalizzazione del saper-fare e delle regole rende possibile di conservarne traccia nel tempo, infine, l’assicurazione qualità conduce ad una maggiore responsabilizzazione e coinvolgimento del personale. 143 L’assicurazione qualità interviene in tutte le aree/funzioni che operano trasversalmente per il buon funzionamento della struttura, ovvero considerando la gestione della documentazione interna ed esterna, la gestione della non conformità e delle azioni correttive e preventive, la realizzazione delle verifiche ispettive.
142 142
CAPITOLO QUATTRO
L’APPRENDISTATO IN ITALIA: UNA PROSPET T IVA COMPARAT A, ST ORICA E QUANT IT AT IVA
Pro s pe ttiva c o mparata Dive rs i s e ntie ri tra s c uo la e lavo ro L’OECD (2000) ha prodotto un’impor tante r ice rca comparativa s u 14 pae s i144 caratte r izzati da una dive rs a re altà s tor ica, culturale , e conomica e s ociale , a l fine di compre nde re le modalità attrave rs o cui s i s viluppa la trans izione dalla s cuola al lavoro e l’acquis izione de llo s tatus di adulto. T ale r ice rca me tte in luce che l’e s pe r ie nza combinata tra lavoro e s tudio è impor tante pe r un gran nume ro di ragioni: favor is ce l’incontro tra dator i di lavoro e giovani, migliora la qualità de ll’appre ndime nto attrave rs o l’applicazione , s viluppa impor tanti compe te nze - conos ce nze coe re nti con l’agire , può ave re un impatto pos itivo s ull’impre s a in te rmini di organizzazione che appre nde . Que s ta e s pe r ie nza combinata tra s cuola e lavoro può avve nire in modi diffe re nti, l’e fficacia de i quali dipe nde da un gran nume ro di fattor i, diffic ili da is olare , come : una buona e conomia, una buona organizzazione de i s e ntie r i che conne ttono formazione iniziale , lavoro e s tudi s upe r ior i; ampie oppor tunità di combinare e s pe r ie nze mis te di a lte rnanza s cuola- lavoro; s aldi rappor ti inte rorganizzativi (tightly k nit), una buona diffus ione di s e rvizi di informazione e or ie ntame nto. La r ice rca me tte in e vide nza, inoltre , che buoni r is ultati s i r intracciano in pae s i tra loro comple tame nte diffe re nti que s to pe rché ne s s un mode llo può e s s e re cons ide rato buono in as s oluto ma de ve e s s e re le tto ne l più ampio quadro s tor ico is tituzionale in cui s i è s viluppato.
L’appre ndis tato è cons ide rato il migliore di que s ti s trume nti di trans izione che cons e ntono al giovane di acquis ire una qualifica profe s s ionale e , a l conte mpo, un ve ntaglio di conos ce nze più ampio attrave rs o la formazione e s te rna che , come s i avrà modo di os s e rvare ne i paragrafi s ucce s s ivi, può e s s e re organizzata in modi diffe re nti a s e condo de ll’impianto e ducativo pre s ce lto. Altre vie che cons e ntono di combinare una formazione alte rnata tra s cuola e lavoro, utile a s viluppare s k ills e favor ire que s ta diffic ile trans izione , s ono: s tage / tirocini (bre vi pe r iodi di formazione on the job inte grati ne i programmi s colas tic i); co- ope rativ e e ducation (appre ndime nto fra par i); s tudio/ lavoro. La novità di r ilie vo è data dal fatto che pe r la pr ima volta vie ne r iconos ciuta come s trate gia pos itiva pe r favor ire la trans izione , la diffus a modalità de gli s tude nti di s volge re lavor i part- time , e s tivi o
144 I paesi coinvolti nella ricerca sono: Australia, Austria, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Ungheria, Giappone, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera, Stati Uniti, Regno Unito
143 143
s altuar i pe r mante ne rs i agli s tudi. De l re s to anche l’ultima r ice rca IST AT (2001) ha me s s o in e vide nza che tale modalità inve s te , in Ita lia , una pe rce ntuale di giovani molto alta : c irca il 50%.
Ne lla le tte ratura s cie ntifica inte rnazionale s i trovano nume ros i s forzi volti a te ntare una clas s ificazione capace di re s tituire mode lli o ide altipi di trans izione pos s ibile all’inte rno di un frame w ork conce ttuale comple to e capace di te ne r conto: de lla s truttura e de ll’organizzazione de i s is te mi e ducativi e de i s is te mi di pas s aggio al mondo de l lavoro; de lla natura de i link s tra e ducazione e s is te ma occupazionale ; de i policy approache s nazionali volti a migliorare la trans izione s cuola- lavoro; de i mode lli di de cis ion mak ing diffus i tra gli a ttor i chiave de l proce s s o; e , infine , de l proce s s o di trans izione e i re lativi r is ultati.
T ra i contr ibuti più inte re s s anti s i pos s ono annove rare que lli di McKe nzie Hannan, Raffe e Smyth (OECD, 2000) i quali dis tinguono tra pae s i che hanno una trans izione caratte r izzata da tightly conne cte d link s e d altr i, inve ce , che hanno conne s s ioni loos e ly couple d . Se condo gli autor i, i pr imi s i dis tinguono pe r : “occupationally organis e d labour mark e ts ; s trong ce ntral tripartit inv olv e me nt in e ducation and e mploy me nt de cis ion mak ing; v e rtical s e gme ntation and diffe re ntiation of the e ducation and training s y s te m; s trongly ins titutionally bas e d pathw ay s ; and nationally s tandardis e d curriculum and ce rtif ication arrange me nts ”; me ntre i s e condi s ono contraddis tinti da “inte rnal labour mark e ts and s e le ction bas e d upon broad e mploy ability and trainability , ofte n as e v ide nce d by ge ne ral e ducation that is horizontally s e gme nte d by le v e l but re lativ e ly undiffe re ntiate d by ins titutional ty pe at e ach le v e l; indiv idually cons tructe d pathw ay s be tw e e n e ducation and w ork ; and w ide re gional and local v ariation in curricula and ce rtif ication.”
Altr i autor i, inve ce , e laborano una clas s ificazione tra que llo che loro de finis cono qualificational s pace s e organis ational s pace s con i quali vie ne e ffe ttuata la trans izione al lavoro. I qualificational s pace s s ono caratte r izzati da un’e nfas i s ulla pre parazione vocazionale ; un s is te ma e ducativo s tratificato che mantie ne una ne tta diffe re nza tra profilo accade mico e vocazionale e una s tandardizzazione de i curr icula . Vice ve rs a, gli organis ational s pace s s i dis tinguono pe r l’e nfas i r iconos ciuta all’e ducazione ge ne rale e accade mica; le s k ills acquis ite s ul lavoro dopo la s cuola piuttos to che a s cuola; una s os tanzios a diffe re nza de i curr icula e de lle ce r tificazioni a live llo re gionale o tra diffe re nti tipi di s cuola (Mulle r , Shavit, 1998).
Se condo T homas (1977) infine , s i pos s ono s uddivide re i due mode lli fondame ntali di formazione profe s s ionale in due cate gor ie : la pr ima r iconos ce un ruolo pr imar io alla s cuola s tatale e garantis ce una maggiore atte nzione alla cre s cita pe rs onale de gli s tude nti a s vantaggio de l rappor to
144 144
dire tto con la re altà e conomico- produttiva; la s e conda è l’appre ndis tato in azie nda che garantis ce maggiore incis ività e un aggancio dire tto a me s tie r i s pe cifici, ma è me no atte nto alla dime ns ione formativa globale de lla pe rs ona. In molti Pae s i, c iò nonos tante , s i s ta te ntando una te rza via in cui l’e ducazione s tatale cons e rva una pre cis a re s pons abilità formativa, affidando alle impre s e la cura di garantire una formazione pratica ne lla pros pe ttiva di un impie go. Il proble ma che re s ta da r is olve re è que llo di una formazione adattabile alle fluttuazioni de l me rcato de l lavoro e ai cambiame nti impos ti dall’e voluzione te cnologica s e nza tras curare il pie no s viluppo de lle facoltà di c ias cun individuo. Il limite di que s te clas s ificazioni, nondime no, cons is te ne l fatto che conce ntrano il loro focus di analis i e s s e nzialme nte s ulle diffe re nze che e s is tono tra s is te mi e ducativi e profe s s ionali e la loro re lazione con il me rcato de l lavoro tralas ciando gli impor tanti fattor i conte s tuali che vi incidono, come , ad e s e mpio: tipologia di gov e rnme nt , cultura, e conomia e cc..
Il c ita to s tudio de ll’OECD, r iconos ce ndo un ruolo ce ntrale al conce tto di pathw ay (s e ntie ro) ne llo s tudio dalla trans izione al lavoro e ffe ttua una clas s ificazione s ulla bas e de l loro “dominant uppe r s e condary pathw ay s ”. Il vantaggio di que s to modo di proce de re cons is te ne l fatto che pe rme tte di individuare il s e ntie ro a cui i policy mak e rs a ttr ibuis cono un maggiore inte re s s e pe r la politica inte rna. Se condo que s ta via , la c las s ificazione propos ta dall’OECD è cos ì ar ticolata:
♦ A ppre ntice s hip countrie s s ono de finiti que i pae s i dove più de l 50% de lla popolazione par te cipa a l canale de ll’appre ndis tato: Ge rmania e Svizze ra.
♦ Mix e d pathw ay countrie s s ono de finiti in que s to modo i pae s i ne i quali più de l 20%, ma me no de l 50%, de i giovani par te cipano al canale de ll’appre ndis tato e me no de l 50% di e s s i s i trovano ne i programmi di e ducazione ge ne rale . I pae s i che r is pondono a que s to cr ite r io hanno il più var io mix di s oluzioni pos s ibili e s ono: Aus tr ia , Danimarca, Norve gia e Olanda.
♦ School- bas e d v ocational countrie s ve ngono de finiti in que s to modo i pae s i ove più de l 50% de i giovani par te cipano alla formazione profe s s ionale , e una quota infe r iore al 20%, s i trovano in appre ndis tato. Que s ti pae s i, s pe s s o, combinano i loro programmi s colas tici di bas e con pe r iodi di training o di e s pe r ie nza in impre s a; ma, tradizionalme nte , que s ti pe r iodi s ono re lativame nte bre vi s e comparati a ll’e s pe r ie nza tipica di appre ndis tato. Ne lla maggior par te de i cas i e s s i non s i e volvono in una re lazione di impie go né in un contratto di lavoro. T ra que s ti pae s i s i
145 145
pos s ono annove rare : Be lgio, Re pubblica Ce ca, Finlandia, Francia , Unghe r ia , Ita lia , Polonia, Sve zia e Re gno Unito.
♦ Ge ne ral e ducation countrie s s ono, inve ce , que i pae s i ove più de l 50% de i giovani pre nde par te al s e gme nto di e ducazione ge ne rale . T ra que s ti pae s i ve ngono ins cr itti: Aus tralia , Canada, Gre cia , Ir landa, Giappone , Kore a, Nuova Ze landa, Por togallo, Spagna e Stati Uniti.
Al nos tro s copo, può e s s e re utile ope rare una r icos truzione più de ttagliata di que s ti mode lli pre nde ndo ad e s e mpio alcune de lle più s ignificative e s pe r ie nze e urope e , a l fine di e nucle are punti di forza e nodi cr itic i di que s to is tituto oggi tanto dibattuto e r ilanciato in tutti i dibattiti politico-is tituzionali a live llo comunitar io e inte rnazionale . Le e s pe r ie nze cui s i ce rche rà di dare conto, avvale ndos i de lla le tte ratura s cie ntifica s ul te ma, s ono (s e condo la clas s ificazione OECD): • a p p r e nt ic e s c hip c o unt r y : Ge rmania • s c ho o l- b a s e d v o c a t io na l c o unt r y : Francia/Inghilte r ra e , in manie ra più approfondita , Ita lia • g e ne r a l e d uc a t io n c o unt r y : Spagna • Mix e d p a t hw a y c o unt r y : Olanda/Danimarca/Lus s e mburgo
Apprenticeschip Country : Germania
Il s is te ma duale te de s co rappre s e nta l’e s e mpio di a lte rnanza s cuola- lavoro più cita to. In que s to s is te ma i giovani che non inte ndono pros e guire gli s tudi, a l te rmine de ll’obbligo, s ono te nuti a s e guire un’is truzione profe s s ionale o a te mpo pie no, o a te mpo parziale , fino al compime nto de l 18° anno di e tà. Pe r acce de re a ta le s is te ma s i de ve s tipulare con un’impre s a produttiva, un par ticolare contratto di lavoro che garantis ce il dir itto alla formazione s ul pos to di lavoro alla quale s i affianca l’ins e gname nto pubblico a te mpo parziale ne lla “Be rufs s chule ” (s cuola profe s s ionale a te mpo parziale ). Que s to impianto s i dis tingue pe r l’e s tre ma fle s s ibilità de gli itine rar i formativi tanto che s i può par lare di una formazione profe s s ionale come formaz ione autonoma de l mondo e conomico . Ne gli ultimi anni il s is te ma te de s co ha s ubito de i corre ttivi, a l fine di is tituire un pr imo anno di formazione profe s s ionale di bas e , non vincolata ad una s pe cifica qualifica profe s s ionale be ns ì a s e ttor i profe s s ionali a ll’inte rno de i quali ope rare una s ce lta s ucce s s iva (Bocca, 1998). Nonos tante il dibattito e le cr itiche che oggi s i pos s ono muove re al s is te ma duale te de s co è indubbiame nte que llo che , ancor oggi, appare più compatto e s icuro ne gli ordiname nti e ne lla filos ofia che lo anima. Que s ta s olidità s e mbra e s s e re il frutto di un proge tto ide ologicame nte coe re nte e
146 146
s os te nuto da un for te cons e ns o s ociale . Alla bas e di que s to s is te ma s i r is contrano due conce tti impor tanti: “il proce s s o di acculturazione di cui l’is tituzione s i fa car ico non è cons ide rato conclus o s e non inte gra un’e s pe r ie nza profe s s ionalizzante [ …] ; la formazione profe s s ionale è ge ne ralizzata (pe r tutti i s ogge tti e tutte le profe s s ioni) e rappre s e nta un mome nto di grande r ilie vo formale ne l proce s s o di acquis izione di uno s tatus / ruolo lavorativo e s ociale (s i conclude con prove ce r tificate che vincolano le azie nde ne lla fas e di inquadrame nto)” (Be llo op. 1994 , pp. 5-10). Attrave rs o il s is te ma duale dopo due , tre anni e me zzo di appre ndis tato s i ottie ne la qualifica di ope raio s pe cializzato; me ntre , le s cuole profe s s ionali durano da uno a tre anni e r ilas ciano un diploma profe s s ionale che non vie ne r iconos ciuto s ul me rcato de l lavoro come qualifica di ope raio s pe cializzato. Le Be rufs aufs chule n, le Fachobe rs chule n e le Fachs chule n s ono s cuole profe s s ionali a te mpo pie no che s i fondano o s u un pe rcors o di formazione duale o s u un pe rcors o di tipo s colas tico. Que s te s cuole profe s s ionali s e rvono a pros e guire la formazione profe s s ionale s pe cifica e fornis cono diplomi che cons e ntono di acce de re a s ucce s s ivi pe rcors i di appre ndis tato s colas tico fino a giunge re alle : Fachhos chule e d alla Houchs chule .
Ne gli ultimi de ce nni, la compos izione de gli s tude nti che fuor ie s cono dal s is te ma e ducativo s i è molto modificata . Si è as s is tito ad una cre s cita molto for te de i fre que ntanti de lle s cuole di formazione profe s s ionale e s i è re gis trato un nume ro cre s ce nte di giovani che s ce glie , pr ima e dopo l’appre ndis tato, le s cuole profe s s ionali. Que s to s ignifica che non è la s cuola tradizionale a s volge re il ruolo pr imar io ne lla formazione de i giovani te de s chi be ns ì la formazione profe s s ionale . In altre parole , è l’impre s a a r icopr ire il ruolo dominante me ntre la s cuola s volge una funzione inte grativa. Ne l s is te ma duale te de s co l’appre ndis ta e ffe ttua il s uo adde s trame nto pe r tre giorni la s e ttimana in impre s a e pe r due giorni ne lla s cuola profe s s ionale . I giorni di fre que nza in tali s cuole , in ge ne re , ve ngono conce ntrati in uno o più blocchi al fine di favor ire una maggiore conne s s ione tra adde s trame nto s colas tico e adde s trame nto on the job, ne ll’ottica di migliorare la pos s ibilità di appre ndime nto de l giovane . Il s ucce s s o di ta le s is te ma s ta ne ll’alto grado di armonizzazione tra: formazione profe s s ionale , formazione s colas tica e formazione in impre s a de te rminata da un contatto s tre tto e continuo tra gli adde tti a lla formazione in impre s a e gli ins e gnanti. ”Attrave rs o l’alte rnars i di fas i lavorative e di s tudio s is te matico, s i offre la vantaggios a pos s ibilità di unire applicazioni e d e s pe r ie nze pratiche con approfondime nti e r ifle s s ioni te or iche (alte rnativa r is pe tto ad una formazione purame nte s colas tica)”(Kath, 1994, p 26).
147 147
Nonos tante la comple s s ità e il fas cino che ancor oggi l’impianto duale raccoglie , è pos s ibile e vide nziare s ia alcuni e le me nti di me r ito che alcune cr itic ità.
T ra i vantaggi de l s is te ma duale s i pos s ono annove rare : una armonios a trans izione dalla s cuola al lavoro. E ciò è confe rmato dal fatto che tutti i pae s i che hanno un tipo di formazione profe s s ionale pre vale nte me nte duale (Ge rmania, Aus tr ia e Svizze ra) e s cono vince nti ne l confronto inte rnazionale s ul tas s o di dis occupazione giovanile ; inoltre , l’ampia gamma di qualifiche offe r te cons e nte a quas i tutti i giovani, anche a que lli con pe rcors i s colas tic i molto diffic ili, di cons e guire una qualifica che cons e nte loro di acce de re in modo dignitos o al me rcato de l lavoro (con cons e gue nte abbas s ame nto de l tas s o di analfabe tis mo e una r iduzione de lla mobilità lavorativa). In Ge rmania, c irca il 70% de gli appre ndis ti ha un lavoro alla fine de l pe r iodo di formazione . Que s to r is ultato occupazionale rappre s e nta un grande motivo di s ucce s s o de l s is te ma duale e dimos tra che i giovani in pos s e s s o di una qualifica profe s s ionale s ono avvantaggiati ne lla trans izione al lavoro r is pe tto a coloro che ne s ono s provvis ti. E’ dove ros o s ottoline are , tuttavia, che , in Ge rmania, il s is te ma duale rappre s e nta l’unico pe rcors o formativo pe r acce de re alla qualificazione profe s s ionale , c ioè non e s is tono s is te mi paralle li tra loro in concorre nza come s ucce de , ad e s e mpio, in Ita lia (Scuole te cniche e profe s s ionali, pe rcors i s tatali e re gionali, qualifiche di fatto come appre ndis tato o CFL). Cos ì conce pito, ta le s is te ma, rappre s e nta non s olo un pe rcors o formativo ma anche un s is te ma di promozione inte rno all’azie nda.
Ne gli anni ’90, nondime no, il s is te ma duale è s tato fatto ogge tto di nume ros i a ttacchi che hanno te ntato di me tte rne in e vide nza i punti cr itic i a llo s copo di favor ire una r ivis itazione de ll’inte ro s is te ma. Ad e s e mpio, Stratmann lo ha de finito: una cus todia pe r un re liquar io, poiché la re golame ntazione de lle qualifiche profe s s ionali r is ale pe r un quar to agli anni 1936- 1945, pe r il 46% al pe r iodo 1946- 1980 e pe r il re s tante 10% manca quals ias i tipo di re golame ntazione . Pe r que s to motivo, s i è provve duto ad un ammode rname nto di que s te norme , r imas te invar iate pe r oltre quaranta anni, apre ndo, cos ì, una s e r ie di proble mi di grande impor tanza.
In pr imo luogo, il nuovo caratte re de i cors i di s tudio, a ltame nte te or ici, r iguardanti la par te azie ndale de lla formazione profe s s ionale “avvicina i due pe zzi, de lla s cuola e de ll’impre s a, ma pe nalizza for te me nte la fas cia più de bole de ll’ute nza, vale a dire gli a lunni diplomati de lla Haupts chule . Le ‘abilità’ r ichie s te dai nuovi re golame nti (autonomia ne lla programmazione , ne ll’e s e cuzione e ne l controllo de i r is ultati de l lavoro, capacità di lavorare in te am e di utilizzare i s is te mi di s tudio inte rattivi) s upe rano di gran lunga que llo che la Haupts chule offre oggi ai s uoi alunni diplomati” (Be llo, 1994, p. 8).
148 148
Inoltre , il quadro normativo s i pre s e nta ormai troppo r igido di fronte ai mutame nti s ociali e te cnologici che hanno inve s tito tutte le s ocie tà mode rne . T ra i proble mi e me rs i in que s ti anni s i è r ile vato che fle s s ibilità quantita tiva e d offe r ta de i pos ti di appre ndis ta pos s ono non armonizzars i. In alcune profe s s ioni, infatti, s i è re gis trato un tas s o di cre s cita di gran lunga s upe r iore al fabbis ogno.
Si as s is te , tra l’altro, ad un ge ne ralizzato cambiame nto di a tte ggiame nto da par te de i giovani ve rs o le profe s s ioni ope raie e manuali che conduce s e mpre più giovani ad or ie ntars i ve rs o l’is truzione ge ne rale . A que s to s copo, molti e s pe r ti aus picano la par ificazione tra is truzione ge ne rale e formazione profe s s ionale in modo che , a l te rmine di un appre ndis tato in impre s a, unito ad un’ade guata e s pe r ie nza lavorativa, s i pos s a acce de re ad una Fachs chule n o all’Unive rs ità. T ale par ificazione s are bbe utile pe r porre le pre me s s e utili a cons e rvare i pe rcors i di adde s trame nto profe s s ionale accanto al Gy mnas ium . Se condo altr i autor i, tuttavia , il proble ma r iguarda le pros pe ttive de l pos t- appre ndis tato e non l’appre ndis tato in s é . La par ificazione di is truzione ge ne rale e formazione profe s s ionale de ve e s s e re condotta anche ne ll’ottica di un re ddito e quilibrato e migliore che pos s a funge re da ince ntivo (Kath , 1994, p. 27).
Nonos tante le cr itic ità che è pos s ibile individuare , l’e le me nto di pre gio che caratte r izza que s to s is te ma cons is te ne l fatto che all’inte rno de lla formazione duale s i compe ne trano forze , inte re s s i e ordiname nti dive rs i, for te me nte inte grati tra loro e che pos s ono e s s e re cos ì s inte tizzati.
• Le funzioni di controllo, pianificazione e finanziame nto s ono dive rs e a s e conda de l luogo in cui s i s volge l’appre ndis tato: impre s a o s cuola. Allo s te s s o modo le compe te nze di re golame ntazione s ono diffe re nte me nte r ipar tite tra gove rno fe de rale e Lande r. In s inte s i, pe r la formazione in azie nda vige il dir itto fe de rale , me ntre pe r que lla s colas tica que llo de i Lande r.
• Gli ordiname nti de lla formazione de lle s ingole profe s s ioni r iconos ciute , concordati tra le par ti s ociali e r iconos ciuti s u tutto il te r r itor io nazionale da un’ordinanza le gis lativa fe de rale , rappre s e ntano l’unità di mis ura pe r la formazione profe s s ionale ne l s uo ins ie me e pe r gli e s ami finali; me ntre , a l contrar io, i programmi di ins e gname nto de lle s cuole s i bas ano s ulle le ggi e le ordinanze de i s ingoli Lande r.
• Le organizzazioni e conomiche autonome e gli organi compe te nti pe r la formazione profe s s ionale , s ono re s pons abili de lla cons ule nza, de lla s orve glianza e de ll’idone ità di chi adde s tra , oltre che de lle prove di idone ità profe s s ionale e de gli e s ami conclus ivi.
• Le Came re s i occupano de lla conduzione de lla formazione azie ndale come , ad e s e mpio, la re golame ntazione de ll’adde s trame nto in officine e xtra- azie ndali.
149 149
Pe r quanto conce rne , infine , le s pe s e la par te s colas tica145 è s os te nuta dai Lande r, dai colle gi e le ttorali e dai Comuni.
Pe r le azie nde impe gnars i ne ll’adde s trame nto profe s s ionale de i giovani è impor tante tanto pe r mante ne re alta la qualificazione e conomica ge ne rale , quanto pe r e vitare i cos ti di un me rcato de lle qualifiche poco tras pare nte , nonché pe r l’ade guame nto de lla qualificazione di forza lavoro già impie gata ma pr iva di formazione . Ne gli ultimi anni, c iò nondime no, s i è ve r ificato un mome nto di cr is i in s e no a ta le impianto. La te rziar izzazione de ll’e conomia, infatti, compor ta una cr is i de i s is te mi di appre ndis tato il quale s i s viluppa pre vale nte me nte ne ll’ar tigianato e ne l comme rcio e ha conos ciuto un cons is te nte incre me nto ne l dopogue rra grazie allo s viluppo de lle organizzazioni impre nditor iali. Le profe s s ioni de l te rziar io r ichie dono, a diffe re nza de lle profe s s ioni tradizionali de ll’indus tr ia e de ll’ar tigianato, una formazione di bas e ge ne rale che s i avvicina di più ai diplomi acquis ibili ne ll’ambito de l s is te ma e ducativo. Pe r que s to motivo s i as s is te ad una ge ne ralizzata te nde nza da par te de i giovani a prolungare la propr ia pe rmane nza ne gli s tudi pr ivile giando, s e mpre più, gli indir izzi s colas tic i di tipo te cnico profe s s ionale . Si pone , dunque , un proble ma di ordine qualita tivo146 .
Il mondo impre nditor iale in Ge rmania è re s pons abile de lla formazione profe s s ionale e de l fatto che que s ta ve nga or ie ntata in bas e alle ne ce s s ità de ll’e conomia. Sono s oprattutto le azie nde ar tigianali ad offr ire in Ge rmania un’ampia e fruttuos a formazione profe s s ionale . La FP è for te me nte ancorata al s is te ma di is truzione te de s co e affonda le s ue radici
145 Pur non affrontando nello specifico il dibattito sul sistema scolastico tedesco ci sembra utile soffermarci brevemente sulla sua articolazione. Tale sistema è articolato in percorsi “progressivamente ramificati” a cui corrispondono “momenti di scelta guidata o meglio condizionata dal corpo docente ad ogni biforcazione e, al contempo, circuiti di recupero assistito rispetto a eventuali scelte sbagliate.” Così strutturato questo sistema educativo si fa carico della riuscita personale/professionale di ogni singolo allievo. Al contrario, alla base degli altri sistemi educativi europei, pur nelle notevoli differenze che possiamo riscontrare nei singoli casi, troviamo un unico comune denominatore che si fonda in un progetto pedagogico/educativo di segno opposto, secondo il quale “la scuola non ha la responsabilità di accompagnare strutturalmente l’inserimento dei giovani nella vita attiva, bensì ha la responsabilità primaria di svilupparne la personalità come elemento chiave dell’inserimento.” Alla base di questo impianto c’è la l’idea che l’accesso “agli status/ruolo avviene in virtù dell’iniziativa e della responsabilità del singolo e della capacità di esercitarli” cioè, è la personalità acquisita a fare status e non il titolo di studio conseguito. Questo modello, che contraddistingue anche il sistema educativo italiano, non sembra riscontrare lo stesso successo in termini di accompagnamento dei giovani nella fase di transizione scuola/lavoro, lungo il loro percorso professionale (Bello, 1994/bis). Nel sistema educativo tedesco - articolato in un gran numero di scuole e percorsi formativi - la sfera culturale non è di competenza della federazione ma di ogni singolo Stato federale tanto è vero che si possono trovare differenze tra i diversi Lander. I percorsi formativi sono così articolati: Grundshule (scuola primaria) dura normalmente 4 anni, ma in alcuni Lander può arrivare a 6 anni, Hauptschule va dal quinto (o settimo) al nono (o decimo) e termina con il Hauptshulabschluss (diploma), in alcuni casi permette di accedere ad un diploma qualificato; Realschule va dal quinto (o settimo) anno al decimo e fornisce il diploma di Mittlerer Abschluss; Gymnasium va dal quinto (o settimo) anno al tredicesimo. Al decimo anno si consegue , come nel caso precedente il diploma di Mittlerer Abschkuss, mentre nel livello secondario, con il tredicesimo anno si consegue l’Abitur, che consente l’accesso agli studi superiori e all’Università. In alcuni Lander è possibile trovare anche la Gesamtschule, o come scuola regolare o come scuola sperimentale, che riunisce in un unico blocco i tre precedenti ordini di scuola. 5. Sonderchule è una scuola che assicura speciali sostegni pedagogici ai giovani con grandi difficoltà di apprendimento pur garantendo lo svolgimento dei programmi regolamentari. (Kath, 1994). 146 In Paesi come l’Austria e la Svizzera, dove l’apprendistato assume più o meno le stesse caratteristiche della Germania, questa tendenza preoccupa molto l’amministrazione pubblica che, in questo modo, vede lievitare i costi del proprio sistema educativo. Spesso, infatti, non si tiene sufficientemente conto che l’apprendistato rappresenta un istituto di formazione che impegna poche risorse pubbliche.
150 150
ne ll’ar tigianato me die vale .147 Qual è , a llora , il tornaconto de lle par ti dator iali in que s to s is te ma, cons ide rando che un appre ndis ta , in Ge rmania, cos ta molto di più di quanto non cos ti in Ita lia? E pos s ibile dis tingue re due tipi di conve nie nze : la pr ima è di tipo imme diato e la s e conda è di tipo diffe r ito.
Conv e nie nze di tipo imme diato : gli impre nditor i te de s chi confe r is cono una par ticolare impor tanza alla qualificazione de lla propr ia forza lavoro, poiché, pe r loro, l’alte rnativa all’as s unzione di un appre ndis ta s i concre tizza con l’as s unzione di un giovane lice nziato dalla s cuola de ll’obbligo con un s alar io alme no doppio r is pe tto a que llo de ll’appre ndis ta . Il me rcato de l lavoro, in que s to modo, r is ulta auto- re golato pe rché le impre s e non hanno inte re s s e , in as s e nza di un fabbis ogno re ale , a formare giovani, è chiaro che in mome nti di cr is i e di a lti tas s i di dis occupazione anche in que s to impianto una pe rce ntuale di giovani, a lla fine de l pe r iodo di appre ndis tato, non r ie s ce a r icollocars i imme diatame nte . Il s ucce s s o di que s to s is te ma è dato da un pre cis o e quilibr io capace , da una par te , di garantire una formazione di bas e che cons e nte all’appre ndis ta di r icollocars i age volme nte ne l me rcato de l lavoro; dall’altra , una formazione idone a alle e s ige nze s pe cifiche de ll’impre s a in modo da non ince ntivare troppo la mobilità inte r - azie ndale che de motive re bbe le azie nde me tte ndo in cr is i le fondame nta de ll’inte ro s is te ma. Il gius to e quilibr io tra que s te due compone nti rappre s e nta la que s tione ce ntrale de l proble ma: mante ne re alto l’inte re s s e de lle impre s e ad accollars i l’one re de lla formazione in azie nda.
Conv e nie nze di tipo diffe rito: a ttrave rs o l’appre ndis tato le impre s e hanno l’oppor tunità di qualificare una mano d’ope ra ade guata alle loro e s ige nze e d acquis irne in s e guito una par te con re tr ibuzioni non par ticolarme nte one ros e (Giovine , 1994).
School- Based Vocational Country : Francia, Inghilterra
Francia
Ne l 1971, con la le gge s ulla formazione profe s s ionale continua il Minis te ro de ll’Educazione france s e ha de cis o di utilizzare , pe r la formazione in alte rnanza de i lavorator i, la normale s truttura didattico formativa già e s is te nte , s e nza cre are nuovi ce ntr i ad hoc, ciò allo s copo di inne s care un proce s s o di mode rnizzazione e di ade guame nto de i programmi s colas tic i tradizionali grazie al contatto con l’e s pe r ie nza di lavoro- s tudio de gli adulti in formazione . In que s to clima, s i s ono avviate nume ros e s pe r ime ntazioni diffic ilme nte r iducibili ad un mode llo unitar io. Succe s s ivame nte , ne l 1979, il
147 Per un analisi più approfondita sulla struttura della formazione professionale in Germania si veda: Studio Meta & associati, 1996.
151 151
Minis te ro ha pubblicato un docume nto - volto a r ias s ume re il dibattito tra le par ti s ociali s ui te mi de lla formazione iniziale e de lla formazione continua de gli adulti- che può e s s e re r ias s unto ne i s e gue nti punti: “ar ticolare in modo concre to la formazione iniziale di tutti i giovani all’e s e rcizio di una profe s s ione ; offr ire de gli s trume nti a ll’e ducazione pubblica pe r as s icurare la formazione iniziale [ …] in vis ta de ll’acquis izione da par te de i giovani di una cultura ge ne rale , te cnica e profe s s ionale [ ...] che pos s a ave re uno s bocco in una forma di qualificazione r iconos ciuta s ul me rcato de l lavoro; as s icurare un le game fra s cuola e le re altà s ocio-e conomiche pe r fare e volve re le modalità di ins e gname nto e fare s ì che la formazione profe s s ionale offe r ta r is ponda alle as pirazioni de i giovani e d alle e s ige nze de lla vita e conomica e s ociale ”(Bocca, 1992, p. 57).
Pe r gli s tude nti a te mpo pie no s i propone un s is te ma e ducativo, s otto la re s pons abilità de lla s cuola pubblica che cons e nta contatti con le re altà produttive . Pur cons e rvando lo s tatus di s tude nti le s e que nze formative tras cors e in impre s a s ono cons ide rate par te de l proce s s o di formazione . L’e ducazione profe s s ionale e il s is te ma di formazione france s e compre ndono un’ampia gamma di programmi che vanno diffe re nziandos i s e mpre di più. Ne gli ultimi anni, e s s i s ono s tati comple tati da una s ce lta e s aus tiva e d in continua cre s cita di programmi di formazione or ie ntati a lla dire tta inte grazione de l me rcato de l lavoro pe r i giovani dis occupati.
L’obie ttivo pr incipale de lle politiche de l lavoro france s i è que llo di aume ntare il coinvolgime nto dire tto de lle impre s e in programmi e ducativi e mis ure formative , incoraggiandole ad organizzare cors i di formazione on the job. Le s te s s e par ti s ociali s ono inte nzionate ad incre me ntare in que s to s e ns o il live llo de ll’e ducazione profe s s ionale in modo da otte ne re que lla che vie ne de finita la ide al w ay (De uts che s Ins titut, 1996). Il s is te ma formativo france s e , dunque , s i pre s e nta ar ticolato in due s ubs is te mi: que llo e ducativo (compre s a la formazione iniziale ) che fa capo al Minis te ro de ll’Educazione Nazionale ;148 e la formazione profe s s ionale non s colas tica di compe te nza de l Minis te ro de l Lavoro e de lle Re gioni. All’inte rno de lla formazione unive rs itar ia , inoltre , s i annove rano una var ie gata s ce lta di opzioni te cnico- profe s s ionali che , in bre ve , r ipor tano al pr imo ciclo unive rs itar io propr iame nte de tto DEUG- DEUST e allo IUT , Ins titut Profe s s ionnalis é (altame nte s e le ttivo e de lla durata di due anni e s te ns ibili a tre , s ce lto dal 7% de gli s tude nti de l te rziar io) il quale è
148 I corsi di studio francesi sono organizzati in cicli pluriennali per permettere ai docenti di adattare l’azione pedagogica ai ritmi individuali di apprendimento di ogni allievo per migliorare la continuità educativa. Il sistema di insegnamento elementare e quello secondario inferiore costituiscono un asse comune di formazione per tutti gli allievi, le differenziazioni dei percorsi appaiono al livello di insegnamento secondario superiore. L’obbligo scolastico dura 10 anni, dai 6 anni di età a16.Il sistema educativo si caratterizza per la notevole ricchezza di diplomi e titoli in tutti i settori, dal secondario superiore, sia universitario che non, nel tentativo di rispondere alla più ampia gamma possibile di esigenze dell’utenza. Per un’analisi più approfondita del sistema di formazione francese si veda, tra gli altri, Cappucci, in Fondazione RUI, n. 69 e il sito www.treccani.it/site/iniziative/scuola/documenti/modelli.pdf
152 152
autonomo ma colle gato all’unive rs ità. Pe r il loro finanziame nto è pre vis ta l’e rogazione di fondi da par te de llo s tato pe r pos to- s tude nte , oltre ad un contr ibuto da par te de lle impre s e , la tax e d’appre ntis s age . Lo IUT può anche autofinanziars i me diante conv e ntion s tipulate con l’indus tr ia pe r proge tti comuni. As s i por tanti de llo s viluppo attuale de l s is te ma di formazione profe s s ionale france s e s ono: l’attuazione de l proce s s o di r iforma che ha s ancito l’introduzione de l pr incipio di de ce ntrame nto e che ha confe r ito alle re gioni una s e mpre cre s ce nte re s pons abilità a live llo di formazione ; l’ins e r ime nto di una dime ns ione e urope a ne lle politiche di formazione profe s s ionale ; la te nde nza a favor ire proce s s i di individualizzazione de i pe rcors i formativi. I pr incipali pe rcors i di formazione profe s s ionale iniziale non s colas tica s ono: l’appre ndis tato; i cors i in alte rnanza e i cre diti formativi individualizzati. Si può dire , dunque , che l’ordiname nto france s e è cos truito s u una s e r ie di pas s aggi formativi ad incas tro, che de te rminano una re te di pe rcors i pos s ibili. Dal 1989 il s is te ma france s e ha inte ns ificato la s ua politica di autonomia de lle is tituzioni formative , ar r ivando a conce pire un contratto di 4 anni tra Stato e is tituzioni in cui que s te s i impe gnano ad e laborare un piano di s viluppo che coincida con gli obie ttivi nazionali e le e s ige nze formative locali. Una tale autonomia compor ta un e fficace s is te ma di valutazione inte rna da par te de gli is tituti, pe r mis urare l’e fficacia de ll’ins e gname nto, e una e s te rna che vie ne e s pre s s a dal CNE (Comité national d’e v aluation), organis mo autonomo formato da e s pe r ti che e s aminano la qualità de i curr icula e de lle attività s volte , con un giudizio globale s ulle s trutture e non s ugli individui. Un fe nome no non tras curabile è il s ucce s s o de llo ST S (Se ction de T e chnicie ns Supérie urs ), di tipo pos t- s e condar io e molto s pe cialis tico (de lla durata di due anni) s ce lto da più de l 25% de gli s tude nti. Gli IUT e gli ST S trovano s bocchi imme diati ne l mondo de l lavoro. Il 90% è impie gato mas s imo dopo un anno. Il gove rno france s e inte nde adattare la formazione te cnico- profe s s ionale ai bis ogni de ll’e conomia e is cr ive r la ne lle dinamiche e conomiche locali e inte rnazionali a ttrave rs o la progre s s iva s os tituzione de l DEUST con lo IUP, che por ta a 3 anni la formazione te cnico-profe s s ionale de lla filie ra unive rs itar ia dopo un anno di or ie ntame nto prope de utico, e l’incre me nto de gli IUT . In Francia i dis pos itivi di formazione in alte rnanza s ono de finiti e re golati dal codice de l lavoro e pos s ono e s s e re clas s ificati a s e conda de llo s tatuto contrattuale de l be ne ficiar io (contratto di tirocinio, di qualificazione , di or ie ntame nto, di adattame nto); c ias cuno di ta li contratti pre ve de una formazione , di durata var iabile , ne l pe r iodo di lavoro e l’as s is te nza al giovane da par te di un tutore . Inghilte rra.
153 153
Le bas i de l s is te ma formativo br itannico r is algono all’Educational Act (1944). In que s to s is te ma, la pr incipale re s pons abilità pe r la formazione profe s s ionale s pe tta ai dator i di lavoro, me ntre lo Stato ha cre ato de gli organis mi, quali: l’I.T .B. (Indus try T raining Board, 1964), pe r la promozione de lla formazione ne l s e ttore indus tr iale ; l’M.S.C. (Manpow e r Se rv ice s Commis s ion, 1973), con compe te nze amminis trative e di s timolo ne i s e ttor i in cui l’IT B non è ins e r ito. E’ pos s ibile dis tingue re due canali di formazione profe s s ionale : l’appre ndis tato con fre que nza giornalie ra o s e rale in ce ntr i di formazione ; o i cors i inte grati (a te mpo pie no, di s tudio e di e s pe r ie nze pratico- ope rative ). Il fondame nto giur idico de ll’ordiname nto s colas tico149 e de l s is te ma de lla formazione profe s s ionale è cos tituito dalla Le gge di Riforma de ll’Is truzione ERA (Education Re form Act), approvata ne l 1988, che as s e gna più ampi pote r i de cis ionali a l DES (De parte me nt of Education and Scie nce ), e limita l’autonomia ge s tionale de lle LEAs , favore ndo la re s pons abilizzazione de lle s ingole s cuole .150
149 Il sistema scolastico inglese è caratterizzato da importanti differenze a livello regionale poiché le Local Education Authorities (LEAs) dispongono di un ampio raggio d’azione. Il sistema educativo ha una valenza decisamente decentrata: le competenze sono divise tra il governo centrale e le autorità locali. In Inghilterra ci sono tre livelli di istruzione: primary, secondary, further; quest’ultima comprende tutta l’istruzione oltre l’obbligo, compresa la formazione iniziale. La scolarità obbligatoria riguarda i ragazzi da 5 a 16 anni: la scuola primaria impegna gli alunni fino ad 11 anni, quella secondaria inferiore riguarda, invece, i ragazzi da 11 a 16 anni. La maggioranza degli allievi frequenta le Comprehensive School: scuole polivalenti che danno una formazione generale comune. Al termine della scuola secondaria inferiore, si svolge un esame esterno per conseguire il General Certificate of Secondary Education (GCSE). Al compimento del sedicesimo anno d’età, al termine, cioè, della scuola secondaria inferiore, é proposto un certo numero di opzioni per il proseguimento degli studi o della formazione fino a 18 anni. I giovani possono proseguire gli studi nella propria scuola secondaria, iscriversi a delle scuole professionali in vigore a livello regionale, scegliere percorsi professionalizzanti nell’ambito della Further Education (istruzione a tempo pieno o parziale per i soggetti che hanno concluso la scuola obbligatoria) (Deutsches Institut fur Internazionale Pedagogische Forschung, 1996). Per quanto attiene invece al sistema universitario bisogna dire che la Gran Bretagna ha abbandonato nel 1992 il sistema binario per il sistema universitario Polythecnics e Colleges, erogatori dell’offerta tecnico-professionale, al fine di aumentare la competitività tra le strutture terziarie e la qualità delle prestazioni. Questi istituti definiti new universities hanno mantenuto la loro autonomia e forniscono i titoli undergraduated della durata di due anni o di tre anni, che conducono al titolo di primo ciclo di bachelor. Le new universities offrono un’ampia gamma di corsi e di soluzioni di frequenza, a tempo pieno, o parziale, corsi sandwich con alternanza di periodi di lavoro e di studio. Come le old universities (le università tradizionali), le new rientrano nel capillare sistema di valutazione per ottenere il finanziamento basato: produttività, qualità dei curricula attivati e andamento della didattica. Tale sistema di valutazione prevede una fase interna, a cura dell’istituto ed una esterna. Questa seconda fase si articola in un controllo compiuto da un’agenzia autonoma della Conferenza dei Rettori e nella valutazione sulle strutture e sui docenti, da parte dello Higher EducationFunding Council, che eroga i fondi governativi dell’università. Il piano di studi ha un impianto modulare per consentire agli studenti di scegliere e combinare le unità didattiche a vantaggio della flessibilità e della possibilità di cambiamento del percorso formativo. Il sistema dei crediti, è molto sviluppato nelle old e nelle new universities, questi vengono accumulati sia per le cognizioni acquisite che per l’esperienza professionale svolta, e assicurano allo studente una sorta di capitale formativo che può essere speso tanto all’interno del corso quanto per la ripresa degli studi interrotti. La trasparenza deve essere alla base di questo sistema formativo, sia i candidati che i valutatori devono avere piena consapevolezza dei percorsi svolti e delle competenze acquisite al fine di garantire la flessibilità del percorso. A tal proposito una delle principali difficoltà incontrate è stata la necessità di bilanciare l’assoluta uniformità degli standard con la flessibilità nella valutazione la quale avviene presso centri di valutazione riconosciuti e posti sotto il controllo di qualità dell’ awarding body responsabile. Questi centri sono, solitamente, istituti di istruzione, di formazione, imprese. Per assicurare una maggiore trasparenza ed un alto grado di uniformità nella prassi seguita dagli awarding bodies, “è stato concluso un accordo con i principali awarding bodies che regola la terminologia, i termini della certificazione, il ruolo ed i criteri di riconoscimento per i centri di valutazione” (Studio Meta e Associati, 1996, p. 59). 150 Nello specifico gli obiettivi di tale riforma possono essere così sintetizzati: rafforzare il potere del Dipartimento dell’Educazione; garantire una maggiore autonomia alle singole istituzioni scolastiche; ridurre le funzioni delle LEA (Local Educational Authorities); contestuale introduzione di un piano di studi nazionale (core curriculum), che copre il 70% dell’orario scolastico; istituzione di un nuovo organismo di valutazione ed esami (School Examinations Assessments Council); rafforzamento del ruolo degli Ispettori che operano una vigilanza molto stretta sull’applicazione della normativa relativa al curriculum; riconoscimento di una maggiore partecipazione alle parti sociali e alle famiglie al governo della scuola.
154 154
Pe r quanto r iguarda il ve rs ante de lla formazione profe s s ionale , un as pe tto di fondame ntale impor tanza è rappre s e ntato dalla r iforma de l s is te ma de lle qualifiche profe s s ionali, che ha por tato alla cre azione de l National Council of V ocational Qualifications , (NCVQ) de l 1986. La NCVQ cons is te in un atte s tato di compe te nza profe s s ionale , as s e gnato da un e nte formalme nte r iconos ciuto e chiarame nte pe r tine nte ad un lavoro allo s copo di facilitare l’acce s s o o la car r ie ra di un individuo ne l mondo de l lavoro e de lla formazione profe s s ionale . La s te s s a Formazione profe s s ionale ha conos ciuto, a par tire dalla me tà de gli anni ’80, una profonda r ivis itazione . Lo Stato che ave va comple tame nte de le gato alle impre s e o is tituti pr ivati que s to s e ttore de lla formazione ha r ite nuto oppor tuno, a fronte de lla cre s ce nte dis occupazione , in s pe cial modo giovanile , e de ll’as s e nza di una qualificazione ade guata alle re ali e s ige nze de lla produzione , varare una s e r ie di inte rve nti. Ne l 1986 è s tato is tituito il NCVQ, allo s copo di inte rve nire ne l s e ttore de lla formazione profe s s ionale r ite nuta ormai obs ole ta , incoe re nte e bis ognos a di razionalizzazione e maggiore tras pare nza. Il s is te ma e ra caratte r izzato da una s or ta di giungla de lle qualifiche poiché mancava un quadro nazionale di r ife r ime nto. In vir tù di c iò, s i as s is te va alla non tras fe r ibilità de lle compe te nze acquis ite , a lla s valutazione de i pe rcors i profe s s ionali r is pe tto a que lli accade mici, a un’e cce s s iva s pe cificità de lle compe te nze . Il compito di que s to organis mo non è que llo di r ilas ciare ce r tificazioni, le quali, pe r lunga tradizione , s ono e rogate dagli aw arding bodie s (organis mi autonomi cos tituiti da organizzazioni profe s s ionali o e s pre s s ioni de ll’indus tr ia), ma pe r garantire il r is pe tto di de te rminati s tandard. Le ce r tificazioni r ilas ciate da organizzazioni profe s s ionali, dunque , pos s ono e s s e re o non e s s e re r iconos ciute , in vir tù di que s ti s tandard di tras pare nza, fle s s ibilità, tras fe r ibilità. Accanto al tradizionale pe rcors o s colas tico i giovani oggi pos s ono optare pe r : a) le qualifiche NVQ (National V ocational Qualifications ), ar ticolate in 5 live lli, pe r le quali ve ngono valutati i r is ultati de lla formazione me ntre il modo, il te mpo e il luogo non hanno impor tanza; b) e le qualifiche GNVQ (Ge ne ral National V ocational Qualifications ) is tituite ne l 1992 e ar ticolate s u 3 live lli: iniziale , me dio, avanzato. T ali qualifiche s i cons e guono ne l s is te ma e ducativo a te mpo pie no e s ono s tate introdotte pe r i giovani in re gola con l’obbligo s colas tico (16 anni) pe r offr ire un’alte rnativa alle qualifiche profe s s ionali tradizionali e una pre parazione e le vata non mirata ad un lavoro s pe cifico. In que s ti pe rcors i s ono ins e r ite de lle unità di formazione ge ne rale (core s k ills ) obbligator ie , pe r qualunque are a profe s s ionale , a l fine di r ie quilibrare il rappor to tra formazione ge ne rale e formazione profe s s ionale , compe te nze di bas e e compe te nze te cnico- s e pcialis tiche (Forghie r i, 1994).
155 155
General education countries : Spagna
Gianfranco Re s calli è , tra gli s tudios i ita liani, que llo che maggiorme nte s i è occupato, a ttrave rs o un inte re s s ante s tudio comparativo pre s e ntato ne l libro “Il cambiame nto ne i s is te mi e ducativ i” (1995) di r icos truire il proce s s o di r iforma s pagnolo. L’autore me tte in e vide nza che , s e ppure l’inte rve nto le gis lativo che r iordina comple tame nte l’as s e tto e ducativo s pagnolo è de l 1990, il proce s s o di r iforma ha avuto inizio con la Le gge ge ne rale di r iforma de l 1970 (Le y Ge ne ral de Educatiòn) tras formando in un bre ve arco di te mpo il s is te ma formativo s pagnolo da uno s tato di ar re trate zza ad uno di e cce lle nza.
La le gge de l 1990, infatti, is tituis ce la s cuola unica obbligator ia dai 6 ai 14 anni e d e s te nde l’obbligo s colas tico al s ucce s s ivo bie nnio di formazione profe s s ionale pe r coloro che non pros e guono gli s tudi. Me ntre , la s cuola s e condar ia di s e condo grado, dal 14° al 17° anno di e tà vie ne unificata ne l Bacce llie rato che s i contraddis tingue pe r e s s e re una s cuola for te me nte unitar ia e polivale nte , ar ticolata in mate r ie comuni e d opzionali s ullo s tile de lla Compre he ns iv e School ingle s e . Allo s te s s o te mpo s i is tituis ce un cors o te rminale de lla durata di un anno de nominato: cors o di or ie ntame nto unive rs itar io (COU), allo s copo di favor ire un coe re nte raccordo con gli s tudi s upe r ior i a ttrave rs o l’approfondime nto de lle conos ce nze di bas e e l’or ie ntame nto s pe cifico pe r are e dis ciplinar i. La formazione profe s s ionale vie ne ar ticolata in due cicli bie nnali dal 14 al 18° anno di e tà rappre s e ntando un canale s e parato ma r icco di oppor tunità formative e in line a con le tras formazioni te cnologiche che il pae s e s ta affrontando. Se condo Re s calli la le gge de l 1970 può e s s e re cons ide rata come il s imbolo de l pas s aggio de lla Spagna da pae s e agr icolo a pae s e indus tr iale e come l’inizio di una lunga s tagione di r iforme s e gnate da e ntus ias mo151 .
E’ il par tito PSOE a cape ggiare ta le dibattito - face ndo te s oro de lle cr itic ità e me rs e con gli anni de lla cr is i e s os te nuto da un contagios o e ntus ias mo pe r il nuovo- e pe r que s ta via divie ne por tavoce di una ince s s ante ope ra di r iforma che ne l giro di pochis s imi anni r idis e gna comple tame nte il s is te ma
151 Gli economisti spagnoli sono soliti suddividere questo periodo di rinascita in tre fasi.La fase che va dal 1964 al 1974 è segnata da un forte sviluppo del settore industriale, caratterizzato da un basso contenuto tecnologico e da un’economia di sottoimpiego. In virtù di questo sviluppo anomalo il mercato del lavoro richiede, in questo periodo, per lo più tecnici intermedi e manodopera specializzata. Di qui la pressione sulla scuola secondaria e sulle strutture della formazione professione affinché prestassero un’attenzione maggiore ai più alti livelli di conoscenze teoriche e di addestramento specialistico. La fase dal 1975 al 1985, al contrario, è caratterizzata da una dura crisi economica durante la quale vengono messi in crisi i principi che avevano fondato la precedente riforma (innalzamento dell’obbligo scolastico, scuola unica di base, preparazione ultra-specialistica della F.P.). In questi anni il dibattito sulla riforma che ha caratterizzato la fase precedente si richiude nell’ambito delle associazioni professionali e perde vitalità ed efficacia. Infine, la fase che va dal 1986 al 1988 segna una nuova stagione di ottimismo. Il prodotto interno lordo (PIL) torna a salire e questo favorisce la diffusione di un clima positivo che facilita la democratizzazione delle strutture sociali e dell’allargamento della base produttiva. La novità di questi anni è che il nuovo vigore del dibattito sulla scuola non viene più, come nella fase precedente, dalle forze economiche, ma dall’arena politica.
156 156
e ducativo- formativo s pagnolo152 che , a ttualme nte , s i ar ticola in cinque ordini di s cuola:
• 0- 6 anni: e ducazione infantile ;
• 6- 12 anni e ducazione pr imar ia;
• 12- 16 anni: e ducazione s e condar ia obbligator ia;
• 16- 18 anni: bachille rato153 (ar ticolato in 4 canali: s cie nza umane e s ociali, s cie nze de lla natura e de lla s alute , te cnologie , ar te . A 18 anni è pre vis to un cors o di or ie ntame nto unive rs itar io); e formazione profe s s ionale di 2° live llo (non pre ve de la pos s ibilità di pas s are dire ttame nte al 3° live llo);
• Oltre i 18 anni: Unive rs ità e Formazione profe s s ionale di te rzo live llo.
Nonos tante le cr itiche che ve ngono mos s e dagli oppos itor i c i s ono alcuni e le me nti di indubbia s ignificatività in que s ta r iforma che pos s ono e s s e re r ias s unti: ne lla s traordinar ia vitalità di que s to popolo che fino a pochi de ce nni fa è s tato appiattito da un re gime autor itar io; ne lla capacità de l movime nto r iformatore di te ne re il pas s o anche ne i più acuti mome nti di cr is i e conomica; ne ll’innalzame nto de ll’obbligo s colas tico che s i è e ffe ttivame nte re gis trato in que s ti anni; ne ll’accorciame nto de lla fas e te rminale de lla s cuola s e condar ia; ne ll’ins e r ime nto de l s is te ma profe s s ionale ne ll’ambito de l s is te ma e ducativo; ne l colle game nto, s e ppure ancora poco chiaro, con il mondo de l lavoro; ne ll’ar ticolazione di una s truttura unitar ia de gli indir izzi de lla s cuola s e condar ia attrave rs o un mix di mate r ie comuni, opzionali e facoltative s e condo il mode llo de lla compre he ns iv e s chool.154
152 I passi salienti di questa riedificazione possono essere riassunti nel modo seguente: ♦ 1983 riforma universitaria secondo i principi dell’autonomia, della dipartimentalizzazione, della flessibilità dei curricoli, della diversificazione delle specializzazioni e della ricerca. ♦ 1985 Legge organica del diritto all’educazione (LODE) ♦ tra il 1983 e il 1987 vengono sperimentate alcune innovazioni proposte dalle associazioni professionali e dal mondo accademico volte all’unificazione del biennio nella fascia di età 14-16 anni. ♦ Nel 1987 l’allora Ministro dell’educazione (Maraval) avvia un dibattito nazionale su un progetto globale di riforma studiato dal Consiglio educativo centrale. ♦ 1989 pubblicazione e diffusione capillare di un libro bianco che illustra le deficienze del sistema formativo e illustra le necessità della riforma. ♦ Nel Febbraio 1990 il nuovo Ministro dell’educazione (Solana) sintetizza i risultati del dibattito nazionale e delle sperimentazioni sottoponendo un nuovo progetto al parere tecnico del Consiglio nazionale dell’educazione. Nonostante le critiche della Conferenza dei Vescovi, il Parlamento nel mese di settembre approva il progetto a grande maggioranza (297 voti a favore, 89 contrari, 3 astenuti) e in ottobre è già operativo in termini di legge. 153 Il bachilerato incorpora elementi di istruzione tecnologica e rappresenta il primo livello della formazione professionale. Prevede la possibilità di passare al 3° livello della F.P. e all’università. 154 Per un’attenta considerazione del caso spagnolo si rimanda a: Rescalli, 1995 e 1994.
157 157
Mix ed pathway countries : Olanda, Danimarca, Lussemburgo
Olanda
Già dalla fine de gli anni ’60 l’Olanda pre s e nta una s trate gia s imile a que lla te de s ca pe r quanto conce rne l’appre ndis tato anche s e , ne l cas o s pe cifico, è la s cuola a s volge re il ruolo di colle game nto tra te or ia e pratica s e condo il me todo practicum che pone in e vide nza tutte le difficoltà ine re nti il dialogo fra le dive rs e compone nti de lla formazione de ll’appre ndis ta . In Olanda s ono s tati avviati due proge tti di tras formazione de l rappor to formazione - lavoro, par te ndo dall’ins e gname nto tradizionale s i è ce rcato di s uddivide re il programma di lavoro in unità didattiche al fine di armonizzare i te mpi di formazione e lavoro, tutto ciò pe r favor ire il dialogo tra azie nda e ce ntro di formazione . Con il 1979, inoltre , s i è dato vita ad una s e r ie di proge tti pilota pe r l’ins e gname nto profe s s ionale continuo a te mpo pie no e s otto la dire tta re s pons abilità de l ce ntro formativo. Alla fine de l pe r iodo di formazione s i cons e gue una formazione e quivale nte a que lla de ll’appre ndis tato attrave rs o me todologie di ins e gname nto par te cipato. In que s to s pe cifico cas o, a llo s tude nte vie ne r iconos ciuto uno s tatus di s ogge tto in formazione e la re s pons abilità formativa è dire ttame nte a car ico de lla s cuola e non più congiuntame nte alle impre s e 155 .
Danimarca
La Danimarca dal 1969 ha avviato una s pe r ime ntazione ne lla formazione profe s s ionale ar ticolata s ull’anno di formazione di bas e cui s e gue un s is te ma alte rnato s cuola- azie nda, a ll’inte rno di una s pe cifica s pe cializzazione – da 2 a 4 anni, con un pe r iodo s colas tico che var ia dalle 20 alle 40 s e ttimane , a s e conda de lla qualifica s ce lta . Si può r is contrare , inoltre , uno s tre tto rappor to fra formazione profe s s ionale de gli appre ndis ti e s is te ma formativo globale . In Danimarca vige un s is te ma mis to. L’ins e gname nto s e condar io profe s s ionale ve de il 60% de l te mpo in impre s a. Il giovane , pur mante ne ndo il s uo s tatus di s tude nte , s tipula con l’impre s a un par ticolare tipo di contratto. I pos ti di formazione ne lle s trutture s colas tiche s ono programmati in coe re nza con i pos ti in alte rnanza offe r ti dalle impre s e . Que s to non accade ne lla maggior par te de gli a ltr i pae s i dove s i re gis tra , inve ce , un’e cce de nza di s tude nti e una note vole difficoltà a re pe r ire azie nde dis ponibili pe r copr ire il nume ro de gli s tage s . E’ pos s ibile os s e rvare , tuttavia, che ovunque e s is te una tradizione di “alte rnanza” come e le me nto s trutturante de l pe rcors o formativo le s cuole godono di una note vole autonomia ge s tionale .
155 In Francia, Olanda e Gran Bretagna, l’apprendistato rappresenta una delle possibili modalità per acquisire una qualifica professionale e in tutti e tre i Paesi costituisce un titolo valido per il rientro nel sistema di istruzione anche se sono pochi coloro che usufruiscono di questa possibilità.
158 158
Lus s e mburgo
Pe r pe rve nire alla qualifica profe s s ionale in Lus s e mburgo è pos s ibile acce de re a due dive rs i canali: il pr imo, de nominato ciclo bre v e , pre ve de un pe r iodo di appre ndis tato di 6 me s i o di un anno e d è a te mpo pie no; il s e condo, de finito ciclo lungo , è a te mpo parziale e pre ve de l’alte rnanza de lla pratica azie ndale con la formazione , pre vio controllo s ulla formazione r ice vuta in impre s a. Ne l 1979 è s tata avviata anche un forma di appre ndis tato me dio , a re gime profe s s ionale , che pre ve de cors i inte grativi a ll’inte rno di is tituti te cnici. Succe s s ivame nte , inve ce , è s tata introdotta un’ulte r iore via: que lla de lla formazione profe s s ionale inte grativa tr ie nnale , concomitante alla formazione pratica ne l lavoro; e que lla a re gime mis to che pe rme tte di us ufruire di pe r iodi a te mpo pie no ne lla formazione e xtra-azie ndale s ommati a i normali cors i inte grativi.
La v ia italiana Lo s tudio de ll’OECD ins e r is ce l’Ita lia ne l gruppo di pae s i de finiti School-bas e d v ocational countrie s . Ne gli ultimi cinque anni, ne l nos tro pae s e , dopo de ce nni di immobilis mo, s i è dato inizio ad un cambiame nto impone nte e vor ticos o, anche s e ancora lontano dal dirs i conclus o. Se nza dubbio l’inte nzione de l le gis latore ha dimos trato ne i fatti, oltre che ne gli inte nti, la volontà di r idis e gnare l’inte ro e ducation s y s te m a l fine di re cupe rare il gap ne i confronti de i pae s i più avanzati e migliorare la pos izione compe titiva ne l me rcato globale . T ale proce s s o di ammode rname nto pre nde le mos s e dalla Le gge 196/97, volta a de finire : la r iforma de ll’appre ndis tato, introduce ndo l’obbligo di formazione e s te rna pe r le impre s e (ar t. 16); s is te matizzare e promuove re i tirocini di formazione e di or ie ntame nto (ar t 18); e avviare la r iforma de i Ce ntr i di Formazione profe s s ionale (ar t. 15).
A comple tame nto di que s to impone nte proce s s o di r iforma s ono s e guiti nume ros i a ltr i provve dime nti come in una s or ta di puzz le che , via via , s i è ce rcato di cos truire 156 . T uttavia , ta le tras formazione non può e s s e re
156 Provvedimenti correlati: D.lvo 112/98, che ha ridisegnato le competenze di Stato e Regioni sia in merito alla formazione professionale che in merito all’istruzione, autonomia scolastica, elevamento dell’obbligo scolastico a 18 anni, introduzione della FIS con la quale sono stati avviati anche gli IFTS (Istruzione e formazione tecnica superiore), riforma universitaria con l’introduzione del 3+2, riforma dei cicli scolastici, con l’introduzione delle passerelle (sia in orizzontale che in verticale) con il vantaggio di restituire nuova vitalità alla formazione professionale che in questo modo non costituirebbe più un vicolo cieco ma consentirebbe, come avviene in Germania, di proseguire fino alla IFTS, riforma dell’assetto centrale e periferico dell’amministrazione scolastica con lo smantellamento dei provveditorati e la costituzione delle Direzioni Regionali, decollo della formazione continua su spinta delle indicazioni che ci pervengono dalla Comunità Europea e che prevede l’introduzione dei voucher individuali e dei congedi formativi, accordi Stato-Regioni per quanto attiene alla certificazione dei risultati, all’accreditamento delle sedi
159 159
cons ide rata che in s tre tta re lazione con un proce s s o di r iforma ancora più comple s s o quale que llo pe r il de ce ntrame nto. T ralas ciando tutto il dibattito s ugli e ffe tti e i proble mi che può compor tare un de ce ntrame nto che avvie ne pe r via ce ntralizzata è ne ce s s ar io r icordare che un’e voluzione di que s to tipo implica la ne ce s s ita di: r is trutturare inte rame nte gli apparati amminis trativi; favor ire una inte ns a capacità di raccordo tra i dive rs i live lli (Ce ntro, Re gioni, province , comuni); individuare de gli s tandard nazionali che conte ngano il r is chio di un ulte r iore divar io tra Nord e Sud. Da ciò de r iva un cambiame nto radicale che i s is te mi e ducativo- formativo e produttivo s ono chiamati ad affrontare ne l me dio- lungo pe r iodo congiuntame nte a tutti gli as pe tti proble matici da ge s tire lungo il cammino.
Re lativame nte agli s pe tti proble matici, è pos s ibile e vide nziare un ce r to r itardo r is pe tto all’Europa pe r quanto r iguarda: il live llo comple s s ivo di is truzione raggiunto; il bas s o grado di e fficie nza e d e fficacia de l s is te ma s colas tico – ci s i r ife r is ce all’alto tas s o di abbandoni ne lla s cuola me dia s upe r iore e ne ll’unive rs ità ove s i re gis tra anche un alto tas s o di fuor i cors o; le dis par ità te r r itor iali, di ge ne re e di c las s e s ociale che ancora non s ono s tate de be llate ; la difficoltà ad as s orbire pe rs onale qualificato da par te de lle piccole e me die impre s e . Vi s ono, tuttavia , anche as pe tti pos itivi da r icordare , tra i quali: la s os te nuta domanda di formazione e qualificazione ; la domanda di formazione pe rmane nte ; l’impe gno manife s tato in que s ti ultimi anni dal le gis latore ; il s os te gno culturale e d e conomico de lla Comunità e urope a (Be s ozzi, 1998).
Ci troviamo ne l pie no di un pe r iodo di trans izione che , da una par te , las cia intrave de re i re s idui de l ve cchio s is te ma e , dall’altra , il de line ars i di nuove pros pe ttive . T utti que s ti inte rve nti as pirano a de finire l’inte grazione de i s is te mi formativo- e ducativo- produttivo, s tor icame nte lontani e auto-re fe re nziali, s ulla bas e de ll’opinione , ormai da tutti condivis a, s e condo la quale pe r as s ume re una cittadinanza attiva ne lla nuova s ocie tà de ll’informazione e de lla conos ce nza è ne ce s s ar ia la re alizzazione di una e ducazione pe rmane nte che cons e nta alle pe rs one di e ntrare e us cire dai dive rs i s is te mi formativo- produttivo in modo da favor ire age voli r icollocazioni s ul me rcato de l lavoro, avanzame nti di car r ie ra, progre s s o individuale e comunitar io e cc.. Come e vide nziato dal Rappor to ISFOL de l 2000 tale proce s s o di r innovame nto s i trova ora ne lla fas e più de licata , que lla de ll’imple me ntazione . Me tte re mano ad una innovazione cos ì impor tante , infatti, pre ve de un note vole s forzo di ade guame nto da par te di tutte le s trutture coinvolte . La s comme s s a non è que lla di ve r ificare il
formative, accordi ed il Regolamento sull’obbligo formativo che ridefiniscono i rapporti tra scuole e centri di formazione professionale e servizi per l’impiego, riforma dei servizi per l’impiego che dovranno trasformarsi il reali agenzie capaci sostenere attivamente i processi di ingresso nel mondo del lavoro.
160 160
r is pe tto de lle re gole e de lle proce dure , be ns ì di favor ire l’e ffe ttiva capacità de l te r r itor io di re alizzare quanto pre vis to dal nuovo s is te ma formativo. 157 Que s to cambiame nto chiama in caus a tutte le compone nti is tituzionali e non, dai Minis te r i de l Lavoro e de lla Pubblica Is truzione , a lle Re gioni, Province , Comuni e s e rvizi te r r itor iali pe r l’impie go. Dire ttame nte coinvolte s ono anche le Par ti s ociali che , in vir tù de l nuovo s tile ne goziale s ono chiamate a dive nire co- attor i de l proce s s o, s oprattutto ne lla dime ns ione locale . Anche dalla loro capacità di a ttivare re ti a live llo micro dipe nde il s ucce s s o di que s to nuovo impianto volto all’inte grazione tra s is te ma e conomico e s is te mi formativi. T uttavia , un ruolo impor tante continua a s volge r lo la Comunità e urope a non s olo in te rmini di indir izzo ma anche in te rmini di s os te gno e conomico attrave rs o il FSE. Anche s e il nos tro pae s e de ve ovviare ad una dis tors ione ve r ificatas i ne gli ultimi anni: que lla di r idurre le r is ors e nazionali e re gionali pe r la formazione profe s s ionale a favore di que lle a bando FSE con e s iti ne gativi pe r il me rcato de l lavoro. Da quanto e me rge , dunque , è ne ce s s ar io re cupe rare un ce r to s e ns o di re s pons abilità, a tutti i live lli e d in tutti i s e ttor i, pe r r ipe ns are l’inte ra offe r ta formativa.
Il nuovo impulso dato dalla riforma: uno sguardo ai dati nazionali 158
Da un’analis i de ll’e voluzione de ll’is tituto de ll’appre ndis tato ne i 40 anni che vanno dal 1955 al 1998 s i e vide nzia un andame nto cre s ce nte fino ai pr imi anni ’70, una ce r ta s tabilità fino ai pr imi anni ’80, pe r poi re gis trare un tre nd cos tante me nte ne gativo fino alle modifiche introdotte con la le gge 196/97. Su que s to calo hanno incis o fattor i di dive rs a natura (e conomici, normativi, s ociologici e de mografici). In par ticolare , in que s ti anni, s i è re gis trata un’impor tante diminuzione de l nume ro de i contratti di appre ndis tato ne lle azie nde ar tigiane , ove tale is tituto è s e mpre s tato il tradizionale s trume nto di ingre s s o al lavoro.
Come s i può os s e rvare dal grafico s ottos tante (grafico n. 1), il 1998 s e gna l’anno de lla s volta con una ne tta r ipre s a de i contratti di appre ndis tato. A giovare de lla r iforma s ono s tate propr io le impre s e ar tigiane , è tra que s te , infatti, che s i re gis tra la maggiore diffus ione (tab. 1 in appe ndice ). Il motivo di que s to cambiame nto è da le gge rs i ne l s upe rame nto di a lcune r igidità normative ins ite ne lla pre ce de nte le gge 25 de l 1955 e le gate , pre vale nte me nte , a l limite di e tà e al titolo di s tudio. L’Unione Europe a ha
157 Per fare ciò è necessario: monitorare lo sviluppo dei processi sul territorio; creare collegamenti e reti a livello centrale e periferico tra tutti coloro che a vario titolo sono inseriti in questo processo di riforma; predisporre strumenti di sostegno per l’attuazione di tale innovazione; verificare i risultati conseguiti, diffondere le migliori prassi, sostenere le aree di debolezza e favorire quelle di eccellenza. 158 In dati in base ai quali sono state fatte queste analisi provengono dai già citati rapporti ISFOL sull’apprendistato.
161 161
avanzato de lle for ti cr itiche all’Ita lia r iguardo la pre s e nza di contratti di lavoro a caus a mis ta in concorre nza tra loro. In vir tù di c iò, s i de line a l’ipote s i di e s te nde re l’is tituto de ll’appre ndis tato ai giovani fino a 25 anni di e tà. E’ pos s ibile ipotizzare , tra le altre cos e , che con la nuova r iforma Biagi, che modifica radicalme nte il contratto di formazione lavoro, l’is tituto de ll’appre ndis tato conos ca un’ulte r iore cre s cita .
Gra f ic o n . 1 : P a ra bo la c o ntra t to a ppre ndis ta to da l 1 9 8 0 a l 1 9 9 8
1980
736140
1985
547023
1990
529741
1995
418233
1996
413892
1997
393138
1998
422664
0100000200000300000400000500000600000700000800000
1 2 3 4 5 6 7
Parabola contratto apprendistato dal 1980 al 1998 (v.a.)
Fonte : nos tra e laborazione s u da ti ISFOL
Il grafico s e gue nte , inve ce (grafico n. 2), me tte in e vide nza come l’aume nto de l nume ro di appre ndis ti dal 1997 al 1999 ha r iguardato, s e ppure con un dive rs o tas s o di incre me nto, tutte le re gioni ita liane , compre s o il s ud dove e s is te una minore conve nie nza e conomica de ll’appre ndis tato a caus a de lla for te concorre nza de i CFL che impone minor i vincoli normativi. Le re gioni che de te ngono il maggior nume ro di appre ndis ti, in valor i as s oluti, s ono que lle contras s e gnate da un me rcato de l lavoro molto vivace : Lombardia, Ve ne to, T os cana Emilia Romagna e Pie monte ; me ntre , tra le re gioni de l Sud il pr imato s pe tta alla Puglia (tab. 2 in appe ndice ). Gra f ic o n . 2 : Dis tribuz io ne re g io na le a ppre ndis t i da l 1 9 9 7 a l 1 9 9 9
162 162
Distribuzione regionale apprendisti dal 1997 al 1999 (v.a.)
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000
Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Molise
Abruzzo
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
1999*19981997
Fonte : nos tra e laborazione s u da ti ISFOL Ne l grafico che s e gue (grafico n. 3) è pos s ibile r ile vare la cre s cita de l r icors o a tale is tituto anche da par te di impre s e tradizionalme nte e s clus e . Infatti, a s e guito de lla r iforma, l’appre ndis tato, da s e mpre s trume nto pr ivile giato di acce s s o ne l s e ttore de ll’ar tigianato, s i s ta diffonde ndo ne lle impre s e non ar tigiane , grazie al fatto che la re vis ione de lla Le gge 25/55 ne e s te nde l’utilizzo ad azie nde di maggior i dime ns ioni (tab. 3 in appe ndice ). I rami di a ttività e conomica maggiorme nte inte re s s ati, in te rmini as s oluti, r is ultano e s s e re : le indus tr ie manifattur ie re con 219.672 appre ndis ti; il s e ttore de l comme rcio e de l tur is mo con 107.994 appre ndis ti; e , infine , il s e ttore de lle cos truzioni e d ins tallazioni di impianti con 54.632 giovani as s unti.
Gra f ic o n . 3 : Ripa rt iz io ne a ppre ndis t i pe r t ipo lo g ia d i impre s a da l 1 9 9 6 a l 1 9 9 9
163 163
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
1995 1996 1997 1998 1999
Ripartizione apprendisti per tipologia di impresa dal 1996 al 1999 (v.a.)
Aziende artigiane
Aziende nonartigiane
Fonte : nos tra e laborazione s u da ti ISFOL E’ ipor tante r icordare , inoltre , che s i ipotizza la pos s ibilità di un trattame nto dive rs ificato pe r gli appre ndis ti in obbligo formativo e que lli e s clus i dall’obbligo, a l fine di re nde re più appe tibile , pe r gli impre nditor i, l’as s unzione di giovani attrave rs o que s to contratto che r is chia di s compar ire a caus a de lla concorre nza di altre tipologie più conve nie nti pe r l’azie nda (par t- time , te mpo de te rminato, job- s haring , e cc.) poiché s vincolate dalla formazione e s te rna. Ris pe tto alle s pe r ime ntazioni nazionali approvate dal Minis te ro de l Lavoro, e co- finanziate con i fondi comunitar i, come s i e vince dal grafico s e gue nte (grafico n. 4) il proge tto de ll’ar tigianato ha as s unto un pe s o pe rce ntuale s e ns ibilme nte maggiore r is pe tto alle pre vis ioni or iginar ie e rappre s e nta il più r ile vante in te rmini di nume ro di cors i da re alizzare : 501, di cui 411 al Ce ntro- Nord e 90 al Sud; e di appre ndis ti da coinvolge re : oltre 10.000 s u tutto il te r r itor io nazionale (tab. 4 in appe ndice ).
Gra f ic o n . 4 : Appre ndis t i pre v is t i e ins c rit t i ne l le prime s pe rime nta z io ni na z io na l i
164 164
Apprendisti previsti e inscritti nelle prime sperimentazioni nazionali (v.a.)
5112
1692
3654
2025
10020
1884
Metalmeccanica
Edilizia
Turismo
Pmi
artigianato
Tessile
Fonte : nos tra e laborazione s u da ti ISFOL
Pur toppo il monitoraggio ISFOL de l 2000, ha me s s o in e vide nza anche una cr itic ità molto impor tante , que lla re lativa agli abbandoni. Come e me rge dal grafico s ucce s s ivo (grafico n. 5) tutti i s e ttor i di produzione fanno re gis trare tas s i di abbandono comple s s ivi molto alti. La pe rce ntuale di abbandono più alta s i ve r ifica ne l cors o de lla pr ima annualità con punte de l 17%, contro il 15,9% de l s e condo anno. Le r ile vazioni e ffe ttuate s ui s e i proge tti s pe r ime ntali ha pe rme s s o di os s e rvare la comple s s ità de ll’offe r ta formativa le gata a que s ta par ticolare tipologia di ute nza, che , in par ticolare in alcuni s e ttor i, s conta una for te s tagionalità: con una punta che tocca addir ittura il 26,1% ne l tur is mo (tab. 5 in appe ndice ). Pe r que s ti motivi, dunque , s i r ive la par ticolarme nte impor tante dis porre ne l più bre ve te mpo pos s ibile di una anagrafe appre ndis ti che cons e nta di gove rnare il dato in te mpo re ale in modo da pre dis porre una offe r ta che , c iclicame nte , s ia in grado di abbracciare tutti i pote nziali ute nti.
Gra f ic o n . 5 : T a s s i d i a bba ndo no
165 165
Metalmeccanica
Edilizia
Turismo
Pmi
Artigianato
Tessile
% abbandono I anno% abbandono II anno0
51015202530 Tassi di abbandono (%)
Fonte : nos tra e laborazione s u da ti ISFOL
Il monitoraggio 2001, inve ce , fornis ce inte re s s anti informazioni s ulla formazione de i tutor azie ndali che oramai s e mbra e ntrata a re gime , s i e vide nzia infatti un picco di a ttività in tutte le re gioni cons ide rate , c iò, e vide nte me nte , dimos tra un’atte nzione cre s ce nte a que s to as pe tto de ll’is tituto. T utte le nuove attività programmate , infatti, pre ve dono alme no gli inte rve nti di 8 ore da te ne rs i a ll’avvio de i pe rcors i pe r gli appre ndis ti. Da tale monitoraggio, tuttavia , e me rge una re altà molto var ie gata s ul te r r itor io nazionale . Re s ta il dubbio, dunque , s u quanto s ia e ffe ttivame nte e fficace que s to e le me nto di congiunzione tra i diffe re nti s ub- s is te mi. Anche s e , ancora una volta , s i de ve ipotizzare una diffe re nza a live llo te r r itor iale , s e ttor iale e dime ns ionale .
Il grafico s ottos tante (grafico n. 6) s inte tizza chiarame nte le te nde nze e me rs e dai dati de l monitoraggio s e condo le informazioni fornite dalle Re gioni s ul nume ro di appre ndis ti occupati (tab. 6 in appe ndice ). La parzialità de lle informazioni confe rma chiarame nte l’impor tanza e , al te mpo s te s s o, la difficoltà di organizzare e ge s tire una anagrafe appre ndis ti che s ia in grado di fornire le ne ce s s ar ie indicazioni pe r la programmazione de ll’offe r ta formativa. Infatti, come è pos s ibibile os s e rvare non tutte le Re gioni s ono in grado di re s tituire l’informazione s ul nume ro di appre ndis ti occupati. Alcune re gioni non s ono addir ittura ne lla condizione di garantire la corre tte zza de ll’informazione circa l’ammontare e ffe ttivo e la r ipar tizione s e ttor iale de gli appre ndis ti pre s e nti s ul te r r itor io. Il Lazio fa par te di que s to gruppo di re gioni e la banca dati, s e ppur già re alizzata , non vie ne ancora imple me ntata . Un altro e le me nto da cons ide rare è il fa tto che pe r il 2002 non s ono pre s e nti i dati re lativi a l Lazio, que s to potre bbe
166 166
e s s e re indicativo de lla fas e di s tas i che s ta attrave rs ando la Re gione ogge tto d’e s ame ne lla me s s a a punto de l s is te ma.
Gra f ic o n . 6 : Appre ndis t i o c c upa t i ne l le v a rie re g io ni i ta l ia ne d is t int i pe r
g e ne re , a nno 2 0 0 1
Apprendisti occupati nelle varie regioni italiane distinti per genere, anno 2001
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000
Valle d’Aosta
P iemonte (a)
Lombardia
Provincia di Bolzano
Provincia di Trento
Veneto (b)
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Toscana ©
Umbria (d)
Marche
Molise
Basilicata
Sardegna
Femmine
MaschiTotale
Fonte: rapporti regionali di monitoraggio (a) e (b) I da ti r ipor ta ti s ono r ife r it i a l 31/12/2000
© Ne l da to non s ono cons ide ra te a lcune Province (d) I da ti s ono r ife r it i a lla s ola Provincia di T e rni
Dai rappor ti di monitoraggio e ffe ttuati fino ad ora r is ulta che s ono s tati coinvolti oltre 58.000 appre ndis ti face ndo re gis trare , dunque , un note vole incre me nto ne l 2001. Se s i cons ide ra che i proge tti s pe r ime ntali e vide nziavano il coinvolgime nto di 20.000 giovani s i può affe rmare che la me s s a a re gime di ta le is tituto, s e ppure faticos ame nte , s ta andando avanti in manie ra de cis a. Come be n e me rge dal grafico s ottos tante (grafico n. 7), le re gioni che più hanno contr ibuito, a lme no in te rmini as s oluti, a que s to r is ultato s ono il Pie monte e l’Emilia Romagna, che hanno pre s o un impe gno inge nte s ull’appre ndis tato anche attrave rs o r is ors e de l FSE. Impor tante , tuttavia, è anche il ruolo s volto dalla Lombardia (che è la re gione con il maggior
167 167
nume ro di appre ndis ti) e dalla T os cana. Pe r le Re gioni de l Nord e , in par te , de l Ce ntro s i può affe rmare che la cos truzione de l s is te ma di formazione pe r l’appre ndis tato proce de a r itmi s e r rati, coinvolge ndo ormai nume ri inge nti di ute nza, s oprattutto s e s i cons ide ra il gap che r is ulta fra appre ndis ti chiamati a par te cipare alle iniziative di formazione e s te rna e que lli utili a lla compos izione de i gruppi clas s e . Se condo molte amminis trazioni, infatti, il rappor to fra i chiamati e gli utili è di c irca 2:1, pe r cui il volume de ll’ute nza e ffe ttivame nte inte rce ttata ne l 2001 potre bbe e s s e re circa doppio.
Grafic o n. 7 : Dis tribuzio ne de g li appre ndis ti ne lle Re g io ni italiane
Fonte: nostra elaborazione su rapporti regionali di monitoraggio Comparando le attività formative re alizzate ne l cors o de l 2001 con que lle programmate ne l 2002 s i e vince un tre nd ancora cre s ce nte s timato attorno ai 72.089 allie vi e 14.164 cors i pre vis ti, contro i 58.332 allie vi formati e 9.985 cors i re alizzati ne l 2001 (tab. n. 1/a , 1/b).
Distribuzione degli apprendisti nelle Regioni italiane
2.411
55.318
94.612
5.488 4.886
73.311
8.913 10.882
30.508
1.601
26.072
1.426 2.060
10.463
Valle d’Aosta Piemonte Lombardia Provincia diBolzano
Provincia diTrento
Veneto FriuliVeneziaGiulia
Liguria Toscana Umbria Marche Molise Basilicata Sardegna
168 168
T a be l la 1 a e 1 b: At t iv ità fo rma t iv e pro g ra mma te 2 0 0 1 e a t t iv ità re a l iz z a te 2 0 0 2
Con il monitoraggio de l 2001 s i è ce rcato di ve r ificare gli inte rve nti pe r l’appre ndis tato attuati a live llo re gionale attrave rs o le r is ors e finanziar ie impe gnate . Lo s copo e ra que llo di dis tingue re la fonte di prove nie nza: r is ors e propr ie , comunitar ie , nazionali e la tipologia di azione s ulla quale s ono s tate impe gnate : a ttività formative o azioni colle gate . Pur troppo, tuttavia , i dati forniti dalle Re gioni s ono incomple ti, di fa tto, le os s e rvazioni che e me rgono s ono provvis or ie e limitate .
Da quanto e me rge , ne l 2001 s ono s tati impe gnati comple s s ivame nte dalle Re gioni 98 milioni di € uro, par i a 190 miliardi di lire , di cui il 70% s olo ne ll’Ita lia Se tte ntr ionale . T utte le Re gioni, tranne il Pie monte , hanno impe gnato r is ors e nazionali che rappre s e ntano il 70% de i fondi di cui è s tata s pe cificata la prove nie nza; s olo s e tte Re gioni hanno aggiunto, a lle r is ors e r ice vute dal live llo ce ntrale , finanziame nti di or igine comunitar ia o propr i. In par ticolare , s olo il Molis e e la Valle d’Aos ta hanno re alizzato un impe gno utilizzando tutte e tre le tipologie di r is ors e . Come s i e vince dal grafico che s e gue (grafico n. 8) l’impe gno di r is ors e propr ie da par te de lle re gioni è ancora minimo e rappre s e nta lo 0,06% de l totale ; è aus picabile che s i tra tti de l pr imo s e gnale di un inve s time nto s is te matico da par te de lle re gioni e , s oprattutto, che s ia de s tinato a cre s ce re .
T ab. n. 1/a – Le attiv ità formative realizzate
ne l corso del 2001
Regione Corsi/Percorsi realizzati nel 2001
Allievi frequentanti 2001
Valle d’Aosta 6 53 Piemonte (a) 677 8.499 Lombardia 529 8.131 Provincia di Bolzano
280 4.576
Provincia di Trento 63 756 Veneto 460 6.000 Friuli V. G. 740 3.347 Liguria 91 1.055 Emilia Romagna 8.800 Toscana 6.635 8.973 Umbria 32 624 Marche 196 3.174 Lazio 73 1.272 Abruzzo 117 2.008 Molise 32 436 Campania (b) 26 318 Basilicata 19 130 Sardegna 9 180 TOTALE 9.985 58.332
(a) Dato in parte stimato per le attività riferite alla Direttiva 2001-2002 (b) Attività genericamente definite “in atto” dalla Regione I dati di alcune Regioni del Sud (Puglia, Calabria e Sicilia) non sono disponibili. Fonte: rapporti regionali di monitoraggio.
T ab. n. 1/b – Le attiv ità formative programmate per il 2002
Regione Corsi programmati 2002 Allievi previsti nel 2002 Valle d’Aosta
56 438
Piemonte 1.130 13.400 Lombardia 1.206 19.142 Provincia di Bolzano
265 4.150
Provincia di Trento
111 1.320
Veneto 1.387 21.800 Friuli V. G.
1.000 5.000
Liguria 167 2.592 Toscana* 8.429 Umbria 2 24 Lazio 400 Abruzzo 117 2.008 Molise 33 Basilicata 180 600 Sardegna 81 1.215 TOTALE 14.164 72.089 Fonte: rapporti regionali di monitoraggio
169 169
Fra le Re gioni ce ntrali, la T os cana e l’Umbria hanno impe gnato r is pe ttivame nte il 10 e d il 19% de lle r is ors e s u azioni colle gate , me ntre non r is ulta alcun impe gno de lle Marche e de l Lazio. Me diame nte le re gioni hanno impe gnato circa € 284 pe r appre ndis ta occupato. Come è pos s ibile os s e rvare , l’impe gno più r ile vante è que llo de lla Provincia di Bolzano che ha s pe s o € 1 .880 pe r ogni appre ndis ta; il dato è tanto più s ignificativo vis ta la cope r tura de l bacino di ute nza. Infatti, pe r le altre re gioni la s pe s a pe r occupato è infe r iore anche pe rché la quota di giovani coinvolti ne lla formazione e s te rna è minore (tab. 7 in appe ndice ). Gra f ic o n . 8 : Dis tribuz io ne re g io na le de l le ris o rs e impe g na te ne l le a t t iv ità
fo rma t iv e e ne l le a t t iv ità c o l le g a te a l l ’a ppre ndis ta to
Distribuzione regionale delle risorse impegnate nelle attivitità formative e nelle attività collegate per l'apprendistato, 2001 (valori in €)
0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000
Valle d’Aosta
Piemonte
Lombardia
Provincia di Bolzano
Provincia di Trento
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Toscana
Umbria (b)
Marche
Lazio
Molise (a)
Abruzzo
Basilicata
Sardegna
Totale delle risorseimpegnate
Risorse impegnate perle attività collegate
Risorse impegnate perle attività di formazione
Fonte : nos tra e laborazione s u da ti ISFOL I rappor ti di monitoraggio s ull’obbligo formativo s olitame nte non s i s offe rmano a illus trare quanto avvie ne a live llo re gionale pe r garantire l’offe r ta formativa ai giovani che s ce lgono di as s olve re l’obbligo s colas tico attrave rs o l’appre ndis tato. T ale mancanza di informazioni può e s s e re s pie gata attrave rs o la molte plicità di a ttor i che concorrono alla re alizzazione di que s to is tituto e , a l conte mpo, indica l’as s e nza di dialogo fra i dive rs i re s pons abili pe r l’attuazione de ll’obbligo formativo. Informazioni più pre cis e s i r intracciano, inve ce , ne ll’ambito de i Rappor ti di monitoraggio de ll’appre ndis tato che cos tituis cono la pr incipale fonte di
170 170
raccolta di informazioni. Come acce nnato, la re golame ntazione de ll’obbligo ha inne s cato un e ffe tto di s os tituzione che ha vis to il rapido r idurs i de i giovani minore nni as s unti con contratto di appre ndis tato, a caus a de lla concorre nza di a ltre tipologie contrattuali me no gravos e pe r l’impre nditore . Se condo le s time INPS pre ce de nti a lla le gge T re u i giovani fino a 20 anni as s unti con contratto di appre ndis tato rappre s e ntavano oltre il 70%. La pr ima indagine Is fol, inve ce , dimos tra che i minor i, con la nuova normativa, cos tituis cono una quota par i a c irca il 25% de i contratti di appre ndis tato con un tre nd in cos tante diminuzione . Bis ogna cons ide rare , tuttavia , che , in molti cas i, gli appre ndis ti in obbligo formativo s ono s tati coinvolti in attività di formazione e s te rna s olo pe r la pr ima tranche di 120 ore di formazione ; ciò s ignifica che l’e rogazione de i moduli aggiuntivi è ancora poco diffus a.
Criticita’ e problemi aperti
In Ita lia il dibattito culturale attorno al te ma de ll’inte grazione , avviatos i agli inizi de gli anni ’80, ha dato vita ad inte re s s anti s pe r ime ntazioni pur in as s e nza di un quadro normativo di re s piro nazionale capace di de finirne confini, compe te nze e re gole . Alcune di que s te e s pe r ie nze , che pos s ono e s s e re cons ide rate alla s tre gua di proge tti pilota , hanno s volto una funzione di catalizzazione de gli e ve nti normativi e cos tituis cono punti di r ife r ime nto e s tre mame nte s ignificativi pe r lo s timolo che hanno dato alla cos truzione di un par te nar iato multiattore . Come è s tato pos s ibile os s e rvare , il dibattito s ul s is te ma inte grato è pas s ato da uno s tato di de bole zza tipica de gli accordi de i pr imi anni ’90 a de lle forme di inte grazione for te che , grazie alla fe rvida attività le gis lativa e di conce r tazione de gli ultimi cinque anni, ha te s o a r idis e gnare l’inte ra archite ttura e a r icondur la all’inte rno di un s is te ma di re gole unitar io. Que s ti c inque anni di a ttuazione , dibattito e monitoraggi hanno me s s o in luce che l’e ntrata a re gime r ichie de ancora te mpi lunghi e che la dime ns ione te r r itor iale as s ume un ruolo cruciale . Lo s tato di a ttuazione , infatti, è caratte r izzato da diffe re nti ve locità s ul te r r itor io nazionale frutto di diffe re nti tradizioni amminis trative e re altà s ocio- e conomiche dalle quali non s i può pre s cinde re 159 . E’ difficile , fors e impos s ibile , trovare un mode llo di conce r tazione che pos s a e s s e re tras fe r ibile da un conte s to all’altro poiché que s to è s tre ttame nte le gato al ruolo che i s ingoli a ttor i is tituzionali, e non, giocano a live llo locale .
159 Per un approfondimento sulle diversità territoriali si rinvia ai citati rapporti di monitoraggio ISFOL.
171 171
I te mpi lunghi ne ce s s ar i pe r la re alizzazione di que s ta r iforma dipe ndono da dive rs i fattor i tra loro corre lati: la difficoltà di de finire una volta pe r s e mpre e ine quivocabilme nte l’ogge tto de lla r iforma in un me rcato convuls o come que llo mode rno; la difficoltà di ge s tire le var ie gate te matiche che in e s s a conve rgono; la ne ce s s ità di cons olidare uno s tile di gove rno fondato s ul dialogo inte r - is tituzionale e non più s ulla s e parate zza amminis trativa, l’inade guate zza de llo s trume nto in rappor to al te rziar io caratte r izzato da s piccata fle s s ibilità. Allo s tato attuale i re ce nti monitoraggi de ll’ISFOL e il dibattito politico-is tituzionale cons e ntono di porre in e vide nza alcuni nodi proble matici, cui è ne ce s s ar io far s e guire un nuovo ade guame nto normativo, al fine di armonizzare quanto finora re alizzato. T ra le cr itic ità de l s is te ma in atto è pos s ibile annove rare : 1. la ne ce s s ità di una politica formativa di indir izzo nazionale che chiar is ca me glio il ruolo di c ias cun s ogge tto coinvolto, le finalità formative , le re s pons abilità politico ge s tionali, le funzioni e le compe te nze de i s ingoli a ttor i. E’ ve ro che la forza de ll’inte grazione s ta ne lla capacità di dialogare a live llo locale ma è anche ve ro che pe rché que s to pos s a avve nire s e nza fr izioni è ne ce s s ar io che vi s ia un’ins ie me s trutturato di re gole de finite e un s is te ma di valutazione in grado di garantire omoge ne ità e tras fe r ibilità s u tutto il te r r itor io nazionale ; 2. da ciò dis ce nde la ne ce s s ità di de finire in manie ra chiara e d univoca gli s tandard formativi, le modalità di ce r tificazione e di r iconos cime nto de i cre diti; 3 . le finalità da as s e gnare al s is te ma formativo; in altr i te rmini, occorre pe ns are ad un s is te ma formativo multiculturale che por ti a s upe rare l’attuale impos tazione ce ntrata s u un mode llo s cuolace ntr ico e che conduca all’affe rmazione di un ve ro mode llo police ntr ico capace di r iconos ce re pie na dignità alle modalità di formazione alte rnative che pos s ono ve nire dalla formazione profe s s ionale o dal mondo de l lavoro. Infatti, il r is chio che s i profila è que llo di ins e r ire ne ll’attuale cr is i pos t- fordis ta che caratte r izza la s ocie tà de lla conos ce nza, una s or ta di mode llo azie ndace ntr ico, dove la s cuola continua ad e s s e re la de pos itar ia de lle te or ie , me ntre l’azie nda re s ta il luogo de lla pratica, de l re ale e de ll’e s pe r ie nza (Chiar i , 2000). Altr i nodi cr itic i r iguardano le fonti di finanziame nto e la formazione de l pe rs onale pre pos to al coordiname nto e alla doce nza pe r que s ta par ticolar is s ima tipologia di ute nza pe r la quale va r ipe ns ato comple tame ne l’approcio e le me todologie di ins e gname nto; s e nza contare , inoltre , i vincoli burocratici e amminis trativi che ancora pe s ano s ul corre tto s volgime nto di un pe rcors o che de ve e s s e re improntato alla mas s ima fle s s ibilità (D’arcange lo, 1998). Oggi, tutti gli ope rator i de lla s cuola, de lla formazione e gli s te s s i impre nditor i s ono d’accordo in modo unanime s u un punto: il s ape re che gli a llie vi de vono pote r acquis ire ne lla s cuola pe r
172 172
e s s e re autonomi e produttivi ne l mondo de l lavoro s i r ias s ume ne l s ape r proge ttare ; e cioè e s s e re in grado di individuare le var iabili e s s e nziali di un proble ma in modo da impos tare una corre tta me todologia pe r r is olve r lo. Que s to accordo di fondo pre s uppone la ne ce s s ità di us cire dal tradizionale s ape re nozionis tico pe r me tte re i giovani ne lla condizione di imparare un me todo di appre ndime nto. Non è chiaro, tuttavia , a ttrave rs o quali s trate gie è pos s ibile re alizzare que s to obie ttivo volto al tras fe r ime nto di compe te nze fondame ntali pe r lo s volgime nto di un ruolo lavorativo ne l mode rno proce s s o di produzione . Bis ogna cons ide rare , inoltre che in Ita lia i dator i di lavoro danno una maggiore impor tanza alla formazione acquis ita s ul lavoro che non a que lla acquis ita ne l s is te ma s colas tico. Le impre s e ita liane pur inve s te ndo ne lla formazione –s ia pure on the job de l propr io pe rs onale - non trovano le modalità pe r rappre s e ntare que s to loro ruolo ne l dibattito politico-is tituzionale , in altre parole , le organizzazioni non s e ne fanno car ico, non lo r ite ngono impor tante . Le par ti dator iali e s pr imono s olo una ge ne r ica r ive ndicazione (in par te gius tificata) di inde nnizzazione de i re lativi one r i. Inde nnizzazione che è s tata loro accordata attrave rs o la normativa che re golame nta l’appre ndis tato. In que s to modo, pe rò, lo Stato ita liano s pe nde due volte pe r la formazione de lla forza lavoro: da una par te , a ttrave rs o gli one r i che s os tie ne pe r il s is te ma s colas tico e re gionale ; e , dall’altra , pe r l’ince ntivazione r iconos ciuta alle impre s e re lativame nte ad appre ndis tato e CFL; da ciò r is ulta una s ovraproduzione di qualificati formali e di fattoI r is ultati de l lavoro di monitoraggio de ll’ISFOL s ono in grado di por tare alla luce tutta una s e r ie di proble matiche conne s s e alla modalità di e rogazione che in que s ta s e de ve ngono pre s e ntati bre ve me nte r imandando ai te s ti inte grali.
Le cr itic ità più r icorre nti e me rs e da que s to lavoro di r ice rca, e che pe s ano s ul buon e s ito de lla formazione e s te rna, r iguardano pr imo fra tutti la for te framme ntazione te r r itor iale che s i concre tizza pe r molti appre ndis ti ne lla difficoltà a raggiunge re la s e de de l cors o. La difficoltà di raggruppare te r r itor ialme nte e s e ttor ialme nte un cons is te nte nume ro di appre ndis ti, inoltre , cos tr inge a cre are gruppi e te roge ne i. Ma, ta le e te roge ne ità s i r ive rs a pe s ante me nte s ulla ge s tione de ll’aula. Non s olo è dive rs a la profe s s ione di r ife r ime nto de i s ingoli appre ndis ti e quanto fanno in azie nda ma anche le loro motivazioni, as pe ttative , e s pe r ie nze pre gre s s e e cc.. T ali proble matiche , s pe s s o, re ndono molto difficile l’attuazione de lle dive rs e fas i de l proce s s o di appre ndime nto. Pe r que s to motivo, s i s e nte l’e s ige nza di comporre gruppi più omoge ne i s ui quali e ffe ttuare l’inte rve nto formativo in modo da garantire una maggiore coe re nza e favor ire una più alta motivazione e par te cipazione . Se l’appre ndis ta trova inutile la formazione e s te rna o non è inte re s s ato ai s uoi conte nuti, l’ins oddis fazione e il r is chio di abbandono aume ntano. Al conte mpo, l’azie nda che già vive con s acr ific io
173 173
l’as s e nza di una r is ors a umana, s pe cie s e s i tratta di una piccola re altà produttiva, te nde ad opporre re s is te nze o, comunque , a non cons ide rare pos itivame nte l’impe gno formativo e s te rno. Il ve ro proble ma non è che gli impre nditor i s ono contrar i a lla formazione e s te rna tout cour, ma che tale formazione de ve e s s e re e fficace e coe re nte all’attività lavorativa –come avvie ne , ad e s e mpio, ne l s is te ma duale te de s co. T ra le altre cr itic ità, tuttora ir r is olte , s i pos s ono altre s ì r icordare : il pe s o de i proble mi inte rni a ll’azie nda in te rmini di r itardi de lla produzione ; la difficoltà a conciliare l’attività formativa con le e s ige nze de ll’azie nda (la modalità di fruizione pre fe r ita dalla maggioranza è , comunque , l’alte rnanza tra mome nto te or ico- ope rativo); la ne ce s s ità di e ffe ttuare un’analis i de lle compe te nze in e ntrata che non de ve as s olutame nte e s s e re pe rce pita come una prova; la cre azione di banche dati re gionali con l’individuazione de l live llo di imputazione de l dato e di ge s tione de ll’informazione 160 ; la ne ce s s ità di s upe rare la s pe r ime ntazione allargando le e s pe r ie nze e s ocializzando le pratiche miglior i; la ne ce s s ità di garantire un’as s is te nza te cnica re gionale (in tutte le re gioni) e magar i la pre s e nza di s trutture di coordiname nto inte rme dio (che in par te già e s is tono, s i pe ns i, ad e s e mpio, a lle Age nzie re gionali de l lavoro o alle Age nzie di s viluppo locale ) che s uppor ti la cre azione de lla re te , ma, al conte mpo, anche un’as s is te nza te cnica alle re gioni che s ono r imas te più indie tro ne l proce s s o di imple me ntazione .
160 La questione è strettamente connessa alle singole realtà regionali e al livello di delega raggiunto. In alcune Regioni questo problema è stato risolto con la delega alle Province. Dove questo non è ancora avvenuto, come per esempio nel Lazio, non è ancora chiaro chi, deve fare, cosa per la messa a punto e il mantenimento della banca dati in rete. In prospettiva, bisognerebbe tener conto che, in una logica di mobilità delle conoscenze e dei lavoratori, la banca dati dovrebbe poter essere nazionale.
174 174
CAPITOLO CINQUE
ANALISI DI UN PROCESSO DI “T RADUZIONE”: L’APPRENDISTATO NEL LAZIO
Dati s trutturali de l c o nte s to
La nos tra atte nzione , a que s to punto, s i conce ntra s ulla r icompos izione de gli e ve nti che hanno contras s e gnato il proce s s o di a ttuazione de lla r iforma ogge tto d’e s ame , ne l te ntativo di me tte rne in luce le tappe più s alie nti.
Il flus s o che s i pre s e nta ai nos tr i occhi è caratte r izzato da fas i a lte rne e da una note vole fluidità de lle re lazioni. Que s to re nde par ticolarme nte comple s s o il te ntativo di r icos truzione de llo s te s s o che , imbr igliato all’inte rno di fotografie s e mpre parziali e mome ntane e , non è mai fe de le al fluire convuls o de gli e ve nti. Nonos tante que s te e vide nti difficoltà s i ce rche rà di dar conto, pe r quanto pos s ibile , di que s to s viluppo ancora tutto in dive nire . Pe r compre nde re il pe s o che l’is tituto de ll’appre ndis tato as s ume ne lla nos tra re gione , e la s ua s ignificatività in re lazione ai dive rs i s e ttor i o conte s ti te r r itor iali, è oppor tuno capire come è mutato il s uo utilizzo in s e guito alla r iforma. Se condo quanto e me rge dal grafico s ottos tante (grafico n. 9) è e vide nte che a s e guito de lla L. 196/97 il r icors o al contratto di appre ndis tato anche ne l Lazio (in line a con le te nde nze nazionali) ha s ubito una s ignificativa impe nnata che ha te s o a s tabilizzars i ne gli anni s ucce s s ivi.
Gra f ic o n . 9 : Gl i a ppre ndis t i ne l La z io da l 1 9 9 7 a l 1 9 9 9
9915
11481
10295
9000
9500
10000
10500
11000
11500
1997 1998 1999
Gli apprendisti nel Lazio dal 1997 al 1999 (V.A.)
(Fonte : nos tra e laborazione s u da ti de l Min de l lavoro)
175 175
I dati s ui quali vie ne e ffe ttuato lo s cre e ning ne ce s s ar io a r icos truire il conte s to e conomico- produttivo de lla re gione Lazio s ono que lli ins e r iti tra gli anni 1998- 2002 (ne l cors o de l proge tto: “una re te di s porte lli pe r l’appre ndis tato”), a l fine di cos tituire l’anagrafe appre ndis ti re gionale . E’ dove ros o s pe cificare , tuttavia , che s i tra tta di re gis trazioni e ffe ttuate s ulla bas e de lla s che da di s e gnalazione de i tutor che le azie nde , s e condo la normativa, s ono te nute ad inviare alla re gione . T ale s cre e ning ha contr ibuito ad e vide nziare l’incons is te nza di que s ta s e gnalazione , in quanto, il raffronto de i dati ins e r iti ne lla banca dati con que lli in pos s e s s o de lle province , ha por tato alla luce un campione di appre ndis ti par i a c irca un te rzo de ll’unive rs o e ffe ttivame nte pre s e nte s ul te r r itor io. Ciò s ignifica che s olo un te rzo de lle azie nde che fanno r icors o a ta le is tituto e ffe ttuano re golare s e gnalazione de l tutor . Nonos tante que s ta vis tos a incongrue nza de i dati in pos s e s s o de lla re gione , r is pe tto a que lli provinciali, è pos s ibile individuare de lle r ile vanti te nde nze che contr ibuis cono a chiar ire il te s s uto s ocio- e conomico locale 161 . Nonos tante i dati in nos tro pos s e s s o rappre s e ntino s oltanto una s tima pe r dife tto de l totale appre ndis ti pre s e nti s ul te r r itor io, è s tato pos s ibile os s e rvare che i giovani as s unti in contratto di appre ndis tato da ge nnaio a ottobre 2002 s ono s tati be n 7.477; que s to dato las cia intrave de re , dunque , una line a di continuità con il tre nd avviato dalla r iforma. L’analis i de i dati ha permesso di osservare , inoltre , una forte polverizzazione , tanto a live llo regionale quanto ne lle cinque province , per ques to motivo ne lle valuzioni di se ttore s i è tenuto conto di que lli ove la presenza di apprendis ti è maggiormente rappresentata (> 1,2%). Sulla base di ques ti e lementi sono s tate es tratte le 9 attività economiche più s ignificative per la regione alle quali corrispondono 68 qualifiche , per un totale di 5.705 apprendis ti su 7.477 avviati al lavoro di apprendis tato ne l 2002: cioè il 76,3% de l campione . Il res tante 27,7% s i dis tribuisce ne ll’area se rvizi senza, peraltro, alcun dato dis tintivo che permetta di evidenziare ulte riori caratte rizzazioni (Tab. 8 in appendice).
Il se ttore di attività economica, che offre maggiori occas ioni di avviamento al lavoro come apprendis ta, tra i se ttori più rappresentati ne l campione analizzato (grafico n. 10), è que llo de l commercio con il 30,0% di giovani (pari a 1.711 unità). Seguono l’attività economica: definita fabbricazione (dato aggregato) con il 14,3% (813 adde tti), le cos truzioni pari al 12, 5% e l’ins tallazione de i se rvizi in fabbricato con il 12, 3% di apprendis ti.
161 E’ importante sottolineare, altresì, che si tratta di informazioni raccolte sulla base di indicatori che non sono assolutamente in grado di informare i vertici politico-istituzionali rispetto ad eventuali scelte programmatiche. Ed è questo un elemento molto importante da considerare se si vuole mettere a regime una anagrafe apprendisti davvero indicativa rispetto alle priorità territoriali.
176 176
Significativo è anche il dato de ll’attività economica contraddis tinta dalla voce “alberghi e ris toranti”, la quale è pari al 13,0%162 .
Gra f ic o n . 1 0 : S e t to ri p iù s ig nif ic a t iv i pe r i l t e s s uto e c o no mic o -
pro dut t iv o la z ia le
30%
14,30% 12,50% 12,30% 13%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
commercio fabbricazione costruzioni installaz. infabbricati
alberghi eristoranti
Settori più significativi per il tessuto economico-produttivo laziale
Fonte : nos tra e laborazione s u da ti r e gionali
Re lativame nte all’e tà, come e me rge dal grafico s ottos tante (grafico n. 11), la c las s e di e tà più rappre s e ntata dai giovani appre ndis ti è que lla tra i 18 e i 24 anni, con una s ignificativa conce ntrazione tra i 20 e i 23 anni (tab. 9 in appe ndice ).
Gra f ic o n . 1 1 : S uddiv is io ne pe r g e ne re e e tà de g l i a ppre ndis t i ne l La z io
Fonte : nos tra e laborazione su dati regionali
162 Si ritiene opportuno sottolineare che le categorie utilizzate sono quelle presenti nelle schede di rilevazione.
177 177
L’analis i de l titolo di s tudio (grafico n. 12) pone in e vide nza che s i ha una maggiore diffus ione de ll’is tituto de ll’appre ndis tato tra i ragazzi con la s ola qualifica di s cuola me dia infe r iore (54,9%), s olo il 15,8% s ono i giovani in pos s e s s o di diploma di s cuola me dia s upe r iore e il 14,6% que lli con atte s tato di qualifica profe s s ionale . Pre occupante è l’indicazione di quas i un 15% di giovani s e nza alcun titolo e pe r i quali que s to s trume nto di ins e r ime nto ne l me rcato de l lavoro s i pre s e nta l’unica via pe r acquis ire una qualifica profe s s ionale valida anche in dife s a de lla propr ia “occupabilità”.
Gra f ic o n . 1 2 : T ito lo d i s tudio de g l i a ppre ndis t i ne l le a z ie nde de l La z io
Fonte: nostra elaborazione su dati regionali
Poiché uno de i proble mi più fre que nte me nte de nunciati r iguarda la s tagionalità de i contratti di appre ndis tato e la mobilità de i giovani che s i avvicinano a que s to is tituto s i è r ite nuto oppor tuno os s e rvare anche la loro te nde nziale durata .
A que s to propos ito, l’analis i de l campione (grafico n. 13) ha pe rme s s o di e vide nziare che la durata me dia di ta li contratti s i a tte s ta attorno ai 24 e ai 36 me s i, me ntre s cars i s ono que lli che s i s viluppano in un arco infe r iore ai 23 me s i (tab 10 in appe ndice ).
178 178
Gra f ic o n . 1 3 : Dura ta in me s i de l c o ntra t to d i a ppre ndis ta to
Fonte : nos tra e laborazione s u da ti r e gionali
L’analis i de lle qualifiche maggiorme nte rappre s e ntate ne lle attività e conomiche più s ignificative de lla re gione , pe rme tte di e s trapolare le 50 qualifiche più impor tanti de l te s s uto e conomico- produttivo re gionale (tab. 11 in appe ndice ); tra que s te , coe re nte me nte con le macro- are e di a ttività individuate , s i dis tinguono pe r il maggior pe s o in valor i as s oluti: gli adde tti a lle ve ndite (1.345); gli adde tti a lla r is torazione (1.186), il pe rs onale di s e gre te r ia (699); gli ar tigiani e gli ope rai de lle cos truzioni e dili (546); gliar tigiani e gli ope rai adde tti a lla ins tallazione - manute nzione di a ttre zzi e le ttr ic i e e le ttronici (444); gli adde tti a lle r ifiniture de lle cos truzioni (269); e , infine , le profe s s ioni inte rme die amminis trative e organizzative (212). Le dive rs e fas i de lla “traduzione ”: il s ignific ato c onfe rito al c onc e tto di inte grazione
Dopo que s ta bre ve dis amina de gli as pe tti propr iame nte s trutturali de l conte s to ci s e mbra utile , ora , tornare agli e le me nti che hanno guidato tutto l’ite r di r ice rca. Si è te s o a de finire , in que s ta s e de , con il te rmine “politica inte grata” que gli inte rve nti di policy fondati s u una vis ione s is te mica e contraddis tinti da una pratica multiattore or ie ntata ad una programmazione inte grata (a tutti i live lli e non s olo in te rmini e conomici), e , c ioè, capace di far conve rge re s u un unico obie ttivo/ inte rve nto s e ttor i di policy dive rs i ma concomitanti, a l fine di ottimizzarne gli e ffe tti. In que s to s e ns o, le politiche e i proge tti inte grati hanno l’ambizione di fonde re approcci, s e ttor i,
179 179
compe te nze e s ape r i dis ciplinar i dive rs i, pe r compe ns are la parzialità de ll’azione programmator ia che , come l’e s pe r ie nza ins e gna, non può contare s u una razionalità s inottica.
L’approccio de lla tras lazione , andando oltre l’analis i de ll’output , ha pe rme s s o di inte rce ttare la r icche zza e la comple s s ità de lle re lazioni e de i proce s s i che s i s ono attivati, a ltre s ì, ha cons e ntito tanto di r icos truire con pre cis ione l’incons is te nza de l s is te ma di par te nza (ve di appe ndice ), quanto di far e me rge re attor i, pratiche , conce zioni, s littame nti e cc. con cui r icos truire il fluire de gli e ve nti.
L’analis i de lla “traduzione ” de lla r iforma ne l Lazio ha pe rme s s o di e nucle are alcune dime ns ioni par ticolarme nte s ignificative pe r compre nde re come cambia il conce tto e l’approccio all’inte grazione tra i diffe re nti a ttor i a i dive rs i nodi de l proce s s o; e , di cons e gue nza, quali a tte ggiame nti o prodotti que s ti hanno attivato. Attrave rs o le “rappre s e ntazioni” fornite dagli a ttor i coinvolti è s tato pos s ibile , infatti, r icos truire la s tor ia di que s ta e s pe r ie nza punte ggiandone le tappe s alie nti a ttrave rs o la loro s te s s a voce (tutte le fas i de lla “traduzione ” os s e rvata ve ngono r ipor tate con r icche zza di par ticolar i in appe ndice ).
Que s te dime ns ioni rappre s e ntano, a nos tro avvis o, de gli impor tanti indicator i de l grado e de l live llo di coordiname nto inte rorganizzativo raggiunto. E’ plaus ibile che da un’atte nta r ifle s s ione pos s ano s catur ire anche altre cate gor ie di analis i ma, in que s ta s e de , s ulla s cia de lle s ugge s tioni s us citate dal campo, s i è pre s tata atte nzione alle s e gue nti voci: a ttor i, cre de nze , s ignificato attr ibuito dagli a ttor i locali a l conce tto di inte grazione pe rs e guita , ogge tti prodotti, obie ttivi pre fis s ati, motivazioni dichiarate (e pe rce pita), c lima, appre ndime nto (inte s o come capacità di produrre s oluzioni e conos ce nze innovative , dunque , nuovi s trume nti), s littame nti ve r ificati. �Come è pos s ibile os s e rvare ne lla tavola s inottica che s e gue (s che ma n. 4) s i re gis trano vis tos e diffe re nze re lativame nte a que s ti indicator i in bas e alle configurazioni re ticolar i che , di volta in volta , s i ve ngono a cre are .
Come s i è r ile vato dalle s tor ie che raccontano que s ta “traduzione “ s i as s is te , a i dive rs i live lli, a diffe re nti te ntativi di tras por tare il conce tto di inte grazione dal globale al locale . L’impuls o comunitar io, infatti, s e mbra limitars i ad una comunicazione re tor ica top dow n (Battis te lli, 2002) che indica cos a s i dovre bbe fare s e nza e ntrare ne llo s pe cifico de l come . I policy mak e rs (1 fas e ), ne l te ntativo di tras lare al live llo nazionale que s to input s i s ono or ie ntati –s ulla s cia di quanto avvie ne già in altr i pae s i e urope i- ve rs o la r ice rca de l dialogo ne goziale e la razionalizzazione de lla ge s tione e conomica, a l fine di favor ire un maggior coordiname nto de gli inve s time nti in s e ttor i di policy dis tinti. Si è avuto modo di r ile vare in que s ta pr ima fas e (che coincide con il Gove rno Prodi) un conte s to pos itivo,
180 180
caratte r izzato da un clima di fiducia e re lazioni inte ns e , che ge tta le bas i pe r un confronto propos itivo tra le par ti e pe r la produzione di nuove conos ce nze , l’adozione di s oluzioni alte rnative ; a ciò contr ibuis cono for te me nte due fattor i: a) l’inve s time nto de lle pe rs one coinvolte , inte re s s ate al s ucce s s o de lle iniziative intrapre s e ; b) la fiducia e la s tabilità s te s s a de lle inte ns e re lazioni. Già in que s ta pr imis s ima fas e , c iò nondime no, s i può re gis trare uno s littame nto de l conce tto di inte grazione dal piano comunitar io a que llo nazionale . La Ue , infatti, incita ad una programmazione inte rgrata alla quale par te cipino attor i, s e ttor i e inte re s s i dive rs i che concorrono s u un obie ttivo unico e condivis o; la r is pos ta de i policy mak e rs nazionali, vice ve rs a, s i conce ntra s ullo s viluppo di una “pratica pattiz ia” atte nta più alla dime ns ione e conomica che programmator ia , più alla razionalizzazione de lle s pe s e che all’inte grazione e al coordiname nto de gli obie ttivi. E’ in que s ta fas e , tuttavia , che s e mbra affe rmars i un pr imo live llo di appre ndime nto: que llo s ociale (May, 1992), volto a de finire il proble ma e me rge nte attrave rs o la produzione di nuovi s trume nti (copiati a lla ge s tione azie ndale ) quali il manage r inte gratore , la commis s ione mis ta di coordiname nto, il mas te rplan.
Con la s e conda traduzione (2° fas e ) s i as s is te al pas aggio dal live llo nazionale a que llo de lle s trutture di imple me ntazione re gionali. In que s ta fas e , dunque , s i formano gli actor ne t locali chiamati ad imple me ntare l’inte rve nto s e condo i de cre ti a ttuativi che , via via , ve nivano de line andos i. Ne l Lazio la pr ima configurazione re ticolare ad affe rmars i è cos tituita da: policy mak e rs locali, burocrati, e s pe r ti, s tack holde rs e te cnici. Il c lima che contraddis tingue le re lazioni tra que s ti a ttor i è ancora improntato alla fiducia e or ie ntato alla collaborazione fattiva che s i e s pr ime attrave rs o un inte ns o dialogo ne goziale e coincide con il pr imo pe r iodo di s pe r ime ntazione . T ale dialogo, in que s ta fas e , è volto alla cos truzione de l cons e ns o e alla re s pons abilizzazione de lle forze pre s e nti s ul te r r itor io, a l fine di de line are le nuove re lazioni che dovre bbe ro guidare un gove rno fondato s u re lazioni or izzontali e tutte da cos truire . Il pr imo obie ttivo individuato in que s to pe r iodo è, infatti, propr io que llo de lla cre azione di un gove rno condivis o e di re lazioni cos truttive e s tabili. E’ in que s to pe r iodo che s i ope ra una ulte r iore traduzione a live llo locale , que s ta volta , tuttavia , de gli s trume nti e laborati, s pe r ime ntati e s os pinti dal ce ntro. Lo s littame nto più s ignificativo s i re gis tra r is pe tto al mas te rplan che , inve ce di e s s e re inte s o come me zzo di razionalizzazione e conomica, vie ne inte rpre tato, ne l cas o ogge tto d’e s ame , come uno s trume nto di monitoraggio e di comunicazione . Se mbre re bbe di e s s e re ancora in una condizione di appre ndime nto s ociale s e ppure s i intrave dono de lle contaminazioni che las ciano tras par ire altr i s pazi di appre ndime nto.
Un ulte r iore s littame nto (3° fas e ) s i ve r ifica con il cambiame nto de lla giunta che modifica inte rame nte l’attore re ticolare e , di cons e gue nza, le
181 181
re lazioni inte rne ad e s s o, il c lima e d il s ignificato attr ibuito all’inte rve nto. Ne lla nuova configurazione vie ne me no la compone nte politica me ntre as s ume un pe s o r ile vante la s truttura di imple me ntazione con i s uoi burocrati (tutti inte rni a l s e ttore formazione ) e i te cnici. In que s to pe r iodo, la traduzione e ntra in una fas e di s tallo dove tutti gli a ttor i s e mbrano concorre re a s ottrare e ne rgia al proce s s o di s tabilizzazione . Si re gis tra una diffus a s fiducia all’inte rno de l ne tw ork ing e uno s cars o inve s time nto pe rs onale (e motivo e profe s s ionale ) da par te de gli a ttor i inte rvis tati. In que s to frange nte la re tor ica dominante è la “cos truz ione de l s is te ma” che s i vuole pe rs e guire attrave rs o la r ice rca di una migliore collaborazione inte rs is te mica, a l fine di garantire una maggiore coe re nza al proce s s o in te rmini di coordiname nto e condivis ione de lle informazioni s pars e . Gli s trume nti de putati ad e dificare il nuovo s is te ma s ono: la re te di s porte lli pe r l’appre ndis tato , la banca dati, i colle game nti te le matici. In que s to mutato conte s to s i pos s ono re gis trare due ulte r ior i s littame nti: a) la s trate gia ne goziale non è più inte s a come s trume nto pe r la cos truzione de l cons e ns o, be ns ì come luogo di ratifica di s ce lte compiute altrove ; b) il conce tto di re te non è più ancorato ad un nuovo mode llo di gov e rnance bas ato s u re lazioni or izzontali, be ns ì a lla de finizione de lle re lazioni inte rorganizzative e me rge nti. Inoltre , a ttrave rs o l’is tituzionalizzazione di a lcune pratiche avviate s i ne lla fas i pre ce de nti (commis s ione di conce r tazione , mas te rplan) s i ve r ificano due e le me nti di par ticolare impor tanza: pe r un ve rs o, s i re gis tra una s or ta di appre ndime nto politico (ibide m) che conduce a modificare de te rminate re altà e s trume nti di ge s tione ; pe r l’altro, s i ve r ifica una s or ta di tras formazione de l s e ns o or iginar io attr ibuito alle pratiche appe na is tituzionalizzate .
Il quar to s littame nto (4° fas e ) coincide con un nuovo mutame nto in s e no al ne tw ork ing locale , caus ato, s tavolta , da una r iorganizzazione dir ige nziale inte rna alla re gione . La ge s tione de ll’inte rve nto vie ne s ottratto alla re s pons abilità de i burocrati de lla formazione pe r e s s e re affidato al compar to lavoro. Sono pre s e nti ancora te cnici, e s pe r ti, cons ule nti; ma s ube ntra un nuovo attore inte re s s ato a ne goziare un margine s e mpre più r ile vante di autonomia: le province . Que s to cambiame nto las cia trape lare una nuova ve ntata di fiducia e , a lme no in te rmini di dichiarazione di inte nti, la volontà di r ivivacizzare il ruolo conce r tativo a live llo locale . Le re lazioni, tuttavia , continuano ad e s s e re caratte r izzate da profonda s fiducia, de le gittimazione de lle is tituzioni ce ntrali e for te conflittualità attorno al te ma de lle de le ghe alla provincia . Il nuovo obie ttivo che s i de line a all’or izzonte è cos tituito dalla programmazione de ll’offe r ta formativa pe r appre ndis ti s ia a live llo re gionale che provinciale . In que s ta fas e , l’atte nzione è conce ntrata s ulla re alizzazione de lla banca dati come s trume nto di gove rno in te mpo re ale de i dati s ugli appre ndis ti. L’as s unzione di ruolo de gli a ttor i provinciali conduce a nuovi s littame nti a s e conda de lle e s ige nze locali, ma in ne s s un cas o s i r ie s ce a s upe rare un





























































































































































































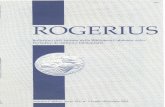
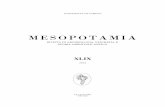




![[2014] Testamento Olografo delle Ombre [translation]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631daffc4da51fc4a3033c94/2014-testamento-olografo-delle-ombre-translation.jpg)




