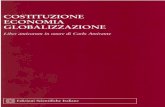De la "hermeneutización" de la metafísica a la "hermeneutización" de la política.
La costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli Stati in età...
Transcript of La costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli Stati in età...
SOCIETAgrave ITALIANA
DEGLI STORICI DELLECONOMIA
TRA VECCIDENUOVIEQUILmRI DOMANDA EOFFERTA DI SERVIZI IN ITALIA
IN ETA
MODERNA ECONTEMPORANEA
Atti del quinto Convegno Nazionale Torino 12-13 novembre 2004
a cura di Iginia Lopane Ezio Ritrovato
CACUCCI EDITORE - BARl- 2007
SOCIETAgrave ITALIANA
DEGU STORICI DELLECONOMIA
TRA VECCm ENUOVI EQUILmRI DOMANDA EOFFERTA DI SERVIZI IN ITALIA
IN ETA MODERNA ECONTEMPORANEA
Atti del quinto Convegno Nazionale Torino 12-13 novembre 2004
a cura di Iginia Lopane Ezio Ritrovato
CACUCCI EDITORE - BARl- 2007
RENZO p CORRITORE
LA COSTITUZIONE DI SCORTE GRANARIE t
PUBBLICHE E LA PqLITICAEccedilO~OMIqA
DEGLI STATI IN ETA PRE-INDUSTRIAL~ (LA DIgraveSTRIBUZIONE DEL GRANO E LA STRUTIURA
DEUE SCORTE NEI TERRITORI ITAUANL Ii FONTICO DEL MERCATO)
1 ILTEMAELASUAPROBLEMATIZZiZIONE
Investimento della paUra cosi Carlo M Cipolla definiva nel suo piugrave noto ~uashyle la formazione e conservazione di scorte alimentari da parte di soggetti iprivati e pubblici nellEuropa pre-it)dustriale (CIPOlLA 1974 68) La propensione allaliantoshynamento di de11llte agricole 00 parte delle famiglie ~ delle autoritagrave nell etagrave ~~evale e moderna assumeva in tal modo una connotazione negativa le scorte erano reddito non consumatO cioegrave un risparmio incapace di tradursi in domanda di beni ccedilapitali dunque ~ sterilizzazione di ricchezza dal pilnlQ ~ vista della crescita ecoll9mica e dell evoluzione della produttivitagrave Con ciograve faceva proprio quanto aveva scritto uno storico pavese a lui vicino Dante Zanetti
La fonruttion et le maintien de stockIgravel Iln particulier de stocks alimeritairegraves ~sti- tuent une forme particuliegravere dinvestissement cest-i-dire daccumulalion de capitagraveJ li sagit dun invesnssement ayant un caractegravere pour ainsi dire statique et non eacutevplUshytif car il ne contribue pas i laccroissement du revenu pendant celte Iongue ~pde mais sert seulement agrave une meilleure distribution du ~venu dans le temps nfaut aj0luter que Ies stocks repreacutesentent limmobllisation dune partie consideacuterable de leacutepargneiprishy
veacutee qui dans une eacuteconomie de type preacute-industriel repreacutesente une part deacutejagravetrop ~te du revenu (ZANErn 1963 44)
Lo stesso CipoIIa tuttavia nellultima edizione del manuale (CIPolLA 1991 227) decideva di applicare anche allevo moderno quanto aveva scritto piugrave di trentanni prinia a proposito della politica economica dei governi nellepoca medievale cioegrave
che laccumulo di scorte frumentarie da parte deacuteUautoritagrave fosse uno strumento di politica economica per promuovere unecogravenomia piugrave equilibrata meno lttqmiigraveuita dallincertezza del ciclo dccedili racegraveolti Nel 1965 infattila preferenza era sta~ da lui accordata allanalisi delle politiche pubbliche in un cpntesto di mercato inigraveperfetshyto in un oriZzonte che deborda il ciclo annuale agricolo
Pii) imperfetto era il mercato piugrave urgente si faceva la necessitagrave dimantenere massicshyce riserve di prodotti Per tutto il corso del Medioevo ogni individuo che non fosse
501 488 Renzo P Corritore
povero ammassograve nella propria dimora scorte di grano carne salata sale candele ecc e la medesima cosa fece lo Stato Nel periodo feudale non venne mai meno nel castello del signore ]abitudine di tenere da parte grosse scorte per i periodi di emergenza Sucshycessivamente le autoritagrave comunali predisposeromiddot il magazzinaggio di grosse derrate
lt specie di grano da rivendere a basso prezzo in periodi di emergenza e nello stesso tempo si preoccuparono di prevenire un indebito accumulo di scorte da parte di specushylatori privati Nelle economie medievali gli stock di derrate di prima necessitagrave rappreshysentarono pertanto una delle piugrave importanti Jorme di investimento pubblico e privato (CipollA [1965] 468)
Nella prima versione delmanualeacute invece finograve allinserimento nel 1997 del nuovo capitolo dedicato alla politica economica neUetagrave preindusiriale il punto di vista preshyvalente era quello microeconomico entro il perimetro stregravetto dell individualismo meshytodologico
Le scorte costano e costano doppiamenie Esse implicano il costo diretto che egrave rapshypresentato dal costo del magazzinaggio e daI deterioramento-eventuale del prodotto O di parte di esso Se luomo daffari finanzia la costitiIZIgraveone delle scorte con danaro preso~a prestito il costo diretto include anche il tasso di interesse pagato Se luomo daffari finanzia con capitale proprio la costltuzione delle scorte il costo delle scorte deve inshycludere un costo-opportunitagrave e cioegrave il mancato rendimento (mancato tasso dinteresse attivo) del capitale finanziario impiegato (CIPOllA 1974 154)
Le ragioni della costituzione e del mantenimento di scorte alimentari da parte delshylautoritagrave pubblica diventavano unicamente ragioni morali (umanitarie e di buona amministrazione) o di opportunitagrave politica (la fame era la piugrave frequente ~ausa di sommosse e furori popolari) (CIPolLA 1974 74)
Nel 1997 si riammettegraveva dunque linterpretazione originaria della costituzione di scorte pubbliche come strumento di riequilibrio del mercato senza peraltro rinnegare le consideraZioni sulla valenza statica di tale forma di investimento per gli agenti economici privati
In merito allutilitagrave economica e al significato delle scorte in etagrave pre-industriale Cishypolla non espresse perciograve sempre lo stesso punto di vista La rassegna delle pogravesizioni da lui assunte anzi permette di individuare tre approcci e tre giudizi costitutivamente diversi sulla funzione delle scorte granarie nellepoca pre-indUstriale
In prima approssimazione laccumulazione di scorte alimentari mostra il carattere fondamentalmente difensivo delle scelte degli agenti economici pubblici e privati in etagrave pre-industriale La paura latradizione la superstizione li induce a tabuizzare il rischio la speculazione linvestimento nella produzione -e nella distribuzione dei beni essenziali alla vita e ad aderire intimamente a un ideale di economia e societagrave stazionarie aggravando con la nonna sociale le istituzioni il comportamento indivishyduale e collettivo leffetto dei condizionamenti materiali delleconomia pre-industriashyleacute (bassa produttivitagrave agricola alti costi di trasporto modesta efficienza energetica) esponendo ancor di piugrave la comunitagrave umana ai degravemoni della natura
La seconda interpretazione rigetta luniversale imperio dellhomo oeconomicus rishyscoprendo leteronomia dei fini dellagire economico degli uomini nelletagrave pre-inshydustriale La politica economica dello Stato o-delle autoritagrave non persegue puri scopi economici lintegritagrave del corpo sociale fin nelle sue cellule elementari (persone e famiglie) deve essere assicurata secondo i principi e la prassi di uneconomia morale che SOVlasta leconomia regolata dal mercato spersonalizzata e antipopolare Una
La costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli staIgravei
PuLT QUAGUA 1984A M PULT QUAGLiA Mercato dei prodotti agricoli e magistratushyre annonarie a Pisa nelletagrave moderna in Ricerche di storia moderna a cura di M Mirri voI m Pisa Pacini 1984 pp 57-141 lt
PULT QUAGliA 1990 A M PULT QUAGUA lt Per provvedere ai popoli Il sistema anshynonario nella Toscana dei Medici Firenze Olschki 1990
SERUO 1994 S SERilO Architettura civile Libri sesto settimo e ottavo nei manoscritshyti di Monaco e Vienna (a cura di F P Fiore) Milano TI Polifi10 1994
SIGAUT 1985 F SIGAUT Questions deacuteconomie agrave propos des politiques ceacutereacutea1iegraveres et de stockage in Les techniques de conservation des grains agrave long terme leur r6le dans la dynamique dessystegravemes de cultures et des socieacuteteacutes (sous ladirection de M Gast F Sigaut e~Beutler avec la collaboration de O Bijchsenschutz) voI m 2 Paris Eacuteditionsdu CNRS 1985 pp 597-606
SMfIH [1776] A SMITH Aninquiry into the nature andcauses ofthe wealth ofnations London W Strahanand T CadeIl 17762 voll (trad it Indagine sulla natura e le causedellagrave ricchezza delle nazioni Milano A Mondadori 1977 2 voll da cui si cita)
STAnmB(i~ACOLSIANI [1313] STATUTI BONACOLSIANI (a cura di E Dezza A M Lorenshyzoni M Vaini) Mantova G Arcari 2002
STATtm GONZAOHESCHI [1404] STATUTlGONZAGHESCHI presso la Biblioteca comunale di Mantova ms FV 11 [775]
VECCHIATO 1979 F VECCHIATOPane e-politica annonaria in Terraferma veneta tra secolo XV e secolo XVIlI (Il caso di Verona) Verona Stamperia Zendrini 1979
ZANETTI 1963 D ZANETTI Contribution agrave leacutetude des structures eacuteconomiques lapshyprovisiQnnement dePavie au XVI siegravecle in Annales ESC XVIII 1963 l pp 44-62 ora in ID Fra le antiche torri Scritti distoria pavese Pavia Universitagrave di Pavia 2000 pp 165-182
ZANETTI 1964 D ZANErn Problemi alimentari di una economia preindustriale Ceshyreali a Pavia dal 1398 al 1700 Torino PBoringhieri 1964
ZUO TuCCl 1990 H ZUG TUCCl Le derrate agriCole problemi materiali e concezioni mentali della conservazione in Lambiente vegetale nellalto Medioevo XXXVII Settimana di studio del Centro italiano di studi sullalto Medioevo (30 marzo-5 aprile 1989) Spoleto Centro italiano di studi sullalto Medioevo 1990 voI II pp 865-902
489 500 Renzo P Capitare
GUENZI 1982 A GUBNZI Sistema annonario e controllo sociale a Bologna nei secoli XVII e XVIII in E SORI (a cura di) Cittagrave e controllo sociale in Italia a XVIII e XIX secolo Milano R Angeli 1982 pp~ 293-306
HICKS [1989] J R HICKS A nwrket theory of money OxfQrd Oxford University Piess 1989 (trad itmiddot Una teoria di mercato della moneacuteta Bologna Il Mulino 1992 da cui si cita)
JACOPEn 1965 N I JACOPEITI Monete eprewa Cremona dal XVI al XVIII secolo Cremona Athenaeum Cremonense1965
KAPLAN 1984S L KAPLAN Provisioning Paris Merchaius and Millers in me Grain and Flour Trade during the Eighteenth Century Ithaca~London Cornell Univershysity Press 1984~middot
KULA [1962] W KULA Teoria ekonomiczna ustrojufeudalnego Proba modelu Warshyszawa~4nstwowe WydavnictwoNaukove 1962 (trad it Teoria economica del sistema feudale Proposta di un modello lorino EinaUdi 1972 da cui si cita)
LABROUSSB [1933] c-E LABRoussB Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIII si~cle Paris Eacuteditions des Archives Contemporaines 1984 2 voll (1 ed Paris Librairie Dalloz 1933)
MAlANIMA 1976 P MALANlMA Aspetti di mercato e prew del grano e della segale a Pisa dal 1548 al 1818 in Ricerche di storia moderna voL I Pisa Pacini 1976 pp289-327
MANTOVA 1430 MANTOVA 1430 Pareri a Gian Francesco Go~ga per il governo (a cura di M A Grignani A M Lorenzoni A Mortari C Mozzarelli) Mantova G Arcari1990
MAsSA 1999 PMAsSA AMonae corporazioni del settore alimentare ~ Genova orshyganizzazione e corflittualitagrave (XVI-XVIII secolo) in A GPJlNZI P MAsSA A MOlOshyu (a cura di) Corporazioni e gruppi professionali nellItalia moderna M4ano R Angeli 1999 pp 390403
MAnoZZI 1983 I MATroZZl R BoLEUl C CHiAsBRA D SABBIONl Il politico e il pane a Venezia (1570-1650) calmieri e governo della sussistenza in Societagrave e storia V1198320pp271-303
MAZZI RAVBOOI 1983 M T MAzzI S RAVBOOI Gli uomini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento Firenze Olscbki 1983
MERONI 1957 U MERoNI Cremonafedeiissima Cremona Athenaeum Cremonenshyse1957
MBUVRET 1977 J MBUVRm Le progravebl~me 4es subsistances agrave leacutepoque LouisXIv 1 La productiOn des ceacutereacuteales dans la France du XVIIet du XVIII si~cle Pans Mouton - EacuteEHss 1977 2 voll
MBUVRm 1988 J MBuVRET Le probl~me des subsistances agrave leacutepoque Louis XlY III Le commerce des grains et la conjoncture Pans EacuteEHss 19882 voll
PICClNNI 1976 G PICClNNl Vita contluJina in una capanna dei dintorni di Siena (1250) in Archeologia medievale JII 1976 pp 395-399
PINTO 1978 G PINTO Il libro del Biadaiolo Carestie e annona a Firenze dalla metagrave del 200 al 1348 Firenze Olschld 1978
PINTO 1982 G PINTO La Toscana nel tarda Medioevo Ambiente economia rurale societagrave Firenze Sansoni 1982
PIRENNB [1933J H PmmINB La civilisation occidentale au Moyen Age du XIe au mishyZieu du XVe si~cle Paris PUF 1933 (trad it Storia economica e sociale del Meshydioevo Milano Garzanti 1967 da cui si cita)
wcostitlJlWne di scorte granarie pubbliche e la politica economiCa degli stati
redistribuzione sostenibile dei beni di sussistenza egrave ricercata in questo cielo da quegli stessi particolari che mllI8lllaldeggiano nella produzione negli scambi nei consumi e che costituiscono il nerbo della classe di governo Le scorte pubbliche rappresenteshyrebbero in questa prospettiva un presidio civico e un ris~nto politico e morale ai componenti della comunitagrave spossessati deIbene supremo dellaUtarchia alimentare
Resta infine latente unidea del magazzmo pubblico come quasi-mercato cioegrave come luogo volto (1) a risolvere i fallimenti informativi d~lla piazza del mercato (in megraverlto alle disponihilitagrave alle caratteristiche del prodotto alle condizioni di vendita della merce) (2) a ddimensionare lalea per agricoltori consumatori poveri artigiani del comparto alimentare (3) a sosteqere i consumi e i profitti privati in funzione anticicli ca in una prospettiva I0n meramente congiunturigraveugravee Si tratta in questo caso di unorshyganizzaZionepienamente razionale che non opera in maniera saltuaria e riflessa ma in modo continuativo secondo obiettivi prefissati di allocazione dei beni primari TI funshyzionamento deJlacanovagrave (il magazzino pubblico) si porrebbe come strumento inteshygrativo ma nOliinteramente sostitutivo delloperare della piazza Si tratterebbe di unaforma ( megravercato distinta dalla pi~ del mercato considerataIn seacute e per seacute cosl come dallegraverompravendite effetttiate nei solari privati o dalla meacutera centralJzzazione e redistribuzione di derrate con fiqatitagrave umanitarie La canova rappresenterebbe in tal modo uno dei possibili mecc~ di governo delle transaziopi locali per risolvere i problCmi dellapprovv~gionameqto senza intaccare certi interessi di classe (dei proshyprietari ma anche del popolo graSso) s) da essere prescelta da autoritagrave e gruppi domishynanti come struttura complemen8Ie della piazza del mercato in certi contestiprodutshydvi ed economici La suasacnilizzazione perciograve non esclude la possibilitagrave di un ritorno alle sole compravendite qella piazza ~ e del solari privati - una volta inverti- tosi il ~nd o spirate le condizio~ economiche della sua istituzionalizzazione
La problematizzazione esorcizza una liquidazione semplicistica del problema delle scorte graUarie in etagrave pre-indus~e nel nome di-~a loro presunta irrazionalitagrave eco- nomica per il compito di assicll1~ la sussistenza della popolazione
Le middotpagine che segUono sono Vintroduzione a un lavoro in corso volto a offrire uninterpretazione generale di tal~ capitolo fondamentale della politica economica dei govemi ~ etagrave pre-industriale
2 SE UN MONDO SENZA SGORTE Egrave INCONGRUO cm Egrave OPPORTUNO CHE LE DETENGA
Nei fatti nel settore granario conI vincoli delletagrave pre-industriale in tema diprodutshytivitagrave energia trasporti non ha ~nso ipotizzare un mondo senza scorte Se il mercato del grano egrave - come nellEuropa Igravenedievale e moderna - un sistema tendenzialmente chiuso
ad ogni raccolto nuove offeXfe arriv[eranno] sul mercato men~e la domanda si mant[erragrave] relativamente costanlf nel corso dellanno Qualcuno dunque [dovragrave1 ~nere delle scorte che saranno elevate isubito dopo il raccolto e poi via via minori fino lIragshygiungere un livello minimo in prpssimitagrave del successivo raccolto (HICKS [1989] 31)
Nella loro forma piugrave semplice tali scorte saranno legate allora alla perlodi~itagrave anshynuale del ciclo agricolo (che aUfnenta il movimento stagionale dei prezzi ccedilfr LAshyBROUSSB [1933 157-66) il loro livello saragrave elevato allindomani del prlnciprue racshy
499 490 RelloP COrrilore
colto (agosto-settembre-ottob~) e in via di esaurimento almomento della saldatura dei raccolti (aprile-maggio-giugno)lA questo proposito nota Franccedilois Sigaut
Le stockage agrave court terme (moms dune campagne) Ieacutepond agrave la neacuteCessiteacute egravek concilier une offre variable et une demande constante mais toutesdeux reacutegulieacuteres et pIeacutevisibles dans la pratique il est ccedilonsideacutereacute comme tagraveisant partie du procegravessus ordigravenaire de la prOduction et ne pose agrave ce titre quedes probJegravemes doplimisation assez simples (SIGAUT 1985 602)
La discussione generale sulla razionalitagraveegraveconomica delle scorte alimentari in etagrave pre-industriale puograve allora essere ridotta alla formulaZione e allo scioglimento di due semplici quesiti 1 Accertato che laccantonamento di grani per la periodicitagrave arinuale del ciclo agricoshy
lo epel i vincoli tecnici di un rifornimento spazialmente allargatoegrave inevitabile chi egrave conveniente che conservi le scorte chi produce O chi cOnlmercia il contadino o il mercante lapossidenza o il popolo i particolari o ilpubblico E qual egrave la realtagrave effettiva
2 Se le forme di distrigravebIgravelZIgraveone economicamente razionale sono plurali in quale conshytesto - e in omaggio a quali interessi - egrave piugrave utile iI sistema della canova rispetto al sistema della piazza del mercato e dei solari privati
3 SULLADISTRlBUZIONE DEL GRANO NELLETAgrave PRE-INDUSTRlALE E LA STRUTTURA DELLE SCORTE NEI TERRITORI ITALIANI
Raramente le case contadine erano dotate di attrezzature per la conservazione dei cereali piugrave che elementari Nelle campagne toscane del Quattrocento dunqueJn unetagrave favorevole al reddito contadino in una regione fra le piugrave ricche dellEuropa pre-indushystriale
pochissime case contadine disponevano del granaio vero e proprio alcune avevano una cella che poteva servire allo stesso scopo ma la maggior parte di quelle abitazioni era priva di spazi destinabili esclusivamente alla conservazione dei cereali Perciograve i contenitori deigrani - arche casse sacchi bugnole - dovevano trovare posto nelle cucine o nelle camere (MAzzI RAvEGOI 1983 174)bull
Le ridotte capacitagrave patrimoniali e reddituali della grande matregoranza dei produttori facevano si che fosse ampiamente invalso nella conservazione domestica dei grani limshypiego di contenitori in legno (come arche casse botti bugnoletini tinelle corbelli)in
Riguardo ai passi evidenziati di Zanetti e Cipolla egrave necessario osservare che la principale atteshystazione sullesistenza di stock detenuti da privati che esorbitassero ilfabbisogno stagionale tali da essere classificati come immobilizzazione di ricchezza (Zanetti) o come beni capitale (Cipolla) a unanalisi piugrave fine si rivela fallace O non direttamente utilizzabile La propalazione dei grani effetshytuata a Pavia fra ilIo e il 5 maggio 1555 che egrave il fondaIgravenento di entrambi i giudizinon mostra una somma di derrate realmente eccedente il fabbisogno delle famigiie per il periodo che manca allarrishyvo dei grani novelligrave sulla piazza pavese Daltra partelastessa natura dellistituto della propaazio- ne dei grani cioegrave della denllncia obbligatoria delle scorte da parte dei particolari una misura demergenza decisa in momenti critici dellapprovvigionamento cittadino affiancata quellanno dalshylispezione diretta presso le case dei privati da parte di deputati straordinari avrebbe dovuto consishygliare una maggiore cautela nella sua utilizzazione per individuare regolaritagrave di carattere generaledelleconomia pre-industriale
La costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli slatibull
FONTI
ABEL [1966] W ABEL Agrarkrisen und Agrarkonjunktur Eine Oeschichte der Landshy und Ernlihrungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter Hamburg
und Berlin Paul Parey 19661 (P ed -1935 trad it Congiuntura agraria e crisi agrarie Storia dellagricoltura e della produzione alimentare nellEuropa centrashyle dalXlII secolo alletagrave industriale Torino Einaudi 1976 da cui si cita)
AG ARCHIVIO GONZAGA presso lArchivio di Stato di Mantova AuFANO 1996 E AuFANO Il grano il pane e la politica annonarla a Napoli nel Setshy
tecento Napoli ESI 1996 bull AYMARD 1966 M AYMARD Veacutenise Ragusegrave et le commerce du bleacute pendant la seconde
motti du XVI siegravecle pans SEVPEN 1966 CA1TINl1984 M CATlINl I contadini di San Felice Metamorfosi di un mondo rurale
nellEmilia delletagrave moderna Torino Einaudi 1984 CEsTARI 1794 p CESTARI Saggio storico dei Fondachi delle farine di Chioggia e
Pellestrina~ bullbull Venezia A Zatta1794 CIPOLLA [1-965] C M CIPOllA La politica economica dei governi V La penisola
italigraveana e la penisola iberic(l in Storia economica Cambridge ID La cittagrave e la politica economica nel Medioevo Torino Einaudi 1977 (Cambridge 1965) pp 462-496
CirollA 1974 C M CiPollA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna TI Mulino 1974
CIpOLLi 1997 C M CIPOllA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna TI Mulino 1997 (6 ed riveduta)
CORRITORB 2000 R P CORRITORB La naturale abbondanza del Mantovano Produshyzione mercato e consumi grqnari a Mantova in etagrave moderna Pavia Universitagrave di Pavia 2000
CORTONESl 1991 A CORTONESr Sulla conservazione dei cereali nellItalia medioevale woro e tecniche nelle tesnnonianze laziali (secc XIII-XV) in Rivista di storia dellagricoltura XXXI 1991 l pp 33-49
DElLA VALENTINA 1992 M DEJ1A VALENTlNA I mestieri del pane a Venezia tra 600 e 700 in Atti dellIstituto igraveVeneto di Scienze Lettere ed Arti Classe di scienze morali lettere ed arti CL 1991-92 pp 113-217
DIRLMEIER 1984 U DiRLMEIER Le condizioni materiali dellesistenza nelle cittagrave tedeshy sche del Basso Medioevo wlwiente esterno reddito consumi in Aristocrazia citshy
tadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia e in Germania (a cura di Reinhard Elze e Gina Fasoli) Bologna Societagrave editrice il Mulino 1984 pp 79shy122
FORNASIN 1999 A FORNASlN II rnercatodei grani di Udine Indagine per una storia dei prezzi in Friuli (secoli X1(1-XVIII) Nota di ricerca del Dipartimento di Scienshyze Statistiche dellUniversitagrave degli Studi di Udine 4 1999 pp 1-24 ora in ID La Patria del Friuli in etagrave frtoderna Saggi di storia economica Udine Forum 2000 pp 33-60
GRENDI 1986 E GRENOl Lapprf(vvigionamento dei grani nella Liguria del Seicento libera pratica e annone in rMiscellaneastorica ligure Studi in onore di Luigi Bulferetti XVIII1986 2 IP 1021-1047
GUENZl 1981 AGUENZI Ilfrumento e la cittagrave il caso di Bologna nelletagrave moderna in Quaderni storici XVI ~98l 46 pp 153-167
GUENZlI982 A GUENZI Pane efornai a Bologna in etagrave moderna Venezia Marsilio 1982
l
491 498 Renzo P Corritore
alla spartizione dei proventi derivanti dalla vendita e dal commercio del grano shylemolumento grandissimo - di chi doveva poi fruire della redistribuzione di tale ricchezza Tale norma avvantaggiava i possidenti cittadini e i gentiluomini privilegiashyti in grado di ottenere le tratte di esportazione Spl piano dellappropriazione essi erano in condizione di mettere fuori gioco gli altri possessori che producev~o eccedenze nel Dorilinio poicheacute si accresceva la loro forza contrattuale e la loro capacitagrave di occupare i canali commerciali piugrave redditizi Sul piano della commercializzazione gli stessi fruivashyno dello smantellamento della rete dintermediazionerappresentata dai fornai Per i rushystici significava perdere un collegamento essenziale con la cittagrave ed essere emarginati dal mercato urbano nelle campagne o sul broletto di Mantova essi non trovarono piugrave i trashydizionali interlocutori (CORRIJ9RE 2000 228231-2)
Nel caso di Bologna terra strutturalmente deficitaria e cittagrave dalla vocazione manishyfatturie1a si costringeva i fornai ad acquistareformenti terrieri presso i solari privati in cittagrave proibendogli lincetta nel contado autorizzandoli ad acquistarefornientiforeshystieri al di fuori delle mura cittadine presso rsensati da grCUlO solo a patto che fosseshyro stati smaltiti i grani cittadini a un prezzo talota superiore a quello dei grani dimshyportazione (GTlBNZl1982A 35 52-3)
Nella Toscana dei Medici il diritto allincetta nel contado venne concesso ai fornai in periodo di bassa congiuntura (in particolare dagli anni Trenta del Seicegravento) Per sostenere i prezzi interni in tal caso essi restavano gli interlocutori principali dei granshydi proprietari semplicemente spostando la loro principale fonte di approvvigionashymento dai solari dei particolari in cittagrave ai granai decentrati delle grandi aziende agrishycole oppure ai mercati rurali su cui affluiva la produzione cerealicola delle grandi fattorie (PULT QUAOUA 1984 86-9 PucrQUAGUA 1990 100 106-7)
Laddove non vi egrave come invece succede a Genova una diretta ingerenza del potere pubblico nella vita della corporazione (MAsSA 1999) i fornai di cittagrave- nonostante i lacci e lacciuoli normativi e il lavoro prevalentemente manuale svolto neUord laboshyratori - erano dei veri imprenditori dipendenti per il loro profitto - noilrinalmente stabilito per legge - dalla produttivitagrave del lavoro e dalla dotazione tecnica e finanziaria delle imprese Di ciograve fa fede la grande sperequazione esistente fra le aziende speciashylizzate nena fabbricazione del pane venale in cittagrave (AYMARD 1966 75 VBCCHIATO 1979 82-3 GTlBNZl1982A
77 segg PULT QUAGUA 1984100 102-3) NellItalia delshyletagrave moderna questi artigiani-imprenditori della filiera del grano trattavano insieme
afarinaifarinaiolifarinottifondachierifontechierifidelarijormentinari lasagneshyri maccaronari taraltari vermicellari ecc fra il 40 eil70 per centodel frumento consumato in Cittagrave nelle annate normali (CORlUTORE 2000 126 segg) e ~no alIDO per cento nelle annate di carestia (PULT QUAGUA 1984 98-9)
In una ricognizione delle asimmetrie informative del mercato non cegrave gruppo quale i fornai che possa integraverpretare la parte dellagente economico onnisciente Se dunque i regolamenti annonari tendevano a regolare minuziogravesamente la collocazione il volushyme e la durata delle loro scorte cosi come disponevano per gli altri artigiani della fishyliera era per neutralizzare il carattere potenzialmente eversivo di tale accantonamenshyto per i proprietari-venditori prima ancora che per i consumatori-acquirenti nlivello delle scorte rinforzava o attenuava il rischio di monopsonio da parte dei pistores piugrave potenti e facoltosi cosi come eventuali tentazioni da parte della categoria di esercitare un dominio egoistico sul mercato del pane (MATroZZI 1983 298)
Sarebbe quindi un errore concep~ le sccedilorte dei fornai come entrilpica allocazione di capitale che sconta lincertezza futura esse venivano gestite secondo criteri di rashyzionalitagrave economica e secondQ la migliore efficienza tecnica nonostante i vincoli imposti alla lievitazione degli stock dalle disposizioni annonarie
LA costituzione di scorre granarie pubbliche e la polilica economica degli stati
vimini paglia o canne intrecciate (come ceste stuoiecannizzi) in terracotta (addirittura anfore) piuttosto che di tessuto (i sacchi costavano troppo) (PICClNNl 1976 397 MAzzA RAvBGGI 1983 174-5 Zoo Turo 1990 893-4 CORIONESI 1991 35n-36n)
Nella casa del piccolo produttore O del titolare di un piccolo possesso il penus (la scorta domestica) difficilmente eccedeva il consumo famigliare chi fortunato raccoshyglieva piugrave dellannona famigliare e di quanto gli serviva per il campo era spinto a venderselo nei mesi immediatamente successivi alla mietitura e alla trebbiatura per necessitagrave di denaro ma anche per la difficoltagrave di stoccare e conservare il prodotto in condizioni ottimali (MEUVRET 1988 17-9 Pmr QUAGUA 1984 88) e financo per ridurre il rischio di vederselo soffiare da vagabondi e malintenzionati In questo caso in presenshyza di eccedenze (ma probabilmente anche in assenza) il bisogno di liquiditagrave e 1alea cospiravano nel ridl1rre ai minimi termini le scorte giagrave allindomani del raccolto In caso alternativo il contadino che non egrave - ripete Jean Meuvret - un homme daffaires quanshyto un homme de peur concepiva la sua riserva come un fondo di previdenza sul racshycolto futuro da non immettere sul mercato se non nel caso dellapprossimarsi di una messe sicura secondo una logica economica a contrario (MEUVRBT 1988 19 e 147)
Era Hltente la disparitagrave fra i produttori non solo fra chi era in possesso di eccedenshyze e chi non lo era ma piugrave ancora fra chi poteva scegliere - in virtugrave di una maggiore capienza economica e un adeguata dotazione tecnica - il mercato piugrave favorevole per i propri grani (il periodo di saldatura dei raccolti) e chi invece li cedeva troppo presto o in controtempo a livelli non ottimali
Nella gerarchia delle abitazioni rurali -- in quel vero e proprio saggio di sociologia che egrave il sesto libro del De Architectura di Sebastiano Serlio (scritto fra il 1537 e il 1555 inedito per tutto levo moderno) - per trovare case attrezzate di granaio occorshyreva ascendere sino alla magione del basso mercante o cittadino fuori della cittagrave (SERLIO 1994 43 segg anche per le successive informazioni) Condizione di cui non potevano fregiarsi invece i ricchi contadini in ~ssuno dei tre gradi possibili di ricshychezza al massimo la loro casa poteva es~ere attrezzata di portici per ricoverare le biade e di unaia per batterle segni di distinzione giagrave fra i mediocri contadini Fra questi perograve avrebbero potuto avvalersene soltanto i fortUIgravelati et di beni et di famishyglia (3deg grado di mediocritagrave) Dforno per cuocere il pane e una cantina per conservashyre il vino invece li si sarebbe trovati a partire dai piugrave accomodati fra i poveri contashydini cioegrave al 4deg gradino della scala sociale alla cui base erano da collocare i poveri mendichi con vil capanna (1deg grado di povertagrave) i salariati che vivevano delle [loro] fatiche avendo un puoco di terreno (2deg grado di povertagrave) i poveri con qualche beshylitiuola et massimamente de buovi possessori di una stalletta congiunta con la casa (3deg grado di povertagrave) In sintesi nelle campagne delletagrave pre-industriale pochi avevano scorte pochissimi
erano in grado di ricoverarle in un solaro privilegiatissimo chi le incanevava per speculare Dunque fra i contadJni se si esclude quanto celato nella madia o nella dishyspensa le scorte erano un pri~ilegio di pochi Il Sedio nato intorno al 1475 insiste sullimpoverimento delle class~ rurali intervenuto fra gli anni della sua giovinezza e quelli della vecchiezza in cui segraverive Sotto il titolo Dellabitazione del ricco contadishyno per tre gradi di ricchezza si preoccupa di puntualizzare
bencheacute al digrave dogi non se ne truovi piugrave de tali merceacute delle discordie et di gli animi fieri et ostinati alla vendetta onde per tal cagioni et per le continue guerre et anche pei citadini divoratori de gli altrui beni che con le usure con glinganni con le rapine gli hano impoveriti (SERllO 1994 48)
492 497 Renzo P COlTitore
Tale disparitagrave sociale si riverberava sulla struttura del conunercio cerealicolo La funzione dei piccoli conunercianti di biade (granaioibiadaiolijarinaioli balshy
zarotti cavallanti vaticali ecc) era infatti ancillare alla capacitagrave di affacciarsi sul nercato della fascia marginale dei possidenti con eccedenze Solo che nelle annate di
abbondanza si verificavano ingorghi nellofferta di grano che deprimevano i prezzi e incentivavano i piccoli produttori a smerciare direttamente le eccedenze allindomani del raccolto nellarea urbana anche al di fuori dei luoghi deputati (MA1TOZZl 1983 278 281-2 300n PULT QuAGLIA 1984 86) Mentre nelle annate di penuria si contraeshyva drasticamente proprio questo segmento dellofferta (ABEL (1966J 22-4 KULA (1962] 73-4 CATIINI 1984 111-23 PuLT QUAGLIA 1984 88) scatenando nelle campashygne una caccia al grano-merce la cui quota piugrave consistente era detenuta dai grandi proprietari dai maggiori affittuari dai percettori di canoni diritti o rendite in grano e la cui quota residua era piugrave facilmente preda di chi occupava posizioni chiave nellasshysetto terriero nella catena dei diritti nel credito alla produzione e al consumo
Tanto la distribuzione era frammentata nelle annate di abbondanza tanto in epoclshydi penuria il conunercio del grano diventava un affare di pochi In questo caso lazioshyne dei mercanti diventava dimpiccio sul mercato interno dove la coperta si restringeshyva per i proprietari e gli imprenditori agricoli (KULA (1962J 56-61 CATIINI 1984 114-8) - dove la necessitagrave di ricorrere al credito da parte dei piccoli possessori pOneva questi nelle mani degli agenti dei proprietari dei percettori di canoni diritti o rendite - dove i piccoli proprietari vedevano minacciata la loro stessa condizione da parte di chi controllava localmente in maniera capillare e decentrata il mercato del denaro e dei beni necessari alla riproduzione (sernenti strumenti cibo) La soluzione era quelshyla di precludere amministrativamente ai sensali e ai conunercianti di grani i mercati locali su istigazione dei medi possessori le cui occasioni di normale profitto agrario soffrivano un ridimensionamento e che si vedevano costretti a impegnarsi ccedilontiltte le loro forze per integrare le proprie entrate accaparrandosi le magre eccedenze disponishybili nelle campagne e nei borghi rurali (PuLT QUAGLIA 1984 84-8 PuLT QUAGLIA 1990 107-14)
Il destino dei piccoli conunercianti in grano era quindi quello di occupare una posishyzione marginale nel mercato del grano (MEUVRET 1977 30 PINTO 1978 13 MATTOZZI 1983 277) e di operare non solo a causa degli ordinamenti annonari - secondo una logica di corto respiro in cui non era contemplata neacute la conservazione di grani a lungo termine neacute lutilizzo di depositi piugrave che provvisori Come per i piccoli possidenti non si puograve parlare nel loro caso della formazione e del mantenimento di scorte consistenti (MEUVRET 1988 156-7) Non tali comunque da sostenere il reddito contadino nelle stagioni ordinarie e da esercitare sul versante cittadino unefficace azione anticonshygiunturale in caso di carestia
Peraltro in cittagrave la struttura dellofferta era anche piugrave sperequata di quella che si rishyscontra nel contado Che si tratti di Prato ne) 1339 (PlNTO 1978 129 PINTO 1982 160n e 171n) Pavia negli anni 1539 1555 1573 1602 1603 (ZANIITTI 1963) o Mantova nellultima parte del secolo XVI (CORRITORE 2000 81-9) la distribuzione delle scorte fra i privati era singolarmente ineguale Lo attesta la rilevanza nellarea urbana della povertagrave cioegrave secondo una definizione coeva di coloro che non vivono di entrate ma sono necessitati ricorrere mattina e sera alle pistorie a comprare il pane per il vitto loro e delle sue famiglie col denaro che di giorno in giorno si vanno guadagnando (MATshyTOZZI 1983 281) PUOgrave essere utile richiamare la situazione delle cittagrave tedesche nel basso Medioevo in una fase che egrave stata definita da Wilhelm Abel l epoca doro degli artigiani e del lavoro salariato si puograve stimare che almeno la metagrave degli iscritti ai
il costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica ecol1Omica degli stati
te con il principio della piazza Il mercato pubblico periodico disciplinato la spiagshygia la piazza la loggia o il recinto riservato alle contrattazioni - coesisteva confabshybriche magazzini ebotteghe La stessa piazza per funzionare al meglio secondo il principio dello scambio diretto necessitava di magazzini di supporto
4 LE SCORTE DEI FORNAI CITTADINI
Nellarea urbana e nelle relazioni tra cittagrave e campagna operavano perograve temibili conshycorrenti dei privati possessori I fornai cittadini possedevano le competenze le strutshyture tecniche le relazioni sociali e il credito per incettagravere il prodogravetto per essere inforshymati tempestivamente sul mercato del grano e potenzialmente per dispensarlo con profitto in qualunque momento Il fatto che il loro operato fosse imprigionato in un arshycaica impalcatura di norme divieti obblighi che risalivano alletagrave romana che ne fashycevano in modograve quasi istituzionalizzato il capro espiatorio delle tensioni fra produtshytori di grano povertagrave e autoritagrave non impedisce di affermare che tali vessatorie disposizio~i trovassero la loro principale ragione dessere nella parte che essi giocashyvano di interlocutorilantagonisti dei proprietari terrieri nella determinazione del prezshyzo del grano sul mercato locale e nella realizzazione della rendita terriera (GUENZI 1982 35 GUENZl 1982 297)
Nel caso di Mantova terra cornucopia a partire dal 1492 si consenti a zentilhomini cittadini et qualuncho altro di comprare biade nel Dominio per approvvigionare la cittagrave di fatto si sancigrave un diritto allincetta che mise fuori gioco i fornai a cui venne imposto di rifornirsi nei solari dei cittadini senza avere piugrave la possibilitagrave di effettuare acquisti nel contado e di ritenere a casa scorte superiori a 100 staia di frumento Lintento della disposhysizione egrave chiarissimo espresso senza reticenze dai Maestri delle Entrate che riportarono al marchese la soddisfazione dei possidenti mantovani per la riforma statutaria
tutta la Terra (cioegrave il Mantovano] ne (egrave] rimasta satisfactissima pensando che Vostra Excellentigravea pretenda ali comodi et utilitagrave universale senza dampno et preuiditio suo Vero egrave che li fumari non si contentano parendoli comegrave il vero che non si poteranno ingrnssar asuo modo come hanno facto per il passato et poterigravea Igravelchader ( ] che veneranno adolershyse et supplicar aVostra Signoria Perograve me egrave parso dargene aviso per questa nostra et farli intender che questa terra ha soliigrave due membri de li quali li cittadini soi se ne possono aiutashyre e valersene uno egrave il grano laltro egrave larte de la lana et quando se concedesse che li furshyDari potessero comprare come h~o facto li tempi passati sana un fare beneficio acinquanshytaocto dessi et dampnifichar elresto de fa republica sua quale de questo ban ordine ne receve emolumento grandissimo et se gaude in la Citagrave [percheacute] li fumari portano fuora el denaro et pretendono solo a suo benefitio (AG b 2441 lettera del 13 luglio 1492)
Egrave indubbio che il plauso della Terra fosse da attribuire piugrave alla possibilitagrave per i proshyprietari di accrescere le proprie entrate che a quella dei consumatori cittadini e dell arte della lana di trarre beneficio dalla disposizione Egrave significativo che la motivazione pro cigravevitate non accenni allesistenza di monopoli da parte dei fornai o di artificiose lievitashyzioni dei prezzi per causa loro Il loro attivismo non confiiggeva per quanto riguarda i prezzi finali della sussistenza con linteresse dei produttori cittadini E daltra parte largomento dellQ storno dal merpato cittadino dei profitti incamerati dai fornai -laccushysa consueta a proposito dei pistores egrave che fossero in gran parte stranieri (GUENZII982 22) -- era una giustificazione debole che appassionava piugrave chi concorreva direttamente
496 493
Renzo P Corritore
appare altrettanto astratto dogmatico o virtuale del principio di mercato (Market Pri1lciple) che il medesimo gli contrappone Henri Pirenne parlando della politica annonaria dei comuni medievali avverte Lapplicazione del principio della vendita diretta ebbe numerosi eccezioni (PumNNE [1933] 193n)
Nel caso di Mantova la scelta della Piazza egrave facoltativa per i terrieri COn eccedenze Gli Statuti signorili che si rifanno largamente alle raccolte statutarie comunali non sancivano alcun obbligo in proposito (v SVJUTI BONACOLSIANI [1313] libro m rubr 55 De mercato blave 253 STATlITl GoNZAOHESCHI [1404J libro m rubr 93 De mercato blave fiendo in civitate Mantue f 73v) Decreti di carattere straordinario e regolamenshytazioni transitorie correggevano il tiro Nel 1405 in piena saldatura dei raccolti si c0shy
strinse a rifornire forzosamel)~ la piazza concentrandovi tutte le contrattazioni Nel 1417 si obbligograve a riservare al mercato un terzo del frumento introdotto in cittagrave (CORRIshyTORE 2000 235-6) Ma sono atti straordinari che non sopravvissero nel migliore dei casi piugravedi qualchelustro (MANroVA 1430 88 90 181) A Mantova la Piazza era affianshycata da un granaio pubblico la Domus del mercato (altrove definito Folllico o Fonrego del mercato) in cui avrebbero dovuto prolungarsi le contrattazioni oltre lorario e i giorshyni deputati (venerdigrave o sabato) rendendo disponibile ciograve che restava invenduto e che non poteva essere ritirato per legge dal mercato Nel 1430 eminenti cittadini sollecitati dal principe lamentavano perograve lincapacitagrave del magazzino - inoperoso in tutto o in parte per il pericolo di crolli -- di rispondere ai bisogni del popolo in una situazione in cUi da parte dei possessori si protestava la difficoltagrave di non poter esitare e smerciare fuori delshyla cittagrave le eccedenze conservate nei solari privati
Item videtur quod valde utille foret civibus Mantue habentibus possessiones et quishybuscumque alijs personis de civitate Mantue aut districtu colligantibus bIada et vina in magna copia ut omni tempore ipsa bIada et vinum possent extrahere de civitate et dishystrictu Mantue et conducere ad Iaea ad que et in quibus ma vendere poterunt cum otdishynibus et dacijs competentibus ipsa tamen civitate semper remanente fulta pro usu dicte civitatis et populi eiusdem ne dieta biada marceschant super granarlis ut hactenus feceshyrunt cum maximo incomodo ipsorum civium (MANTOVA 1430 177-8)
nmedesimo fondaco abbinato al mercato operava a Verona a Ferrara a Vegravenezia a Udine a Chioggia in molte altre cittagrave (MANToVA 1430 100 FORNASIN 1999 7-9 CEshySTAR 1794)
Lintegrale e pedissequa applicazione del principio della piazza di mercato comporshytava - per i vincoli tecnici dell etagrave pre-industriale -la massima affermazione del prinshycipio della canova cioegrave del magazzino pubblico centrale Unico argine alla sua invashydenza era costituito da una distribuzione perequata ab imis del raccolto cioegrave la possibilitagrave - egrave questo il paradosso - di realizzare da parte dei produttori la massima aspirazione nelle societagrave tradizionali lautarchia domestica Piugrave avanzava invece la sperequazione nel reddito e nel patrimonio piugrave da parte dei consumatori privi di scorshyte si impetrava il principio del Magazzino pubblico nella ronna di un efficiente sisteshyma di ricovero conservazione distribuzione delle derrate a garanzia del funzionashymento della Piazza di mercato La disponibilitagrave di crescenti quote di raccolto tuttavia indirizzava i piugrave accomodati verso soluzioni piugrave ghiotte la vendita allingrosso sul mercato cittadino ai fornai o allimpresa pubblica creata a sussidio di questi (o in loro vece) Oppure allopposto lesito delle eccedenze extra muros sui grandi mercatishyemporio regionali per il tramite di mercanti o agenti diretti
Il principio del magazzino pubblico centrale cioegrave laccumulazione di riserve per lo smercio continuo o anticiclico egrave quindi alla sua origine in opposizione solo apparen-
La costirU1ione di scorre granarie pubbliche e la politica economica degli srati
ruoli fiscali non fosserograve in grado di accantonare scorte Nel 1444 a Strasburgo quattro cittadini su dieci non possedevano alcuna riserva cerealicola (DRlMBIER 1984 112)
Nelle cittagrave italiane delletagrave moderna si puograve stimare che non meno di due terzi della popolazione fosse costretta ad acquistare o consumare pane confezionato con grani e farine comperati nelle piazze nelle vie e nelle botteghe cittadine oppure ottenuti come compenso del proprio servizio nelle casate (CORRrroRE 2000 126-36 MA11oZZI 1983 27~-82) Evidentemente questa fascia di lavoratori salariati non possedeva -shyper definizione - neacute scorte neacute depositi personali e nel primo caso era strettamente dipendente dal mercatograve urbano acquistando la sua sussistenza con frequenza non piugrave che settimanale (essendo costretti a comprare il pane tutti i giorni allafinestra si dishyceva a Genova [GRENDI1986 1031])
Ma anche fra i citiOdini con possesso extra moenia la distribuzione delle scorte era tuttaltro che egalitaria A Prato nel 1339
A parte gli enti religiosi sette famiglie [ ] avevano ii disposizione piugrave di mille staia di granaglie (circa 18 tonnellate) fino a un massimo di 3500 Altri venti nuciei familiashyri avevano scorte comprese tra le 500 e le 1000 staia (PINTO 1978 129n)
A Mantova nei magazzini ducali nellultima parte del 500 erano ammassati non meno di un ottavo talora piugrave di un quarto delle riserve cittadine di grani panificabili (CoRRITORE 200081-6) A Pavia nel corso dello stesso secolo e allinizio di quello successivo nei solagraveri di una sessantina di famiglie si concentrava non meno del 40 per cento dellintera offerta cittadinIgrave di frumento(ZANBUgrave11964 70-7) Anche in questo caso egrave utile sapere che nelle cittagrave tedesche esistevano mercanti (ad Augusta RatisboshyDa Norimberga) in grado di axnPmssare riserve da 6 a 45 tonnellate e che a Francoshyforte nel 1488 due patrizi totali~zavano insieme un terzo delle scorte cerealicole dei particolari nella cittagrave alta (DnuMmER 1984113)
Ritenere tali soggetti sprovv~uti al punto di incanevare grani con il solo scopo di esorc~ i pericoli della Fstia egrave perlomeno riduttivo A grandi solari comshyspondevano vaste familiae e pIftore di servi tori e ospiti ma tali scorte eccedevano largamente la sussistenza del maggiore palazzo nobiliare o patrizio senza peraltro costituire un fondo di accantonafoento eccedente il fabbisogno della cittagrave a meno che non vi fosse la concreta possibilitagrave di commercializzare il surplus sui mercati esteri Come nota infatti Adam Smith
a meno che leccedenza non possa essere esportata in tutte le circostanze ordinarie i coltivatori staranno molto attenti a non produrre e gli importatori a non importare mai una quantitagrave maggiore di quell~ che egrave strettamente richiesta dal consumo del mercato interno Questo mercato saragrave difficilmente sovrafomito ma saragrave in generale sottoriforshyDito dato che coloro che svolgqno lattivitagrave per rifomirlo avranno in generale il timore che la loro merce possa rimanete invenduta (SMlTH [1776] 528)
Lipotesi egrave suffragata dai cas~ storici conosciuti A Bologna macrodistretto serico dellevo moderno laddove gli ipteressi manifatturieri e mercantili avrebbero dovuto consigliare una sussistenza a b~on mercato per tenere basso il costo del lavoro le istituzioni annonarie operavano per garantire con il calmiero deljorme1lto la monetizshyzazione della rendita granaria dei possidenti - strutturalmente incapace di coprire il fabbisogno della cittagrave anchea rischio della carezza dei viveri contingentando il mercato dei grani forestieri (GtJFNZl1982A 37-76) Di fatto
495 494 Renzo P Corrllnre
In ogni caso si tendeva a limitare al minimo indispensabile lemiddot importazioni di frushymento per evitare che stocks invenduti potessero turbare la collocazione dei grani tershyrieri nel nuovo anno agrario (GuENZI 1981 153)
In tutti i centri comunque la tendenza a ritardare la vendita del surplus nei mesi della saldatura lutilizzo di depositi specializzati con personale addetto alla custodia al conshydizionamento e alla commercializzazione del prodotto ponevano i grandi proprietari di biade su un gradino superiore e diverso rispetto al resto della cittagrave Laccantonamento di grani per questa cupola di possessori rispondeva al principio dellutilitagrave soggettiva atshytesa e richiedeva sia capitale fisso sia capitale circolante per raggiungere gli scopipreshyfissati un profitto speculativo la valorizzazione della rendita
In molte cittagrave i possessori non avrebbero dovuto trattenere in casa piugrave grano e farina di quantoprescritto dalla legge cioegrave il consumo mensile per bocca - fissato anchesshyso statutariamente - per arrivare al nuovo raccolto Ma i cittadini credeVano veramenshyte ai loro comandamenti Egrave lecito dubitare La norma era scolpita negli Statuti e pubshyblicamente violata con la complicitagrave dll1e autoritagrave e dei groppi professionali interessati alla distribuzione del grano nelle sue ~arie forme
Nelle annate ordinarie la quota di grano auto consumato - cioegrave non acquistata sul mercato - nelle cittagrave italiane dell evo moderno rappresentava fra il 30 e il 60 per censhyto del fabbisogno urbano di frumento
Nella capitale dei Gonzaga nel 1615 si valutava che su 27000 bocche
il terzo [di] gentilhuomini fittadri servitori et altri [ ] non comprano biada et gli duoi tenigrave tra poveri artisti mercanti fomari fondachieri hebrei et altri [bull] non possono in tutto levar sufficientemente la somma de detti dua terzi sl che saranno boshychegrave 18000 che compraranno biada (COIUUTORl 2000 126)
AVenezia a cavaliere fra XVI e XVII secolo alla mensa delle casade si dispensava circa un terzo del frumento consumato ordinariamente in cittagrave (AMARD 1966 74 MATTOZZI 1983 281) ABologna per tutto il Seicento i fornai che impastavano farine in conto lavorazione per i particolari pareggiavano piugrave o meno il numero di quelli da scqffa che smerciavano pane venale (GUENZI 1982A
27) Peraltro la proporzione a Rialto tra chi lavorava per le casade e chi vendeva pane al pubblico - 65 Jo~ri a fronte di 44-48 pistori negli anni 1583-1685 (DELLA VALBNTINA 1992 143-4 167 192-3) - fa ritenere la struttura del mercato del pane felsinea non molto dissimile da quella veneziana Nelle cittagrave liguri o toscane sei-settecentesche la porzione autocon sumata quando il raccolto era buono era anche piugrave elevata (GRENDI 1986 1024-6 1034 PuLT QUAOUA 1984 98-104 PULT QUAGUA 1990 171-2) A Napoli nel 1758 a Monasteri Luoghi pii e Particolari eta riservato il 28 per cento del consumo cittadishyno di frumento (AuFANO 1996 37n)
Lelevato numero di servi domestici persone al servizio delle casate faceva sigrave che in alcuni palazzi si concentrassero masse cospicue di grano per la spesa familiare Ma accanto ad esse gli operatori dell annona -- la stessa povertagrave -- si auguravano che vi fosse sempre anche la materia per rifornireil mercato e i forni cittadinimiddot nella fase piugrave delicata del ciclo annuale il periodo di saldatura dei raccolti Come spiegare altrimenshyti la norma che imponeva ai grossi detentori di biade (non esclusi enti e opere pie) in varie cittagrave italiane dellevo moderno la vendita straordinaria in primavera dellegrave ecshycedenze ammassate in granaio (per Pisa e la Toscana v PuLT QUAGUA 1984 88-9)
A Mantova nel 1554 si stabiliva che i patroni che avessero fruito in cittagrave di piugrave di 20 sacchi di grano come porzione dominicale avrebbero dovuto coilservare in granaio
lA costituzioni digrave scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
il 4 per cento per le necessitagrave dei consumatori dei fornai e dei Jontachieri quando fosse mancato il prodotto sulla piazza o nelle offerte deisensali Nel 1603 ci si preocshycupograve di elevare la quota al 6 per cento (CORRlTQRE 2000 237n) Beninteso le vendite sarebbero avvenute ai valori di mercato Lo stesso sistema vigeva a Cremona (6 per cento nel 1608 e nel 1612) (MERON 1957 59n 63 JACOPETl1 1965 128) ea Verona Qui una delibera consiliare del 1549 autorizzava per la prima volta
[il deputati [alle Biadel [a] tassar e comandar con quelle pene che al Clarissimo Podestagrave pareragrave quella quantitagrave di biade a ciascuno secolare o eclesiastico sia di qual grado o condittione esser si voglia che havesse biade in questa cittagrave oltre il viver suo
(VOCCHIATO 1979 145)
La tassa sarebbe stata stabilita - da11558 - per sorteggio fra le casate che avessero introdotto in cittagrave dai propri possedimenti piugrave di 70 minali per rifo1llire il Mercato delle biave Essa-venne anche incrementata nella stessa occasione dal 5 al6 per censhyto per restare in vigore fino al 1631 (VECCHIATO 1979 141-58)
Quest9 tiIfo di normativa nasce e si affiogravea in ambito amministrativo perciograve echeggia la realtagrave molto meglio della veneranda legge generale
Da tali disposizioni si deducono alcuni fatti incontrovertibili 1entro la cerchia cittadina esistevano scorte private eccedenti la spesa delle famiglie
in violazione in molti casi della legge statutaria 2il possesso della terra che solo assicurava lautarchia delle casate era il piugrave-potente
fattore di discriminazione fra i cives tanto da precipitare nel girone dei pauperes la moltitudine che acquistava correntemente la sussistenza nellarea urbana
3fra gli stessi possidenti cittadini esisteva uneacutelite che non solo conservava scorte oltre il viver suo ma che si proponeva egoisticamente di speculare ritardando limshymissione dei grani sulle piazze cittadine o che a~endeva il momento piugrave opportuno per smerciarli allesterno nelle grandi piazze frumentarie come livorno Desenzashyno Legnago Romano (di Lombardia) ecc
4lineguaglianza fra i cives tese ad aggravarsi con la metagrave del 500 poicheacute questi reshygolamenti innovano quasi sempre disposizioni generali risalenti al tardo Medioevo che sancivano lobbligo di convogliare il surplus sulla piazza cittadina segno di una distribuzione del reddito originariamente meno sbilanciata A Cremona gli Statuti del 1388 obbligavano - cosl egrave ancora nel 1510 - a vendere il
sovrappiugrave in Piazza Maggiore sul mercato pubblico dei grani (MERON 1957 59n
63)A Pisa il rescritto che imponeva di effettuare le vendite al minuto in platea bladi
risale al 1401 MALANlMA 1976 293) lobbligo era ribadito ancora nel 1548 ma nella seconda metagrave del secolo XVI si affermava la pratica di vendere fuori mercato tanto che nel 1581 il Magistrato dei Nove dovette intervenire per far vendere i grani delle comunitagrave degli enti e dei luoghimiddotpii soltanto da marzo-aprile in piccole quantitagrave sul mercato (PULT QUAGUA 1984 81-91) La disposizione per altro si applicava allinteshyro Stato (PULT QUAGUA 1984 88)
Tuttavia non egrave da pensare che il principio della concentrazione delle compravendite sulla piazza di mercato cittadina fosse universale universalmente rispettato e sopratshytutto perenne La centralizzazione del grano non significa automaticamente lobbligo di vendita diretta sulla Piazza deiformenti Affermare come Steven L Kaplan che
There was no single more important regulation concerning tbe provisioning trade tban tbe requirement tbat alI transactions occur in tbe marketplace (KAPLAN 1984 27)
494 495 Renzo P Corritore
In ogni caso si tendeva a limitare al minimo indispensabile le importazioni di frushymento per evitare che stocks invendutigrave potessero turbare )a collocaziolle dei grani tershyrieri ileI nuovo anno agrario (GUENZI 1981 153)
In tutti i centri comunque la tendenza a ritardare la vendita del surplus nei mesi della saldatura lutilizzo di depositi specializzati con personale addetto alla custodia al conshydizionamento e alla commercializzazione del prodotto ponevano i grandi proprietari di biade su un gradino superiore e diverso rispetto al resto della cittagrave Laccantonamento di grani per questa cupola di possessori rispondeva al principio dellutilitagrave soggettiva atshytesa e richiedeva sia capitale fisso sia capitale circolante per raggiungere gli scopipreshyfissati un profitto speculativo la valorizzazione della rendita
In molte cittagrave i possessori non avrebbero dovuto trattenere in casa piagrave grano e farina di quantoprescritto dalla legge cioegrave il consumo mensile per bocca ~- fissato anchesshy
so statutariamente --per arrivare al nuovo raccolto Ma i cittadini credevano veramenshyte ai loro comandamenti Egrave lecito dubitare La norma era scogravelpitagrave negli Statuti e pubshyblicamente violatamiddot con la complicitagrave dccedillle autoritagrave e dei gruppi professionali interessati alla distribuzione del grano nelle sue varie forme
Nelle annate ordinarie la quota di grano autoconsumato - cioegrave non acquistata sul mercato - nelle cittagrave italiane dell evo moderno rappresentava fra il 30 e i160 per censhyto del fabbisogno urbano di frumento
Nella capitale dei Gonzaga nel 1615 si valutava che su 27000 bocche
il terzo [di] gentilhuomini ligravettadri servitori et altri [ ] non comprano biada et gli duoi terzi tra poveri artisti mercanti fomari fondachieri hebrei et altri [ l non possono in tutto levar sufficientemente la $omma de detti dua terzi sl che saranno boshyche 18000 che compraranno biada (CoRRlTORB 2000 126)
AVenezia a cavaliere fra XVI e xvn secoioalla mensa delle casade si dispensava circa un terzo del frumento consumato ordinariamente in cittagrave (AYMARD 1966 74 MArroZZI 1983 281) A Bologna per tutto il Seicento i fornai che impastavano farine in conto lavorazione per i particolari pareggiavano piil o meno il numero di quelli da scaifa che smerciavano pane venale (GUBNZI 1982 27) Peraltro la proporzione a Rialto tra chi lavorava per le casade e chi vendeva pane al pubblico - 65 fOf7lri a fronte di 44-48 pistori negli anni 1583-1685 (DELLA VAUNTINA 1992 143-4167 192-3) - fa ritenere la struttura del mercato del pane felsinea non molto dissimile da quella veneziana Nelle cittagrave liguri o toscane sei-settecentesche la porzione autoconshysumata quando il raccolto era buono era anche piil elevata (ORENOI 1986 1024-6 1034 PuLT QUAGLIA 1984 98-104 PULT QUAOLIA 1990 171-2) A Napoli nel 1758 a Monasteri Luoghi pii e Particolari eta riservato il 28 per cento del consumo cittadishyno di frumento (AuFANO 1996 370)
Lelevato numero di servi domestici persone al servizio delle casate faceva si che in alcuni palazzi si concentrassero masse cospicue di grano per la spesa familiare Ma accanto ad esse gli operatori dellannona -lastessapovertagrave __ si auguravano che vi fosse sempre anche la materia per rifornire il mercato e i forni cittadini nella fase piil delicata del ciclo annuale il periodo di saldatura dei raccolti Come spiegare altrimenshyti la norma che imponeva ai grossi detentori digrave biade (non esclusi enti e opere piegrave) in varie cittagrave italiane dellevo moderno la vendita straordinaria in primavera delle ecshyredenze ammassate in granaio (per Pisa e la Toscana v PuLT QUAGLIA 1984 88-9)
A Mantova nel 1554 si stabiliva che i patroni che avessero fruito in cittagrave di piugrave di 20 sacchi di grano come porzione dominicale avrebbero dovuto conservare in granaio
lA costituzione di SC0114 granarie pubbliche e la politica economica degli stati
il 4 per cento per le necessitagrave dei consumatori dei fornai e dei fontachieri quando fosse mancato il prodotto sulla piazza o nelle offerte deimiddotsensati Nel 1603 ci si preocshycupograve di elevare la quota al 6 per cento (CoRRlTORE 2000 237n) Beninteso le vendite sarebbero avvenute ai valori di mercato 10 stessa sistema vigeva a Cremona (6 per cento nel 1608 e nel 1612) (MERON 1957 -59n 63 JACOPETl11965 128) ea Verona Qui una delibera consiliare del 1549 autoruzava per la prima volta
[i] deputati [alle Biade) [al tassar e comandar con quelle pene che al Clarissimo Podestagrave pareragrave quella quantitagrave di biade a ciascuno secolare o eclesiastico sia di qual grado o condittione esser si voglia che havesse biade in questa cittagrave oltre il viver suo (VBCClI1ATO 1979 145)
La tassa sarebbe stata stabilita - dal 1558 - per sorteggio fra le casate che avessero introdotto in cittagrave dai propri possedimenti piagrave di 70 minali per rifornire il Mercato delle biave Essaveane anche incrementata nella stessa occasione dal 5 al6 per censhyto per restare in vigore fino al 1631 (VECCHIATO 1979 141-58)
Questccedil tijlo di normativa nasce e si affuia in ambito amministrativo perciograve echeggia la realtagrave molto meglio della veneranda legge generale
Da tali disposizioni si deducono alcuni fatti incontrovertibili 1entro la cerchia cittadina esistevano scorte private eccedenti la spesa delle famiglie
in violazione in molti casi della legge statutaria 2il possesso della terra che solo assicurava lautarchia delle casate era il piugravemiddotpotente
fattore di discriminazione fra i cives tanto da precipitare nel girone dei pauperes la moltitudine che acquistava correntemente la sussistenza nellarea urbana
3fra gli stessi possidenti cittadini esisteva uneacutelite che non solo conservava scorte oltre il viver suo ma che si proponeva egoisticamente di speculare ritardando limshymissione dei grani sulle piazze cittadine o che a~endeva il momento piagrave opportuno per smerciarli allesterno nelle grandi piazze frumentarie come Uvorno Desenzashyno Legnago Romano di Lombardia) ecc
4lineguaglianza fra i cives tese ad aggravarsi con la metagrave del 500 poicheacute questi reshygolamenti innovano quasi sempre disposizioni generali risalenti al tardo Medioevo che sancivano lobbligo di convogliare il surplus sulla piazza cittadina segno di una distribuzione del reddito originariamente meno sbilanciata shyACremona gli Statuti del 1388 obbligavano - cosl egrave ancora nel 1510 - a vendere il
sovrappigraveagrave in Piazza Maggiore sul mercato pubblico dei grani (MERON 1957 59n 63)
A Pisa il rescritto che imponeva di effettuare le vendite al minuto in platea bladi risale al 1401 (MALANIMA 1976 293) lobbligo era ribadito ancora nel 1548 ma nella seconda metagrave del secolo XVI si affermava la pratica di vendere fuori mercato tanto che nel 1581 il Magistrato dei Nove dovette intervenire per far vendere i grani delle comunitagrave degli enti e dei luoghi pii soltanto da marzo-aprile in piccole quantitagrave sul mercato (PULT QUAGLIA 1984 8191) La disposizione per altro si applicava allinteshyro Stato (PULT QUAGLIA 1984 88)
Tuttavia non egrave da pensare che il principio della concentrazione delle compravendite sulla piazza di mercato cittadina fosse universale universalmente rispettato e sopratshytutto perenne La centralizzazione del grano non significa automaticamente lobbligo di vendita diretta sulla Piazza deiformenti Affermare come Steven L Kaplan che
There was no single more important regulation conceming the provisioning trade han the requirement that ali transactions occur in the marketplace (KAPuN 1984 27)
493 496 Renw P Corritore
appare altrettanto astratto dogmatico O virtuale del principio di mercato (Market Principle) che il medesimo gli contrappone Henri Pirenne parlando della politica annonaria dei comuni medievali avverte Lapplicazione del principio della vendita diretta ebbe numerosi eccezioni (PIRENNE [1933] 193n)
Nel caso di Mantova la scelta della Piazza egrave facoltativa per i terrieri con eccedenze GliStatuti signorili che si rifanno largamente alle raccolte statutarie comunali non sancivano alcun obbligo in proposito (v SYJI1l BONACOLSlANI [1313] libro ID rubr 55 De mercato blave 253 STATUTI GoNZAOHESCHI [1404] libro m rubr 93 De mercato blave fiendo in civitate Mantue f 73v) Decreti di carattere straordinario e regolamenshytazioni transitorie correggevano il tiro Nel 1405 in piena saldatura dei raccolti si coshystrinse a rifornire forzosamen~e la piazza concentrandovi tutte le contrattazioni Nel 1417 si obbligograve a riservare al mercato un terzo del frumento introdotto in cittagrave (CoRRIshyTORE 2000 235-6) Ma sono atti straordinari che non sopravvissero nel migliore dei casi piugrave di qualchelustro (MANToVA 1430 88 90 181) A Mantova la Piazza era affianshycata da un granaio pubblico la Domus del mercato (altrove definito Fornico o Fontego del mercato) in cui avrebbero dovuto prolungarsi le contrattazioni oltre lorario e i giorshyni deputati (venerdl o sabato) rendendo disponibile ciograve che restava invenduto e che non poteva essere ritirato per legge dal mercato Nel 1430 eminenti cittadini sollecitati dal principe lamentavano pero lincapacitagrave del magazzino - inoperoso in tutto o in ~per il pericolo di crolli - di rispondere ai bisogni del popolo in una situazione in cui da parte dei possessori si protestava la difficoltagrave di non poter esitare e smerciare fuori delshyla cittagrave le eccedenze conservate nei solari privati
ltem videtur quod valde utille foret civibus Mantue habentibus possessiones et quishybuscumque alijs personis de civitate Mantue aut districtu colligantibus bIada et vina in magna copia ut amni tempore ipsa bIada et vinum possent exttahere de civitate et dishystrictu Mantue et conducere ad Iaea ad que et in quibus illa vendere poterunt cum otdigraveshynibus et dacijs competentibus ipsa tamen civitate semper remanente fulta pro usu diete civitatis et populi eiusdem ne dicta bIada mateeschant super granariis ut hactenus fecemiddot runt cum maximo incomodo ipsorum civium (MANToVA 1430 177-8)
Il medesimo fondaco abbinato al mercato operava a Verona a Ferrara a Venezia a Udine a Chioggia in molte altre cittagrave (MANToVA 1430 100 FORNASIN 1999 7-9 CBshySTARl1794)
Lintegrale e pedissequa applicazione del principio della piazza di mercato comporshytava - per i vincoli tecnici dell etagrave pre-industriale -la massima affermazione del prinshycipio della canova cioegrave del magazzino pubblico centrale Unico argine alla sua invashydenza era costituito da una distribuzione perequata ab imis del raccolto cioegrave la possibilitagrave egrave questo il paradosso di realizzare da parte dei produttori la massima aspirazione nelle societagrave tradizionali lautarchia domestica Piugrave avanzava invecela sperequazione nel reddito e nel patrimonio piugrave da parte dei consumatori privi di scorshyte si impetrava il principio del Magazzino pubblico nella forma di un efficiente sisteshyma di ricovero conservazione distribuzione delle derrate a garanzia del funzionashymento della Piazza di mercato La disponibilitagrave di crescenti quote di raccolto tuttavia indirizzava i piugrave accomodati verso soluzioni piugrave ghiotte la vendita allingrosso sul mercato cittadino ai fornai o allimpresa pubblica creata a sussidio di questi (o in loro vece) Oppure allopposto lesito delle eccedenze extra muros sui grandi mercatishyemporio regionali per il tramite di mercanti o agenti diretti
Il principio del magazzino pubblico centrale cioegrave laccumulazione di riserve per lo smercio continuo o anticiclico egrave quindi alla sua origine in opposizione solo apparen-
La costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
ruoli fiscali non fossero in grado di accantonare scorte Nel 1444 a Strasburgo quattro cittadini su dieci non possedevano alcuna riserva cerealicola (DIIUMBIER 1984 112)
Nelle cittagrave italiane delletagrave moderna si puograve stimare che non meno di due terzi della popolazione fosse costretta ad acquistare o consumare pane confezionato con grani e farine comperati nelle piazze nelle vie e nelle botteghe cittadine oppure ottenuti come compenso del proprio servizio nelle casate (CoRRITORE 2000 126-36 MAnoZZI 1983 27~-82) Evidentemente questa fascia di lavoratori salariati non possedevashyper definizione -- neacute scorte neacute depositi personali e nel primo caso era strettamente dipendente dal mercato urbano acquistando la sua sussistenza con frequenza non piugrave che settimaIIgraveale (essendo costretti a comprare il pane tutti i giorni alla finestra si dishyceva a Genova (GRENDI 1986 1031])
Ma anche fra i citUutini con possesso extra moenia la distribuzione delle scorte era tuttaltro che egalitaria A Prato nel 1339
A patte gli enti religiosi sette famiglie [ bull ] avevano Il disposizione piugrave di mille staia di granaglie (circa 18 tonnellate) fino a un massimo di 3500 Altri venti nuclei familiashyri avevano scorte comprese tra le SOOe le 1000 staia (PINTO 1978 129n)
A Mantova nei magazzini ducali nellultima parte del 500 erano ammassati non meno di un ottavo talora piugrave di un quarto delle riserve cittadine di grani panificabili (CORRlTORE 2000 81c6) A Pavia nel corsq dello stesso secolo e allinizio di quello successivo nei sozagraveri di una sessantina di famiglie si concentrava non meno del 40 per cento dell intera offerta cittadin8 di frumentomiddot (ZANJin 1964 70-7) Anche in questo caso egrave utile sapere che nelle cittagrave tedesche esistevano mercanti (ad Augusta Ratisboshyna Norimberga) in grado di ~sare riserve da 6 a 45 tonnellate e che a Francoshyforte nel 1488 due patrizi totalizzavano insieme un terzo delle scorte cerealicole dei particolari nella cittagrave alta (DlRLMB1ER 1984113)
Ritenere tali soggetti sprovv~duti al punto di incanevare grani con il solo scopo di esorcizzare i pericoli della clarestia egrave perlomeno riduttivo A grandi solari corrishyspondevano vaste familiae e plftore di servitori e ospiti ma tali scorte eccedevano largamente la sussistenza del D-aggiore palazzo nobiliare o patrizio senza peraltro costituire un fondo di accantofilljnento eccedente il fabbisogno della cittagrave a meno che non vi fosse la concreta possibfjitagrave di commercializzare il surplus sui mercati esteri Come nota infatti Adam Smith
a meno che leccedenza non possa essere esportata in tutte le circostanze ordinarie i coltivatori staranno molto attenti a non produrre e gli importatori a non importare mai una quantitagrave maggiore di quell~ che egrave strettamente richiesta dal consumo del mercato interno Questo mercato saragrave difficilmente sovrafornito ma saragrave in generale sottomorshynito dato che coloro che svolgono lattivitagrave per mornirlo avranno in generale il timore che la loro merce possa rimane~ invenduta (SMITH[l776] 528)
Lipotesi egrave suffragata dai cas storici conosciuti A Bologna macrodistretto serico dellevo modemoladdove gli interessi manifatturieri e mercantili avrebbero dovuto consigliare una sussistenza a b~on mercato per tenere basso il costo del lavoro le istituzioni annonarie operavano per-garantire con il calmiero delformento la monetizshyzazione della rendita granaria dei possidenti - strutturalmente incapace di coprire il fabbisogno della cittagrave - anche ~ rischio della carezza dei viveri contingentando il mercato dei grani forestieri (GupaI 1982 37-76) Di fatto
492 Renzo P COITitore
Tale disparitagrave sociale si riverberava sulla struttura del commercio cerealicolo La funzione dei piccoli commercianti di biade (granaiolibull biadaiolifarinaioli balshy
zarotti cavallanti vatlcali ecc) era infatti ancillare alla capacitagrave di affacciarsi sul nercato della fascia marginale deipossidenti con eccedenze Solo che nelle annate di abbondanza si venficavano ingorghi nell offerta di grano che deprimevano i prezzi e incentivavano i piccoli produttori a smerciare direttamente le eccedenze allindomani del raccolto nellarea urbana anche al di fuori dei luoghi deputati (MATI02ZI 1983 278281-2 300n PULr QUAGLIA 1984 86) Mentre nelle annate di penuria si contraeshyva drasticamente proprio questo segmento dellofferta (ABa [1966Jmiddot 22-4 KULA [1962J 73-4 CATrINI1984 111-23 PuIr QUAGUA 1984 88) scatenando nelle campashygne una caccia al grano-merce la cui quota piugrave consistente era detenuta dai grandi proprietari dai maggiori affittuari dai percettori di canoni diritti o rendite in grano e la cui quota residua era piugrave facilmente preda di chi occupava posizioni chiave nellasshysetto terriero nella catena dei diritti nel credito alla produzione e al consumo
Tanto la distribuZione era frammentata nelle annate di abbondanza tanto in epoc~ di penuria il commercio del grano diventava un affare di pochi In questo caso lazioshyne dei mercanti diVentava dimpiccio sul mercato interno dove la coperta si restringeshyva per i proprietari e gli imprenditori agricoli (KULA [1962] 56-61 CATl1NI 1984 114-8) - dove la necessitagrave di ricorrere al credito da parte dei piccoli possessori poneva questi nelle mani degli agenti dei proprietari dei percettoridi canoni diritti o rendite - dove i piccoli proprietari vedevano minacciata la loro stessa condizione da parte di chi controllava localInente in maniera capillare e decentrata il mercato del denaro e dei beni necessari alla riproduzione (sementi strumenti cibo) La soluzione era quelshyla di precludere amministrativamente ai sensali e ai commercianti di grani i mercati locali su istigazione dei medi possessori le cui occasioni di normale profitto agrario soffrivano un ridimensionamento e che si vedevano costretti a impegnarsi ccedilon tutte le loro forze per integrare le proprie entrate accaparrandosi le magre eccedeiiZe disponishybili nelle campagne e nei borghi rurali (PuLT QUAGLIA 1984 84-8 PULT QUAGLIA 1990 lO7-14)
TI destino dei piccoli commercianti in grano era quindi quello di occupare una posishyzione margilJale nel mercato del grano (MBlNrurr 1977 30 PINTO 1978 13 MAITOZZl 1983 277) e di operare - non solo a causa degli ordinamenti annonari - secondo una logica di corto respiro in cui non era contemplata neacute la conservazione di grani a lungo termine neacute lutilizzo di depositi piugrave che provvisori Come per i piccoli possidenti non si puograve parlare ne1loro caso della formazione e del mantenimento di scorte consistenti (MBlNREr 1988 156~7) Non tali comunque da sostenere il reddito contadino nelle stagioni ordinarie e da esercitare sul versante cittadino unefficace azione anticonshygiunturale in caso di carestia
Peraltro in cittagrave la struttura dellofferta era anche piugrave sperequata di quella che si rishyscontra nel contado Che si tratti di Prato nel 1339 (PINTO 1978 129 PINTO 1982 160n e 17In) Pavia negli anni 1539 1555 1513 1602 1603 (ZANEm 1963) o Mantova nellultima parte del secolo XVI (CORRITORE 2000 81-9) la distribuzione delle scorte fra i privati era singolarmente ineguale Lo attesta la rilevanza nellarea urbana della povertagrave cioegrave secondo una definizione coeva di coloro che non vivono di entrate ma sono necessitati ricorrere mattina e sera alle pistorie a comprare il pane per iI vitto loro e delle sue famiglie col denaro che di giomo in giomo si vanno guadagnando (MATshyTOZZI 1983 281) PUOgrave essere utile richiamare la situazione delle cittagrave tedesche nel basso Medioevo in una fase che egrave stata definita da Wilhelm Abellepoca doro degli artigiani e del lavoro salariato si puograve stimare che almeno la metagrave degli iscritti ai
lA costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli statibull middot497
te con il principio della piazza TI mercato pubblico periodico disciplinatola spiagshygiala piazza la loggia o iI recinto riservato alle contrattazioni - coesis~va confabshybriche magazzini e botteghe La stessa piazza per funzionare al meglio secondo il principio dello scambio diretto necessitava di magaZzini di supporto bull
4 LE SCORTE DEI FORNAI CITTADINI
Nellarea urbanagrave e nelle relazioni tra cittagrave e campagna operavano perograve temibili conshycorrenti dei privati possessori I fornai cittadini possedevano le competenze le strutshyture tecniche le relazioni sociali e il credito per incettagravere il prodotto per essere inforshymati tempestivamentesul mercato del grano e potenzialmente per dispensarlo con profitto in qualunque momento Il fatto che il loro operato fosse imprigionato in unarshycaica impalcatura di norme divieti obblighi che risalivano alletagrave romana che ne fashycevano in modo quasi istituzionalizzato il capro espiatorio delle tensioni fra produtshytori di grano povertagrave e autotitagrave non impedisce di affermare che tali vessatorie disposiziograveD1 trovassero la loro principale ragione dessere nella parte che essi giocashyvano di interlocutorilantagonisti dei proprietari terrieri nelladeterminazione del prezshyzo del grano sul mercato locale e nella realizzazione della rendita terriera (GUENZI 19824
35 GUENZI 1982 297) Neacutel caso di Mantova terra comucopia a partire dal 1492 si consend a zentilhomini
cittadini et qualuncho altro di comprare biade nel Dominio per approvvigionare la cittagrave di fatto si sand un diritto allincetta che mise fuori gioco i fornai a cui venne imposto di rifornirsi nei solarimiddotdei cittadini senza avere piugrave la possibilitagrave di effettuare acquisti nel contado e di ritenere a casa scorte superiori amiddotl 00 staia di frumento Lintento della disposhysizione egrave chiarissimo espresso senza reticenze dai Maestri delle Entrate che riportarono al marchese la soddisfazione dei possidenti mantovani per la riforma statutaria
tutta la Terra [cioegrave il Mantovano] ne [egravel rimasta satisfactissirna pensando che Vostra Excellenilii pretenda ali comodi et utilitagrave universagrave1e senza dampno et preuiditio suo Vero egraveche li fumari non si contentano parendoli comegrave il vero che non si poteranno ingrassar a suo modo come haqno factO per il passato et poteria achader [bulll Che venetanno adolershyse et supplicar aVosUa Signoria Perograve me egrave parso d~ene aviso per ques~ nostra et farli inteni1er Che questaterril ha solii due membri de li quali li cittadini soi se ne possono aiutashyre e valersene uno egrave il grano laltro egrave larte de la lana et quando se concedesse che li furshynari potessero comprare come hapno facto li tempi passati sana un fare benefitio acinquanshytaocto dessi et dampnificharelreslO de la republicasua quale de questo bon ordine ne receve emolumento grandissimo et se gaude in la Citagrave [percheacute] li fumari portano fuora el denaro et pretendono solo a suo benefitio (AG b 2441 lettera del 13 luglio 1492)
Egrave indubbio che il plauso della Terra fosse da attribuire piugrave alla possibilitagrave per i proshyprietari di accrescere le proprie entrate che a quella dei consumagravetori cittadini e dell arte della lana di trarre beneficio daJla disposizione Egrave significativo che la motivazione pro civitate nori accenni allesistenza di monopoli da parte dei fornai o di artificiose lievitashyzioni dei prezzi per causa lOro nloro attivismograve non egraveonfliggeva per quanto riguarda i prezzi finali della sussistenza con linteresse dei produttori cittadini E daltra parte largomentodello stomo dal metFato cittadino dei profitti incamerati dai fornai -laccushysa consueta a proposito deipistores egrave che fossero in gran parte stranieri (GUBNZl 19824
22) -- era unagiustificazione debole che appassionava piugrave chi concorreva direttamente
491 498 Renzo P Comtore
alla spartizione dei proventi derivanti dalla vendita e dal commercio del grano shylemolumento grandissimo - di chi doveva poi fruire della redistribnzione di tale ricchezza Tale norma avvantaggiava i possidenti cittadini e i gentiluomini ptivilegiashyti in grado di ottenere le tratte di esportazione Sul piano dellappropriazione essi erano in condizione di mettere fuori gioco gli altri possessori che producev~o eccedenze nel Dominio poicheacute si accresceva Igravea loro forza contrattuale e la loro capacitagrave di occUpare i canall commerciali piugrave redditizi Sul piano della commercialiZzazione gli stessi fruivashyno dello smantellamento della rete dintennediazione rappresentata dai fornai Per i rushystici significava perdere un collegamento essenZiale con la cittagrave ed essere emarginati dal mercato urbano nelle campagne o sul broletto di Mantova essi non trovarono piugrave i trashydizionali interlocutori (CORBlJ9RE 2000 228 231-2)
Nel caso di Bologna terra strutturalmente deficitaria e cittagrave dalla vocaiione manishyfatturie~ si costringeva i fornai ad acquistare formenti terrieri presso i solari privati in cittagrave proibendogligrave lincetta nel contado autorizzandoli ad acquistareformentiforeshystieri al di fuori delle mura cittadine presso i sensati da grqno solo a patto che fosseshyro stati smaltiti i grani cittadini a un prezzo talora superiore a quello dei grani dimshyportazione (GUlNZI1982A35 52-3)
Nella Toscana dei Medici il diritto allincetta nel contado venne concesso ai fornai in periodo di bassa congiuntura (in particolare dagli anni Trenta del Seicegravento)Per sostenere i prezzi interni in tal caso essi restavano gli interlocutori principali dei granshydi proprietari semplicemente spostando la loro principale fonte di approvvigionashymento dai solari dei particolari in cittagrave ai granai decentrati delle grandi aziende agrishycole oppure ai mercati rurali su cui affluiva la produzione cerealicola delle grandi fattorie (PuLT QUAOUA 1984 86-9 PuLTQUAOUA 1990 100 106-7)
Laddove non vi egrave come invece succede a Genova una diretta ingerenza del potere pubblico nella vita della corporazione (MAsSA 1999) i fumai di cittagrave - nonostante i lacci e lacciuoli normativi e il lavoro prevalentePlente manuale svolto neiloro laboshyratori - erano dei veri imprenditori dipendenti per il loro profitto - noininalmente stabilito per legge - dalla produttivitagrave del lavoro e dalla dotazione tecnica e finanziaria delle imprese Di ciograve fa fede la grande sperequazione esistente fra le aziende speciashylizzate nena fabbricazione del pane venale in cittagrave (AYMARD 1966 75 VECCHltltJQ 1979 82-3 GUlNZI1982 77 segg PuLT QUAOUA 1984 100 102-3) NellItalia delshyletagrave moderna questi artigiani-imprenditori della filiera del grano trattavano insieme
afarinaifarinaiolifarinottifondachierifontechierifidelariformentinari lasagneshyri maccaronari torallari vermicellari ecc fra il 40 e il 70 per cento del frumento consumato in Cittagrave nelle annate normali (CoRRJTORE 2000 126 segg) e ~ino al 100 per cento nelle annate di carestia (Puu QUAOUA 1984 98-9)
In una ricognizione delle asimmetrie informative del mercato non cegrave gruppo quale i fornai che possa integraverpretare la parte dell agente economico onnisciente Se dunque i regolamenti annonari tendevano a regolare minuziogravesamente la collocazione il volushyme e la durata delle loro scorte cosi come disponevano per gli altri artigiani della fishyliera era per neutralizzare il carattere potenzialmente eversivo di tale accantonamenshyto per i proprietari-venditori Prima ancora che per i consumatori-acquirenti n livello delle scorte rinforzava o attenuava il rischio di monopsonio da parte dei pistores piugrave potenti e facoltosi cosigrave come eventuali tentazioni da parte della categoria di esercitare un dominio egoistico sul mercato del pane (MAITOZZl1983 298)
Sarebbe quindi un errore concepire le scorte dei fornai come entropica allocazione di capitale che sconta lincertezza futura esse venivano gestite secondo criteri di rashyzionalitagrave economica e secondo la migliore efficienza tecnica nonostante i vincoli imposti alla lievitazione degli stock dalle disposizioni annonarie
lA costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
vimini paglia o canne intrecciate (come ceste stuoiecannizzi) in terracotta (addirittura anfore) piuttosto che di tessuto (i sacchi costavano troppo) (PICCINNl1976 397 MAzzA RAvEGol 1983 174-5 Zoo Toce 1990 893-4 COIiITONES11991 35n-36n)
Nella casa del piccolo produttore o del titolare di un piccolo possesso il penw (la scorta domestica) difficilmente eccedeva il consumo famigliare chi fortunato raccoshyglieva piugrave dell annona famigliare e di quanto gli serviva per il campo era spinto a venderselo nei mesi immediatamente successivi alla mietitura e alla trebbiatura per necessitagrave di denaro ma anche per la difficoltagrave di stoccare e conservare il prodotto in condizioni ottimali (MEuvRET 1988 17-9 PuLT QUAOUA 1984 88) e figravenanco per ridurre il rischio di vederselo soffiare da vagabondi e malintenzionati In questo caso in presenshyza di eccedenze (ma probabilmente anche in assenza) il bisogno di liquiditagrave e lalea cospiravano nel ridl1ITe ai minimi termini le scorte giagrave allindomani del raccolto In caso alternativo il contadino che non egrave - ripete Jean Meuvret - un homme daffaires quanshyto un homme de peur concepiva la sua riserva come un fondo di previdenza sul racshycolto futuro da non immettere sul mercato se non nel caso dellapprossimarsi di una messe sicura secondo una logica economica a contrario (MEUVRET 1988 19 e 147)
Era Jl~tente la disparitagrave fra i produttori non solo fra chi era in possesso di eccedenshyze e chi non lo era ma piugrave anqgtra fra chi poteva scegliere in virtugrave di una maggiore capienza economica e unadeguata dotazione tecnica - il mercato piugrave favorevole per i propri grani (il periodo di saldatura dei raccolti) e chi invece li cedeva troppo presto o in controtempo a livelli non ottimali
Nella gerarchia delle abitazioni rurali -- in quel vero e proprio saggio di sociologia che egrave il sesto libro del DeArchitectura di Sebastiano Serlio (scritto fra il 1537 eil 1555 inedito per tutto levo moderno) -- per trovare case attrezzate di granaio occorshyreva ascendere sino alla magione del basso mercante o cittadino fuori della cittagrave (SERLlO 1994 43 segg anche per le successive informazioni) Condizione di cui non potevano fregiarsi invece i ricchi contadini in ~essuno dei tre gradi possibili di ricshychezza al massimo la loro casa poteva essere attrezzata di portici per ricoverare le biade e di unaia per batterle segni di distinzione giagrave fra i mediocri contadini Fra questi perograve avrebbero potuto avvalersene soltanto i fortUIgravelati et di beni et di famishyglia (3deg grado di mediocritagrave) nforno per cuocere il pane e una cantina per conservashyre il vino invece li si sarebbe trovati a partire dai piugrave accomodati fra i poveri contashydini cioegrave al 4deg gradino della scala sociale alla cui base erano da collocare i poveri mendichi con vii capanna (10 grado di povertagrave) i salariati che vivevano delle [loro] fatiche avendo un puoco di terreno (2deg grado di povertagrave) i poveri con qualche beshystiuola et massimamente de buOvi possessori di una stalletta congiunta con la casa 0deg grado di povertagrave)
In sintesi nelle campagne delletagrave pre-industriale pochi avevano scorte pochissimi erano in grado di ricoverarle in un solaro privilegiatissimo chi le incanevava per speculare Dunquefra i conta4ini se si esclude quanto celato nella madia o nella dishyspensa le scorte erano un pri~ilegio di pochi nSerlio nato intorno al 1475 insiste sullimpoverimento delle class~ rurali intervenuto fra gli anni della sua giovinezza e quelli della vecchiezza in cui scrive Sotto il titolo Dellabitazione del ricco contadishyno per tre gradi di ricchezza si preoccupa di puntualizzare
bencheacute al di dogi non se n~ truovi piugrave de tali merceacute delle discordie et di gli animi fieri et ostinati alla vendetta onde per tal cagioni et per le continue guerre et anche pei citadini divoratori de gli altrui beni che con le usure con glinganni con le rapine gli bano impoveriti (SERUO 1994 ~8)
490 RellOP CorrilOle
colto (agosto-settembre-ottobre) e invia di esaurimento almomento della saldatura dei raccolti (aprile-maggio-giugno )1A questo proposito nota Franccedilois Sigaut
Le stockage agrave court terme (moins dune campagne) reacutepond agrave la neacuteCessiteacute cIeacute concilier une offre variable et une demande constante mais toutes deux reacutegulieacuteres et preacutevisibles dans la
pratique il est consideacutereacute comme tiiisant pame du processus ordinaire de la production et ne pose agrave ce titre que desproblegravernes doptimisation assez simples (SlOAUI 1985 602)
La discussione generale sulla razionalitagrave economica delle scorte alimentari in etagrave pre-industriale puograve allora essere ridotta alla fonnulaiione e allo scioglimento di due
semplici quesiti 1 Accertato che laccantonamento digram per la periodicitagrave annuale del ciclo agricoshy
lo epet i vincoli tecnici di un rifomimento spazialmente allargato egrave inevitabile chi egrave conveniente che conservi le scorte chi produce o chi commercia il contadino o il mercante lapossidenzagrave o il popolo i particolari o il pubblico E qual egrave la realtagrave effettiva
2 Se le forme di distribUzione economicamente razionale sono plurali in quale conshytesto e in omaggio a quali interessi piugrave utile il sistema della canova rispetto al sistema delll piazza del mercato e dei solari privati
3 SULLADISTRIBUZIONE DEL GRANO NELUETAgrave PRE-INDUSTRIALE E LA STRUTTURA DELLE SCORTE NEI TERRITORI ITALIANI
Raramente le case contadine erano dotate di attrezzature per la conservazione dei cereali piugrave che elementari Nelle campagne toscane del Quattrocento dunquein unetagrave favorevole al reddito contadino in una regione fra le piugrave ricche dellEuropa pre-indushystriale
pochissime case contadine disponevano del granaio vero e proprio alcune avevano una cella che poteva servire allo stesso scopo ma la maggior parte di quelle abitazioni era priva di spazi destinabili esclugravesivamente alla conservazione dei cereali Perciograve i contenitori dei grani arche casse sacchi bugnole - dovevano trovare posto nelle cucine o nelle camere CMA= RAVEGGI 1983 174)
Le ridotte capacitagrave patrimoniali e reddituali della grande maggioranza dei produttori facevano sIgrave che fosse ampiamente invalso nella conservazione domestica dei grani limshypiego di contenitori in legno (come arche casse botti bugnole tini tinelle corbelli)in
Riguardo ai passi evidenziati di Zanetti e Cipolla egrave neCessario osservare che la principale atteshystazione sullesistenza di stock detenuti da privati che esorbitassero ilfabbisognostagionale tali da essere classificati come immobili=zione di ricchezza (Zanetti) o come beni capitale (Cipolla) a unanalisi piugrave fine si rivela fallace o non direttamente utilizzabile La propalazione dei grani effetshytuata a Pavia fra ilimiddot e il5 maggio 1555 che egrave il fondamento di entrambi i giudizinon mostra una somma di derrate realmente eccedente il fabbisogno delle famiglie per il periodo che manca allarri_ vo dei grani novelli sulla piazza pavese Daltra parte lastessa natura dellistituto della propalazioshyne dei grani cioegrave della denljncia obbligatoria delle scorte da parte dei particolari una misura demergenza decisa in momenti critici dellapprovvigionamento cittadino affiancata quellanno dalshylispezione diretta presso le case dei privati da parte di deputati straordinari avrebbe dovuto consishygliare una maggiore cautela nella sua utilizzazione per individuare regolaritagrave di carattere generale delleconomia pre-industriale
499 La costituzione di scorte granarie pubbliche e la ptlitica ecoMmica degli stati
FONTI
ABEL [1966) W ABEL Agrarkrisen undAgra~kJJnjunktur Eine Geschichte der londshy und Erniihrungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter Hamburg
und Berlin Paul Parey 19662 (la ed -1935 trad it Congiuntura agraria e crisi agrarie Storia dellagricoltura e della produzione alimentare nellEuropa centrashyle dal XIII secolo alletagrave industriale Torino Einaudi 1976 da cui si cita)
AG ARCHIVIO GoNZAGA presso lArchivio di Stato di Mantova AuFANO 1996 E AuFANO Il grano il pane e la politica annonaria a Napoli nel Setshy
tecento Napoli ESI 1996bull AYMARO 1966 M A YMARO Wmise Raguse et le commerce du bMpendant la seconde
moitieacute du XVI siegravecle Pans SEVPEN 1966 CATIINI 1984 M CATl1NI I contadini di San Felice Metamorfosi di un mondo rurale
nellEmilia delletagrave modernIgravel Torino Einaudi 1984 CESTARl 1794 p CESTARI Saggio storico dei Fondachi delle farine di Chioggia e
Pellestrina Venezia A Zatta 1794 CIPOllAJ1965] C M CIPOllA La politica economica dei governi V La penisola
italigraveana e la penisola iberica in Storia economica Cambridge m La cittagrave e la politica economica nel Medioevo Torino Einaudi 1977 (Cambridge 1965) pp 462-496
CIPollA 1974 C M CIPollA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna nMulino 1974
CIpollA 1997 C M CIPOllA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna nMUlino 1997 (6 ed riveduta)
CORRITORE 2000 R P CoRRITORE La naturale abbondanza del Montovano Produshyzione mercato e c01isumi granari a Mantova in etagrave moderna Pavia Universitagrave di Pavia 2000
CORIONBSI 1991 A CORIONBSI Sulla conservazione dei cereali nellItagravelia medioevale Lavoro e tecniche nelle tesnmonlanze laziali (secc XIII-XV) in Rivista di storia dellagricoltura XXXI 1991 l pp 33-49
DELLA VALENTINA 1992 M DELLA VALENTINA I mestieri del pane a ~nezia tra 600 e 700 in Atti dellIstituto [Veneto di Scienze Lettere ed Arti Classe di scienze morali lettere ed arti CL 1991-92 pp 113-217
DIRLMEIER 1984 U DIRLMEIER le condizioni materiali dellesistenza nelle cittagrave tedeshy sche del Basso Medioevo ~iente esterno reddito consumi in Aristocrazia citshy
tadina e ceti popolari nel tprdo Medioevo in Italia e in Germania (a cura di Reinhard Elze e Gina Fasoli) Bologna Societagrave editrice il Mulino 1984 pp 79shy122
FORNASIN 1999 A FORNASIN Il pzercatodei grani di Udine Indagine per una storia dei prew in Friuli (secoli XfI-XVIII) Nota di ricerca del Dipartimento di Scienshyze Statistiche dellUniversit4 degli Studi di Udine 4 1999 pp 1-24 ora in lo La Patria del Friuli in etagrave 1fIOderna Saggi di storia economica Udine Forum 2000 pp 33-60
GRENDI 1986 E GRENOI Lapprccedilwigionamento dei grani nella Liguria del Seicento libera pratica e annone in iMiscellanea storica ligure Studi in onore di Luigi Bulferetti XVIII 1986 2Jp 1021-1047
GUENZI 1981 A GUENZI Ilfrurnfnto e la cittagrave il caso di Bologna nelletagrave moderna in Quaderni storici XVI ~981 46 pp 153-167
GUENZI 1982 A GUENZI Pane ~fornai a Bologna in etagrave moderna Venezia Marsilio 1982
I
489 500 Renzo P CornIOle
GUBNZI1982 A GUEml Sistema annonario e egraveontrollo sociale a Bologna nei seccediloli XVII e XVIII in E SORI (a cura di) Cittagrave e controllo sociale in Italia fra XVIII e XIX secolo Milano F Angeli 1982 pp 293-306
HICKS [1989] 1 R HIClCS A narlcet theory of money Oxford Oxford Universigravety Press 1989 (trad it Una teoria di mercato della monefa Bologna li Mulino 1992 da cui sigrave cita)
JACOPBITI 1965 N L JACOPBITI Monete e prezzi a Cremona dal XVI al XVlIi secolo Cremona Athenaeum CregravemoneJlSe 1965
KAPLAN 1984S L KAPLAN Provisioning Paris Merchants and Millers in the Grain and Flour Trade during the Eighteenth Century Ithaca-London Cornell Univershysity Press 1984~middot
KULA [1962] W KULA Teoria ekonomiczna ustrojufeudalnego Proba modelu Warshyszawa-Panstwowe WydawnictwoNaukowe 1962 (trad it Teoriagrave economica del sistema feudale Proposta di un modello Tormo EinaUdi 1972 ccedilla cui si cita)
WROUSSE [1933] C-E LABRoussE Esquisse du mouvement des prix et des reverws en France au XVIII siegravecle Paris Eacuteditions des Archives Contemporaines 19842 volI (l ed Paris Librairie Dalloz 1933)
MALANtMA 1976 P MALANiMA Aspetti di mercato e prezzi del grano e della segalea Pisa dal 1548 al 1818 in Ricerche di storia moderna vaL I Pisa Pacini 1976 pp ~n
MANToVA 1430 MwroVA 1430 Pareri a Gian Francesco Gonaga per il governo (a cura di M AQrignaniA M Lorenzoni A Mortari C Mozzarelli) MUltova G~ Arcari 1990
MASSA 1999 PMAssA Annona e corporazioni del settore alimentare ~ Genova orshyganizzazione e conflittualitagrave (XVI-XVIII secolo) in A GUENZI PMAssA A MOIOshyu (a cura di) Corporazioni e gruppi professionali nellItalia moderna MilIllO F Angeli 1999 pp 390-403
MATIoZ7J 1983 1 MiJroZ7J F BOLELLI C CmAsBRA D SABBIONI Il politico e il pane a Venezia (157Q-1650) calmieri e governo della sussistenza in Societagrave e storia VI 198320 pp 271-303
MAzzI RAVEOOI 1983 M T MAzzI S RAVEOGI Gli uogravemini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento Firenze Olscbki 1983
MERONI 1957 U MERONI Cremona fedelissima Ciemona Athenaeum Cremonenshy~~~ _
MBUVRBl 1977 J MEuVRsT Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque LouisXIvI La productiograven des ceacutereacuteales dans la France du XVII et du XVIII siegravecle Paris Mouton -EacuteEHSS19772voll
MBUVRET 1988 J MBtJVRf Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque Louis XIv III Le commerce des gralns et la conjoncture Paris EacuteEHss 1988 2 volI
PtCClNNI 1976 G PtCClNNl Wta contagravedina in una capanna dei dintorni di Siena (1250) in ~Archeologia medievale m 1976 pp 395-399
PlNIO 1978 G PINTOII Libro del BiaPaiolo Carestie e annona a Firenze dalla metagrave del 200 al 1348 Fire~ Olscbki 1978
PiNTO 1982 G PtNro La Toscana nel tardo Medioevo Ambiente economia rurale societagrave Fllenze Sansoni 1982
PtRENNE [1933J H PIRENNB La civilisation occidentale au Moyen Age du XIe au mishylieu du XVe siegravecle Paris PUF 1933 (trad it Storia economica e sociale del Meshydioevo Milano Garzanti 1967 da cui si cita)
Lacostituticne di scorte granarie pubbliche e la politica economiegravea degli stati
redigravestribuzione sostenibile dei beni di sussistenza egrave ricercata in questo cielo da quegli stessi particolari che ~amaldeggiano nella produzione negli scambi nei consumi e che costituiscono il nerbo della classe di governo Le scorte pubbliche rappresenteshyrebbero in questa prospettiva un presidio civico e un risltCimento politico e morale ai cOl1ponenti della comunitagrave spossessati delbene supremo dellautarchia alimentare
Resta infine latente unidea del magazzmo pubblico come quasi-mercato cioegrave come luogo volto (1) a risolvere i fa1limentiinfo~vi della piazza del mercato (in meacuterito alle disponi~ilitagrave alle caratteristiche del prodotto alle condizioni di vendita della merce) (2) a ridimensionare lalea per agricoltori consumatori poveri artigiani del comparto alimentare (3) a sostenere i consumi e i profitti privati m funzione anticicli ca in una prospettiva Ilpn meram~nte congiunturale Si tratta in questo caso di un orshyganizzaZionepienattiCnte razio~e Che non opera in maniera saltuaria e riflessa ma in modo continuativo secondo obifttili prefissati di allocazione dei beni primari li funshyzionamento dellacanovagrave (il magazzino pubblico) si porrebbe come strumento inteshygrativo ma no~~igraventeramente so~titutivo delloperare della piazza Si tratterebbe di unaforma di mercato distinta dalla p~ del mercato considerata in seacute e per seacute cosigrave come dallegraveOOmpravendite effetttlate nei solari privati o dalla mera centrallzzazione e redistribuzione di derrate con fi~alitagrave umanitarie La canova rappresenterebbe in tal modo uno dei possibili meccaoi~ di governo delle trllls3ZIgrave~ni locali per risolvere i problemi deUapprovvigionameIto senza intaccare certi interessi di classe (dei proshyprietari ma anche del popolo grasso) S da essere prescelta da autoritagrave e gruppi domishynanti come struttura complementare della piazza del mercato incerti contestiprodutshytivi ed economici La suasacrilizzazione perciograve non esclude la possibilitagrave di un ritorno alle sole compravendite qella piazza e dei solari privati - una volta invertishytosi il trend o spirate le condizioqi economiche della sua istituzionalizzazione
La problematizzazione esorc~ una liquidazione semplicistica del problema delle scorte gran8rle in etagrave pre-industriUgravee nel nome di una loro presunta irrazionalitagrave eco- nomica per il compito di assi~ la sussistenza della popolazione
Le pagine che segUono sono rintroduzione a un lavoro in corso volto a offrire un interpretazione generale di tal~ capitolo fondamentale della politica economica dei governi
in
etagrave pre-industriale
2 SE UN MONDO SENZA SCORTE Egrave INCONGRUO cm Egrave OPPORTUNO CHE LEgrave DETENGA
Nei fatti nel settore granarlo CQni vincoli dell etagrave pre-industriale in tema diprodutshytivitagrave energia trasporti non ha s~nso ipotizzare un mondo senza scorte Se il mercato del grano egrave - come nellEuropa medievale e moderna - un sjstema tendenzialmente chiuso
ad ogni raccolto nuove offe~ aniv(erannol sul mercato mentre la domanda si mant[erragrave] relativamente costantt nel corso dellanno Qualcuno dunque [dovragrave] ~ere delle scorte che saranno elevate ~ubito dopo il raccolto e poi via via minori fino aragshygiungere un livello minimo in prpssimitagrave del successivo raccolto (HICICS [19891 31)
Nella loro forma piugrave sempliceI tali scorte saranno legate allora alla periodi~itagrave anshynuale del ciclo agricolo (che a1iplenta il movimento stagionale dei prezzi ccedilfr LAshyBROlJSSE [1933] 157-66) il loro livello saragrave elevato allindomani del principiLle racshy
501 488 Renzo P Corritore
povero ammassograve nella propria dimora scorte di grano carne ~alata sale candele ecc e la medesima cosa fece lo Stato Nel periodo feudale non venne mai meno nel castello del signore labitudine di tenere da parte grosse scorte per i periodi di emergenza Sucshycessivamente le autoritagrave comunali predisposero il magazzinaggio di grosse derrate specie di grano da rivendere a basso prezzo in periodi di emergenza e nello stesso tempo si preoccuparono di prevenire un indebito accumulo di scorte da parte di specushylatori privati Nelle economie medievali gli stock di derrate di prima necessitagrave rappreshysentarono pertanto una delle piugrave importanti forme di investimento pubblico e privato (CIPOLLA (1965] 468)
Nella prima versione del manualeacute invece fino allinserimento nel 1997 del nuovo capitolo dedicato alla politica economica nell etagrave pre-mdustriale il punto di vista preshyvalente era quello microeconomico entro il perimetro stretto dellindividualismo meshytodologico
Le scorte costano e costano doppiamente Esse implicano il costo diretto che egrave rapshypresentato dal costo del magazzinaggio edal deterioramento eventuale del pr04otto o di parte di esso Se luomo daffari finanzia la costituzione delle scorte con danaro preso a prestito il costo diretto include anche il tasso di interesse pagato Se luomo daffari finanzia con capitale proprio la costituzione delle scorte il costo delle scorte deve inshycludere un costo-opportunitagrave e cioegrave il mancato rendimento (tIllU1cato tasso dinteresse attivo) del capitale finanziario impiegato (CIPOLLA 1974 154)
Le ragioni della costituzione e del mantenimento di scorte alimentari da parte delshylautoritagrave pubblica diventavano unicamente ragioni morali (umanitarie e di buona amministrazione) o di opportunitagrave politica (la fame era la piugrave frequente ligraveausa di sommosse e furori popolari) (CIPOLLA 1974 74)
Nel 1997 si riammetteva dunque linterpretazione originaria della costituzione di scorte pubbliche come strumento di riequilibrio del mercato senza peraltro rinnegare le considerazioni sulla valenza statica di tale forma di investimento per gli agenti economici privati
In merito allutilitagrave economica e al significato delle scorte in etagrave pre-industriale Cishypolla non espresse perciograve sempre lo stesso punto di vista La rassegna delle posizioni da lui assunte anzi permette di individuare tre approcci e tre giudizi costitutivamente diversi sulla funzione delle scorte granarie nellepoca pre-industriale
In prima approssimazione laccumulazione di scorte alimentari mostra il carattere fondamentalmente difensivo delle scelte degli agenti economici pubblici e privati in etagrave pre-industriale La paura la tradizione la superstizione li induce a tabuizzare il rischio la speculazione linvestimento nella produzione e nella distribuzione dei beni essenziali alla vita e ad aderire intimamente a un ideale di economia e societagrave stazionarie aggravando con la norma sociale le istituzioni il comportamento indivishyduale e collettivo leffetto dei condizionamenti materiali delleconomia pre-industriashyle (bassa produttivitagrave agricola alti costi di v~sporto modesta efficienza energetica) esponendo ancor di piugrave la comunitagrave umana ai degravemoni della natura
La seconda interpretazione rigetta luniversale imperio dellhomo oeconomicus rishyscoprendo leteronomia dei fini dellagire economico degli uomini nelletagrave pre-inshydustriale Ia politica economica dello Stato o-delle autoritagrave non persegue puri scopi economici lintegritagrave del corpo sociale fin nelle sue cellule elementari (persone e famiglie) deve essere assicurata secondo i principi e la prassi di uneconomia morale che SOVJa5ta leconomia regolata dal mercato spersonalizzata e antipopolare Una
La costituzione di scorte grantlTie pubbliche e la poligravetigraveca economica degli stati
PuLT QUAGUA 1984 A M PULT QUAGUA Mercato dei prodotti agricoli e magistratushyre annonarie a Pisa nelletagrave moderna in Ricerche di storia moderna a cura di M Mirri voI III Pisa Pacini 1984 pp 57-141
PULT QUAGLIA 1990 A M PULT QUAGLIA Per provvedere ai popoli Il sistema anshynonario nella Toscana dei Medici Firenze Olschki 1990
SERUO 1994 S SERLIO Architettura civile Libri sesto settimo e ottavo nei manoscritshyti di Monaco e Vienna (a cura di F P Fiore) Milano TI Polifi10 1994
SIGAlIT 1985 F SIGAlIT Questions deacuteconomie agrave propos des politiques ceacutereacutealiegraveres et de stockage in Les techniques de conservation des grains agrave long terme leur rale dans la dynamique des systegravemes de cultures et des socieacuteteacutes (sous la direction de M Gast F Sigaut et C Beutler avec la collaboratlon de O Bllchsenschutz) voI III 2 Paris Eacuteditionsdu CNRS 1985 pp 597-606
SMITH [1776 A SMITH An inquiry into the nature and causes ojthe wealth ojnations London W Strahanand T Cadell 17762 volI (trad it Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni Milano A Mondadori 1977 2 volI da cui
si cita) STATlITlBoNACOLSIANI [1313] STATUTI BONACOLSlANl (a cura di E Dezza A M Lorenshy
zoni M Vaini) Mantova GArcari 2002 STATUTI GONZAGHESCHI [1404] STATUTI GONZAGHESCHI presso la Biblioteca comunale di
Mantova ms FV 11 [775]VECCHIATO 1979 F VOCCHIATO Pane e politica annonaria in Terrajerma veneta tra
secolo XV e secolo XVIII (Il caso di Verona) Verona Stamperia Zendrini 1979 ZANETTI 1963 D ZANETTl Contribution agrave leacutetude des structures eacuteconomiques lapshy
provisiQnnement de Pavie au XVI siegravecle in Annales ESC XVIII 1963 1 pp 44-62 ora in lo Fra le antiche torri Scritti di storia pavese Pavia Universitagrave di Pavia 2000 pp 165-182
ZANETTl 1964 D ZANEITI Problemi alimentari di una economia preindustriale Ceshyreali a Pavia dal 1398 al 1700 Torino P Borlnghieri 1964
ZUG TUCCI 1990 H ZUG TuCCI Le derrate agricole problemi materiali e concezioni mentali della conservazione in Lambiente vegetale nellalto Medioevo XXXVII Settimana di studio del Centro italiano di studi sullalto Medioevo (30 marzo-5 aprile 1989) Spoleto Centro italiano di studi sullalto Medioevo 1990 voI n pp 865-902
SOCIETAgrave ITALIANA
DEGU STORICI DELLECONOMIA
TRA VECCm ENUOVI EQUILmRI DOMANDA EOFFERTA DI SERVIZI IN ITALIA
IN ETA MODERNA ECONTEMPORANEA
Atti del quinto Convegno Nazionale Torino 12-13 novembre 2004
a cura di Iginia Lopane Ezio Ritrovato
CACUCCI EDITORE - BARl- 2007
RENZO p CORRITORE
LA COSTITUZIONE DI SCORTE GRANARIE t
PUBBLICHE E LA PqLITICAEccedilO~OMIqA
DEGLI STATI IN ETA PRE-INDUSTRIAL~ (LA DIgraveSTRIBUZIONE DEL GRANO E LA STRUTIURA
DEUE SCORTE NEI TERRITORI ITAUANL Ii FONTICO DEL MERCATO)
1 ILTEMAELASUAPROBLEMATIZZiZIONE
Investimento della paUra cosi Carlo M Cipolla definiva nel suo piugrave noto ~uashyle la formazione e conservazione di scorte alimentari da parte di soggetti iprivati e pubblici nellEuropa pre-it)dustriale (CIPOlLA 1974 68) La propensione allaliantoshynamento di de11llte agricole 00 parte delle famiglie ~ delle autoritagrave nell etagrave ~~evale e moderna assumeva in tal modo una connotazione negativa le scorte erano reddito non consumatO cioegrave un risparmio incapace di tradursi in domanda di beni ccedilapitali dunque ~ sterilizzazione di ricchezza dal pilnlQ ~ vista della crescita ecoll9mica e dell evoluzione della produttivitagrave Con ciograve faceva proprio quanto aveva scritto uno storico pavese a lui vicino Dante Zanetti
La fonruttion et le maintien de stockIgravel Iln particulier de stocks alimeritairegraves ~sti- tuent une forme particuliegravere dinvestissement cest-i-dire daccumulalion de capitagraveJ li sagit dun invesnssement ayant un caractegravere pour ainsi dire statique et non eacutevplUshytif car il ne contribue pas i laccroissement du revenu pendant celte Iongue ~pde mais sert seulement agrave une meilleure distribution du ~venu dans le temps nfaut aj0luter que Ies stocks repreacutesentent limmobllisation dune partie consideacuterable de leacutepargneiprishy
veacutee qui dans une eacuteconomie de type preacute-industriel repreacutesente une part deacutejagravetrop ~te du revenu (ZANErn 1963 44)
Lo stesso CipoIIa tuttavia nellultima edizione del manuale (CIPolLA 1991 227) decideva di applicare anche allevo moderno quanto aveva scritto piugrave di trentanni prinia a proposito della politica economica dei governi nellepoca medievale cioegrave
che laccumulo di scorte frumentarie da parte deacuteUautoritagrave fosse uno strumento di politica economica per promuovere unecogravenomia piugrave equilibrata meno lttqmiigraveuita dallincertezza del ciclo dccedili racegraveolti Nel 1965 infattila preferenza era sta~ da lui accordata allanalisi delle politiche pubbliche in un cpntesto di mercato inigraveperfetshyto in un oriZzonte che deborda il ciclo annuale agricolo
Pii) imperfetto era il mercato piugrave urgente si faceva la necessitagrave dimantenere massicshyce riserve di prodotti Per tutto il corso del Medioevo ogni individuo che non fosse
501 488 Renzo P Corritore
povero ammassograve nella propria dimora scorte di grano carne salata sale candele ecc e la medesima cosa fece lo Stato Nel periodo feudale non venne mai meno nel castello del signore ]abitudine di tenere da parte grosse scorte per i periodi di emergenza Sucshycessivamente le autoritagrave comunali predisposeromiddot il magazzinaggio di grosse derrate
lt specie di grano da rivendere a basso prezzo in periodi di emergenza e nello stesso tempo si preoccuparono di prevenire un indebito accumulo di scorte da parte di specushylatori privati Nelle economie medievali gli stock di derrate di prima necessitagrave rappreshysentarono pertanto una delle piugrave importanti Jorme di investimento pubblico e privato (CipollA [1965] 468)
Nella prima versione delmanualeacute invece finograve allinserimento nel 1997 del nuovo capitolo dedicato alla politica economica neUetagrave preindusiriale il punto di vista preshyvalente era quello microeconomico entro il perimetro stregravetto dell individualismo meshytodologico
Le scorte costano e costano doppiamenie Esse implicano il costo diretto che egrave rapshypresentato dal costo del magazzinaggio e daI deterioramento-eventuale del prodotto O di parte di esso Se luomo daffari finanzia la costitiIZIgraveone delle scorte con danaro preso~a prestito il costo diretto include anche il tasso di interesse pagato Se luomo daffari finanzia con capitale proprio la costltuzione delle scorte il costo delle scorte deve inshycludere un costo-opportunitagrave e cioegrave il mancato rendimento (mancato tasso dinteresse attivo) del capitale finanziario impiegato (CIPOllA 1974 154)
Le ragioni della costituzione e del mantenimento di scorte alimentari da parte delshylautoritagrave pubblica diventavano unicamente ragioni morali (umanitarie e di buona amministrazione) o di opportunitagrave politica (la fame era la piugrave frequente ~ausa di sommosse e furori popolari) (CIPolLA 1974 74)
Nel 1997 si riammettegraveva dunque linterpretazione originaria della costituzione di scorte pubbliche come strumento di riequilibrio del mercato senza peraltro rinnegare le consideraZioni sulla valenza statica di tale forma di investimento per gli agenti economici privati
In merito allutilitagrave economica e al significato delle scorte in etagrave pre-industriale Cishypolla non espresse perciograve sempre lo stesso punto di vista La rassegna delle pogravesizioni da lui assunte anzi permette di individuare tre approcci e tre giudizi costitutivamente diversi sulla funzione delle scorte granarie nellepoca pre-indUstriale
In prima approssimazione laccumulazione di scorte alimentari mostra il carattere fondamentalmente difensivo delle scelte degli agenti economici pubblici e privati in etagrave pre-industriale La paura latradizione la superstizione li induce a tabuizzare il rischio la speculazione linvestimento nella produzione -e nella distribuzione dei beni essenziali alla vita e ad aderire intimamente a un ideale di economia e societagrave stazionarie aggravando con la nonna sociale le istituzioni il comportamento indivishyduale e collettivo leffetto dei condizionamenti materiali delleconomia pre-industriashyleacute (bassa produttivitagrave agricola alti costi di trasporto modesta efficienza energetica) esponendo ancor di piugrave la comunitagrave umana ai degravemoni della natura
La seconda interpretazione rigetta luniversale imperio dellhomo oeconomicus rishyscoprendo leteronomia dei fini dellagire economico degli uomini nelletagrave pre-inshydustriale La politica economica dello Stato o-delle autoritagrave non persegue puri scopi economici lintegritagrave del corpo sociale fin nelle sue cellule elementari (persone e famiglie) deve essere assicurata secondo i principi e la prassi di uneconomia morale che SOVlasta leconomia regolata dal mercato spersonalizzata e antipopolare Una
La costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli staIgravei
PuLT QUAGUA 1984A M PULT QUAGLiA Mercato dei prodotti agricoli e magistratushyre annonarie a Pisa nelletagrave moderna in Ricerche di storia moderna a cura di M Mirri voI m Pisa Pacini 1984 pp 57-141 lt
PULT QUAGliA 1990 A M PULT QUAGUA lt Per provvedere ai popoli Il sistema anshynonario nella Toscana dei Medici Firenze Olschki 1990
SERUO 1994 S SERilO Architettura civile Libri sesto settimo e ottavo nei manoscritshyti di Monaco e Vienna (a cura di F P Fiore) Milano TI Polifi10 1994
SIGAUT 1985 F SIGAUT Questions deacuteconomie agrave propos des politiques ceacutereacutea1iegraveres et de stockage in Les techniques de conservation des grains agrave long terme leur r6le dans la dynamique dessystegravemes de cultures et des socieacuteteacutes (sous ladirection de M Gast F Sigaut e~Beutler avec la collaboration de O Bijchsenschutz) voI m 2 Paris Eacuteditionsdu CNRS 1985 pp 597-606
SMfIH [1776] A SMITH Aninquiry into the nature andcauses ofthe wealth ofnations London W Strahanand T CadeIl 17762 voll (trad it Indagine sulla natura e le causedellagrave ricchezza delle nazioni Milano A Mondadori 1977 2 voll da cui si cita)
STAnmB(i~ACOLSIANI [1313] STATUTI BONACOLSIANI (a cura di E Dezza A M Lorenshyzoni M Vaini) Mantova G Arcari 2002
STATtm GONZAOHESCHI [1404] STATUTlGONZAGHESCHI presso la Biblioteca comunale di Mantova ms FV 11 [775]
VECCHIATO 1979 F VECCHIATOPane e-politica annonaria in Terraferma veneta tra secolo XV e secolo XVIlI (Il caso di Verona) Verona Stamperia Zendrini 1979
ZANETTI 1963 D ZANETTI Contribution agrave leacutetude des structures eacuteconomiques lapshyprovisiQnnement dePavie au XVI siegravecle in Annales ESC XVIII 1963 l pp 44-62 ora in ID Fra le antiche torri Scritti distoria pavese Pavia Universitagrave di Pavia 2000 pp 165-182
ZANETTI 1964 D ZANErn Problemi alimentari di una economia preindustriale Ceshyreali a Pavia dal 1398 al 1700 Torino PBoringhieri 1964
ZUO TuCCl 1990 H ZUG TUCCl Le derrate agriCole problemi materiali e concezioni mentali della conservazione in Lambiente vegetale nellalto Medioevo XXXVII Settimana di studio del Centro italiano di studi sullalto Medioevo (30 marzo-5 aprile 1989) Spoleto Centro italiano di studi sullalto Medioevo 1990 voI II pp 865-902
489 500 Renzo P Capitare
GUENZI 1982 A GUBNZI Sistema annonario e controllo sociale a Bologna nei secoli XVII e XVIII in E SORI (a cura di) Cittagrave e controllo sociale in Italia a XVIII e XIX secolo Milano R Angeli 1982 pp~ 293-306
HICKS [1989] J R HICKS A nwrket theory of money OxfQrd Oxford University Piess 1989 (trad itmiddot Una teoria di mercato della moneacuteta Bologna Il Mulino 1992 da cui si cita)
JACOPEn 1965 N I JACOPEITI Monete eprewa Cremona dal XVI al XVIII secolo Cremona Athenaeum Cremonense1965
KAPLAN 1984S L KAPLAN Provisioning Paris Merchaius and Millers in me Grain and Flour Trade during the Eighteenth Century Ithaca~London Cornell Univershysity Press 1984~middot
KULA [1962] W KULA Teoria ekonomiczna ustrojufeudalnego Proba modelu Warshyszawa~4nstwowe WydavnictwoNaukove 1962 (trad it Teoria economica del sistema feudale Proposta di un modello lorino EinaUdi 1972 da cui si cita)
LABROUSSB [1933] c-E LABRoussB Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIII si~cle Paris Eacuteditions des Archives Contemporaines 1984 2 voll (1 ed Paris Librairie Dalloz 1933)
MAlANIMA 1976 P MALANlMA Aspetti di mercato e prew del grano e della segale a Pisa dal 1548 al 1818 in Ricerche di storia moderna voL I Pisa Pacini 1976 pp289-327
MANTOVA 1430 MANTOVA 1430 Pareri a Gian Francesco Go~ga per il governo (a cura di M A Grignani A M Lorenzoni A Mortari C Mozzarelli) Mantova G Arcari1990
MAsSA 1999 PMAsSA AMonae corporazioni del settore alimentare ~ Genova orshyganizzazione e corflittualitagrave (XVI-XVIII secolo) in A GPJlNZI P MAsSA A MOlOshyu (a cura di) Corporazioni e gruppi professionali nellItalia moderna M4ano R Angeli 1999 pp 390403
MAnoZZI 1983 I MATroZZl R BoLEUl C CHiAsBRA D SABBIONl Il politico e il pane a Venezia (1570-1650) calmieri e governo della sussistenza in Societagrave e storia V1198320pp271-303
MAZZI RAVBOOI 1983 M T MAzzI S RAVBOOI Gli uomini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento Firenze Olscbki 1983
MERONI 1957 U MERoNI Cremonafedeiissima Cremona Athenaeum Cremonenshyse1957
MBUVRET 1977 J MBUVRm Le progravebl~me 4es subsistances agrave leacutepoque LouisXIv 1 La productiOn des ceacutereacuteales dans la France du XVIIet du XVIII si~cle Pans Mouton - EacuteEHss 1977 2 voll
MBUVRm 1988 J MBuVRET Le probl~me des subsistances agrave leacutepoque Louis XlY III Le commerce des grains et la conjoncture Pans EacuteEHss 19882 voll
PICClNNI 1976 G PICClNNl Vita contluJina in una capanna dei dintorni di Siena (1250) in Archeologia medievale JII 1976 pp 395-399
PINTO 1978 G PINTO Il libro del Biadaiolo Carestie e annona a Firenze dalla metagrave del 200 al 1348 Firenze Olschld 1978
PINTO 1982 G PINTO La Toscana nel tarda Medioevo Ambiente economia rurale societagrave Firenze Sansoni 1982
PIRENNB [1933J H PmmINB La civilisation occidentale au Moyen Age du XIe au mishyZieu du XVe si~cle Paris PUF 1933 (trad it Storia economica e sociale del Meshydioevo Milano Garzanti 1967 da cui si cita)
wcostitlJlWne di scorte granarie pubbliche e la politica economiCa degli stati
redistribuzione sostenibile dei beni di sussistenza egrave ricercata in questo cielo da quegli stessi particolari che mllI8lllaldeggiano nella produzione negli scambi nei consumi e che costituiscono il nerbo della classe di governo Le scorte pubbliche rappresenteshyrebbero in questa prospettiva un presidio civico e un ris~nto politico e morale ai componenti della comunitagrave spossessati deIbene supremo dellaUtarchia alimentare
Resta infine latente unidea del magazzmo pubblico come quasi-mercato cioegrave come luogo volto (1) a risolvere i fallimenti informativi d~lla piazza del mercato (in megraverlto alle disponihilitagrave alle caratteristiche del prodotto alle condizioni di vendita della merce) (2) a ddimensionare lalea per agricoltori consumatori poveri artigiani del comparto alimentare (3) a sosteqere i consumi e i profitti privati in funzione anticicli ca in una prospettiva I0n meramente congiunturigraveugravee Si tratta in questo caso di unorshyganizzaZionepienamente razionale che non opera in maniera saltuaria e riflessa ma in modo continuativo secondo obiettivi prefissati di allocazione dei beni primari TI funshyzionamento deJlacanovagrave (il magazzino pubblico) si porrebbe come strumento inteshygrativo ma nOliinteramente sostitutivo delloperare della piazza Si tratterebbe di unaforma ( megravercato distinta dalla pi~ del mercato considerataIn seacute e per seacute cosl come dallegraverompravendite effetttiate nei solari privati o dalla meacutera centralJzzazione e redistribuzione di derrate con fiqatitagrave umanitarie La canova rappresenterebbe in tal modo uno dei possibili mecc~ di governo delle transaziopi locali per risolvere i problCmi dellapprovv~gionameqto senza intaccare certi interessi di classe (dei proshyprietari ma anche del popolo graSso) s) da essere prescelta da autoritagrave e gruppi domishynanti come struttura complemen8Ie della piazza del mercato in certi contestiprodutshydvi ed economici La suasacnilizzazione perciograve non esclude la possibilitagrave di un ritorno alle sole compravendite qella piazza ~ e del solari privati - una volta inverti- tosi il ~nd o spirate le condizio~ economiche della sua istituzionalizzazione
La problematizzazione esorcizza una liquidazione semplicistica del problema delle scorte graUarie in etagrave pre-indus~e nel nome di-~a loro presunta irrazionalitagrave eco- nomica per il compito di assicll1~ la sussistenza della popolazione
Le middotpagine che segUono sono Vintroduzione a un lavoro in corso volto a offrire uninterpretazione generale di tal~ capitolo fondamentale della politica economica dei govemi ~ etagrave pre-industriale
2 SE UN MONDO SENZA SGORTE Egrave INCONGRUO cm Egrave OPPORTUNO CHE LE DETENGA
Nei fatti nel settore granario conI vincoli delletagrave pre-industriale in tema diprodutshytivitagrave energia trasporti non ha ~nso ipotizzare un mondo senza scorte Se il mercato del grano egrave - come nellEuropa Igravenedievale e moderna - un sistema tendenzialmente chiuso
ad ogni raccolto nuove offeXfe arriv[eranno] sul mercato men~e la domanda si mant[erragrave] relativamente costanlf nel corso dellanno Qualcuno dunque [dovragrave1 ~nere delle scorte che saranno elevate isubito dopo il raccolto e poi via via minori fino lIragshygiungere un livello minimo in prpssimitagrave del successivo raccolto (HICKS [1989] 31)
Nella loro forma piugrave semplice tali scorte saranno legate allora alla perlodi~itagrave anshynuale del ciclo agricolo (che aUfnenta il movimento stagionale dei prezzi ccedilfr LAshyBROUSSB [1933 157-66) il loro livello saragrave elevato allindomani del prlnciprue racshy
499 490 RelloP COrrilore
colto (agosto-settembre-ottob~) e in via di esaurimento almomento della saldatura dei raccolti (aprile-maggio-giugno)lA questo proposito nota Franccedilois Sigaut
Le stockage agrave court terme (moms dune campagne) Ieacutepond agrave la neacuteCessiteacute egravek concilier une offre variable et une demande constante mais toutesdeux reacutegulieacuteres et pIeacutevisibles dans la pratique il est ccedilonsideacutereacute comme tagraveisant partie du procegravessus ordigravenaire de la prOduction et ne pose agrave ce titre quedes probJegravemes doplimisation assez simples (SIGAUT 1985 602)
La discussione generale sulla razionalitagraveegraveconomica delle scorte alimentari in etagrave pre-industriale puograve allora essere ridotta alla formulaZione e allo scioglimento di due semplici quesiti 1 Accertato che laccantonamento di grani per la periodicitagrave arinuale del ciclo agricoshy
lo epel i vincoli tecnici di un rifornimento spazialmente allargatoegrave inevitabile chi egrave conveniente che conservi le scorte chi produce O chi cOnlmercia il contadino o il mercante lapossidenza o il popolo i particolari o ilpubblico E qual egrave la realtagrave effettiva
2 Se le forme di distrigravebIgravelZIgraveone economicamente razionale sono plurali in quale conshytesto - e in omaggio a quali interessi - egrave piugrave utile iI sistema della canova rispetto al sistema della piazza del mercato e dei solari privati
3 SULLADISTRlBUZIONE DEL GRANO NELLETAgrave PRE-INDUSTRlALE E LA STRUTTURA DELLE SCORTE NEI TERRITORI ITALIANI
Raramente le case contadine erano dotate di attrezzature per la conservazione dei cereali piugrave che elementari Nelle campagne toscane del Quattrocento dunqueJn unetagrave favorevole al reddito contadino in una regione fra le piugrave ricche dellEuropa pre-indushystriale
pochissime case contadine disponevano del granaio vero e proprio alcune avevano una cella che poteva servire allo stesso scopo ma la maggior parte di quelle abitazioni era priva di spazi destinabili esclusivamente alla conservazione dei cereali Perciograve i contenitori deigrani - arche casse sacchi bugnole - dovevano trovare posto nelle cucine o nelle camere (MAzzI RAvEGOI 1983 174)bull
Le ridotte capacitagrave patrimoniali e reddituali della grande matregoranza dei produttori facevano si che fosse ampiamente invalso nella conservazione domestica dei grani limshypiego di contenitori in legno (come arche casse botti bugnoletini tinelle corbelli)in
Riguardo ai passi evidenziati di Zanetti e Cipolla egrave necessario osservare che la principale atteshystazione sullesistenza di stock detenuti da privati che esorbitassero ilfabbisogno stagionale tali da essere classificati come immobilizzazione di ricchezza (Zanetti) o come beni capitale (Cipolla) a unanalisi piugrave fine si rivela fallace O non direttamente utilizzabile La propalazione dei grani effetshytuata a Pavia fra ilIo e il 5 maggio 1555 che egrave il fondaIgravenento di entrambi i giudizinon mostra una somma di derrate realmente eccedente il fabbisogno delle famigiie per il periodo che manca allarrishyvo dei grani novelligrave sulla piazza pavese Daltra partelastessa natura dellistituto della propaazio- ne dei grani cioegrave della denllncia obbligatoria delle scorte da parte dei particolari una misura demergenza decisa in momenti critici dellapprovvigionamento cittadino affiancata quellanno dalshylispezione diretta presso le case dei privati da parte di deputati straordinari avrebbe dovuto consishygliare una maggiore cautela nella sua utilizzazione per individuare regolaritagrave di carattere generaledelleconomia pre-industriale
La costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli slatibull
FONTI
ABEL [1966] W ABEL Agrarkrisen und Agrarkonjunktur Eine Oeschichte der Landshy und Ernlihrungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter Hamburg
und Berlin Paul Parey 19661 (P ed -1935 trad it Congiuntura agraria e crisi agrarie Storia dellagricoltura e della produzione alimentare nellEuropa centrashyle dalXlII secolo alletagrave industriale Torino Einaudi 1976 da cui si cita)
AG ARCHIVIO GONZAGA presso lArchivio di Stato di Mantova AuFANO 1996 E AuFANO Il grano il pane e la politica annonarla a Napoli nel Setshy
tecento Napoli ESI 1996 bull AYMARD 1966 M AYMARD Veacutenise Ragusegrave et le commerce du bleacute pendant la seconde
motti du XVI siegravecle pans SEVPEN 1966 CA1TINl1984 M CATlINl I contadini di San Felice Metamorfosi di un mondo rurale
nellEmilia delletagrave moderna Torino Einaudi 1984 CEsTARI 1794 p CESTARI Saggio storico dei Fondachi delle farine di Chioggia e
Pellestrina~ bullbull Venezia A Zatta1794 CIPOLLA [1-965] C M CIPOllA La politica economica dei governi V La penisola
italigraveana e la penisola iberic(l in Storia economica Cambridge ID La cittagrave e la politica economica nel Medioevo Torino Einaudi 1977 (Cambridge 1965) pp 462-496
CirollA 1974 C M CiPollA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna TI Mulino 1974
CIpOLLi 1997 C M CIPOllA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna TI Mulino 1997 (6 ed riveduta)
CORRITORB 2000 R P CORRITORB La naturale abbondanza del Mantovano Produshyzione mercato e consumi grqnari a Mantova in etagrave moderna Pavia Universitagrave di Pavia 2000
CORTONESl 1991 A CORTONESr Sulla conservazione dei cereali nellItalia medioevale woro e tecniche nelle tesnnonianze laziali (secc XIII-XV) in Rivista di storia dellagricoltura XXXI 1991 l pp 33-49
DElLA VALENTINA 1992 M DEJ1A VALENTlNA I mestieri del pane a Venezia tra 600 e 700 in Atti dellIstituto igraveVeneto di Scienze Lettere ed Arti Classe di scienze morali lettere ed arti CL 1991-92 pp 113-217
DIRLMEIER 1984 U DiRLMEIER Le condizioni materiali dellesistenza nelle cittagrave tedeshy sche del Basso Medioevo wlwiente esterno reddito consumi in Aristocrazia citshy
tadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia e in Germania (a cura di Reinhard Elze e Gina Fasoli) Bologna Societagrave editrice il Mulino 1984 pp 79shy122
FORNASIN 1999 A FORNASlN II rnercatodei grani di Udine Indagine per una storia dei prezzi in Friuli (secoli X1(1-XVIII) Nota di ricerca del Dipartimento di Scienshyze Statistiche dellUniversitagrave degli Studi di Udine 4 1999 pp 1-24 ora in ID La Patria del Friuli in etagrave frtoderna Saggi di storia economica Udine Forum 2000 pp 33-60
GRENDI 1986 E GRENOl Lapprf(vvigionamento dei grani nella Liguria del Seicento libera pratica e annone in rMiscellaneastorica ligure Studi in onore di Luigi Bulferetti XVIII1986 2 IP 1021-1047
GUENZl 1981 AGUENZI Ilfrumento e la cittagrave il caso di Bologna nelletagrave moderna in Quaderni storici XVI ~98l 46 pp 153-167
GUENZlI982 A GUENZI Pane efornai a Bologna in etagrave moderna Venezia Marsilio 1982
l
491 498 Renzo P Corritore
alla spartizione dei proventi derivanti dalla vendita e dal commercio del grano shylemolumento grandissimo - di chi doveva poi fruire della redistribuzione di tale ricchezza Tale norma avvantaggiava i possidenti cittadini e i gentiluomini privilegiashyti in grado di ottenere le tratte di esportazione Spl piano dellappropriazione essi erano in condizione di mettere fuori gioco gli altri possessori che producev~o eccedenze nel Dorilinio poicheacute si accresceva la loro forza contrattuale e la loro capacitagrave di occupare i canali commerciali piugrave redditizi Sul piano della commercializzazione gli stessi fruivashyno dello smantellamento della rete dintermediazionerappresentata dai fornai Per i rushystici significava perdere un collegamento essenziale con la cittagrave ed essere emarginati dal mercato urbano nelle campagne o sul broletto di Mantova essi non trovarono piugrave i trashydizionali interlocutori (CORRIJ9RE 2000 228231-2)
Nel caso di Bologna terra strutturalmente deficitaria e cittagrave dalla vocazione manishyfatturie1a si costringeva i fornai ad acquistareformenti terrieri presso i solari privati in cittagrave proibendogli lincetta nel contado autorizzandoli ad acquistarefornientiforeshystieri al di fuori delle mura cittadine presso rsensati da grCUlO solo a patto che fosseshyro stati smaltiti i grani cittadini a un prezzo talota superiore a quello dei grani dimshyportazione (GTlBNZl1982A 35 52-3)
Nella Toscana dei Medici il diritto allincetta nel contado venne concesso ai fornai in periodo di bassa congiuntura (in particolare dagli anni Trenta del Seicegravento) Per sostenere i prezzi interni in tal caso essi restavano gli interlocutori principali dei granshydi proprietari semplicemente spostando la loro principale fonte di approvvigionashymento dai solari dei particolari in cittagrave ai granai decentrati delle grandi aziende agrishycole oppure ai mercati rurali su cui affluiva la produzione cerealicola delle grandi fattorie (PULT QUAOUA 1984 86-9 PucrQUAGUA 1990 100 106-7)
Laddove non vi egrave come invece succede a Genova una diretta ingerenza del potere pubblico nella vita della corporazione (MAsSA 1999) i fornai di cittagrave- nonostante i lacci e lacciuoli normativi e il lavoro prevalentemente manuale svolto neUord laboshyratori - erano dei veri imprenditori dipendenti per il loro profitto - noilrinalmente stabilito per legge - dalla produttivitagrave del lavoro e dalla dotazione tecnica e finanziaria delle imprese Di ciograve fa fede la grande sperequazione esistente fra le aziende speciashylizzate nena fabbricazione del pane venale in cittagrave (AYMARD 1966 75 VBCCHIATO 1979 82-3 GTlBNZl1982A
77 segg PULT QUAGUA 1984100 102-3) NellItalia delshyletagrave moderna questi artigiani-imprenditori della filiera del grano trattavano insieme
afarinaifarinaiolifarinottifondachierifontechierifidelarijormentinari lasagneshyri maccaronari taraltari vermicellari ecc fra il 40 eil70 per centodel frumento consumato in Cittagrave nelle annate normali (CORlUTORE 2000 126 segg) e ~no alIDO per cento nelle annate di carestia (PULT QUAGUA 1984 98-9)
In una ricognizione delle asimmetrie informative del mercato non cegrave gruppo quale i fornai che possa integraverpretare la parte dellagente economico onnisciente Se dunque i regolamenti annonari tendevano a regolare minuziogravesamente la collocazione il volushyme e la durata delle loro scorte cosi come disponevano per gli altri artigiani della fishyliera era per neutralizzare il carattere potenzialmente eversivo di tale accantonamenshyto per i proprietari-venditori prima ancora che per i consumatori-acquirenti nlivello delle scorte rinforzava o attenuava il rischio di monopsonio da parte dei pistores piugrave potenti e facoltosi cosi come eventuali tentazioni da parte della categoria di esercitare un dominio egoistico sul mercato del pane (MATroZZI 1983 298)
Sarebbe quindi un errore concep~ le sccedilorte dei fornai come entrilpica allocazione di capitale che sconta lincertezza futura esse venivano gestite secondo criteri di rashyzionalitagrave economica e secondQ la migliore efficienza tecnica nonostante i vincoli imposti alla lievitazione degli stock dalle disposizioni annonarie
LA costituzione di scorre granarie pubbliche e la polilica economica degli stati
vimini paglia o canne intrecciate (come ceste stuoiecannizzi) in terracotta (addirittura anfore) piuttosto che di tessuto (i sacchi costavano troppo) (PICClNNl 1976 397 MAzzA RAvBGGI 1983 174-5 Zoo Turo 1990 893-4 CORIONESI 1991 35n-36n)
Nella casa del piccolo produttore O del titolare di un piccolo possesso il penus (la scorta domestica) difficilmente eccedeva il consumo famigliare chi fortunato raccoshyglieva piugrave dellannona famigliare e di quanto gli serviva per il campo era spinto a venderselo nei mesi immediatamente successivi alla mietitura e alla trebbiatura per necessitagrave di denaro ma anche per la difficoltagrave di stoccare e conservare il prodotto in condizioni ottimali (MEUVRET 1988 17-9 Pmr QUAGUA 1984 88) e financo per ridurre il rischio di vederselo soffiare da vagabondi e malintenzionati In questo caso in presenshyza di eccedenze (ma probabilmente anche in assenza) il bisogno di liquiditagrave e 1alea cospiravano nel ridl1rre ai minimi termini le scorte giagrave allindomani del raccolto In caso alternativo il contadino che non egrave - ripete Jean Meuvret - un homme daffaires quanshyto un homme de peur concepiva la sua riserva come un fondo di previdenza sul racshycolto futuro da non immettere sul mercato se non nel caso dellapprossimarsi di una messe sicura secondo una logica economica a contrario (MEUVRBT 1988 19 e 147)
Era Hltente la disparitagrave fra i produttori non solo fra chi era in possesso di eccedenshyze e chi non lo era ma piugrave ancora fra chi poteva scegliere - in virtugrave di una maggiore capienza economica e un adeguata dotazione tecnica - il mercato piugrave favorevole per i propri grani (il periodo di saldatura dei raccolti) e chi invece li cedeva troppo presto o in controtempo a livelli non ottimali
Nella gerarchia delle abitazioni rurali -- in quel vero e proprio saggio di sociologia che egrave il sesto libro del De Architectura di Sebastiano Serlio (scritto fra il 1537 e il 1555 inedito per tutto levo moderno) - per trovare case attrezzate di granaio occorshyreva ascendere sino alla magione del basso mercante o cittadino fuori della cittagrave (SERLIO 1994 43 segg anche per le successive informazioni) Condizione di cui non potevano fregiarsi invece i ricchi contadini in ~ssuno dei tre gradi possibili di ricshychezza al massimo la loro casa poteva es~ere attrezzata di portici per ricoverare le biade e di unaia per batterle segni di distinzione giagrave fra i mediocri contadini Fra questi perograve avrebbero potuto avvalersene soltanto i fortUIgravelati et di beni et di famishyglia (3deg grado di mediocritagrave) Dforno per cuocere il pane e una cantina per conservashyre il vino invece li si sarebbe trovati a partire dai piugrave accomodati fra i poveri contashydini cioegrave al 4deg gradino della scala sociale alla cui base erano da collocare i poveri mendichi con vil capanna (1deg grado di povertagrave) i salariati che vivevano delle [loro] fatiche avendo un puoco di terreno (2deg grado di povertagrave) i poveri con qualche beshylitiuola et massimamente de buovi possessori di una stalletta congiunta con la casa (3deg grado di povertagrave) In sintesi nelle campagne delletagrave pre-industriale pochi avevano scorte pochissimi
erano in grado di ricoverarle in un solaro privilegiatissimo chi le incanevava per speculare Dunque fra i contadJni se si esclude quanto celato nella madia o nella dishyspensa le scorte erano un pri~ilegio di pochi Il Sedio nato intorno al 1475 insiste sullimpoverimento delle class~ rurali intervenuto fra gli anni della sua giovinezza e quelli della vecchiezza in cui segraverive Sotto il titolo Dellabitazione del ricco contadishyno per tre gradi di ricchezza si preoccupa di puntualizzare
bencheacute al digrave dogi non se ne truovi piugrave de tali merceacute delle discordie et di gli animi fieri et ostinati alla vendetta onde per tal cagioni et per le continue guerre et anche pei citadini divoratori de gli altrui beni che con le usure con glinganni con le rapine gli hano impoveriti (SERllO 1994 48)
492 497 Renzo P COlTitore
Tale disparitagrave sociale si riverberava sulla struttura del conunercio cerealicolo La funzione dei piccoli conunercianti di biade (granaioibiadaiolijarinaioli balshy
zarotti cavallanti vaticali ecc) era infatti ancillare alla capacitagrave di affacciarsi sul nercato della fascia marginale dei possidenti con eccedenze Solo che nelle annate di
abbondanza si verificavano ingorghi nellofferta di grano che deprimevano i prezzi e incentivavano i piccoli produttori a smerciare direttamente le eccedenze allindomani del raccolto nellarea urbana anche al di fuori dei luoghi deputati (MA1TOZZl 1983 278 281-2 300n PULT QuAGLIA 1984 86) Mentre nelle annate di penuria si contraeshyva drasticamente proprio questo segmento dellofferta (ABEL (1966J 22-4 KULA (1962] 73-4 CATIINI 1984 111-23 PuLT QUAGLIA 1984 88) scatenando nelle campashygne una caccia al grano-merce la cui quota piugrave consistente era detenuta dai grandi proprietari dai maggiori affittuari dai percettori di canoni diritti o rendite in grano e la cui quota residua era piugrave facilmente preda di chi occupava posizioni chiave nellasshysetto terriero nella catena dei diritti nel credito alla produzione e al consumo
Tanto la distribuzione era frammentata nelle annate di abbondanza tanto in epoclshydi penuria il conunercio del grano diventava un affare di pochi In questo caso lazioshyne dei mercanti diventava dimpiccio sul mercato interno dove la coperta si restringeshyva per i proprietari e gli imprenditori agricoli (KULA (1962J 56-61 CATIINI 1984 114-8) - dove la necessitagrave di ricorrere al credito da parte dei piccoli possessori pOneva questi nelle mani degli agenti dei proprietari dei percettori di canoni diritti o rendite - dove i piccoli proprietari vedevano minacciata la loro stessa condizione da parte di chi controllava localmente in maniera capillare e decentrata il mercato del denaro e dei beni necessari alla riproduzione (sernenti strumenti cibo) La soluzione era quelshyla di precludere amministrativamente ai sensali e ai conunercianti di grani i mercati locali su istigazione dei medi possessori le cui occasioni di normale profitto agrario soffrivano un ridimensionamento e che si vedevano costretti a impegnarsi ccedilontiltte le loro forze per integrare le proprie entrate accaparrandosi le magre eccedenze disponishybili nelle campagne e nei borghi rurali (PuLT QUAGLIA 1984 84-8 PuLT QUAGLIA 1990 107-14)
Il destino dei piccoli conunercianti in grano era quindi quello di occupare una posishyzione marginale nel mercato del grano (MEUVRET 1977 30 PINTO 1978 13 MATTOZZI 1983 277) e di operare non solo a causa degli ordinamenti annonari - secondo una logica di corto respiro in cui non era contemplata neacute la conservazione di grani a lungo termine neacute lutilizzo di depositi piugrave che provvisori Come per i piccoli possidenti non si puograve parlare nel loro caso della formazione e del mantenimento di scorte consistenti (MEUVRET 1988 156-7) Non tali comunque da sostenere il reddito contadino nelle stagioni ordinarie e da esercitare sul versante cittadino unefficace azione anticonshygiunturale in caso di carestia
Peraltro in cittagrave la struttura dellofferta era anche piugrave sperequata di quella che si rishyscontra nel contado Che si tratti di Prato ne) 1339 (PlNTO 1978 129 PINTO 1982 160n e 171n) Pavia negli anni 1539 1555 1573 1602 1603 (ZANIITTI 1963) o Mantova nellultima parte del secolo XVI (CORRITORE 2000 81-9) la distribuzione delle scorte fra i privati era singolarmente ineguale Lo attesta la rilevanza nellarea urbana della povertagrave cioegrave secondo una definizione coeva di coloro che non vivono di entrate ma sono necessitati ricorrere mattina e sera alle pistorie a comprare il pane per il vitto loro e delle sue famiglie col denaro che di giorno in giorno si vanno guadagnando (MATshyTOZZI 1983 281) PUOgrave essere utile richiamare la situazione delle cittagrave tedesche nel basso Medioevo in una fase che egrave stata definita da Wilhelm Abel l epoca doro degli artigiani e del lavoro salariato si puograve stimare che almeno la metagrave degli iscritti ai
il costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica ecol1Omica degli stati
te con il principio della piazza Il mercato pubblico periodico disciplinato la spiagshygia la piazza la loggia o il recinto riservato alle contrattazioni - coesisteva confabshybriche magazzini ebotteghe La stessa piazza per funzionare al meglio secondo il principio dello scambio diretto necessitava di magazzini di supporto
4 LE SCORTE DEI FORNAI CITTADINI
Nellarea urbana e nelle relazioni tra cittagrave e campagna operavano perograve temibili conshycorrenti dei privati possessori I fornai cittadini possedevano le competenze le strutshyture tecniche le relazioni sociali e il credito per incettagravere il prodogravetto per essere inforshymati tempestivamente sul mercato del grano e potenzialmente per dispensarlo con profitto in qualunque momento Il fatto che il loro operato fosse imprigionato in un arshycaica impalcatura di norme divieti obblighi che risalivano alletagrave romana che ne fashycevano in modograve quasi istituzionalizzato il capro espiatorio delle tensioni fra produtshytori di grano povertagrave e autoritagrave non impedisce di affermare che tali vessatorie disposizio~i trovassero la loro principale ragione dessere nella parte che essi giocashyvano di interlocutorilantagonisti dei proprietari terrieri nella determinazione del prezshyzo del grano sul mercato locale e nella realizzazione della rendita terriera (GUENZI 1982 35 GUENZl 1982 297)
Nel caso di Mantova terra cornucopia a partire dal 1492 si consenti a zentilhomini cittadini et qualuncho altro di comprare biade nel Dominio per approvvigionare la cittagrave di fatto si sancigrave un diritto allincetta che mise fuori gioco i fornai a cui venne imposto di rifornirsi nei solari dei cittadini senza avere piugrave la possibilitagrave di effettuare acquisti nel contado e di ritenere a casa scorte superiori a 100 staia di frumento Lintento della disposhysizione egrave chiarissimo espresso senza reticenze dai Maestri delle Entrate che riportarono al marchese la soddisfazione dei possidenti mantovani per la riforma statutaria
tutta la Terra (cioegrave il Mantovano] ne (egrave] rimasta satisfactissima pensando che Vostra Excellentigravea pretenda ali comodi et utilitagrave universale senza dampno et preuiditio suo Vero egrave che li fumari non si contentano parendoli comegrave il vero che non si poteranno ingrnssar asuo modo come hanno facto per il passato et poterigravea Igravelchader ( ] che veneranno adolershyse et supplicar aVostra Signoria Perograve me egrave parso dargene aviso per questa nostra et farli intender che questa terra ha soliigrave due membri de li quali li cittadini soi se ne possono aiutashyre e valersene uno egrave il grano laltro egrave larte de la lana et quando se concedesse che li furshyDari potessero comprare come h~o facto li tempi passati sana un fare beneficio acinquanshytaocto dessi et dampnifichar elresto de fa republica sua quale de questo ban ordine ne receve emolumento grandissimo et se gaude in la Citagrave [percheacute] li fumari portano fuora el denaro et pretendono solo a suo benefitio (AG b 2441 lettera del 13 luglio 1492)
Egrave indubbio che il plauso della Terra fosse da attribuire piugrave alla possibilitagrave per i proshyprietari di accrescere le proprie entrate che a quella dei consumatori cittadini e dell arte della lana di trarre beneficio dalla disposizione Egrave significativo che la motivazione pro cigravevitate non accenni allesistenza di monopoli da parte dei fornai o di artificiose lievitashyzioni dei prezzi per causa loro Il loro attivismo non confiiggeva per quanto riguarda i prezzi finali della sussistenza con linteresse dei produttori cittadini E daltra parte largomento dellQ storno dal merpato cittadino dei profitti incamerati dai fornai -laccushysa consueta a proposito dei pistores egrave che fossero in gran parte stranieri (GUENZII982 22) -- era una giustificazione debole che appassionava piugrave chi concorreva direttamente
496 493
Renzo P Corritore
appare altrettanto astratto dogmatico o virtuale del principio di mercato (Market Pri1lciple) che il medesimo gli contrappone Henri Pirenne parlando della politica annonaria dei comuni medievali avverte Lapplicazione del principio della vendita diretta ebbe numerosi eccezioni (PumNNE [1933] 193n)
Nel caso di Mantova la scelta della Piazza egrave facoltativa per i terrieri COn eccedenze Gli Statuti signorili che si rifanno largamente alle raccolte statutarie comunali non sancivano alcun obbligo in proposito (v SVJUTI BONACOLSIANI [1313] libro m rubr 55 De mercato blave 253 STATlITl GoNZAOHESCHI [1404J libro m rubr 93 De mercato blave fiendo in civitate Mantue f 73v) Decreti di carattere straordinario e regolamenshytazioni transitorie correggevano il tiro Nel 1405 in piena saldatura dei raccolti si c0shy
strinse a rifornire forzosamel)~ la piazza concentrandovi tutte le contrattazioni Nel 1417 si obbligograve a riservare al mercato un terzo del frumento introdotto in cittagrave (CORRIshyTORE 2000 235-6) Ma sono atti straordinari che non sopravvissero nel migliore dei casi piugravedi qualchelustro (MANroVA 1430 88 90 181) A Mantova la Piazza era affianshycata da un granaio pubblico la Domus del mercato (altrove definito Folllico o Fonrego del mercato) in cui avrebbero dovuto prolungarsi le contrattazioni oltre lorario e i giorshyni deputati (venerdigrave o sabato) rendendo disponibile ciograve che restava invenduto e che non poteva essere ritirato per legge dal mercato Nel 1430 eminenti cittadini sollecitati dal principe lamentavano perograve lincapacitagrave del magazzino - inoperoso in tutto o in parte per il pericolo di crolli -- di rispondere ai bisogni del popolo in una situazione in cUi da parte dei possessori si protestava la difficoltagrave di non poter esitare e smerciare fuori delshyla cittagrave le eccedenze conservate nei solari privati
Item videtur quod valde utille foret civibus Mantue habentibus possessiones et quishybuscumque alijs personis de civitate Mantue aut districtu colligantibus bIada et vina in magna copia ut omni tempore ipsa bIada et vinum possent extrahere de civitate et dishystrictu Mantue et conducere ad Iaea ad que et in quibus ma vendere poterunt cum otdishynibus et dacijs competentibus ipsa tamen civitate semper remanente fulta pro usu dicte civitatis et populi eiusdem ne dieta biada marceschant super granarlis ut hactenus feceshyrunt cum maximo incomodo ipsorum civium (MANTOVA 1430 177-8)
nmedesimo fondaco abbinato al mercato operava a Verona a Ferrara a Vegravenezia a Udine a Chioggia in molte altre cittagrave (MANToVA 1430 100 FORNASIN 1999 7-9 CEshySTAR 1794)
Lintegrale e pedissequa applicazione del principio della piazza di mercato comporshytava - per i vincoli tecnici dell etagrave pre-industriale -la massima affermazione del prinshycipio della canova cioegrave del magazzino pubblico centrale Unico argine alla sua invashydenza era costituito da una distribuzione perequata ab imis del raccolto cioegrave la possibilitagrave - egrave questo il paradosso - di realizzare da parte dei produttori la massima aspirazione nelle societagrave tradizionali lautarchia domestica Piugrave avanzava invece la sperequazione nel reddito e nel patrimonio piugrave da parte dei consumatori privi di scorshyte si impetrava il principio del Magazzino pubblico nella ronna di un efficiente sisteshyma di ricovero conservazione distribuzione delle derrate a garanzia del funzionashymento della Piazza di mercato La disponibilitagrave di crescenti quote di raccolto tuttavia indirizzava i piugrave accomodati verso soluzioni piugrave ghiotte la vendita allingrosso sul mercato cittadino ai fornai o allimpresa pubblica creata a sussidio di questi (o in loro vece) Oppure allopposto lesito delle eccedenze extra muros sui grandi mercatishyemporio regionali per il tramite di mercanti o agenti diretti
Il principio del magazzino pubblico centrale cioegrave laccumulazione di riserve per lo smercio continuo o anticiclico egrave quindi alla sua origine in opposizione solo apparen-
La costirU1ione di scorre granarie pubbliche e la politica economica degli srati
ruoli fiscali non fosserograve in grado di accantonare scorte Nel 1444 a Strasburgo quattro cittadini su dieci non possedevano alcuna riserva cerealicola (DRlMBIER 1984 112)
Nelle cittagrave italiane delletagrave moderna si puograve stimare che non meno di due terzi della popolazione fosse costretta ad acquistare o consumare pane confezionato con grani e farine comperati nelle piazze nelle vie e nelle botteghe cittadine oppure ottenuti come compenso del proprio servizio nelle casate (CORRrroRE 2000 126-36 MA11oZZI 1983 27~-82) Evidentemente questa fascia di lavoratori salariati non possedeva -shyper definizione - neacute scorte neacute depositi personali e nel primo caso era strettamente dipendente dal mercatograve urbano acquistando la sua sussistenza con frequenza non piugrave che settimanale (essendo costretti a comprare il pane tutti i giorni allafinestra si dishyceva a Genova [GRENDI1986 1031])
Ma anche fra i citiOdini con possesso extra moenia la distribuzione delle scorte era tuttaltro che egalitaria A Prato nel 1339
A parte gli enti religiosi sette famiglie [ ] avevano ii disposizione piugrave di mille staia di granaglie (circa 18 tonnellate) fino a un massimo di 3500 Altri venti nuciei familiashyri avevano scorte comprese tra le 500 e le 1000 staia (PINTO 1978 129n)
A Mantova nei magazzini ducali nellultima parte del 500 erano ammassati non meno di un ottavo talora piugrave di un quarto delle riserve cittadine di grani panificabili (CoRRITORE 200081-6) A Pavia nel corso dello stesso secolo e allinizio di quello successivo nei solagraveri di una sessantina di famiglie si concentrava non meno del 40 per cento dellintera offerta cittadinIgrave di frumento(ZANBUgrave11964 70-7) Anche in questo caso egrave utile sapere che nelle cittagrave tedesche esistevano mercanti (ad Augusta RatisboshyDa Norimberga) in grado di axnPmssare riserve da 6 a 45 tonnellate e che a Francoshyforte nel 1488 due patrizi totali~zavano insieme un terzo delle scorte cerealicole dei particolari nella cittagrave alta (DnuMmER 1984113)
Ritenere tali soggetti sprovv~uti al punto di incanevare grani con il solo scopo di esorc~ i pericoli della Fstia egrave perlomeno riduttivo A grandi solari comshyspondevano vaste familiae e pIftore di servi tori e ospiti ma tali scorte eccedevano largamente la sussistenza del maggiore palazzo nobiliare o patrizio senza peraltro costituire un fondo di accantonafoento eccedente il fabbisogno della cittagrave a meno che non vi fosse la concreta possibilitagrave di commercializzare il surplus sui mercati esteri Come nota infatti Adam Smith
a meno che leccedenza non possa essere esportata in tutte le circostanze ordinarie i coltivatori staranno molto attenti a non produrre e gli importatori a non importare mai una quantitagrave maggiore di quell~ che egrave strettamente richiesta dal consumo del mercato interno Questo mercato saragrave difficilmente sovrafomito ma saragrave in generale sottoriforshyDito dato che coloro che svolgqno lattivitagrave per rifomirlo avranno in generale il timore che la loro merce possa rimanete invenduta (SMlTH [1776] 528)
Lipotesi egrave suffragata dai cas~ storici conosciuti A Bologna macrodistretto serico dellevo moderno laddove gli ipteressi manifatturieri e mercantili avrebbero dovuto consigliare una sussistenza a b~on mercato per tenere basso il costo del lavoro le istituzioni annonarie operavano per garantire con il calmiero deljorme1lto la monetizshyzazione della rendita granaria dei possidenti - strutturalmente incapace di coprire il fabbisogno della cittagrave anchea rischio della carezza dei viveri contingentando il mercato dei grani forestieri (GtJFNZl1982A 37-76) Di fatto
495 494 Renzo P Corrllnre
In ogni caso si tendeva a limitare al minimo indispensabile lemiddot importazioni di frushymento per evitare che stocks invenduti potessero turbare la collocazione dei grani tershyrieri nel nuovo anno agrario (GuENZI 1981 153)
In tutti i centri comunque la tendenza a ritardare la vendita del surplus nei mesi della saldatura lutilizzo di depositi specializzati con personale addetto alla custodia al conshydizionamento e alla commercializzazione del prodotto ponevano i grandi proprietari di biade su un gradino superiore e diverso rispetto al resto della cittagrave Laccantonamento di grani per questa cupola di possessori rispondeva al principio dellutilitagrave soggettiva atshytesa e richiedeva sia capitale fisso sia capitale circolante per raggiungere gli scopipreshyfissati un profitto speculativo la valorizzazione della rendita
In molte cittagrave i possessori non avrebbero dovuto trattenere in casa piugrave grano e farina di quantoprescritto dalla legge cioegrave il consumo mensile per bocca - fissato anchesshyso statutariamente - per arrivare al nuovo raccolto Ma i cittadini credeVano veramenshyte ai loro comandamenti Egrave lecito dubitare La norma era scolpita negli Statuti e pubshyblicamente violata con la complicitagrave dll1e autoritagrave e dei groppi professionali interessati alla distribuzione del grano nelle sue ~arie forme
Nelle annate ordinarie la quota di grano auto consumato - cioegrave non acquistata sul mercato - nelle cittagrave italiane dell evo moderno rappresentava fra il 30 e il 60 per censhyto del fabbisogno urbano di frumento
Nella capitale dei Gonzaga nel 1615 si valutava che su 27000 bocche
il terzo [di] gentilhuomini fittadri servitori et altri [ ] non comprano biada et gli duoi tenigrave tra poveri artisti mercanti fomari fondachieri hebrei et altri [bull] non possono in tutto levar sufficientemente la somma de detti dua terzi sl che saranno boshychegrave 18000 che compraranno biada (COIUUTORl 2000 126)
AVenezia a cavaliere fra XVI e XVII secolo alla mensa delle casade si dispensava circa un terzo del frumento consumato ordinariamente in cittagrave (AMARD 1966 74 MATTOZZI 1983 281) ABologna per tutto il Seicento i fornai che impastavano farine in conto lavorazione per i particolari pareggiavano piugrave o meno il numero di quelli da scqffa che smerciavano pane venale (GUENZI 1982A
27) Peraltro la proporzione a Rialto tra chi lavorava per le casade e chi vendeva pane al pubblico - 65 Jo~ri a fronte di 44-48 pistori negli anni 1583-1685 (DELLA VALBNTINA 1992 143-4 167 192-3) - fa ritenere la struttura del mercato del pane felsinea non molto dissimile da quella veneziana Nelle cittagrave liguri o toscane sei-settecentesche la porzione autocon sumata quando il raccolto era buono era anche piugrave elevata (GRENDI 1986 1024-6 1034 PuLT QUAOUA 1984 98-104 PULT QUAGUA 1990 171-2) A Napoli nel 1758 a Monasteri Luoghi pii e Particolari eta riservato il 28 per cento del consumo cittadishyno di frumento (AuFANO 1996 37n)
Lelevato numero di servi domestici persone al servizio delle casate faceva sigrave che in alcuni palazzi si concentrassero masse cospicue di grano per la spesa familiare Ma accanto ad esse gli operatori dell annona -- la stessa povertagrave -- si auguravano che vi fosse sempre anche la materia per rifornireil mercato e i forni cittadinimiddot nella fase piugrave delicata del ciclo annuale il periodo di saldatura dei raccolti Come spiegare altrimenshyti la norma che imponeva ai grossi detentori di biade (non esclusi enti e opere pie) in varie cittagrave italiane dellevo moderno la vendita straordinaria in primavera dellegrave ecshycedenze ammassate in granaio (per Pisa e la Toscana v PuLT QUAGUA 1984 88-9)
A Mantova nel 1554 si stabiliva che i patroni che avessero fruito in cittagrave di piugrave di 20 sacchi di grano come porzione dominicale avrebbero dovuto coilservare in granaio
lA costituzioni digrave scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
il 4 per cento per le necessitagrave dei consumatori dei fornai e dei Jontachieri quando fosse mancato il prodotto sulla piazza o nelle offerte deisensali Nel 1603 ci si preocshycupograve di elevare la quota al 6 per cento (CORRlTQRE 2000 237n) Beninteso le vendite sarebbero avvenute ai valori di mercato Lo stesso sistema vigeva a Cremona (6 per cento nel 1608 e nel 1612) (MERON 1957 59n 63 JACOPETl1 1965 128) ea Verona Qui una delibera consiliare del 1549 autorizzava per la prima volta
[il deputati [alle Biadel [a] tassar e comandar con quelle pene che al Clarissimo Podestagrave pareragrave quella quantitagrave di biade a ciascuno secolare o eclesiastico sia di qual grado o condittione esser si voglia che havesse biade in questa cittagrave oltre il viver suo
(VOCCHIATO 1979 145)
La tassa sarebbe stata stabilita - da11558 - per sorteggio fra le casate che avessero introdotto in cittagrave dai propri possedimenti piugrave di 70 minali per rifo1llire il Mercato delle biave Essa-venne anche incrementata nella stessa occasione dal 5 al6 per censhyto per restare in vigore fino al 1631 (VECCHIATO 1979 141-58)
Quest9 tiIfo di normativa nasce e si affiogravea in ambito amministrativo perciograve echeggia la realtagrave molto meglio della veneranda legge generale
Da tali disposizioni si deducono alcuni fatti incontrovertibili 1entro la cerchia cittadina esistevano scorte private eccedenti la spesa delle famiglie
in violazione in molti casi della legge statutaria 2il possesso della terra che solo assicurava lautarchia delle casate era il piugrave-potente
fattore di discriminazione fra i cives tanto da precipitare nel girone dei pauperes la moltitudine che acquistava correntemente la sussistenza nellarea urbana
3fra gli stessi possidenti cittadini esisteva uneacutelite che non solo conservava scorte oltre il viver suo ma che si proponeva egoisticamente di speculare ritardando limshymissione dei grani sulle piazze cittadine o che a~endeva il momento piugrave opportuno per smerciarli allesterno nelle grandi piazze frumentarie come livorno Desenzashyno Legnago Romano (di Lombardia) ecc
4lineguaglianza fra i cives tese ad aggravarsi con la metagrave del 500 poicheacute questi reshygolamenti innovano quasi sempre disposizioni generali risalenti al tardo Medioevo che sancivano lobbligo di convogliare il surplus sulla piazza cittadina segno di una distribuzione del reddito originariamente meno sbilanciata A Cremona gli Statuti del 1388 obbligavano - cosl egrave ancora nel 1510 - a vendere il
sovrappiugrave in Piazza Maggiore sul mercato pubblico dei grani (MERON 1957 59n
63)A Pisa il rescritto che imponeva di effettuare le vendite al minuto in platea bladi
risale al 1401 MALANlMA 1976 293) lobbligo era ribadito ancora nel 1548 ma nella seconda metagrave del secolo XVI si affermava la pratica di vendere fuori mercato tanto che nel 1581 il Magistrato dei Nove dovette intervenire per far vendere i grani delle comunitagrave degli enti e dei luoghimiddotpii soltanto da marzo-aprile in piccole quantitagrave sul mercato (PULT QUAGUA 1984 81-91) La disposizione per altro si applicava allinteshyro Stato (PULT QUAGUA 1984 88)
Tuttavia non egrave da pensare che il principio della concentrazione delle compravendite sulla piazza di mercato cittadina fosse universale universalmente rispettato e sopratshytutto perenne La centralizzazione del grano non significa automaticamente lobbligo di vendita diretta sulla Piazza deiformenti Affermare come Steven L Kaplan che
There was no single more important regulation concerning tbe provisioning trade tban tbe requirement tbat alI transactions occur in tbe marketplace (KAPLAN 1984 27)
494 495 Renzo P Corritore
In ogni caso si tendeva a limitare al minimo indispensabile le importazioni di frushymento per evitare che stocks invendutigrave potessero turbare )a collocaziolle dei grani tershyrieri ileI nuovo anno agrario (GUENZI 1981 153)
In tutti i centri comunque la tendenza a ritardare la vendita del surplus nei mesi della saldatura lutilizzo di depositi specializzati con personale addetto alla custodia al conshydizionamento e alla commercializzazione del prodotto ponevano i grandi proprietari di biade su un gradino superiore e diverso rispetto al resto della cittagrave Laccantonamento di grani per questa cupola di possessori rispondeva al principio dellutilitagrave soggettiva atshytesa e richiedeva sia capitale fisso sia capitale circolante per raggiungere gli scopipreshyfissati un profitto speculativo la valorizzazione della rendita
In molte cittagrave i possessori non avrebbero dovuto trattenere in casa piagrave grano e farina di quantoprescritto dalla legge cioegrave il consumo mensile per bocca ~- fissato anchesshy
so statutariamente --per arrivare al nuovo raccolto Ma i cittadini credevano veramenshyte ai loro comandamenti Egrave lecito dubitare La norma era scogravelpitagrave negli Statuti e pubshyblicamente violatamiddot con la complicitagrave dccedillle autoritagrave e dei gruppi professionali interessati alla distribuzione del grano nelle sue varie forme
Nelle annate ordinarie la quota di grano autoconsumato - cioegrave non acquistata sul mercato - nelle cittagrave italiane dell evo moderno rappresentava fra il 30 e i160 per censhyto del fabbisogno urbano di frumento
Nella capitale dei Gonzaga nel 1615 si valutava che su 27000 bocche
il terzo [di] gentilhuomini ligravettadri servitori et altri [ ] non comprano biada et gli duoi terzi tra poveri artisti mercanti fomari fondachieri hebrei et altri [ l non possono in tutto levar sufficientemente la $omma de detti dua terzi sl che saranno boshyche 18000 che compraranno biada (CoRRlTORB 2000 126)
AVenezia a cavaliere fra XVI e xvn secoioalla mensa delle casade si dispensava circa un terzo del frumento consumato ordinariamente in cittagrave (AYMARD 1966 74 MArroZZI 1983 281) A Bologna per tutto il Seicento i fornai che impastavano farine in conto lavorazione per i particolari pareggiavano piil o meno il numero di quelli da scaifa che smerciavano pane venale (GUBNZI 1982 27) Peraltro la proporzione a Rialto tra chi lavorava per le casade e chi vendeva pane al pubblico - 65 fOf7lri a fronte di 44-48 pistori negli anni 1583-1685 (DELLA VAUNTINA 1992 143-4167 192-3) - fa ritenere la struttura del mercato del pane felsinea non molto dissimile da quella veneziana Nelle cittagrave liguri o toscane sei-settecentesche la porzione autoconshysumata quando il raccolto era buono era anche piil elevata (ORENOI 1986 1024-6 1034 PuLT QUAGLIA 1984 98-104 PULT QUAOLIA 1990 171-2) A Napoli nel 1758 a Monasteri Luoghi pii e Particolari eta riservato il 28 per cento del consumo cittadishyno di frumento (AuFANO 1996 370)
Lelevato numero di servi domestici persone al servizio delle casate faceva si che in alcuni palazzi si concentrassero masse cospicue di grano per la spesa familiare Ma accanto ad esse gli operatori dellannona -lastessapovertagrave __ si auguravano che vi fosse sempre anche la materia per rifornire il mercato e i forni cittadini nella fase piil delicata del ciclo annuale il periodo di saldatura dei raccolti Come spiegare altrimenshyti la norma che imponeva ai grossi detentori digrave biade (non esclusi enti e opere piegrave) in varie cittagrave italiane dellevo moderno la vendita straordinaria in primavera delle ecshyredenze ammassate in granaio (per Pisa e la Toscana v PuLT QUAGLIA 1984 88-9)
A Mantova nel 1554 si stabiliva che i patroni che avessero fruito in cittagrave di piugrave di 20 sacchi di grano come porzione dominicale avrebbero dovuto conservare in granaio
lA costituzione di SC0114 granarie pubbliche e la politica economica degli stati
il 4 per cento per le necessitagrave dei consumatori dei fornai e dei fontachieri quando fosse mancato il prodotto sulla piazza o nelle offerte deimiddotsensati Nel 1603 ci si preocshycupograve di elevare la quota al 6 per cento (CoRRlTORE 2000 237n) Beninteso le vendite sarebbero avvenute ai valori di mercato 10 stessa sistema vigeva a Cremona (6 per cento nel 1608 e nel 1612) (MERON 1957 -59n 63 JACOPETl11965 128) ea Verona Qui una delibera consiliare del 1549 autoruzava per la prima volta
[i] deputati [alle Biade) [al tassar e comandar con quelle pene che al Clarissimo Podestagrave pareragrave quella quantitagrave di biade a ciascuno secolare o eclesiastico sia di qual grado o condittione esser si voglia che havesse biade in questa cittagrave oltre il viver suo (VBCClI1ATO 1979 145)
La tassa sarebbe stata stabilita - dal 1558 - per sorteggio fra le casate che avessero introdotto in cittagrave dai propri possedimenti piagrave di 70 minali per rifornire il Mercato delle biave Essaveane anche incrementata nella stessa occasione dal 5 al6 per censhyto per restare in vigore fino al 1631 (VECCHIATO 1979 141-58)
Questccedil tijlo di normativa nasce e si affuia in ambito amministrativo perciograve echeggia la realtagrave molto meglio della veneranda legge generale
Da tali disposizioni si deducono alcuni fatti incontrovertibili 1entro la cerchia cittadina esistevano scorte private eccedenti la spesa delle famiglie
in violazione in molti casi della legge statutaria 2il possesso della terra che solo assicurava lautarchia delle casate era il piugravemiddotpotente
fattore di discriminazione fra i cives tanto da precipitare nel girone dei pauperes la moltitudine che acquistava correntemente la sussistenza nellarea urbana
3fra gli stessi possidenti cittadini esisteva uneacutelite che non solo conservava scorte oltre il viver suo ma che si proponeva egoisticamente di speculare ritardando limshymissione dei grani sulle piazze cittadine o che a~endeva il momento piagrave opportuno per smerciarli allesterno nelle grandi piazze frumentarie come Uvorno Desenzashyno Legnago Romano di Lombardia) ecc
4lineguaglianza fra i cives tese ad aggravarsi con la metagrave del 500 poicheacute questi reshygolamenti innovano quasi sempre disposizioni generali risalenti al tardo Medioevo che sancivano lobbligo di convogliare il surplus sulla piazza cittadina segno di una distribuzione del reddito originariamente meno sbilanciata shyACremona gli Statuti del 1388 obbligavano - cosl egrave ancora nel 1510 - a vendere il
sovrappigraveagrave in Piazza Maggiore sul mercato pubblico dei grani (MERON 1957 59n 63)
A Pisa il rescritto che imponeva di effettuare le vendite al minuto in platea bladi risale al 1401 (MALANIMA 1976 293) lobbligo era ribadito ancora nel 1548 ma nella seconda metagrave del secolo XVI si affermava la pratica di vendere fuori mercato tanto che nel 1581 il Magistrato dei Nove dovette intervenire per far vendere i grani delle comunitagrave degli enti e dei luoghi pii soltanto da marzo-aprile in piccole quantitagrave sul mercato (PULT QUAGLIA 1984 8191) La disposizione per altro si applicava allinteshyro Stato (PULT QUAGLIA 1984 88)
Tuttavia non egrave da pensare che il principio della concentrazione delle compravendite sulla piazza di mercato cittadina fosse universale universalmente rispettato e sopratshytutto perenne La centralizzazione del grano non significa automaticamente lobbligo di vendita diretta sulla Piazza deiformenti Affermare come Steven L Kaplan che
There was no single more important regulation conceming the provisioning trade han the requirement that ali transactions occur in the marketplace (KAPuN 1984 27)
493 496 Renw P Corritore
appare altrettanto astratto dogmatico O virtuale del principio di mercato (Market Principle) che il medesimo gli contrappone Henri Pirenne parlando della politica annonaria dei comuni medievali avverte Lapplicazione del principio della vendita diretta ebbe numerosi eccezioni (PIRENNE [1933] 193n)
Nel caso di Mantova la scelta della Piazza egrave facoltativa per i terrieri con eccedenze GliStatuti signorili che si rifanno largamente alle raccolte statutarie comunali non sancivano alcun obbligo in proposito (v SYJI1l BONACOLSlANI [1313] libro ID rubr 55 De mercato blave 253 STATUTI GoNZAOHESCHI [1404] libro m rubr 93 De mercato blave fiendo in civitate Mantue f 73v) Decreti di carattere straordinario e regolamenshytazioni transitorie correggevano il tiro Nel 1405 in piena saldatura dei raccolti si coshystrinse a rifornire forzosamen~e la piazza concentrandovi tutte le contrattazioni Nel 1417 si obbligograve a riservare al mercato un terzo del frumento introdotto in cittagrave (CoRRIshyTORE 2000 235-6) Ma sono atti straordinari che non sopravvissero nel migliore dei casi piugrave di qualchelustro (MANToVA 1430 88 90 181) A Mantova la Piazza era affianshycata da un granaio pubblico la Domus del mercato (altrove definito Fornico o Fontego del mercato) in cui avrebbero dovuto prolungarsi le contrattazioni oltre lorario e i giorshyni deputati (venerdl o sabato) rendendo disponibile ciograve che restava invenduto e che non poteva essere ritirato per legge dal mercato Nel 1430 eminenti cittadini sollecitati dal principe lamentavano pero lincapacitagrave del magazzino - inoperoso in tutto o in ~per il pericolo di crolli - di rispondere ai bisogni del popolo in una situazione in cui da parte dei possessori si protestava la difficoltagrave di non poter esitare e smerciare fuori delshyla cittagrave le eccedenze conservate nei solari privati
ltem videtur quod valde utille foret civibus Mantue habentibus possessiones et quishybuscumque alijs personis de civitate Mantue aut districtu colligantibus bIada et vina in magna copia ut amni tempore ipsa bIada et vinum possent exttahere de civitate et dishystrictu Mantue et conducere ad Iaea ad que et in quibus illa vendere poterunt cum otdigraveshynibus et dacijs competentibus ipsa tamen civitate semper remanente fulta pro usu diete civitatis et populi eiusdem ne dicta bIada mateeschant super granariis ut hactenus fecemiddot runt cum maximo incomodo ipsorum civium (MANToVA 1430 177-8)
Il medesimo fondaco abbinato al mercato operava a Verona a Ferrara a Venezia a Udine a Chioggia in molte altre cittagrave (MANToVA 1430 100 FORNASIN 1999 7-9 CBshySTARl1794)
Lintegrale e pedissequa applicazione del principio della piazza di mercato comporshytava - per i vincoli tecnici dell etagrave pre-industriale -la massima affermazione del prinshycipio della canova cioegrave del magazzino pubblico centrale Unico argine alla sua invashydenza era costituito da una distribuzione perequata ab imis del raccolto cioegrave la possibilitagrave egrave questo il paradosso di realizzare da parte dei produttori la massima aspirazione nelle societagrave tradizionali lautarchia domestica Piugrave avanzava invecela sperequazione nel reddito e nel patrimonio piugrave da parte dei consumatori privi di scorshyte si impetrava il principio del Magazzino pubblico nella forma di un efficiente sisteshyma di ricovero conservazione distribuzione delle derrate a garanzia del funzionashymento della Piazza di mercato La disponibilitagrave di crescenti quote di raccolto tuttavia indirizzava i piugrave accomodati verso soluzioni piugrave ghiotte la vendita allingrosso sul mercato cittadino ai fornai o allimpresa pubblica creata a sussidio di questi (o in loro vece) Oppure allopposto lesito delle eccedenze extra muros sui grandi mercatishyemporio regionali per il tramite di mercanti o agenti diretti
Il principio del magazzino pubblico centrale cioegrave laccumulazione di riserve per lo smercio continuo o anticiclico egrave quindi alla sua origine in opposizione solo apparen-
La costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
ruoli fiscali non fossero in grado di accantonare scorte Nel 1444 a Strasburgo quattro cittadini su dieci non possedevano alcuna riserva cerealicola (DIIUMBIER 1984 112)
Nelle cittagrave italiane delletagrave moderna si puograve stimare che non meno di due terzi della popolazione fosse costretta ad acquistare o consumare pane confezionato con grani e farine comperati nelle piazze nelle vie e nelle botteghe cittadine oppure ottenuti come compenso del proprio servizio nelle casate (CoRRITORE 2000 126-36 MAnoZZI 1983 27~-82) Evidentemente questa fascia di lavoratori salariati non possedevashyper definizione -- neacute scorte neacute depositi personali e nel primo caso era strettamente dipendente dal mercato urbano acquistando la sua sussistenza con frequenza non piugrave che settimaIIgraveale (essendo costretti a comprare il pane tutti i giorni alla finestra si dishyceva a Genova (GRENDI 1986 1031])
Ma anche fra i citUutini con possesso extra moenia la distribuzione delle scorte era tuttaltro che egalitaria A Prato nel 1339
A patte gli enti religiosi sette famiglie [ bull ] avevano Il disposizione piugrave di mille staia di granaglie (circa 18 tonnellate) fino a un massimo di 3500 Altri venti nuclei familiashyri avevano scorte comprese tra le SOOe le 1000 staia (PINTO 1978 129n)
A Mantova nei magazzini ducali nellultima parte del 500 erano ammassati non meno di un ottavo talora piugrave di un quarto delle riserve cittadine di grani panificabili (CORRlTORE 2000 81c6) A Pavia nel corsq dello stesso secolo e allinizio di quello successivo nei sozagraveri di una sessantina di famiglie si concentrava non meno del 40 per cento dell intera offerta cittadin8 di frumentomiddot (ZANJin 1964 70-7) Anche in questo caso egrave utile sapere che nelle cittagrave tedesche esistevano mercanti (ad Augusta Ratisboshyna Norimberga) in grado di ~sare riserve da 6 a 45 tonnellate e che a Francoshyforte nel 1488 due patrizi totalizzavano insieme un terzo delle scorte cerealicole dei particolari nella cittagrave alta (DlRLMB1ER 1984113)
Ritenere tali soggetti sprovv~duti al punto di incanevare grani con il solo scopo di esorcizzare i pericoli della clarestia egrave perlomeno riduttivo A grandi solari corrishyspondevano vaste familiae e plftore di servitori e ospiti ma tali scorte eccedevano largamente la sussistenza del D-aggiore palazzo nobiliare o patrizio senza peraltro costituire un fondo di accantofilljnento eccedente il fabbisogno della cittagrave a meno che non vi fosse la concreta possibfjitagrave di commercializzare il surplus sui mercati esteri Come nota infatti Adam Smith
a meno che leccedenza non possa essere esportata in tutte le circostanze ordinarie i coltivatori staranno molto attenti a non produrre e gli importatori a non importare mai una quantitagrave maggiore di quell~ che egrave strettamente richiesta dal consumo del mercato interno Questo mercato saragrave difficilmente sovrafornito ma saragrave in generale sottomorshynito dato che coloro che svolgono lattivitagrave per mornirlo avranno in generale il timore che la loro merce possa rimane~ invenduta (SMITH[l776] 528)
Lipotesi egrave suffragata dai cas storici conosciuti A Bologna macrodistretto serico dellevo modemoladdove gli interessi manifatturieri e mercantili avrebbero dovuto consigliare una sussistenza a b~on mercato per tenere basso il costo del lavoro le istituzioni annonarie operavano per-garantire con il calmiero delformento la monetizshyzazione della rendita granaria dei possidenti - strutturalmente incapace di coprire il fabbisogno della cittagrave - anche ~ rischio della carezza dei viveri contingentando il mercato dei grani forestieri (GupaI 1982 37-76) Di fatto
492 Renzo P COITitore
Tale disparitagrave sociale si riverberava sulla struttura del commercio cerealicolo La funzione dei piccoli commercianti di biade (granaiolibull biadaiolifarinaioli balshy
zarotti cavallanti vatlcali ecc) era infatti ancillare alla capacitagrave di affacciarsi sul nercato della fascia marginale deipossidenti con eccedenze Solo che nelle annate di abbondanza si venficavano ingorghi nell offerta di grano che deprimevano i prezzi e incentivavano i piccoli produttori a smerciare direttamente le eccedenze allindomani del raccolto nellarea urbana anche al di fuori dei luoghi deputati (MATI02ZI 1983 278281-2 300n PULr QUAGLIA 1984 86) Mentre nelle annate di penuria si contraeshyva drasticamente proprio questo segmento dellofferta (ABa [1966Jmiddot 22-4 KULA [1962J 73-4 CATrINI1984 111-23 PuIr QUAGUA 1984 88) scatenando nelle campashygne una caccia al grano-merce la cui quota piugrave consistente era detenuta dai grandi proprietari dai maggiori affittuari dai percettori di canoni diritti o rendite in grano e la cui quota residua era piugrave facilmente preda di chi occupava posizioni chiave nellasshysetto terriero nella catena dei diritti nel credito alla produzione e al consumo
Tanto la distribuZione era frammentata nelle annate di abbondanza tanto in epoc~ di penuria il commercio del grano diventava un affare di pochi In questo caso lazioshyne dei mercanti diVentava dimpiccio sul mercato interno dove la coperta si restringeshyva per i proprietari e gli imprenditori agricoli (KULA [1962] 56-61 CATl1NI 1984 114-8) - dove la necessitagrave di ricorrere al credito da parte dei piccoli possessori poneva questi nelle mani degli agenti dei proprietari dei percettoridi canoni diritti o rendite - dove i piccoli proprietari vedevano minacciata la loro stessa condizione da parte di chi controllava localInente in maniera capillare e decentrata il mercato del denaro e dei beni necessari alla riproduzione (sementi strumenti cibo) La soluzione era quelshyla di precludere amministrativamente ai sensali e ai commercianti di grani i mercati locali su istigazione dei medi possessori le cui occasioni di normale profitto agrario soffrivano un ridimensionamento e che si vedevano costretti a impegnarsi ccedilon tutte le loro forze per integrare le proprie entrate accaparrandosi le magre eccedeiiZe disponishybili nelle campagne e nei borghi rurali (PuLT QUAGLIA 1984 84-8 PULT QUAGLIA 1990 lO7-14)
TI destino dei piccoli commercianti in grano era quindi quello di occupare una posishyzione margilJale nel mercato del grano (MBlNrurr 1977 30 PINTO 1978 13 MAITOZZl 1983 277) e di operare - non solo a causa degli ordinamenti annonari - secondo una logica di corto respiro in cui non era contemplata neacute la conservazione di grani a lungo termine neacute lutilizzo di depositi piugrave che provvisori Come per i piccoli possidenti non si puograve parlare ne1loro caso della formazione e del mantenimento di scorte consistenti (MBlNREr 1988 156~7) Non tali comunque da sostenere il reddito contadino nelle stagioni ordinarie e da esercitare sul versante cittadino unefficace azione anticonshygiunturale in caso di carestia
Peraltro in cittagrave la struttura dellofferta era anche piugrave sperequata di quella che si rishyscontra nel contado Che si tratti di Prato nel 1339 (PINTO 1978 129 PINTO 1982 160n e 17In) Pavia negli anni 1539 1555 1513 1602 1603 (ZANEm 1963) o Mantova nellultima parte del secolo XVI (CORRITORE 2000 81-9) la distribuzione delle scorte fra i privati era singolarmente ineguale Lo attesta la rilevanza nellarea urbana della povertagrave cioegrave secondo una definizione coeva di coloro che non vivono di entrate ma sono necessitati ricorrere mattina e sera alle pistorie a comprare il pane per iI vitto loro e delle sue famiglie col denaro che di giomo in giomo si vanno guadagnando (MATshyTOZZI 1983 281) PUOgrave essere utile richiamare la situazione delle cittagrave tedesche nel basso Medioevo in una fase che egrave stata definita da Wilhelm Abellepoca doro degli artigiani e del lavoro salariato si puograve stimare che almeno la metagrave degli iscritti ai
lA costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli statibull middot497
te con il principio della piazza TI mercato pubblico periodico disciplinatola spiagshygiala piazza la loggia o iI recinto riservato alle contrattazioni - coesis~va confabshybriche magazzini e botteghe La stessa piazza per funzionare al meglio secondo il principio dello scambio diretto necessitava di magaZzini di supporto bull
4 LE SCORTE DEI FORNAI CITTADINI
Nellarea urbanagrave e nelle relazioni tra cittagrave e campagna operavano perograve temibili conshycorrenti dei privati possessori I fornai cittadini possedevano le competenze le strutshyture tecniche le relazioni sociali e il credito per incettagravere il prodotto per essere inforshymati tempestivamentesul mercato del grano e potenzialmente per dispensarlo con profitto in qualunque momento Il fatto che il loro operato fosse imprigionato in unarshycaica impalcatura di norme divieti obblighi che risalivano alletagrave romana che ne fashycevano in modo quasi istituzionalizzato il capro espiatorio delle tensioni fra produtshytori di grano povertagrave e autotitagrave non impedisce di affermare che tali vessatorie disposiziograveD1 trovassero la loro principale ragione dessere nella parte che essi giocashyvano di interlocutorilantagonisti dei proprietari terrieri nelladeterminazione del prezshyzo del grano sul mercato locale e nella realizzazione della rendita terriera (GUENZI 19824
35 GUENZI 1982 297) Neacutel caso di Mantova terra comucopia a partire dal 1492 si consend a zentilhomini
cittadini et qualuncho altro di comprare biade nel Dominio per approvvigionare la cittagrave di fatto si sand un diritto allincetta che mise fuori gioco i fornai a cui venne imposto di rifornirsi nei solarimiddotdei cittadini senza avere piugrave la possibilitagrave di effettuare acquisti nel contado e di ritenere a casa scorte superiori amiddotl 00 staia di frumento Lintento della disposhysizione egrave chiarissimo espresso senza reticenze dai Maestri delle Entrate che riportarono al marchese la soddisfazione dei possidenti mantovani per la riforma statutaria
tutta la Terra [cioegrave il Mantovano] ne [egravel rimasta satisfactissirna pensando che Vostra Excellenilii pretenda ali comodi et utilitagrave universagrave1e senza dampno et preuiditio suo Vero egraveche li fumari non si contentano parendoli comegrave il vero che non si poteranno ingrassar a suo modo come haqno factO per il passato et poteria achader [bulll Che venetanno adolershyse et supplicar aVosUa Signoria Perograve me egrave parso d~ene aviso per ques~ nostra et farli inteni1er Che questaterril ha solii due membri de li quali li cittadini soi se ne possono aiutashyre e valersene uno egrave il grano laltro egrave larte de la lana et quando se concedesse che li furshynari potessero comprare come hapno facto li tempi passati sana un fare benefitio acinquanshytaocto dessi et dampnificharelreslO de la republicasua quale de questo bon ordine ne receve emolumento grandissimo et se gaude in la Citagrave [percheacute] li fumari portano fuora el denaro et pretendono solo a suo benefitio (AG b 2441 lettera del 13 luglio 1492)
Egrave indubbio che il plauso della Terra fosse da attribuire piugrave alla possibilitagrave per i proshyprietari di accrescere le proprie entrate che a quella dei consumagravetori cittadini e dell arte della lana di trarre beneficio daJla disposizione Egrave significativo che la motivazione pro civitate nori accenni allesistenza di monopoli da parte dei fornai o di artificiose lievitashyzioni dei prezzi per causa lOro nloro attivismograve non egraveonfliggeva per quanto riguarda i prezzi finali della sussistenza con linteresse dei produttori cittadini E daltra parte largomentodello stomo dal metFato cittadino dei profitti incamerati dai fornai -laccushysa consueta a proposito deipistores egrave che fossero in gran parte stranieri (GUBNZl 19824
22) -- era unagiustificazione debole che appassionava piugrave chi concorreva direttamente
491 498 Renzo P Comtore
alla spartizione dei proventi derivanti dalla vendita e dal commercio del grano shylemolumento grandissimo - di chi doveva poi fruire della redistribnzione di tale ricchezza Tale norma avvantaggiava i possidenti cittadini e i gentiluomini ptivilegiashyti in grado di ottenere le tratte di esportazione Sul piano dellappropriazione essi erano in condizione di mettere fuori gioco gli altri possessori che producev~o eccedenze nel Dominio poicheacute si accresceva Igravea loro forza contrattuale e la loro capacitagrave di occUpare i canall commerciali piugrave redditizi Sul piano della commercialiZzazione gli stessi fruivashyno dello smantellamento della rete dintennediazione rappresentata dai fornai Per i rushystici significava perdere un collegamento essenZiale con la cittagrave ed essere emarginati dal mercato urbano nelle campagne o sul broletto di Mantova essi non trovarono piugrave i trashydizionali interlocutori (CORBlJ9RE 2000 228 231-2)
Nel caso di Bologna terra strutturalmente deficitaria e cittagrave dalla vocaiione manishyfatturie~ si costringeva i fornai ad acquistare formenti terrieri presso i solari privati in cittagrave proibendogligrave lincetta nel contado autorizzandoli ad acquistareformentiforeshystieri al di fuori delle mura cittadine presso i sensati da grqno solo a patto che fosseshyro stati smaltiti i grani cittadini a un prezzo talora superiore a quello dei grani dimshyportazione (GUlNZI1982A35 52-3)
Nella Toscana dei Medici il diritto allincetta nel contado venne concesso ai fornai in periodo di bassa congiuntura (in particolare dagli anni Trenta del Seicegravento)Per sostenere i prezzi interni in tal caso essi restavano gli interlocutori principali dei granshydi proprietari semplicemente spostando la loro principale fonte di approvvigionashymento dai solari dei particolari in cittagrave ai granai decentrati delle grandi aziende agrishycole oppure ai mercati rurali su cui affluiva la produzione cerealicola delle grandi fattorie (PuLT QUAOUA 1984 86-9 PuLTQUAOUA 1990 100 106-7)
Laddove non vi egrave come invece succede a Genova una diretta ingerenza del potere pubblico nella vita della corporazione (MAsSA 1999) i fumai di cittagrave - nonostante i lacci e lacciuoli normativi e il lavoro prevalentePlente manuale svolto neiloro laboshyratori - erano dei veri imprenditori dipendenti per il loro profitto - noininalmente stabilito per legge - dalla produttivitagrave del lavoro e dalla dotazione tecnica e finanziaria delle imprese Di ciograve fa fede la grande sperequazione esistente fra le aziende speciashylizzate nena fabbricazione del pane venale in cittagrave (AYMARD 1966 75 VECCHltltJQ 1979 82-3 GUlNZI1982 77 segg PuLT QUAOUA 1984 100 102-3) NellItalia delshyletagrave moderna questi artigiani-imprenditori della filiera del grano trattavano insieme
afarinaifarinaiolifarinottifondachierifontechierifidelariformentinari lasagneshyri maccaronari torallari vermicellari ecc fra il 40 e il 70 per cento del frumento consumato in Cittagrave nelle annate normali (CoRRJTORE 2000 126 segg) e ~ino al 100 per cento nelle annate di carestia (Puu QUAOUA 1984 98-9)
In una ricognizione delle asimmetrie informative del mercato non cegrave gruppo quale i fornai che possa integraverpretare la parte dell agente economico onnisciente Se dunque i regolamenti annonari tendevano a regolare minuziogravesamente la collocazione il volushyme e la durata delle loro scorte cosi come disponevano per gli altri artigiani della fishyliera era per neutralizzare il carattere potenzialmente eversivo di tale accantonamenshyto per i proprietari-venditori Prima ancora che per i consumatori-acquirenti n livello delle scorte rinforzava o attenuava il rischio di monopsonio da parte dei pistores piugrave potenti e facoltosi cosigrave come eventuali tentazioni da parte della categoria di esercitare un dominio egoistico sul mercato del pane (MAITOZZl1983 298)
Sarebbe quindi un errore concepire le scorte dei fornai come entropica allocazione di capitale che sconta lincertezza futura esse venivano gestite secondo criteri di rashyzionalitagrave economica e secondo la migliore efficienza tecnica nonostante i vincoli imposti alla lievitazione degli stock dalle disposizioni annonarie
lA costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
vimini paglia o canne intrecciate (come ceste stuoiecannizzi) in terracotta (addirittura anfore) piuttosto che di tessuto (i sacchi costavano troppo) (PICCINNl1976 397 MAzzA RAvEGol 1983 174-5 Zoo Toce 1990 893-4 COIiITONES11991 35n-36n)
Nella casa del piccolo produttore o del titolare di un piccolo possesso il penw (la scorta domestica) difficilmente eccedeva il consumo famigliare chi fortunato raccoshyglieva piugrave dell annona famigliare e di quanto gli serviva per il campo era spinto a venderselo nei mesi immediatamente successivi alla mietitura e alla trebbiatura per necessitagrave di denaro ma anche per la difficoltagrave di stoccare e conservare il prodotto in condizioni ottimali (MEuvRET 1988 17-9 PuLT QUAOUA 1984 88) e figravenanco per ridurre il rischio di vederselo soffiare da vagabondi e malintenzionati In questo caso in presenshyza di eccedenze (ma probabilmente anche in assenza) il bisogno di liquiditagrave e lalea cospiravano nel ridl1ITe ai minimi termini le scorte giagrave allindomani del raccolto In caso alternativo il contadino che non egrave - ripete Jean Meuvret - un homme daffaires quanshyto un homme de peur concepiva la sua riserva come un fondo di previdenza sul racshycolto futuro da non immettere sul mercato se non nel caso dellapprossimarsi di una messe sicura secondo una logica economica a contrario (MEUVRET 1988 19 e 147)
Era Jl~tente la disparitagrave fra i produttori non solo fra chi era in possesso di eccedenshyze e chi non lo era ma piugrave anqgtra fra chi poteva scegliere in virtugrave di una maggiore capienza economica e unadeguata dotazione tecnica - il mercato piugrave favorevole per i propri grani (il periodo di saldatura dei raccolti) e chi invece li cedeva troppo presto o in controtempo a livelli non ottimali
Nella gerarchia delle abitazioni rurali -- in quel vero e proprio saggio di sociologia che egrave il sesto libro del DeArchitectura di Sebastiano Serlio (scritto fra il 1537 eil 1555 inedito per tutto levo moderno) -- per trovare case attrezzate di granaio occorshyreva ascendere sino alla magione del basso mercante o cittadino fuori della cittagrave (SERLlO 1994 43 segg anche per le successive informazioni) Condizione di cui non potevano fregiarsi invece i ricchi contadini in ~essuno dei tre gradi possibili di ricshychezza al massimo la loro casa poteva essere attrezzata di portici per ricoverare le biade e di unaia per batterle segni di distinzione giagrave fra i mediocri contadini Fra questi perograve avrebbero potuto avvalersene soltanto i fortUIgravelati et di beni et di famishyglia (3deg grado di mediocritagrave) nforno per cuocere il pane e una cantina per conservashyre il vino invece li si sarebbe trovati a partire dai piugrave accomodati fra i poveri contashydini cioegrave al 4deg gradino della scala sociale alla cui base erano da collocare i poveri mendichi con vii capanna (10 grado di povertagrave) i salariati che vivevano delle [loro] fatiche avendo un puoco di terreno (2deg grado di povertagrave) i poveri con qualche beshystiuola et massimamente de buOvi possessori di una stalletta congiunta con la casa 0deg grado di povertagrave)
In sintesi nelle campagne delletagrave pre-industriale pochi avevano scorte pochissimi erano in grado di ricoverarle in un solaro privilegiatissimo chi le incanevava per speculare Dunquefra i conta4ini se si esclude quanto celato nella madia o nella dishyspensa le scorte erano un pri~ilegio di pochi nSerlio nato intorno al 1475 insiste sullimpoverimento delle class~ rurali intervenuto fra gli anni della sua giovinezza e quelli della vecchiezza in cui scrive Sotto il titolo Dellabitazione del ricco contadishyno per tre gradi di ricchezza si preoccupa di puntualizzare
bencheacute al di dogi non se n~ truovi piugrave de tali merceacute delle discordie et di gli animi fieri et ostinati alla vendetta onde per tal cagioni et per le continue guerre et anche pei citadini divoratori de gli altrui beni che con le usure con glinganni con le rapine gli bano impoveriti (SERUO 1994 ~8)
490 RellOP CorrilOle
colto (agosto-settembre-ottobre) e invia di esaurimento almomento della saldatura dei raccolti (aprile-maggio-giugno )1A questo proposito nota Franccedilois Sigaut
Le stockage agrave court terme (moins dune campagne) reacutepond agrave la neacuteCessiteacute cIeacute concilier une offre variable et une demande constante mais toutes deux reacutegulieacuteres et preacutevisibles dans la
pratique il est consideacutereacute comme tiiisant pame du processus ordinaire de la production et ne pose agrave ce titre que desproblegravernes doptimisation assez simples (SlOAUI 1985 602)
La discussione generale sulla razionalitagrave economica delle scorte alimentari in etagrave pre-industriale puograve allora essere ridotta alla fonnulaiione e allo scioglimento di due
semplici quesiti 1 Accertato che laccantonamento digram per la periodicitagrave annuale del ciclo agricoshy
lo epet i vincoli tecnici di un rifomimento spazialmente allargato egrave inevitabile chi egrave conveniente che conservi le scorte chi produce o chi commercia il contadino o il mercante lapossidenzagrave o il popolo i particolari o il pubblico E qual egrave la realtagrave effettiva
2 Se le forme di distribUzione economicamente razionale sono plurali in quale conshytesto e in omaggio a quali interessi piugrave utile il sistema della canova rispetto al sistema delll piazza del mercato e dei solari privati
3 SULLADISTRIBUZIONE DEL GRANO NELUETAgrave PRE-INDUSTRIALE E LA STRUTTURA DELLE SCORTE NEI TERRITORI ITALIANI
Raramente le case contadine erano dotate di attrezzature per la conservazione dei cereali piugrave che elementari Nelle campagne toscane del Quattrocento dunquein unetagrave favorevole al reddito contadino in una regione fra le piugrave ricche dellEuropa pre-indushystriale
pochissime case contadine disponevano del granaio vero e proprio alcune avevano una cella che poteva servire allo stesso scopo ma la maggior parte di quelle abitazioni era priva di spazi destinabili esclugravesivamente alla conservazione dei cereali Perciograve i contenitori dei grani arche casse sacchi bugnole - dovevano trovare posto nelle cucine o nelle camere CMA= RAVEGGI 1983 174)
Le ridotte capacitagrave patrimoniali e reddituali della grande maggioranza dei produttori facevano sIgrave che fosse ampiamente invalso nella conservazione domestica dei grani limshypiego di contenitori in legno (come arche casse botti bugnole tini tinelle corbelli)in
Riguardo ai passi evidenziati di Zanetti e Cipolla egrave neCessario osservare che la principale atteshystazione sullesistenza di stock detenuti da privati che esorbitassero ilfabbisognostagionale tali da essere classificati come immobili=zione di ricchezza (Zanetti) o come beni capitale (Cipolla) a unanalisi piugrave fine si rivela fallace o non direttamente utilizzabile La propalazione dei grani effetshytuata a Pavia fra ilimiddot e il5 maggio 1555 che egrave il fondamento di entrambi i giudizinon mostra una somma di derrate realmente eccedente il fabbisogno delle famiglie per il periodo che manca allarri_ vo dei grani novelli sulla piazza pavese Daltra parte lastessa natura dellistituto della propalazioshyne dei grani cioegrave della denljncia obbligatoria delle scorte da parte dei particolari una misura demergenza decisa in momenti critici dellapprovvigionamento cittadino affiancata quellanno dalshylispezione diretta presso le case dei privati da parte di deputati straordinari avrebbe dovuto consishygliare una maggiore cautela nella sua utilizzazione per individuare regolaritagrave di carattere generale delleconomia pre-industriale
499 La costituzione di scorte granarie pubbliche e la ptlitica ecoMmica degli stati
FONTI
ABEL [1966) W ABEL Agrarkrisen undAgra~kJJnjunktur Eine Geschichte der londshy und Erniihrungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter Hamburg
und Berlin Paul Parey 19662 (la ed -1935 trad it Congiuntura agraria e crisi agrarie Storia dellagricoltura e della produzione alimentare nellEuropa centrashyle dal XIII secolo alletagrave industriale Torino Einaudi 1976 da cui si cita)
AG ARCHIVIO GoNZAGA presso lArchivio di Stato di Mantova AuFANO 1996 E AuFANO Il grano il pane e la politica annonaria a Napoli nel Setshy
tecento Napoli ESI 1996bull AYMARO 1966 M A YMARO Wmise Raguse et le commerce du bMpendant la seconde
moitieacute du XVI siegravecle Pans SEVPEN 1966 CATIINI 1984 M CATl1NI I contadini di San Felice Metamorfosi di un mondo rurale
nellEmilia delletagrave modernIgravel Torino Einaudi 1984 CESTARl 1794 p CESTARI Saggio storico dei Fondachi delle farine di Chioggia e
Pellestrina Venezia A Zatta 1794 CIPOllAJ1965] C M CIPOllA La politica economica dei governi V La penisola
italigraveana e la penisola iberica in Storia economica Cambridge m La cittagrave e la politica economica nel Medioevo Torino Einaudi 1977 (Cambridge 1965) pp 462-496
CIPollA 1974 C M CIPollA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna nMulino 1974
CIpollA 1997 C M CIPOllA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna nMUlino 1997 (6 ed riveduta)
CORRITORE 2000 R P CoRRITORE La naturale abbondanza del Montovano Produshyzione mercato e c01isumi granari a Mantova in etagrave moderna Pavia Universitagrave di Pavia 2000
CORIONBSI 1991 A CORIONBSI Sulla conservazione dei cereali nellItagravelia medioevale Lavoro e tecniche nelle tesnmonlanze laziali (secc XIII-XV) in Rivista di storia dellagricoltura XXXI 1991 l pp 33-49
DELLA VALENTINA 1992 M DELLA VALENTINA I mestieri del pane a ~nezia tra 600 e 700 in Atti dellIstituto [Veneto di Scienze Lettere ed Arti Classe di scienze morali lettere ed arti CL 1991-92 pp 113-217
DIRLMEIER 1984 U DIRLMEIER le condizioni materiali dellesistenza nelle cittagrave tedeshy sche del Basso Medioevo ~iente esterno reddito consumi in Aristocrazia citshy
tadina e ceti popolari nel tprdo Medioevo in Italia e in Germania (a cura di Reinhard Elze e Gina Fasoli) Bologna Societagrave editrice il Mulino 1984 pp 79shy122
FORNASIN 1999 A FORNASIN Il pzercatodei grani di Udine Indagine per una storia dei prew in Friuli (secoli XfI-XVIII) Nota di ricerca del Dipartimento di Scienshyze Statistiche dellUniversit4 degli Studi di Udine 4 1999 pp 1-24 ora in lo La Patria del Friuli in etagrave 1fIOderna Saggi di storia economica Udine Forum 2000 pp 33-60
GRENDI 1986 E GRENOI Lapprccedilwigionamento dei grani nella Liguria del Seicento libera pratica e annone in iMiscellanea storica ligure Studi in onore di Luigi Bulferetti XVIII 1986 2Jp 1021-1047
GUENZI 1981 A GUENZI Ilfrurnfnto e la cittagrave il caso di Bologna nelletagrave moderna in Quaderni storici XVI ~981 46 pp 153-167
GUENZI 1982 A GUENZI Pane ~fornai a Bologna in etagrave moderna Venezia Marsilio 1982
I
489 500 Renzo P CornIOle
GUBNZI1982 A GUEml Sistema annonario e egraveontrollo sociale a Bologna nei seccediloli XVII e XVIII in E SORI (a cura di) Cittagrave e controllo sociale in Italia fra XVIII e XIX secolo Milano F Angeli 1982 pp 293-306
HICKS [1989] 1 R HIClCS A narlcet theory of money Oxford Oxford Universigravety Press 1989 (trad it Una teoria di mercato della monefa Bologna li Mulino 1992 da cui sigrave cita)
JACOPBITI 1965 N L JACOPBITI Monete e prezzi a Cremona dal XVI al XVlIi secolo Cremona Athenaeum CregravemoneJlSe 1965
KAPLAN 1984S L KAPLAN Provisioning Paris Merchants and Millers in the Grain and Flour Trade during the Eighteenth Century Ithaca-London Cornell Univershysity Press 1984~middot
KULA [1962] W KULA Teoria ekonomiczna ustrojufeudalnego Proba modelu Warshyszawa-Panstwowe WydawnictwoNaukowe 1962 (trad it Teoriagrave economica del sistema feudale Proposta di un modello Tormo EinaUdi 1972 ccedilla cui si cita)
WROUSSE [1933] C-E LABRoussE Esquisse du mouvement des prix et des reverws en France au XVIII siegravecle Paris Eacuteditions des Archives Contemporaines 19842 volI (l ed Paris Librairie Dalloz 1933)
MALANtMA 1976 P MALANiMA Aspetti di mercato e prezzi del grano e della segalea Pisa dal 1548 al 1818 in Ricerche di storia moderna vaL I Pisa Pacini 1976 pp ~n
MANToVA 1430 MwroVA 1430 Pareri a Gian Francesco Gonaga per il governo (a cura di M AQrignaniA M Lorenzoni A Mortari C Mozzarelli) MUltova G~ Arcari 1990
MASSA 1999 PMAssA Annona e corporazioni del settore alimentare ~ Genova orshyganizzazione e conflittualitagrave (XVI-XVIII secolo) in A GUENZI PMAssA A MOIOshyu (a cura di) Corporazioni e gruppi professionali nellItalia moderna MilIllO F Angeli 1999 pp 390-403
MATIoZ7J 1983 1 MiJroZ7J F BOLELLI C CmAsBRA D SABBIONI Il politico e il pane a Venezia (157Q-1650) calmieri e governo della sussistenza in Societagrave e storia VI 198320 pp 271-303
MAzzI RAVEOOI 1983 M T MAzzI S RAVEOGI Gli uogravemini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento Firenze Olscbki 1983
MERONI 1957 U MERONI Cremona fedelissima Ciemona Athenaeum Cremonenshy~~~ _
MBUVRBl 1977 J MEuVRsT Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque LouisXIvI La productiograven des ceacutereacuteales dans la France du XVII et du XVIII siegravecle Paris Mouton -EacuteEHSS19772voll
MBUVRET 1988 J MBtJVRf Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque Louis XIv III Le commerce des gralns et la conjoncture Paris EacuteEHss 1988 2 volI
PtCClNNI 1976 G PtCClNNl Wta contagravedina in una capanna dei dintorni di Siena (1250) in ~Archeologia medievale m 1976 pp 395-399
PlNIO 1978 G PINTOII Libro del BiaPaiolo Carestie e annona a Firenze dalla metagrave del 200 al 1348 Fire~ Olscbki 1978
PiNTO 1982 G PtNro La Toscana nel tardo Medioevo Ambiente economia rurale societagrave Fllenze Sansoni 1982
PtRENNE [1933J H PIRENNB La civilisation occidentale au Moyen Age du XIe au mishylieu du XVe siegravecle Paris PUF 1933 (trad it Storia economica e sociale del Meshydioevo Milano Garzanti 1967 da cui si cita)
Lacostituticne di scorte granarie pubbliche e la politica economiegravea degli stati
redigravestribuzione sostenibile dei beni di sussistenza egrave ricercata in questo cielo da quegli stessi particolari che ~amaldeggiano nella produzione negli scambi nei consumi e che costituiscono il nerbo della classe di governo Le scorte pubbliche rappresenteshyrebbero in questa prospettiva un presidio civico e un risltCimento politico e morale ai cOl1ponenti della comunitagrave spossessati delbene supremo dellautarchia alimentare
Resta infine latente unidea del magazzmo pubblico come quasi-mercato cioegrave come luogo volto (1) a risolvere i fa1limentiinfo~vi della piazza del mercato (in meacuterito alle disponi~ilitagrave alle caratteristiche del prodotto alle condizioni di vendita della merce) (2) a ridimensionare lalea per agricoltori consumatori poveri artigiani del comparto alimentare (3) a sostenere i consumi e i profitti privati m funzione anticicli ca in una prospettiva Ilpn meram~nte congiunturale Si tratta in questo caso di un orshyganizzaZionepienattiCnte razio~e Che non opera in maniera saltuaria e riflessa ma in modo continuativo secondo obifttili prefissati di allocazione dei beni primari li funshyzionamento dellacanovagrave (il magazzino pubblico) si porrebbe come strumento inteshygrativo ma no~~igraventeramente so~titutivo delloperare della piazza Si tratterebbe di unaforma di mercato distinta dalla p~ del mercato considerata in seacute e per seacute cosigrave come dallegraveOOmpravendite effetttlate nei solari privati o dalla mera centrallzzazione e redistribuzione di derrate con fi~alitagrave umanitarie La canova rappresenterebbe in tal modo uno dei possibili meccaoi~ di governo delle trllls3ZIgrave~ni locali per risolvere i problemi deUapprovvigionameIto senza intaccare certi interessi di classe (dei proshyprietari ma anche del popolo grasso) S da essere prescelta da autoritagrave e gruppi domishynanti come struttura complementare della piazza del mercato incerti contestiprodutshytivi ed economici La suasacrilizzazione perciograve non esclude la possibilitagrave di un ritorno alle sole compravendite qella piazza e dei solari privati - una volta invertishytosi il trend o spirate le condizioqi economiche della sua istituzionalizzazione
La problematizzazione esorc~ una liquidazione semplicistica del problema delle scorte gran8rle in etagrave pre-industriUgravee nel nome di una loro presunta irrazionalitagrave eco- nomica per il compito di assi~ la sussistenza della popolazione
Le pagine che segUono sono rintroduzione a un lavoro in corso volto a offrire un interpretazione generale di tal~ capitolo fondamentale della politica economica dei governi
in
etagrave pre-industriale
2 SE UN MONDO SENZA SCORTE Egrave INCONGRUO cm Egrave OPPORTUNO CHE LEgrave DETENGA
Nei fatti nel settore granarlo CQni vincoli dell etagrave pre-industriale in tema diprodutshytivitagrave energia trasporti non ha s~nso ipotizzare un mondo senza scorte Se il mercato del grano egrave - come nellEuropa medievale e moderna - un sjstema tendenzialmente chiuso
ad ogni raccolto nuove offe~ aniv(erannol sul mercato mentre la domanda si mant[erragrave] relativamente costantt nel corso dellanno Qualcuno dunque [dovragrave] ~ere delle scorte che saranno elevate ~ubito dopo il raccolto e poi via via minori fino aragshygiungere un livello minimo in prpssimitagrave del successivo raccolto (HICICS [19891 31)
Nella loro forma piugrave sempliceI tali scorte saranno legate allora alla periodi~itagrave anshynuale del ciclo agricolo (che a1iplenta il movimento stagionale dei prezzi ccedilfr LAshyBROlJSSE [1933] 157-66) il loro livello saragrave elevato allindomani del principiLle racshy
501 488 Renzo P Corritore
povero ammassograve nella propria dimora scorte di grano carne ~alata sale candele ecc e la medesima cosa fece lo Stato Nel periodo feudale non venne mai meno nel castello del signore labitudine di tenere da parte grosse scorte per i periodi di emergenza Sucshycessivamente le autoritagrave comunali predisposero il magazzinaggio di grosse derrate specie di grano da rivendere a basso prezzo in periodi di emergenza e nello stesso tempo si preoccuparono di prevenire un indebito accumulo di scorte da parte di specushylatori privati Nelle economie medievali gli stock di derrate di prima necessitagrave rappreshysentarono pertanto una delle piugrave importanti forme di investimento pubblico e privato (CIPOLLA (1965] 468)
Nella prima versione del manualeacute invece fino allinserimento nel 1997 del nuovo capitolo dedicato alla politica economica nell etagrave pre-mdustriale il punto di vista preshyvalente era quello microeconomico entro il perimetro stretto dellindividualismo meshytodologico
Le scorte costano e costano doppiamente Esse implicano il costo diretto che egrave rapshypresentato dal costo del magazzinaggio edal deterioramento eventuale del pr04otto o di parte di esso Se luomo daffari finanzia la costituzione delle scorte con danaro preso a prestito il costo diretto include anche il tasso di interesse pagato Se luomo daffari finanzia con capitale proprio la costituzione delle scorte il costo delle scorte deve inshycludere un costo-opportunitagrave e cioegrave il mancato rendimento (tIllU1cato tasso dinteresse attivo) del capitale finanziario impiegato (CIPOLLA 1974 154)
Le ragioni della costituzione e del mantenimento di scorte alimentari da parte delshylautoritagrave pubblica diventavano unicamente ragioni morali (umanitarie e di buona amministrazione) o di opportunitagrave politica (la fame era la piugrave frequente ligraveausa di sommosse e furori popolari) (CIPOLLA 1974 74)
Nel 1997 si riammetteva dunque linterpretazione originaria della costituzione di scorte pubbliche come strumento di riequilibrio del mercato senza peraltro rinnegare le considerazioni sulla valenza statica di tale forma di investimento per gli agenti economici privati
In merito allutilitagrave economica e al significato delle scorte in etagrave pre-industriale Cishypolla non espresse perciograve sempre lo stesso punto di vista La rassegna delle posizioni da lui assunte anzi permette di individuare tre approcci e tre giudizi costitutivamente diversi sulla funzione delle scorte granarie nellepoca pre-industriale
In prima approssimazione laccumulazione di scorte alimentari mostra il carattere fondamentalmente difensivo delle scelte degli agenti economici pubblici e privati in etagrave pre-industriale La paura la tradizione la superstizione li induce a tabuizzare il rischio la speculazione linvestimento nella produzione e nella distribuzione dei beni essenziali alla vita e ad aderire intimamente a un ideale di economia e societagrave stazionarie aggravando con la norma sociale le istituzioni il comportamento indivishyduale e collettivo leffetto dei condizionamenti materiali delleconomia pre-industriashyle (bassa produttivitagrave agricola alti costi di v~sporto modesta efficienza energetica) esponendo ancor di piugrave la comunitagrave umana ai degravemoni della natura
La seconda interpretazione rigetta luniversale imperio dellhomo oeconomicus rishyscoprendo leteronomia dei fini dellagire economico degli uomini nelletagrave pre-inshydustriale Ia politica economica dello Stato o-delle autoritagrave non persegue puri scopi economici lintegritagrave del corpo sociale fin nelle sue cellule elementari (persone e famiglie) deve essere assicurata secondo i principi e la prassi di uneconomia morale che SOVJa5ta leconomia regolata dal mercato spersonalizzata e antipopolare Una
La costituzione di scorte grantlTie pubbliche e la poligravetigraveca economica degli stati
PuLT QUAGUA 1984 A M PULT QUAGUA Mercato dei prodotti agricoli e magistratushyre annonarie a Pisa nelletagrave moderna in Ricerche di storia moderna a cura di M Mirri voI III Pisa Pacini 1984 pp 57-141
PULT QUAGLIA 1990 A M PULT QUAGLIA Per provvedere ai popoli Il sistema anshynonario nella Toscana dei Medici Firenze Olschki 1990
SERUO 1994 S SERLIO Architettura civile Libri sesto settimo e ottavo nei manoscritshyti di Monaco e Vienna (a cura di F P Fiore) Milano TI Polifi10 1994
SIGAlIT 1985 F SIGAlIT Questions deacuteconomie agrave propos des politiques ceacutereacutealiegraveres et de stockage in Les techniques de conservation des grains agrave long terme leur rale dans la dynamique des systegravemes de cultures et des socieacuteteacutes (sous la direction de M Gast F Sigaut et C Beutler avec la collaboratlon de O Bllchsenschutz) voI III 2 Paris Eacuteditionsdu CNRS 1985 pp 597-606
SMITH [1776 A SMITH An inquiry into the nature and causes ojthe wealth ojnations London W Strahanand T Cadell 17762 volI (trad it Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni Milano A Mondadori 1977 2 volI da cui
si cita) STATlITlBoNACOLSIANI [1313] STATUTI BONACOLSlANl (a cura di E Dezza A M Lorenshy
zoni M Vaini) Mantova GArcari 2002 STATUTI GONZAGHESCHI [1404] STATUTI GONZAGHESCHI presso la Biblioteca comunale di
Mantova ms FV 11 [775]VECCHIATO 1979 F VOCCHIATO Pane e politica annonaria in Terrajerma veneta tra
secolo XV e secolo XVIII (Il caso di Verona) Verona Stamperia Zendrini 1979 ZANETTI 1963 D ZANETTl Contribution agrave leacutetude des structures eacuteconomiques lapshy
provisiQnnement de Pavie au XVI siegravecle in Annales ESC XVIII 1963 1 pp 44-62 ora in lo Fra le antiche torri Scritti di storia pavese Pavia Universitagrave di Pavia 2000 pp 165-182
ZANETTl 1964 D ZANEITI Problemi alimentari di una economia preindustriale Ceshyreali a Pavia dal 1398 al 1700 Torino P Borlnghieri 1964
ZUG TUCCI 1990 H ZUG TuCCI Le derrate agricole problemi materiali e concezioni mentali della conservazione in Lambiente vegetale nellalto Medioevo XXXVII Settimana di studio del Centro italiano di studi sullalto Medioevo (30 marzo-5 aprile 1989) Spoleto Centro italiano di studi sullalto Medioevo 1990 voI n pp 865-902
RENZO p CORRITORE
LA COSTITUZIONE DI SCORTE GRANARIE t
PUBBLICHE E LA PqLITICAEccedilO~OMIqA
DEGLI STATI IN ETA PRE-INDUSTRIAL~ (LA DIgraveSTRIBUZIONE DEL GRANO E LA STRUTIURA
DEUE SCORTE NEI TERRITORI ITAUANL Ii FONTICO DEL MERCATO)
1 ILTEMAELASUAPROBLEMATIZZiZIONE
Investimento della paUra cosi Carlo M Cipolla definiva nel suo piugrave noto ~uashyle la formazione e conservazione di scorte alimentari da parte di soggetti iprivati e pubblici nellEuropa pre-it)dustriale (CIPOlLA 1974 68) La propensione allaliantoshynamento di de11llte agricole 00 parte delle famiglie ~ delle autoritagrave nell etagrave ~~evale e moderna assumeva in tal modo una connotazione negativa le scorte erano reddito non consumatO cioegrave un risparmio incapace di tradursi in domanda di beni ccedilapitali dunque ~ sterilizzazione di ricchezza dal pilnlQ ~ vista della crescita ecoll9mica e dell evoluzione della produttivitagrave Con ciograve faceva proprio quanto aveva scritto uno storico pavese a lui vicino Dante Zanetti
La fonruttion et le maintien de stockIgravel Iln particulier de stocks alimeritairegraves ~sti- tuent une forme particuliegravere dinvestissement cest-i-dire daccumulalion de capitagraveJ li sagit dun invesnssement ayant un caractegravere pour ainsi dire statique et non eacutevplUshytif car il ne contribue pas i laccroissement du revenu pendant celte Iongue ~pde mais sert seulement agrave une meilleure distribution du ~venu dans le temps nfaut aj0luter que Ies stocks repreacutesentent limmobllisation dune partie consideacuterable de leacutepargneiprishy
veacutee qui dans une eacuteconomie de type preacute-industriel repreacutesente une part deacutejagravetrop ~te du revenu (ZANErn 1963 44)
Lo stesso CipoIIa tuttavia nellultima edizione del manuale (CIPolLA 1991 227) decideva di applicare anche allevo moderno quanto aveva scritto piugrave di trentanni prinia a proposito della politica economica dei governi nellepoca medievale cioegrave
che laccumulo di scorte frumentarie da parte deacuteUautoritagrave fosse uno strumento di politica economica per promuovere unecogravenomia piugrave equilibrata meno lttqmiigraveuita dallincertezza del ciclo dccedili racegraveolti Nel 1965 infattila preferenza era sta~ da lui accordata allanalisi delle politiche pubbliche in un cpntesto di mercato inigraveperfetshyto in un oriZzonte che deborda il ciclo annuale agricolo
Pii) imperfetto era il mercato piugrave urgente si faceva la necessitagrave dimantenere massicshyce riserve di prodotti Per tutto il corso del Medioevo ogni individuo che non fosse
501 488 Renzo P Corritore
povero ammassograve nella propria dimora scorte di grano carne salata sale candele ecc e la medesima cosa fece lo Stato Nel periodo feudale non venne mai meno nel castello del signore ]abitudine di tenere da parte grosse scorte per i periodi di emergenza Sucshycessivamente le autoritagrave comunali predisposeromiddot il magazzinaggio di grosse derrate
lt specie di grano da rivendere a basso prezzo in periodi di emergenza e nello stesso tempo si preoccuparono di prevenire un indebito accumulo di scorte da parte di specushylatori privati Nelle economie medievali gli stock di derrate di prima necessitagrave rappreshysentarono pertanto una delle piugrave importanti Jorme di investimento pubblico e privato (CipollA [1965] 468)
Nella prima versione delmanualeacute invece finograve allinserimento nel 1997 del nuovo capitolo dedicato alla politica economica neUetagrave preindusiriale il punto di vista preshyvalente era quello microeconomico entro il perimetro stregravetto dell individualismo meshytodologico
Le scorte costano e costano doppiamenie Esse implicano il costo diretto che egrave rapshypresentato dal costo del magazzinaggio e daI deterioramento-eventuale del prodotto O di parte di esso Se luomo daffari finanzia la costitiIZIgraveone delle scorte con danaro preso~a prestito il costo diretto include anche il tasso di interesse pagato Se luomo daffari finanzia con capitale proprio la costltuzione delle scorte il costo delle scorte deve inshycludere un costo-opportunitagrave e cioegrave il mancato rendimento (mancato tasso dinteresse attivo) del capitale finanziario impiegato (CIPOllA 1974 154)
Le ragioni della costituzione e del mantenimento di scorte alimentari da parte delshylautoritagrave pubblica diventavano unicamente ragioni morali (umanitarie e di buona amministrazione) o di opportunitagrave politica (la fame era la piugrave frequente ~ausa di sommosse e furori popolari) (CIPolLA 1974 74)
Nel 1997 si riammettegraveva dunque linterpretazione originaria della costituzione di scorte pubbliche come strumento di riequilibrio del mercato senza peraltro rinnegare le consideraZioni sulla valenza statica di tale forma di investimento per gli agenti economici privati
In merito allutilitagrave economica e al significato delle scorte in etagrave pre-industriale Cishypolla non espresse perciograve sempre lo stesso punto di vista La rassegna delle pogravesizioni da lui assunte anzi permette di individuare tre approcci e tre giudizi costitutivamente diversi sulla funzione delle scorte granarie nellepoca pre-indUstriale
In prima approssimazione laccumulazione di scorte alimentari mostra il carattere fondamentalmente difensivo delle scelte degli agenti economici pubblici e privati in etagrave pre-industriale La paura latradizione la superstizione li induce a tabuizzare il rischio la speculazione linvestimento nella produzione -e nella distribuzione dei beni essenziali alla vita e ad aderire intimamente a un ideale di economia e societagrave stazionarie aggravando con la nonna sociale le istituzioni il comportamento indivishyduale e collettivo leffetto dei condizionamenti materiali delleconomia pre-industriashyleacute (bassa produttivitagrave agricola alti costi di trasporto modesta efficienza energetica) esponendo ancor di piugrave la comunitagrave umana ai degravemoni della natura
La seconda interpretazione rigetta luniversale imperio dellhomo oeconomicus rishyscoprendo leteronomia dei fini dellagire economico degli uomini nelletagrave pre-inshydustriale La politica economica dello Stato o-delle autoritagrave non persegue puri scopi economici lintegritagrave del corpo sociale fin nelle sue cellule elementari (persone e famiglie) deve essere assicurata secondo i principi e la prassi di uneconomia morale che SOVlasta leconomia regolata dal mercato spersonalizzata e antipopolare Una
La costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli staIgravei
PuLT QUAGUA 1984A M PULT QUAGLiA Mercato dei prodotti agricoli e magistratushyre annonarie a Pisa nelletagrave moderna in Ricerche di storia moderna a cura di M Mirri voI m Pisa Pacini 1984 pp 57-141 lt
PULT QUAGliA 1990 A M PULT QUAGUA lt Per provvedere ai popoli Il sistema anshynonario nella Toscana dei Medici Firenze Olschki 1990
SERUO 1994 S SERilO Architettura civile Libri sesto settimo e ottavo nei manoscritshyti di Monaco e Vienna (a cura di F P Fiore) Milano TI Polifi10 1994
SIGAUT 1985 F SIGAUT Questions deacuteconomie agrave propos des politiques ceacutereacutea1iegraveres et de stockage in Les techniques de conservation des grains agrave long terme leur r6le dans la dynamique dessystegravemes de cultures et des socieacuteteacutes (sous ladirection de M Gast F Sigaut e~Beutler avec la collaboration de O Bijchsenschutz) voI m 2 Paris Eacuteditionsdu CNRS 1985 pp 597-606
SMfIH [1776] A SMITH Aninquiry into the nature andcauses ofthe wealth ofnations London W Strahanand T CadeIl 17762 voll (trad it Indagine sulla natura e le causedellagrave ricchezza delle nazioni Milano A Mondadori 1977 2 voll da cui si cita)
STAnmB(i~ACOLSIANI [1313] STATUTI BONACOLSIANI (a cura di E Dezza A M Lorenshyzoni M Vaini) Mantova G Arcari 2002
STATtm GONZAOHESCHI [1404] STATUTlGONZAGHESCHI presso la Biblioteca comunale di Mantova ms FV 11 [775]
VECCHIATO 1979 F VECCHIATOPane e-politica annonaria in Terraferma veneta tra secolo XV e secolo XVIlI (Il caso di Verona) Verona Stamperia Zendrini 1979
ZANETTI 1963 D ZANETTI Contribution agrave leacutetude des structures eacuteconomiques lapshyprovisiQnnement dePavie au XVI siegravecle in Annales ESC XVIII 1963 l pp 44-62 ora in ID Fra le antiche torri Scritti distoria pavese Pavia Universitagrave di Pavia 2000 pp 165-182
ZANETTI 1964 D ZANErn Problemi alimentari di una economia preindustriale Ceshyreali a Pavia dal 1398 al 1700 Torino PBoringhieri 1964
ZUO TuCCl 1990 H ZUG TUCCl Le derrate agriCole problemi materiali e concezioni mentali della conservazione in Lambiente vegetale nellalto Medioevo XXXVII Settimana di studio del Centro italiano di studi sullalto Medioevo (30 marzo-5 aprile 1989) Spoleto Centro italiano di studi sullalto Medioevo 1990 voI II pp 865-902
489 500 Renzo P Capitare
GUENZI 1982 A GUBNZI Sistema annonario e controllo sociale a Bologna nei secoli XVII e XVIII in E SORI (a cura di) Cittagrave e controllo sociale in Italia a XVIII e XIX secolo Milano R Angeli 1982 pp~ 293-306
HICKS [1989] J R HICKS A nwrket theory of money OxfQrd Oxford University Piess 1989 (trad itmiddot Una teoria di mercato della moneacuteta Bologna Il Mulino 1992 da cui si cita)
JACOPEn 1965 N I JACOPEITI Monete eprewa Cremona dal XVI al XVIII secolo Cremona Athenaeum Cremonense1965
KAPLAN 1984S L KAPLAN Provisioning Paris Merchaius and Millers in me Grain and Flour Trade during the Eighteenth Century Ithaca~London Cornell Univershysity Press 1984~middot
KULA [1962] W KULA Teoria ekonomiczna ustrojufeudalnego Proba modelu Warshyszawa~4nstwowe WydavnictwoNaukove 1962 (trad it Teoria economica del sistema feudale Proposta di un modello lorino EinaUdi 1972 da cui si cita)
LABROUSSB [1933] c-E LABRoussB Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIII si~cle Paris Eacuteditions des Archives Contemporaines 1984 2 voll (1 ed Paris Librairie Dalloz 1933)
MAlANIMA 1976 P MALANlMA Aspetti di mercato e prew del grano e della segale a Pisa dal 1548 al 1818 in Ricerche di storia moderna voL I Pisa Pacini 1976 pp289-327
MANTOVA 1430 MANTOVA 1430 Pareri a Gian Francesco Go~ga per il governo (a cura di M A Grignani A M Lorenzoni A Mortari C Mozzarelli) Mantova G Arcari1990
MAsSA 1999 PMAsSA AMonae corporazioni del settore alimentare ~ Genova orshyganizzazione e corflittualitagrave (XVI-XVIII secolo) in A GPJlNZI P MAsSA A MOlOshyu (a cura di) Corporazioni e gruppi professionali nellItalia moderna M4ano R Angeli 1999 pp 390403
MAnoZZI 1983 I MATroZZl R BoLEUl C CHiAsBRA D SABBIONl Il politico e il pane a Venezia (1570-1650) calmieri e governo della sussistenza in Societagrave e storia V1198320pp271-303
MAZZI RAVBOOI 1983 M T MAzzI S RAVBOOI Gli uomini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento Firenze Olscbki 1983
MERONI 1957 U MERoNI Cremonafedeiissima Cremona Athenaeum Cremonenshyse1957
MBUVRET 1977 J MBUVRm Le progravebl~me 4es subsistances agrave leacutepoque LouisXIv 1 La productiOn des ceacutereacuteales dans la France du XVIIet du XVIII si~cle Pans Mouton - EacuteEHss 1977 2 voll
MBUVRm 1988 J MBuVRET Le probl~me des subsistances agrave leacutepoque Louis XlY III Le commerce des grains et la conjoncture Pans EacuteEHss 19882 voll
PICClNNI 1976 G PICClNNl Vita contluJina in una capanna dei dintorni di Siena (1250) in Archeologia medievale JII 1976 pp 395-399
PINTO 1978 G PINTO Il libro del Biadaiolo Carestie e annona a Firenze dalla metagrave del 200 al 1348 Firenze Olschld 1978
PINTO 1982 G PINTO La Toscana nel tarda Medioevo Ambiente economia rurale societagrave Firenze Sansoni 1982
PIRENNB [1933J H PmmINB La civilisation occidentale au Moyen Age du XIe au mishyZieu du XVe si~cle Paris PUF 1933 (trad it Storia economica e sociale del Meshydioevo Milano Garzanti 1967 da cui si cita)
wcostitlJlWne di scorte granarie pubbliche e la politica economiCa degli stati
redistribuzione sostenibile dei beni di sussistenza egrave ricercata in questo cielo da quegli stessi particolari che mllI8lllaldeggiano nella produzione negli scambi nei consumi e che costituiscono il nerbo della classe di governo Le scorte pubbliche rappresenteshyrebbero in questa prospettiva un presidio civico e un ris~nto politico e morale ai componenti della comunitagrave spossessati deIbene supremo dellaUtarchia alimentare
Resta infine latente unidea del magazzmo pubblico come quasi-mercato cioegrave come luogo volto (1) a risolvere i fallimenti informativi d~lla piazza del mercato (in megraverlto alle disponihilitagrave alle caratteristiche del prodotto alle condizioni di vendita della merce) (2) a ddimensionare lalea per agricoltori consumatori poveri artigiani del comparto alimentare (3) a sosteqere i consumi e i profitti privati in funzione anticicli ca in una prospettiva I0n meramente congiunturigraveugravee Si tratta in questo caso di unorshyganizzaZionepienamente razionale che non opera in maniera saltuaria e riflessa ma in modo continuativo secondo obiettivi prefissati di allocazione dei beni primari TI funshyzionamento deJlacanovagrave (il magazzino pubblico) si porrebbe come strumento inteshygrativo ma nOliinteramente sostitutivo delloperare della piazza Si tratterebbe di unaforma ( megravercato distinta dalla pi~ del mercato considerataIn seacute e per seacute cosl come dallegraverompravendite effetttiate nei solari privati o dalla meacutera centralJzzazione e redistribuzione di derrate con fiqatitagrave umanitarie La canova rappresenterebbe in tal modo uno dei possibili mecc~ di governo delle transaziopi locali per risolvere i problCmi dellapprovv~gionameqto senza intaccare certi interessi di classe (dei proshyprietari ma anche del popolo graSso) s) da essere prescelta da autoritagrave e gruppi domishynanti come struttura complemen8Ie della piazza del mercato in certi contestiprodutshydvi ed economici La suasacnilizzazione perciograve non esclude la possibilitagrave di un ritorno alle sole compravendite qella piazza ~ e del solari privati - una volta inverti- tosi il ~nd o spirate le condizio~ economiche della sua istituzionalizzazione
La problematizzazione esorcizza una liquidazione semplicistica del problema delle scorte graUarie in etagrave pre-indus~e nel nome di-~a loro presunta irrazionalitagrave eco- nomica per il compito di assicll1~ la sussistenza della popolazione
Le middotpagine che segUono sono Vintroduzione a un lavoro in corso volto a offrire uninterpretazione generale di tal~ capitolo fondamentale della politica economica dei govemi ~ etagrave pre-industriale
2 SE UN MONDO SENZA SGORTE Egrave INCONGRUO cm Egrave OPPORTUNO CHE LE DETENGA
Nei fatti nel settore granario conI vincoli delletagrave pre-industriale in tema diprodutshytivitagrave energia trasporti non ha ~nso ipotizzare un mondo senza scorte Se il mercato del grano egrave - come nellEuropa Igravenedievale e moderna - un sistema tendenzialmente chiuso
ad ogni raccolto nuove offeXfe arriv[eranno] sul mercato men~e la domanda si mant[erragrave] relativamente costanlf nel corso dellanno Qualcuno dunque [dovragrave1 ~nere delle scorte che saranno elevate isubito dopo il raccolto e poi via via minori fino lIragshygiungere un livello minimo in prpssimitagrave del successivo raccolto (HICKS [1989] 31)
Nella loro forma piugrave semplice tali scorte saranno legate allora alla perlodi~itagrave anshynuale del ciclo agricolo (che aUfnenta il movimento stagionale dei prezzi ccedilfr LAshyBROUSSB [1933 157-66) il loro livello saragrave elevato allindomani del prlnciprue racshy
499 490 RelloP COrrilore
colto (agosto-settembre-ottob~) e in via di esaurimento almomento della saldatura dei raccolti (aprile-maggio-giugno)lA questo proposito nota Franccedilois Sigaut
Le stockage agrave court terme (moms dune campagne) Ieacutepond agrave la neacuteCessiteacute egravek concilier une offre variable et une demande constante mais toutesdeux reacutegulieacuteres et pIeacutevisibles dans la pratique il est ccedilonsideacutereacute comme tagraveisant partie du procegravessus ordigravenaire de la prOduction et ne pose agrave ce titre quedes probJegravemes doplimisation assez simples (SIGAUT 1985 602)
La discussione generale sulla razionalitagraveegraveconomica delle scorte alimentari in etagrave pre-industriale puograve allora essere ridotta alla formulaZione e allo scioglimento di due semplici quesiti 1 Accertato che laccantonamento di grani per la periodicitagrave arinuale del ciclo agricoshy
lo epel i vincoli tecnici di un rifornimento spazialmente allargatoegrave inevitabile chi egrave conveniente che conservi le scorte chi produce O chi cOnlmercia il contadino o il mercante lapossidenza o il popolo i particolari o ilpubblico E qual egrave la realtagrave effettiva
2 Se le forme di distrigravebIgravelZIgraveone economicamente razionale sono plurali in quale conshytesto - e in omaggio a quali interessi - egrave piugrave utile iI sistema della canova rispetto al sistema della piazza del mercato e dei solari privati
3 SULLADISTRlBUZIONE DEL GRANO NELLETAgrave PRE-INDUSTRlALE E LA STRUTTURA DELLE SCORTE NEI TERRITORI ITALIANI
Raramente le case contadine erano dotate di attrezzature per la conservazione dei cereali piugrave che elementari Nelle campagne toscane del Quattrocento dunqueJn unetagrave favorevole al reddito contadino in una regione fra le piugrave ricche dellEuropa pre-indushystriale
pochissime case contadine disponevano del granaio vero e proprio alcune avevano una cella che poteva servire allo stesso scopo ma la maggior parte di quelle abitazioni era priva di spazi destinabili esclusivamente alla conservazione dei cereali Perciograve i contenitori deigrani - arche casse sacchi bugnole - dovevano trovare posto nelle cucine o nelle camere (MAzzI RAvEGOI 1983 174)bull
Le ridotte capacitagrave patrimoniali e reddituali della grande matregoranza dei produttori facevano si che fosse ampiamente invalso nella conservazione domestica dei grani limshypiego di contenitori in legno (come arche casse botti bugnoletini tinelle corbelli)in
Riguardo ai passi evidenziati di Zanetti e Cipolla egrave necessario osservare che la principale atteshystazione sullesistenza di stock detenuti da privati che esorbitassero ilfabbisogno stagionale tali da essere classificati come immobilizzazione di ricchezza (Zanetti) o come beni capitale (Cipolla) a unanalisi piugrave fine si rivela fallace O non direttamente utilizzabile La propalazione dei grani effetshytuata a Pavia fra ilIo e il 5 maggio 1555 che egrave il fondaIgravenento di entrambi i giudizinon mostra una somma di derrate realmente eccedente il fabbisogno delle famigiie per il periodo che manca allarrishyvo dei grani novelligrave sulla piazza pavese Daltra partelastessa natura dellistituto della propaazio- ne dei grani cioegrave della denllncia obbligatoria delle scorte da parte dei particolari una misura demergenza decisa in momenti critici dellapprovvigionamento cittadino affiancata quellanno dalshylispezione diretta presso le case dei privati da parte di deputati straordinari avrebbe dovuto consishygliare una maggiore cautela nella sua utilizzazione per individuare regolaritagrave di carattere generaledelleconomia pre-industriale
La costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli slatibull
FONTI
ABEL [1966] W ABEL Agrarkrisen und Agrarkonjunktur Eine Oeschichte der Landshy und Ernlihrungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter Hamburg
und Berlin Paul Parey 19661 (P ed -1935 trad it Congiuntura agraria e crisi agrarie Storia dellagricoltura e della produzione alimentare nellEuropa centrashyle dalXlII secolo alletagrave industriale Torino Einaudi 1976 da cui si cita)
AG ARCHIVIO GONZAGA presso lArchivio di Stato di Mantova AuFANO 1996 E AuFANO Il grano il pane e la politica annonarla a Napoli nel Setshy
tecento Napoli ESI 1996 bull AYMARD 1966 M AYMARD Veacutenise Ragusegrave et le commerce du bleacute pendant la seconde
motti du XVI siegravecle pans SEVPEN 1966 CA1TINl1984 M CATlINl I contadini di San Felice Metamorfosi di un mondo rurale
nellEmilia delletagrave moderna Torino Einaudi 1984 CEsTARI 1794 p CESTARI Saggio storico dei Fondachi delle farine di Chioggia e
Pellestrina~ bullbull Venezia A Zatta1794 CIPOLLA [1-965] C M CIPOllA La politica economica dei governi V La penisola
italigraveana e la penisola iberic(l in Storia economica Cambridge ID La cittagrave e la politica economica nel Medioevo Torino Einaudi 1977 (Cambridge 1965) pp 462-496
CirollA 1974 C M CiPollA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna TI Mulino 1974
CIpOLLi 1997 C M CIPOllA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna TI Mulino 1997 (6 ed riveduta)
CORRITORB 2000 R P CORRITORB La naturale abbondanza del Mantovano Produshyzione mercato e consumi grqnari a Mantova in etagrave moderna Pavia Universitagrave di Pavia 2000
CORTONESl 1991 A CORTONESr Sulla conservazione dei cereali nellItalia medioevale woro e tecniche nelle tesnnonianze laziali (secc XIII-XV) in Rivista di storia dellagricoltura XXXI 1991 l pp 33-49
DElLA VALENTINA 1992 M DEJ1A VALENTlNA I mestieri del pane a Venezia tra 600 e 700 in Atti dellIstituto igraveVeneto di Scienze Lettere ed Arti Classe di scienze morali lettere ed arti CL 1991-92 pp 113-217
DIRLMEIER 1984 U DiRLMEIER Le condizioni materiali dellesistenza nelle cittagrave tedeshy sche del Basso Medioevo wlwiente esterno reddito consumi in Aristocrazia citshy
tadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia e in Germania (a cura di Reinhard Elze e Gina Fasoli) Bologna Societagrave editrice il Mulino 1984 pp 79shy122
FORNASIN 1999 A FORNASlN II rnercatodei grani di Udine Indagine per una storia dei prezzi in Friuli (secoli X1(1-XVIII) Nota di ricerca del Dipartimento di Scienshyze Statistiche dellUniversitagrave degli Studi di Udine 4 1999 pp 1-24 ora in ID La Patria del Friuli in etagrave frtoderna Saggi di storia economica Udine Forum 2000 pp 33-60
GRENDI 1986 E GRENOl Lapprf(vvigionamento dei grani nella Liguria del Seicento libera pratica e annone in rMiscellaneastorica ligure Studi in onore di Luigi Bulferetti XVIII1986 2 IP 1021-1047
GUENZl 1981 AGUENZI Ilfrumento e la cittagrave il caso di Bologna nelletagrave moderna in Quaderni storici XVI ~98l 46 pp 153-167
GUENZlI982 A GUENZI Pane efornai a Bologna in etagrave moderna Venezia Marsilio 1982
l
491 498 Renzo P Corritore
alla spartizione dei proventi derivanti dalla vendita e dal commercio del grano shylemolumento grandissimo - di chi doveva poi fruire della redistribuzione di tale ricchezza Tale norma avvantaggiava i possidenti cittadini e i gentiluomini privilegiashyti in grado di ottenere le tratte di esportazione Spl piano dellappropriazione essi erano in condizione di mettere fuori gioco gli altri possessori che producev~o eccedenze nel Dorilinio poicheacute si accresceva la loro forza contrattuale e la loro capacitagrave di occupare i canali commerciali piugrave redditizi Sul piano della commercializzazione gli stessi fruivashyno dello smantellamento della rete dintermediazionerappresentata dai fornai Per i rushystici significava perdere un collegamento essenziale con la cittagrave ed essere emarginati dal mercato urbano nelle campagne o sul broletto di Mantova essi non trovarono piugrave i trashydizionali interlocutori (CORRIJ9RE 2000 228231-2)
Nel caso di Bologna terra strutturalmente deficitaria e cittagrave dalla vocazione manishyfatturie1a si costringeva i fornai ad acquistareformenti terrieri presso i solari privati in cittagrave proibendogli lincetta nel contado autorizzandoli ad acquistarefornientiforeshystieri al di fuori delle mura cittadine presso rsensati da grCUlO solo a patto che fosseshyro stati smaltiti i grani cittadini a un prezzo talota superiore a quello dei grani dimshyportazione (GTlBNZl1982A 35 52-3)
Nella Toscana dei Medici il diritto allincetta nel contado venne concesso ai fornai in periodo di bassa congiuntura (in particolare dagli anni Trenta del Seicegravento) Per sostenere i prezzi interni in tal caso essi restavano gli interlocutori principali dei granshydi proprietari semplicemente spostando la loro principale fonte di approvvigionashymento dai solari dei particolari in cittagrave ai granai decentrati delle grandi aziende agrishycole oppure ai mercati rurali su cui affluiva la produzione cerealicola delle grandi fattorie (PULT QUAOUA 1984 86-9 PucrQUAGUA 1990 100 106-7)
Laddove non vi egrave come invece succede a Genova una diretta ingerenza del potere pubblico nella vita della corporazione (MAsSA 1999) i fornai di cittagrave- nonostante i lacci e lacciuoli normativi e il lavoro prevalentemente manuale svolto neUord laboshyratori - erano dei veri imprenditori dipendenti per il loro profitto - noilrinalmente stabilito per legge - dalla produttivitagrave del lavoro e dalla dotazione tecnica e finanziaria delle imprese Di ciograve fa fede la grande sperequazione esistente fra le aziende speciashylizzate nena fabbricazione del pane venale in cittagrave (AYMARD 1966 75 VBCCHIATO 1979 82-3 GTlBNZl1982A
77 segg PULT QUAGUA 1984100 102-3) NellItalia delshyletagrave moderna questi artigiani-imprenditori della filiera del grano trattavano insieme
afarinaifarinaiolifarinottifondachierifontechierifidelarijormentinari lasagneshyri maccaronari taraltari vermicellari ecc fra il 40 eil70 per centodel frumento consumato in Cittagrave nelle annate normali (CORlUTORE 2000 126 segg) e ~no alIDO per cento nelle annate di carestia (PULT QUAGUA 1984 98-9)
In una ricognizione delle asimmetrie informative del mercato non cegrave gruppo quale i fornai che possa integraverpretare la parte dellagente economico onnisciente Se dunque i regolamenti annonari tendevano a regolare minuziogravesamente la collocazione il volushyme e la durata delle loro scorte cosi come disponevano per gli altri artigiani della fishyliera era per neutralizzare il carattere potenzialmente eversivo di tale accantonamenshyto per i proprietari-venditori prima ancora che per i consumatori-acquirenti nlivello delle scorte rinforzava o attenuava il rischio di monopsonio da parte dei pistores piugrave potenti e facoltosi cosi come eventuali tentazioni da parte della categoria di esercitare un dominio egoistico sul mercato del pane (MATroZZI 1983 298)
Sarebbe quindi un errore concep~ le sccedilorte dei fornai come entrilpica allocazione di capitale che sconta lincertezza futura esse venivano gestite secondo criteri di rashyzionalitagrave economica e secondQ la migliore efficienza tecnica nonostante i vincoli imposti alla lievitazione degli stock dalle disposizioni annonarie
LA costituzione di scorre granarie pubbliche e la polilica economica degli stati
vimini paglia o canne intrecciate (come ceste stuoiecannizzi) in terracotta (addirittura anfore) piuttosto che di tessuto (i sacchi costavano troppo) (PICClNNl 1976 397 MAzzA RAvBGGI 1983 174-5 Zoo Turo 1990 893-4 CORIONESI 1991 35n-36n)
Nella casa del piccolo produttore O del titolare di un piccolo possesso il penus (la scorta domestica) difficilmente eccedeva il consumo famigliare chi fortunato raccoshyglieva piugrave dellannona famigliare e di quanto gli serviva per il campo era spinto a venderselo nei mesi immediatamente successivi alla mietitura e alla trebbiatura per necessitagrave di denaro ma anche per la difficoltagrave di stoccare e conservare il prodotto in condizioni ottimali (MEUVRET 1988 17-9 Pmr QUAGUA 1984 88) e financo per ridurre il rischio di vederselo soffiare da vagabondi e malintenzionati In questo caso in presenshyza di eccedenze (ma probabilmente anche in assenza) il bisogno di liquiditagrave e 1alea cospiravano nel ridl1rre ai minimi termini le scorte giagrave allindomani del raccolto In caso alternativo il contadino che non egrave - ripete Jean Meuvret - un homme daffaires quanshyto un homme de peur concepiva la sua riserva come un fondo di previdenza sul racshycolto futuro da non immettere sul mercato se non nel caso dellapprossimarsi di una messe sicura secondo una logica economica a contrario (MEUVRBT 1988 19 e 147)
Era Hltente la disparitagrave fra i produttori non solo fra chi era in possesso di eccedenshyze e chi non lo era ma piugrave ancora fra chi poteva scegliere - in virtugrave di una maggiore capienza economica e un adeguata dotazione tecnica - il mercato piugrave favorevole per i propri grani (il periodo di saldatura dei raccolti) e chi invece li cedeva troppo presto o in controtempo a livelli non ottimali
Nella gerarchia delle abitazioni rurali -- in quel vero e proprio saggio di sociologia che egrave il sesto libro del De Architectura di Sebastiano Serlio (scritto fra il 1537 e il 1555 inedito per tutto levo moderno) - per trovare case attrezzate di granaio occorshyreva ascendere sino alla magione del basso mercante o cittadino fuori della cittagrave (SERLIO 1994 43 segg anche per le successive informazioni) Condizione di cui non potevano fregiarsi invece i ricchi contadini in ~ssuno dei tre gradi possibili di ricshychezza al massimo la loro casa poteva es~ere attrezzata di portici per ricoverare le biade e di unaia per batterle segni di distinzione giagrave fra i mediocri contadini Fra questi perograve avrebbero potuto avvalersene soltanto i fortUIgravelati et di beni et di famishyglia (3deg grado di mediocritagrave) Dforno per cuocere il pane e una cantina per conservashyre il vino invece li si sarebbe trovati a partire dai piugrave accomodati fra i poveri contashydini cioegrave al 4deg gradino della scala sociale alla cui base erano da collocare i poveri mendichi con vil capanna (1deg grado di povertagrave) i salariati che vivevano delle [loro] fatiche avendo un puoco di terreno (2deg grado di povertagrave) i poveri con qualche beshylitiuola et massimamente de buovi possessori di una stalletta congiunta con la casa (3deg grado di povertagrave) In sintesi nelle campagne delletagrave pre-industriale pochi avevano scorte pochissimi
erano in grado di ricoverarle in un solaro privilegiatissimo chi le incanevava per speculare Dunque fra i contadJni se si esclude quanto celato nella madia o nella dishyspensa le scorte erano un pri~ilegio di pochi Il Sedio nato intorno al 1475 insiste sullimpoverimento delle class~ rurali intervenuto fra gli anni della sua giovinezza e quelli della vecchiezza in cui segraverive Sotto il titolo Dellabitazione del ricco contadishyno per tre gradi di ricchezza si preoccupa di puntualizzare
bencheacute al digrave dogi non se ne truovi piugrave de tali merceacute delle discordie et di gli animi fieri et ostinati alla vendetta onde per tal cagioni et per le continue guerre et anche pei citadini divoratori de gli altrui beni che con le usure con glinganni con le rapine gli hano impoveriti (SERllO 1994 48)
492 497 Renzo P COlTitore
Tale disparitagrave sociale si riverberava sulla struttura del conunercio cerealicolo La funzione dei piccoli conunercianti di biade (granaioibiadaiolijarinaioli balshy
zarotti cavallanti vaticali ecc) era infatti ancillare alla capacitagrave di affacciarsi sul nercato della fascia marginale dei possidenti con eccedenze Solo che nelle annate di
abbondanza si verificavano ingorghi nellofferta di grano che deprimevano i prezzi e incentivavano i piccoli produttori a smerciare direttamente le eccedenze allindomani del raccolto nellarea urbana anche al di fuori dei luoghi deputati (MA1TOZZl 1983 278 281-2 300n PULT QuAGLIA 1984 86) Mentre nelle annate di penuria si contraeshyva drasticamente proprio questo segmento dellofferta (ABEL (1966J 22-4 KULA (1962] 73-4 CATIINI 1984 111-23 PuLT QUAGLIA 1984 88) scatenando nelle campashygne una caccia al grano-merce la cui quota piugrave consistente era detenuta dai grandi proprietari dai maggiori affittuari dai percettori di canoni diritti o rendite in grano e la cui quota residua era piugrave facilmente preda di chi occupava posizioni chiave nellasshysetto terriero nella catena dei diritti nel credito alla produzione e al consumo
Tanto la distribuzione era frammentata nelle annate di abbondanza tanto in epoclshydi penuria il conunercio del grano diventava un affare di pochi In questo caso lazioshyne dei mercanti diventava dimpiccio sul mercato interno dove la coperta si restringeshyva per i proprietari e gli imprenditori agricoli (KULA (1962J 56-61 CATIINI 1984 114-8) - dove la necessitagrave di ricorrere al credito da parte dei piccoli possessori pOneva questi nelle mani degli agenti dei proprietari dei percettori di canoni diritti o rendite - dove i piccoli proprietari vedevano minacciata la loro stessa condizione da parte di chi controllava localmente in maniera capillare e decentrata il mercato del denaro e dei beni necessari alla riproduzione (sernenti strumenti cibo) La soluzione era quelshyla di precludere amministrativamente ai sensali e ai conunercianti di grani i mercati locali su istigazione dei medi possessori le cui occasioni di normale profitto agrario soffrivano un ridimensionamento e che si vedevano costretti a impegnarsi ccedilontiltte le loro forze per integrare le proprie entrate accaparrandosi le magre eccedenze disponishybili nelle campagne e nei borghi rurali (PuLT QUAGLIA 1984 84-8 PuLT QUAGLIA 1990 107-14)
Il destino dei piccoli conunercianti in grano era quindi quello di occupare una posishyzione marginale nel mercato del grano (MEUVRET 1977 30 PINTO 1978 13 MATTOZZI 1983 277) e di operare non solo a causa degli ordinamenti annonari - secondo una logica di corto respiro in cui non era contemplata neacute la conservazione di grani a lungo termine neacute lutilizzo di depositi piugrave che provvisori Come per i piccoli possidenti non si puograve parlare nel loro caso della formazione e del mantenimento di scorte consistenti (MEUVRET 1988 156-7) Non tali comunque da sostenere il reddito contadino nelle stagioni ordinarie e da esercitare sul versante cittadino unefficace azione anticonshygiunturale in caso di carestia
Peraltro in cittagrave la struttura dellofferta era anche piugrave sperequata di quella che si rishyscontra nel contado Che si tratti di Prato ne) 1339 (PlNTO 1978 129 PINTO 1982 160n e 171n) Pavia negli anni 1539 1555 1573 1602 1603 (ZANIITTI 1963) o Mantova nellultima parte del secolo XVI (CORRITORE 2000 81-9) la distribuzione delle scorte fra i privati era singolarmente ineguale Lo attesta la rilevanza nellarea urbana della povertagrave cioegrave secondo una definizione coeva di coloro che non vivono di entrate ma sono necessitati ricorrere mattina e sera alle pistorie a comprare il pane per il vitto loro e delle sue famiglie col denaro che di giorno in giorno si vanno guadagnando (MATshyTOZZI 1983 281) PUOgrave essere utile richiamare la situazione delle cittagrave tedesche nel basso Medioevo in una fase che egrave stata definita da Wilhelm Abel l epoca doro degli artigiani e del lavoro salariato si puograve stimare che almeno la metagrave degli iscritti ai
il costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica ecol1Omica degli stati
te con il principio della piazza Il mercato pubblico periodico disciplinato la spiagshygia la piazza la loggia o il recinto riservato alle contrattazioni - coesisteva confabshybriche magazzini ebotteghe La stessa piazza per funzionare al meglio secondo il principio dello scambio diretto necessitava di magazzini di supporto
4 LE SCORTE DEI FORNAI CITTADINI
Nellarea urbana e nelle relazioni tra cittagrave e campagna operavano perograve temibili conshycorrenti dei privati possessori I fornai cittadini possedevano le competenze le strutshyture tecniche le relazioni sociali e il credito per incettagravere il prodogravetto per essere inforshymati tempestivamente sul mercato del grano e potenzialmente per dispensarlo con profitto in qualunque momento Il fatto che il loro operato fosse imprigionato in un arshycaica impalcatura di norme divieti obblighi che risalivano alletagrave romana che ne fashycevano in modograve quasi istituzionalizzato il capro espiatorio delle tensioni fra produtshytori di grano povertagrave e autoritagrave non impedisce di affermare che tali vessatorie disposizio~i trovassero la loro principale ragione dessere nella parte che essi giocashyvano di interlocutorilantagonisti dei proprietari terrieri nella determinazione del prezshyzo del grano sul mercato locale e nella realizzazione della rendita terriera (GUENZI 1982 35 GUENZl 1982 297)
Nel caso di Mantova terra cornucopia a partire dal 1492 si consenti a zentilhomini cittadini et qualuncho altro di comprare biade nel Dominio per approvvigionare la cittagrave di fatto si sancigrave un diritto allincetta che mise fuori gioco i fornai a cui venne imposto di rifornirsi nei solari dei cittadini senza avere piugrave la possibilitagrave di effettuare acquisti nel contado e di ritenere a casa scorte superiori a 100 staia di frumento Lintento della disposhysizione egrave chiarissimo espresso senza reticenze dai Maestri delle Entrate che riportarono al marchese la soddisfazione dei possidenti mantovani per la riforma statutaria
tutta la Terra (cioegrave il Mantovano] ne (egrave] rimasta satisfactissima pensando che Vostra Excellentigravea pretenda ali comodi et utilitagrave universale senza dampno et preuiditio suo Vero egrave che li fumari non si contentano parendoli comegrave il vero che non si poteranno ingrnssar asuo modo come hanno facto per il passato et poterigravea Igravelchader ( ] che veneranno adolershyse et supplicar aVostra Signoria Perograve me egrave parso dargene aviso per questa nostra et farli intender che questa terra ha soliigrave due membri de li quali li cittadini soi se ne possono aiutashyre e valersene uno egrave il grano laltro egrave larte de la lana et quando se concedesse che li furshyDari potessero comprare come h~o facto li tempi passati sana un fare beneficio acinquanshytaocto dessi et dampnifichar elresto de fa republica sua quale de questo ban ordine ne receve emolumento grandissimo et se gaude in la Citagrave [percheacute] li fumari portano fuora el denaro et pretendono solo a suo benefitio (AG b 2441 lettera del 13 luglio 1492)
Egrave indubbio che il plauso della Terra fosse da attribuire piugrave alla possibilitagrave per i proshyprietari di accrescere le proprie entrate che a quella dei consumatori cittadini e dell arte della lana di trarre beneficio dalla disposizione Egrave significativo che la motivazione pro cigravevitate non accenni allesistenza di monopoli da parte dei fornai o di artificiose lievitashyzioni dei prezzi per causa loro Il loro attivismo non confiiggeva per quanto riguarda i prezzi finali della sussistenza con linteresse dei produttori cittadini E daltra parte largomento dellQ storno dal merpato cittadino dei profitti incamerati dai fornai -laccushysa consueta a proposito dei pistores egrave che fossero in gran parte stranieri (GUENZII982 22) -- era una giustificazione debole che appassionava piugrave chi concorreva direttamente
496 493
Renzo P Corritore
appare altrettanto astratto dogmatico o virtuale del principio di mercato (Market Pri1lciple) che il medesimo gli contrappone Henri Pirenne parlando della politica annonaria dei comuni medievali avverte Lapplicazione del principio della vendita diretta ebbe numerosi eccezioni (PumNNE [1933] 193n)
Nel caso di Mantova la scelta della Piazza egrave facoltativa per i terrieri COn eccedenze Gli Statuti signorili che si rifanno largamente alle raccolte statutarie comunali non sancivano alcun obbligo in proposito (v SVJUTI BONACOLSIANI [1313] libro m rubr 55 De mercato blave 253 STATlITl GoNZAOHESCHI [1404J libro m rubr 93 De mercato blave fiendo in civitate Mantue f 73v) Decreti di carattere straordinario e regolamenshytazioni transitorie correggevano il tiro Nel 1405 in piena saldatura dei raccolti si c0shy
strinse a rifornire forzosamel)~ la piazza concentrandovi tutte le contrattazioni Nel 1417 si obbligograve a riservare al mercato un terzo del frumento introdotto in cittagrave (CORRIshyTORE 2000 235-6) Ma sono atti straordinari che non sopravvissero nel migliore dei casi piugravedi qualchelustro (MANroVA 1430 88 90 181) A Mantova la Piazza era affianshycata da un granaio pubblico la Domus del mercato (altrove definito Folllico o Fonrego del mercato) in cui avrebbero dovuto prolungarsi le contrattazioni oltre lorario e i giorshyni deputati (venerdigrave o sabato) rendendo disponibile ciograve che restava invenduto e che non poteva essere ritirato per legge dal mercato Nel 1430 eminenti cittadini sollecitati dal principe lamentavano perograve lincapacitagrave del magazzino - inoperoso in tutto o in parte per il pericolo di crolli -- di rispondere ai bisogni del popolo in una situazione in cUi da parte dei possessori si protestava la difficoltagrave di non poter esitare e smerciare fuori delshyla cittagrave le eccedenze conservate nei solari privati
Item videtur quod valde utille foret civibus Mantue habentibus possessiones et quishybuscumque alijs personis de civitate Mantue aut districtu colligantibus bIada et vina in magna copia ut omni tempore ipsa bIada et vinum possent extrahere de civitate et dishystrictu Mantue et conducere ad Iaea ad que et in quibus ma vendere poterunt cum otdishynibus et dacijs competentibus ipsa tamen civitate semper remanente fulta pro usu dicte civitatis et populi eiusdem ne dieta biada marceschant super granarlis ut hactenus feceshyrunt cum maximo incomodo ipsorum civium (MANTOVA 1430 177-8)
nmedesimo fondaco abbinato al mercato operava a Verona a Ferrara a Vegravenezia a Udine a Chioggia in molte altre cittagrave (MANToVA 1430 100 FORNASIN 1999 7-9 CEshySTAR 1794)
Lintegrale e pedissequa applicazione del principio della piazza di mercato comporshytava - per i vincoli tecnici dell etagrave pre-industriale -la massima affermazione del prinshycipio della canova cioegrave del magazzino pubblico centrale Unico argine alla sua invashydenza era costituito da una distribuzione perequata ab imis del raccolto cioegrave la possibilitagrave - egrave questo il paradosso - di realizzare da parte dei produttori la massima aspirazione nelle societagrave tradizionali lautarchia domestica Piugrave avanzava invece la sperequazione nel reddito e nel patrimonio piugrave da parte dei consumatori privi di scorshyte si impetrava il principio del Magazzino pubblico nella ronna di un efficiente sisteshyma di ricovero conservazione distribuzione delle derrate a garanzia del funzionashymento della Piazza di mercato La disponibilitagrave di crescenti quote di raccolto tuttavia indirizzava i piugrave accomodati verso soluzioni piugrave ghiotte la vendita allingrosso sul mercato cittadino ai fornai o allimpresa pubblica creata a sussidio di questi (o in loro vece) Oppure allopposto lesito delle eccedenze extra muros sui grandi mercatishyemporio regionali per il tramite di mercanti o agenti diretti
Il principio del magazzino pubblico centrale cioegrave laccumulazione di riserve per lo smercio continuo o anticiclico egrave quindi alla sua origine in opposizione solo apparen-
La costirU1ione di scorre granarie pubbliche e la politica economica degli srati
ruoli fiscali non fosserograve in grado di accantonare scorte Nel 1444 a Strasburgo quattro cittadini su dieci non possedevano alcuna riserva cerealicola (DRlMBIER 1984 112)
Nelle cittagrave italiane delletagrave moderna si puograve stimare che non meno di due terzi della popolazione fosse costretta ad acquistare o consumare pane confezionato con grani e farine comperati nelle piazze nelle vie e nelle botteghe cittadine oppure ottenuti come compenso del proprio servizio nelle casate (CORRrroRE 2000 126-36 MA11oZZI 1983 27~-82) Evidentemente questa fascia di lavoratori salariati non possedeva -shyper definizione - neacute scorte neacute depositi personali e nel primo caso era strettamente dipendente dal mercatograve urbano acquistando la sua sussistenza con frequenza non piugrave che settimanale (essendo costretti a comprare il pane tutti i giorni allafinestra si dishyceva a Genova [GRENDI1986 1031])
Ma anche fra i citiOdini con possesso extra moenia la distribuzione delle scorte era tuttaltro che egalitaria A Prato nel 1339
A parte gli enti religiosi sette famiglie [ ] avevano ii disposizione piugrave di mille staia di granaglie (circa 18 tonnellate) fino a un massimo di 3500 Altri venti nuciei familiashyri avevano scorte comprese tra le 500 e le 1000 staia (PINTO 1978 129n)
A Mantova nei magazzini ducali nellultima parte del 500 erano ammassati non meno di un ottavo talora piugrave di un quarto delle riserve cittadine di grani panificabili (CoRRITORE 200081-6) A Pavia nel corso dello stesso secolo e allinizio di quello successivo nei solagraveri di una sessantina di famiglie si concentrava non meno del 40 per cento dellintera offerta cittadinIgrave di frumento(ZANBUgrave11964 70-7) Anche in questo caso egrave utile sapere che nelle cittagrave tedesche esistevano mercanti (ad Augusta RatisboshyDa Norimberga) in grado di axnPmssare riserve da 6 a 45 tonnellate e che a Francoshyforte nel 1488 due patrizi totali~zavano insieme un terzo delle scorte cerealicole dei particolari nella cittagrave alta (DnuMmER 1984113)
Ritenere tali soggetti sprovv~uti al punto di incanevare grani con il solo scopo di esorc~ i pericoli della Fstia egrave perlomeno riduttivo A grandi solari comshyspondevano vaste familiae e pIftore di servi tori e ospiti ma tali scorte eccedevano largamente la sussistenza del maggiore palazzo nobiliare o patrizio senza peraltro costituire un fondo di accantonafoento eccedente il fabbisogno della cittagrave a meno che non vi fosse la concreta possibilitagrave di commercializzare il surplus sui mercati esteri Come nota infatti Adam Smith
a meno che leccedenza non possa essere esportata in tutte le circostanze ordinarie i coltivatori staranno molto attenti a non produrre e gli importatori a non importare mai una quantitagrave maggiore di quell~ che egrave strettamente richiesta dal consumo del mercato interno Questo mercato saragrave difficilmente sovrafomito ma saragrave in generale sottoriforshyDito dato che coloro che svolgqno lattivitagrave per rifomirlo avranno in generale il timore che la loro merce possa rimanete invenduta (SMlTH [1776] 528)
Lipotesi egrave suffragata dai cas~ storici conosciuti A Bologna macrodistretto serico dellevo moderno laddove gli ipteressi manifatturieri e mercantili avrebbero dovuto consigliare una sussistenza a b~on mercato per tenere basso il costo del lavoro le istituzioni annonarie operavano per garantire con il calmiero deljorme1lto la monetizshyzazione della rendita granaria dei possidenti - strutturalmente incapace di coprire il fabbisogno della cittagrave anchea rischio della carezza dei viveri contingentando il mercato dei grani forestieri (GtJFNZl1982A 37-76) Di fatto
495 494 Renzo P Corrllnre
In ogni caso si tendeva a limitare al minimo indispensabile lemiddot importazioni di frushymento per evitare che stocks invenduti potessero turbare la collocazione dei grani tershyrieri nel nuovo anno agrario (GuENZI 1981 153)
In tutti i centri comunque la tendenza a ritardare la vendita del surplus nei mesi della saldatura lutilizzo di depositi specializzati con personale addetto alla custodia al conshydizionamento e alla commercializzazione del prodotto ponevano i grandi proprietari di biade su un gradino superiore e diverso rispetto al resto della cittagrave Laccantonamento di grani per questa cupola di possessori rispondeva al principio dellutilitagrave soggettiva atshytesa e richiedeva sia capitale fisso sia capitale circolante per raggiungere gli scopipreshyfissati un profitto speculativo la valorizzazione della rendita
In molte cittagrave i possessori non avrebbero dovuto trattenere in casa piugrave grano e farina di quantoprescritto dalla legge cioegrave il consumo mensile per bocca - fissato anchesshyso statutariamente - per arrivare al nuovo raccolto Ma i cittadini credeVano veramenshyte ai loro comandamenti Egrave lecito dubitare La norma era scolpita negli Statuti e pubshyblicamente violata con la complicitagrave dll1e autoritagrave e dei groppi professionali interessati alla distribuzione del grano nelle sue ~arie forme
Nelle annate ordinarie la quota di grano auto consumato - cioegrave non acquistata sul mercato - nelle cittagrave italiane dell evo moderno rappresentava fra il 30 e il 60 per censhyto del fabbisogno urbano di frumento
Nella capitale dei Gonzaga nel 1615 si valutava che su 27000 bocche
il terzo [di] gentilhuomini fittadri servitori et altri [ ] non comprano biada et gli duoi tenigrave tra poveri artisti mercanti fomari fondachieri hebrei et altri [bull] non possono in tutto levar sufficientemente la somma de detti dua terzi sl che saranno boshychegrave 18000 che compraranno biada (COIUUTORl 2000 126)
AVenezia a cavaliere fra XVI e XVII secolo alla mensa delle casade si dispensava circa un terzo del frumento consumato ordinariamente in cittagrave (AMARD 1966 74 MATTOZZI 1983 281) ABologna per tutto il Seicento i fornai che impastavano farine in conto lavorazione per i particolari pareggiavano piugrave o meno il numero di quelli da scqffa che smerciavano pane venale (GUENZI 1982A
27) Peraltro la proporzione a Rialto tra chi lavorava per le casade e chi vendeva pane al pubblico - 65 Jo~ri a fronte di 44-48 pistori negli anni 1583-1685 (DELLA VALBNTINA 1992 143-4 167 192-3) - fa ritenere la struttura del mercato del pane felsinea non molto dissimile da quella veneziana Nelle cittagrave liguri o toscane sei-settecentesche la porzione autocon sumata quando il raccolto era buono era anche piugrave elevata (GRENDI 1986 1024-6 1034 PuLT QUAOUA 1984 98-104 PULT QUAGUA 1990 171-2) A Napoli nel 1758 a Monasteri Luoghi pii e Particolari eta riservato il 28 per cento del consumo cittadishyno di frumento (AuFANO 1996 37n)
Lelevato numero di servi domestici persone al servizio delle casate faceva sigrave che in alcuni palazzi si concentrassero masse cospicue di grano per la spesa familiare Ma accanto ad esse gli operatori dell annona -- la stessa povertagrave -- si auguravano che vi fosse sempre anche la materia per rifornireil mercato e i forni cittadinimiddot nella fase piugrave delicata del ciclo annuale il periodo di saldatura dei raccolti Come spiegare altrimenshyti la norma che imponeva ai grossi detentori di biade (non esclusi enti e opere pie) in varie cittagrave italiane dellevo moderno la vendita straordinaria in primavera dellegrave ecshycedenze ammassate in granaio (per Pisa e la Toscana v PuLT QUAGUA 1984 88-9)
A Mantova nel 1554 si stabiliva che i patroni che avessero fruito in cittagrave di piugrave di 20 sacchi di grano come porzione dominicale avrebbero dovuto coilservare in granaio
lA costituzioni digrave scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
il 4 per cento per le necessitagrave dei consumatori dei fornai e dei Jontachieri quando fosse mancato il prodotto sulla piazza o nelle offerte deisensali Nel 1603 ci si preocshycupograve di elevare la quota al 6 per cento (CORRlTQRE 2000 237n) Beninteso le vendite sarebbero avvenute ai valori di mercato Lo stesso sistema vigeva a Cremona (6 per cento nel 1608 e nel 1612) (MERON 1957 59n 63 JACOPETl1 1965 128) ea Verona Qui una delibera consiliare del 1549 autorizzava per la prima volta
[il deputati [alle Biadel [a] tassar e comandar con quelle pene che al Clarissimo Podestagrave pareragrave quella quantitagrave di biade a ciascuno secolare o eclesiastico sia di qual grado o condittione esser si voglia che havesse biade in questa cittagrave oltre il viver suo
(VOCCHIATO 1979 145)
La tassa sarebbe stata stabilita - da11558 - per sorteggio fra le casate che avessero introdotto in cittagrave dai propri possedimenti piugrave di 70 minali per rifo1llire il Mercato delle biave Essa-venne anche incrementata nella stessa occasione dal 5 al6 per censhyto per restare in vigore fino al 1631 (VECCHIATO 1979 141-58)
Quest9 tiIfo di normativa nasce e si affiogravea in ambito amministrativo perciograve echeggia la realtagrave molto meglio della veneranda legge generale
Da tali disposizioni si deducono alcuni fatti incontrovertibili 1entro la cerchia cittadina esistevano scorte private eccedenti la spesa delle famiglie
in violazione in molti casi della legge statutaria 2il possesso della terra che solo assicurava lautarchia delle casate era il piugrave-potente
fattore di discriminazione fra i cives tanto da precipitare nel girone dei pauperes la moltitudine che acquistava correntemente la sussistenza nellarea urbana
3fra gli stessi possidenti cittadini esisteva uneacutelite che non solo conservava scorte oltre il viver suo ma che si proponeva egoisticamente di speculare ritardando limshymissione dei grani sulle piazze cittadine o che a~endeva il momento piugrave opportuno per smerciarli allesterno nelle grandi piazze frumentarie come livorno Desenzashyno Legnago Romano (di Lombardia) ecc
4lineguaglianza fra i cives tese ad aggravarsi con la metagrave del 500 poicheacute questi reshygolamenti innovano quasi sempre disposizioni generali risalenti al tardo Medioevo che sancivano lobbligo di convogliare il surplus sulla piazza cittadina segno di una distribuzione del reddito originariamente meno sbilanciata A Cremona gli Statuti del 1388 obbligavano - cosl egrave ancora nel 1510 - a vendere il
sovrappiugrave in Piazza Maggiore sul mercato pubblico dei grani (MERON 1957 59n
63)A Pisa il rescritto che imponeva di effettuare le vendite al minuto in platea bladi
risale al 1401 MALANlMA 1976 293) lobbligo era ribadito ancora nel 1548 ma nella seconda metagrave del secolo XVI si affermava la pratica di vendere fuori mercato tanto che nel 1581 il Magistrato dei Nove dovette intervenire per far vendere i grani delle comunitagrave degli enti e dei luoghimiddotpii soltanto da marzo-aprile in piccole quantitagrave sul mercato (PULT QUAGUA 1984 81-91) La disposizione per altro si applicava allinteshyro Stato (PULT QUAGUA 1984 88)
Tuttavia non egrave da pensare che il principio della concentrazione delle compravendite sulla piazza di mercato cittadina fosse universale universalmente rispettato e sopratshytutto perenne La centralizzazione del grano non significa automaticamente lobbligo di vendita diretta sulla Piazza deiformenti Affermare come Steven L Kaplan che
There was no single more important regulation concerning tbe provisioning trade tban tbe requirement tbat alI transactions occur in tbe marketplace (KAPLAN 1984 27)
494 495 Renzo P Corritore
In ogni caso si tendeva a limitare al minimo indispensabile le importazioni di frushymento per evitare che stocks invendutigrave potessero turbare )a collocaziolle dei grani tershyrieri ileI nuovo anno agrario (GUENZI 1981 153)
In tutti i centri comunque la tendenza a ritardare la vendita del surplus nei mesi della saldatura lutilizzo di depositi specializzati con personale addetto alla custodia al conshydizionamento e alla commercializzazione del prodotto ponevano i grandi proprietari di biade su un gradino superiore e diverso rispetto al resto della cittagrave Laccantonamento di grani per questa cupola di possessori rispondeva al principio dellutilitagrave soggettiva atshytesa e richiedeva sia capitale fisso sia capitale circolante per raggiungere gli scopipreshyfissati un profitto speculativo la valorizzazione della rendita
In molte cittagrave i possessori non avrebbero dovuto trattenere in casa piagrave grano e farina di quantoprescritto dalla legge cioegrave il consumo mensile per bocca ~- fissato anchesshy
so statutariamente --per arrivare al nuovo raccolto Ma i cittadini credevano veramenshyte ai loro comandamenti Egrave lecito dubitare La norma era scogravelpitagrave negli Statuti e pubshyblicamente violatamiddot con la complicitagrave dccedillle autoritagrave e dei gruppi professionali interessati alla distribuzione del grano nelle sue varie forme
Nelle annate ordinarie la quota di grano autoconsumato - cioegrave non acquistata sul mercato - nelle cittagrave italiane dell evo moderno rappresentava fra il 30 e i160 per censhyto del fabbisogno urbano di frumento
Nella capitale dei Gonzaga nel 1615 si valutava che su 27000 bocche
il terzo [di] gentilhuomini ligravettadri servitori et altri [ ] non comprano biada et gli duoi terzi tra poveri artisti mercanti fomari fondachieri hebrei et altri [ l non possono in tutto levar sufficientemente la $omma de detti dua terzi sl che saranno boshyche 18000 che compraranno biada (CoRRlTORB 2000 126)
AVenezia a cavaliere fra XVI e xvn secoioalla mensa delle casade si dispensava circa un terzo del frumento consumato ordinariamente in cittagrave (AYMARD 1966 74 MArroZZI 1983 281) A Bologna per tutto il Seicento i fornai che impastavano farine in conto lavorazione per i particolari pareggiavano piil o meno il numero di quelli da scaifa che smerciavano pane venale (GUBNZI 1982 27) Peraltro la proporzione a Rialto tra chi lavorava per le casade e chi vendeva pane al pubblico - 65 fOf7lri a fronte di 44-48 pistori negli anni 1583-1685 (DELLA VAUNTINA 1992 143-4167 192-3) - fa ritenere la struttura del mercato del pane felsinea non molto dissimile da quella veneziana Nelle cittagrave liguri o toscane sei-settecentesche la porzione autoconshysumata quando il raccolto era buono era anche piil elevata (ORENOI 1986 1024-6 1034 PuLT QUAGLIA 1984 98-104 PULT QUAOLIA 1990 171-2) A Napoli nel 1758 a Monasteri Luoghi pii e Particolari eta riservato il 28 per cento del consumo cittadishyno di frumento (AuFANO 1996 370)
Lelevato numero di servi domestici persone al servizio delle casate faceva si che in alcuni palazzi si concentrassero masse cospicue di grano per la spesa familiare Ma accanto ad esse gli operatori dellannona -lastessapovertagrave __ si auguravano che vi fosse sempre anche la materia per rifornire il mercato e i forni cittadini nella fase piil delicata del ciclo annuale il periodo di saldatura dei raccolti Come spiegare altrimenshyti la norma che imponeva ai grossi detentori digrave biade (non esclusi enti e opere piegrave) in varie cittagrave italiane dellevo moderno la vendita straordinaria in primavera delle ecshyredenze ammassate in granaio (per Pisa e la Toscana v PuLT QUAGLIA 1984 88-9)
A Mantova nel 1554 si stabiliva che i patroni che avessero fruito in cittagrave di piugrave di 20 sacchi di grano come porzione dominicale avrebbero dovuto conservare in granaio
lA costituzione di SC0114 granarie pubbliche e la politica economica degli stati
il 4 per cento per le necessitagrave dei consumatori dei fornai e dei fontachieri quando fosse mancato il prodotto sulla piazza o nelle offerte deimiddotsensati Nel 1603 ci si preocshycupograve di elevare la quota al 6 per cento (CoRRlTORE 2000 237n) Beninteso le vendite sarebbero avvenute ai valori di mercato 10 stessa sistema vigeva a Cremona (6 per cento nel 1608 e nel 1612) (MERON 1957 -59n 63 JACOPETl11965 128) ea Verona Qui una delibera consiliare del 1549 autoruzava per la prima volta
[i] deputati [alle Biade) [al tassar e comandar con quelle pene che al Clarissimo Podestagrave pareragrave quella quantitagrave di biade a ciascuno secolare o eclesiastico sia di qual grado o condittione esser si voglia che havesse biade in questa cittagrave oltre il viver suo (VBCClI1ATO 1979 145)
La tassa sarebbe stata stabilita - dal 1558 - per sorteggio fra le casate che avessero introdotto in cittagrave dai propri possedimenti piagrave di 70 minali per rifornire il Mercato delle biave Essaveane anche incrementata nella stessa occasione dal 5 al6 per censhyto per restare in vigore fino al 1631 (VECCHIATO 1979 141-58)
Questccedil tijlo di normativa nasce e si affuia in ambito amministrativo perciograve echeggia la realtagrave molto meglio della veneranda legge generale
Da tali disposizioni si deducono alcuni fatti incontrovertibili 1entro la cerchia cittadina esistevano scorte private eccedenti la spesa delle famiglie
in violazione in molti casi della legge statutaria 2il possesso della terra che solo assicurava lautarchia delle casate era il piugravemiddotpotente
fattore di discriminazione fra i cives tanto da precipitare nel girone dei pauperes la moltitudine che acquistava correntemente la sussistenza nellarea urbana
3fra gli stessi possidenti cittadini esisteva uneacutelite che non solo conservava scorte oltre il viver suo ma che si proponeva egoisticamente di speculare ritardando limshymissione dei grani sulle piazze cittadine o che a~endeva il momento piagrave opportuno per smerciarli allesterno nelle grandi piazze frumentarie come Uvorno Desenzashyno Legnago Romano di Lombardia) ecc
4lineguaglianza fra i cives tese ad aggravarsi con la metagrave del 500 poicheacute questi reshygolamenti innovano quasi sempre disposizioni generali risalenti al tardo Medioevo che sancivano lobbligo di convogliare il surplus sulla piazza cittadina segno di una distribuzione del reddito originariamente meno sbilanciata shyACremona gli Statuti del 1388 obbligavano - cosl egrave ancora nel 1510 - a vendere il
sovrappigraveagrave in Piazza Maggiore sul mercato pubblico dei grani (MERON 1957 59n 63)
A Pisa il rescritto che imponeva di effettuare le vendite al minuto in platea bladi risale al 1401 (MALANIMA 1976 293) lobbligo era ribadito ancora nel 1548 ma nella seconda metagrave del secolo XVI si affermava la pratica di vendere fuori mercato tanto che nel 1581 il Magistrato dei Nove dovette intervenire per far vendere i grani delle comunitagrave degli enti e dei luoghi pii soltanto da marzo-aprile in piccole quantitagrave sul mercato (PULT QUAGLIA 1984 8191) La disposizione per altro si applicava allinteshyro Stato (PULT QUAGLIA 1984 88)
Tuttavia non egrave da pensare che il principio della concentrazione delle compravendite sulla piazza di mercato cittadina fosse universale universalmente rispettato e sopratshytutto perenne La centralizzazione del grano non significa automaticamente lobbligo di vendita diretta sulla Piazza deiformenti Affermare come Steven L Kaplan che
There was no single more important regulation conceming the provisioning trade han the requirement that ali transactions occur in the marketplace (KAPuN 1984 27)
493 496 Renw P Corritore
appare altrettanto astratto dogmatico O virtuale del principio di mercato (Market Principle) che il medesimo gli contrappone Henri Pirenne parlando della politica annonaria dei comuni medievali avverte Lapplicazione del principio della vendita diretta ebbe numerosi eccezioni (PIRENNE [1933] 193n)
Nel caso di Mantova la scelta della Piazza egrave facoltativa per i terrieri con eccedenze GliStatuti signorili che si rifanno largamente alle raccolte statutarie comunali non sancivano alcun obbligo in proposito (v SYJI1l BONACOLSlANI [1313] libro ID rubr 55 De mercato blave 253 STATUTI GoNZAOHESCHI [1404] libro m rubr 93 De mercato blave fiendo in civitate Mantue f 73v) Decreti di carattere straordinario e regolamenshytazioni transitorie correggevano il tiro Nel 1405 in piena saldatura dei raccolti si coshystrinse a rifornire forzosamen~e la piazza concentrandovi tutte le contrattazioni Nel 1417 si obbligograve a riservare al mercato un terzo del frumento introdotto in cittagrave (CoRRIshyTORE 2000 235-6) Ma sono atti straordinari che non sopravvissero nel migliore dei casi piugrave di qualchelustro (MANToVA 1430 88 90 181) A Mantova la Piazza era affianshycata da un granaio pubblico la Domus del mercato (altrove definito Fornico o Fontego del mercato) in cui avrebbero dovuto prolungarsi le contrattazioni oltre lorario e i giorshyni deputati (venerdl o sabato) rendendo disponibile ciograve che restava invenduto e che non poteva essere ritirato per legge dal mercato Nel 1430 eminenti cittadini sollecitati dal principe lamentavano pero lincapacitagrave del magazzino - inoperoso in tutto o in ~per il pericolo di crolli - di rispondere ai bisogni del popolo in una situazione in cui da parte dei possessori si protestava la difficoltagrave di non poter esitare e smerciare fuori delshyla cittagrave le eccedenze conservate nei solari privati
ltem videtur quod valde utille foret civibus Mantue habentibus possessiones et quishybuscumque alijs personis de civitate Mantue aut districtu colligantibus bIada et vina in magna copia ut amni tempore ipsa bIada et vinum possent exttahere de civitate et dishystrictu Mantue et conducere ad Iaea ad que et in quibus illa vendere poterunt cum otdigraveshynibus et dacijs competentibus ipsa tamen civitate semper remanente fulta pro usu diete civitatis et populi eiusdem ne dicta bIada mateeschant super granariis ut hactenus fecemiddot runt cum maximo incomodo ipsorum civium (MANToVA 1430 177-8)
Il medesimo fondaco abbinato al mercato operava a Verona a Ferrara a Venezia a Udine a Chioggia in molte altre cittagrave (MANToVA 1430 100 FORNASIN 1999 7-9 CBshySTARl1794)
Lintegrale e pedissequa applicazione del principio della piazza di mercato comporshytava - per i vincoli tecnici dell etagrave pre-industriale -la massima affermazione del prinshycipio della canova cioegrave del magazzino pubblico centrale Unico argine alla sua invashydenza era costituito da una distribuzione perequata ab imis del raccolto cioegrave la possibilitagrave egrave questo il paradosso di realizzare da parte dei produttori la massima aspirazione nelle societagrave tradizionali lautarchia domestica Piugrave avanzava invecela sperequazione nel reddito e nel patrimonio piugrave da parte dei consumatori privi di scorshyte si impetrava il principio del Magazzino pubblico nella forma di un efficiente sisteshyma di ricovero conservazione distribuzione delle derrate a garanzia del funzionashymento della Piazza di mercato La disponibilitagrave di crescenti quote di raccolto tuttavia indirizzava i piugrave accomodati verso soluzioni piugrave ghiotte la vendita allingrosso sul mercato cittadino ai fornai o allimpresa pubblica creata a sussidio di questi (o in loro vece) Oppure allopposto lesito delle eccedenze extra muros sui grandi mercatishyemporio regionali per il tramite di mercanti o agenti diretti
Il principio del magazzino pubblico centrale cioegrave laccumulazione di riserve per lo smercio continuo o anticiclico egrave quindi alla sua origine in opposizione solo apparen-
La costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
ruoli fiscali non fossero in grado di accantonare scorte Nel 1444 a Strasburgo quattro cittadini su dieci non possedevano alcuna riserva cerealicola (DIIUMBIER 1984 112)
Nelle cittagrave italiane delletagrave moderna si puograve stimare che non meno di due terzi della popolazione fosse costretta ad acquistare o consumare pane confezionato con grani e farine comperati nelle piazze nelle vie e nelle botteghe cittadine oppure ottenuti come compenso del proprio servizio nelle casate (CoRRITORE 2000 126-36 MAnoZZI 1983 27~-82) Evidentemente questa fascia di lavoratori salariati non possedevashyper definizione -- neacute scorte neacute depositi personali e nel primo caso era strettamente dipendente dal mercato urbano acquistando la sua sussistenza con frequenza non piugrave che settimaIIgraveale (essendo costretti a comprare il pane tutti i giorni alla finestra si dishyceva a Genova (GRENDI 1986 1031])
Ma anche fra i citUutini con possesso extra moenia la distribuzione delle scorte era tuttaltro che egalitaria A Prato nel 1339
A patte gli enti religiosi sette famiglie [ bull ] avevano Il disposizione piugrave di mille staia di granaglie (circa 18 tonnellate) fino a un massimo di 3500 Altri venti nuclei familiashyri avevano scorte comprese tra le SOOe le 1000 staia (PINTO 1978 129n)
A Mantova nei magazzini ducali nellultima parte del 500 erano ammassati non meno di un ottavo talora piugrave di un quarto delle riserve cittadine di grani panificabili (CORRlTORE 2000 81c6) A Pavia nel corsq dello stesso secolo e allinizio di quello successivo nei sozagraveri di una sessantina di famiglie si concentrava non meno del 40 per cento dell intera offerta cittadin8 di frumentomiddot (ZANJin 1964 70-7) Anche in questo caso egrave utile sapere che nelle cittagrave tedesche esistevano mercanti (ad Augusta Ratisboshyna Norimberga) in grado di ~sare riserve da 6 a 45 tonnellate e che a Francoshyforte nel 1488 due patrizi totalizzavano insieme un terzo delle scorte cerealicole dei particolari nella cittagrave alta (DlRLMB1ER 1984113)
Ritenere tali soggetti sprovv~duti al punto di incanevare grani con il solo scopo di esorcizzare i pericoli della clarestia egrave perlomeno riduttivo A grandi solari corrishyspondevano vaste familiae e plftore di servitori e ospiti ma tali scorte eccedevano largamente la sussistenza del D-aggiore palazzo nobiliare o patrizio senza peraltro costituire un fondo di accantofilljnento eccedente il fabbisogno della cittagrave a meno che non vi fosse la concreta possibfjitagrave di commercializzare il surplus sui mercati esteri Come nota infatti Adam Smith
a meno che leccedenza non possa essere esportata in tutte le circostanze ordinarie i coltivatori staranno molto attenti a non produrre e gli importatori a non importare mai una quantitagrave maggiore di quell~ che egrave strettamente richiesta dal consumo del mercato interno Questo mercato saragrave difficilmente sovrafornito ma saragrave in generale sottomorshynito dato che coloro che svolgono lattivitagrave per mornirlo avranno in generale il timore che la loro merce possa rimane~ invenduta (SMITH[l776] 528)
Lipotesi egrave suffragata dai cas storici conosciuti A Bologna macrodistretto serico dellevo modemoladdove gli interessi manifatturieri e mercantili avrebbero dovuto consigliare una sussistenza a b~on mercato per tenere basso il costo del lavoro le istituzioni annonarie operavano per-garantire con il calmiero delformento la monetizshyzazione della rendita granaria dei possidenti - strutturalmente incapace di coprire il fabbisogno della cittagrave - anche ~ rischio della carezza dei viveri contingentando il mercato dei grani forestieri (GupaI 1982 37-76) Di fatto
492 Renzo P COITitore
Tale disparitagrave sociale si riverberava sulla struttura del commercio cerealicolo La funzione dei piccoli commercianti di biade (granaiolibull biadaiolifarinaioli balshy
zarotti cavallanti vatlcali ecc) era infatti ancillare alla capacitagrave di affacciarsi sul nercato della fascia marginale deipossidenti con eccedenze Solo che nelle annate di abbondanza si venficavano ingorghi nell offerta di grano che deprimevano i prezzi e incentivavano i piccoli produttori a smerciare direttamente le eccedenze allindomani del raccolto nellarea urbana anche al di fuori dei luoghi deputati (MATI02ZI 1983 278281-2 300n PULr QUAGLIA 1984 86) Mentre nelle annate di penuria si contraeshyva drasticamente proprio questo segmento dellofferta (ABa [1966Jmiddot 22-4 KULA [1962J 73-4 CATrINI1984 111-23 PuIr QUAGUA 1984 88) scatenando nelle campashygne una caccia al grano-merce la cui quota piugrave consistente era detenuta dai grandi proprietari dai maggiori affittuari dai percettori di canoni diritti o rendite in grano e la cui quota residua era piugrave facilmente preda di chi occupava posizioni chiave nellasshysetto terriero nella catena dei diritti nel credito alla produzione e al consumo
Tanto la distribuZione era frammentata nelle annate di abbondanza tanto in epoc~ di penuria il commercio del grano diventava un affare di pochi In questo caso lazioshyne dei mercanti diVentava dimpiccio sul mercato interno dove la coperta si restringeshyva per i proprietari e gli imprenditori agricoli (KULA [1962] 56-61 CATl1NI 1984 114-8) - dove la necessitagrave di ricorrere al credito da parte dei piccoli possessori poneva questi nelle mani degli agenti dei proprietari dei percettoridi canoni diritti o rendite - dove i piccoli proprietari vedevano minacciata la loro stessa condizione da parte di chi controllava localInente in maniera capillare e decentrata il mercato del denaro e dei beni necessari alla riproduzione (sementi strumenti cibo) La soluzione era quelshyla di precludere amministrativamente ai sensali e ai commercianti di grani i mercati locali su istigazione dei medi possessori le cui occasioni di normale profitto agrario soffrivano un ridimensionamento e che si vedevano costretti a impegnarsi ccedilon tutte le loro forze per integrare le proprie entrate accaparrandosi le magre eccedeiiZe disponishybili nelle campagne e nei borghi rurali (PuLT QUAGLIA 1984 84-8 PULT QUAGLIA 1990 lO7-14)
TI destino dei piccoli commercianti in grano era quindi quello di occupare una posishyzione margilJale nel mercato del grano (MBlNrurr 1977 30 PINTO 1978 13 MAITOZZl 1983 277) e di operare - non solo a causa degli ordinamenti annonari - secondo una logica di corto respiro in cui non era contemplata neacute la conservazione di grani a lungo termine neacute lutilizzo di depositi piugrave che provvisori Come per i piccoli possidenti non si puograve parlare ne1loro caso della formazione e del mantenimento di scorte consistenti (MBlNREr 1988 156~7) Non tali comunque da sostenere il reddito contadino nelle stagioni ordinarie e da esercitare sul versante cittadino unefficace azione anticonshygiunturale in caso di carestia
Peraltro in cittagrave la struttura dellofferta era anche piugrave sperequata di quella che si rishyscontra nel contado Che si tratti di Prato nel 1339 (PINTO 1978 129 PINTO 1982 160n e 17In) Pavia negli anni 1539 1555 1513 1602 1603 (ZANEm 1963) o Mantova nellultima parte del secolo XVI (CORRITORE 2000 81-9) la distribuzione delle scorte fra i privati era singolarmente ineguale Lo attesta la rilevanza nellarea urbana della povertagrave cioegrave secondo una definizione coeva di coloro che non vivono di entrate ma sono necessitati ricorrere mattina e sera alle pistorie a comprare il pane per iI vitto loro e delle sue famiglie col denaro che di giomo in giomo si vanno guadagnando (MATshyTOZZI 1983 281) PUOgrave essere utile richiamare la situazione delle cittagrave tedesche nel basso Medioevo in una fase che egrave stata definita da Wilhelm Abellepoca doro degli artigiani e del lavoro salariato si puograve stimare che almeno la metagrave degli iscritti ai
lA costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli statibull middot497
te con il principio della piazza TI mercato pubblico periodico disciplinatola spiagshygiala piazza la loggia o iI recinto riservato alle contrattazioni - coesis~va confabshybriche magazzini e botteghe La stessa piazza per funzionare al meglio secondo il principio dello scambio diretto necessitava di magaZzini di supporto bull
4 LE SCORTE DEI FORNAI CITTADINI
Nellarea urbanagrave e nelle relazioni tra cittagrave e campagna operavano perograve temibili conshycorrenti dei privati possessori I fornai cittadini possedevano le competenze le strutshyture tecniche le relazioni sociali e il credito per incettagravere il prodotto per essere inforshymati tempestivamentesul mercato del grano e potenzialmente per dispensarlo con profitto in qualunque momento Il fatto che il loro operato fosse imprigionato in unarshycaica impalcatura di norme divieti obblighi che risalivano alletagrave romana che ne fashycevano in modo quasi istituzionalizzato il capro espiatorio delle tensioni fra produtshytori di grano povertagrave e autotitagrave non impedisce di affermare che tali vessatorie disposiziograveD1 trovassero la loro principale ragione dessere nella parte che essi giocashyvano di interlocutorilantagonisti dei proprietari terrieri nelladeterminazione del prezshyzo del grano sul mercato locale e nella realizzazione della rendita terriera (GUENZI 19824
35 GUENZI 1982 297) Neacutel caso di Mantova terra comucopia a partire dal 1492 si consend a zentilhomini
cittadini et qualuncho altro di comprare biade nel Dominio per approvvigionare la cittagrave di fatto si sand un diritto allincetta che mise fuori gioco i fornai a cui venne imposto di rifornirsi nei solarimiddotdei cittadini senza avere piugrave la possibilitagrave di effettuare acquisti nel contado e di ritenere a casa scorte superiori amiddotl 00 staia di frumento Lintento della disposhysizione egrave chiarissimo espresso senza reticenze dai Maestri delle Entrate che riportarono al marchese la soddisfazione dei possidenti mantovani per la riforma statutaria
tutta la Terra [cioegrave il Mantovano] ne [egravel rimasta satisfactissirna pensando che Vostra Excellenilii pretenda ali comodi et utilitagrave universagrave1e senza dampno et preuiditio suo Vero egraveche li fumari non si contentano parendoli comegrave il vero che non si poteranno ingrassar a suo modo come haqno factO per il passato et poteria achader [bulll Che venetanno adolershyse et supplicar aVosUa Signoria Perograve me egrave parso d~ene aviso per ques~ nostra et farli inteni1er Che questaterril ha solii due membri de li quali li cittadini soi se ne possono aiutashyre e valersene uno egrave il grano laltro egrave larte de la lana et quando se concedesse che li furshynari potessero comprare come hapno facto li tempi passati sana un fare benefitio acinquanshytaocto dessi et dampnificharelreslO de la republicasua quale de questo bon ordine ne receve emolumento grandissimo et se gaude in la Citagrave [percheacute] li fumari portano fuora el denaro et pretendono solo a suo benefitio (AG b 2441 lettera del 13 luglio 1492)
Egrave indubbio che il plauso della Terra fosse da attribuire piugrave alla possibilitagrave per i proshyprietari di accrescere le proprie entrate che a quella dei consumagravetori cittadini e dell arte della lana di trarre beneficio daJla disposizione Egrave significativo che la motivazione pro civitate nori accenni allesistenza di monopoli da parte dei fornai o di artificiose lievitashyzioni dei prezzi per causa lOro nloro attivismograve non egraveonfliggeva per quanto riguarda i prezzi finali della sussistenza con linteresse dei produttori cittadini E daltra parte largomentodello stomo dal metFato cittadino dei profitti incamerati dai fornai -laccushysa consueta a proposito deipistores egrave che fossero in gran parte stranieri (GUBNZl 19824
22) -- era unagiustificazione debole che appassionava piugrave chi concorreva direttamente
491 498 Renzo P Comtore
alla spartizione dei proventi derivanti dalla vendita e dal commercio del grano shylemolumento grandissimo - di chi doveva poi fruire della redistribnzione di tale ricchezza Tale norma avvantaggiava i possidenti cittadini e i gentiluomini ptivilegiashyti in grado di ottenere le tratte di esportazione Sul piano dellappropriazione essi erano in condizione di mettere fuori gioco gli altri possessori che producev~o eccedenze nel Dominio poicheacute si accresceva Igravea loro forza contrattuale e la loro capacitagrave di occUpare i canall commerciali piugrave redditizi Sul piano della commercialiZzazione gli stessi fruivashyno dello smantellamento della rete dintennediazione rappresentata dai fornai Per i rushystici significava perdere un collegamento essenZiale con la cittagrave ed essere emarginati dal mercato urbano nelle campagne o sul broletto di Mantova essi non trovarono piugrave i trashydizionali interlocutori (CORBlJ9RE 2000 228 231-2)
Nel caso di Bologna terra strutturalmente deficitaria e cittagrave dalla vocaiione manishyfatturie~ si costringeva i fornai ad acquistare formenti terrieri presso i solari privati in cittagrave proibendogligrave lincetta nel contado autorizzandoli ad acquistareformentiforeshystieri al di fuori delle mura cittadine presso i sensati da grqno solo a patto che fosseshyro stati smaltiti i grani cittadini a un prezzo talora superiore a quello dei grani dimshyportazione (GUlNZI1982A35 52-3)
Nella Toscana dei Medici il diritto allincetta nel contado venne concesso ai fornai in periodo di bassa congiuntura (in particolare dagli anni Trenta del Seicegravento)Per sostenere i prezzi interni in tal caso essi restavano gli interlocutori principali dei granshydi proprietari semplicemente spostando la loro principale fonte di approvvigionashymento dai solari dei particolari in cittagrave ai granai decentrati delle grandi aziende agrishycole oppure ai mercati rurali su cui affluiva la produzione cerealicola delle grandi fattorie (PuLT QUAOUA 1984 86-9 PuLTQUAOUA 1990 100 106-7)
Laddove non vi egrave come invece succede a Genova una diretta ingerenza del potere pubblico nella vita della corporazione (MAsSA 1999) i fumai di cittagrave - nonostante i lacci e lacciuoli normativi e il lavoro prevalentePlente manuale svolto neiloro laboshyratori - erano dei veri imprenditori dipendenti per il loro profitto - noininalmente stabilito per legge - dalla produttivitagrave del lavoro e dalla dotazione tecnica e finanziaria delle imprese Di ciograve fa fede la grande sperequazione esistente fra le aziende speciashylizzate nena fabbricazione del pane venale in cittagrave (AYMARD 1966 75 VECCHltltJQ 1979 82-3 GUlNZI1982 77 segg PuLT QUAOUA 1984 100 102-3) NellItalia delshyletagrave moderna questi artigiani-imprenditori della filiera del grano trattavano insieme
afarinaifarinaiolifarinottifondachierifontechierifidelariformentinari lasagneshyri maccaronari torallari vermicellari ecc fra il 40 e il 70 per cento del frumento consumato in Cittagrave nelle annate normali (CoRRJTORE 2000 126 segg) e ~ino al 100 per cento nelle annate di carestia (Puu QUAOUA 1984 98-9)
In una ricognizione delle asimmetrie informative del mercato non cegrave gruppo quale i fornai che possa integraverpretare la parte dell agente economico onnisciente Se dunque i regolamenti annonari tendevano a regolare minuziogravesamente la collocazione il volushyme e la durata delle loro scorte cosi come disponevano per gli altri artigiani della fishyliera era per neutralizzare il carattere potenzialmente eversivo di tale accantonamenshyto per i proprietari-venditori Prima ancora che per i consumatori-acquirenti n livello delle scorte rinforzava o attenuava il rischio di monopsonio da parte dei pistores piugrave potenti e facoltosi cosigrave come eventuali tentazioni da parte della categoria di esercitare un dominio egoistico sul mercato del pane (MAITOZZl1983 298)
Sarebbe quindi un errore concepire le scorte dei fornai come entropica allocazione di capitale che sconta lincertezza futura esse venivano gestite secondo criteri di rashyzionalitagrave economica e secondo la migliore efficienza tecnica nonostante i vincoli imposti alla lievitazione degli stock dalle disposizioni annonarie
lA costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
vimini paglia o canne intrecciate (come ceste stuoiecannizzi) in terracotta (addirittura anfore) piuttosto che di tessuto (i sacchi costavano troppo) (PICCINNl1976 397 MAzzA RAvEGol 1983 174-5 Zoo Toce 1990 893-4 COIiITONES11991 35n-36n)
Nella casa del piccolo produttore o del titolare di un piccolo possesso il penw (la scorta domestica) difficilmente eccedeva il consumo famigliare chi fortunato raccoshyglieva piugrave dell annona famigliare e di quanto gli serviva per il campo era spinto a venderselo nei mesi immediatamente successivi alla mietitura e alla trebbiatura per necessitagrave di denaro ma anche per la difficoltagrave di stoccare e conservare il prodotto in condizioni ottimali (MEuvRET 1988 17-9 PuLT QUAOUA 1984 88) e figravenanco per ridurre il rischio di vederselo soffiare da vagabondi e malintenzionati In questo caso in presenshyza di eccedenze (ma probabilmente anche in assenza) il bisogno di liquiditagrave e lalea cospiravano nel ridl1ITe ai minimi termini le scorte giagrave allindomani del raccolto In caso alternativo il contadino che non egrave - ripete Jean Meuvret - un homme daffaires quanshyto un homme de peur concepiva la sua riserva come un fondo di previdenza sul racshycolto futuro da non immettere sul mercato se non nel caso dellapprossimarsi di una messe sicura secondo una logica economica a contrario (MEUVRET 1988 19 e 147)
Era Jl~tente la disparitagrave fra i produttori non solo fra chi era in possesso di eccedenshyze e chi non lo era ma piugrave anqgtra fra chi poteva scegliere in virtugrave di una maggiore capienza economica e unadeguata dotazione tecnica - il mercato piugrave favorevole per i propri grani (il periodo di saldatura dei raccolti) e chi invece li cedeva troppo presto o in controtempo a livelli non ottimali
Nella gerarchia delle abitazioni rurali -- in quel vero e proprio saggio di sociologia che egrave il sesto libro del DeArchitectura di Sebastiano Serlio (scritto fra il 1537 eil 1555 inedito per tutto levo moderno) -- per trovare case attrezzate di granaio occorshyreva ascendere sino alla magione del basso mercante o cittadino fuori della cittagrave (SERLlO 1994 43 segg anche per le successive informazioni) Condizione di cui non potevano fregiarsi invece i ricchi contadini in ~essuno dei tre gradi possibili di ricshychezza al massimo la loro casa poteva essere attrezzata di portici per ricoverare le biade e di unaia per batterle segni di distinzione giagrave fra i mediocri contadini Fra questi perograve avrebbero potuto avvalersene soltanto i fortUIgravelati et di beni et di famishyglia (3deg grado di mediocritagrave) nforno per cuocere il pane e una cantina per conservashyre il vino invece li si sarebbe trovati a partire dai piugrave accomodati fra i poveri contashydini cioegrave al 4deg gradino della scala sociale alla cui base erano da collocare i poveri mendichi con vii capanna (10 grado di povertagrave) i salariati che vivevano delle [loro] fatiche avendo un puoco di terreno (2deg grado di povertagrave) i poveri con qualche beshystiuola et massimamente de buOvi possessori di una stalletta congiunta con la casa 0deg grado di povertagrave)
In sintesi nelle campagne delletagrave pre-industriale pochi avevano scorte pochissimi erano in grado di ricoverarle in un solaro privilegiatissimo chi le incanevava per speculare Dunquefra i conta4ini se si esclude quanto celato nella madia o nella dishyspensa le scorte erano un pri~ilegio di pochi nSerlio nato intorno al 1475 insiste sullimpoverimento delle class~ rurali intervenuto fra gli anni della sua giovinezza e quelli della vecchiezza in cui scrive Sotto il titolo Dellabitazione del ricco contadishyno per tre gradi di ricchezza si preoccupa di puntualizzare
bencheacute al di dogi non se n~ truovi piugrave de tali merceacute delle discordie et di gli animi fieri et ostinati alla vendetta onde per tal cagioni et per le continue guerre et anche pei citadini divoratori de gli altrui beni che con le usure con glinganni con le rapine gli bano impoveriti (SERUO 1994 ~8)
490 RellOP CorrilOle
colto (agosto-settembre-ottobre) e invia di esaurimento almomento della saldatura dei raccolti (aprile-maggio-giugno )1A questo proposito nota Franccedilois Sigaut
Le stockage agrave court terme (moins dune campagne) reacutepond agrave la neacuteCessiteacute cIeacute concilier une offre variable et une demande constante mais toutes deux reacutegulieacuteres et preacutevisibles dans la
pratique il est consideacutereacute comme tiiisant pame du processus ordinaire de la production et ne pose agrave ce titre que desproblegravernes doptimisation assez simples (SlOAUI 1985 602)
La discussione generale sulla razionalitagrave economica delle scorte alimentari in etagrave pre-industriale puograve allora essere ridotta alla fonnulaiione e allo scioglimento di due
semplici quesiti 1 Accertato che laccantonamento digram per la periodicitagrave annuale del ciclo agricoshy
lo epet i vincoli tecnici di un rifomimento spazialmente allargato egrave inevitabile chi egrave conveniente che conservi le scorte chi produce o chi commercia il contadino o il mercante lapossidenzagrave o il popolo i particolari o il pubblico E qual egrave la realtagrave effettiva
2 Se le forme di distribUzione economicamente razionale sono plurali in quale conshytesto e in omaggio a quali interessi piugrave utile il sistema della canova rispetto al sistema delll piazza del mercato e dei solari privati
3 SULLADISTRIBUZIONE DEL GRANO NELUETAgrave PRE-INDUSTRIALE E LA STRUTTURA DELLE SCORTE NEI TERRITORI ITALIANI
Raramente le case contadine erano dotate di attrezzature per la conservazione dei cereali piugrave che elementari Nelle campagne toscane del Quattrocento dunquein unetagrave favorevole al reddito contadino in una regione fra le piugrave ricche dellEuropa pre-indushystriale
pochissime case contadine disponevano del granaio vero e proprio alcune avevano una cella che poteva servire allo stesso scopo ma la maggior parte di quelle abitazioni era priva di spazi destinabili esclugravesivamente alla conservazione dei cereali Perciograve i contenitori dei grani arche casse sacchi bugnole - dovevano trovare posto nelle cucine o nelle camere CMA= RAVEGGI 1983 174)
Le ridotte capacitagrave patrimoniali e reddituali della grande maggioranza dei produttori facevano sIgrave che fosse ampiamente invalso nella conservazione domestica dei grani limshypiego di contenitori in legno (come arche casse botti bugnole tini tinelle corbelli)in
Riguardo ai passi evidenziati di Zanetti e Cipolla egrave neCessario osservare che la principale atteshystazione sullesistenza di stock detenuti da privati che esorbitassero ilfabbisognostagionale tali da essere classificati come immobili=zione di ricchezza (Zanetti) o come beni capitale (Cipolla) a unanalisi piugrave fine si rivela fallace o non direttamente utilizzabile La propalazione dei grani effetshytuata a Pavia fra ilimiddot e il5 maggio 1555 che egrave il fondamento di entrambi i giudizinon mostra una somma di derrate realmente eccedente il fabbisogno delle famiglie per il periodo che manca allarri_ vo dei grani novelli sulla piazza pavese Daltra parte lastessa natura dellistituto della propalazioshyne dei grani cioegrave della denljncia obbligatoria delle scorte da parte dei particolari una misura demergenza decisa in momenti critici dellapprovvigionamento cittadino affiancata quellanno dalshylispezione diretta presso le case dei privati da parte di deputati straordinari avrebbe dovuto consishygliare una maggiore cautela nella sua utilizzazione per individuare regolaritagrave di carattere generale delleconomia pre-industriale
499 La costituzione di scorte granarie pubbliche e la ptlitica ecoMmica degli stati
FONTI
ABEL [1966) W ABEL Agrarkrisen undAgra~kJJnjunktur Eine Geschichte der londshy und Erniihrungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter Hamburg
und Berlin Paul Parey 19662 (la ed -1935 trad it Congiuntura agraria e crisi agrarie Storia dellagricoltura e della produzione alimentare nellEuropa centrashyle dal XIII secolo alletagrave industriale Torino Einaudi 1976 da cui si cita)
AG ARCHIVIO GoNZAGA presso lArchivio di Stato di Mantova AuFANO 1996 E AuFANO Il grano il pane e la politica annonaria a Napoli nel Setshy
tecento Napoli ESI 1996bull AYMARO 1966 M A YMARO Wmise Raguse et le commerce du bMpendant la seconde
moitieacute du XVI siegravecle Pans SEVPEN 1966 CATIINI 1984 M CATl1NI I contadini di San Felice Metamorfosi di un mondo rurale
nellEmilia delletagrave modernIgravel Torino Einaudi 1984 CESTARl 1794 p CESTARI Saggio storico dei Fondachi delle farine di Chioggia e
Pellestrina Venezia A Zatta 1794 CIPOllAJ1965] C M CIPOllA La politica economica dei governi V La penisola
italigraveana e la penisola iberica in Storia economica Cambridge m La cittagrave e la politica economica nel Medioevo Torino Einaudi 1977 (Cambridge 1965) pp 462-496
CIPollA 1974 C M CIPollA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna nMulino 1974
CIpollA 1997 C M CIPOllA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna nMUlino 1997 (6 ed riveduta)
CORRITORE 2000 R P CoRRITORE La naturale abbondanza del Montovano Produshyzione mercato e c01isumi granari a Mantova in etagrave moderna Pavia Universitagrave di Pavia 2000
CORIONBSI 1991 A CORIONBSI Sulla conservazione dei cereali nellItagravelia medioevale Lavoro e tecniche nelle tesnmonlanze laziali (secc XIII-XV) in Rivista di storia dellagricoltura XXXI 1991 l pp 33-49
DELLA VALENTINA 1992 M DELLA VALENTINA I mestieri del pane a ~nezia tra 600 e 700 in Atti dellIstituto [Veneto di Scienze Lettere ed Arti Classe di scienze morali lettere ed arti CL 1991-92 pp 113-217
DIRLMEIER 1984 U DIRLMEIER le condizioni materiali dellesistenza nelle cittagrave tedeshy sche del Basso Medioevo ~iente esterno reddito consumi in Aristocrazia citshy
tadina e ceti popolari nel tprdo Medioevo in Italia e in Germania (a cura di Reinhard Elze e Gina Fasoli) Bologna Societagrave editrice il Mulino 1984 pp 79shy122
FORNASIN 1999 A FORNASIN Il pzercatodei grani di Udine Indagine per una storia dei prew in Friuli (secoli XfI-XVIII) Nota di ricerca del Dipartimento di Scienshyze Statistiche dellUniversit4 degli Studi di Udine 4 1999 pp 1-24 ora in lo La Patria del Friuli in etagrave 1fIOderna Saggi di storia economica Udine Forum 2000 pp 33-60
GRENDI 1986 E GRENOI Lapprccedilwigionamento dei grani nella Liguria del Seicento libera pratica e annone in iMiscellanea storica ligure Studi in onore di Luigi Bulferetti XVIII 1986 2Jp 1021-1047
GUENZI 1981 A GUENZI Ilfrurnfnto e la cittagrave il caso di Bologna nelletagrave moderna in Quaderni storici XVI ~981 46 pp 153-167
GUENZI 1982 A GUENZI Pane ~fornai a Bologna in etagrave moderna Venezia Marsilio 1982
I
489 500 Renzo P CornIOle
GUBNZI1982 A GUEml Sistema annonario e egraveontrollo sociale a Bologna nei seccediloli XVII e XVIII in E SORI (a cura di) Cittagrave e controllo sociale in Italia fra XVIII e XIX secolo Milano F Angeli 1982 pp 293-306
HICKS [1989] 1 R HIClCS A narlcet theory of money Oxford Oxford Universigravety Press 1989 (trad it Una teoria di mercato della monefa Bologna li Mulino 1992 da cui sigrave cita)
JACOPBITI 1965 N L JACOPBITI Monete e prezzi a Cremona dal XVI al XVlIi secolo Cremona Athenaeum CregravemoneJlSe 1965
KAPLAN 1984S L KAPLAN Provisioning Paris Merchants and Millers in the Grain and Flour Trade during the Eighteenth Century Ithaca-London Cornell Univershysity Press 1984~middot
KULA [1962] W KULA Teoria ekonomiczna ustrojufeudalnego Proba modelu Warshyszawa-Panstwowe WydawnictwoNaukowe 1962 (trad it Teoriagrave economica del sistema feudale Proposta di un modello Tormo EinaUdi 1972 ccedilla cui si cita)
WROUSSE [1933] C-E LABRoussE Esquisse du mouvement des prix et des reverws en France au XVIII siegravecle Paris Eacuteditions des Archives Contemporaines 19842 volI (l ed Paris Librairie Dalloz 1933)
MALANtMA 1976 P MALANiMA Aspetti di mercato e prezzi del grano e della segalea Pisa dal 1548 al 1818 in Ricerche di storia moderna vaL I Pisa Pacini 1976 pp ~n
MANToVA 1430 MwroVA 1430 Pareri a Gian Francesco Gonaga per il governo (a cura di M AQrignaniA M Lorenzoni A Mortari C Mozzarelli) MUltova G~ Arcari 1990
MASSA 1999 PMAssA Annona e corporazioni del settore alimentare ~ Genova orshyganizzazione e conflittualitagrave (XVI-XVIII secolo) in A GUENZI PMAssA A MOIOshyu (a cura di) Corporazioni e gruppi professionali nellItalia moderna MilIllO F Angeli 1999 pp 390-403
MATIoZ7J 1983 1 MiJroZ7J F BOLELLI C CmAsBRA D SABBIONI Il politico e il pane a Venezia (157Q-1650) calmieri e governo della sussistenza in Societagrave e storia VI 198320 pp 271-303
MAzzI RAVEOOI 1983 M T MAzzI S RAVEOGI Gli uogravemini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento Firenze Olscbki 1983
MERONI 1957 U MERONI Cremona fedelissima Ciemona Athenaeum Cremonenshy~~~ _
MBUVRBl 1977 J MEuVRsT Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque LouisXIvI La productiograven des ceacutereacuteales dans la France du XVII et du XVIII siegravecle Paris Mouton -EacuteEHSS19772voll
MBUVRET 1988 J MBtJVRf Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque Louis XIv III Le commerce des gralns et la conjoncture Paris EacuteEHss 1988 2 volI
PtCClNNI 1976 G PtCClNNl Wta contagravedina in una capanna dei dintorni di Siena (1250) in ~Archeologia medievale m 1976 pp 395-399
PlNIO 1978 G PINTOII Libro del BiaPaiolo Carestie e annona a Firenze dalla metagrave del 200 al 1348 Fire~ Olscbki 1978
PiNTO 1982 G PtNro La Toscana nel tardo Medioevo Ambiente economia rurale societagrave Fllenze Sansoni 1982
PtRENNE [1933J H PIRENNB La civilisation occidentale au Moyen Age du XIe au mishylieu du XVe siegravecle Paris PUF 1933 (trad it Storia economica e sociale del Meshydioevo Milano Garzanti 1967 da cui si cita)
Lacostituticne di scorte granarie pubbliche e la politica economiegravea degli stati
redigravestribuzione sostenibile dei beni di sussistenza egrave ricercata in questo cielo da quegli stessi particolari che ~amaldeggiano nella produzione negli scambi nei consumi e che costituiscono il nerbo della classe di governo Le scorte pubbliche rappresenteshyrebbero in questa prospettiva un presidio civico e un risltCimento politico e morale ai cOl1ponenti della comunitagrave spossessati delbene supremo dellautarchia alimentare
Resta infine latente unidea del magazzmo pubblico come quasi-mercato cioegrave come luogo volto (1) a risolvere i fa1limentiinfo~vi della piazza del mercato (in meacuterito alle disponi~ilitagrave alle caratteristiche del prodotto alle condizioni di vendita della merce) (2) a ridimensionare lalea per agricoltori consumatori poveri artigiani del comparto alimentare (3) a sostenere i consumi e i profitti privati m funzione anticicli ca in una prospettiva Ilpn meram~nte congiunturale Si tratta in questo caso di un orshyganizzaZionepienattiCnte razio~e Che non opera in maniera saltuaria e riflessa ma in modo continuativo secondo obifttili prefissati di allocazione dei beni primari li funshyzionamento dellacanovagrave (il magazzino pubblico) si porrebbe come strumento inteshygrativo ma no~~igraventeramente so~titutivo delloperare della piazza Si tratterebbe di unaforma di mercato distinta dalla p~ del mercato considerata in seacute e per seacute cosigrave come dallegraveOOmpravendite effetttlate nei solari privati o dalla mera centrallzzazione e redistribuzione di derrate con fi~alitagrave umanitarie La canova rappresenterebbe in tal modo uno dei possibili meccaoi~ di governo delle trllls3ZIgrave~ni locali per risolvere i problemi deUapprovvigionameIto senza intaccare certi interessi di classe (dei proshyprietari ma anche del popolo grasso) S da essere prescelta da autoritagrave e gruppi domishynanti come struttura complementare della piazza del mercato incerti contestiprodutshytivi ed economici La suasacrilizzazione perciograve non esclude la possibilitagrave di un ritorno alle sole compravendite qella piazza e dei solari privati - una volta invertishytosi il trend o spirate le condizioqi economiche della sua istituzionalizzazione
La problematizzazione esorc~ una liquidazione semplicistica del problema delle scorte gran8rle in etagrave pre-industriUgravee nel nome di una loro presunta irrazionalitagrave eco- nomica per il compito di assi~ la sussistenza della popolazione
Le pagine che segUono sono rintroduzione a un lavoro in corso volto a offrire un interpretazione generale di tal~ capitolo fondamentale della politica economica dei governi
in
etagrave pre-industriale
2 SE UN MONDO SENZA SCORTE Egrave INCONGRUO cm Egrave OPPORTUNO CHE LEgrave DETENGA
Nei fatti nel settore granarlo CQni vincoli dell etagrave pre-industriale in tema diprodutshytivitagrave energia trasporti non ha s~nso ipotizzare un mondo senza scorte Se il mercato del grano egrave - come nellEuropa medievale e moderna - un sjstema tendenzialmente chiuso
ad ogni raccolto nuove offe~ aniv(erannol sul mercato mentre la domanda si mant[erragrave] relativamente costantt nel corso dellanno Qualcuno dunque [dovragrave] ~ere delle scorte che saranno elevate ~ubito dopo il raccolto e poi via via minori fino aragshygiungere un livello minimo in prpssimitagrave del successivo raccolto (HICICS [19891 31)
Nella loro forma piugrave sempliceI tali scorte saranno legate allora alla periodi~itagrave anshynuale del ciclo agricolo (che a1iplenta il movimento stagionale dei prezzi ccedilfr LAshyBROlJSSE [1933] 157-66) il loro livello saragrave elevato allindomani del principiLle racshy
501 488 Renzo P Corritore
povero ammassograve nella propria dimora scorte di grano carne ~alata sale candele ecc e la medesima cosa fece lo Stato Nel periodo feudale non venne mai meno nel castello del signore labitudine di tenere da parte grosse scorte per i periodi di emergenza Sucshycessivamente le autoritagrave comunali predisposero il magazzinaggio di grosse derrate specie di grano da rivendere a basso prezzo in periodi di emergenza e nello stesso tempo si preoccuparono di prevenire un indebito accumulo di scorte da parte di specushylatori privati Nelle economie medievali gli stock di derrate di prima necessitagrave rappreshysentarono pertanto una delle piugrave importanti forme di investimento pubblico e privato (CIPOLLA (1965] 468)
Nella prima versione del manualeacute invece fino allinserimento nel 1997 del nuovo capitolo dedicato alla politica economica nell etagrave pre-mdustriale il punto di vista preshyvalente era quello microeconomico entro il perimetro stretto dellindividualismo meshytodologico
Le scorte costano e costano doppiamente Esse implicano il costo diretto che egrave rapshypresentato dal costo del magazzinaggio edal deterioramento eventuale del pr04otto o di parte di esso Se luomo daffari finanzia la costituzione delle scorte con danaro preso a prestito il costo diretto include anche il tasso di interesse pagato Se luomo daffari finanzia con capitale proprio la costituzione delle scorte il costo delle scorte deve inshycludere un costo-opportunitagrave e cioegrave il mancato rendimento (tIllU1cato tasso dinteresse attivo) del capitale finanziario impiegato (CIPOLLA 1974 154)
Le ragioni della costituzione e del mantenimento di scorte alimentari da parte delshylautoritagrave pubblica diventavano unicamente ragioni morali (umanitarie e di buona amministrazione) o di opportunitagrave politica (la fame era la piugrave frequente ligraveausa di sommosse e furori popolari) (CIPOLLA 1974 74)
Nel 1997 si riammetteva dunque linterpretazione originaria della costituzione di scorte pubbliche come strumento di riequilibrio del mercato senza peraltro rinnegare le considerazioni sulla valenza statica di tale forma di investimento per gli agenti economici privati
In merito allutilitagrave economica e al significato delle scorte in etagrave pre-industriale Cishypolla non espresse perciograve sempre lo stesso punto di vista La rassegna delle posizioni da lui assunte anzi permette di individuare tre approcci e tre giudizi costitutivamente diversi sulla funzione delle scorte granarie nellepoca pre-industriale
In prima approssimazione laccumulazione di scorte alimentari mostra il carattere fondamentalmente difensivo delle scelte degli agenti economici pubblici e privati in etagrave pre-industriale La paura la tradizione la superstizione li induce a tabuizzare il rischio la speculazione linvestimento nella produzione e nella distribuzione dei beni essenziali alla vita e ad aderire intimamente a un ideale di economia e societagrave stazionarie aggravando con la norma sociale le istituzioni il comportamento indivishyduale e collettivo leffetto dei condizionamenti materiali delleconomia pre-industriashyle (bassa produttivitagrave agricola alti costi di v~sporto modesta efficienza energetica) esponendo ancor di piugrave la comunitagrave umana ai degravemoni della natura
La seconda interpretazione rigetta luniversale imperio dellhomo oeconomicus rishyscoprendo leteronomia dei fini dellagire economico degli uomini nelletagrave pre-inshydustriale Ia politica economica dello Stato o-delle autoritagrave non persegue puri scopi economici lintegritagrave del corpo sociale fin nelle sue cellule elementari (persone e famiglie) deve essere assicurata secondo i principi e la prassi di uneconomia morale che SOVJa5ta leconomia regolata dal mercato spersonalizzata e antipopolare Una
La costituzione di scorte grantlTie pubbliche e la poligravetigraveca economica degli stati
PuLT QUAGUA 1984 A M PULT QUAGUA Mercato dei prodotti agricoli e magistratushyre annonarie a Pisa nelletagrave moderna in Ricerche di storia moderna a cura di M Mirri voI III Pisa Pacini 1984 pp 57-141
PULT QUAGLIA 1990 A M PULT QUAGLIA Per provvedere ai popoli Il sistema anshynonario nella Toscana dei Medici Firenze Olschki 1990
SERUO 1994 S SERLIO Architettura civile Libri sesto settimo e ottavo nei manoscritshyti di Monaco e Vienna (a cura di F P Fiore) Milano TI Polifi10 1994
SIGAlIT 1985 F SIGAlIT Questions deacuteconomie agrave propos des politiques ceacutereacutealiegraveres et de stockage in Les techniques de conservation des grains agrave long terme leur rale dans la dynamique des systegravemes de cultures et des socieacuteteacutes (sous la direction de M Gast F Sigaut et C Beutler avec la collaboratlon de O Bllchsenschutz) voI III 2 Paris Eacuteditionsdu CNRS 1985 pp 597-606
SMITH [1776 A SMITH An inquiry into the nature and causes ojthe wealth ojnations London W Strahanand T Cadell 17762 volI (trad it Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni Milano A Mondadori 1977 2 volI da cui
si cita) STATlITlBoNACOLSIANI [1313] STATUTI BONACOLSlANl (a cura di E Dezza A M Lorenshy
zoni M Vaini) Mantova GArcari 2002 STATUTI GONZAGHESCHI [1404] STATUTI GONZAGHESCHI presso la Biblioteca comunale di
Mantova ms FV 11 [775]VECCHIATO 1979 F VOCCHIATO Pane e politica annonaria in Terrajerma veneta tra
secolo XV e secolo XVIII (Il caso di Verona) Verona Stamperia Zendrini 1979 ZANETTI 1963 D ZANETTl Contribution agrave leacutetude des structures eacuteconomiques lapshy
provisiQnnement de Pavie au XVI siegravecle in Annales ESC XVIII 1963 1 pp 44-62 ora in lo Fra le antiche torri Scritti di storia pavese Pavia Universitagrave di Pavia 2000 pp 165-182
ZANETTl 1964 D ZANEITI Problemi alimentari di una economia preindustriale Ceshyreali a Pavia dal 1398 al 1700 Torino P Borlnghieri 1964
ZUG TUCCI 1990 H ZUG TuCCI Le derrate agricole problemi materiali e concezioni mentali della conservazione in Lambiente vegetale nellalto Medioevo XXXVII Settimana di studio del Centro italiano di studi sullalto Medioevo (30 marzo-5 aprile 1989) Spoleto Centro italiano di studi sullalto Medioevo 1990 voI n pp 865-902
501 488 Renzo P Corritore
povero ammassograve nella propria dimora scorte di grano carne salata sale candele ecc e la medesima cosa fece lo Stato Nel periodo feudale non venne mai meno nel castello del signore ]abitudine di tenere da parte grosse scorte per i periodi di emergenza Sucshycessivamente le autoritagrave comunali predisposeromiddot il magazzinaggio di grosse derrate
lt specie di grano da rivendere a basso prezzo in periodi di emergenza e nello stesso tempo si preoccuparono di prevenire un indebito accumulo di scorte da parte di specushylatori privati Nelle economie medievali gli stock di derrate di prima necessitagrave rappreshysentarono pertanto una delle piugrave importanti Jorme di investimento pubblico e privato (CipollA [1965] 468)
Nella prima versione delmanualeacute invece finograve allinserimento nel 1997 del nuovo capitolo dedicato alla politica economica neUetagrave preindusiriale il punto di vista preshyvalente era quello microeconomico entro il perimetro stregravetto dell individualismo meshytodologico
Le scorte costano e costano doppiamenie Esse implicano il costo diretto che egrave rapshypresentato dal costo del magazzinaggio e daI deterioramento-eventuale del prodotto O di parte di esso Se luomo daffari finanzia la costitiIZIgraveone delle scorte con danaro preso~a prestito il costo diretto include anche il tasso di interesse pagato Se luomo daffari finanzia con capitale proprio la costltuzione delle scorte il costo delle scorte deve inshycludere un costo-opportunitagrave e cioegrave il mancato rendimento (mancato tasso dinteresse attivo) del capitale finanziario impiegato (CIPOllA 1974 154)
Le ragioni della costituzione e del mantenimento di scorte alimentari da parte delshylautoritagrave pubblica diventavano unicamente ragioni morali (umanitarie e di buona amministrazione) o di opportunitagrave politica (la fame era la piugrave frequente ~ausa di sommosse e furori popolari) (CIPolLA 1974 74)
Nel 1997 si riammettegraveva dunque linterpretazione originaria della costituzione di scorte pubbliche come strumento di riequilibrio del mercato senza peraltro rinnegare le consideraZioni sulla valenza statica di tale forma di investimento per gli agenti economici privati
In merito allutilitagrave economica e al significato delle scorte in etagrave pre-industriale Cishypolla non espresse perciograve sempre lo stesso punto di vista La rassegna delle pogravesizioni da lui assunte anzi permette di individuare tre approcci e tre giudizi costitutivamente diversi sulla funzione delle scorte granarie nellepoca pre-indUstriale
In prima approssimazione laccumulazione di scorte alimentari mostra il carattere fondamentalmente difensivo delle scelte degli agenti economici pubblici e privati in etagrave pre-industriale La paura latradizione la superstizione li induce a tabuizzare il rischio la speculazione linvestimento nella produzione -e nella distribuzione dei beni essenziali alla vita e ad aderire intimamente a un ideale di economia e societagrave stazionarie aggravando con la nonna sociale le istituzioni il comportamento indivishyduale e collettivo leffetto dei condizionamenti materiali delleconomia pre-industriashyleacute (bassa produttivitagrave agricola alti costi di trasporto modesta efficienza energetica) esponendo ancor di piugrave la comunitagrave umana ai degravemoni della natura
La seconda interpretazione rigetta luniversale imperio dellhomo oeconomicus rishyscoprendo leteronomia dei fini dellagire economico degli uomini nelletagrave pre-inshydustriale La politica economica dello Stato o-delle autoritagrave non persegue puri scopi economici lintegritagrave del corpo sociale fin nelle sue cellule elementari (persone e famiglie) deve essere assicurata secondo i principi e la prassi di uneconomia morale che SOVlasta leconomia regolata dal mercato spersonalizzata e antipopolare Una
La costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli staIgravei
PuLT QUAGUA 1984A M PULT QUAGLiA Mercato dei prodotti agricoli e magistratushyre annonarie a Pisa nelletagrave moderna in Ricerche di storia moderna a cura di M Mirri voI m Pisa Pacini 1984 pp 57-141 lt
PULT QUAGliA 1990 A M PULT QUAGUA lt Per provvedere ai popoli Il sistema anshynonario nella Toscana dei Medici Firenze Olschki 1990
SERUO 1994 S SERilO Architettura civile Libri sesto settimo e ottavo nei manoscritshyti di Monaco e Vienna (a cura di F P Fiore) Milano TI Polifi10 1994
SIGAUT 1985 F SIGAUT Questions deacuteconomie agrave propos des politiques ceacutereacutea1iegraveres et de stockage in Les techniques de conservation des grains agrave long terme leur r6le dans la dynamique dessystegravemes de cultures et des socieacuteteacutes (sous ladirection de M Gast F Sigaut e~Beutler avec la collaboration de O Bijchsenschutz) voI m 2 Paris Eacuteditionsdu CNRS 1985 pp 597-606
SMfIH [1776] A SMITH Aninquiry into the nature andcauses ofthe wealth ofnations London W Strahanand T CadeIl 17762 voll (trad it Indagine sulla natura e le causedellagrave ricchezza delle nazioni Milano A Mondadori 1977 2 voll da cui si cita)
STAnmB(i~ACOLSIANI [1313] STATUTI BONACOLSIANI (a cura di E Dezza A M Lorenshyzoni M Vaini) Mantova G Arcari 2002
STATtm GONZAOHESCHI [1404] STATUTlGONZAGHESCHI presso la Biblioteca comunale di Mantova ms FV 11 [775]
VECCHIATO 1979 F VECCHIATOPane e-politica annonaria in Terraferma veneta tra secolo XV e secolo XVIlI (Il caso di Verona) Verona Stamperia Zendrini 1979
ZANETTI 1963 D ZANETTI Contribution agrave leacutetude des structures eacuteconomiques lapshyprovisiQnnement dePavie au XVI siegravecle in Annales ESC XVIII 1963 l pp 44-62 ora in ID Fra le antiche torri Scritti distoria pavese Pavia Universitagrave di Pavia 2000 pp 165-182
ZANETTI 1964 D ZANErn Problemi alimentari di una economia preindustriale Ceshyreali a Pavia dal 1398 al 1700 Torino PBoringhieri 1964
ZUO TuCCl 1990 H ZUG TUCCl Le derrate agriCole problemi materiali e concezioni mentali della conservazione in Lambiente vegetale nellalto Medioevo XXXVII Settimana di studio del Centro italiano di studi sullalto Medioevo (30 marzo-5 aprile 1989) Spoleto Centro italiano di studi sullalto Medioevo 1990 voI II pp 865-902
489 500 Renzo P Capitare
GUENZI 1982 A GUBNZI Sistema annonario e controllo sociale a Bologna nei secoli XVII e XVIII in E SORI (a cura di) Cittagrave e controllo sociale in Italia a XVIII e XIX secolo Milano R Angeli 1982 pp~ 293-306
HICKS [1989] J R HICKS A nwrket theory of money OxfQrd Oxford University Piess 1989 (trad itmiddot Una teoria di mercato della moneacuteta Bologna Il Mulino 1992 da cui si cita)
JACOPEn 1965 N I JACOPEITI Monete eprewa Cremona dal XVI al XVIII secolo Cremona Athenaeum Cremonense1965
KAPLAN 1984S L KAPLAN Provisioning Paris Merchaius and Millers in me Grain and Flour Trade during the Eighteenth Century Ithaca~London Cornell Univershysity Press 1984~middot
KULA [1962] W KULA Teoria ekonomiczna ustrojufeudalnego Proba modelu Warshyszawa~4nstwowe WydavnictwoNaukove 1962 (trad it Teoria economica del sistema feudale Proposta di un modello lorino EinaUdi 1972 da cui si cita)
LABROUSSB [1933] c-E LABRoussB Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIII si~cle Paris Eacuteditions des Archives Contemporaines 1984 2 voll (1 ed Paris Librairie Dalloz 1933)
MAlANIMA 1976 P MALANlMA Aspetti di mercato e prew del grano e della segale a Pisa dal 1548 al 1818 in Ricerche di storia moderna voL I Pisa Pacini 1976 pp289-327
MANTOVA 1430 MANTOVA 1430 Pareri a Gian Francesco Go~ga per il governo (a cura di M A Grignani A M Lorenzoni A Mortari C Mozzarelli) Mantova G Arcari1990
MAsSA 1999 PMAsSA AMonae corporazioni del settore alimentare ~ Genova orshyganizzazione e corflittualitagrave (XVI-XVIII secolo) in A GPJlNZI P MAsSA A MOlOshyu (a cura di) Corporazioni e gruppi professionali nellItalia moderna M4ano R Angeli 1999 pp 390403
MAnoZZI 1983 I MATroZZl R BoLEUl C CHiAsBRA D SABBIONl Il politico e il pane a Venezia (1570-1650) calmieri e governo della sussistenza in Societagrave e storia V1198320pp271-303
MAZZI RAVBOOI 1983 M T MAzzI S RAVBOOI Gli uomini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento Firenze Olscbki 1983
MERONI 1957 U MERoNI Cremonafedeiissima Cremona Athenaeum Cremonenshyse1957
MBUVRET 1977 J MBUVRm Le progravebl~me 4es subsistances agrave leacutepoque LouisXIv 1 La productiOn des ceacutereacuteales dans la France du XVIIet du XVIII si~cle Pans Mouton - EacuteEHss 1977 2 voll
MBUVRm 1988 J MBuVRET Le probl~me des subsistances agrave leacutepoque Louis XlY III Le commerce des grains et la conjoncture Pans EacuteEHss 19882 voll
PICClNNI 1976 G PICClNNl Vita contluJina in una capanna dei dintorni di Siena (1250) in Archeologia medievale JII 1976 pp 395-399
PINTO 1978 G PINTO Il libro del Biadaiolo Carestie e annona a Firenze dalla metagrave del 200 al 1348 Firenze Olschld 1978
PINTO 1982 G PINTO La Toscana nel tarda Medioevo Ambiente economia rurale societagrave Firenze Sansoni 1982
PIRENNB [1933J H PmmINB La civilisation occidentale au Moyen Age du XIe au mishyZieu du XVe si~cle Paris PUF 1933 (trad it Storia economica e sociale del Meshydioevo Milano Garzanti 1967 da cui si cita)
wcostitlJlWne di scorte granarie pubbliche e la politica economiCa degli stati
redistribuzione sostenibile dei beni di sussistenza egrave ricercata in questo cielo da quegli stessi particolari che mllI8lllaldeggiano nella produzione negli scambi nei consumi e che costituiscono il nerbo della classe di governo Le scorte pubbliche rappresenteshyrebbero in questa prospettiva un presidio civico e un ris~nto politico e morale ai componenti della comunitagrave spossessati deIbene supremo dellaUtarchia alimentare
Resta infine latente unidea del magazzmo pubblico come quasi-mercato cioegrave come luogo volto (1) a risolvere i fallimenti informativi d~lla piazza del mercato (in megraverlto alle disponihilitagrave alle caratteristiche del prodotto alle condizioni di vendita della merce) (2) a ddimensionare lalea per agricoltori consumatori poveri artigiani del comparto alimentare (3) a sosteqere i consumi e i profitti privati in funzione anticicli ca in una prospettiva I0n meramente congiunturigraveugravee Si tratta in questo caso di unorshyganizzaZionepienamente razionale che non opera in maniera saltuaria e riflessa ma in modo continuativo secondo obiettivi prefissati di allocazione dei beni primari TI funshyzionamento deJlacanovagrave (il magazzino pubblico) si porrebbe come strumento inteshygrativo ma nOliinteramente sostitutivo delloperare della piazza Si tratterebbe di unaforma ( megravercato distinta dalla pi~ del mercato considerataIn seacute e per seacute cosl come dallegraverompravendite effetttiate nei solari privati o dalla meacutera centralJzzazione e redistribuzione di derrate con fiqatitagrave umanitarie La canova rappresenterebbe in tal modo uno dei possibili mecc~ di governo delle transaziopi locali per risolvere i problCmi dellapprovv~gionameqto senza intaccare certi interessi di classe (dei proshyprietari ma anche del popolo graSso) s) da essere prescelta da autoritagrave e gruppi domishynanti come struttura complemen8Ie della piazza del mercato in certi contestiprodutshydvi ed economici La suasacnilizzazione perciograve non esclude la possibilitagrave di un ritorno alle sole compravendite qella piazza ~ e del solari privati - una volta inverti- tosi il ~nd o spirate le condizio~ economiche della sua istituzionalizzazione
La problematizzazione esorcizza una liquidazione semplicistica del problema delle scorte graUarie in etagrave pre-indus~e nel nome di-~a loro presunta irrazionalitagrave eco- nomica per il compito di assicll1~ la sussistenza della popolazione
Le middotpagine che segUono sono Vintroduzione a un lavoro in corso volto a offrire uninterpretazione generale di tal~ capitolo fondamentale della politica economica dei govemi ~ etagrave pre-industriale
2 SE UN MONDO SENZA SGORTE Egrave INCONGRUO cm Egrave OPPORTUNO CHE LE DETENGA
Nei fatti nel settore granario conI vincoli delletagrave pre-industriale in tema diprodutshytivitagrave energia trasporti non ha ~nso ipotizzare un mondo senza scorte Se il mercato del grano egrave - come nellEuropa Igravenedievale e moderna - un sistema tendenzialmente chiuso
ad ogni raccolto nuove offeXfe arriv[eranno] sul mercato men~e la domanda si mant[erragrave] relativamente costanlf nel corso dellanno Qualcuno dunque [dovragrave1 ~nere delle scorte che saranno elevate isubito dopo il raccolto e poi via via minori fino lIragshygiungere un livello minimo in prpssimitagrave del successivo raccolto (HICKS [1989] 31)
Nella loro forma piugrave semplice tali scorte saranno legate allora alla perlodi~itagrave anshynuale del ciclo agricolo (che aUfnenta il movimento stagionale dei prezzi ccedilfr LAshyBROUSSB [1933 157-66) il loro livello saragrave elevato allindomani del prlnciprue racshy
499 490 RelloP COrrilore
colto (agosto-settembre-ottob~) e in via di esaurimento almomento della saldatura dei raccolti (aprile-maggio-giugno)lA questo proposito nota Franccedilois Sigaut
Le stockage agrave court terme (moms dune campagne) Ieacutepond agrave la neacuteCessiteacute egravek concilier une offre variable et une demande constante mais toutesdeux reacutegulieacuteres et pIeacutevisibles dans la pratique il est ccedilonsideacutereacute comme tagraveisant partie du procegravessus ordigravenaire de la prOduction et ne pose agrave ce titre quedes probJegravemes doplimisation assez simples (SIGAUT 1985 602)
La discussione generale sulla razionalitagraveegraveconomica delle scorte alimentari in etagrave pre-industriale puograve allora essere ridotta alla formulaZione e allo scioglimento di due semplici quesiti 1 Accertato che laccantonamento di grani per la periodicitagrave arinuale del ciclo agricoshy
lo epel i vincoli tecnici di un rifornimento spazialmente allargatoegrave inevitabile chi egrave conveniente che conservi le scorte chi produce O chi cOnlmercia il contadino o il mercante lapossidenza o il popolo i particolari o ilpubblico E qual egrave la realtagrave effettiva
2 Se le forme di distrigravebIgravelZIgraveone economicamente razionale sono plurali in quale conshytesto - e in omaggio a quali interessi - egrave piugrave utile iI sistema della canova rispetto al sistema della piazza del mercato e dei solari privati
3 SULLADISTRlBUZIONE DEL GRANO NELLETAgrave PRE-INDUSTRlALE E LA STRUTTURA DELLE SCORTE NEI TERRITORI ITALIANI
Raramente le case contadine erano dotate di attrezzature per la conservazione dei cereali piugrave che elementari Nelle campagne toscane del Quattrocento dunqueJn unetagrave favorevole al reddito contadino in una regione fra le piugrave ricche dellEuropa pre-indushystriale
pochissime case contadine disponevano del granaio vero e proprio alcune avevano una cella che poteva servire allo stesso scopo ma la maggior parte di quelle abitazioni era priva di spazi destinabili esclusivamente alla conservazione dei cereali Perciograve i contenitori deigrani - arche casse sacchi bugnole - dovevano trovare posto nelle cucine o nelle camere (MAzzI RAvEGOI 1983 174)bull
Le ridotte capacitagrave patrimoniali e reddituali della grande matregoranza dei produttori facevano si che fosse ampiamente invalso nella conservazione domestica dei grani limshypiego di contenitori in legno (come arche casse botti bugnoletini tinelle corbelli)in
Riguardo ai passi evidenziati di Zanetti e Cipolla egrave necessario osservare che la principale atteshystazione sullesistenza di stock detenuti da privati che esorbitassero ilfabbisogno stagionale tali da essere classificati come immobilizzazione di ricchezza (Zanetti) o come beni capitale (Cipolla) a unanalisi piugrave fine si rivela fallace O non direttamente utilizzabile La propalazione dei grani effetshytuata a Pavia fra ilIo e il 5 maggio 1555 che egrave il fondaIgravenento di entrambi i giudizinon mostra una somma di derrate realmente eccedente il fabbisogno delle famigiie per il periodo che manca allarrishyvo dei grani novelligrave sulla piazza pavese Daltra partelastessa natura dellistituto della propaazio- ne dei grani cioegrave della denllncia obbligatoria delle scorte da parte dei particolari una misura demergenza decisa in momenti critici dellapprovvigionamento cittadino affiancata quellanno dalshylispezione diretta presso le case dei privati da parte di deputati straordinari avrebbe dovuto consishygliare una maggiore cautela nella sua utilizzazione per individuare regolaritagrave di carattere generaledelleconomia pre-industriale
La costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli slatibull
FONTI
ABEL [1966] W ABEL Agrarkrisen und Agrarkonjunktur Eine Oeschichte der Landshy und Ernlihrungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter Hamburg
und Berlin Paul Parey 19661 (P ed -1935 trad it Congiuntura agraria e crisi agrarie Storia dellagricoltura e della produzione alimentare nellEuropa centrashyle dalXlII secolo alletagrave industriale Torino Einaudi 1976 da cui si cita)
AG ARCHIVIO GONZAGA presso lArchivio di Stato di Mantova AuFANO 1996 E AuFANO Il grano il pane e la politica annonarla a Napoli nel Setshy
tecento Napoli ESI 1996 bull AYMARD 1966 M AYMARD Veacutenise Ragusegrave et le commerce du bleacute pendant la seconde
motti du XVI siegravecle pans SEVPEN 1966 CA1TINl1984 M CATlINl I contadini di San Felice Metamorfosi di un mondo rurale
nellEmilia delletagrave moderna Torino Einaudi 1984 CEsTARI 1794 p CESTARI Saggio storico dei Fondachi delle farine di Chioggia e
Pellestrina~ bullbull Venezia A Zatta1794 CIPOLLA [1-965] C M CIPOllA La politica economica dei governi V La penisola
italigraveana e la penisola iberic(l in Storia economica Cambridge ID La cittagrave e la politica economica nel Medioevo Torino Einaudi 1977 (Cambridge 1965) pp 462-496
CirollA 1974 C M CiPollA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna TI Mulino 1974
CIpOLLi 1997 C M CIPOllA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna TI Mulino 1997 (6 ed riveduta)
CORRITORB 2000 R P CORRITORB La naturale abbondanza del Mantovano Produshyzione mercato e consumi grqnari a Mantova in etagrave moderna Pavia Universitagrave di Pavia 2000
CORTONESl 1991 A CORTONESr Sulla conservazione dei cereali nellItalia medioevale woro e tecniche nelle tesnnonianze laziali (secc XIII-XV) in Rivista di storia dellagricoltura XXXI 1991 l pp 33-49
DElLA VALENTINA 1992 M DEJ1A VALENTlNA I mestieri del pane a Venezia tra 600 e 700 in Atti dellIstituto igraveVeneto di Scienze Lettere ed Arti Classe di scienze morali lettere ed arti CL 1991-92 pp 113-217
DIRLMEIER 1984 U DiRLMEIER Le condizioni materiali dellesistenza nelle cittagrave tedeshy sche del Basso Medioevo wlwiente esterno reddito consumi in Aristocrazia citshy
tadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia e in Germania (a cura di Reinhard Elze e Gina Fasoli) Bologna Societagrave editrice il Mulino 1984 pp 79shy122
FORNASIN 1999 A FORNASlN II rnercatodei grani di Udine Indagine per una storia dei prezzi in Friuli (secoli X1(1-XVIII) Nota di ricerca del Dipartimento di Scienshyze Statistiche dellUniversitagrave degli Studi di Udine 4 1999 pp 1-24 ora in ID La Patria del Friuli in etagrave frtoderna Saggi di storia economica Udine Forum 2000 pp 33-60
GRENDI 1986 E GRENOl Lapprf(vvigionamento dei grani nella Liguria del Seicento libera pratica e annone in rMiscellaneastorica ligure Studi in onore di Luigi Bulferetti XVIII1986 2 IP 1021-1047
GUENZl 1981 AGUENZI Ilfrumento e la cittagrave il caso di Bologna nelletagrave moderna in Quaderni storici XVI ~98l 46 pp 153-167
GUENZlI982 A GUENZI Pane efornai a Bologna in etagrave moderna Venezia Marsilio 1982
l
491 498 Renzo P Corritore
alla spartizione dei proventi derivanti dalla vendita e dal commercio del grano shylemolumento grandissimo - di chi doveva poi fruire della redistribuzione di tale ricchezza Tale norma avvantaggiava i possidenti cittadini e i gentiluomini privilegiashyti in grado di ottenere le tratte di esportazione Spl piano dellappropriazione essi erano in condizione di mettere fuori gioco gli altri possessori che producev~o eccedenze nel Dorilinio poicheacute si accresceva la loro forza contrattuale e la loro capacitagrave di occupare i canali commerciali piugrave redditizi Sul piano della commercializzazione gli stessi fruivashyno dello smantellamento della rete dintermediazionerappresentata dai fornai Per i rushystici significava perdere un collegamento essenziale con la cittagrave ed essere emarginati dal mercato urbano nelle campagne o sul broletto di Mantova essi non trovarono piugrave i trashydizionali interlocutori (CORRIJ9RE 2000 228231-2)
Nel caso di Bologna terra strutturalmente deficitaria e cittagrave dalla vocazione manishyfatturie1a si costringeva i fornai ad acquistareformenti terrieri presso i solari privati in cittagrave proibendogli lincetta nel contado autorizzandoli ad acquistarefornientiforeshystieri al di fuori delle mura cittadine presso rsensati da grCUlO solo a patto che fosseshyro stati smaltiti i grani cittadini a un prezzo talota superiore a quello dei grani dimshyportazione (GTlBNZl1982A 35 52-3)
Nella Toscana dei Medici il diritto allincetta nel contado venne concesso ai fornai in periodo di bassa congiuntura (in particolare dagli anni Trenta del Seicegravento) Per sostenere i prezzi interni in tal caso essi restavano gli interlocutori principali dei granshydi proprietari semplicemente spostando la loro principale fonte di approvvigionashymento dai solari dei particolari in cittagrave ai granai decentrati delle grandi aziende agrishycole oppure ai mercati rurali su cui affluiva la produzione cerealicola delle grandi fattorie (PULT QUAOUA 1984 86-9 PucrQUAGUA 1990 100 106-7)
Laddove non vi egrave come invece succede a Genova una diretta ingerenza del potere pubblico nella vita della corporazione (MAsSA 1999) i fornai di cittagrave- nonostante i lacci e lacciuoli normativi e il lavoro prevalentemente manuale svolto neUord laboshyratori - erano dei veri imprenditori dipendenti per il loro profitto - noilrinalmente stabilito per legge - dalla produttivitagrave del lavoro e dalla dotazione tecnica e finanziaria delle imprese Di ciograve fa fede la grande sperequazione esistente fra le aziende speciashylizzate nena fabbricazione del pane venale in cittagrave (AYMARD 1966 75 VBCCHIATO 1979 82-3 GTlBNZl1982A
77 segg PULT QUAGUA 1984100 102-3) NellItalia delshyletagrave moderna questi artigiani-imprenditori della filiera del grano trattavano insieme
afarinaifarinaiolifarinottifondachierifontechierifidelarijormentinari lasagneshyri maccaronari taraltari vermicellari ecc fra il 40 eil70 per centodel frumento consumato in Cittagrave nelle annate normali (CORlUTORE 2000 126 segg) e ~no alIDO per cento nelle annate di carestia (PULT QUAGUA 1984 98-9)
In una ricognizione delle asimmetrie informative del mercato non cegrave gruppo quale i fornai che possa integraverpretare la parte dellagente economico onnisciente Se dunque i regolamenti annonari tendevano a regolare minuziogravesamente la collocazione il volushyme e la durata delle loro scorte cosi come disponevano per gli altri artigiani della fishyliera era per neutralizzare il carattere potenzialmente eversivo di tale accantonamenshyto per i proprietari-venditori prima ancora che per i consumatori-acquirenti nlivello delle scorte rinforzava o attenuava il rischio di monopsonio da parte dei pistores piugrave potenti e facoltosi cosi come eventuali tentazioni da parte della categoria di esercitare un dominio egoistico sul mercato del pane (MATroZZI 1983 298)
Sarebbe quindi un errore concep~ le sccedilorte dei fornai come entrilpica allocazione di capitale che sconta lincertezza futura esse venivano gestite secondo criteri di rashyzionalitagrave economica e secondQ la migliore efficienza tecnica nonostante i vincoli imposti alla lievitazione degli stock dalle disposizioni annonarie
LA costituzione di scorre granarie pubbliche e la polilica economica degli stati
vimini paglia o canne intrecciate (come ceste stuoiecannizzi) in terracotta (addirittura anfore) piuttosto che di tessuto (i sacchi costavano troppo) (PICClNNl 1976 397 MAzzA RAvBGGI 1983 174-5 Zoo Turo 1990 893-4 CORIONESI 1991 35n-36n)
Nella casa del piccolo produttore O del titolare di un piccolo possesso il penus (la scorta domestica) difficilmente eccedeva il consumo famigliare chi fortunato raccoshyglieva piugrave dellannona famigliare e di quanto gli serviva per il campo era spinto a venderselo nei mesi immediatamente successivi alla mietitura e alla trebbiatura per necessitagrave di denaro ma anche per la difficoltagrave di stoccare e conservare il prodotto in condizioni ottimali (MEUVRET 1988 17-9 Pmr QUAGUA 1984 88) e financo per ridurre il rischio di vederselo soffiare da vagabondi e malintenzionati In questo caso in presenshyza di eccedenze (ma probabilmente anche in assenza) il bisogno di liquiditagrave e 1alea cospiravano nel ridl1rre ai minimi termini le scorte giagrave allindomani del raccolto In caso alternativo il contadino che non egrave - ripete Jean Meuvret - un homme daffaires quanshyto un homme de peur concepiva la sua riserva come un fondo di previdenza sul racshycolto futuro da non immettere sul mercato se non nel caso dellapprossimarsi di una messe sicura secondo una logica economica a contrario (MEUVRBT 1988 19 e 147)
Era Hltente la disparitagrave fra i produttori non solo fra chi era in possesso di eccedenshyze e chi non lo era ma piugrave ancora fra chi poteva scegliere - in virtugrave di una maggiore capienza economica e un adeguata dotazione tecnica - il mercato piugrave favorevole per i propri grani (il periodo di saldatura dei raccolti) e chi invece li cedeva troppo presto o in controtempo a livelli non ottimali
Nella gerarchia delle abitazioni rurali -- in quel vero e proprio saggio di sociologia che egrave il sesto libro del De Architectura di Sebastiano Serlio (scritto fra il 1537 e il 1555 inedito per tutto levo moderno) - per trovare case attrezzate di granaio occorshyreva ascendere sino alla magione del basso mercante o cittadino fuori della cittagrave (SERLIO 1994 43 segg anche per le successive informazioni) Condizione di cui non potevano fregiarsi invece i ricchi contadini in ~ssuno dei tre gradi possibili di ricshychezza al massimo la loro casa poteva es~ere attrezzata di portici per ricoverare le biade e di unaia per batterle segni di distinzione giagrave fra i mediocri contadini Fra questi perograve avrebbero potuto avvalersene soltanto i fortUIgravelati et di beni et di famishyglia (3deg grado di mediocritagrave) Dforno per cuocere il pane e una cantina per conservashyre il vino invece li si sarebbe trovati a partire dai piugrave accomodati fra i poveri contashydini cioegrave al 4deg gradino della scala sociale alla cui base erano da collocare i poveri mendichi con vil capanna (1deg grado di povertagrave) i salariati che vivevano delle [loro] fatiche avendo un puoco di terreno (2deg grado di povertagrave) i poveri con qualche beshylitiuola et massimamente de buovi possessori di una stalletta congiunta con la casa (3deg grado di povertagrave) In sintesi nelle campagne delletagrave pre-industriale pochi avevano scorte pochissimi
erano in grado di ricoverarle in un solaro privilegiatissimo chi le incanevava per speculare Dunque fra i contadJni se si esclude quanto celato nella madia o nella dishyspensa le scorte erano un pri~ilegio di pochi Il Sedio nato intorno al 1475 insiste sullimpoverimento delle class~ rurali intervenuto fra gli anni della sua giovinezza e quelli della vecchiezza in cui segraverive Sotto il titolo Dellabitazione del ricco contadishyno per tre gradi di ricchezza si preoccupa di puntualizzare
bencheacute al digrave dogi non se ne truovi piugrave de tali merceacute delle discordie et di gli animi fieri et ostinati alla vendetta onde per tal cagioni et per le continue guerre et anche pei citadini divoratori de gli altrui beni che con le usure con glinganni con le rapine gli hano impoveriti (SERllO 1994 48)
492 497 Renzo P COlTitore
Tale disparitagrave sociale si riverberava sulla struttura del conunercio cerealicolo La funzione dei piccoli conunercianti di biade (granaioibiadaiolijarinaioli balshy
zarotti cavallanti vaticali ecc) era infatti ancillare alla capacitagrave di affacciarsi sul nercato della fascia marginale dei possidenti con eccedenze Solo che nelle annate di
abbondanza si verificavano ingorghi nellofferta di grano che deprimevano i prezzi e incentivavano i piccoli produttori a smerciare direttamente le eccedenze allindomani del raccolto nellarea urbana anche al di fuori dei luoghi deputati (MA1TOZZl 1983 278 281-2 300n PULT QuAGLIA 1984 86) Mentre nelle annate di penuria si contraeshyva drasticamente proprio questo segmento dellofferta (ABEL (1966J 22-4 KULA (1962] 73-4 CATIINI 1984 111-23 PuLT QUAGLIA 1984 88) scatenando nelle campashygne una caccia al grano-merce la cui quota piugrave consistente era detenuta dai grandi proprietari dai maggiori affittuari dai percettori di canoni diritti o rendite in grano e la cui quota residua era piugrave facilmente preda di chi occupava posizioni chiave nellasshysetto terriero nella catena dei diritti nel credito alla produzione e al consumo
Tanto la distribuzione era frammentata nelle annate di abbondanza tanto in epoclshydi penuria il conunercio del grano diventava un affare di pochi In questo caso lazioshyne dei mercanti diventava dimpiccio sul mercato interno dove la coperta si restringeshyva per i proprietari e gli imprenditori agricoli (KULA (1962J 56-61 CATIINI 1984 114-8) - dove la necessitagrave di ricorrere al credito da parte dei piccoli possessori pOneva questi nelle mani degli agenti dei proprietari dei percettori di canoni diritti o rendite - dove i piccoli proprietari vedevano minacciata la loro stessa condizione da parte di chi controllava localmente in maniera capillare e decentrata il mercato del denaro e dei beni necessari alla riproduzione (sernenti strumenti cibo) La soluzione era quelshyla di precludere amministrativamente ai sensali e ai conunercianti di grani i mercati locali su istigazione dei medi possessori le cui occasioni di normale profitto agrario soffrivano un ridimensionamento e che si vedevano costretti a impegnarsi ccedilontiltte le loro forze per integrare le proprie entrate accaparrandosi le magre eccedenze disponishybili nelle campagne e nei borghi rurali (PuLT QUAGLIA 1984 84-8 PuLT QUAGLIA 1990 107-14)
Il destino dei piccoli conunercianti in grano era quindi quello di occupare una posishyzione marginale nel mercato del grano (MEUVRET 1977 30 PINTO 1978 13 MATTOZZI 1983 277) e di operare non solo a causa degli ordinamenti annonari - secondo una logica di corto respiro in cui non era contemplata neacute la conservazione di grani a lungo termine neacute lutilizzo di depositi piugrave che provvisori Come per i piccoli possidenti non si puograve parlare nel loro caso della formazione e del mantenimento di scorte consistenti (MEUVRET 1988 156-7) Non tali comunque da sostenere il reddito contadino nelle stagioni ordinarie e da esercitare sul versante cittadino unefficace azione anticonshygiunturale in caso di carestia
Peraltro in cittagrave la struttura dellofferta era anche piugrave sperequata di quella che si rishyscontra nel contado Che si tratti di Prato ne) 1339 (PlNTO 1978 129 PINTO 1982 160n e 171n) Pavia negli anni 1539 1555 1573 1602 1603 (ZANIITTI 1963) o Mantova nellultima parte del secolo XVI (CORRITORE 2000 81-9) la distribuzione delle scorte fra i privati era singolarmente ineguale Lo attesta la rilevanza nellarea urbana della povertagrave cioegrave secondo una definizione coeva di coloro che non vivono di entrate ma sono necessitati ricorrere mattina e sera alle pistorie a comprare il pane per il vitto loro e delle sue famiglie col denaro che di giorno in giorno si vanno guadagnando (MATshyTOZZI 1983 281) PUOgrave essere utile richiamare la situazione delle cittagrave tedesche nel basso Medioevo in una fase che egrave stata definita da Wilhelm Abel l epoca doro degli artigiani e del lavoro salariato si puograve stimare che almeno la metagrave degli iscritti ai
il costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica ecol1Omica degli stati
te con il principio della piazza Il mercato pubblico periodico disciplinato la spiagshygia la piazza la loggia o il recinto riservato alle contrattazioni - coesisteva confabshybriche magazzini ebotteghe La stessa piazza per funzionare al meglio secondo il principio dello scambio diretto necessitava di magazzini di supporto
4 LE SCORTE DEI FORNAI CITTADINI
Nellarea urbana e nelle relazioni tra cittagrave e campagna operavano perograve temibili conshycorrenti dei privati possessori I fornai cittadini possedevano le competenze le strutshyture tecniche le relazioni sociali e il credito per incettagravere il prodogravetto per essere inforshymati tempestivamente sul mercato del grano e potenzialmente per dispensarlo con profitto in qualunque momento Il fatto che il loro operato fosse imprigionato in un arshycaica impalcatura di norme divieti obblighi che risalivano alletagrave romana che ne fashycevano in modograve quasi istituzionalizzato il capro espiatorio delle tensioni fra produtshytori di grano povertagrave e autoritagrave non impedisce di affermare che tali vessatorie disposizio~i trovassero la loro principale ragione dessere nella parte che essi giocashyvano di interlocutorilantagonisti dei proprietari terrieri nella determinazione del prezshyzo del grano sul mercato locale e nella realizzazione della rendita terriera (GUENZI 1982 35 GUENZl 1982 297)
Nel caso di Mantova terra cornucopia a partire dal 1492 si consenti a zentilhomini cittadini et qualuncho altro di comprare biade nel Dominio per approvvigionare la cittagrave di fatto si sancigrave un diritto allincetta che mise fuori gioco i fornai a cui venne imposto di rifornirsi nei solari dei cittadini senza avere piugrave la possibilitagrave di effettuare acquisti nel contado e di ritenere a casa scorte superiori a 100 staia di frumento Lintento della disposhysizione egrave chiarissimo espresso senza reticenze dai Maestri delle Entrate che riportarono al marchese la soddisfazione dei possidenti mantovani per la riforma statutaria
tutta la Terra (cioegrave il Mantovano] ne (egrave] rimasta satisfactissima pensando che Vostra Excellentigravea pretenda ali comodi et utilitagrave universale senza dampno et preuiditio suo Vero egrave che li fumari non si contentano parendoli comegrave il vero che non si poteranno ingrnssar asuo modo come hanno facto per il passato et poterigravea Igravelchader ( ] che veneranno adolershyse et supplicar aVostra Signoria Perograve me egrave parso dargene aviso per questa nostra et farli intender che questa terra ha soliigrave due membri de li quali li cittadini soi se ne possono aiutashyre e valersene uno egrave il grano laltro egrave larte de la lana et quando se concedesse che li furshyDari potessero comprare come h~o facto li tempi passati sana un fare beneficio acinquanshytaocto dessi et dampnifichar elresto de fa republica sua quale de questo ban ordine ne receve emolumento grandissimo et se gaude in la Citagrave [percheacute] li fumari portano fuora el denaro et pretendono solo a suo benefitio (AG b 2441 lettera del 13 luglio 1492)
Egrave indubbio che il plauso della Terra fosse da attribuire piugrave alla possibilitagrave per i proshyprietari di accrescere le proprie entrate che a quella dei consumatori cittadini e dell arte della lana di trarre beneficio dalla disposizione Egrave significativo che la motivazione pro cigravevitate non accenni allesistenza di monopoli da parte dei fornai o di artificiose lievitashyzioni dei prezzi per causa loro Il loro attivismo non confiiggeva per quanto riguarda i prezzi finali della sussistenza con linteresse dei produttori cittadini E daltra parte largomento dellQ storno dal merpato cittadino dei profitti incamerati dai fornai -laccushysa consueta a proposito dei pistores egrave che fossero in gran parte stranieri (GUENZII982 22) -- era una giustificazione debole che appassionava piugrave chi concorreva direttamente
496 493
Renzo P Corritore
appare altrettanto astratto dogmatico o virtuale del principio di mercato (Market Pri1lciple) che il medesimo gli contrappone Henri Pirenne parlando della politica annonaria dei comuni medievali avverte Lapplicazione del principio della vendita diretta ebbe numerosi eccezioni (PumNNE [1933] 193n)
Nel caso di Mantova la scelta della Piazza egrave facoltativa per i terrieri COn eccedenze Gli Statuti signorili che si rifanno largamente alle raccolte statutarie comunali non sancivano alcun obbligo in proposito (v SVJUTI BONACOLSIANI [1313] libro m rubr 55 De mercato blave 253 STATlITl GoNZAOHESCHI [1404J libro m rubr 93 De mercato blave fiendo in civitate Mantue f 73v) Decreti di carattere straordinario e regolamenshytazioni transitorie correggevano il tiro Nel 1405 in piena saldatura dei raccolti si c0shy
strinse a rifornire forzosamel)~ la piazza concentrandovi tutte le contrattazioni Nel 1417 si obbligograve a riservare al mercato un terzo del frumento introdotto in cittagrave (CORRIshyTORE 2000 235-6) Ma sono atti straordinari che non sopravvissero nel migliore dei casi piugravedi qualchelustro (MANroVA 1430 88 90 181) A Mantova la Piazza era affianshycata da un granaio pubblico la Domus del mercato (altrove definito Folllico o Fonrego del mercato) in cui avrebbero dovuto prolungarsi le contrattazioni oltre lorario e i giorshyni deputati (venerdigrave o sabato) rendendo disponibile ciograve che restava invenduto e che non poteva essere ritirato per legge dal mercato Nel 1430 eminenti cittadini sollecitati dal principe lamentavano perograve lincapacitagrave del magazzino - inoperoso in tutto o in parte per il pericolo di crolli -- di rispondere ai bisogni del popolo in una situazione in cUi da parte dei possessori si protestava la difficoltagrave di non poter esitare e smerciare fuori delshyla cittagrave le eccedenze conservate nei solari privati
Item videtur quod valde utille foret civibus Mantue habentibus possessiones et quishybuscumque alijs personis de civitate Mantue aut districtu colligantibus bIada et vina in magna copia ut omni tempore ipsa bIada et vinum possent extrahere de civitate et dishystrictu Mantue et conducere ad Iaea ad que et in quibus ma vendere poterunt cum otdishynibus et dacijs competentibus ipsa tamen civitate semper remanente fulta pro usu dicte civitatis et populi eiusdem ne dieta biada marceschant super granarlis ut hactenus feceshyrunt cum maximo incomodo ipsorum civium (MANTOVA 1430 177-8)
nmedesimo fondaco abbinato al mercato operava a Verona a Ferrara a Vegravenezia a Udine a Chioggia in molte altre cittagrave (MANToVA 1430 100 FORNASIN 1999 7-9 CEshySTAR 1794)
Lintegrale e pedissequa applicazione del principio della piazza di mercato comporshytava - per i vincoli tecnici dell etagrave pre-industriale -la massima affermazione del prinshycipio della canova cioegrave del magazzino pubblico centrale Unico argine alla sua invashydenza era costituito da una distribuzione perequata ab imis del raccolto cioegrave la possibilitagrave - egrave questo il paradosso - di realizzare da parte dei produttori la massima aspirazione nelle societagrave tradizionali lautarchia domestica Piugrave avanzava invece la sperequazione nel reddito e nel patrimonio piugrave da parte dei consumatori privi di scorshyte si impetrava il principio del Magazzino pubblico nella ronna di un efficiente sisteshyma di ricovero conservazione distribuzione delle derrate a garanzia del funzionashymento della Piazza di mercato La disponibilitagrave di crescenti quote di raccolto tuttavia indirizzava i piugrave accomodati verso soluzioni piugrave ghiotte la vendita allingrosso sul mercato cittadino ai fornai o allimpresa pubblica creata a sussidio di questi (o in loro vece) Oppure allopposto lesito delle eccedenze extra muros sui grandi mercatishyemporio regionali per il tramite di mercanti o agenti diretti
Il principio del magazzino pubblico centrale cioegrave laccumulazione di riserve per lo smercio continuo o anticiclico egrave quindi alla sua origine in opposizione solo apparen-
La costirU1ione di scorre granarie pubbliche e la politica economica degli srati
ruoli fiscali non fosserograve in grado di accantonare scorte Nel 1444 a Strasburgo quattro cittadini su dieci non possedevano alcuna riserva cerealicola (DRlMBIER 1984 112)
Nelle cittagrave italiane delletagrave moderna si puograve stimare che non meno di due terzi della popolazione fosse costretta ad acquistare o consumare pane confezionato con grani e farine comperati nelle piazze nelle vie e nelle botteghe cittadine oppure ottenuti come compenso del proprio servizio nelle casate (CORRrroRE 2000 126-36 MA11oZZI 1983 27~-82) Evidentemente questa fascia di lavoratori salariati non possedeva -shyper definizione - neacute scorte neacute depositi personali e nel primo caso era strettamente dipendente dal mercatograve urbano acquistando la sua sussistenza con frequenza non piugrave che settimanale (essendo costretti a comprare il pane tutti i giorni allafinestra si dishyceva a Genova [GRENDI1986 1031])
Ma anche fra i citiOdini con possesso extra moenia la distribuzione delle scorte era tuttaltro che egalitaria A Prato nel 1339
A parte gli enti religiosi sette famiglie [ ] avevano ii disposizione piugrave di mille staia di granaglie (circa 18 tonnellate) fino a un massimo di 3500 Altri venti nuciei familiashyri avevano scorte comprese tra le 500 e le 1000 staia (PINTO 1978 129n)
A Mantova nei magazzini ducali nellultima parte del 500 erano ammassati non meno di un ottavo talora piugrave di un quarto delle riserve cittadine di grani panificabili (CoRRITORE 200081-6) A Pavia nel corso dello stesso secolo e allinizio di quello successivo nei solagraveri di una sessantina di famiglie si concentrava non meno del 40 per cento dellintera offerta cittadinIgrave di frumento(ZANBUgrave11964 70-7) Anche in questo caso egrave utile sapere che nelle cittagrave tedesche esistevano mercanti (ad Augusta RatisboshyDa Norimberga) in grado di axnPmssare riserve da 6 a 45 tonnellate e che a Francoshyforte nel 1488 due patrizi totali~zavano insieme un terzo delle scorte cerealicole dei particolari nella cittagrave alta (DnuMmER 1984113)
Ritenere tali soggetti sprovv~uti al punto di incanevare grani con il solo scopo di esorc~ i pericoli della Fstia egrave perlomeno riduttivo A grandi solari comshyspondevano vaste familiae e pIftore di servi tori e ospiti ma tali scorte eccedevano largamente la sussistenza del maggiore palazzo nobiliare o patrizio senza peraltro costituire un fondo di accantonafoento eccedente il fabbisogno della cittagrave a meno che non vi fosse la concreta possibilitagrave di commercializzare il surplus sui mercati esteri Come nota infatti Adam Smith
a meno che leccedenza non possa essere esportata in tutte le circostanze ordinarie i coltivatori staranno molto attenti a non produrre e gli importatori a non importare mai una quantitagrave maggiore di quell~ che egrave strettamente richiesta dal consumo del mercato interno Questo mercato saragrave difficilmente sovrafomito ma saragrave in generale sottoriforshyDito dato che coloro che svolgqno lattivitagrave per rifomirlo avranno in generale il timore che la loro merce possa rimanete invenduta (SMlTH [1776] 528)
Lipotesi egrave suffragata dai cas~ storici conosciuti A Bologna macrodistretto serico dellevo moderno laddove gli ipteressi manifatturieri e mercantili avrebbero dovuto consigliare una sussistenza a b~on mercato per tenere basso il costo del lavoro le istituzioni annonarie operavano per garantire con il calmiero deljorme1lto la monetizshyzazione della rendita granaria dei possidenti - strutturalmente incapace di coprire il fabbisogno della cittagrave anchea rischio della carezza dei viveri contingentando il mercato dei grani forestieri (GtJFNZl1982A 37-76) Di fatto
495 494 Renzo P Corrllnre
In ogni caso si tendeva a limitare al minimo indispensabile lemiddot importazioni di frushymento per evitare che stocks invenduti potessero turbare la collocazione dei grani tershyrieri nel nuovo anno agrario (GuENZI 1981 153)
In tutti i centri comunque la tendenza a ritardare la vendita del surplus nei mesi della saldatura lutilizzo di depositi specializzati con personale addetto alla custodia al conshydizionamento e alla commercializzazione del prodotto ponevano i grandi proprietari di biade su un gradino superiore e diverso rispetto al resto della cittagrave Laccantonamento di grani per questa cupola di possessori rispondeva al principio dellutilitagrave soggettiva atshytesa e richiedeva sia capitale fisso sia capitale circolante per raggiungere gli scopipreshyfissati un profitto speculativo la valorizzazione della rendita
In molte cittagrave i possessori non avrebbero dovuto trattenere in casa piugrave grano e farina di quantoprescritto dalla legge cioegrave il consumo mensile per bocca - fissato anchesshyso statutariamente - per arrivare al nuovo raccolto Ma i cittadini credeVano veramenshyte ai loro comandamenti Egrave lecito dubitare La norma era scolpita negli Statuti e pubshyblicamente violata con la complicitagrave dll1e autoritagrave e dei groppi professionali interessati alla distribuzione del grano nelle sue ~arie forme
Nelle annate ordinarie la quota di grano auto consumato - cioegrave non acquistata sul mercato - nelle cittagrave italiane dell evo moderno rappresentava fra il 30 e il 60 per censhyto del fabbisogno urbano di frumento
Nella capitale dei Gonzaga nel 1615 si valutava che su 27000 bocche
il terzo [di] gentilhuomini fittadri servitori et altri [ ] non comprano biada et gli duoi tenigrave tra poveri artisti mercanti fomari fondachieri hebrei et altri [bull] non possono in tutto levar sufficientemente la somma de detti dua terzi sl che saranno boshychegrave 18000 che compraranno biada (COIUUTORl 2000 126)
AVenezia a cavaliere fra XVI e XVII secolo alla mensa delle casade si dispensava circa un terzo del frumento consumato ordinariamente in cittagrave (AMARD 1966 74 MATTOZZI 1983 281) ABologna per tutto il Seicento i fornai che impastavano farine in conto lavorazione per i particolari pareggiavano piugrave o meno il numero di quelli da scqffa che smerciavano pane venale (GUENZI 1982A
27) Peraltro la proporzione a Rialto tra chi lavorava per le casade e chi vendeva pane al pubblico - 65 Jo~ri a fronte di 44-48 pistori negli anni 1583-1685 (DELLA VALBNTINA 1992 143-4 167 192-3) - fa ritenere la struttura del mercato del pane felsinea non molto dissimile da quella veneziana Nelle cittagrave liguri o toscane sei-settecentesche la porzione autocon sumata quando il raccolto era buono era anche piugrave elevata (GRENDI 1986 1024-6 1034 PuLT QUAOUA 1984 98-104 PULT QUAGUA 1990 171-2) A Napoli nel 1758 a Monasteri Luoghi pii e Particolari eta riservato il 28 per cento del consumo cittadishyno di frumento (AuFANO 1996 37n)
Lelevato numero di servi domestici persone al servizio delle casate faceva sigrave che in alcuni palazzi si concentrassero masse cospicue di grano per la spesa familiare Ma accanto ad esse gli operatori dell annona -- la stessa povertagrave -- si auguravano che vi fosse sempre anche la materia per rifornireil mercato e i forni cittadinimiddot nella fase piugrave delicata del ciclo annuale il periodo di saldatura dei raccolti Come spiegare altrimenshyti la norma che imponeva ai grossi detentori di biade (non esclusi enti e opere pie) in varie cittagrave italiane dellevo moderno la vendita straordinaria in primavera dellegrave ecshycedenze ammassate in granaio (per Pisa e la Toscana v PuLT QUAGUA 1984 88-9)
A Mantova nel 1554 si stabiliva che i patroni che avessero fruito in cittagrave di piugrave di 20 sacchi di grano come porzione dominicale avrebbero dovuto coilservare in granaio
lA costituzioni digrave scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
il 4 per cento per le necessitagrave dei consumatori dei fornai e dei Jontachieri quando fosse mancato il prodotto sulla piazza o nelle offerte deisensali Nel 1603 ci si preocshycupograve di elevare la quota al 6 per cento (CORRlTQRE 2000 237n) Beninteso le vendite sarebbero avvenute ai valori di mercato Lo stesso sistema vigeva a Cremona (6 per cento nel 1608 e nel 1612) (MERON 1957 59n 63 JACOPETl1 1965 128) ea Verona Qui una delibera consiliare del 1549 autorizzava per la prima volta
[il deputati [alle Biadel [a] tassar e comandar con quelle pene che al Clarissimo Podestagrave pareragrave quella quantitagrave di biade a ciascuno secolare o eclesiastico sia di qual grado o condittione esser si voglia che havesse biade in questa cittagrave oltre il viver suo
(VOCCHIATO 1979 145)
La tassa sarebbe stata stabilita - da11558 - per sorteggio fra le casate che avessero introdotto in cittagrave dai propri possedimenti piugrave di 70 minali per rifo1llire il Mercato delle biave Essa-venne anche incrementata nella stessa occasione dal 5 al6 per censhyto per restare in vigore fino al 1631 (VECCHIATO 1979 141-58)
Quest9 tiIfo di normativa nasce e si affiogravea in ambito amministrativo perciograve echeggia la realtagrave molto meglio della veneranda legge generale
Da tali disposizioni si deducono alcuni fatti incontrovertibili 1entro la cerchia cittadina esistevano scorte private eccedenti la spesa delle famiglie
in violazione in molti casi della legge statutaria 2il possesso della terra che solo assicurava lautarchia delle casate era il piugrave-potente
fattore di discriminazione fra i cives tanto da precipitare nel girone dei pauperes la moltitudine che acquistava correntemente la sussistenza nellarea urbana
3fra gli stessi possidenti cittadini esisteva uneacutelite che non solo conservava scorte oltre il viver suo ma che si proponeva egoisticamente di speculare ritardando limshymissione dei grani sulle piazze cittadine o che a~endeva il momento piugrave opportuno per smerciarli allesterno nelle grandi piazze frumentarie come livorno Desenzashyno Legnago Romano (di Lombardia) ecc
4lineguaglianza fra i cives tese ad aggravarsi con la metagrave del 500 poicheacute questi reshygolamenti innovano quasi sempre disposizioni generali risalenti al tardo Medioevo che sancivano lobbligo di convogliare il surplus sulla piazza cittadina segno di una distribuzione del reddito originariamente meno sbilanciata A Cremona gli Statuti del 1388 obbligavano - cosl egrave ancora nel 1510 - a vendere il
sovrappiugrave in Piazza Maggiore sul mercato pubblico dei grani (MERON 1957 59n
63)A Pisa il rescritto che imponeva di effettuare le vendite al minuto in platea bladi
risale al 1401 MALANlMA 1976 293) lobbligo era ribadito ancora nel 1548 ma nella seconda metagrave del secolo XVI si affermava la pratica di vendere fuori mercato tanto che nel 1581 il Magistrato dei Nove dovette intervenire per far vendere i grani delle comunitagrave degli enti e dei luoghimiddotpii soltanto da marzo-aprile in piccole quantitagrave sul mercato (PULT QUAGUA 1984 81-91) La disposizione per altro si applicava allinteshyro Stato (PULT QUAGUA 1984 88)
Tuttavia non egrave da pensare che il principio della concentrazione delle compravendite sulla piazza di mercato cittadina fosse universale universalmente rispettato e sopratshytutto perenne La centralizzazione del grano non significa automaticamente lobbligo di vendita diretta sulla Piazza deiformenti Affermare come Steven L Kaplan che
There was no single more important regulation concerning tbe provisioning trade tban tbe requirement tbat alI transactions occur in tbe marketplace (KAPLAN 1984 27)
494 495 Renzo P Corritore
In ogni caso si tendeva a limitare al minimo indispensabile le importazioni di frushymento per evitare che stocks invendutigrave potessero turbare )a collocaziolle dei grani tershyrieri ileI nuovo anno agrario (GUENZI 1981 153)
In tutti i centri comunque la tendenza a ritardare la vendita del surplus nei mesi della saldatura lutilizzo di depositi specializzati con personale addetto alla custodia al conshydizionamento e alla commercializzazione del prodotto ponevano i grandi proprietari di biade su un gradino superiore e diverso rispetto al resto della cittagrave Laccantonamento di grani per questa cupola di possessori rispondeva al principio dellutilitagrave soggettiva atshytesa e richiedeva sia capitale fisso sia capitale circolante per raggiungere gli scopipreshyfissati un profitto speculativo la valorizzazione della rendita
In molte cittagrave i possessori non avrebbero dovuto trattenere in casa piagrave grano e farina di quantoprescritto dalla legge cioegrave il consumo mensile per bocca ~- fissato anchesshy
so statutariamente --per arrivare al nuovo raccolto Ma i cittadini credevano veramenshyte ai loro comandamenti Egrave lecito dubitare La norma era scogravelpitagrave negli Statuti e pubshyblicamente violatamiddot con la complicitagrave dccedillle autoritagrave e dei gruppi professionali interessati alla distribuzione del grano nelle sue varie forme
Nelle annate ordinarie la quota di grano autoconsumato - cioegrave non acquistata sul mercato - nelle cittagrave italiane dell evo moderno rappresentava fra il 30 e i160 per censhyto del fabbisogno urbano di frumento
Nella capitale dei Gonzaga nel 1615 si valutava che su 27000 bocche
il terzo [di] gentilhuomini ligravettadri servitori et altri [ ] non comprano biada et gli duoi terzi tra poveri artisti mercanti fomari fondachieri hebrei et altri [ l non possono in tutto levar sufficientemente la $omma de detti dua terzi sl che saranno boshyche 18000 che compraranno biada (CoRRlTORB 2000 126)
AVenezia a cavaliere fra XVI e xvn secoioalla mensa delle casade si dispensava circa un terzo del frumento consumato ordinariamente in cittagrave (AYMARD 1966 74 MArroZZI 1983 281) A Bologna per tutto il Seicento i fornai che impastavano farine in conto lavorazione per i particolari pareggiavano piil o meno il numero di quelli da scaifa che smerciavano pane venale (GUBNZI 1982 27) Peraltro la proporzione a Rialto tra chi lavorava per le casade e chi vendeva pane al pubblico - 65 fOf7lri a fronte di 44-48 pistori negli anni 1583-1685 (DELLA VAUNTINA 1992 143-4167 192-3) - fa ritenere la struttura del mercato del pane felsinea non molto dissimile da quella veneziana Nelle cittagrave liguri o toscane sei-settecentesche la porzione autoconshysumata quando il raccolto era buono era anche piil elevata (ORENOI 1986 1024-6 1034 PuLT QUAGLIA 1984 98-104 PULT QUAOLIA 1990 171-2) A Napoli nel 1758 a Monasteri Luoghi pii e Particolari eta riservato il 28 per cento del consumo cittadishyno di frumento (AuFANO 1996 370)
Lelevato numero di servi domestici persone al servizio delle casate faceva si che in alcuni palazzi si concentrassero masse cospicue di grano per la spesa familiare Ma accanto ad esse gli operatori dellannona -lastessapovertagrave __ si auguravano che vi fosse sempre anche la materia per rifornire il mercato e i forni cittadini nella fase piil delicata del ciclo annuale il periodo di saldatura dei raccolti Come spiegare altrimenshyti la norma che imponeva ai grossi detentori digrave biade (non esclusi enti e opere piegrave) in varie cittagrave italiane dellevo moderno la vendita straordinaria in primavera delle ecshyredenze ammassate in granaio (per Pisa e la Toscana v PuLT QUAGLIA 1984 88-9)
A Mantova nel 1554 si stabiliva che i patroni che avessero fruito in cittagrave di piugrave di 20 sacchi di grano come porzione dominicale avrebbero dovuto conservare in granaio
lA costituzione di SC0114 granarie pubbliche e la politica economica degli stati
il 4 per cento per le necessitagrave dei consumatori dei fornai e dei fontachieri quando fosse mancato il prodotto sulla piazza o nelle offerte deimiddotsensati Nel 1603 ci si preocshycupograve di elevare la quota al 6 per cento (CoRRlTORE 2000 237n) Beninteso le vendite sarebbero avvenute ai valori di mercato 10 stessa sistema vigeva a Cremona (6 per cento nel 1608 e nel 1612) (MERON 1957 -59n 63 JACOPETl11965 128) ea Verona Qui una delibera consiliare del 1549 autoruzava per la prima volta
[i] deputati [alle Biade) [al tassar e comandar con quelle pene che al Clarissimo Podestagrave pareragrave quella quantitagrave di biade a ciascuno secolare o eclesiastico sia di qual grado o condittione esser si voglia che havesse biade in questa cittagrave oltre il viver suo (VBCClI1ATO 1979 145)
La tassa sarebbe stata stabilita - dal 1558 - per sorteggio fra le casate che avessero introdotto in cittagrave dai propri possedimenti piagrave di 70 minali per rifornire il Mercato delle biave Essaveane anche incrementata nella stessa occasione dal 5 al6 per censhyto per restare in vigore fino al 1631 (VECCHIATO 1979 141-58)
Questccedil tijlo di normativa nasce e si affuia in ambito amministrativo perciograve echeggia la realtagrave molto meglio della veneranda legge generale
Da tali disposizioni si deducono alcuni fatti incontrovertibili 1entro la cerchia cittadina esistevano scorte private eccedenti la spesa delle famiglie
in violazione in molti casi della legge statutaria 2il possesso della terra che solo assicurava lautarchia delle casate era il piugravemiddotpotente
fattore di discriminazione fra i cives tanto da precipitare nel girone dei pauperes la moltitudine che acquistava correntemente la sussistenza nellarea urbana
3fra gli stessi possidenti cittadini esisteva uneacutelite che non solo conservava scorte oltre il viver suo ma che si proponeva egoisticamente di speculare ritardando limshymissione dei grani sulle piazze cittadine o che a~endeva il momento piagrave opportuno per smerciarli allesterno nelle grandi piazze frumentarie come Uvorno Desenzashyno Legnago Romano di Lombardia) ecc
4lineguaglianza fra i cives tese ad aggravarsi con la metagrave del 500 poicheacute questi reshygolamenti innovano quasi sempre disposizioni generali risalenti al tardo Medioevo che sancivano lobbligo di convogliare il surplus sulla piazza cittadina segno di una distribuzione del reddito originariamente meno sbilanciata shyACremona gli Statuti del 1388 obbligavano - cosl egrave ancora nel 1510 - a vendere il
sovrappigraveagrave in Piazza Maggiore sul mercato pubblico dei grani (MERON 1957 59n 63)
A Pisa il rescritto che imponeva di effettuare le vendite al minuto in platea bladi risale al 1401 (MALANIMA 1976 293) lobbligo era ribadito ancora nel 1548 ma nella seconda metagrave del secolo XVI si affermava la pratica di vendere fuori mercato tanto che nel 1581 il Magistrato dei Nove dovette intervenire per far vendere i grani delle comunitagrave degli enti e dei luoghi pii soltanto da marzo-aprile in piccole quantitagrave sul mercato (PULT QUAGLIA 1984 8191) La disposizione per altro si applicava allinteshyro Stato (PULT QUAGLIA 1984 88)
Tuttavia non egrave da pensare che il principio della concentrazione delle compravendite sulla piazza di mercato cittadina fosse universale universalmente rispettato e sopratshytutto perenne La centralizzazione del grano non significa automaticamente lobbligo di vendita diretta sulla Piazza deiformenti Affermare come Steven L Kaplan che
There was no single more important regulation conceming the provisioning trade han the requirement that ali transactions occur in the marketplace (KAPuN 1984 27)
493 496 Renw P Corritore
appare altrettanto astratto dogmatico O virtuale del principio di mercato (Market Principle) che il medesimo gli contrappone Henri Pirenne parlando della politica annonaria dei comuni medievali avverte Lapplicazione del principio della vendita diretta ebbe numerosi eccezioni (PIRENNE [1933] 193n)
Nel caso di Mantova la scelta della Piazza egrave facoltativa per i terrieri con eccedenze GliStatuti signorili che si rifanno largamente alle raccolte statutarie comunali non sancivano alcun obbligo in proposito (v SYJI1l BONACOLSlANI [1313] libro ID rubr 55 De mercato blave 253 STATUTI GoNZAOHESCHI [1404] libro m rubr 93 De mercato blave fiendo in civitate Mantue f 73v) Decreti di carattere straordinario e regolamenshytazioni transitorie correggevano il tiro Nel 1405 in piena saldatura dei raccolti si coshystrinse a rifornire forzosamen~e la piazza concentrandovi tutte le contrattazioni Nel 1417 si obbligograve a riservare al mercato un terzo del frumento introdotto in cittagrave (CoRRIshyTORE 2000 235-6) Ma sono atti straordinari che non sopravvissero nel migliore dei casi piugrave di qualchelustro (MANToVA 1430 88 90 181) A Mantova la Piazza era affianshycata da un granaio pubblico la Domus del mercato (altrove definito Fornico o Fontego del mercato) in cui avrebbero dovuto prolungarsi le contrattazioni oltre lorario e i giorshyni deputati (venerdl o sabato) rendendo disponibile ciograve che restava invenduto e che non poteva essere ritirato per legge dal mercato Nel 1430 eminenti cittadini sollecitati dal principe lamentavano pero lincapacitagrave del magazzino - inoperoso in tutto o in ~per il pericolo di crolli - di rispondere ai bisogni del popolo in una situazione in cui da parte dei possessori si protestava la difficoltagrave di non poter esitare e smerciare fuori delshyla cittagrave le eccedenze conservate nei solari privati
ltem videtur quod valde utille foret civibus Mantue habentibus possessiones et quishybuscumque alijs personis de civitate Mantue aut districtu colligantibus bIada et vina in magna copia ut amni tempore ipsa bIada et vinum possent exttahere de civitate et dishystrictu Mantue et conducere ad Iaea ad que et in quibus illa vendere poterunt cum otdigraveshynibus et dacijs competentibus ipsa tamen civitate semper remanente fulta pro usu diete civitatis et populi eiusdem ne dicta bIada mateeschant super granariis ut hactenus fecemiddot runt cum maximo incomodo ipsorum civium (MANToVA 1430 177-8)
Il medesimo fondaco abbinato al mercato operava a Verona a Ferrara a Venezia a Udine a Chioggia in molte altre cittagrave (MANToVA 1430 100 FORNASIN 1999 7-9 CBshySTARl1794)
Lintegrale e pedissequa applicazione del principio della piazza di mercato comporshytava - per i vincoli tecnici dell etagrave pre-industriale -la massima affermazione del prinshycipio della canova cioegrave del magazzino pubblico centrale Unico argine alla sua invashydenza era costituito da una distribuzione perequata ab imis del raccolto cioegrave la possibilitagrave egrave questo il paradosso di realizzare da parte dei produttori la massima aspirazione nelle societagrave tradizionali lautarchia domestica Piugrave avanzava invecela sperequazione nel reddito e nel patrimonio piugrave da parte dei consumatori privi di scorshyte si impetrava il principio del Magazzino pubblico nella forma di un efficiente sisteshyma di ricovero conservazione distribuzione delle derrate a garanzia del funzionashymento della Piazza di mercato La disponibilitagrave di crescenti quote di raccolto tuttavia indirizzava i piugrave accomodati verso soluzioni piugrave ghiotte la vendita allingrosso sul mercato cittadino ai fornai o allimpresa pubblica creata a sussidio di questi (o in loro vece) Oppure allopposto lesito delle eccedenze extra muros sui grandi mercatishyemporio regionali per il tramite di mercanti o agenti diretti
Il principio del magazzino pubblico centrale cioegrave laccumulazione di riserve per lo smercio continuo o anticiclico egrave quindi alla sua origine in opposizione solo apparen-
La costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
ruoli fiscali non fossero in grado di accantonare scorte Nel 1444 a Strasburgo quattro cittadini su dieci non possedevano alcuna riserva cerealicola (DIIUMBIER 1984 112)
Nelle cittagrave italiane delletagrave moderna si puograve stimare che non meno di due terzi della popolazione fosse costretta ad acquistare o consumare pane confezionato con grani e farine comperati nelle piazze nelle vie e nelle botteghe cittadine oppure ottenuti come compenso del proprio servizio nelle casate (CoRRITORE 2000 126-36 MAnoZZI 1983 27~-82) Evidentemente questa fascia di lavoratori salariati non possedevashyper definizione -- neacute scorte neacute depositi personali e nel primo caso era strettamente dipendente dal mercato urbano acquistando la sua sussistenza con frequenza non piugrave che settimaIIgraveale (essendo costretti a comprare il pane tutti i giorni alla finestra si dishyceva a Genova (GRENDI 1986 1031])
Ma anche fra i citUutini con possesso extra moenia la distribuzione delle scorte era tuttaltro che egalitaria A Prato nel 1339
A patte gli enti religiosi sette famiglie [ bull ] avevano Il disposizione piugrave di mille staia di granaglie (circa 18 tonnellate) fino a un massimo di 3500 Altri venti nuclei familiashyri avevano scorte comprese tra le SOOe le 1000 staia (PINTO 1978 129n)
A Mantova nei magazzini ducali nellultima parte del 500 erano ammassati non meno di un ottavo talora piugrave di un quarto delle riserve cittadine di grani panificabili (CORRlTORE 2000 81c6) A Pavia nel corsq dello stesso secolo e allinizio di quello successivo nei sozagraveri di una sessantina di famiglie si concentrava non meno del 40 per cento dell intera offerta cittadin8 di frumentomiddot (ZANJin 1964 70-7) Anche in questo caso egrave utile sapere che nelle cittagrave tedesche esistevano mercanti (ad Augusta Ratisboshyna Norimberga) in grado di ~sare riserve da 6 a 45 tonnellate e che a Francoshyforte nel 1488 due patrizi totalizzavano insieme un terzo delle scorte cerealicole dei particolari nella cittagrave alta (DlRLMB1ER 1984113)
Ritenere tali soggetti sprovv~duti al punto di incanevare grani con il solo scopo di esorcizzare i pericoli della clarestia egrave perlomeno riduttivo A grandi solari corrishyspondevano vaste familiae e plftore di servitori e ospiti ma tali scorte eccedevano largamente la sussistenza del D-aggiore palazzo nobiliare o patrizio senza peraltro costituire un fondo di accantofilljnento eccedente il fabbisogno della cittagrave a meno che non vi fosse la concreta possibfjitagrave di commercializzare il surplus sui mercati esteri Come nota infatti Adam Smith
a meno che leccedenza non possa essere esportata in tutte le circostanze ordinarie i coltivatori staranno molto attenti a non produrre e gli importatori a non importare mai una quantitagrave maggiore di quell~ che egrave strettamente richiesta dal consumo del mercato interno Questo mercato saragrave difficilmente sovrafornito ma saragrave in generale sottomorshynito dato che coloro che svolgono lattivitagrave per mornirlo avranno in generale il timore che la loro merce possa rimane~ invenduta (SMITH[l776] 528)
Lipotesi egrave suffragata dai cas storici conosciuti A Bologna macrodistretto serico dellevo modemoladdove gli interessi manifatturieri e mercantili avrebbero dovuto consigliare una sussistenza a b~on mercato per tenere basso il costo del lavoro le istituzioni annonarie operavano per-garantire con il calmiero delformento la monetizshyzazione della rendita granaria dei possidenti - strutturalmente incapace di coprire il fabbisogno della cittagrave - anche ~ rischio della carezza dei viveri contingentando il mercato dei grani forestieri (GupaI 1982 37-76) Di fatto
492 Renzo P COITitore
Tale disparitagrave sociale si riverberava sulla struttura del commercio cerealicolo La funzione dei piccoli commercianti di biade (granaiolibull biadaiolifarinaioli balshy
zarotti cavallanti vatlcali ecc) era infatti ancillare alla capacitagrave di affacciarsi sul nercato della fascia marginale deipossidenti con eccedenze Solo che nelle annate di abbondanza si venficavano ingorghi nell offerta di grano che deprimevano i prezzi e incentivavano i piccoli produttori a smerciare direttamente le eccedenze allindomani del raccolto nellarea urbana anche al di fuori dei luoghi deputati (MATI02ZI 1983 278281-2 300n PULr QUAGLIA 1984 86) Mentre nelle annate di penuria si contraeshyva drasticamente proprio questo segmento dellofferta (ABa [1966Jmiddot 22-4 KULA [1962J 73-4 CATrINI1984 111-23 PuIr QUAGUA 1984 88) scatenando nelle campashygne una caccia al grano-merce la cui quota piugrave consistente era detenuta dai grandi proprietari dai maggiori affittuari dai percettori di canoni diritti o rendite in grano e la cui quota residua era piugrave facilmente preda di chi occupava posizioni chiave nellasshysetto terriero nella catena dei diritti nel credito alla produzione e al consumo
Tanto la distribuZione era frammentata nelle annate di abbondanza tanto in epoc~ di penuria il commercio del grano diventava un affare di pochi In questo caso lazioshyne dei mercanti diVentava dimpiccio sul mercato interno dove la coperta si restringeshyva per i proprietari e gli imprenditori agricoli (KULA [1962] 56-61 CATl1NI 1984 114-8) - dove la necessitagrave di ricorrere al credito da parte dei piccoli possessori poneva questi nelle mani degli agenti dei proprietari dei percettoridi canoni diritti o rendite - dove i piccoli proprietari vedevano minacciata la loro stessa condizione da parte di chi controllava localInente in maniera capillare e decentrata il mercato del denaro e dei beni necessari alla riproduzione (sementi strumenti cibo) La soluzione era quelshyla di precludere amministrativamente ai sensali e ai commercianti di grani i mercati locali su istigazione dei medi possessori le cui occasioni di normale profitto agrario soffrivano un ridimensionamento e che si vedevano costretti a impegnarsi ccedilon tutte le loro forze per integrare le proprie entrate accaparrandosi le magre eccedeiiZe disponishybili nelle campagne e nei borghi rurali (PuLT QUAGLIA 1984 84-8 PULT QUAGLIA 1990 lO7-14)
TI destino dei piccoli commercianti in grano era quindi quello di occupare una posishyzione margilJale nel mercato del grano (MBlNrurr 1977 30 PINTO 1978 13 MAITOZZl 1983 277) e di operare - non solo a causa degli ordinamenti annonari - secondo una logica di corto respiro in cui non era contemplata neacute la conservazione di grani a lungo termine neacute lutilizzo di depositi piugrave che provvisori Come per i piccoli possidenti non si puograve parlare ne1loro caso della formazione e del mantenimento di scorte consistenti (MBlNREr 1988 156~7) Non tali comunque da sostenere il reddito contadino nelle stagioni ordinarie e da esercitare sul versante cittadino unefficace azione anticonshygiunturale in caso di carestia
Peraltro in cittagrave la struttura dellofferta era anche piugrave sperequata di quella che si rishyscontra nel contado Che si tratti di Prato nel 1339 (PINTO 1978 129 PINTO 1982 160n e 17In) Pavia negli anni 1539 1555 1513 1602 1603 (ZANEm 1963) o Mantova nellultima parte del secolo XVI (CORRITORE 2000 81-9) la distribuzione delle scorte fra i privati era singolarmente ineguale Lo attesta la rilevanza nellarea urbana della povertagrave cioegrave secondo una definizione coeva di coloro che non vivono di entrate ma sono necessitati ricorrere mattina e sera alle pistorie a comprare il pane per iI vitto loro e delle sue famiglie col denaro che di giomo in giomo si vanno guadagnando (MATshyTOZZI 1983 281) PUOgrave essere utile richiamare la situazione delle cittagrave tedesche nel basso Medioevo in una fase che egrave stata definita da Wilhelm Abellepoca doro degli artigiani e del lavoro salariato si puograve stimare che almeno la metagrave degli iscritti ai
lA costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli statibull middot497
te con il principio della piazza TI mercato pubblico periodico disciplinatola spiagshygiala piazza la loggia o iI recinto riservato alle contrattazioni - coesis~va confabshybriche magazzini e botteghe La stessa piazza per funzionare al meglio secondo il principio dello scambio diretto necessitava di magaZzini di supporto bull
4 LE SCORTE DEI FORNAI CITTADINI
Nellarea urbanagrave e nelle relazioni tra cittagrave e campagna operavano perograve temibili conshycorrenti dei privati possessori I fornai cittadini possedevano le competenze le strutshyture tecniche le relazioni sociali e il credito per incettagravere il prodotto per essere inforshymati tempestivamentesul mercato del grano e potenzialmente per dispensarlo con profitto in qualunque momento Il fatto che il loro operato fosse imprigionato in unarshycaica impalcatura di norme divieti obblighi che risalivano alletagrave romana che ne fashycevano in modo quasi istituzionalizzato il capro espiatorio delle tensioni fra produtshytori di grano povertagrave e autotitagrave non impedisce di affermare che tali vessatorie disposiziograveD1 trovassero la loro principale ragione dessere nella parte che essi giocashyvano di interlocutorilantagonisti dei proprietari terrieri nelladeterminazione del prezshyzo del grano sul mercato locale e nella realizzazione della rendita terriera (GUENZI 19824
35 GUENZI 1982 297) Neacutel caso di Mantova terra comucopia a partire dal 1492 si consend a zentilhomini
cittadini et qualuncho altro di comprare biade nel Dominio per approvvigionare la cittagrave di fatto si sand un diritto allincetta che mise fuori gioco i fornai a cui venne imposto di rifornirsi nei solarimiddotdei cittadini senza avere piugrave la possibilitagrave di effettuare acquisti nel contado e di ritenere a casa scorte superiori amiddotl 00 staia di frumento Lintento della disposhysizione egrave chiarissimo espresso senza reticenze dai Maestri delle Entrate che riportarono al marchese la soddisfazione dei possidenti mantovani per la riforma statutaria
tutta la Terra [cioegrave il Mantovano] ne [egravel rimasta satisfactissirna pensando che Vostra Excellenilii pretenda ali comodi et utilitagrave universagrave1e senza dampno et preuiditio suo Vero egraveche li fumari non si contentano parendoli comegrave il vero che non si poteranno ingrassar a suo modo come haqno factO per il passato et poteria achader [bulll Che venetanno adolershyse et supplicar aVosUa Signoria Perograve me egrave parso d~ene aviso per ques~ nostra et farli inteni1er Che questaterril ha solii due membri de li quali li cittadini soi se ne possono aiutashyre e valersene uno egrave il grano laltro egrave larte de la lana et quando se concedesse che li furshynari potessero comprare come hapno facto li tempi passati sana un fare benefitio acinquanshytaocto dessi et dampnificharelreslO de la republicasua quale de questo bon ordine ne receve emolumento grandissimo et se gaude in la Citagrave [percheacute] li fumari portano fuora el denaro et pretendono solo a suo benefitio (AG b 2441 lettera del 13 luglio 1492)
Egrave indubbio che il plauso della Terra fosse da attribuire piugrave alla possibilitagrave per i proshyprietari di accrescere le proprie entrate che a quella dei consumagravetori cittadini e dell arte della lana di trarre beneficio daJla disposizione Egrave significativo che la motivazione pro civitate nori accenni allesistenza di monopoli da parte dei fornai o di artificiose lievitashyzioni dei prezzi per causa lOro nloro attivismograve non egraveonfliggeva per quanto riguarda i prezzi finali della sussistenza con linteresse dei produttori cittadini E daltra parte largomentodello stomo dal metFato cittadino dei profitti incamerati dai fornai -laccushysa consueta a proposito deipistores egrave che fossero in gran parte stranieri (GUBNZl 19824
22) -- era unagiustificazione debole che appassionava piugrave chi concorreva direttamente
491 498 Renzo P Comtore
alla spartizione dei proventi derivanti dalla vendita e dal commercio del grano shylemolumento grandissimo - di chi doveva poi fruire della redistribnzione di tale ricchezza Tale norma avvantaggiava i possidenti cittadini e i gentiluomini ptivilegiashyti in grado di ottenere le tratte di esportazione Sul piano dellappropriazione essi erano in condizione di mettere fuori gioco gli altri possessori che producev~o eccedenze nel Dominio poicheacute si accresceva Igravea loro forza contrattuale e la loro capacitagrave di occUpare i canall commerciali piugrave redditizi Sul piano della commercialiZzazione gli stessi fruivashyno dello smantellamento della rete dintennediazione rappresentata dai fornai Per i rushystici significava perdere un collegamento essenZiale con la cittagrave ed essere emarginati dal mercato urbano nelle campagne o sul broletto di Mantova essi non trovarono piugrave i trashydizionali interlocutori (CORBlJ9RE 2000 228 231-2)
Nel caso di Bologna terra strutturalmente deficitaria e cittagrave dalla vocaiione manishyfatturie~ si costringeva i fornai ad acquistare formenti terrieri presso i solari privati in cittagrave proibendogligrave lincetta nel contado autorizzandoli ad acquistareformentiforeshystieri al di fuori delle mura cittadine presso i sensati da grqno solo a patto che fosseshyro stati smaltiti i grani cittadini a un prezzo talora superiore a quello dei grani dimshyportazione (GUlNZI1982A35 52-3)
Nella Toscana dei Medici il diritto allincetta nel contado venne concesso ai fornai in periodo di bassa congiuntura (in particolare dagli anni Trenta del Seicegravento)Per sostenere i prezzi interni in tal caso essi restavano gli interlocutori principali dei granshydi proprietari semplicemente spostando la loro principale fonte di approvvigionashymento dai solari dei particolari in cittagrave ai granai decentrati delle grandi aziende agrishycole oppure ai mercati rurali su cui affluiva la produzione cerealicola delle grandi fattorie (PuLT QUAOUA 1984 86-9 PuLTQUAOUA 1990 100 106-7)
Laddove non vi egrave come invece succede a Genova una diretta ingerenza del potere pubblico nella vita della corporazione (MAsSA 1999) i fumai di cittagrave - nonostante i lacci e lacciuoli normativi e il lavoro prevalentePlente manuale svolto neiloro laboshyratori - erano dei veri imprenditori dipendenti per il loro profitto - noininalmente stabilito per legge - dalla produttivitagrave del lavoro e dalla dotazione tecnica e finanziaria delle imprese Di ciograve fa fede la grande sperequazione esistente fra le aziende speciashylizzate nena fabbricazione del pane venale in cittagrave (AYMARD 1966 75 VECCHltltJQ 1979 82-3 GUlNZI1982 77 segg PuLT QUAOUA 1984 100 102-3) NellItalia delshyletagrave moderna questi artigiani-imprenditori della filiera del grano trattavano insieme
afarinaifarinaiolifarinottifondachierifontechierifidelariformentinari lasagneshyri maccaronari torallari vermicellari ecc fra il 40 e il 70 per cento del frumento consumato in Cittagrave nelle annate normali (CoRRJTORE 2000 126 segg) e ~ino al 100 per cento nelle annate di carestia (Puu QUAOUA 1984 98-9)
In una ricognizione delle asimmetrie informative del mercato non cegrave gruppo quale i fornai che possa integraverpretare la parte dell agente economico onnisciente Se dunque i regolamenti annonari tendevano a regolare minuziogravesamente la collocazione il volushyme e la durata delle loro scorte cosi come disponevano per gli altri artigiani della fishyliera era per neutralizzare il carattere potenzialmente eversivo di tale accantonamenshyto per i proprietari-venditori Prima ancora che per i consumatori-acquirenti n livello delle scorte rinforzava o attenuava il rischio di monopsonio da parte dei pistores piugrave potenti e facoltosi cosigrave come eventuali tentazioni da parte della categoria di esercitare un dominio egoistico sul mercato del pane (MAITOZZl1983 298)
Sarebbe quindi un errore concepire le scorte dei fornai come entropica allocazione di capitale che sconta lincertezza futura esse venivano gestite secondo criteri di rashyzionalitagrave economica e secondo la migliore efficienza tecnica nonostante i vincoli imposti alla lievitazione degli stock dalle disposizioni annonarie
lA costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
vimini paglia o canne intrecciate (come ceste stuoiecannizzi) in terracotta (addirittura anfore) piuttosto che di tessuto (i sacchi costavano troppo) (PICCINNl1976 397 MAzzA RAvEGol 1983 174-5 Zoo Toce 1990 893-4 COIiITONES11991 35n-36n)
Nella casa del piccolo produttore o del titolare di un piccolo possesso il penw (la scorta domestica) difficilmente eccedeva il consumo famigliare chi fortunato raccoshyglieva piugrave dell annona famigliare e di quanto gli serviva per il campo era spinto a venderselo nei mesi immediatamente successivi alla mietitura e alla trebbiatura per necessitagrave di denaro ma anche per la difficoltagrave di stoccare e conservare il prodotto in condizioni ottimali (MEuvRET 1988 17-9 PuLT QUAOUA 1984 88) e figravenanco per ridurre il rischio di vederselo soffiare da vagabondi e malintenzionati In questo caso in presenshyza di eccedenze (ma probabilmente anche in assenza) il bisogno di liquiditagrave e lalea cospiravano nel ridl1ITe ai minimi termini le scorte giagrave allindomani del raccolto In caso alternativo il contadino che non egrave - ripete Jean Meuvret - un homme daffaires quanshyto un homme de peur concepiva la sua riserva come un fondo di previdenza sul racshycolto futuro da non immettere sul mercato se non nel caso dellapprossimarsi di una messe sicura secondo una logica economica a contrario (MEUVRET 1988 19 e 147)
Era Jl~tente la disparitagrave fra i produttori non solo fra chi era in possesso di eccedenshyze e chi non lo era ma piugrave anqgtra fra chi poteva scegliere in virtugrave di una maggiore capienza economica e unadeguata dotazione tecnica - il mercato piugrave favorevole per i propri grani (il periodo di saldatura dei raccolti) e chi invece li cedeva troppo presto o in controtempo a livelli non ottimali
Nella gerarchia delle abitazioni rurali -- in quel vero e proprio saggio di sociologia che egrave il sesto libro del DeArchitectura di Sebastiano Serlio (scritto fra il 1537 eil 1555 inedito per tutto levo moderno) -- per trovare case attrezzate di granaio occorshyreva ascendere sino alla magione del basso mercante o cittadino fuori della cittagrave (SERLlO 1994 43 segg anche per le successive informazioni) Condizione di cui non potevano fregiarsi invece i ricchi contadini in ~essuno dei tre gradi possibili di ricshychezza al massimo la loro casa poteva essere attrezzata di portici per ricoverare le biade e di unaia per batterle segni di distinzione giagrave fra i mediocri contadini Fra questi perograve avrebbero potuto avvalersene soltanto i fortUIgravelati et di beni et di famishyglia (3deg grado di mediocritagrave) nforno per cuocere il pane e una cantina per conservashyre il vino invece li si sarebbe trovati a partire dai piugrave accomodati fra i poveri contashydini cioegrave al 4deg gradino della scala sociale alla cui base erano da collocare i poveri mendichi con vii capanna (10 grado di povertagrave) i salariati che vivevano delle [loro] fatiche avendo un puoco di terreno (2deg grado di povertagrave) i poveri con qualche beshystiuola et massimamente de buOvi possessori di una stalletta congiunta con la casa 0deg grado di povertagrave)
In sintesi nelle campagne delletagrave pre-industriale pochi avevano scorte pochissimi erano in grado di ricoverarle in un solaro privilegiatissimo chi le incanevava per speculare Dunquefra i conta4ini se si esclude quanto celato nella madia o nella dishyspensa le scorte erano un pri~ilegio di pochi nSerlio nato intorno al 1475 insiste sullimpoverimento delle class~ rurali intervenuto fra gli anni della sua giovinezza e quelli della vecchiezza in cui scrive Sotto il titolo Dellabitazione del ricco contadishyno per tre gradi di ricchezza si preoccupa di puntualizzare
bencheacute al di dogi non se n~ truovi piugrave de tali merceacute delle discordie et di gli animi fieri et ostinati alla vendetta onde per tal cagioni et per le continue guerre et anche pei citadini divoratori de gli altrui beni che con le usure con glinganni con le rapine gli bano impoveriti (SERUO 1994 ~8)
490 RellOP CorrilOle
colto (agosto-settembre-ottobre) e invia di esaurimento almomento della saldatura dei raccolti (aprile-maggio-giugno )1A questo proposito nota Franccedilois Sigaut
Le stockage agrave court terme (moins dune campagne) reacutepond agrave la neacuteCessiteacute cIeacute concilier une offre variable et une demande constante mais toutes deux reacutegulieacuteres et preacutevisibles dans la
pratique il est consideacutereacute comme tiiisant pame du processus ordinaire de la production et ne pose agrave ce titre que desproblegravernes doptimisation assez simples (SlOAUI 1985 602)
La discussione generale sulla razionalitagrave economica delle scorte alimentari in etagrave pre-industriale puograve allora essere ridotta alla fonnulaiione e allo scioglimento di due
semplici quesiti 1 Accertato che laccantonamento digram per la periodicitagrave annuale del ciclo agricoshy
lo epet i vincoli tecnici di un rifomimento spazialmente allargato egrave inevitabile chi egrave conveniente che conservi le scorte chi produce o chi commercia il contadino o il mercante lapossidenzagrave o il popolo i particolari o il pubblico E qual egrave la realtagrave effettiva
2 Se le forme di distribUzione economicamente razionale sono plurali in quale conshytesto e in omaggio a quali interessi piugrave utile il sistema della canova rispetto al sistema delll piazza del mercato e dei solari privati
3 SULLADISTRIBUZIONE DEL GRANO NELUETAgrave PRE-INDUSTRIALE E LA STRUTTURA DELLE SCORTE NEI TERRITORI ITALIANI
Raramente le case contadine erano dotate di attrezzature per la conservazione dei cereali piugrave che elementari Nelle campagne toscane del Quattrocento dunquein unetagrave favorevole al reddito contadino in una regione fra le piugrave ricche dellEuropa pre-indushystriale
pochissime case contadine disponevano del granaio vero e proprio alcune avevano una cella che poteva servire allo stesso scopo ma la maggior parte di quelle abitazioni era priva di spazi destinabili esclugravesivamente alla conservazione dei cereali Perciograve i contenitori dei grani arche casse sacchi bugnole - dovevano trovare posto nelle cucine o nelle camere CMA= RAVEGGI 1983 174)
Le ridotte capacitagrave patrimoniali e reddituali della grande maggioranza dei produttori facevano sIgrave che fosse ampiamente invalso nella conservazione domestica dei grani limshypiego di contenitori in legno (come arche casse botti bugnole tini tinelle corbelli)in
Riguardo ai passi evidenziati di Zanetti e Cipolla egrave neCessario osservare che la principale atteshystazione sullesistenza di stock detenuti da privati che esorbitassero ilfabbisognostagionale tali da essere classificati come immobili=zione di ricchezza (Zanetti) o come beni capitale (Cipolla) a unanalisi piugrave fine si rivela fallace o non direttamente utilizzabile La propalazione dei grani effetshytuata a Pavia fra ilimiddot e il5 maggio 1555 che egrave il fondamento di entrambi i giudizinon mostra una somma di derrate realmente eccedente il fabbisogno delle famiglie per il periodo che manca allarri_ vo dei grani novelli sulla piazza pavese Daltra parte lastessa natura dellistituto della propalazioshyne dei grani cioegrave della denljncia obbligatoria delle scorte da parte dei particolari una misura demergenza decisa in momenti critici dellapprovvigionamento cittadino affiancata quellanno dalshylispezione diretta presso le case dei privati da parte di deputati straordinari avrebbe dovuto consishygliare una maggiore cautela nella sua utilizzazione per individuare regolaritagrave di carattere generale delleconomia pre-industriale
499 La costituzione di scorte granarie pubbliche e la ptlitica ecoMmica degli stati
FONTI
ABEL [1966) W ABEL Agrarkrisen undAgra~kJJnjunktur Eine Geschichte der londshy und Erniihrungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter Hamburg
und Berlin Paul Parey 19662 (la ed -1935 trad it Congiuntura agraria e crisi agrarie Storia dellagricoltura e della produzione alimentare nellEuropa centrashyle dal XIII secolo alletagrave industriale Torino Einaudi 1976 da cui si cita)
AG ARCHIVIO GoNZAGA presso lArchivio di Stato di Mantova AuFANO 1996 E AuFANO Il grano il pane e la politica annonaria a Napoli nel Setshy
tecento Napoli ESI 1996bull AYMARO 1966 M A YMARO Wmise Raguse et le commerce du bMpendant la seconde
moitieacute du XVI siegravecle Pans SEVPEN 1966 CATIINI 1984 M CATl1NI I contadini di San Felice Metamorfosi di un mondo rurale
nellEmilia delletagrave modernIgravel Torino Einaudi 1984 CESTARl 1794 p CESTARI Saggio storico dei Fondachi delle farine di Chioggia e
Pellestrina Venezia A Zatta 1794 CIPOllAJ1965] C M CIPOllA La politica economica dei governi V La penisola
italigraveana e la penisola iberica in Storia economica Cambridge m La cittagrave e la politica economica nel Medioevo Torino Einaudi 1977 (Cambridge 1965) pp 462-496
CIPollA 1974 C M CIPollA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna nMulino 1974
CIpollA 1997 C M CIPOllA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna nMUlino 1997 (6 ed riveduta)
CORRITORE 2000 R P CoRRITORE La naturale abbondanza del Montovano Produshyzione mercato e c01isumi granari a Mantova in etagrave moderna Pavia Universitagrave di Pavia 2000
CORIONBSI 1991 A CORIONBSI Sulla conservazione dei cereali nellItagravelia medioevale Lavoro e tecniche nelle tesnmonlanze laziali (secc XIII-XV) in Rivista di storia dellagricoltura XXXI 1991 l pp 33-49
DELLA VALENTINA 1992 M DELLA VALENTINA I mestieri del pane a ~nezia tra 600 e 700 in Atti dellIstituto [Veneto di Scienze Lettere ed Arti Classe di scienze morali lettere ed arti CL 1991-92 pp 113-217
DIRLMEIER 1984 U DIRLMEIER le condizioni materiali dellesistenza nelle cittagrave tedeshy sche del Basso Medioevo ~iente esterno reddito consumi in Aristocrazia citshy
tadina e ceti popolari nel tprdo Medioevo in Italia e in Germania (a cura di Reinhard Elze e Gina Fasoli) Bologna Societagrave editrice il Mulino 1984 pp 79shy122
FORNASIN 1999 A FORNASIN Il pzercatodei grani di Udine Indagine per una storia dei prew in Friuli (secoli XfI-XVIII) Nota di ricerca del Dipartimento di Scienshyze Statistiche dellUniversit4 degli Studi di Udine 4 1999 pp 1-24 ora in lo La Patria del Friuli in etagrave 1fIOderna Saggi di storia economica Udine Forum 2000 pp 33-60
GRENDI 1986 E GRENOI Lapprccedilwigionamento dei grani nella Liguria del Seicento libera pratica e annone in iMiscellanea storica ligure Studi in onore di Luigi Bulferetti XVIII 1986 2Jp 1021-1047
GUENZI 1981 A GUENZI Ilfrurnfnto e la cittagrave il caso di Bologna nelletagrave moderna in Quaderni storici XVI ~981 46 pp 153-167
GUENZI 1982 A GUENZI Pane ~fornai a Bologna in etagrave moderna Venezia Marsilio 1982
I
489 500 Renzo P CornIOle
GUBNZI1982 A GUEml Sistema annonario e egraveontrollo sociale a Bologna nei seccediloli XVII e XVIII in E SORI (a cura di) Cittagrave e controllo sociale in Italia fra XVIII e XIX secolo Milano F Angeli 1982 pp 293-306
HICKS [1989] 1 R HIClCS A narlcet theory of money Oxford Oxford Universigravety Press 1989 (trad it Una teoria di mercato della monefa Bologna li Mulino 1992 da cui sigrave cita)
JACOPBITI 1965 N L JACOPBITI Monete e prezzi a Cremona dal XVI al XVlIi secolo Cremona Athenaeum CregravemoneJlSe 1965
KAPLAN 1984S L KAPLAN Provisioning Paris Merchants and Millers in the Grain and Flour Trade during the Eighteenth Century Ithaca-London Cornell Univershysity Press 1984~middot
KULA [1962] W KULA Teoria ekonomiczna ustrojufeudalnego Proba modelu Warshyszawa-Panstwowe WydawnictwoNaukowe 1962 (trad it Teoriagrave economica del sistema feudale Proposta di un modello Tormo EinaUdi 1972 ccedilla cui si cita)
WROUSSE [1933] C-E LABRoussE Esquisse du mouvement des prix et des reverws en France au XVIII siegravecle Paris Eacuteditions des Archives Contemporaines 19842 volI (l ed Paris Librairie Dalloz 1933)
MALANtMA 1976 P MALANiMA Aspetti di mercato e prezzi del grano e della segalea Pisa dal 1548 al 1818 in Ricerche di storia moderna vaL I Pisa Pacini 1976 pp ~n
MANToVA 1430 MwroVA 1430 Pareri a Gian Francesco Gonaga per il governo (a cura di M AQrignaniA M Lorenzoni A Mortari C Mozzarelli) MUltova G~ Arcari 1990
MASSA 1999 PMAssA Annona e corporazioni del settore alimentare ~ Genova orshyganizzazione e conflittualitagrave (XVI-XVIII secolo) in A GUENZI PMAssA A MOIOshyu (a cura di) Corporazioni e gruppi professionali nellItalia moderna MilIllO F Angeli 1999 pp 390-403
MATIoZ7J 1983 1 MiJroZ7J F BOLELLI C CmAsBRA D SABBIONI Il politico e il pane a Venezia (157Q-1650) calmieri e governo della sussistenza in Societagrave e storia VI 198320 pp 271-303
MAzzI RAVEOOI 1983 M T MAzzI S RAVEOGI Gli uogravemini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento Firenze Olscbki 1983
MERONI 1957 U MERONI Cremona fedelissima Ciemona Athenaeum Cremonenshy~~~ _
MBUVRBl 1977 J MEuVRsT Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque LouisXIvI La productiograven des ceacutereacuteales dans la France du XVII et du XVIII siegravecle Paris Mouton -EacuteEHSS19772voll
MBUVRET 1988 J MBtJVRf Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque Louis XIv III Le commerce des gralns et la conjoncture Paris EacuteEHss 1988 2 volI
PtCClNNI 1976 G PtCClNNl Wta contagravedina in una capanna dei dintorni di Siena (1250) in ~Archeologia medievale m 1976 pp 395-399
PlNIO 1978 G PINTOII Libro del BiaPaiolo Carestie e annona a Firenze dalla metagrave del 200 al 1348 Fire~ Olscbki 1978
PiNTO 1982 G PtNro La Toscana nel tardo Medioevo Ambiente economia rurale societagrave Fllenze Sansoni 1982
PtRENNE [1933J H PIRENNB La civilisation occidentale au Moyen Age du XIe au mishylieu du XVe siegravecle Paris PUF 1933 (trad it Storia economica e sociale del Meshydioevo Milano Garzanti 1967 da cui si cita)
Lacostituticne di scorte granarie pubbliche e la politica economiegravea degli stati
redigravestribuzione sostenibile dei beni di sussistenza egrave ricercata in questo cielo da quegli stessi particolari che ~amaldeggiano nella produzione negli scambi nei consumi e che costituiscono il nerbo della classe di governo Le scorte pubbliche rappresenteshyrebbero in questa prospettiva un presidio civico e un risltCimento politico e morale ai cOl1ponenti della comunitagrave spossessati delbene supremo dellautarchia alimentare
Resta infine latente unidea del magazzmo pubblico come quasi-mercato cioegrave come luogo volto (1) a risolvere i fa1limentiinfo~vi della piazza del mercato (in meacuterito alle disponi~ilitagrave alle caratteristiche del prodotto alle condizioni di vendita della merce) (2) a ridimensionare lalea per agricoltori consumatori poveri artigiani del comparto alimentare (3) a sostenere i consumi e i profitti privati m funzione anticicli ca in una prospettiva Ilpn meram~nte congiunturale Si tratta in questo caso di un orshyganizzaZionepienattiCnte razio~e Che non opera in maniera saltuaria e riflessa ma in modo continuativo secondo obifttili prefissati di allocazione dei beni primari li funshyzionamento dellacanovagrave (il magazzino pubblico) si porrebbe come strumento inteshygrativo ma no~~igraventeramente so~titutivo delloperare della piazza Si tratterebbe di unaforma di mercato distinta dalla p~ del mercato considerata in seacute e per seacute cosigrave come dallegraveOOmpravendite effetttlate nei solari privati o dalla mera centrallzzazione e redistribuzione di derrate con fi~alitagrave umanitarie La canova rappresenterebbe in tal modo uno dei possibili meccaoi~ di governo delle trllls3ZIgrave~ni locali per risolvere i problemi deUapprovvigionameIto senza intaccare certi interessi di classe (dei proshyprietari ma anche del popolo grasso) S da essere prescelta da autoritagrave e gruppi domishynanti come struttura complementare della piazza del mercato incerti contestiprodutshytivi ed economici La suasacrilizzazione perciograve non esclude la possibilitagrave di un ritorno alle sole compravendite qella piazza e dei solari privati - una volta invertishytosi il trend o spirate le condizioqi economiche della sua istituzionalizzazione
La problematizzazione esorc~ una liquidazione semplicistica del problema delle scorte gran8rle in etagrave pre-industriUgravee nel nome di una loro presunta irrazionalitagrave eco- nomica per il compito di assi~ la sussistenza della popolazione
Le pagine che segUono sono rintroduzione a un lavoro in corso volto a offrire un interpretazione generale di tal~ capitolo fondamentale della politica economica dei governi
in
etagrave pre-industriale
2 SE UN MONDO SENZA SCORTE Egrave INCONGRUO cm Egrave OPPORTUNO CHE LEgrave DETENGA
Nei fatti nel settore granarlo CQni vincoli dell etagrave pre-industriale in tema diprodutshytivitagrave energia trasporti non ha s~nso ipotizzare un mondo senza scorte Se il mercato del grano egrave - come nellEuropa medievale e moderna - un sjstema tendenzialmente chiuso
ad ogni raccolto nuove offe~ aniv(erannol sul mercato mentre la domanda si mant[erragrave] relativamente costantt nel corso dellanno Qualcuno dunque [dovragrave] ~ere delle scorte che saranno elevate ~ubito dopo il raccolto e poi via via minori fino aragshygiungere un livello minimo in prpssimitagrave del successivo raccolto (HICICS [19891 31)
Nella loro forma piugrave sempliceI tali scorte saranno legate allora alla periodi~itagrave anshynuale del ciclo agricolo (che a1iplenta il movimento stagionale dei prezzi ccedilfr LAshyBROlJSSE [1933] 157-66) il loro livello saragrave elevato allindomani del principiLle racshy
501 488 Renzo P Corritore
povero ammassograve nella propria dimora scorte di grano carne ~alata sale candele ecc e la medesima cosa fece lo Stato Nel periodo feudale non venne mai meno nel castello del signore labitudine di tenere da parte grosse scorte per i periodi di emergenza Sucshycessivamente le autoritagrave comunali predisposero il magazzinaggio di grosse derrate specie di grano da rivendere a basso prezzo in periodi di emergenza e nello stesso tempo si preoccuparono di prevenire un indebito accumulo di scorte da parte di specushylatori privati Nelle economie medievali gli stock di derrate di prima necessitagrave rappreshysentarono pertanto una delle piugrave importanti forme di investimento pubblico e privato (CIPOLLA (1965] 468)
Nella prima versione del manualeacute invece fino allinserimento nel 1997 del nuovo capitolo dedicato alla politica economica nell etagrave pre-mdustriale il punto di vista preshyvalente era quello microeconomico entro il perimetro stretto dellindividualismo meshytodologico
Le scorte costano e costano doppiamente Esse implicano il costo diretto che egrave rapshypresentato dal costo del magazzinaggio edal deterioramento eventuale del pr04otto o di parte di esso Se luomo daffari finanzia la costituzione delle scorte con danaro preso a prestito il costo diretto include anche il tasso di interesse pagato Se luomo daffari finanzia con capitale proprio la costituzione delle scorte il costo delle scorte deve inshycludere un costo-opportunitagrave e cioegrave il mancato rendimento (tIllU1cato tasso dinteresse attivo) del capitale finanziario impiegato (CIPOLLA 1974 154)
Le ragioni della costituzione e del mantenimento di scorte alimentari da parte delshylautoritagrave pubblica diventavano unicamente ragioni morali (umanitarie e di buona amministrazione) o di opportunitagrave politica (la fame era la piugrave frequente ligraveausa di sommosse e furori popolari) (CIPOLLA 1974 74)
Nel 1997 si riammetteva dunque linterpretazione originaria della costituzione di scorte pubbliche come strumento di riequilibrio del mercato senza peraltro rinnegare le considerazioni sulla valenza statica di tale forma di investimento per gli agenti economici privati
In merito allutilitagrave economica e al significato delle scorte in etagrave pre-industriale Cishypolla non espresse perciograve sempre lo stesso punto di vista La rassegna delle posizioni da lui assunte anzi permette di individuare tre approcci e tre giudizi costitutivamente diversi sulla funzione delle scorte granarie nellepoca pre-industriale
In prima approssimazione laccumulazione di scorte alimentari mostra il carattere fondamentalmente difensivo delle scelte degli agenti economici pubblici e privati in etagrave pre-industriale La paura la tradizione la superstizione li induce a tabuizzare il rischio la speculazione linvestimento nella produzione e nella distribuzione dei beni essenziali alla vita e ad aderire intimamente a un ideale di economia e societagrave stazionarie aggravando con la norma sociale le istituzioni il comportamento indivishyduale e collettivo leffetto dei condizionamenti materiali delleconomia pre-industriashyle (bassa produttivitagrave agricola alti costi di v~sporto modesta efficienza energetica) esponendo ancor di piugrave la comunitagrave umana ai degravemoni della natura
La seconda interpretazione rigetta luniversale imperio dellhomo oeconomicus rishyscoprendo leteronomia dei fini dellagire economico degli uomini nelletagrave pre-inshydustriale Ia politica economica dello Stato o-delle autoritagrave non persegue puri scopi economici lintegritagrave del corpo sociale fin nelle sue cellule elementari (persone e famiglie) deve essere assicurata secondo i principi e la prassi di uneconomia morale che SOVJa5ta leconomia regolata dal mercato spersonalizzata e antipopolare Una
La costituzione di scorte grantlTie pubbliche e la poligravetigraveca economica degli stati
PuLT QUAGUA 1984 A M PULT QUAGUA Mercato dei prodotti agricoli e magistratushyre annonarie a Pisa nelletagrave moderna in Ricerche di storia moderna a cura di M Mirri voI III Pisa Pacini 1984 pp 57-141
PULT QUAGLIA 1990 A M PULT QUAGLIA Per provvedere ai popoli Il sistema anshynonario nella Toscana dei Medici Firenze Olschki 1990
SERUO 1994 S SERLIO Architettura civile Libri sesto settimo e ottavo nei manoscritshyti di Monaco e Vienna (a cura di F P Fiore) Milano TI Polifi10 1994
SIGAlIT 1985 F SIGAlIT Questions deacuteconomie agrave propos des politiques ceacutereacutealiegraveres et de stockage in Les techniques de conservation des grains agrave long terme leur rale dans la dynamique des systegravemes de cultures et des socieacuteteacutes (sous la direction de M Gast F Sigaut et C Beutler avec la collaboratlon de O Bllchsenschutz) voI III 2 Paris Eacuteditionsdu CNRS 1985 pp 597-606
SMITH [1776 A SMITH An inquiry into the nature and causes ojthe wealth ojnations London W Strahanand T Cadell 17762 volI (trad it Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni Milano A Mondadori 1977 2 volI da cui
si cita) STATlITlBoNACOLSIANI [1313] STATUTI BONACOLSlANl (a cura di E Dezza A M Lorenshy
zoni M Vaini) Mantova GArcari 2002 STATUTI GONZAGHESCHI [1404] STATUTI GONZAGHESCHI presso la Biblioteca comunale di
Mantova ms FV 11 [775]VECCHIATO 1979 F VOCCHIATO Pane e politica annonaria in Terrajerma veneta tra
secolo XV e secolo XVIII (Il caso di Verona) Verona Stamperia Zendrini 1979 ZANETTI 1963 D ZANETTl Contribution agrave leacutetude des structures eacuteconomiques lapshy
provisiQnnement de Pavie au XVI siegravecle in Annales ESC XVIII 1963 1 pp 44-62 ora in lo Fra le antiche torri Scritti di storia pavese Pavia Universitagrave di Pavia 2000 pp 165-182
ZANETTl 1964 D ZANEITI Problemi alimentari di una economia preindustriale Ceshyreali a Pavia dal 1398 al 1700 Torino P Borlnghieri 1964
ZUG TUCCI 1990 H ZUG TuCCI Le derrate agricole problemi materiali e concezioni mentali della conservazione in Lambiente vegetale nellalto Medioevo XXXVII Settimana di studio del Centro italiano di studi sullalto Medioevo (30 marzo-5 aprile 1989) Spoleto Centro italiano di studi sullalto Medioevo 1990 voI n pp 865-902
489 500 Renzo P Capitare
GUENZI 1982 A GUBNZI Sistema annonario e controllo sociale a Bologna nei secoli XVII e XVIII in E SORI (a cura di) Cittagrave e controllo sociale in Italia a XVIII e XIX secolo Milano R Angeli 1982 pp~ 293-306
HICKS [1989] J R HICKS A nwrket theory of money OxfQrd Oxford University Piess 1989 (trad itmiddot Una teoria di mercato della moneacuteta Bologna Il Mulino 1992 da cui si cita)
JACOPEn 1965 N I JACOPEITI Monete eprewa Cremona dal XVI al XVIII secolo Cremona Athenaeum Cremonense1965
KAPLAN 1984S L KAPLAN Provisioning Paris Merchaius and Millers in me Grain and Flour Trade during the Eighteenth Century Ithaca~London Cornell Univershysity Press 1984~middot
KULA [1962] W KULA Teoria ekonomiczna ustrojufeudalnego Proba modelu Warshyszawa~4nstwowe WydavnictwoNaukove 1962 (trad it Teoria economica del sistema feudale Proposta di un modello lorino EinaUdi 1972 da cui si cita)
LABROUSSB [1933] c-E LABRoussB Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIII si~cle Paris Eacuteditions des Archives Contemporaines 1984 2 voll (1 ed Paris Librairie Dalloz 1933)
MAlANIMA 1976 P MALANlMA Aspetti di mercato e prew del grano e della segale a Pisa dal 1548 al 1818 in Ricerche di storia moderna voL I Pisa Pacini 1976 pp289-327
MANTOVA 1430 MANTOVA 1430 Pareri a Gian Francesco Go~ga per il governo (a cura di M A Grignani A M Lorenzoni A Mortari C Mozzarelli) Mantova G Arcari1990
MAsSA 1999 PMAsSA AMonae corporazioni del settore alimentare ~ Genova orshyganizzazione e corflittualitagrave (XVI-XVIII secolo) in A GPJlNZI P MAsSA A MOlOshyu (a cura di) Corporazioni e gruppi professionali nellItalia moderna M4ano R Angeli 1999 pp 390403
MAnoZZI 1983 I MATroZZl R BoLEUl C CHiAsBRA D SABBIONl Il politico e il pane a Venezia (1570-1650) calmieri e governo della sussistenza in Societagrave e storia V1198320pp271-303
MAZZI RAVBOOI 1983 M T MAzzI S RAVBOOI Gli uomini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento Firenze Olscbki 1983
MERONI 1957 U MERoNI Cremonafedeiissima Cremona Athenaeum Cremonenshyse1957
MBUVRET 1977 J MBUVRm Le progravebl~me 4es subsistances agrave leacutepoque LouisXIv 1 La productiOn des ceacutereacuteales dans la France du XVIIet du XVIII si~cle Pans Mouton - EacuteEHss 1977 2 voll
MBUVRm 1988 J MBuVRET Le probl~me des subsistances agrave leacutepoque Louis XlY III Le commerce des grains et la conjoncture Pans EacuteEHss 19882 voll
PICClNNI 1976 G PICClNNl Vita contluJina in una capanna dei dintorni di Siena (1250) in Archeologia medievale JII 1976 pp 395-399
PINTO 1978 G PINTO Il libro del Biadaiolo Carestie e annona a Firenze dalla metagrave del 200 al 1348 Firenze Olschld 1978
PINTO 1982 G PINTO La Toscana nel tarda Medioevo Ambiente economia rurale societagrave Firenze Sansoni 1982
PIRENNB [1933J H PmmINB La civilisation occidentale au Moyen Age du XIe au mishyZieu du XVe si~cle Paris PUF 1933 (trad it Storia economica e sociale del Meshydioevo Milano Garzanti 1967 da cui si cita)
wcostitlJlWne di scorte granarie pubbliche e la politica economiCa degli stati
redistribuzione sostenibile dei beni di sussistenza egrave ricercata in questo cielo da quegli stessi particolari che mllI8lllaldeggiano nella produzione negli scambi nei consumi e che costituiscono il nerbo della classe di governo Le scorte pubbliche rappresenteshyrebbero in questa prospettiva un presidio civico e un ris~nto politico e morale ai componenti della comunitagrave spossessati deIbene supremo dellaUtarchia alimentare
Resta infine latente unidea del magazzmo pubblico come quasi-mercato cioegrave come luogo volto (1) a risolvere i fallimenti informativi d~lla piazza del mercato (in megraverlto alle disponihilitagrave alle caratteristiche del prodotto alle condizioni di vendita della merce) (2) a ddimensionare lalea per agricoltori consumatori poveri artigiani del comparto alimentare (3) a sosteqere i consumi e i profitti privati in funzione anticicli ca in una prospettiva I0n meramente congiunturigraveugravee Si tratta in questo caso di unorshyganizzaZionepienamente razionale che non opera in maniera saltuaria e riflessa ma in modo continuativo secondo obiettivi prefissati di allocazione dei beni primari TI funshyzionamento deJlacanovagrave (il magazzino pubblico) si porrebbe come strumento inteshygrativo ma nOliinteramente sostitutivo delloperare della piazza Si tratterebbe di unaforma ( megravercato distinta dalla pi~ del mercato considerataIn seacute e per seacute cosl come dallegraverompravendite effetttiate nei solari privati o dalla meacutera centralJzzazione e redistribuzione di derrate con fiqatitagrave umanitarie La canova rappresenterebbe in tal modo uno dei possibili mecc~ di governo delle transaziopi locali per risolvere i problCmi dellapprovv~gionameqto senza intaccare certi interessi di classe (dei proshyprietari ma anche del popolo graSso) s) da essere prescelta da autoritagrave e gruppi domishynanti come struttura complemen8Ie della piazza del mercato in certi contestiprodutshydvi ed economici La suasacnilizzazione perciograve non esclude la possibilitagrave di un ritorno alle sole compravendite qella piazza ~ e del solari privati - una volta inverti- tosi il ~nd o spirate le condizio~ economiche della sua istituzionalizzazione
La problematizzazione esorcizza una liquidazione semplicistica del problema delle scorte graUarie in etagrave pre-indus~e nel nome di-~a loro presunta irrazionalitagrave eco- nomica per il compito di assicll1~ la sussistenza della popolazione
Le middotpagine che segUono sono Vintroduzione a un lavoro in corso volto a offrire uninterpretazione generale di tal~ capitolo fondamentale della politica economica dei govemi ~ etagrave pre-industriale
2 SE UN MONDO SENZA SGORTE Egrave INCONGRUO cm Egrave OPPORTUNO CHE LE DETENGA
Nei fatti nel settore granario conI vincoli delletagrave pre-industriale in tema diprodutshytivitagrave energia trasporti non ha ~nso ipotizzare un mondo senza scorte Se il mercato del grano egrave - come nellEuropa Igravenedievale e moderna - un sistema tendenzialmente chiuso
ad ogni raccolto nuove offeXfe arriv[eranno] sul mercato men~e la domanda si mant[erragrave] relativamente costanlf nel corso dellanno Qualcuno dunque [dovragrave1 ~nere delle scorte che saranno elevate isubito dopo il raccolto e poi via via minori fino lIragshygiungere un livello minimo in prpssimitagrave del successivo raccolto (HICKS [1989] 31)
Nella loro forma piugrave semplice tali scorte saranno legate allora alla perlodi~itagrave anshynuale del ciclo agricolo (che aUfnenta il movimento stagionale dei prezzi ccedilfr LAshyBROUSSB [1933 157-66) il loro livello saragrave elevato allindomani del prlnciprue racshy
499 490 RelloP COrrilore
colto (agosto-settembre-ottob~) e in via di esaurimento almomento della saldatura dei raccolti (aprile-maggio-giugno)lA questo proposito nota Franccedilois Sigaut
Le stockage agrave court terme (moms dune campagne) Ieacutepond agrave la neacuteCessiteacute egravek concilier une offre variable et une demande constante mais toutesdeux reacutegulieacuteres et pIeacutevisibles dans la pratique il est ccedilonsideacutereacute comme tagraveisant partie du procegravessus ordigravenaire de la prOduction et ne pose agrave ce titre quedes probJegravemes doplimisation assez simples (SIGAUT 1985 602)
La discussione generale sulla razionalitagraveegraveconomica delle scorte alimentari in etagrave pre-industriale puograve allora essere ridotta alla formulaZione e allo scioglimento di due semplici quesiti 1 Accertato che laccantonamento di grani per la periodicitagrave arinuale del ciclo agricoshy
lo epel i vincoli tecnici di un rifornimento spazialmente allargatoegrave inevitabile chi egrave conveniente che conservi le scorte chi produce O chi cOnlmercia il contadino o il mercante lapossidenza o il popolo i particolari o ilpubblico E qual egrave la realtagrave effettiva
2 Se le forme di distrigravebIgravelZIgraveone economicamente razionale sono plurali in quale conshytesto - e in omaggio a quali interessi - egrave piugrave utile iI sistema della canova rispetto al sistema della piazza del mercato e dei solari privati
3 SULLADISTRlBUZIONE DEL GRANO NELLETAgrave PRE-INDUSTRlALE E LA STRUTTURA DELLE SCORTE NEI TERRITORI ITALIANI
Raramente le case contadine erano dotate di attrezzature per la conservazione dei cereali piugrave che elementari Nelle campagne toscane del Quattrocento dunqueJn unetagrave favorevole al reddito contadino in una regione fra le piugrave ricche dellEuropa pre-indushystriale
pochissime case contadine disponevano del granaio vero e proprio alcune avevano una cella che poteva servire allo stesso scopo ma la maggior parte di quelle abitazioni era priva di spazi destinabili esclusivamente alla conservazione dei cereali Perciograve i contenitori deigrani - arche casse sacchi bugnole - dovevano trovare posto nelle cucine o nelle camere (MAzzI RAvEGOI 1983 174)bull
Le ridotte capacitagrave patrimoniali e reddituali della grande matregoranza dei produttori facevano si che fosse ampiamente invalso nella conservazione domestica dei grani limshypiego di contenitori in legno (come arche casse botti bugnoletini tinelle corbelli)in
Riguardo ai passi evidenziati di Zanetti e Cipolla egrave necessario osservare che la principale atteshystazione sullesistenza di stock detenuti da privati che esorbitassero ilfabbisogno stagionale tali da essere classificati come immobilizzazione di ricchezza (Zanetti) o come beni capitale (Cipolla) a unanalisi piugrave fine si rivela fallace O non direttamente utilizzabile La propalazione dei grani effetshytuata a Pavia fra ilIo e il 5 maggio 1555 che egrave il fondaIgravenento di entrambi i giudizinon mostra una somma di derrate realmente eccedente il fabbisogno delle famigiie per il periodo che manca allarrishyvo dei grani novelligrave sulla piazza pavese Daltra partelastessa natura dellistituto della propaazio- ne dei grani cioegrave della denllncia obbligatoria delle scorte da parte dei particolari una misura demergenza decisa in momenti critici dellapprovvigionamento cittadino affiancata quellanno dalshylispezione diretta presso le case dei privati da parte di deputati straordinari avrebbe dovuto consishygliare una maggiore cautela nella sua utilizzazione per individuare regolaritagrave di carattere generaledelleconomia pre-industriale
La costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli slatibull
FONTI
ABEL [1966] W ABEL Agrarkrisen und Agrarkonjunktur Eine Oeschichte der Landshy und Ernlihrungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter Hamburg
und Berlin Paul Parey 19661 (P ed -1935 trad it Congiuntura agraria e crisi agrarie Storia dellagricoltura e della produzione alimentare nellEuropa centrashyle dalXlII secolo alletagrave industriale Torino Einaudi 1976 da cui si cita)
AG ARCHIVIO GONZAGA presso lArchivio di Stato di Mantova AuFANO 1996 E AuFANO Il grano il pane e la politica annonarla a Napoli nel Setshy
tecento Napoli ESI 1996 bull AYMARD 1966 M AYMARD Veacutenise Ragusegrave et le commerce du bleacute pendant la seconde
motti du XVI siegravecle pans SEVPEN 1966 CA1TINl1984 M CATlINl I contadini di San Felice Metamorfosi di un mondo rurale
nellEmilia delletagrave moderna Torino Einaudi 1984 CEsTARI 1794 p CESTARI Saggio storico dei Fondachi delle farine di Chioggia e
Pellestrina~ bullbull Venezia A Zatta1794 CIPOLLA [1-965] C M CIPOllA La politica economica dei governi V La penisola
italigraveana e la penisola iberic(l in Storia economica Cambridge ID La cittagrave e la politica economica nel Medioevo Torino Einaudi 1977 (Cambridge 1965) pp 462-496
CirollA 1974 C M CiPollA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna TI Mulino 1974
CIpOLLi 1997 C M CIPOllA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna TI Mulino 1997 (6 ed riveduta)
CORRITORB 2000 R P CORRITORB La naturale abbondanza del Mantovano Produshyzione mercato e consumi grqnari a Mantova in etagrave moderna Pavia Universitagrave di Pavia 2000
CORTONESl 1991 A CORTONESr Sulla conservazione dei cereali nellItalia medioevale woro e tecniche nelle tesnnonianze laziali (secc XIII-XV) in Rivista di storia dellagricoltura XXXI 1991 l pp 33-49
DElLA VALENTINA 1992 M DEJ1A VALENTlNA I mestieri del pane a Venezia tra 600 e 700 in Atti dellIstituto igraveVeneto di Scienze Lettere ed Arti Classe di scienze morali lettere ed arti CL 1991-92 pp 113-217
DIRLMEIER 1984 U DiRLMEIER Le condizioni materiali dellesistenza nelle cittagrave tedeshy sche del Basso Medioevo wlwiente esterno reddito consumi in Aristocrazia citshy
tadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia e in Germania (a cura di Reinhard Elze e Gina Fasoli) Bologna Societagrave editrice il Mulino 1984 pp 79shy122
FORNASIN 1999 A FORNASlN II rnercatodei grani di Udine Indagine per una storia dei prezzi in Friuli (secoli X1(1-XVIII) Nota di ricerca del Dipartimento di Scienshyze Statistiche dellUniversitagrave degli Studi di Udine 4 1999 pp 1-24 ora in ID La Patria del Friuli in etagrave frtoderna Saggi di storia economica Udine Forum 2000 pp 33-60
GRENDI 1986 E GRENOl Lapprf(vvigionamento dei grani nella Liguria del Seicento libera pratica e annone in rMiscellaneastorica ligure Studi in onore di Luigi Bulferetti XVIII1986 2 IP 1021-1047
GUENZl 1981 AGUENZI Ilfrumento e la cittagrave il caso di Bologna nelletagrave moderna in Quaderni storici XVI ~98l 46 pp 153-167
GUENZlI982 A GUENZI Pane efornai a Bologna in etagrave moderna Venezia Marsilio 1982
l
491 498 Renzo P Corritore
alla spartizione dei proventi derivanti dalla vendita e dal commercio del grano shylemolumento grandissimo - di chi doveva poi fruire della redistribuzione di tale ricchezza Tale norma avvantaggiava i possidenti cittadini e i gentiluomini privilegiashyti in grado di ottenere le tratte di esportazione Spl piano dellappropriazione essi erano in condizione di mettere fuori gioco gli altri possessori che producev~o eccedenze nel Dorilinio poicheacute si accresceva la loro forza contrattuale e la loro capacitagrave di occupare i canali commerciali piugrave redditizi Sul piano della commercializzazione gli stessi fruivashyno dello smantellamento della rete dintermediazionerappresentata dai fornai Per i rushystici significava perdere un collegamento essenziale con la cittagrave ed essere emarginati dal mercato urbano nelle campagne o sul broletto di Mantova essi non trovarono piugrave i trashydizionali interlocutori (CORRIJ9RE 2000 228231-2)
Nel caso di Bologna terra strutturalmente deficitaria e cittagrave dalla vocazione manishyfatturie1a si costringeva i fornai ad acquistareformenti terrieri presso i solari privati in cittagrave proibendogli lincetta nel contado autorizzandoli ad acquistarefornientiforeshystieri al di fuori delle mura cittadine presso rsensati da grCUlO solo a patto che fosseshyro stati smaltiti i grani cittadini a un prezzo talota superiore a quello dei grani dimshyportazione (GTlBNZl1982A 35 52-3)
Nella Toscana dei Medici il diritto allincetta nel contado venne concesso ai fornai in periodo di bassa congiuntura (in particolare dagli anni Trenta del Seicegravento) Per sostenere i prezzi interni in tal caso essi restavano gli interlocutori principali dei granshydi proprietari semplicemente spostando la loro principale fonte di approvvigionashymento dai solari dei particolari in cittagrave ai granai decentrati delle grandi aziende agrishycole oppure ai mercati rurali su cui affluiva la produzione cerealicola delle grandi fattorie (PULT QUAOUA 1984 86-9 PucrQUAGUA 1990 100 106-7)
Laddove non vi egrave come invece succede a Genova una diretta ingerenza del potere pubblico nella vita della corporazione (MAsSA 1999) i fornai di cittagrave- nonostante i lacci e lacciuoli normativi e il lavoro prevalentemente manuale svolto neUord laboshyratori - erano dei veri imprenditori dipendenti per il loro profitto - noilrinalmente stabilito per legge - dalla produttivitagrave del lavoro e dalla dotazione tecnica e finanziaria delle imprese Di ciograve fa fede la grande sperequazione esistente fra le aziende speciashylizzate nena fabbricazione del pane venale in cittagrave (AYMARD 1966 75 VBCCHIATO 1979 82-3 GTlBNZl1982A
77 segg PULT QUAGUA 1984100 102-3) NellItalia delshyletagrave moderna questi artigiani-imprenditori della filiera del grano trattavano insieme
afarinaifarinaiolifarinottifondachierifontechierifidelarijormentinari lasagneshyri maccaronari taraltari vermicellari ecc fra il 40 eil70 per centodel frumento consumato in Cittagrave nelle annate normali (CORlUTORE 2000 126 segg) e ~no alIDO per cento nelle annate di carestia (PULT QUAGUA 1984 98-9)
In una ricognizione delle asimmetrie informative del mercato non cegrave gruppo quale i fornai che possa integraverpretare la parte dellagente economico onnisciente Se dunque i regolamenti annonari tendevano a regolare minuziogravesamente la collocazione il volushyme e la durata delle loro scorte cosi come disponevano per gli altri artigiani della fishyliera era per neutralizzare il carattere potenzialmente eversivo di tale accantonamenshyto per i proprietari-venditori prima ancora che per i consumatori-acquirenti nlivello delle scorte rinforzava o attenuava il rischio di monopsonio da parte dei pistores piugrave potenti e facoltosi cosi come eventuali tentazioni da parte della categoria di esercitare un dominio egoistico sul mercato del pane (MATroZZI 1983 298)
Sarebbe quindi un errore concep~ le sccedilorte dei fornai come entrilpica allocazione di capitale che sconta lincertezza futura esse venivano gestite secondo criteri di rashyzionalitagrave economica e secondQ la migliore efficienza tecnica nonostante i vincoli imposti alla lievitazione degli stock dalle disposizioni annonarie
LA costituzione di scorre granarie pubbliche e la polilica economica degli stati
vimini paglia o canne intrecciate (come ceste stuoiecannizzi) in terracotta (addirittura anfore) piuttosto che di tessuto (i sacchi costavano troppo) (PICClNNl 1976 397 MAzzA RAvBGGI 1983 174-5 Zoo Turo 1990 893-4 CORIONESI 1991 35n-36n)
Nella casa del piccolo produttore O del titolare di un piccolo possesso il penus (la scorta domestica) difficilmente eccedeva il consumo famigliare chi fortunato raccoshyglieva piugrave dellannona famigliare e di quanto gli serviva per il campo era spinto a venderselo nei mesi immediatamente successivi alla mietitura e alla trebbiatura per necessitagrave di denaro ma anche per la difficoltagrave di stoccare e conservare il prodotto in condizioni ottimali (MEUVRET 1988 17-9 Pmr QUAGUA 1984 88) e financo per ridurre il rischio di vederselo soffiare da vagabondi e malintenzionati In questo caso in presenshyza di eccedenze (ma probabilmente anche in assenza) il bisogno di liquiditagrave e 1alea cospiravano nel ridl1rre ai minimi termini le scorte giagrave allindomani del raccolto In caso alternativo il contadino che non egrave - ripete Jean Meuvret - un homme daffaires quanshyto un homme de peur concepiva la sua riserva come un fondo di previdenza sul racshycolto futuro da non immettere sul mercato se non nel caso dellapprossimarsi di una messe sicura secondo una logica economica a contrario (MEUVRBT 1988 19 e 147)
Era Hltente la disparitagrave fra i produttori non solo fra chi era in possesso di eccedenshyze e chi non lo era ma piugrave ancora fra chi poteva scegliere - in virtugrave di una maggiore capienza economica e un adeguata dotazione tecnica - il mercato piugrave favorevole per i propri grani (il periodo di saldatura dei raccolti) e chi invece li cedeva troppo presto o in controtempo a livelli non ottimali
Nella gerarchia delle abitazioni rurali -- in quel vero e proprio saggio di sociologia che egrave il sesto libro del De Architectura di Sebastiano Serlio (scritto fra il 1537 e il 1555 inedito per tutto levo moderno) - per trovare case attrezzate di granaio occorshyreva ascendere sino alla magione del basso mercante o cittadino fuori della cittagrave (SERLIO 1994 43 segg anche per le successive informazioni) Condizione di cui non potevano fregiarsi invece i ricchi contadini in ~ssuno dei tre gradi possibili di ricshychezza al massimo la loro casa poteva es~ere attrezzata di portici per ricoverare le biade e di unaia per batterle segni di distinzione giagrave fra i mediocri contadini Fra questi perograve avrebbero potuto avvalersene soltanto i fortUIgravelati et di beni et di famishyglia (3deg grado di mediocritagrave) Dforno per cuocere il pane e una cantina per conservashyre il vino invece li si sarebbe trovati a partire dai piugrave accomodati fra i poveri contashydini cioegrave al 4deg gradino della scala sociale alla cui base erano da collocare i poveri mendichi con vil capanna (1deg grado di povertagrave) i salariati che vivevano delle [loro] fatiche avendo un puoco di terreno (2deg grado di povertagrave) i poveri con qualche beshylitiuola et massimamente de buovi possessori di una stalletta congiunta con la casa (3deg grado di povertagrave) In sintesi nelle campagne delletagrave pre-industriale pochi avevano scorte pochissimi
erano in grado di ricoverarle in un solaro privilegiatissimo chi le incanevava per speculare Dunque fra i contadJni se si esclude quanto celato nella madia o nella dishyspensa le scorte erano un pri~ilegio di pochi Il Sedio nato intorno al 1475 insiste sullimpoverimento delle class~ rurali intervenuto fra gli anni della sua giovinezza e quelli della vecchiezza in cui segraverive Sotto il titolo Dellabitazione del ricco contadishyno per tre gradi di ricchezza si preoccupa di puntualizzare
bencheacute al digrave dogi non se ne truovi piugrave de tali merceacute delle discordie et di gli animi fieri et ostinati alla vendetta onde per tal cagioni et per le continue guerre et anche pei citadini divoratori de gli altrui beni che con le usure con glinganni con le rapine gli hano impoveriti (SERllO 1994 48)
492 497 Renzo P COlTitore
Tale disparitagrave sociale si riverberava sulla struttura del conunercio cerealicolo La funzione dei piccoli conunercianti di biade (granaioibiadaiolijarinaioli balshy
zarotti cavallanti vaticali ecc) era infatti ancillare alla capacitagrave di affacciarsi sul nercato della fascia marginale dei possidenti con eccedenze Solo che nelle annate di
abbondanza si verificavano ingorghi nellofferta di grano che deprimevano i prezzi e incentivavano i piccoli produttori a smerciare direttamente le eccedenze allindomani del raccolto nellarea urbana anche al di fuori dei luoghi deputati (MA1TOZZl 1983 278 281-2 300n PULT QuAGLIA 1984 86) Mentre nelle annate di penuria si contraeshyva drasticamente proprio questo segmento dellofferta (ABEL (1966J 22-4 KULA (1962] 73-4 CATIINI 1984 111-23 PuLT QUAGLIA 1984 88) scatenando nelle campashygne una caccia al grano-merce la cui quota piugrave consistente era detenuta dai grandi proprietari dai maggiori affittuari dai percettori di canoni diritti o rendite in grano e la cui quota residua era piugrave facilmente preda di chi occupava posizioni chiave nellasshysetto terriero nella catena dei diritti nel credito alla produzione e al consumo
Tanto la distribuzione era frammentata nelle annate di abbondanza tanto in epoclshydi penuria il conunercio del grano diventava un affare di pochi In questo caso lazioshyne dei mercanti diventava dimpiccio sul mercato interno dove la coperta si restringeshyva per i proprietari e gli imprenditori agricoli (KULA (1962J 56-61 CATIINI 1984 114-8) - dove la necessitagrave di ricorrere al credito da parte dei piccoli possessori pOneva questi nelle mani degli agenti dei proprietari dei percettori di canoni diritti o rendite - dove i piccoli proprietari vedevano minacciata la loro stessa condizione da parte di chi controllava localmente in maniera capillare e decentrata il mercato del denaro e dei beni necessari alla riproduzione (sernenti strumenti cibo) La soluzione era quelshyla di precludere amministrativamente ai sensali e ai conunercianti di grani i mercati locali su istigazione dei medi possessori le cui occasioni di normale profitto agrario soffrivano un ridimensionamento e che si vedevano costretti a impegnarsi ccedilontiltte le loro forze per integrare le proprie entrate accaparrandosi le magre eccedenze disponishybili nelle campagne e nei borghi rurali (PuLT QUAGLIA 1984 84-8 PuLT QUAGLIA 1990 107-14)
Il destino dei piccoli conunercianti in grano era quindi quello di occupare una posishyzione marginale nel mercato del grano (MEUVRET 1977 30 PINTO 1978 13 MATTOZZI 1983 277) e di operare non solo a causa degli ordinamenti annonari - secondo una logica di corto respiro in cui non era contemplata neacute la conservazione di grani a lungo termine neacute lutilizzo di depositi piugrave che provvisori Come per i piccoli possidenti non si puograve parlare nel loro caso della formazione e del mantenimento di scorte consistenti (MEUVRET 1988 156-7) Non tali comunque da sostenere il reddito contadino nelle stagioni ordinarie e da esercitare sul versante cittadino unefficace azione anticonshygiunturale in caso di carestia
Peraltro in cittagrave la struttura dellofferta era anche piugrave sperequata di quella che si rishyscontra nel contado Che si tratti di Prato ne) 1339 (PlNTO 1978 129 PINTO 1982 160n e 171n) Pavia negli anni 1539 1555 1573 1602 1603 (ZANIITTI 1963) o Mantova nellultima parte del secolo XVI (CORRITORE 2000 81-9) la distribuzione delle scorte fra i privati era singolarmente ineguale Lo attesta la rilevanza nellarea urbana della povertagrave cioegrave secondo una definizione coeva di coloro che non vivono di entrate ma sono necessitati ricorrere mattina e sera alle pistorie a comprare il pane per il vitto loro e delle sue famiglie col denaro che di giorno in giorno si vanno guadagnando (MATshyTOZZI 1983 281) PUOgrave essere utile richiamare la situazione delle cittagrave tedesche nel basso Medioevo in una fase che egrave stata definita da Wilhelm Abel l epoca doro degli artigiani e del lavoro salariato si puograve stimare che almeno la metagrave degli iscritti ai
il costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica ecol1Omica degli stati
te con il principio della piazza Il mercato pubblico periodico disciplinato la spiagshygia la piazza la loggia o il recinto riservato alle contrattazioni - coesisteva confabshybriche magazzini ebotteghe La stessa piazza per funzionare al meglio secondo il principio dello scambio diretto necessitava di magazzini di supporto
4 LE SCORTE DEI FORNAI CITTADINI
Nellarea urbana e nelle relazioni tra cittagrave e campagna operavano perograve temibili conshycorrenti dei privati possessori I fornai cittadini possedevano le competenze le strutshyture tecniche le relazioni sociali e il credito per incettagravere il prodogravetto per essere inforshymati tempestivamente sul mercato del grano e potenzialmente per dispensarlo con profitto in qualunque momento Il fatto che il loro operato fosse imprigionato in un arshycaica impalcatura di norme divieti obblighi che risalivano alletagrave romana che ne fashycevano in modograve quasi istituzionalizzato il capro espiatorio delle tensioni fra produtshytori di grano povertagrave e autoritagrave non impedisce di affermare che tali vessatorie disposizio~i trovassero la loro principale ragione dessere nella parte che essi giocashyvano di interlocutorilantagonisti dei proprietari terrieri nella determinazione del prezshyzo del grano sul mercato locale e nella realizzazione della rendita terriera (GUENZI 1982 35 GUENZl 1982 297)
Nel caso di Mantova terra cornucopia a partire dal 1492 si consenti a zentilhomini cittadini et qualuncho altro di comprare biade nel Dominio per approvvigionare la cittagrave di fatto si sancigrave un diritto allincetta che mise fuori gioco i fornai a cui venne imposto di rifornirsi nei solari dei cittadini senza avere piugrave la possibilitagrave di effettuare acquisti nel contado e di ritenere a casa scorte superiori a 100 staia di frumento Lintento della disposhysizione egrave chiarissimo espresso senza reticenze dai Maestri delle Entrate che riportarono al marchese la soddisfazione dei possidenti mantovani per la riforma statutaria
tutta la Terra (cioegrave il Mantovano] ne (egrave] rimasta satisfactissima pensando che Vostra Excellentigravea pretenda ali comodi et utilitagrave universale senza dampno et preuiditio suo Vero egrave che li fumari non si contentano parendoli comegrave il vero che non si poteranno ingrnssar asuo modo come hanno facto per il passato et poterigravea Igravelchader ( ] che veneranno adolershyse et supplicar aVostra Signoria Perograve me egrave parso dargene aviso per questa nostra et farli intender che questa terra ha soliigrave due membri de li quali li cittadini soi se ne possono aiutashyre e valersene uno egrave il grano laltro egrave larte de la lana et quando se concedesse che li furshyDari potessero comprare come h~o facto li tempi passati sana un fare beneficio acinquanshytaocto dessi et dampnifichar elresto de fa republica sua quale de questo ban ordine ne receve emolumento grandissimo et se gaude in la Citagrave [percheacute] li fumari portano fuora el denaro et pretendono solo a suo benefitio (AG b 2441 lettera del 13 luglio 1492)
Egrave indubbio che il plauso della Terra fosse da attribuire piugrave alla possibilitagrave per i proshyprietari di accrescere le proprie entrate che a quella dei consumatori cittadini e dell arte della lana di trarre beneficio dalla disposizione Egrave significativo che la motivazione pro cigravevitate non accenni allesistenza di monopoli da parte dei fornai o di artificiose lievitashyzioni dei prezzi per causa loro Il loro attivismo non confiiggeva per quanto riguarda i prezzi finali della sussistenza con linteresse dei produttori cittadini E daltra parte largomento dellQ storno dal merpato cittadino dei profitti incamerati dai fornai -laccushysa consueta a proposito dei pistores egrave che fossero in gran parte stranieri (GUENZII982 22) -- era una giustificazione debole che appassionava piugrave chi concorreva direttamente
496 493
Renzo P Corritore
appare altrettanto astratto dogmatico o virtuale del principio di mercato (Market Pri1lciple) che il medesimo gli contrappone Henri Pirenne parlando della politica annonaria dei comuni medievali avverte Lapplicazione del principio della vendita diretta ebbe numerosi eccezioni (PumNNE [1933] 193n)
Nel caso di Mantova la scelta della Piazza egrave facoltativa per i terrieri COn eccedenze Gli Statuti signorili che si rifanno largamente alle raccolte statutarie comunali non sancivano alcun obbligo in proposito (v SVJUTI BONACOLSIANI [1313] libro m rubr 55 De mercato blave 253 STATlITl GoNZAOHESCHI [1404J libro m rubr 93 De mercato blave fiendo in civitate Mantue f 73v) Decreti di carattere straordinario e regolamenshytazioni transitorie correggevano il tiro Nel 1405 in piena saldatura dei raccolti si c0shy
strinse a rifornire forzosamel)~ la piazza concentrandovi tutte le contrattazioni Nel 1417 si obbligograve a riservare al mercato un terzo del frumento introdotto in cittagrave (CORRIshyTORE 2000 235-6) Ma sono atti straordinari che non sopravvissero nel migliore dei casi piugravedi qualchelustro (MANroVA 1430 88 90 181) A Mantova la Piazza era affianshycata da un granaio pubblico la Domus del mercato (altrove definito Folllico o Fonrego del mercato) in cui avrebbero dovuto prolungarsi le contrattazioni oltre lorario e i giorshyni deputati (venerdigrave o sabato) rendendo disponibile ciograve che restava invenduto e che non poteva essere ritirato per legge dal mercato Nel 1430 eminenti cittadini sollecitati dal principe lamentavano perograve lincapacitagrave del magazzino - inoperoso in tutto o in parte per il pericolo di crolli -- di rispondere ai bisogni del popolo in una situazione in cUi da parte dei possessori si protestava la difficoltagrave di non poter esitare e smerciare fuori delshyla cittagrave le eccedenze conservate nei solari privati
Item videtur quod valde utille foret civibus Mantue habentibus possessiones et quishybuscumque alijs personis de civitate Mantue aut districtu colligantibus bIada et vina in magna copia ut omni tempore ipsa bIada et vinum possent extrahere de civitate et dishystrictu Mantue et conducere ad Iaea ad que et in quibus ma vendere poterunt cum otdishynibus et dacijs competentibus ipsa tamen civitate semper remanente fulta pro usu dicte civitatis et populi eiusdem ne dieta biada marceschant super granarlis ut hactenus feceshyrunt cum maximo incomodo ipsorum civium (MANTOVA 1430 177-8)
nmedesimo fondaco abbinato al mercato operava a Verona a Ferrara a Vegravenezia a Udine a Chioggia in molte altre cittagrave (MANToVA 1430 100 FORNASIN 1999 7-9 CEshySTAR 1794)
Lintegrale e pedissequa applicazione del principio della piazza di mercato comporshytava - per i vincoli tecnici dell etagrave pre-industriale -la massima affermazione del prinshycipio della canova cioegrave del magazzino pubblico centrale Unico argine alla sua invashydenza era costituito da una distribuzione perequata ab imis del raccolto cioegrave la possibilitagrave - egrave questo il paradosso - di realizzare da parte dei produttori la massima aspirazione nelle societagrave tradizionali lautarchia domestica Piugrave avanzava invece la sperequazione nel reddito e nel patrimonio piugrave da parte dei consumatori privi di scorshyte si impetrava il principio del Magazzino pubblico nella ronna di un efficiente sisteshyma di ricovero conservazione distribuzione delle derrate a garanzia del funzionashymento della Piazza di mercato La disponibilitagrave di crescenti quote di raccolto tuttavia indirizzava i piugrave accomodati verso soluzioni piugrave ghiotte la vendita allingrosso sul mercato cittadino ai fornai o allimpresa pubblica creata a sussidio di questi (o in loro vece) Oppure allopposto lesito delle eccedenze extra muros sui grandi mercatishyemporio regionali per il tramite di mercanti o agenti diretti
Il principio del magazzino pubblico centrale cioegrave laccumulazione di riserve per lo smercio continuo o anticiclico egrave quindi alla sua origine in opposizione solo apparen-
La costirU1ione di scorre granarie pubbliche e la politica economica degli srati
ruoli fiscali non fosserograve in grado di accantonare scorte Nel 1444 a Strasburgo quattro cittadini su dieci non possedevano alcuna riserva cerealicola (DRlMBIER 1984 112)
Nelle cittagrave italiane delletagrave moderna si puograve stimare che non meno di due terzi della popolazione fosse costretta ad acquistare o consumare pane confezionato con grani e farine comperati nelle piazze nelle vie e nelle botteghe cittadine oppure ottenuti come compenso del proprio servizio nelle casate (CORRrroRE 2000 126-36 MA11oZZI 1983 27~-82) Evidentemente questa fascia di lavoratori salariati non possedeva -shyper definizione - neacute scorte neacute depositi personali e nel primo caso era strettamente dipendente dal mercatograve urbano acquistando la sua sussistenza con frequenza non piugrave che settimanale (essendo costretti a comprare il pane tutti i giorni allafinestra si dishyceva a Genova [GRENDI1986 1031])
Ma anche fra i citiOdini con possesso extra moenia la distribuzione delle scorte era tuttaltro che egalitaria A Prato nel 1339
A parte gli enti religiosi sette famiglie [ ] avevano ii disposizione piugrave di mille staia di granaglie (circa 18 tonnellate) fino a un massimo di 3500 Altri venti nuciei familiashyri avevano scorte comprese tra le 500 e le 1000 staia (PINTO 1978 129n)
A Mantova nei magazzini ducali nellultima parte del 500 erano ammassati non meno di un ottavo talora piugrave di un quarto delle riserve cittadine di grani panificabili (CoRRITORE 200081-6) A Pavia nel corso dello stesso secolo e allinizio di quello successivo nei solagraveri di una sessantina di famiglie si concentrava non meno del 40 per cento dellintera offerta cittadinIgrave di frumento(ZANBUgrave11964 70-7) Anche in questo caso egrave utile sapere che nelle cittagrave tedesche esistevano mercanti (ad Augusta RatisboshyDa Norimberga) in grado di axnPmssare riserve da 6 a 45 tonnellate e che a Francoshyforte nel 1488 due patrizi totali~zavano insieme un terzo delle scorte cerealicole dei particolari nella cittagrave alta (DnuMmER 1984113)
Ritenere tali soggetti sprovv~uti al punto di incanevare grani con il solo scopo di esorc~ i pericoli della Fstia egrave perlomeno riduttivo A grandi solari comshyspondevano vaste familiae e pIftore di servi tori e ospiti ma tali scorte eccedevano largamente la sussistenza del maggiore palazzo nobiliare o patrizio senza peraltro costituire un fondo di accantonafoento eccedente il fabbisogno della cittagrave a meno che non vi fosse la concreta possibilitagrave di commercializzare il surplus sui mercati esteri Come nota infatti Adam Smith
a meno che leccedenza non possa essere esportata in tutte le circostanze ordinarie i coltivatori staranno molto attenti a non produrre e gli importatori a non importare mai una quantitagrave maggiore di quell~ che egrave strettamente richiesta dal consumo del mercato interno Questo mercato saragrave difficilmente sovrafomito ma saragrave in generale sottoriforshyDito dato che coloro che svolgqno lattivitagrave per rifomirlo avranno in generale il timore che la loro merce possa rimanete invenduta (SMlTH [1776] 528)
Lipotesi egrave suffragata dai cas~ storici conosciuti A Bologna macrodistretto serico dellevo moderno laddove gli ipteressi manifatturieri e mercantili avrebbero dovuto consigliare una sussistenza a b~on mercato per tenere basso il costo del lavoro le istituzioni annonarie operavano per garantire con il calmiero deljorme1lto la monetizshyzazione della rendita granaria dei possidenti - strutturalmente incapace di coprire il fabbisogno della cittagrave anchea rischio della carezza dei viveri contingentando il mercato dei grani forestieri (GtJFNZl1982A 37-76) Di fatto
495 494 Renzo P Corrllnre
In ogni caso si tendeva a limitare al minimo indispensabile lemiddot importazioni di frushymento per evitare che stocks invenduti potessero turbare la collocazione dei grani tershyrieri nel nuovo anno agrario (GuENZI 1981 153)
In tutti i centri comunque la tendenza a ritardare la vendita del surplus nei mesi della saldatura lutilizzo di depositi specializzati con personale addetto alla custodia al conshydizionamento e alla commercializzazione del prodotto ponevano i grandi proprietari di biade su un gradino superiore e diverso rispetto al resto della cittagrave Laccantonamento di grani per questa cupola di possessori rispondeva al principio dellutilitagrave soggettiva atshytesa e richiedeva sia capitale fisso sia capitale circolante per raggiungere gli scopipreshyfissati un profitto speculativo la valorizzazione della rendita
In molte cittagrave i possessori non avrebbero dovuto trattenere in casa piugrave grano e farina di quantoprescritto dalla legge cioegrave il consumo mensile per bocca - fissato anchesshyso statutariamente - per arrivare al nuovo raccolto Ma i cittadini credeVano veramenshyte ai loro comandamenti Egrave lecito dubitare La norma era scolpita negli Statuti e pubshyblicamente violata con la complicitagrave dll1e autoritagrave e dei groppi professionali interessati alla distribuzione del grano nelle sue ~arie forme
Nelle annate ordinarie la quota di grano auto consumato - cioegrave non acquistata sul mercato - nelle cittagrave italiane dell evo moderno rappresentava fra il 30 e il 60 per censhyto del fabbisogno urbano di frumento
Nella capitale dei Gonzaga nel 1615 si valutava che su 27000 bocche
il terzo [di] gentilhuomini fittadri servitori et altri [ ] non comprano biada et gli duoi tenigrave tra poveri artisti mercanti fomari fondachieri hebrei et altri [bull] non possono in tutto levar sufficientemente la somma de detti dua terzi sl che saranno boshychegrave 18000 che compraranno biada (COIUUTORl 2000 126)
AVenezia a cavaliere fra XVI e XVII secolo alla mensa delle casade si dispensava circa un terzo del frumento consumato ordinariamente in cittagrave (AMARD 1966 74 MATTOZZI 1983 281) ABologna per tutto il Seicento i fornai che impastavano farine in conto lavorazione per i particolari pareggiavano piugrave o meno il numero di quelli da scqffa che smerciavano pane venale (GUENZI 1982A
27) Peraltro la proporzione a Rialto tra chi lavorava per le casade e chi vendeva pane al pubblico - 65 Jo~ri a fronte di 44-48 pistori negli anni 1583-1685 (DELLA VALBNTINA 1992 143-4 167 192-3) - fa ritenere la struttura del mercato del pane felsinea non molto dissimile da quella veneziana Nelle cittagrave liguri o toscane sei-settecentesche la porzione autocon sumata quando il raccolto era buono era anche piugrave elevata (GRENDI 1986 1024-6 1034 PuLT QUAOUA 1984 98-104 PULT QUAGUA 1990 171-2) A Napoli nel 1758 a Monasteri Luoghi pii e Particolari eta riservato il 28 per cento del consumo cittadishyno di frumento (AuFANO 1996 37n)
Lelevato numero di servi domestici persone al servizio delle casate faceva sigrave che in alcuni palazzi si concentrassero masse cospicue di grano per la spesa familiare Ma accanto ad esse gli operatori dell annona -- la stessa povertagrave -- si auguravano che vi fosse sempre anche la materia per rifornireil mercato e i forni cittadinimiddot nella fase piugrave delicata del ciclo annuale il periodo di saldatura dei raccolti Come spiegare altrimenshyti la norma che imponeva ai grossi detentori di biade (non esclusi enti e opere pie) in varie cittagrave italiane dellevo moderno la vendita straordinaria in primavera dellegrave ecshycedenze ammassate in granaio (per Pisa e la Toscana v PuLT QUAGUA 1984 88-9)
A Mantova nel 1554 si stabiliva che i patroni che avessero fruito in cittagrave di piugrave di 20 sacchi di grano come porzione dominicale avrebbero dovuto coilservare in granaio
lA costituzioni digrave scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
il 4 per cento per le necessitagrave dei consumatori dei fornai e dei Jontachieri quando fosse mancato il prodotto sulla piazza o nelle offerte deisensali Nel 1603 ci si preocshycupograve di elevare la quota al 6 per cento (CORRlTQRE 2000 237n) Beninteso le vendite sarebbero avvenute ai valori di mercato Lo stesso sistema vigeva a Cremona (6 per cento nel 1608 e nel 1612) (MERON 1957 59n 63 JACOPETl1 1965 128) ea Verona Qui una delibera consiliare del 1549 autorizzava per la prima volta
[il deputati [alle Biadel [a] tassar e comandar con quelle pene che al Clarissimo Podestagrave pareragrave quella quantitagrave di biade a ciascuno secolare o eclesiastico sia di qual grado o condittione esser si voglia che havesse biade in questa cittagrave oltre il viver suo
(VOCCHIATO 1979 145)
La tassa sarebbe stata stabilita - da11558 - per sorteggio fra le casate che avessero introdotto in cittagrave dai propri possedimenti piugrave di 70 minali per rifo1llire il Mercato delle biave Essa-venne anche incrementata nella stessa occasione dal 5 al6 per censhyto per restare in vigore fino al 1631 (VECCHIATO 1979 141-58)
Quest9 tiIfo di normativa nasce e si affiogravea in ambito amministrativo perciograve echeggia la realtagrave molto meglio della veneranda legge generale
Da tali disposizioni si deducono alcuni fatti incontrovertibili 1entro la cerchia cittadina esistevano scorte private eccedenti la spesa delle famiglie
in violazione in molti casi della legge statutaria 2il possesso della terra che solo assicurava lautarchia delle casate era il piugrave-potente
fattore di discriminazione fra i cives tanto da precipitare nel girone dei pauperes la moltitudine che acquistava correntemente la sussistenza nellarea urbana
3fra gli stessi possidenti cittadini esisteva uneacutelite che non solo conservava scorte oltre il viver suo ma che si proponeva egoisticamente di speculare ritardando limshymissione dei grani sulle piazze cittadine o che a~endeva il momento piugrave opportuno per smerciarli allesterno nelle grandi piazze frumentarie come livorno Desenzashyno Legnago Romano (di Lombardia) ecc
4lineguaglianza fra i cives tese ad aggravarsi con la metagrave del 500 poicheacute questi reshygolamenti innovano quasi sempre disposizioni generali risalenti al tardo Medioevo che sancivano lobbligo di convogliare il surplus sulla piazza cittadina segno di una distribuzione del reddito originariamente meno sbilanciata A Cremona gli Statuti del 1388 obbligavano - cosl egrave ancora nel 1510 - a vendere il
sovrappiugrave in Piazza Maggiore sul mercato pubblico dei grani (MERON 1957 59n
63)A Pisa il rescritto che imponeva di effettuare le vendite al minuto in platea bladi
risale al 1401 MALANlMA 1976 293) lobbligo era ribadito ancora nel 1548 ma nella seconda metagrave del secolo XVI si affermava la pratica di vendere fuori mercato tanto che nel 1581 il Magistrato dei Nove dovette intervenire per far vendere i grani delle comunitagrave degli enti e dei luoghimiddotpii soltanto da marzo-aprile in piccole quantitagrave sul mercato (PULT QUAGUA 1984 81-91) La disposizione per altro si applicava allinteshyro Stato (PULT QUAGUA 1984 88)
Tuttavia non egrave da pensare che il principio della concentrazione delle compravendite sulla piazza di mercato cittadina fosse universale universalmente rispettato e sopratshytutto perenne La centralizzazione del grano non significa automaticamente lobbligo di vendita diretta sulla Piazza deiformenti Affermare come Steven L Kaplan che
There was no single more important regulation concerning tbe provisioning trade tban tbe requirement tbat alI transactions occur in tbe marketplace (KAPLAN 1984 27)
494 495 Renzo P Corritore
In ogni caso si tendeva a limitare al minimo indispensabile le importazioni di frushymento per evitare che stocks invendutigrave potessero turbare )a collocaziolle dei grani tershyrieri ileI nuovo anno agrario (GUENZI 1981 153)
In tutti i centri comunque la tendenza a ritardare la vendita del surplus nei mesi della saldatura lutilizzo di depositi specializzati con personale addetto alla custodia al conshydizionamento e alla commercializzazione del prodotto ponevano i grandi proprietari di biade su un gradino superiore e diverso rispetto al resto della cittagrave Laccantonamento di grani per questa cupola di possessori rispondeva al principio dellutilitagrave soggettiva atshytesa e richiedeva sia capitale fisso sia capitale circolante per raggiungere gli scopipreshyfissati un profitto speculativo la valorizzazione della rendita
In molte cittagrave i possessori non avrebbero dovuto trattenere in casa piagrave grano e farina di quantoprescritto dalla legge cioegrave il consumo mensile per bocca ~- fissato anchesshy
so statutariamente --per arrivare al nuovo raccolto Ma i cittadini credevano veramenshyte ai loro comandamenti Egrave lecito dubitare La norma era scogravelpitagrave negli Statuti e pubshyblicamente violatamiddot con la complicitagrave dccedillle autoritagrave e dei gruppi professionali interessati alla distribuzione del grano nelle sue varie forme
Nelle annate ordinarie la quota di grano autoconsumato - cioegrave non acquistata sul mercato - nelle cittagrave italiane dell evo moderno rappresentava fra il 30 e i160 per censhyto del fabbisogno urbano di frumento
Nella capitale dei Gonzaga nel 1615 si valutava che su 27000 bocche
il terzo [di] gentilhuomini ligravettadri servitori et altri [ ] non comprano biada et gli duoi terzi tra poveri artisti mercanti fomari fondachieri hebrei et altri [ l non possono in tutto levar sufficientemente la $omma de detti dua terzi sl che saranno boshyche 18000 che compraranno biada (CoRRlTORB 2000 126)
AVenezia a cavaliere fra XVI e xvn secoioalla mensa delle casade si dispensava circa un terzo del frumento consumato ordinariamente in cittagrave (AYMARD 1966 74 MArroZZI 1983 281) A Bologna per tutto il Seicento i fornai che impastavano farine in conto lavorazione per i particolari pareggiavano piil o meno il numero di quelli da scaifa che smerciavano pane venale (GUBNZI 1982 27) Peraltro la proporzione a Rialto tra chi lavorava per le casade e chi vendeva pane al pubblico - 65 fOf7lri a fronte di 44-48 pistori negli anni 1583-1685 (DELLA VAUNTINA 1992 143-4167 192-3) - fa ritenere la struttura del mercato del pane felsinea non molto dissimile da quella veneziana Nelle cittagrave liguri o toscane sei-settecentesche la porzione autoconshysumata quando il raccolto era buono era anche piil elevata (ORENOI 1986 1024-6 1034 PuLT QUAGLIA 1984 98-104 PULT QUAOLIA 1990 171-2) A Napoli nel 1758 a Monasteri Luoghi pii e Particolari eta riservato il 28 per cento del consumo cittadishyno di frumento (AuFANO 1996 370)
Lelevato numero di servi domestici persone al servizio delle casate faceva si che in alcuni palazzi si concentrassero masse cospicue di grano per la spesa familiare Ma accanto ad esse gli operatori dellannona -lastessapovertagrave __ si auguravano che vi fosse sempre anche la materia per rifornire il mercato e i forni cittadini nella fase piil delicata del ciclo annuale il periodo di saldatura dei raccolti Come spiegare altrimenshyti la norma che imponeva ai grossi detentori digrave biade (non esclusi enti e opere piegrave) in varie cittagrave italiane dellevo moderno la vendita straordinaria in primavera delle ecshyredenze ammassate in granaio (per Pisa e la Toscana v PuLT QUAGLIA 1984 88-9)
A Mantova nel 1554 si stabiliva che i patroni che avessero fruito in cittagrave di piugrave di 20 sacchi di grano come porzione dominicale avrebbero dovuto conservare in granaio
lA costituzione di SC0114 granarie pubbliche e la politica economica degli stati
il 4 per cento per le necessitagrave dei consumatori dei fornai e dei fontachieri quando fosse mancato il prodotto sulla piazza o nelle offerte deimiddotsensati Nel 1603 ci si preocshycupograve di elevare la quota al 6 per cento (CoRRlTORE 2000 237n) Beninteso le vendite sarebbero avvenute ai valori di mercato 10 stessa sistema vigeva a Cremona (6 per cento nel 1608 e nel 1612) (MERON 1957 -59n 63 JACOPETl11965 128) ea Verona Qui una delibera consiliare del 1549 autoruzava per la prima volta
[i] deputati [alle Biade) [al tassar e comandar con quelle pene che al Clarissimo Podestagrave pareragrave quella quantitagrave di biade a ciascuno secolare o eclesiastico sia di qual grado o condittione esser si voglia che havesse biade in questa cittagrave oltre il viver suo (VBCClI1ATO 1979 145)
La tassa sarebbe stata stabilita - dal 1558 - per sorteggio fra le casate che avessero introdotto in cittagrave dai propri possedimenti piagrave di 70 minali per rifornire il Mercato delle biave Essaveane anche incrementata nella stessa occasione dal 5 al6 per censhyto per restare in vigore fino al 1631 (VECCHIATO 1979 141-58)
Questccedil tijlo di normativa nasce e si affuia in ambito amministrativo perciograve echeggia la realtagrave molto meglio della veneranda legge generale
Da tali disposizioni si deducono alcuni fatti incontrovertibili 1entro la cerchia cittadina esistevano scorte private eccedenti la spesa delle famiglie
in violazione in molti casi della legge statutaria 2il possesso della terra che solo assicurava lautarchia delle casate era il piugravemiddotpotente
fattore di discriminazione fra i cives tanto da precipitare nel girone dei pauperes la moltitudine che acquistava correntemente la sussistenza nellarea urbana
3fra gli stessi possidenti cittadini esisteva uneacutelite che non solo conservava scorte oltre il viver suo ma che si proponeva egoisticamente di speculare ritardando limshymissione dei grani sulle piazze cittadine o che a~endeva il momento piagrave opportuno per smerciarli allesterno nelle grandi piazze frumentarie come Uvorno Desenzashyno Legnago Romano di Lombardia) ecc
4lineguaglianza fra i cives tese ad aggravarsi con la metagrave del 500 poicheacute questi reshygolamenti innovano quasi sempre disposizioni generali risalenti al tardo Medioevo che sancivano lobbligo di convogliare il surplus sulla piazza cittadina segno di una distribuzione del reddito originariamente meno sbilanciata shyACremona gli Statuti del 1388 obbligavano - cosl egrave ancora nel 1510 - a vendere il
sovrappigraveagrave in Piazza Maggiore sul mercato pubblico dei grani (MERON 1957 59n 63)
A Pisa il rescritto che imponeva di effettuare le vendite al minuto in platea bladi risale al 1401 (MALANIMA 1976 293) lobbligo era ribadito ancora nel 1548 ma nella seconda metagrave del secolo XVI si affermava la pratica di vendere fuori mercato tanto che nel 1581 il Magistrato dei Nove dovette intervenire per far vendere i grani delle comunitagrave degli enti e dei luoghi pii soltanto da marzo-aprile in piccole quantitagrave sul mercato (PULT QUAGLIA 1984 8191) La disposizione per altro si applicava allinteshyro Stato (PULT QUAGLIA 1984 88)
Tuttavia non egrave da pensare che il principio della concentrazione delle compravendite sulla piazza di mercato cittadina fosse universale universalmente rispettato e sopratshytutto perenne La centralizzazione del grano non significa automaticamente lobbligo di vendita diretta sulla Piazza deiformenti Affermare come Steven L Kaplan che
There was no single more important regulation conceming the provisioning trade han the requirement that ali transactions occur in the marketplace (KAPuN 1984 27)
493 496 Renw P Corritore
appare altrettanto astratto dogmatico O virtuale del principio di mercato (Market Principle) che il medesimo gli contrappone Henri Pirenne parlando della politica annonaria dei comuni medievali avverte Lapplicazione del principio della vendita diretta ebbe numerosi eccezioni (PIRENNE [1933] 193n)
Nel caso di Mantova la scelta della Piazza egrave facoltativa per i terrieri con eccedenze GliStatuti signorili che si rifanno largamente alle raccolte statutarie comunali non sancivano alcun obbligo in proposito (v SYJI1l BONACOLSlANI [1313] libro ID rubr 55 De mercato blave 253 STATUTI GoNZAOHESCHI [1404] libro m rubr 93 De mercato blave fiendo in civitate Mantue f 73v) Decreti di carattere straordinario e regolamenshytazioni transitorie correggevano il tiro Nel 1405 in piena saldatura dei raccolti si coshystrinse a rifornire forzosamen~e la piazza concentrandovi tutte le contrattazioni Nel 1417 si obbligograve a riservare al mercato un terzo del frumento introdotto in cittagrave (CoRRIshyTORE 2000 235-6) Ma sono atti straordinari che non sopravvissero nel migliore dei casi piugrave di qualchelustro (MANToVA 1430 88 90 181) A Mantova la Piazza era affianshycata da un granaio pubblico la Domus del mercato (altrove definito Fornico o Fontego del mercato) in cui avrebbero dovuto prolungarsi le contrattazioni oltre lorario e i giorshyni deputati (venerdl o sabato) rendendo disponibile ciograve che restava invenduto e che non poteva essere ritirato per legge dal mercato Nel 1430 eminenti cittadini sollecitati dal principe lamentavano pero lincapacitagrave del magazzino - inoperoso in tutto o in ~per il pericolo di crolli - di rispondere ai bisogni del popolo in una situazione in cui da parte dei possessori si protestava la difficoltagrave di non poter esitare e smerciare fuori delshyla cittagrave le eccedenze conservate nei solari privati
ltem videtur quod valde utille foret civibus Mantue habentibus possessiones et quishybuscumque alijs personis de civitate Mantue aut districtu colligantibus bIada et vina in magna copia ut amni tempore ipsa bIada et vinum possent exttahere de civitate et dishystrictu Mantue et conducere ad Iaea ad que et in quibus illa vendere poterunt cum otdigraveshynibus et dacijs competentibus ipsa tamen civitate semper remanente fulta pro usu diete civitatis et populi eiusdem ne dicta bIada mateeschant super granariis ut hactenus fecemiddot runt cum maximo incomodo ipsorum civium (MANToVA 1430 177-8)
Il medesimo fondaco abbinato al mercato operava a Verona a Ferrara a Venezia a Udine a Chioggia in molte altre cittagrave (MANToVA 1430 100 FORNASIN 1999 7-9 CBshySTARl1794)
Lintegrale e pedissequa applicazione del principio della piazza di mercato comporshytava - per i vincoli tecnici dell etagrave pre-industriale -la massima affermazione del prinshycipio della canova cioegrave del magazzino pubblico centrale Unico argine alla sua invashydenza era costituito da una distribuzione perequata ab imis del raccolto cioegrave la possibilitagrave egrave questo il paradosso di realizzare da parte dei produttori la massima aspirazione nelle societagrave tradizionali lautarchia domestica Piugrave avanzava invecela sperequazione nel reddito e nel patrimonio piugrave da parte dei consumatori privi di scorshyte si impetrava il principio del Magazzino pubblico nella forma di un efficiente sisteshyma di ricovero conservazione distribuzione delle derrate a garanzia del funzionashymento della Piazza di mercato La disponibilitagrave di crescenti quote di raccolto tuttavia indirizzava i piugrave accomodati verso soluzioni piugrave ghiotte la vendita allingrosso sul mercato cittadino ai fornai o allimpresa pubblica creata a sussidio di questi (o in loro vece) Oppure allopposto lesito delle eccedenze extra muros sui grandi mercatishyemporio regionali per il tramite di mercanti o agenti diretti
Il principio del magazzino pubblico centrale cioegrave laccumulazione di riserve per lo smercio continuo o anticiclico egrave quindi alla sua origine in opposizione solo apparen-
La costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
ruoli fiscali non fossero in grado di accantonare scorte Nel 1444 a Strasburgo quattro cittadini su dieci non possedevano alcuna riserva cerealicola (DIIUMBIER 1984 112)
Nelle cittagrave italiane delletagrave moderna si puograve stimare che non meno di due terzi della popolazione fosse costretta ad acquistare o consumare pane confezionato con grani e farine comperati nelle piazze nelle vie e nelle botteghe cittadine oppure ottenuti come compenso del proprio servizio nelle casate (CoRRITORE 2000 126-36 MAnoZZI 1983 27~-82) Evidentemente questa fascia di lavoratori salariati non possedevashyper definizione -- neacute scorte neacute depositi personali e nel primo caso era strettamente dipendente dal mercato urbano acquistando la sua sussistenza con frequenza non piugrave che settimaIIgraveale (essendo costretti a comprare il pane tutti i giorni alla finestra si dishyceva a Genova (GRENDI 1986 1031])
Ma anche fra i citUutini con possesso extra moenia la distribuzione delle scorte era tuttaltro che egalitaria A Prato nel 1339
A patte gli enti religiosi sette famiglie [ bull ] avevano Il disposizione piugrave di mille staia di granaglie (circa 18 tonnellate) fino a un massimo di 3500 Altri venti nuclei familiashyri avevano scorte comprese tra le SOOe le 1000 staia (PINTO 1978 129n)
A Mantova nei magazzini ducali nellultima parte del 500 erano ammassati non meno di un ottavo talora piugrave di un quarto delle riserve cittadine di grani panificabili (CORRlTORE 2000 81c6) A Pavia nel corsq dello stesso secolo e allinizio di quello successivo nei sozagraveri di una sessantina di famiglie si concentrava non meno del 40 per cento dell intera offerta cittadin8 di frumentomiddot (ZANJin 1964 70-7) Anche in questo caso egrave utile sapere che nelle cittagrave tedesche esistevano mercanti (ad Augusta Ratisboshyna Norimberga) in grado di ~sare riserve da 6 a 45 tonnellate e che a Francoshyforte nel 1488 due patrizi totalizzavano insieme un terzo delle scorte cerealicole dei particolari nella cittagrave alta (DlRLMB1ER 1984113)
Ritenere tali soggetti sprovv~duti al punto di incanevare grani con il solo scopo di esorcizzare i pericoli della clarestia egrave perlomeno riduttivo A grandi solari corrishyspondevano vaste familiae e plftore di servitori e ospiti ma tali scorte eccedevano largamente la sussistenza del D-aggiore palazzo nobiliare o patrizio senza peraltro costituire un fondo di accantofilljnento eccedente il fabbisogno della cittagrave a meno che non vi fosse la concreta possibfjitagrave di commercializzare il surplus sui mercati esteri Come nota infatti Adam Smith
a meno che leccedenza non possa essere esportata in tutte le circostanze ordinarie i coltivatori staranno molto attenti a non produrre e gli importatori a non importare mai una quantitagrave maggiore di quell~ che egrave strettamente richiesta dal consumo del mercato interno Questo mercato saragrave difficilmente sovrafornito ma saragrave in generale sottomorshynito dato che coloro che svolgono lattivitagrave per mornirlo avranno in generale il timore che la loro merce possa rimane~ invenduta (SMITH[l776] 528)
Lipotesi egrave suffragata dai cas storici conosciuti A Bologna macrodistretto serico dellevo modemoladdove gli interessi manifatturieri e mercantili avrebbero dovuto consigliare una sussistenza a b~on mercato per tenere basso il costo del lavoro le istituzioni annonarie operavano per-garantire con il calmiero delformento la monetizshyzazione della rendita granaria dei possidenti - strutturalmente incapace di coprire il fabbisogno della cittagrave - anche ~ rischio della carezza dei viveri contingentando il mercato dei grani forestieri (GupaI 1982 37-76) Di fatto
492 Renzo P COITitore
Tale disparitagrave sociale si riverberava sulla struttura del commercio cerealicolo La funzione dei piccoli commercianti di biade (granaiolibull biadaiolifarinaioli balshy
zarotti cavallanti vatlcali ecc) era infatti ancillare alla capacitagrave di affacciarsi sul nercato della fascia marginale deipossidenti con eccedenze Solo che nelle annate di abbondanza si venficavano ingorghi nell offerta di grano che deprimevano i prezzi e incentivavano i piccoli produttori a smerciare direttamente le eccedenze allindomani del raccolto nellarea urbana anche al di fuori dei luoghi deputati (MATI02ZI 1983 278281-2 300n PULr QUAGLIA 1984 86) Mentre nelle annate di penuria si contraeshyva drasticamente proprio questo segmento dellofferta (ABa [1966Jmiddot 22-4 KULA [1962J 73-4 CATrINI1984 111-23 PuIr QUAGUA 1984 88) scatenando nelle campashygne una caccia al grano-merce la cui quota piugrave consistente era detenuta dai grandi proprietari dai maggiori affittuari dai percettori di canoni diritti o rendite in grano e la cui quota residua era piugrave facilmente preda di chi occupava posizioni chiave nellasshysetto terriero nella catena dei diritti nel credito alla produzione e al consumo
Tanto la distribuZione era frammentata nelle annate di abbondanza tanto in epoc~ di penuria il commercio del grano diventava un affare di pochi In questo caso lazioshyne dei mercanti diVentava dimpiccio sul mercato interno dove la coperta si restringeshyva per i proprietari e gli imprenditori agricoli (KULA [1962] 56-61 CATl1NI 1984 114-8) - dove la necessitagrave di ricorrere al credito da parte dei piccoli possessori poneva questi nelle mani degli agenti dei proprietari dei percettoridi canoni diritti o rendite - dove i piccoli proprietari vedevano minacciata la loro stessa condizione da parte di chi controllava localInente in maniera capillare e decentrata il mercato del denaro e dei beni necessari alla riproduzione (sementi strumenti cibo) La soluzione era quelshyla di precludere amministrativamente ai sensali e ai commercianti di grani i mercati locali su istigazione dei medi possessori le cui occasioni di normale profitto agrario soffrivano un ridimensionamento e che si vedevano costretti a impegnarsi ccedilon tutte le loro forze per integrare le proprie entrate accaparrandosi le magre eccedeiiZe disponishybili nelle campagne e nei borghi rurali (PuLT QUAGLIA 1984 84-8 PULT QUAGLIA 1990 lO7-14)
TI destino dei piccoli commercianti in grano era quindi quello di occupare una posishyzione margilJale nel mercato del grano (MBlNrurr 1977 30 PINTO 1978 13 MAITOZZl 1983 277) e di operare - non solo a causa degli ordinamenti annonari - secondo una logica di corto respiro in cui non era contemplata neacute la conservazione di grani a lungo termine neacute lutilizzo di depositi piugrave che provvisori Come per i piccoli possidenti non si puograve parlare ne1loro caso della formazione e del mantenimento di scorte consistenti (MBlNREr 1988 156~7) Non tali comunque da sostenere il reddito contadino nelle stagioni ordinarie e da esercitare sul versante cittadino unefficace azione anticonshygiunturale in caso di carestia
Peraltro in cittagrave la struttura dellofferta era anche piugrave sperequata di quella che si rishyscontra nel contado Che si tratti di Prato nel 1339 (PINTO 1978 129 PINTO 1982 160n e 17In) Pavia negli anni 1539 1555 1513 1602 1603 (ZANEm 1963) o Mantova nellultima parte del secolo XVI (CORRITORE 2000 81-9) la distribuzione delle scorte fra i privati era singolarmente ineguale Lo attesta la rilevanza nellarea urbana della povertagrave cioegrave secondo una definizione coeva di coloro che non vivono di entrate ma sono necessitati ricorrere mattina e sera alle pistorie a comprare il pane per iI vitto loro e delle sue famiglie col denaro che di giomo in giomo si vanno guadagnando (MATshyTOZZI 1983 281) PUOgrave essere utile richiamare la situazione delle cittagrave tedesche nel basso Medioevo in una fase che egrave stata definita da Wilhelm Abellepoca doro degli artigiani e del lavoro salariato si puograve stimare che almeno la metagrave degli iscritti ai
lA costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli statibull middot497
te con il principio della piazza TI mercato pubblico periodico disciplinatola spiagshygiala piazza la loggia o iI recinto riservato alle contrattazioni - coesis~va confabshybriche magazzini e botteghe La stessa piazza per funzionare al meglio secondo il principio dello scambio diretto necessitava di magaZzini di supporto bull
4 LE SCORTE DEI FORNAI CITTADINI
Nellarea urbanagrave e nelle relazioni tra cittagrave e campagna operavano perograve temibili conshycorrenti dei privati possessori I fornai cittadini possedevano le competenze le strutshyture tecniche le relazioni sociali e il credito per incettagravere il prodotto per essere inforshymati tempestivamentesul mercato del grano e potenzialmente per dispensarlo con profitto in qualunque momento Il fatto che il loro operato fosse imprigionato in unarshycaica impalcatura di norme divieti obblighi che risalivano alletagrave romana che ne fashycevano in modo quasi istituzionalizzato il capro espiatorio delle tensioni fra produtshytori di grano povertagrave e autotitagrave non impedisce di affermare che tali vessatorie disposiziograveD1 trovassero la loro principale ragione dessere nella parte che essi giocashyvano di interlocutorilantagonisti dei proprietari terrieri nelladeterminazione del prezshyzo del grano sul mercato locale e nella realizzazione della rendita terriera (GUENZI 19824
35 GUENZI 1982 297) Neacutel caso di Mantova terra comucopia a partire dal 1492 si consend a zentilhomini
cittadini et qualuncho altro di comprare biade nel Dominio per approvvigionare la cittagrave di fatto si sand un diritto allincetta che mise fuori gioco i fornai a cui venne imposto di rifornirsi nei solarimiddotdei cittadini senza avere piugrave la possibilitagrave di effettuare acquisti nel contado e di ritenere a casa scorte superiori amiddotl 00 staia di frumento Lintento della disposhysizione egrave chiarissimo espresso senza reticenze dai Maestri delle Entrate che riportarono al marchese la soddisfazione dei possidenti mantovani per la riforma statutaria
tutta la Terra [cioegrave il Mantovano] ne [egravel rimasta satisfactissirna pensando che Vostra Excellenilii pretenda ali comodi et utilitagrave universagrave1e senza dampno et preuiditio suo Vero egraveche li fumari non si contentano parendoli comegrave il vero che non si poteranno ingrassar a suo modo come haqno factO per il passato et poteria achader [bulll Che venetanno adolershyse et supplicar aVosUa Signoria Perograve me egrave parso d~ene aviso per ques~ nostra et farli inteni1er Che questaterril ha solii due membri de li quali li cittadini soi se ne possono aiutashyre e valersene uno egrave il grano laltro egrave larte de la lana et quando se concedesse che li furshynari potessero comprare come hapno facto li tempi passati sana un fare benefitio acinquanshytaocto dessi et dampnificharelreslO de la republicasua quale de questo bon ordine ne receve emolumento grandissimo et se gaude in la Citagrave [percheacute] li fumari portano fuora el denaro et pretendono solo a suo benefitio (AG b 2441 lettera del 13 luglio 1492)
Egrave indubbio che il plauso della Terra fosse da attribuire piugrave alla possibilitagrave per i proshyprietari di accrescere le proprie entrate che a quella dei consumagravetori cittadini e dell arte della lana di trarre beneficio daJla disposizione Egrave significativo che la motivazione pro civitate nori accenni allesistenza di monopoli da parte dei fornai o di artificiose lievitashyzioni dei prezzi per causa lOro nloro attivismograve non egraveonfliggeva per quanto riguarda i prezzi finali della sussistenza con linteresse dei produttori cittadini E daltra parte largomentodello stomo dal metFato cittadino dei profitti incamerati dai fornai -laccushysa consueta a proposito deipistores egrave che fossero in gran parte stranieri (GUBNZl 19824
22) -- era unagiustificazione debole che appassionava piugrave chi concorreva direttamente
491 498 Renzo P Comtore
alla spartizione dei proventi derivanti dalla vendita e dal commercio del grano shylemolumento grandissimo - di chi doveva poi fruire della redistribnzione di tale ricchezza Tale norma avvantaggiava i possidenti cittadini e i gentiluomini ptivilegiashyti in grado di ottenere le tratte di esportazione Sul piano dellappropriazione essi erano in condizione di mettere fuori gioco gli altri possessori che producev~o eccedenze nel Dominio poicheacute si accresceva Igravea loro forza contrattuale e la loro capacitagrave di occUpare i canall commerciali piugrave redditizi Sul piano della commercialiZzazione gli stessi fruivashyno dello smantellamento della rete dintennediazione rappresentata dai fornai Per i rushystici significava perdere un collegamento essenZiale con la cittagrave ed essere emarginati dal mercato urbano nelle campagne o sul broletto di Mantova essi non trovarono piugrave i trashydizionali interlocutori (CORBlJ9RE 2000 228 231-2)
Nel caso di Bologna terra strutturalmente deficitaria e cittagrave dalla vocaiione manishyfatturie~ si costringeva i fornai ad acquistare formenti terrieri presso i solari privati in cittagrave proibendogligrave lincetta nel contado autorizzandoli ad acquistareformentiforeshystieri al di fuori delle mura cittadine presso i sensati da grqno solo a patto che fosseshyro stati smaltiti i grani cittadini a un prezzo talora superiore a quello dei grani dimshyportazione (GUlNZI1982A35 52-3)
Nella Toscana dei Medici il diritto allincetta nel contado venne concesso ai fornai in periodo di bassa congiuntura (in particolare dagli anni Trenta del Seicegravento)Per sostenere i prezzi interni in tal caso essi restavano gli interlocutori principali dei granshydi proprietari semplicemente spostando la loro principale fonte di approvvigionashymento dai solari dei particolari in cittagrave ai granai decentrati delle grandi aziende agrishycole oppure ai mercati rurali su cui affluiva la produzione cerealicola delle grandi fattorie (PuLT QUAOUA 1984 86-9 PuLTQUAOUA 1990 100 106-7)
Laddove non vi egrave come invece succede a Genova una diretta ingerenza del potere pubblico nella vita della corporazione (MAsSA 1999) i fumai di cittagrave - nonostante i lacci e lacciuoli normativi e il lavoro prevalentePlente manuale svolto neiloro laboshyratori - erano dei veri imprenditori dipendenti per il loro profitto - noininalmente stabilito per legge - dalla produttivitagrave del lavoro e dalla dotazione tecnica e finanziaria delle imprese Di ciograve fa fede la grande sperequazione esistente fra le aziende speciashylizzate nena fabbricazione del pane venale in cittagrave (AYMARD 1966 75 VECCHltltJQ 1979 82-3 GUlNZI1982 77 segg PuLT QUAOUA 1984 100 102-3) NellItalia delshyletagrave moderna questi artigiani-imprenditori della filiera del grano trattavano insieme
afarinaifarinaiolifarinottifondachierifontechierifidelariformentinari lasagneshyri maccaronari torallari vermicellari ecc fra il 40 e il 70 per cento del frumento consumato in Cittagrave nelle annate normali (CoRRJTORE 2000 126 segg) e ~ino al 100 per cento nelle annate di carestia (Puu QUAOUA 1984 98-9)
In una ricognizione delle asimmetrie informative del mercato non cegrave gruppo quale i fornai che possa integraverpretare la parte dell agente economico onnisciente Se dunque i regolamenti annonari tendevano a regolare minuziogravesamente la collocazione il volushyme e la durata delle loro scorte cosi come disponevano per gli altri artigiani della fishyliera era per neutralizzare il carattere potenzialmente eversivo di tale accantonamenshyto per i proprietari-venditori Prima ancora che per i consumatori-acquirenti n livello delle scorte rinforzava o attenuava il rischio di monopsonio da parte dei pistores piugrave potenti e facoltosi cosigrave come eventuali tentazioni da parte della categoria di esercitare un dominio egoistico sul mercato del pane (MAITOZZl1983 298)
Sarebbe quindi un errore concepire le scorte dei fornai come entropica allocazione di capitale che sconta lincertezza futura esse venivano gestite secondo criteri di rashyzionalitagrave economica e secondo la migliore efficienza tecnica nonostante i vincoli imposti alla lievitazione degli stock dalle disposizioni annonarie
lA costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
vimini paglia o canne intrecciate (come ceste stuoiecannizzi) in terracotta (addirittura anfore) piuttosto che di tessuto (i sacchi costavano troppo) (PICCINNl1976 397 MAzzA RAvEGol 1983 174-5 Zoo Toce 1990 893-4 COIiITONES11991 35n-36n)
Nella casa del piccolo produttore o del titolare di un piccolo possesso il penw (la scorta domestica) difficilmente eccedeva il consumo famigliare chi fortunato raccoshyglieva piugrave dell annona famigliare e di quanto gli serviva per il campo era spinto a venderselo nei mesi immediatamente successivi alla mietitura e alla trebbiatura per necessitagrave di denaro ma anche per la difficoltagrave di stoccare e conservare il prodotto in condizioni ottimali (MEuvRET 1988 17-9 PuLT QUAOUA 1984 88) e figravenanco per ridurre il rischio di vederselo soffiare da vagabondi e malintenzionati In questo caso in presenshyza di eccedenze (ma probabilmente anche in assenza) il bisogno di liquiditagrave e lalea cospiravano nel ridl1ITe ai minimi termini le scorte giagrave allindomani del raccolto In caso alternativo il contadino che non egrave - ripete Jean Meuvret - un homme daffaires quanshyto un homme de peur concepiva la sua riserva come un fondo di previdenza sul racshycolto futuro da non immettere sul mercato se non nel caso dellapprossimarsi di una messe sicura secondo una logica economica a contrario (MEUVRET 1988 19 e 147)
Era Jl~tente la disparitagrave fra i produttori non solo fra chi era in possesso di eccedenshyze e chi non lo era ma piugrave anqgtra fra chi poteva scegliere in virtugrave di una maggiore capienza economica e unadeguata dotazione tecnica - il mercato piugrave favorevole per i propri grani (il periodo di saldatura dei raccolti) e chi invece li cedeva troppo presto o in controtempo a livelli non ottimali
Nella gerarchia delle abitazioni rurali -- in quel vero e proprio saggio di sociologia che egrave il sesto libro del DeArchitectura di Sebastiano Serlio (scritto fra il 1537 eil 1555 inedito per tutto levo moderno) -- per trovare case attrezzate di granaio occorshyreva ascendere sino alla magione del basso mercante o cittadino fuori della cittagrave (SERLlO 1994 43 segg anche per le successive informazioni) Condizione di cui non potevano fregiarsi invece i ricchi contadini in ~essuno dei tre gradi possibili di ricshychezza al massimo la loro casa poteva essere attrezzata di portici per ricoverare le biade e di unaia per batterle segni di distinzione giagrave fra i mediocri contadini Fra questi perograve avrebbero potuto avvalersene soltanto i fortUIgravelati et di beni et di famishyglia (3deg grado di mediocritagrave) nforno per cuocere il pane e una cantina per conservashyre il vino invece li si sarebbe trovati a partire dai piugrave accomodati fra i poveri contashydini cioegrave al 4deg gradino della scala sociale alla cui base erano da collocare i poveri mendichi con vii capanna (10 grado di povertagrave) i salariati che vivevano delle [loro] fatiche avendo un puoco di terreno (2deg grado di povertagrave) i poveri con qualche beshystiuola et massimamente de buOvi possessori di una stalletta congiunta con la casa 0deg grado di povertagrave)
In sintesi nelle campagne delletagrave pre-industriale pochi avevano scorte pochissimi erano in grado di ricoverarle in un solaro privilegiatissimo chi le incanevava per speculare Dunquefra i conta4ini se si esclude quanto celato nella madia o nella dishyspensa le scorte erano un pri~ilegio di pochi nSerlio nato intorno al 1475 insiste sullimpoverimento delle class~ rurali intervenuto fra gli anni della sua giovinezza e quelli della vecchiezza in cui scrive Sotto il titolo Dellabitazione del ricco contadishyno per tre gradi di ricchezza si preoccupa di puntualizzare
bencheacute al di dogi non se n~ truovi piugrave de tali merceacute delle discordie et di gli animi fieri et ostinati alla vendetta onde per tal cagioni et per le continue guerre et anche pei citadini divoratori de gli altrui beni che con le usure con glinganni con le rapine gli bano impoveriti (SERUO 1994 ~8)
490 RellOP CorrilOle
colto (agosto-settembre-ottobre) e invia di esaurimento almomento della saldatura dei raccolti (aprile-maggio-giugno )1A questo proposito nota Franccedilois Sigaut
Le stockage agrave court terme (moins dune campagne) reacutepond agrave la neacuteCessiteacute cIeacute concilier une offre variable et une demande constante mais toutes deux reacutegulieacuteres et preacutevisibles dans la
pratique il est consideacutereacute comme tiiisant pame du processus ordinaire de la production et ne pose agrave ce titre que desproblegravernes doptimisation assez simples (SlOAUI 1985 602)
La discussione generale sulla razionalitagrave economica delle scorte alimentari in etagrave pre-industriale puograve allora essere ridotta alla fonnulaiione e allo scioglimento di due
semplici quesiti 1 Accertato che laccantonamento digram per la periodicitagrave annuale del ciclo agricoshy
lo epet i vincoli tecnici di un rifomimento spazialmente allargato egrave inevitabile chi egrave conveniente che conservi le scorte chi produce o chi commercia il contadino o il mercante lapossidenzagrave o il popolo i particolari o il pubblico E qual egrave la realtagrave effettiva
2 Se le forme di distribUzione economicamente razionale sono plurali in quale conshytesto e in omaggio a quali interessi piugrave utile il sistema della canova rispetto al sistema delll piazza del mercato e dei solari privati
3 SULLADISTRIBUZIONE DEL GRANO NELUETAgrave PRE-INDUSTRIALE E LA STRUTTURA DELLE SCORTE NEI TERRITORI ITALIANI
Raramente le case contadine erano dotate di attrezzature per la conservazione dei cereali piugrave che elementari Nelle campagne toscane del Quattrocento dunquein unetagrave favorevole al reddito contadino in una regione fra le piugrave ricche dellEuropa pre-indushystriale
pochissime case contadine disponevano del granaio vero e proprio alcune avevano una cella che poteva servire allo stesso scopo ma la maggior parte di quelle abitazioni era priva di spazi destinabili esclugravesivamente alla conservazione dei cereali Perciograve i contenitori dei grani arche casse sacchi bugnole - dovevano trovare posto nelle cucine o nelle camere CMA= RAVEGGI 1983 174)
Le ridotte capacitagrave patrimoniali e reddituali della grande maggioranza dei produttori facevano sIgrave che fosse ampiamente invalso nella conservazione domestica dei grani limshypiego di contenitori in legno (come arche casse botti bugnole tini tinelle corbelli)in
Riguardo ai passi evidenziati di Zanetti e Cipolla egrave neCessario osservare che la principale atteshystazione sullesistenza di stock detenuti da privati che esorbitassero ilfabbisognostagionale tali da essere classificati come immobili=zione di ricchezza (Zanetti) o come beni capitale (Cipolla) a unanalisi piugrave fine si rivela fallace o non direttamente utilizzabile La propalazione dei grani effetshytuata a Pavia fra ilimiddot e il5 maggio 1555 che egrave il fondamento di entrambi i giudizinon mostra una somma di derrate realmente eccedente il fabbisogno delle famiglie per il periodo che manca allarri_ vo dei grani novelli sulla piazza pavese Daltra parte lastessa natura dellistituto della propalazioshyne dei grani cioegrave della denljncia obbligatoria delle scorte da parte dei particolari una misura demergenza decisa in momenti critici dellapprovvigionamento cittadino affiancata quellanno dalshylispezione diretta presso le case dei privati da parte di deputati straordinari avrebbe dovuto consishygliare una maggiore cautela nella sua utilizzazione per individuare regolaritagrave di carattere generale delleconomia pre-industriale
499 La costituzione di scorte granarie pubbliche e la ptlitica ecoMmica degli stati
FONTI
ABEL [1966) W ABEL Agrarkrisen undAgra~kJJnjunktur Eine Geschichte der londshy und Erniihrungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter Hamburg
und Berlin Paul Parey 19662 (la ed -1935 trad it Congiuntura agraria e crisi agrarie Storia dellagricoltura e della produzione alimentare nellEuropa centrashyle dal XIII secolo alletagrave industriale Torino Einaudi 1976 da cui si cita)
AG ARCHIVIO GoNZAGA presso lArchivio di Stato di Mantova AuFANO 1996 E AuFANO Il grano il pane e la politica annonaria a Napoli nel Setshy
tecento Napoli ESI 1996bull AYMARO 1966 M A YMARO Wmise Raguse et le commerce du bMpendant la seconde
moitieacute du XVI siegravecle Pans SEVPEN 1966 CATIINI 1984 M CATl1NI I contadini di San Felice Metamorfosi di un mondo rurale
nellEmilia delletagrave modernIgravel Torino Einaudi 1984 CESTARl 1794 p CESTARI Saggio storico dei Fondachi delle farine di Chioggia e
Pellestrina Venezia A Zatta 1794 CIPOllAJ1965] C M CIPOllA La politica economica dei governi V La penisola
italigraveana e la penisola iberica in Storia economica Cambridge m La cittagrave e la politica economica nel Medioevo Torino Einaudi 1977 (Cambridge 1965) pp 462-496
CIPollA 1974 C M CIPollA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna nMulino 1974
CIpollA 1997 C M CIPOllA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna nMUlino 1997 (6 ed riveduta)
CORRITORE 2000 R P CoRRITORE La naturale abbondanza del Montovano Produshyzione mercato e c01isumi granari a Mantova in etagrave moderna Pavia Universitagrave di Pavia 2000
CORIONBSI 1991 A CORIONBSI Sulla conservazione dei cereali nellItagravelia medioevale Lavoro e tecniche nelle tesnmonlanze laziali (secc XIII-XV) in Rivista di storia dellagricoltura XXXI 1991 l pp 33-49
DELLA VALENTINA 1992 M DELLA VALENTINA I mestieri del pane a ~nezia tra 600 e 700 in Atti dellIstituto [Veneto di Scienze Lettere ed Arti Classe di scienze morali lettere ed arti CL 1991-92 pp 113-217
DIRLMEIER 1984 U DIRLMEIER le condizioni materiali dellesistenza nelle cittagrave tedeshy sche del Basso Medioevo ~iente esterno reddito consumi in Aristocrazia citshy
tadina e ceti popolari nel tprdo Medioevo in Italia e in Germania (a cura di Reinhard Elze e Gina Fasoli) Bologna Societagrave editrice il Mulino 1984 pp 79shy122
FORNASIN 1999 A FORNASIN Il pzercatodei grani di Udine Indagine per una storia dei prew in Friuli (secoli XfI-XVIII) Nota di ricerca del Dipartimento di Scienshyze Statistiche dellUniversit4 degli Studi di Udine 4 1999 pp 1-24 ora in lo La Patria del Friuli in etagrave 1fIOderna Saggi di storia economica Udine Forum 2000 pp 33-60
GRENDI 1986 E GRENOI Lapprccedilwigionamento dei grani nella Liguria del Seicento libera pratica e annone in iMiscellanea storica ligure Studi in onore di Luigi Bulferetti XVIII 1986 2Jp 1021-1047
GUENZI 1981 A GUENZI Ilfrurnfnto e la cittagrave il caso di Bologna nelletagrave moderna in Quaderni storici XVI ~981 46 pp 153-167
GUENZI 1982 A GUENZI Pane ~fornai a Bologna in etagrave moderna Venezia Marsilio 1982
I
489 500 Renzo P CornIOle
GUBNZI1982 A GUEml Sistema annonario e egraveontrollo sociale a Bologna nei seccediloli XVII e XVIII in E SORI (a cura di) Cittagrave e controllo sociale in Italia fra XVIII e XIX secolo Milano F Angeli 1982 pp 293-306
HICKS [1989] 1 R HIClCS A narlcet theory of money Oxford Oxford Universigravety Press 1989 (trad it Una teoria di mercato della monefa Bologna li Mulino 1992 da cui sigrave cita)
JACOPBITI 1965 N L JACOPBITI Monete e prezzi a Cremona dal XVI al XVlIi secolo Cremona Athenaeum CregravemoneJlSe 1965
KAPLAN 1984S L KAPLAN Provisioning Paris Merchants and Millers in the Grain and Flour Trade during the Eighteenth Century Ithaca-London Cornell Univershysity Press 1984~middot
KULA [1962] W KULA Teoria ekonomiczna ustrojufeudalnego Proba modelu Warshyszawa-Panstwowe WydawnictwoNaukowe 1962 (trad it Teoriagrave economica del sistema feudale Proposta di un modello Tormo EinaUdi 1972 ccedilla cui si cita)
WROUSSE [1933] C-E LABRoussE Esquisse du mouvement des prix et des reverws en France au XVIII siegravecle Paris Eacuteditions des Archives Contemporaines 19842 volI (l ed Paris Librairie Dalloz 1933)
MALANtMA 1976 P MALANiMA Aspetti di mercato e prezzi del grano e della segalea Pisa dal 1548 al 1818 in Ricerche di storia moderna vaL I Pisa Pacini 1976 pp ~n
MANToVA 1430 MwroVA 1430 Pareri a Gian Francesco Gonaga per il governo (a cura di M AQrignaniA M Lorenzoni A Mortari C Mozzarelli) MUltova G~ Arcari 1990
MASSA 1999 PMAssA Annona e corporazioni del settore alimentare ~ Genova orshyganizzazione e conflittualitagrave (XVI-XVIII secolo) in A GUENZI PMAssA A MOIOshyu (a cura di) Corporazioni e gruppi professionali nellItalia moderna MilIllO F Angeli 1999 pp 390-403
MATIoZ7J 1983 1 MiJroZ7J F BOLELLI C CmAsBRA D SABBIONI Il politico e il pane a Venezia (157Q-1650) calmieri e governo della sussistenza in Societagrave e storia VI 198320 pp 271-303
MAzzI RAVEOOI 1983 M T MAzzI S RAVEOGI Gli uogravemini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento Firenze Olscbki 1983
MERONI 1957 U MERONI Cremona fedelissima Ciemona Athenaeum Cremonenshy~~~ _
MBUVRBl 1977 J MEuVRsT Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque LouisXIvI La productiograven des ceacutereacuteales dans la France du XVII et du XVIII siegravecle Paris Mouton -EacuteEHSS19772voll
MBUVRET 1988 J MBtJVRf Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque Louis XIv III Le commerce des gralns et la conjoncture Paris EacuteEHss 1988 2 volI
PtCClNNI 1976 G PtCClNNl Wta contagravedina in una capanna dei dintorni di Siena (1250) in ~Archeologia medievale m 1976 pp 395-399
PlNIO 1978 G PINTOII Libro del BiaPaiolo Carestie e annona a Firenze dalla metagrave del 200 al 1348 Fire~ Olscbki 1978
PiNTO 1982 G PtNro La Toscana nel tardo Medioevo Ambiente economia rurale societagrave Fllenze Sansoni 1982
PtRENNE [1933J H PIRENNB La civilisation occidentale au Moyen Age du XIe au mishylieu du XVe siegravecle Paris PUF 1933 (trad it Storia economica e sociale del Meshydioevo Milano Garzanti 1967 da cui si cita)
Lacostituticne di scorte granarie pubbliche e la politica economiegravea degli stati
redigravestribuzione sostenibile dei beni di sussistenza egrave ricercata in questo cielo da quegli stessi particolari che ~amaldeggiano nella produzione negli scambi nei consumi e che costituiscono il nerbo della classe di governo Le scorte pubbliche rappresenteshyrebbero in questa prospettiva un presidio civico e un risltCimento politico e morale ai cOl1ponenti della comunitagrave spossessati delbene supremo dellautarchia alimentare
Resta infine latente unidea del magazzmo pubblico come quasi-mercato cioegrave come luogo volto (1) a risolvere i fa1limentiinfo~vi della piazza del mercato (in meacuterito alle disponi~ilitagrave alle caratteristiche del prodotto alle condizioni di vendita della merce) (2) a ridimensionare lalea per agricoltori consumatori poveri artigiani del comparto alimentare (3) a sostenere i consumi e i profitti privati m funzione anticicli ca in una prospettiva Ilpn meram~nte congiunturale Si tratta in questo caso di un orshyganizzaZionepienattiCnte razio~e Che non opera in maniera saltuaria e riflessa ma in modo continuativo secondo obifttili prefissati di allocazione dei beni primari li funshyzionamento dellacanovagrave (il magazzino pubblico) si porrebbe come strumento inteshygrativo ma no~~igraventeramente so~titutivo delloperare della piazza Si tratterebbe di unaforma di mercato distinta dalla p~ del mercato considerata in seacute e per seacute cosigrave come dallegraveOOmpravendite effetttlate nei solari privati o dalla mera centrallzzazione e redistribuzione di derrate con fi~alitagrave umanitarie La canova rappresenterebbe in tal modo uno dei possibili meccaoi~ di governo delle trllls3ZIgrave~ni locali per risolvere i problemi deUapprovvigionameIto senza intaccare certi interessi di classe (dei proshyprietari ma anche del popolo grasso) S da essere prescelta da autoritagrave e gruppi domishynanti come struttura complementare della piazza del mercato incerti contestiprodutshytivi ed economici La suasacrilizzazione perciograve non esclude la possibilitagrave di un ritorno alle sole compravendite qella piazza e dei solari privati - una volta invertishytosi il trend o spirate le condizioqi economiche della sua istituzionalizzazione
La problematizzazione esorc~ una liquidazione semplicistica del problema delle scorte gran8rle in etagrave pre-industriUgravee nel nome di una loro presunta irrazionalitagrave eco- nomica per il compito di assi~ la sussistenza della popolazione
Le pagine che segUono sono rintroduzione a un lavoro in corso volto a offrire un interpretazione generale di tal~ capitolo fondamentale della politica economica dei governi
in
etagrave pre-industriale
2 SE UN MONDO SENZA SCORTE Egrave INCONGRUO cm Egrave OPPORTUNO CHE LEgrave DETENGA
Nei fatti nel settore granarlo CQni vincoli dell etagrave pre-industriale in tema diprodutshytivitagrave energia trasporti non ha s~nso ipotizzare un mondo senza scorte Se il mercato del grano egrave - come nellEuropa medievale e moderna - un sjstema tendenzialmente chiuso
ad ogni raccolto nuove offe~ aniv(erannol sul mercato mentre la domanda si mant[erragrave] relativamente costantt nel corso dellanno Qualcuno dunque [dovragrave] ~ere delle scorte che saranno elevate ~ubito dopo il raccolto e poi via via minori fino aragshygiungere un livello minimo in prpssimitagrave del successivo raccolto (HICICS [19891 31)
Nella loro forma piugrave sempliceI tali scorte saranno legate allora alla periodi~itagrave anshynuale del ciclo agricolo (che a1iplenta il movimento stagionale dei prezzi ccedilfr LAshyBROlJSSE [1933] 157-66) il loro livello saragrave elevato allindomani del principiLle racshy
501 488 Renzo P Corritore
povero ammassograve nella propria dimora scorte di grano carne ~alata sale candele ecc e la medesima cosa fece lo Stato Nel periodo feudale non venne mai meno nel castello del signore labitudine di tenere da parte grosse scorte per i periodi di emergenza Sucshycessivamente le autoritagrave comunali predisposero il magazzinaggio di grosse derrate specie di grano da rivendere a basso prezzo in periodi di emergenza e nello stesso tempo si preoccuparono di prevenire un indebito accumulo di scorte da parte di specushylatori privati Nelle economie medievali gli stock di derrate di prima necessitagrave rappreshysentarono pertanto una delle piugrave importanti forme di investimento pubblico e privato (CIPOLLA (1965] 468)
Nella prima versione del manualeacute invece fino allinserimento nel 1997 del nuovo capitolo dedicato alla politica economica nell etagrave pre-mdustriale il punto di vista preshyvalente era quello microeconomico entro il perimetro stretto dellindividualismo meshytodologico
Le scorte costano e costano doppiamente Esse implicano il costo diretto che egrave rapshypresentato dal costo del magazzinaggio edal deterioramento eventuale del pr04otto o di parte di esso Se luomo daffari finanzia la costituzione delle scorte con danaro preso a prestito il costo diretto include anche il tasso di interesse pagato Se luomo daffari finanzia con capitale proprio la costituzione delle scorte il costo delle scorte deve inshycludere un costo-opportunitagrave e cioegrave il mancato rendimento (tIllU1cato tasso dinteresse attivo) del capitale finanziario impiegato (CIPOLLA 1974 154)
Le ragioni della costituzione e del mantenimento di scorte alimentari da parte delshylautoritagrave pubblica diventavano unicamente ragioni morali (umanitarie e di buona amministrazione) o di opportunitagrave politica (la fame era la piugrave frequente ligraveausa di sommosse e furori popolari) (CIPOLLA 1974 74)
Nel 1997 si riammetteva dunque linterpretazione originaria della costituzione di scorte pubbliche come strumento di riequilibrio del mercato senza peraltro rinnegare le considerazioni sulla valenza statica di tale forma di investimento per gli agenti economici privati
In merito allutilitagrave economica e al significato delle scorte in etagrave pre-industriale Cishypolla non espresse perciograve sempre lo stesso punto di vista La rassegna delle posizioni da lui assunte anzi permette di individuare tre approcci e tre giudizi costitutivamente diversi sulla funzione delle scorte granarie nellepoca pre-industriale
In prima approssimazione laccumulazione di scorte alimentari mostra il carattere fondamentalmente difensivo delle scelte degli agenti economici pubblici e privati in etagrave pre-industriale La paura la tradizione la superstizione li induce a tabuizzare il rischio la speculazione linvestimento nella produzione e nella distribuzione dei beni essenziali alla vita e ad aderire intimamente a un ideale di economia e societagrave stazionarie aggravando con la norma sociale le istituzioni il comportamento indivishyduale e collettivo leffetto dei condizionamenti materiali delleconomia pre-industriashyle (bassa produttivitagrave agricola alti costi di v~sporto modesta efficienza energetica) esponendo ancor di piugrave la comunitagrave umana ai degravemoni della natura
La seconda interpretazione rigetta luniversale imperio dellhomo oeconomicus rishyscoprendo leteronomia dei fini dellagire economico degli uomini nelletagrave pre-inshydustriale Ia politica economica dello Stato o-delle autoritagrave non persegue puri scopi economici lintegritagrave del corpo sociale fin nelle sue cellule elementari (persone e famiglie) deve essere assicurata secondo i principi e la prassi di uneconomia morale che SOVJa5ta leconomia regolata dal mercato spersonalizzata e antipopolare Una
La costituzione di scorte grantlTie pubbliche e la poligravetigraveca economica degli stati
PuLT QUAGUA 1984 A M PULT QUAGUA Mercato dei prodotti agricoli e magistratushyre annonarie a Pisa nelletagrave moderna in Ricerche di storia moderna a cura di M Mirri voI III Pisa Pacini 1984 pp 57-141
PULT QUAGLIA 1990 A M PULT QUAGLIA Per provvedere ai popoli Il sistema anshynonario nella Toscana dei Medici Firenze Olschki 1990
SERUO 1994 S SERLIO Architettura civile Libri sesto settimo e ottavo nei manoscritshyti di Monaco e Vienna (a cura di F P Fiore) Milano TI Polifi10 1994
SIGAlIT 1985 F SIGAlIT Questions deacuteconomie agrave propos des politiques ceacutereacutealiegraveres et de stockage in Les techniques de conservation des grains agrave long terme leur rale dans la dynamique des systegravemes de cultures et des socieacuteteacutes (sous la direction de M Gast F Sigaut et C Beutler avec la collaboratlon de O Bllchsenschutz) voI III 2 Paris Eacuteditionsdu CNRS 1985 pp 597-606
SMITH [1776 A SMITH An inquiry into the nature and causes ojthe wealth ojnations London W Strahanand T Cadell 17762 volI (trad it Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni Milano A Mondadori 1977 2 volI da cui
si cita) STATlITlBoNACOLSIANI [1313] STATUTI BONACOLSlANl (a cura di E Dezza A M Lorenshy
zoni M Vaini) Mantova GArcari 2002 STATUTI GONZAGHESCHI [1404] STATUTI GONZAGHESCHI presso la Biblioteca comunale di
Mantova ms FV 11 [775]VECCHIATO 1979 F VOCCHIATO Pane e politica annonaria in Terrajerma veneta tra
secolo XV e secolo XVIII (Il caso di Verona) Verona Stamperia Zendrini 1979 ZANETTI 1963 D ZANETTl Contribution agrave leacutetude des structures eacuteconomiques lapshy
provisiQnnement de Pavie au XVI siegravecle in Annales ESC XVIII 1963 1 pp 44-62 ora in lo Fra le antiche torri Scritti di storia pavese Pavia Universitagrave di Pavia 2000 pp 165-182
ZANETTl 1964 D ZANEITI Problemi alimentari di una economia preindustriale Ceshyreali a Pavia dal 1398 al 1700 Torino P Borlnghieri 1964
ZUG TUCCI 1990 H ZUG TuCCI Le derrate agricole problemi materiali e concezioni mentali della conservazione in Lambiente vegetale nellalto Medioevo XXXVII Settimana di studio del Centro italiano di studi sullalto Medioevo (30 marzo-5 aprile 1989) Spoleto Centro italiano di studi sullalto Medioevo 1990 voI n pp 865-902
499 490 RelloP COrrilore
colto (agosto-settembre-ottob~) e in via di esaurimento almomento della saldatura dei raccolti (aprile-maggio-giugno)lA questo proposito nota Franccedilois Sigaut
Le stockage agrave court terme (moms dune campagne) Ieacutepond agrave la neacuteCessiteacute egravek concilier une offre variable et une demande constante mais toutesdeux reacutegulieacuteres et pIeacutevisibles dans la pratique il est ccedilonsideacutereacute comme tagraveisant partie du procegravessus ordigravenaire de la prOduction et ne pose agrave ce titre quedes probJegravemes doplimisation assez simples (SIGAUT 1985 602)
La discussione generale sulla razionalitagraveegraveconomica delle scorte alimentari in etagrave pre-industriale puograve allora essere ridotta alla formulaZione e allo scioglimento di due semplici quesiti 1 Accertato che laccantonamento di grani per la periodicitagrave arinuale del ciclo agricoshy
lo epel i vincoli tecnici di un rifornimento spazialmente allargatoegrave inevitabile chi egrave conveniente che conservi le scorte chi produce O chi cOnlmercia il contadino o il mercante lapossidenza o il popolo i particolari o ilpubblico E qual egrave la realtagrave effettiva
2 Se le forme di distrigravebIgravelZIgraveone economicamente razionale sono plurali in quale conshytesto - e in omaggio a quali interessi - egrave piugrave utile iI sistema della canova rispetto al sistema della piazza del mercato e dei solari privati
3 SULLADISTRlBUZIONE DEL GRANO NELLETAgrave PRE-INDUSTRlALE E LA STRUTTURA DELLE SCORTE NEI TERRITORI ITALIANI
Raramente le case contadine erano dotate di attrezzature per la conservazione dei cereali piugrave che elementari Nelle campagne toscane del Quattrocento dunqueJn unetagrave favorevole al reddito contadino in una regione fra le piugrave ricche dellEuropa pre-indushystriale
pochissime case contadine disponevano del granaio vero e proprio alcune avevano una cella che poteva servire allo stesso scopo ma la maggior parte di quelle abitazioni era priva di spazi destinabili esclusivamente alla conservazione dei cereali Perciograve i contenitori deigrani - arche casse sacchi bugnole - dovevano trovare posto nelle cucine o nelle camere (MAzzI RAvEGOI 1983 174)bull
Le ridotte capacitagrave patrimoniali e reddituali della grande matregoranza dei produttori facevano si che fosse ampiamente invalso nella conservazione domestica dei grani limshypiego di contenitori in legno (come arche casse botti bugnoletini tinelle corbelli)in
Riguardo ai passi evidenziati di Zanetti e Cipolla egrave necessario osservare che la principale atteshystazione sullesistenza di stock detenuti da privati che esorbitassero ilfabbisogno stagionale tali da essere classificati come immobilizzazione di ricchezza (Zanetti) o come beni capitale (Cipolla) a unanalisi piugrave fine si rivela fallace O non direttamente utilizzabile La propalazione dei grani effetshytuata a Pavia fra ilIo e il 5 maggio 1555 che egrave il fondaIgravenento di entrambi i giudizinon mostra una somma di derrate realmente eccedente il fabbisogno delle famigiie per il periodo che manca allarrishyvo dei grani novelligrave sulla piazza pavese Daltra partelastessa natura dellistituto della propaazio- ne dei grani cioegrave della denllncia obbligatoria delle scorte da parte dei particolari una misura demergenza decisa in momenti critici dellapprovvigionamento cittadino affiancata quellanno dalshylispezione diretta presso le case dei privati da parte di deputati straordinari avrebbe dovuto consishygliare una maggiore cautela nella sua utilizzazione per individuare regolaritagrave di carattere generaledelleconomia pre-industriale
La costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli slatibull
FONTI
ABEL [1966] W ABEL Agrarkrisen und Agrarkonjunktur Eine Oeschichte der Landshy und Ernlihrungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter Hamburg
und Berlin Paul Parey 19661 (P ed -1935 trad it Congiuntura agraria e crisi agrarie Storia dellagricoltura e della produzione alimentare nellEuropa centrashyle dalXlII secolo alletagrave industriale Torino Einaudi 1976 da cui si cita)
AG ARCHIVIO GONZAGA presso lArchivio di Stato di Mantova AuFANO 1996 E AuFANO Il grano il pane e la politica annonarla a Napoli nel Setshy
tecento Napoli ESI 1996 bull AYMARD 1966 M AYMARD Veacutenise Ragusegrave et le commerce du bleacute pendant la seconde
motti du XVI siegravecle pans SEVPEN 1966 CA1TINl1984 M CATlINl I contadini di San Felice Metamorfosi di un mondo rurale
nellEmilia delletagrave moderna Torino Einaudi 1984 CEsTARI 1794 p CESTARI Saggio storico dei Fondachi delle farine di Chioggia e
Pellestrina~ bullbull Venezia A Zatta1794 CIPOLLA [1-965] C M CIPOllA La politica economica dei governi V La penisola
italigraveana e la penisola iberic(l in Storia economica Cambridge ID La cittagrave e la politica economica nel Medioevo Torino Einaudi 1977 (Cambridge 1965) pp 462-496
CirollA 1974 C M CiPollA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna TI Mulino 1974
CIpOLLi 1997 C M CIPOllA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna TI Mulino 1997 (6 ed riveduta)
CORRITORB 2000 R P CORRITORB La naturale abbondanza del Mantovano Produshyzione mercato e consumi grqnari a Mantova in etagrave moderna Pavia Universitagrave di Pavia 2000
CORTONESl 1991 A CORTONESr Sulla conservazione dei cereali nellItalia medioevale woro e tecniche nelle tesnnonianze laziali (secc XIII-XV) in Rivista di storia dellagricoltura XXXI 1991 l pp 33-49
DElLA VALENTINA 1992 M DEJ1A VALENTlNA I mestieri del pane a Venezia tra 600 e 700 in Atti dellIstituto igraveVeneto di Scienze Lettere ed Arti Classe di scienze morali lettere ed arti CL 1991-92 pp 113-217
DIRLMEIER 1984 U DiRLMEIER Le condizioni materiali dellesistenza nelle cittagrave tedeshy sche del Basso Medioevo wlwiente esterno reddito consumi in Aristocrazia citshy
tadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia e in Germania (a cura di Reinhard Elze e Gina Fasoli) Bologna Societagrave editrice il Mulino 1984 pp 79shy122
FORNASIN 1999 A FORNASlN II rnercatodei grani di Udine Indagine per una storia dei prezzi in Friuli (secoli X1(1-XVIII) Nota di ricerca del Dipartimento di Scienshyze Statistiche dellUniversitagrave degli Studi di Udine 4 1999 pp 1-24 ora in ID La Patria del Friuli in etagrave frtoderna Saggi di storia economica Udine Forum 2000 pp 33-60
GRENDI 1986 E GRENOl Lapprf(vvigionamento dei grani nella Liguria del Seicento libera pratica e annone in rMiscellaneastorica ligure Studi in onore di Luigi Bulferetti XVIII1986 2 IP 1021-1047
GUENZl 1981 AGUENZI Ilfrumento e la cittagrave il caso di Bologna nelletagrave moderna in Quaderni storici XVI ~98l 46 pp 153-167
GUENZlI982 A GUENZI Pane efornai a Bologna in etagrave moderna Venezia Marsilio 1982
l
491 498 Renzo P Corritore
alla spartizione dei proventi derivanti dalla vendita e dal commercio del grano shylemolumento grandissimo - di chi doveva poi fruire della redistribuzione di tale ricchezza Tale norma avvantaggiava i possidenti cittadini e i gentiluomini privilegiashyti in grado di ottenere le tratte di esportazione Spl piano dellappropriazione essi erano in condizione di mettere fuori gioco gli altri possessori che producev~o eccedenze nel Dorilinio poicheacute si accresceva la loro forza contrattuale e la loro capacitagrave di occupare i canali commerciali piugrave redditizi Sul piano della commercializzazione gli stessi fruivashyno dello smantellamento della rete dintermediazionerappresentata dai fornai Per i rushystici significava perdere un collegamento essenziale con la cittagrave ed essere emarginati dal mercato urbano nelle campagne o sul broletto di Mantova essi non trovarono piugrave i trashydizionali interlocutori (CORRIJ9RE 2000 228231-2)
Nel caso di Bologna terra strutturalmente deficitaria e cittagrave dalla vocazione manishyfatturie1a si costringeva i fornai ad acquistareformenti terrieri presso i solari privati in cittagrave proibendogli lincetta nel contado autorizzandoli ad acquistarefornientiforeshystieri al di fuori delle mura cittadine presso rsensati da grCUlO solo a patto che fosseshyro stati smaltiti i grani cittadini a un prezzo talota superiore a quello dei grani dimshyportazione (GTlBNZl1982A 35 52-3)
Nella Toscana dei Medici il diritto allincetta nel contado venne concesso ai fornai in periodo di bassa congiuntura (in particolare dagli anni Trenta del Seicegravento) Per sostenere i prezzi interni in tal caso essi restavano gli interlocutori principali dei granshydi proprietari semplicemente spostando la loro principale fonte di approvvigionashymento dai solari dei particolari in cittagrave ai granai decentrati delle grandi aziende agrishycole oppure ai mercati rurali su cui affluiva la produzione cerealicola delle grandi fattorie (PULT QUAOUA 1984 86-9 PucrQUAGUA 1990 100 106-7)
Laddove non vi egrave come invece succede a Genova una diretta ingerenza del potere pubblico nella vita della corporazione (MAsSA 1999) i fornai di cittagrave- nonostante i lacci e lacciuoli normativi e il lavoro prevalentemente manuale svolto neUord laboshyratori - erano dei veri imprenditori dipendenti per il loro profitto - noilrinalmente stabilito per legge - dalla produttivitagrave del lavoro e dalla dotazione tecnica e finanziaria delle imprese Di ciograve fa fede la grande sperequazione esistente fra le aziende speciashylizzate nena fabbricazione del pane venale in cittagrave (AYMARD 1966 75 VBCCHIATO 1979 82-3 GTlBNZl1982A
77 segg PULT QUAGUA 1984100 102-3) NellItalia delshyletagrave moderna questi artigiani-imprenditori della filiera del grano trattavano insieme
afarinaifarinaiolifarinottifondachierifontechierifidelarijormentinari lasagneshyri maccaronari taraltari vermicellari ecc fra il 40 eil70 per centodel frumento consumato in Cittagrave nelle annate normali (CORlUTORE 2000 126 segg) e ~no alIDO per cento nelle annate di carestia (PULT QUAGUA 1984 98-9)
In una ricognizione delle asimmetrie informative del mercato non cegrave gruppo quale i fornai che possa integraverpretare la parte dellagente economico onnisciente Se dunque i regolamenti annonari tendevano a regolare minuziogravesamente la collocazione il volushyme e la durata delle loro scorte cosi come disponevano per gli altri artigiani della fishyliera era per neutralizzare il carattere potenzialmente eversivo di tale accantonamenshyto per i proprietari-venditori prima ancora che per i consumatori-acquirenti nlivello delle scorte rinforzava o attenuava il rischio di monopsonio da parte dei pistores piugrave potenti e facoltosi cosi come eventuali tentazioni da parte della categoria di esercitare un dominio egoistico sul mercato del pane (MATroZZI 1983 298)
Sarebbe quindi un errore concep~ le sccedilorte dei fornai come entrilpica allocazione di capitale che sconta lincertezza futura esse venivano gestite secondo criteri di rashyzionalitagrave economica e secondQ la migliore efficienza tecnica nonostante i vincoli imposti alla lievitazione degli stock dalle disposizioni annonarie
LA costituzione di scorre granarie pubbliche e la polilica economica degli stati
vimini paglia o canne intrecciate (come ceste stuoiecannizzi) in terracotta (addirittura anfore) piuttosto che di tessuto (i sacchi costavano troppo) (PICClNNl 1976 397 MAzzA RAvBGGI 1983 174-5 Zoo Turo 1990 893-4 CORIONESI 1991 35n-36n)
Nella casa del piccolo produttore O del titolare di un piccolo possesso il penus (la scorta domestica) difficilmente eccedeva il consumo famigliare chi fortunato raccoshyglieva piugrave dellannona famigliare e di quanto gli serviva per il campo era spinto a venderselo nei mesi immediatamente successivi alla mietitura e alla trebbiatura per necessitagrave di denaro ma anche per la difficoltagrave di stoccare e conservare il prodotto in condizioni ottimali (MEUVRET 1988 17-9 Pmr QUAGUA 1984 88) e financo per ridurre il rischio di vederselo soffiare da vagabondi e malintenzionati In questo caso in presenshyza di eccedenze (ma probabilmente anche in assenza) il bisogno di liquiditagrave e 1alea cospiravano nel ridl1rre ai minimi termini le scorte giagrave allindomani del raccolto In caso alternativo il contadino che non egrave - ripete Jean Meuvret - un homme daffaires quanshyto un homme de peur concepiva la sua riserva come un fondo di previdenza sul racshycolto futuro da non immettere sul mercato se non nel caso dellapprossimarsi di una messe sicura secondo una logica economica a contrario (MEUVRBT 1988 19 e 147)
Era Hltente la disparitagrave fra i produttori non solo fra chi era in possesso di eccedenshyze e chi non lo era ma piugrave ancora fra chi poteva scegliere - in virtugrave di una maggiore capienza economica e un adeguata dotazione tecnica - il mercato piugrave favorevole per i propri grani (il periodo di saldatura dei raccolti) e chi invece li cedeva troppo presto o in controtempo a livelli non ottimali
Nella gerarchia delle abitazioni rurali -- in quel vero e proprio saggio di sociologia che egrave il sesto libro del De Architectura di Sebastiano Serlio (scritto fra il 1537 e il 1555 inedito per tutto levo moderno) - per trovare case attrezzate di granaio occorshyreva ascendere sino alla magione del basso mercante o cittadino fuori della cittagrave (SERLIO 1994 43 segg anche per le successive informazioni) Condizione di cui non potevano fregiarsi invece i ricchi contadini in ~ssuno dei tre gradi possibili di ricshychezza al massimo la loro casa poteva es~ere attrezzata di portici per ricoverare le biade e di unaia per batterle segni di distinzione giagrave fra i mediocri contadini Fra questi perograve avrebbero potuto avvalersene soltanto i fortUIgravelati et di beni et di famishyglia (3deg grado di mediocritagrave) Dforno per cuocere il pane e una cantina per conservashyre il vino invece li si sarebbe trovati a partire dai piugrave accomodati fra i poveri contashydini cioegrave al 4deg gradino della scala sociale alla cui base erano da collocare i poveri mendichi con vil capanna (1deg grado di povertagrave) i salariati che vivevano delle [loro] fatiche avendo un puoco di terreno (2deg grado di povertagrave) i poveri con qualche beshylitiuola et massimamente de buovi possessori di una stalletta congiunta con la casa (3deg grado di povertagrave) In sintesi nelle campagne delletagrave pre-industriale pochi avevano scorte pochissimi
erano in grado di ricoverarle in un solaro privilegiatissimo chi le incanevava per speculare Dunque fra i contadJni se si esclude quanto celato nella madia o nella dishyspensa le scorte erano un pri~ilegio di pochi Il Sedio nato intorno al 1475 insiste sullimpoverimento delle class~ rurali intervenuto fra gli anni della sua giovinezza e quelli della vecchiezza in cui segraverive Sotto il titolo Dellabitazione del ricco contadishyno per tre gradi di ricchezza si preoccupa di puntualizzare
bencheacute al digrave dogi non se ne truovi piugrave de tali merceacute delle discordie et di gli animi fieri et ostinati alla vendetta onde per tal cagioni et per le continue guerre et anche pei citadini divoratori de gli altrui beni che con le usure con glinganni con le rapine gli hano impoveriti (SERllO 1994 48)
492 497 Renzo P COlTitore
Tale disparitagrave sociale si riverberava sulla struttura del conunercio cerealicolo La funzione dei piccoli conunercianti di biade (granaioibiadaiolijarinaioli balshy
zarotti cavallanti vaticali ecc) era infatti ancillare alla capacitagrave di affacciarsi sul nercato della fascia marginale dei possidenti con eccedenze Solo che nelle annate di
abbondanza si verificavano ingorghi nellofferta di grano che deprimevano i prezzi e incentivavano i piccoli produttori a smerciare direttamente le eccedenze allindomani del raccolto nellarea urbana anche al di fuori dei luoghi deputati (MA1TOZZl 1983 278 281-2 300n PULT QuAGLIA 1984 86) Mentre nelle annate di penuria si contraeshyva drasticamente proprio questo segmento dellofferta (ABEL (1966J 22-4 KULA (1962] 73-4 CATIINI 1984 111-23 PuLT QUAGLIA 1984 88) scatenando nelle campashygne una caccia al grano-merce la cui quota piugrave consistente era detenuta dai grandi proprietari dai maggiori affittuari dai percettori di canoni diritti o rendite in grano e la cui quota residua era piugrave facilmente preda di chi occupava posizioni chiave nellasshysetto terriero nella catena dei diritti nel credito alla produzione e al consumo
Tanto la distribuzione era frammentata nelle annate di abbondanza tanto in epoclshydi penuria il conunercio del grano diventava un affare di pochi In questo caso lazioshyne dei mercanti diventava dimpiccio sul mercato interno dove la coperta si restringeshyva per i proprietari e gli imprenditori agricoli (KULA (1962J 56-61 CATIINI 1984 114-8) - dove la necessitagrave di ricorrere al credito da parte dei piccoli possessori pOneva questi nelle mani degli agenti dei proprietari dei percettori di canoni diritti o rendite - dove i piccoli proprietari vedevano minacciata la loro stessa condizione da parte di chi controllava localmente in maniera capillare e decentrata il mercato del denaro e dei beni necessari alla riproduzione (sernenti strumenti cibo) La soluzione era quelshyla di precludere amministrativamente ai sensali e ai conunercianti di grani i mercati locali su istigazione dei medi possessori le cui occasioni di normale profitto agrario soffrivano un ridimensionamento e che si vedevano costretti a impegnarsi ccedilontiltte le loro forze per integrare le proprie entrate accaparrandosi le magre eccedenze disponishybili nelle campagne e nei borghi rurali (PuLT QUAGLIA 1984 84-8 PuLT QUAGLIA 1990 107-14)
Il destino dei piccoli conunercianti in grano era quindi quello di occupare una posishyzione marginale nel mercato del grano (MEUVRET 1977 30 PINTO 1978 13 MATTOZZI 1983 277) e di operare non solo a causa degli ordinamenti annonari - secondo una logica di corto respiro in cui non era contemplata neacute la conservazione di grani a lungo termine neacute lutilizzo di depositi piugrave che provvisori Come per i piccoli possidenti non si puograve parlare nel loro caso della formazione e del mantenimento di scorte consistenti (MEUVRET 1988 156-7) Non tali comunque da sostenere il reddito contadino nelle stagioni ordinarie e da esercitare sul versante cittadino unefficace azione anticonshygiunturale in caso di carestia
Peraltro in cittagrave la struttura dellofferta era anche piugrave sperequata di quella che si rishyscontra nel contado Che si tratti di Prato ne) 1339 (PlNTO 1978 129 PINTO 1982 160n e 171n) Pavia negli anni 1539 1555 1573 1602 1603 (ZANIITTI 1963) o Mantova nellultima parte del secolo XVI (CORRITORE 2000 81-9) la distribuzione delle scorte fra i privati era singolarmente ineguale Lo attesta la rilevanza nellarea urbana della povertagrave cioegrave secondo una definizione coeva di coloro che non vivono di entrate ma sono necessitati ricorrere mattina e sera alle pistorie a comprare il pane per il vitto loro e delle sue famiglie col denaro che di giorno in giorno si vanno guadagnando (MATshyTOZZI 1983 281) PUOgrave essere utile richiamare la situazione delle cittagrave tedesche nel basso Medioevo in una fase che egrave stata definita da Wilhelm Abel l epoca doro degli artigiani e del lavoro salariato si puograve stimare che almeno la metagrave degli iscritti ai
il costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica ecol1Omica degli stati
te con il principio della piazza Il mercato pubblico periodico disciplinato la spiagshygia la piazza la loggia o il recinto riservato alle contrattazioni - coesisteva confabshybriche magazzini ebotteghe La stessa piazza per funzionare al meglio secondo il principio dello scambio diretto necessitava di magazzini di supporto
4 LE SCORTE DEI FORNAI CITTADINI
Nellarea urbana e nelle relazioni tra cittagrave e campagna operavano perograve temibili conshycorrenti dei privati possessori I fornai cittadini possedevano le competenze le strutshyture tecniche le relazioni sociali e il credito per incettagravere il prodogravetto per essere inforshymati tempestivamente sul mercato del grano e potenzialmente per dispensarlo con profitto in qualunque momento Il fatto che il loro operato fosse imprigionato in un arshycaica impalcatura di norme divieti obblighi che risalivano alletagrave romana che ne fashycevano in modograve quasi istituzionalizzato il capro espiatorio delle tensioni fra produtshytori di grano povertagrave e autoritagrave non impedisce di affermare che tali vessatorie disposizio~i trovassero la loro principale ragione dessere nella parte che essi giocashyvano di interlocutorilantagonisti dei proprietari terrieri nella determinazione del prezshyzo del grano sul mercato locale e nella realizzazione della rendita terriera (GUENZI 1982 35 GUENZl 1982 297)
Nel caso di Mantova terra cornucopia a partire dal 1492 si consenti a zentilhomini cittadini et qualuncho altro di comprare biade nel Dominio per approvvigionare la cittagrave di fatto si sancigrave un diritto allincetta che mise fuori gioco i fornai a cui venne imposto di rifornirsi nei solari dei cittadini senza avere piugrave la possibilitagrave di effettuare acquisti nel contado e di ritenere a casa scorte superiori a 100 staia di frumento Lintento della disposhysizione egrave chiarissimo espresso senza reticenze dai Maestri delle Entrate che riportarono al marchese la soddisfazione dei possidenti mantovani per la riforma statutaria
tutta la Terra (cioegrave il Mantovano] ne (egrave] rimasta satisfactissima pensando che Vostra Excellentigravea pretenda ali comodi et utilitagrave universale senza dampno et preuiditio suo Vero egrave che li fumari non si contentano parendoli comegrave il vero che non si poteranno ingrnssar asuo modo come hanno facto per il passato et poterigravea Igravelchader ( ] che veneranno adolershyse et supplicar aVostra Signoria Perograve me egrave parso dargene aviso per questa nostra et farli intender che questa terra ha soliigrave due membri de li quali li cittadini soi se ne possono aiutashyre e valersene uno egrave il grano laltro egrave larte de la lana et quando se concedesse che li furshyDari potessero comprare come h~o facto li tempi passati sana un fare beneficio acinquanshytaocto dessi et dampnifichar elresto de fa republica sua quale de questo ban ordine ne receve emolumento grandissimo et se gaude in la Citagrave [percheacute] li fumari portano fuora el denaro et pretendono solo a suo benefitio (AG b 2441 lettera del 13 luglio 1492)
Egrave indubbio che il plauso della Terra fosse da attribuire piugrave alla possibilitagrave per i proshyprietari di accrescere le proprie entrate che a quella dei consumatori cittadini e dell arte della lana di trarre beneficio dalla disposizione Egrave significativo che la motivazione pro cigravevitate non accenni allesistenza di monopoli da parte dei fornai o di artificiose lievitashyzioni dei prezzi per causa loro Il loro attivismo non confiiggeva per quanto riguarda i prezzi finali della sussistenza con linteresse dei produttori cittadini E daltra parte largomento dellQ storno dal merpato cittadino dei profitti incamerati dai fornai -laccushysa consueta a proposito dei pistores egrave che fossero in gran parte stranieri (GUENZII982 22) -- era una giustificazione debole che appassionava piugrave chi concorreva direttamente
496 493
Renzo P Corritore
appare altrettanto astratto dogmatico o virtuale del principio di mercato (Market Pri1lciple) che il medesimo gli contrappone Henri Pirenne parlando della politica annonaria dei comuni medievali avverte Lapplicazione del principio della vendita diretta ebbe numerosi eccezioni (PumNNE [1933] 193n)
Nel caso di Mantova la scelta della Piazza egrave facoltativa per i terrieri COn eccedenze Gli Statuti signorili che si rifanno largamente alle raccolte statutarie comunali non sancivano alcun obbligo in proposito (v SVJUTI BONACOLSIANI [1313] libro m rubr 55 De mercato blave 253 STATlITl GoNZAOHESCHI [1404J libro m rubr 93 De mercato blave fiendo in civitate Mantue f 73v) Decreti di carattere straordinario e regolamenshytazioni transitorie correggevano il tiro Nel 1405 in piena saldatura dei raccolti si c0shy
strinse a rifornire forzosamel)~ la piazza concentrandovi tutte le contrattazioni Nel 1417 si obbligograve a riservare al mercato un terzo del frumento introdotto in cittagrave (CORRIshyTORE 2000 235-6) Ma sono atti straordinari che non sopravvissero nel migliore dei casi piugravedi qualchelustro (MANroVA 1430 88 90 181) A Mantova la Piazza era affianshycata da un granaio pubblico la Domus del mercato (altrove definito Folllico o Fonrego del mercato) in cui avrebbero dovuto prolungarsi le contrattazioni oltre lorario e i giorshyni deputati (venerdigrave o sabato) rendendo disponibile ciograve che restava invenduto e che non poteva essere ritirato per legge dal mercato Nel 1430 eminenti cittadini sollecitati dal principe lamentavano perograve lincapacitagrave del magazzino - inoperoso in tutto o in parte per il pericolo di crolli -- di rispondere ai bisogni del popolo in una situazione in cUi da parte dei possessori si protestava la difficoltagrave di non poter esitare e smerciare fuori delshyla cittagrave le eccedenze conservate nei solari privati
Item videtur quod valde utille foret civibus Mantue habentibus possessiones et quishybuscumque alijs personis de civitate Mantue aut districtu colligantibus bIada et vina in magna copia ut omni tempore ipsa bIada et vinum possent extrahere de civitate et dishystrictu Mantue et conducere ad Iaea ad que et in quibus ma vendere poterunt cum otdishynibus et dacijs competentibus ipsa tamen civitate semper remanente fulta pro usu dicte civitatis et populi eiusdem ne dieta biada marceschant super granarlis ut hactenus feceshyrunt cum maximo incomodo ipsorum civium (MANTOVA 1430 177-8)
nmedesimo fondaco abbinato al mercato operava a Verona a Ferrara a Vegravenezia a Udine a Chioggia in molte altre cittagrave (MANToVA 1430 100 FORNASIN 1999 7-9 CEshySTAR 1794)
Lintegrale e pedissequa applicazione del principio della piazza di mercato comporshytava - per i vincoli tecnici dell etagrave pre-industriale -la massima affermazione del prinshycipio della canova cioegrave del magazzino pubblico centrale Unico argine alla sua invashydenza era costituito da una distribuzione perequata ab imis del raccolto cioegrave la possibilitagrave - egrave questo il paradosso - di realizzare da parte dei produttori la massima aspirazione nelle societagrave tradizionali lautarchia domestica Piugrave avanzava invece la sperequazione nel reddito e nel patrimonio piugrave da parte dei consumatori privi di scorshyte si impetrava il principio del Magazzino pubblico nella ronna di un efficiente sisteshyma di ricovero conservazione distribuzione delle derrate a garanzia del funzionashymento della Piazza di mercato La disponibilitagrave di crescenti quote di raccolto tuttavia indirizzava i piugrave accomodati verso soluzioni piugrave ghiotte la vendita allingrosso sul mercato cittadino ai fornai o allimpresa pubblica creata a sussidio di questi (o in loro vece) Oppure allopposto lesito delle eccedenze extra muros sui grandi mercatishyemporio regionali per il tramite di mercanti o agenti diretti
Il principio del magazzino pubblico centrale cioegrave laccumulazione di riserve per lo smercio continuo o anticiclico egrave quindi alla sua origine in opposizione solo apparen-
La costirU1ione di scorre granarie pubbliche e la politica economica degli srati
ruoli fiscali non fosserograve in grado di accantonare scorte Nel 1444 a Strasburgo quattro cittadini su dieci non possedevano alcuna riserva cerealicola (DRlMBIER 1984 112)
Nelle cittagrave italiane delletagrave moderna si puograve stimare che non meno di due terzi della popolazione fosse costretta ad acquistare o consumare pane confezionato con grani e farine comperati nelle piazze nelle vie e nelle botteghe cittadine oppure ottenuti come compenso del proprio servizio nelle casate (CORRrroRE 2000 126-36 MA11oZZI 1983 27~-82) Evidentemente questa fascia di lavoratori salariati non possedeva -shyper definizione - neacute scorte neacute depositi personali e nel primo caso era strettamente dipendente dal mercatograve urbano acquistando la sua sussistenza con frequenza non piugrave che settimanale (essendo costretti a comprare il pane tutti i giorni allafinestra si dishyceva a Genova [GRENDI1986 1031])
Ma anche fra i citiOdini con possesso extra moenia la distribuzione delle scorte era tuttaltro che egalitaria A Prato nel 1339
A parte gli enti religiosi sette famiglie [ ] avevano ii disposizione piugrave di mille staia di granaglie (circa 18 tonnellate) fino a un massimo di 3500 Altri venti nuciei familiashyri avevano scorte comprese tra le 500 e le 1000 staia (PINTO 1978 129n)
A Mantova nei magazzini ducali nellultima parte del 500 erano ammassati non meno di un ottavo talora piugrave di un quarto delle riserve cittadine di grani panificabili (CoRRITORE 200081-6) A Pavia nel corso dello stesso secolo e allinizio di quello successivo nei solagraveri di una sessantina di famiglie si concentrava non meno del 40 per cento dellintera offerta cittadinIgrave di frumento(ZANBUgrave11964 70-7) Anche in questo caso egrave utile sapere che nelle cittagrave tedesche esistevano mercanti (ad Augusta RatisboshyDa Norimberga) in grado di axnPmssare riserve da 6 a 45 tonnellate e che a Francoshyforte nel 1488 due patrizi totali~zavano insieme un terzo delle scorte cerealicole dei particolari nella cittagrave alta (DnuMmER 1984113)
Ritenere tali soggetti sprovv~uti al punto di incanevare grani con il solo scopo di esorc~ i pericoli della Fstia egrave perlomeno riduttivo A grandi solari comshyspondevano vaste familiae e pIftore di servi tori e ospiti ma tali scorte eccedevano largamente la sussistenza del maggiore palazzo nobiliare o patrizio senza peraltro costituire un fondo di accantonafoento eccedente il fabbisogno della cittagrave a meno che non vi fosse la concreta possibilitagrave di commercializzare il surplus sui mercati esteri Come nota infatti Adam Smith
a meno che leccedenza non possa essere esportata in tutte le circostanze ordinarie i coltivatori staranno molto attenti a non produrre e gli importatori a non importare mai una quantitagrave maggiore di quell~ che egrave strettamente richiesta dal consumo del mercato interno Questo mercato saragrave difficilmente sovrafomito ma saragrave in generale sottoriforshyDito dato che coloro che svolgqno lattivitagrave per rifomirlo avranno in generale il timore che la loro merce possa rimanete invenduta (SMlTH [1776] 528)
Lipotesi egrave suffragata dai cas~ storici conosciuti A Bologna macrodistretto serico dellevo moderno laddove gli ipteressi manifatturieri e mercantili avrebbero dovuto consigliare una sussistenza a b~on mercato per tenere basso il costo del lavoro le istituzioni annonarie operavano per garantire con il calmiero deljorme1lto la monetizshyzazione della rendita granaria dei possidenti - strutturalmente incapace di coprire il fabbisogno della cittagrave anchea rischio della carezza dei viveri contingentando il mercato dei grani forestieri (GtJFNZl1982A 37-76) Di fatto
495 494 Renzo P Corrllnre
In ogni caso si tendeva a limitare al minimo indispensabile lemiddot importazioni di frushymento per evitare che stocks invenduti potessero turbare la collocazione dei grani tershyrieri nel nuovo anno agrario (GuENZI 1981 153)
In tutti i centri comunque la tendenza a ritardare la vendita del surplus nei mesi della saldatura lutilizzo di depositi specializzati con personale addetto alla custodia al conshydizionamento e alla commercializzazione del prodotto ponevano i grandi proprietari di biade su un gradino superiore e diverso rispetto al resto della cittagrave Laccantonamento di grani per questa cupola di possessori rispondeva al principio dellutilitagrave soggettiva atshytesa e richiedeva sia capitale fisso sia capitale circolante per raggiungere gli scopipreshyfissati un profitto speculativo la valorizzazione della rendita
In molte cittagrave i possessori non avrebbero dovuto trattenere in casa piugrave grano e farina di quantoprescritto dalla legge cioegrave il consumo mensile per bocca - fissato anchesshyso statutariamente - per arrivare al nuovo raccolto Ma i cittadini credeVano veramenshyte ai loro comandamenti Egrave lecito dubitare La norma era scolpita negli Statuti e pubshyblicamente violata con la complicitagrave dll1e autoritagrave e dei groppi professionali interessati alla distribuzione del grano nelle sue ~arie forme
Nelle annate ordinarie la quota di grano auto consumato - cioegrave non acquistata sul mercato - nelle cittagrave italiane dell evo moderno rappresentava fra il 30 e il 60 per censhyto del fabbisogno urbano di frumento
Nella capitale dei Gonzaga nel 1615 si valutava che su 27000 bocche
il terzo [di] gentilhuomini fittadri servitori et altri [ ] non comprano biada et gli duoi tenigrave tra poveri artisti mercanti fomari fondachieri hebrei et altri [bull] non possono in tutto levar sufficientemente la somma de detti dua terzi sl che saranno boshychegrave 18000 che compraranno biada (COIUUTORl 2000 126)
AVenezia a cavaliere fra XVI e XVII secolo alla mensa delle casade si dispensava circa un terzo del frumento consumato ordinariamente in cittagrave (AMARD 1966 74 MATTOZZI 1983 281) ABologna per tutto il Seicento i fornai che impastavano farine in conto lavorazione per i particolari pareggiavano piugrave o meno il numero di quelli da scqffa che smerciavano pane venale (GUENZI 1982A
27) Peraltro la proporzione a Rialto tra chi lavorava per le casade e chi vendeva pane al pubblico - 65 Jo~ri a fronte di 44-48 pistori negli anni 1583-1685 (DELLA VALBNTINA 1992 143-4 167 192-3) - fa ritenere la struttura del mercato del pane felsinea non molto dissimile da quella veneziana Nelle cittagrave liguri o toscane sei-settecentesche la porzione autocon sumata quando il raccolto era buono era anche piugrave elevata (GRENDI 1986 1024-6 1034 PuLT QUAOUA 1984 98-104 PULT QUAGUA 1990 171-2) A Napoli nel 1758 a Monasteri Luoghi pii e Particolari eta riservato il 28 per cento del consumo cittadishyno di frumento (AuFANO 1996 37n)
Lelevato numero di servi domestici persone al servizio delle casate faceva sigrave che in alcuni palazzi si concentrassero masse cospicue di grano per la spesa familiare Ma accanto ad esse gli operatori dell annona -- la stessa povertagrave -- si auguravano che vi fosse sempre anche la materia per rifornireil mercato e i forni cittadinimiddot nella fase piugrave delicata del ciclo annuale il periodo di saldatura dei raccolti Come spiegare altrimenshyti la norma che imponeva ai grossi detentori di biade (non esclusi enti e opere pie) in varie cittagrave italiane dellevo moderno la vendita straordinaria in primavera dellegrave ecshycedenze ammassate in granaio (per Pisa e la Toscana v PuLT QUAGUA 1984 88-9)
A Mantova nel 1554 si stabiliva che i patroni che avessero fruito in cittagrave di piugrave di 20 sacchi di grano come porzione dominicale avrebbero dovuto coilservare in granaio
lA costituzioni digrave scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
il 4 per cento per le necessitagrave dei consumatori dei fornai e dei Jontachieri quando fosse mancato il prodotto sulla piazza o nelle offerte deisensali Nel 1603 ci si preocshycupograve di elevare la quota al 6 per cento (CORRlTQRE 2000 237n) Beninteso le vendite sarebbero avvenute ai valori di mercato Lo stesso sistema vigeva a Cremona (6 per cento nel 1608 e nel 1612) (MERON 1957 59n 63 JACOPETl1 1965 128) ea Verona Qui una delibera consiliare del 1549 autorizzava per la prima volta
[il deputati [alle Biadel [a] tassar e comandar con quelle pene che al Clarissimo Podestagrave pareragrave quella quantitagrave di biade a ciascuno secolare o eclesiastico sia di qual grado o condittione esser si voglia che havesse biade in questa cittagrave oltre il viver suo
(VOCCHIATO 1979 145)
La tassa sarebbe stata stabilita - da11558 - per sorteggio fra le casate che avessero introdotto in cittagrave dai propri possedimenti piugrave di 70 minali per rifo1llire il Mercato delle biave Essa-venne anche incrementata nella stessa occasione dal 5 al6 per censhyto per restare in vigore fino al 1631 (VECCHIATO 1979 141-58)
Quest9 tiIfo di normativa nasce e si affiogravea in ambito amministrativo perciograve echeggia la realtagrave molto meglio della veneranda legge generale
Da tali disposizioni si deducono alcuni fatti incontrovertibili 1entro la cerchia cittadina esistevano scorte private eccedenti la spesa delle famiglie
in violazione in molti casi della legge statutaria 2il possesso della terra che solo assicurava lautarchia delle casate era il piugrave-potente
fattore di discriminazione fra i cives tanto da precipitare nel girone dei pauperes la moltitudine che acquistava correntemente la sussistenza nellarea urbana
3fra gli stessi possidenti cittadini esisteva uneacutelite che non solo conservava scorte oltre il viver suo ma che si proponeva egoisticamente di speculare ritardando limshymissione dei grani sulle piazze cittadine o che a~endeva il momento piugrave opportuno per smerciarli allesterno nelle grandi piazze frumentarie come livorno Desenzashyno Legnago Romano (di Lombardia) ecc
4lineguaglianza fra i cives tese ad aggravarsi con la metagrave del 500 poicheacute questi reshygolamenti innovano quasi sempre disposizioni generali risalenti al tardo Medioevo che sancivano lobbligo di convogliare il surplus sulla piazza cittadina segno di una distribuzione del reddito originariamente meno sbilanciata A Cremona gli Statuti del 1388 obbligavano - cosl egrave ancora nel 1510 - a vendere il
sovrappiugrave in Piazza Maggiore sul mercato pubblico dei grani (MERON 1957 59n
63)A Pisa il rescritto che imponeva di effettuare le vendite al minuto in platea bladi
risale al 1401 MALANlMA 1976 293) lobbligo era ribadito ancora nel 1548 ma nella seconda metagrave del secolo XVI si affermava la pratica di vendere fuori mercato tanto che nel 1581 il Magistrato dei Nove dovette intervenire per far vendere i grani delle comunitagrave degli enti e dei luoghimiddotpii soltanto da marzo-aprile in piccole quantitagrave sul mercato (PULT QUAGUA 1984 81-91) La disposizione per altro si applicava allinteshyro Stato (PULT QUAGUA 1984 88)
Tuttavia non egrave da pensare che il principio della concentrazione delle compravendite sulla piazza di mercato cittadina fosse universale universalmente rispettato e sopratshytutto perenne La centralizzazione del grano non significa automaticamente lobbligo di vendita diretta sulla Piazza deiformenti Affermare come Steven L Kaplan che
There was no single more important regulation concerning tbe provisioning trade tban tbe requirement tbat alI transactions occur in tbe marketplace (KAPLAN 1984 27)
494 495 Renzo P Corritore
In ogni caso si tendeva a limitare al minimo indispensabile le importazioni di frushymento per evitare che stocks invendutigrave potessero turbare )a collocaziolle dei grani tershyrieri ileI nuovo anno agrario (GUENZI 1981 153)
In tutti i centri comunque la tendenza a ritardare la vendita del surplus nei mesi della saldatura lutilizzo di depositi specializzati con personale addetto alla custodia al conshydizionamento e alla commercializzazione del prodotto ponevano i grandi proprietari di biade su un gradino superiore e diverso rispetto al resto della cittagrave Laccantonamento di grani per questa cupola di possessori rispondeva al principio dellutilitagrave soggettiva atshytesa e richiedeva sia capitale fisso sia capitale circolante per raggiungere gli scopipreshyfissati un profitto speculativo la valorizzazione della rendita
In molte cittagrave i possessori non avrebbero dovuto trattenere in casa piagrave grano e farina di quantoprescritto dalla legge cioegrave il consumo mensile per bocca ~- fissato anchesshy
so statutariamente --per arrivare al nuovo raccolto Ma i cittadini credevano veramenshyte ai loro comandamenti Egrave lecito dubitare La norma era scogravelpitagrave negli Statuti e pubshyblicamente violatamiddot con la complicitagrave dccedillle autoritagrave e dei gruppi professionali interessati alla distribuzione del grano nelle sue varie forme
Nelle annate ordinarie la quota di grano autoconsumato - cioegrave non acquistata sul mercato - nelle cittagrave italiane dell evo moderno rappresentava fra il 30 e i160 per censhyto del fabbisogno urbano di frumento
Nella capitale dei Gonzaga nel 1615 si valutava che su 27000 bocche
il terzo [di] gentilhuomini ligravettadri servitori et altri [ ] non comprano biada et gli duoi terzi tra poveri artisti mercanti fomari fondachieri hebrei et altri [ l non possono in tutto levar sufficientemente la $omma de detti dua terzi sl che saranno boshyche 18000 che compraranno biada (CoRRlTORB 2000 126)
AVenezia a cavaliere fra XVI e xvn secoioalla mensa delle casade si dispensava circa un terzo del frumento consumato ordinariamente in cittagrave (AYMARD 1966 74 MArroZZI 1983 281) A Bologna per tutto il Seicento i fornai che impastavano farine in conto lavorazione per i particolari pareggiavano piil o meno il numero di quelli da scaifa che smerciavano pane venale (GUBNZI 1982 27) Peraltro la proporzione a Rialto tra chi lavorava per le casade e chi vendeva pane al pubblico - 65 fOf7lri a fronte di 44-48 pistori negli anni 1583-1685 (DELLA VAUNTINA 1992 143-4167 192-3) - fa ritenere la struttura del mercato del pane felsinea non molto dissimile da quella veneziana Nelle cittagrave liguri o toscane sei-settecentesche la porzione autoconshysumata quando il raccolto era buono era anche piil elevata (ORENOI 1986 1024-6 1034 PuLT QUAGLIA 1984 98-104 PULT QUAOLIA 1990 171-2) A Napoli nel 1758 a Monasteri Luoghi pii e Particolari eta riservato il 28 per cento del consumo cittadishyno di frumento (AuFANO 1996 370)
Lelevato numero di servi domestici persone al servizio delle casate faceva si che in alcuni palazzi si concentrassero masse cospicue di grano per la spesa familiare Ma accanto ad esse gli operatori dellannona -lastessapovertagrave __ si auguravano che vi fosse sempre anche la materia per rifornire il mercato e i forni cittadini nella fase piil delicata del ciclo annuale il periodo di saldatura dei raccolti Come spiegare altrimenshyti la norma che imponeva ai grossi detentori digrave biade (non esclusi enti e opere piegrave) in varie cittagrave italiane dellevo moderno la vendita straordinaria in primavera delle ecshyredenze ammassate in granaio (per Pisa e la Toscana v PuLT QUAGLIA 1984 88-9)
A Mantova nel 1554 si stabiliva che i patroni che avessero fruito in cittagrave di piugrave di 20 sacchi di grano come porzione dominicale avrebbero dovuto conservare in granaio
lA costituzione di SC0114 granarie pubbliche e la politica economica degli stati
il 4 per cento per le necessitagrave dei consumatori dei fornai e dei fontachieri quando fosse mancato il prodotto sulla piazza o nelle offerte deimiddotsensati Nel 1603 ci si preocshycupograve di elevare la quota al 6 per cento (CoRRlTORE 2000 237n) Beninteso le vendite sarebbero avvenute ai valori di mercato 10 stessa sistema vigeva a Cremona (6 per cento nel 1608 e nel 1612) (MERON 1957 -59n 63 JACOPETl11965 128) ea Verona Qui una delibera consiliare del 1549 autoruzava per la prima volta
[i] deputati [alle Biade) [al tassar e comandar con quelle pene che al Clarissimo Podestagrave pareragrave quella quantitagrave di biade a ciascuno secolare o eclesiastico sia di qual grado o condittione esser si voglia che havesse biade in questa cittagrave oltre il viver suo (VBCClI1ATO 1979 145)
La tassa sarebbe stata stabilita - dal 1558 - per sorteggio fra le casate che avessero introdotto in cittagrave dai propri possedimenti piagrave di 70 minali per rifornire il Mercato delle biave Essaveane anche incrementata nella stessa occasione dal 5 al6 per censhyto per restare in vigore fino al 1631 (VECCHIATO 1979 141-58)
Questccedil tijlo di normativa nasce e si affuia in ambito amministrativo perciograve echeggia la realtagrave molto meglio della veneranda legge generale
Da tali disposizioni si deducono alcuni fatti incontrovertibili 1entro la cerchia cittadina esistevano scorte private eccedenti la spesa delle famiglie
in violazione in molti casi della legge statutaria 2il possesso della terra che solo assicurava lautarchia delle casate era il piugravemiddotpotente
fattore di discriminazione fra i cives tanto da precipitare nel girone dei pauperes la moltitudine che acquistava correntemente la sussistenza nellarea urbana
3fra gli stessi possidenti cittadini esisteva uneacutelite che non solo conservava scorte oltre il viver suo ma che si proponeva egoisticamente di speculare ritardando limshymissione dei grani sulle piazze cittadine o che a~endeva il momento piagrave opportuno per smerciarli allesterno nelle grandi piazze frumentarie come Uvorno Desenzashyno Legnago Romano di Lombardia) ecc
4lineguaglianza fra i cives tese ad aggravarsi con la metagrave del 500 poicheacute questi reshygolamenti innovano quasi sempre disposizioni generali risalenti al tardo Medioevo che sancivano lobbligo di convogliare il surplus sulla piazza cittadina segno di una distribuzione del reddito originariamente meno sbilanciata shyACremona gli Statuti del 1388 obbligavano - cosl egrave ancora nel 1510 - a vendere il
sovrappigraveagrave in Piazza Maggiore sul mercato pubblico dei grani (MERON 1957 59n 63)
A Pisa il rescritto che imponeva di effettuare le vendite al minuto in platea bladi risale al 1401 (MALANIMA 1976 293) lobbligo era ribadito ancora nel 1548 ma nella seconda metagrave del secolo XVI si affermava la pratica di vendere fuori mercato tanto che nel 1581 il Magistrato dei Nove dovette intervenire per far vendere i grani delle comunitagrave degli enti e dei luoghi pii soltanto da marzo-aprile in piccole quantitagrave sul mercato (PULT QUAGLIA 1984 8191) La disposizione per altro si applicava allinteshyro Stato (PULT QUAGLIA 1984 88)
Tuttavia non egrave da pensare che il principio della concentrazione delle compravendite sulla piazza di mercato cittadina fosse universale universalmente rispettato e sopratshytutto perenne La centralizzazione del grano non significa automaticamente lobbligo di vendita diretta sulla Piazza deiformenti Affermare come Steven L Kaplan che
There was no single more important regulation conceming the provisioning trade han the requirement that ali transactions occur in the marketplace (KAPuN 1984 27)
493 496 Renw P Corritore
appare altrettanto astratto dogmatico O virtuale del principio di mercato (Market Principle) che il medesimo gli contrappone Henri Pirenne parlando della politica annonaria dei comuni medievali avverte Lapplicazione del principio della vendita diretta ebbe numerosi eccezioni (PIRENNE [1933] 193n)
Nel caso di Mantova la scelta della Piazza egrave facoltativa per i terrieri con eccedenze GliStatuti signorili che si rifanno largamente alle raccolte statutarie comunali non sancivano alcun obbligo in proposito (v SYJI1l BONACOLSlANI [1313] libro ID rubr 55 De mercato blave 253 STATUTI GoNZAOHESCHI [1404] libro m rubr 93 De mercato blave fiendo in civitate Mantue f 73v) Decreti di carattere straordinario e regolamenshytazioni transitorie correggevano il tiro Nel 1405 in piena saldatura dei raccolti si coshystrinse a rifornire forzosamen~e la piazza concentrandovi tutte le contrattazioni Nel 1417 si obbligograve a riservare al mercato un terzo del frumento introdotto in cittagrave (CoRRIshyTORE 2000 235-6) Ma sono atti straordinari che non sopravvissero nel migliore dei casi piugrave di qualchelustro (MANToVA 1430 88 90 181) A Mantova la Piazza era affianshycata da un granaio pubblico la Domus del mercato (altrove definito Fornico o Fontego del mercato) in cui avrebbero dovuto prolungarsi le contrattazioni oltre lorario e i giorshyni deputati (venerdl o sabato) rendendo disponibile ciograve che restava invenduto e che non poteva essere ritirato per legge dal mercato Nel 1430 eminenti cittadini sollecitati dal principe lamentavano pero lincapacitagrave del magazzino - inoperoso in tutto o in ~per il pericolo di crolli - di rispondere ai bisogni del popolo in una situazione in cui da parte dei possessori si protestava la difficoltagrave di non poter esitare e smerciare fuori delshyla cittagrave le eccedenze conservate nei solari privati
ltem videtur quod valde utille foret civibus Mantue habentibus possessiones et quishybuscumque alijs personis de civitate Mantue aut districtu colligantibus bIada et vina in magna copia ut amni tempore ipsa bIada et vinum possent exttahere de civitate et dishystrictu Mantue et conducere ad Iaea ad que et in quibus illa vendere poterunt cum otdigraveshynibus et dacijs competentibus ipsa tamen civitate semper remanente fulta pro usu diete civitatis et populi eiusdem ne dicta bIada mateeschant super granariis ut hactenus fecemiddot runt cum maximo incomodo ipsorum civium (MANToVA 1430 177-8)
Il medesimo fondaco abbinato al mercato operava a Verona a Ferrara a Venezia a Udine a Chioggia in molte altre cittagrave (MANToVA 1430 100 FORNASIN 1999 7-9 CBshySTARl1794)
Lintegrale e pedissequa applicazione del principio della piazza di mercato comporshytava - per i vincoli tecnici dell etagrave pre-industriale -la massima affermazione del prinshycipio della canova cioegrave del magazzino pubblico centrale Unico argine alla sua invashydenza era costituito da una distribuzione perequata ab imis del raccolto cioegrave la possibilitagrave egrave questo il paradosso di realizzare da parte dei produttori la massima aspirazione nelle societagrave tradizionali lautarchia domestica Piugrave avanzava invecela sperequazione nel reddito e nel patrimonio piugrave da parte dei consumatori privi di scorshyte si impetrava il principio del Magazzino pubblico nella forma di un efficiente sisteshyma di ricovero conservazione distribuzione delle derrate a garanzia del funzionashymento della Piazza di mercato La disponibilitagrave di crescenti quote di raccolto tuttavia indirizzava i piugrave accomodati verso soluzioni piugrave ghiotte la vendita allingrosso sul mercato cittadino ai fornai o allimpresa pubblica creata a sussidio di questi (o in loro vece) Oppure allopposto lesito delle eccedenze extra muros sui grandi mercatishyemporio regionali per il tramite di mercanti o agenti diretti
Il principio del magazzino pubblico centrale cioegrave laccumulazione di riserve per lo smercio continuo o anticiclico egrave quindi alla sua origine in opposizione solo apparen-
La costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
ruoli fiscali non fossero in grado di accantonare scorte Nel 1444 a Strasburgo quattro cittadini su dieci non possedevano alcuna riserva cerealicola (DIIUMBIER 1984 112)
Nelle cittagrave italiane delletagrave moderna si puograve stimare che non meno di due terzi della popolazione fosse costretta ad acquistare o consumare pane confezionato con grani e farine comperati nelle piazze nelle vie e nelle botteghe cittadine oppure ottenuti come compenso del proprio servizio nelle casate (CoRRITORE 2000 126-36 MAnoZZI 1983 27~-82) Evidentemente questa fascia di lavoratori salariati non possedevashyper definizione -- neacute scorte neacute depositi personali e nel primo caso era strettamente dipendente dal mercato urbano acquistando la sua sussistenza con frequenza non piugrave che settimaIIgraveale (essendo costretti a comprare il pane tutti i giorni alla finestra si dishyceva a Genova (GRENDI 1986 1031])
Ma anche fra i citUutini con possesso extra moenia la distribuzione delle scorte era tuttaltro che egalitaria A Prato nel 1339
A patte gli enti religiosi sette famiglie [ bull ] avevano Il disposizione piugrave di mille staia di granaglie (circa 18 tonnellate) fino a un massimo di 3500 Altri venti nuclei familiashyri avevano scorte comprese tra le SOOe le 1000 staia (PINTO 1978 129n)
A Mantova nei magazzini ducali nellultima parte del 500 erano ammassati non meno di un ottavo talora piugrave di un quarto delle riserve cittadine di grani panificabili (CORRlTORE 2000 81c6) A Pavia nel corsq dello stesso secolo e allinizio di quello successivo nei sozagraveri di una sessantina di famiglie si concentrava non meno del 40 per cento dell intera offerta cittadin8 di frumentomiddot (ZANJin 1964 70-7) Anche in questo caso egrave utile sapere che nelle cittagrave tedesche esistevano mercanti (ad Augusta Ratisboshyna Norimberga) in grado di ~sare riserve da 6 a 45 tonnellate e che a Francoshyforte nel 1488 due patrizi totalizzavano insieme un terzo delle scorte cerealicole dei particolari nella cittagrave alta (DlRLMB1ER 1984113)
Ritenere tali soggetti sprovv~duti al punto di incanevare grani con il solo scopo di esorcizzare i pericoli della clarestia egrave perlomeno riduttivo A grandi solari corrishyspondevano vaste familiae e plftore di servitori e ospiti ma tali scorte eccedevano largamente la sussistenza del D-aggiore palazzo nobiliare o patrizio senza peraltro costituire un fondo di accantofilljnento eccedente il fabbisogno della cittagrave a meno che non vi fosse la concreta possibfjitagrave di commercializzare il surplus sui mercati esteri Come nota infatti Adam Smith
a meno che leccedenza non possa essere esportata in tutte le circostanze ordinarie i coltivatori staranno molto attenti a non produrre e gli importatori a non importare mai una quantitagrave maggiore di quell~ che egrave strettamente richiesta dal consumo del mercato interno Questo mercato saragrave difficilmente sovrafornito ma saragrave in generale sottomorshynito dato che coloro che svolgono lattivitagrave per mornirlo avranno in generale il timore che la loro merce possa rimane~ invenduta (SMITH[l776] 528)
Lipotesi egrave suffragata dai cas storici conosciuti A Bologna macrodistretto serico dellevo modemoladdove gli interessi manifatturieri e mercantili avrebbero dovuto consigliare una sussistenza a b~on mercato per tenere basso il costo del lavoro le istituzioni annonarie operavano per-garantire con il calmiero delformento la monetizshyzazione della rendita granaria dei possidenti - strutturalmente incapace di coprire il fabbisogno della cittagrave - anche ~ rischio della carezza dei viveri contingentando il mercato dei grani forestieri (GupaI 1982 37-76) Di fatto
492 Renzo P COITitore
Tale disparitagrave sociale si riverberava sulla struttura del commercio cerealicolo La funzione dei piccoli commercianti di biade (granaiolibull biadaiolifarinaioli balshy
zarotti cavallanti vatlcali ecc) era infatti ancillare alla capacitagrave di affacciarsi sul nercato della fascia marginale deipossidenti con eccedenze Solo che nelle annate di abbondanza si venficavano ingorghi nell offerta di grano che deprimevano i prezzi e incentivavano i piccoli produttori a smerciare direttamente le eccedenze allindomani del raccolto nellarea urbana anche al di fuori dei luoghi deputati (MATI02ZI 1983 278281-2 300n PULr QUAGLIA 1984 86) Mentre nelle annate di penuria si contraeshyva drasticamente proprio questo segmento dellofferta (ABa [1966Jmiddot 22-4 KULA [1962J 73-4 CATrINI1984 111-23 PuIr QUAGUA 1984 88) scatenando nelle campashygne una caccia al grano-merce la cui quota piugrave consistente era detenuta dai grandi proprietari dai maggiori affittuari dai percettori di canoni diritti o rendite in grano e la cui quota residua era piugrave facilmente preda di chi occupava posizioni chiave nellasshysetto terriero nella catena dei diritti nel credito alla produzione e al consumo
Tanto la distribuZione era frammentata nelle annate di abbondanza tanto in epoc~ di penuria il commercio del grano diventava un affare di pochi In questo caso lazioshyne dei mercanti diVentava dimpiccio sul mercato interno dove la coperta si restringeshyva per i proprietari e gli imprenditori agricoli (KULA [1962] 56-61 CATl1NI 1984 114-8) - dove la necessitagrave di ricorrere al credito da parte dei piccoli possessori poneva questi nelle mani degli agenti dei proprietari dei percettoridi canoni diritti o rendite - dove i piccoli proprietari vedevano minacciata la loro stessa condizione da parte di chi controllava localInente in maniera capillare e decentrata il mercato del denaro e dei beni necessari alla riproduzione (sementi strumenti cibo) La soluzione era quelshyla di precludere amministrativamente ai sensali e ai commercianti di grani i mercati locali su istigazione dei medi possessori le cui occasioni di normale profitto agrario soffrivano un ridimensionamento e che si vedevano costretti a impegnarsi ccedilon tutte le loro forze per integrare le proprie entrate accaparrandosi le magre eccedeiiZe disponishybili nelle campagne e nei borghi rurali (PuLT QUAGLIA 1984 84-8 PULT QUAGLIA 1990 lO7-14)
TI destino dei piccoli commercianti in grano era quindi quello di occupare una posishyzione margilJale nel mercato del grano (MBlNrurr 1977 30 PINTO 1978 13 MAITOZZl 1983 277) e di operare - non solo a causa degli ordinamenti annonari - secondo una logica di corto respiro in cui non era contemplata neacute la conservazione di grani a lungo termine neacute lutilizzo di depositi piugrave che provvisori Come per i piccoli possidenti non si puograve parlare ne1loro caso della formazione e del mantenimento di scorte consistenti (MBlNREr 1988 156~7) Non tali comunque da sostenere il reddito contadino nelle stagioni ordinarie e da esercitare sul versante cittadino unefficace azione anticonshygiunturale in caso di carestia
Peraltro in cittagrave la struttura dellofferta era anche piugrave sperequata di quella che si rishyscontra nel contado Che si tratti di Prato nel 1339 (PINTO 1978 129 PINTO 1982 160n e 17In) Pavia negli anni 1539 1555 1513 1602 1603 (ZANEm 1963) o Mantova nellultima parte del secolo XVI (CORRITORE 2000 81-9) la distribuzione delle scorte fra i privati era singolarmente ineguale Lo attesta la rilevanza nellarea urbana della povertagrave cioegrave secondo una definizione coeva di coloro che non vivono di entrate ma sono necessitati ricorrere mattina e sera alle pistorie a comprare il pane per iI vitto loro e delle sue famiglie col denaro che di giomo in giomo si vanno guadagnando (MATshyTOZZI 1983 281) PUOgrave essere utile richiamare la situazione delle cittagrave tedesche nel basso Medioevo in una fase che egrave stata definita da Wilhelm Abellepoca doro degli artigiani e del lavoro salariato si puograve stimare che almeno la metagrave degli iscritti ai
lA costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli statibull middot497
te con il principio della piazza TI mercato pubblico periodico disciplinatola spiagshygiala piazza la loggia o iI recinto riservato alle contrattazioni - coesis~va confabshybriche magazzini e botteghe La stessa piazza per funzionare al meglio secondo il principio dello scambio diretto necessitava di magaZzini di supporto bull
4 LE SCORTE DEI FORNAI CITTADINI
Nellarea urbanagrave e nelle relazioni tra cittagrave e campagna operavano perograve temibili conshycorrenti dei privati possessori I fornai cittadini possedevano le competenze le strutshyture tecniche le relazioni sociali e il credito per incettagravere il prodotto per essere inforshymati tempestivamentesul mercato del grano e potenzialmente per dispensarlo con profitto in qualunque momento Il fatto che il loro operato fosse imprigionato in unarshycaica impalcatura di norme divieti obblighi che risalivano alletagrave romana che ne fashycevano in modo quasi istituzionalizzato il capro espiatorio delle tensioni fra produtshytori di grano povertagrave e autotitagrave non impedisce di affermare che tali vessatorie disposiziograveD1 trovassero la loro principale ragione dessere nella parte che essi giocashyvano di interlocutorilantagonisti dei proprietari terrieri nelladeterminazione del prezshyzo del grano sul mercato locale e nella realizzazione della rendita terriera (GUENZI 19824
35 GUENZI 1982 297) Neacutel caso di Mantova terra comucopia a partire dal 1492 si consend a zentilhomini
cittadini et qualuncho altro di comprare biade nel Dominio per approvvigionare la cittagrave di fatto si sand un diritto allincetta che mise fuori gioco i fornai a cui venne imposto di rifornirsi nei solarimiddotdei cittadini senza avere piugrave la possibilitagrave di effettuare acquisti nel contado e di ritenere a casa scorte superiori amiddotl 00 staia di frumento Lintento della disposhysizione egrave chiarissimo espresso senza reticenze dai Maestri delle Entrate che riportarono al marchese la soddisfazione dei possidenti mantovani per la riforma statutaria
tutta la Terra [cioegrave il Mantovano] ne [egravel rimasta satisfactissirna pensando che Vostra Excellenilii pretenda ali comodi et utilitagrave universagrave1e senza dampno et preuiditio suo Vero egraveche li fumari non si contentano parendoli comegrave il vero che non si poteranno ingrassar a suo modo come haqno factO per il passato et poteria achader [bulll Che venetanno adolershyse et supplicar aVosUa Signoria Perograve me egrave parso d~ene aviso per ques~ nostra et farli inteni1er Che questaterril ha solii due membri de li quali li cittadini soi se ne possono aiutashyre e valersene uno egrave il grano laltro egrave larte de la lana et quando se concedesse che li furshynari potessero comprare come hapno facto li tempi passati sana un fare benefitio acinquanshytaocto dessi et dampnificharelreslO de la republicasua quale de questo bon ordine ne receve emolumento grandissimo et se gaude in la Citagrave [percheacute] li fumari portano fuora el denaro et pretendono solo a suo benefitio (AG b 2441 lettera del 13 luglio 1492)
Egrave indubbio che il plauso della Terra fosse da attribuire piugrave alla possibilitagrave per i proshyprietari di accrescere le proprie entrate che a quella dei consumagravetori cittadini e dell arte della lana di trarre beneficio daJla disposizione Egrave significativo che la motivazione pro civitate nori accenni allesistenza di monopoli da parte dei fornai o di artificiose lievitashyzioni dei prezzi per causa lOro nloro attivismograve non egraveonfliggeva per quanto riguarda i prezzi finali della sussistenza con linteresse dei produttori cittadini E daltra parte largomentodello stomo dal metFato cittadino dei profitti incamerati dai fornai -laccushysa consueta a proposito deipistores egrave che fossero in gran parte stranieri (GUBNZl 19824
22) -- era unagiustificazione debole che appassionava piugrave chi concorreva direttamente
491 498 Renzo P Comtore
alla spartizione dei proventi derivanti dalla vendita e dal commercio del grano shylemolumento grandissimo - di chi doveva poi fruire della redistribnzione di tale ricchezza Tale norma avvantaggiava i possidenti cittadini e i gentiluomini ptivilegiashyti in grado di ottenere le tratte di esportazione Sul piano dellappropriazione essi erano in condizione di mettere fuori gioco gli altri possessori che producev~o eccedenze nel Dominio poicheacute si accresceva Igravea loro forza contrattuale e la loro capacitagrave di occUpare i canall commerciali piugrave redditizi Sul piano della commercialiZzazione gli stessi fruivashyno dello smantellamento della rete dintennediazione rappresentata dai fornai Per i rushystici significava perdere un collegamento essenZiale con la cittagrave ed essere emarginati dal mercato urbano nelle campagne o sul broletto di Mantova essi non trovarono piugrave i trashydizionali interlocutori (CORBlJ9RE 2000 228 231-2)
Nel caso di Bologna terra strutturalmente deficitaria e cittagrave dalla vocaiione manishyfatturie~ si costringeva i fornai ad acquistare formenti terrieri presso i solari privati in cittagrave proibendogligrave lincetta nel contado autorizzandoli ad acquistareformentiforeshystieri al di fuori delle mura cittadine presso i sensati da grqno solo a patto che fosseshyro stati smaltiti i grani cittadini a un prezzo talora superiore a quello dei grani dimshyportazione (GUlNZI1982A35 52-3)
Nella Toscana dei Medici il diritto allincetta nel contado venne concesso ai fornai in periodo di bassa congiuntura (in particolare dagli anni Trenta del Seicegravento)Per sostenere i prezzi interni in tal caso essi restavano gli interlocutori principali dei granshydi proprietari semplicemente spostando la loro principale fonte di approvvigionashymento dai solari dei particolari in cittagrave ai granai decentrati delle grandi aziende agrishycole oppure ai mercati rurali su cui affluiva la produzione cerealicola delle grandi fattorie (PuLT QUAOUA 1984 86-9 PuLTQUAOUA 1990 100 106-7)
Laddove non vi egrave come invece succede a Genova una diretta ingerenza del potere pubblico nella vita della corporazione (MAsSA 1999) i fumai di cittagrave - nonostante i lacci e lacciuoli normativi e il lavoro prevalentePlente manuale svolto neiloro laboshyratori - erano dei veri imprenditori dipendenti per il loro profitto - noininalmente stabilito per legge - dalla produttivitagrave del lavoro e dalla dotazione tecnica e finanziaria delle imprese Di ciograve fa fede la grande sperequazione esistente fra le aziende speciashylizzate nena fabbricazione del pane venale in cittagrave (AYMARD 1966 75 VECCHltltJQ 1979 82-3 GUlNZI1982 77 segg PuLT QUAOUA 1984 100 102-3) NellItalia delshyletagrave moderna questi artigiani-imprenditori della filiera del grano trattavano insieme
afarinaifarinaiolifarinottifondachierifontechierifidelariformentinari lasagneshyri maccaronari torallari vermicellari ecc fra il 40 e il 70 per cento del frumento consumato in Cittagrave nelle annate normali (CoRRJTORE 2000 126 segg) e ~ino al 100 per cento nelle annate di carestia (Puu QUAOUA 1984 98-9)
In una ricognizione delle asimmetrie informative del mercato non cegrave gruppo quale i fornai che possa integraverpretare la parte dell agente economico onnisciente Se dunque i regolamenti annonari tendevano a regolare minuziogravesamente la collocazione il volushyme e la durata delle loro scorte cosi come disponevano per gli altri artigiani della fishyliera era per neutralizzare il carattere potenzialmente eversivo di tale accantonamenshyto per i proprietari-venditori Prima ancora che per i consumatori-acquirenti n livello delle scorte rinforzava o attenuava il rischio di monopsonio da parte dei pistores piugrave potenti e facoltosi cosigrave come eventuali tentazioni da parte della categoria di esercitare un dominio egoistico sul mercato del pane (MAITOZZl1983 298)
Sarebbe quindi un errore concepire le scorte dei fornai come entropica allocazione di capitale che sconta lincertezza futura esse venivano gestite secondo criteri di rashyzionalitagrave economica e secondo la migliore efficienza tecnica nonostante i vincoli imposti alla lievitazione degli stock dalle disposizioni annonarie
lA costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
vimini paglia o canne intrecciate (come ceste stuoiecannizzi) in terracotta (addirittura anfore) piuttosto che di tessuto (i sacchi costavano troppo) (PICCINNl1976 397 MAzzA RAvEGol 1983 174-5 Zoo Toce 1990 893-4 COIiITONES11991 35n-36n)
Nella casa del piccolo produttore o del titolare di un piccolo possesso il penw (la scorta domestica) difficilmente eccedeva il consumo famigliare chi fortunato raccoshyglieva piugrave dell annona famigliare e di quanto gli serviva per il campo era spinto a venderselo nei mesi immediatamente successivi alla mietitura e alla trebbiatura per necessitagrave di denaro ma anche per la difficoltagrave di stoccare e conservare il prodotto in condizioni ottimali (MEuvRET 1988 17-9 PuLT QUAOUA 1984 88) e figravenanco per ridurre il rischio di vederselo soffiare da vagabondi e malintenzionati In questo caso in presenshyza di eccedenze (ma probabilmente anche in assenza) il bisogno di liquiditagrave e lalea cospiravano nel ridl1ITe ai minimi termini le scorte giagrave allindomani del raccolto In caso alternativo il contadino che non egrave - ripete Jean Meuvret - un homme daffaires quanshyto un homme de peur concepiva la sua riserva come un fondo di previdenza sul racshycolto futuro da non immettere sul mercato se non nel caso dellapprossimarsi di una messe sicura secondo una logica economica a contrario (MEUVRET 1988 19 e 147)
Era Jl~tente la disparitagrave fra i produttori non solo fra chi era in possesso di eccedenshyze e chi non lo era ma piugrave anqgtra fra chi poteva scegliere in virtugrave di una maggiore capienza economica e unadeguata dotazione tecnica - il mercato piugrave favorevole per i propri grani (il periodo di saldatura dei raccolti) e chi invece li cedeva troppo presto o in controtempo a livelli non ottimali
Nella gerarchia delle abitazioni rurali -- in quel vero e proprio saggio di sociologia che egrave il sesto libro del DeArchitectura di Sebastiano Serlio (scritto fra il 1537 eil 1555 inedito per tutto levo moderno) -- per trovare case attrezzate di granaio occorshyreva ascendere sino alla magione del basso mercante o cittadino fuori della cittagrave (SERLlO 1994 43 segg anche per le successive informazioni) Condizione di cui non potevano fregiarsi invece i ricchi contadini in ~essuno dei tre gradi possibili di ricshychezza al massimo la loro casa poteva essere attrezzata di portici per ricoverare le biade e di unaia per batterle segni di distinzione giagrave fra i mediocri contadini Fra questi perograve avrebbero potuto avvalersene soltanto i fortUIgravelati et di beni et di famishyglia (3deg grado di mediocritagrave) nforno per cuocere il pane e una cantina per conservashyre il vino invece li si sarebbe trovati a partire dai piugrave accomodati fra i poveri contashydini cioegrave al 4deg gradino della scala sociale alla cui base erano da collocare i poveri mendichi con vii capanna (10 grado di povertagrave) i salariati che vivevano delle [loro] fatiche avendo un puoco di terreno (2deg grado di povertagrave) i poveri con qualche beshystiuola et massimamente de buOvi possessori di una stalletta congiunta con la casa 0deg grado di povertagrave)
In sintesi nelle campagne delletagrave pre-industriale pochi avevano scorte pochissimi erano in grado di ricoverarle in un solaro privilegiatissimo chi le incanevava per speculare Dunquefra i conta4ini se si esclude quanto celato nella madia o nella dishyspensa le scorte erano un pri~ilegio di pochi nSerlio nato intorno al 1475 insiste sullimpoverimento delle class~ rurali intervenuto fra gli anni della sua giovinezza e quelli della vecchiezza in cui scrive Sotto il titolo Dellabitazione del ricco contadishyno per tre gradi di ricchezza si preoccupa di puntualizzare
bencheacute al di dogi non se n~ truovi piugrave de tali merceacute delle discordie et di gli animi fieri et ostinati alla vendetta onde per tal cagioni et per le continue guerre et anche pei citadini divoratori de gli altrui beni che con le usure con glinganni con le rapine gli bano impoveriti (SERUO 1994 ~8)
490 RellOP CorrilOle
colto (agosto-settembre-ottobre) e invia di esaurimento almomento della saldatura dei raccolti (aprile-maggio-giugno )1A questo proposito nota Franccedilois Sigaut
Le stockage agrave court terme (moins dune campagne) reacutepond agrave la neacuteCessiteacute cIeacute concilier une offre variable et une demande constante mais toutes deux reacutegulieacuteres et preacutevisibles dans la
pratique il est consideacutereacute comme tiiisant pame du processus ordinaire de la production et ne pose agrave ce titre que desproblegravernes doptimisation assez simples (SlOAUI 1985 602)
La discussione generale sulla razionalitagrave economica delle scorte alimentari in etagrave pre-industriale puograve allora essere ridotta alla fonnulaiione e allo scioglimento di due
semplici quesiti 1 Accertato che laccantonamento digram per la periodicitagrave annuale del ciclo agricoshy
lo epet i vincoli tecnici di un rifomimento spazialmente allargato egrave inevitabile chi egrave conveniente che conservi le scorte chi produce o chi commercia il contadino o il mercante lapossidenzagrave o il popolo i particolari o il pubblico E qual egrave la realtagrave effettiva
2 Se le forme di distribUzione economicamente razionale sono plurali in quale conshytesto e in omaggio a quali interessi piugrave utile il sistema della canova rispetto al sistema delll piazza del mercato e dei solari privati
3 SULLADISTRIBUZIONE DEL GRANO NELUETAgrave PRE-INDUSTRIALE E LA STRUTTURA DELLE SCORTE NEI TERRITORI ITALIANI
Raramente le case contadine erano dotate di attrezzature per la conservazione dei cereali piugrave che elementari Nelle campagne toscane del Quattrocento dunquein unetagrave favorevole al reddito contadino in una regione fra le piugrave ricche dellEuropa pre-indushystriale
pochissime case contadine disponevano del granaio vero e proprio alcune avevano una cella che poteva servire allo stesso scopo ma la maggior parte di quelle abitazioni era priva di spazi destinabili esclugravesivamente alla conservazione dei cereali Perciograve i contenitori dei grani arche casse sacchi bugnole - dovevano trovare posto nelle cucine o nelle camere CMA= RAVEGGI 1983 174)
Le ridotte capacitagrave patrimoniali e reddituali della grande maggioranza dei produttori facevano sIgrave che fosse ampiamente invalso nella conservazione domestica dei grani limshypiego di contenitori in legno (come arche casse botti bugnole tini tinelle corbelli)in
Riguardo ai passi evidenziati di Zanetti e Cipolla egrave neCessario osservare che la principale atteshystazione sullesistenza di stock detenuti da privati che esorbitassero ilfabbisognostagionale tali da essere classificati come immobili=zione di ricchezza (Zanetti) o come beni capitale (Cipolla) a unanalisi piugrave fine si rivela fallace o non direttamente utilizzabile La propalazione dei grani effetshytuata a Pavia fra ilimiddot e il5 maggio 1555 che egrave il fondamento di entrambi i giudizinon mostra una somma di derrate realmente eccedente il fabbisogno delle famiglie per il periodo che manca allarri_ vo dei grani novelli sulla piazza pavese Daltra parte lastessa natura dellistituto della propalazioshyne dei grani cioegrave della denljncia obbligatoria delle scorte da parte dei particolari una misura demergenza decisa in momenti critici dellapprovvigionamento cittadino affiancata quellanno dalshylispezione diretta presso le case dei privati da parte di deputati straordinari avrebbe dovuto consishygliare una maggiore cautela nella sua utilizzazione per individuare regolaritagrave di carattere generale delleconomia pre-industriale
499 La costituzione di scorte granarie pubbliche e la ptlitica ecoMmica degli stati
FONTI
ABEL [1966) W ABEL Agrarkrisen undAgra~kJJnjunktur Eine Geschichte der londshy und Erniihrungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter Hamburg
und Berlin Paul Parey 19662 (la ed -1935 trad it Congiuntura agraria e crisi agrarie Storia dellagricoltura e della produzione alimentare nellEuropa centrashyle dal XIII secolo alletagrave industriale Torino Einaudi 1976 da cui si cita)
AG ARCHIVIO GoNZAGA presso lArchivio di Stato di Mantova AuFANO 1996 E AuFANO Il grano il pane e la politica annonaria a Napoli nel Setshy
tecento Napoli ESI 1996bull AYMARO 1966 M A YMARO Wmise Raguse et le commerce du bMpendant la seconde
moitieacute du XVI siegravecle Pans SEVPEN 1966 CATIINI 1984 M CATl1NI I contadini di San Felice Metamorfosi di un mondo rurale
nellEmilia delletagrave modernIgravel Torino Einaudi 1984 CESTARl 1794 p CESTARI Saggio storico dei Fondachi delle farine di Chioggia e
Pellestrina Venezia A Zatta 1794 CIPOllAJ1965] C M CIPOllA La politica economica dei governi V La penisola
italigraveana e la penisola iberica in Storia economica Cambridge m La cittagrave e la politica economica nel Medioevo Torino Einaudi 1977 (Cambridge 1965) pp 462-496
CIPollA 1974 C M CIPollA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna nMulino 1974
CIpollA 1997 C M CIPOllA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna nMUlino 1997 (6 ed riveduta)
CORRITORE 2000 R P CoRRITORE La naturale abbondanza del Montovano Produshyzione mercato e c01isumi granari a Mantova in etagrave moderna Pavia Universitagrave di Pavia 2000
CORIONBSI 1991 A CORIONBSI Sulla conservazione dei cereali nellItagravelia medioevale Lavoro e tecniche nelle tesnmonlanze laziali (secc XIII-XV) in Rivista di storia dellagricoltura XXXI 1991 l pp 33-49
DELLA VALENTINA 1992 M DELLA VALENTINA I mestieri del pane a ~nezia tra 600 e 700 in Atti dellIstituto [Veneto di Scienze Lettere ed Arti Classe di scienze morali lettere ed arti CL 1991-92 pp 113-217
DIRLMEIER 1984 U DIRLMEIER le condizioni materiali dellesistenza nelle cittagrave tedeshy sche del Basso Medioevo ~iente esterno reddito consumi in Aristocrazia citshy
tadina e ceti popolari nel tprdo Medioevo in Italia e in Germania (a cura di Reinhard Elze e Gina Fasoli) Bologna Societagrave editrice il Mulino 1984 pp 79shy122
FORNASIN 1999 A FORNASIN Il pzercatodei grani di Udine Indagine per una storia dei prew in Friuli (secoli XfI-XVIII) Nota di ricerca del Dipartimento di Scienshyze Statistiche dellUniversit4 degli Studi di Udine 4 1999 pp 1-24 ora in lo La Patria del Friuli in etagrave 1fIOderna Saggi di storia economica Udine Forum 2000 pp 33-60
GRENDI 1986 E GRENOI Lapprccedilwigionamento dei grani nella Liguria del Seicento libera pratica e annone in iMiscellanea storica ligure Studi in onore di Luigi Bulferetti XVIII 1986 2Jp 1021-1047
GUENZI 1981 A GUENZI Ilfrurnfnto e la cittagrave il caso di Bologna nelletagrave moderna in Quaderni storici XVI ~981 46 pp 153-167
GUENZI 1982 A GUENZI Pane ~fornai a Bologna in etagrave moderna Venezia Marsilio 1982
I
489 500 Renzo P CornIOle
GUBNZI1982 A GUEml Sistema annonario e egraveontrollo sociale a Bologna nei seccediloli XVII e XVIII in E SORI (a cura di) Cittagrave e controllo sociale in Italia fra XVIII e XIX secolo Milano F Angeli 1982 pp 293-306
HICKS [1989] 1 R HIClCS A narlcet theory of money Oxford Oxford Universigravety Press 1989 (trad it Una teoria di mercato della monefa Bologna li Mulino 1992 da cui sigrave cita)
JACOPBITI 1965 N L JACOPBITI Monete e prezzi a Cremona dal XVI al XVlIi secolo Cremona Athenaeum CregravemoneJlSe 1965
KAPLAN 1984S L KAPLAN Provisioning Paris Merchants and Millers in the Grain and Flour Trade during the Eighteenth Century Ithaca-London Cornell Univershysity Press 1984~middot
KULA [1962] W KULA Teoria ekonomiczna ustrojufeudalnego Proba modelu Warshyszawa-Panstwowe WydawnictwoNaukowe 1962 (trad it Teoriagrave economica del sistema feudale Proposta di un modello Tormo EinaUdi 1972 ccedilla cui si cita)
WROUSSE [1933] C-E LABRoussE Esquisse du mouvement des prix et des reverws en France au XVIII siegravecle Paris Eacuteditions des Archives Contemporaines 19842 volI (l ed Paris Librairie Dalloz 1933)
MALANtMA 1976 P MALANiMA Aspetti di mercato e prezzi del grano e della segalea Pisa dal 1548 al 1818 in Ricerche di storia moderna vaL I Pisa Pacini 1976 pp ~n
MANToVA 1430 MwroVA 1430 Pareri a Gian Francesco Gonaga per il governo (a cura di M AQrignaniA M Lorenzoni A Mortari C Mozzarelli) MUltova G~ Arcari 1990
MASSA 1999 PMAssA Annona e corporazioni del settore alimentare ~ Genova orshyganizzazione e conflittualitagrave (XVI-XVIII secolo) in A GUENZI PMAssA A MOIOshyu (a cura di) Corporazioni e gruppi professionali nellItalia moderna MilIllO F Angeli 1999 pp 390-403
MATIoZ7J 1983 1 MiJroZ7J F BOLELLI C CmAsBRA D SABBIONI Il politico e il pane a Venezia (157Q-1650) calmieri e governo della sussistenza in Societagrave e storia VI 198320 pp 271-303
MAzzI RAVEOOI 1983 M T MAzzI S RAVEOGI Gli uogravemini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento Firenze Olscbki 1983
MERONI 1957 U MERONI Cremona fedelissima Ciemona Athenaeum Cremonenshy~~~ _
MBUVRBl 1977 J MEuVRsT Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque LouisXIvI La productiograven des ceacutereacuteales dans la France du XVII et du XVIII siegravecle Paris Mouton -EacuteEHSS19772voll
MBUVRET 1988 J MBtJVRf Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque Louis XIv III Le commerce des gralns et la conjoncture Paris EacuteEHss 1988 2 volI
PtCClNNI 1976 G PtCClNNl Wta contagravedina in una capanna dei dintorni di Siena (1250) in ~Archeologia medievale m 1976 pp 395-399
PlNIO 1978 G PINTOII Libro del BiaPaiolo Carestie e annona a Firenze dalla metagrave del 200 al 1348 Fire~ Olscbki 1978
PiNTO 1982 G PtNro La Toscana nel tardo Medioevo Ambiente economia rurale societagrave Fllenze Sansoni 1982
PtRENNE [1933J H PIRENNB La civilisation occidentale au Moyen Age du XIe au mishylieu du XVe siegravecle Paris PUF 1933 (trad it Storia economica e sociale del Meshydioevo Milano Garzanti 1967 da cui si cita)
Lacostituticne di scorte granarie pubbliche e la politica economiegravea degli stati
redigravestribuzione sostenibile dei beni di sussistenza egrave ricercata in questo cielo da quegli stessi particolari che ~amaldeggiano nella produzione negli scambi nei consumi e che costituiscono il nerbo della classe di governo Le scorte pubbliche rappresenteshyrebbero in questa prospettiva un presidio civico e un risltCimento politico e morale ai cOl1ponenti della comunitagrave spossessati delbene supremo dellautarchia alimentare
Resta infine latente unidea del magazzmo pubblico come quasi-mercato cioegrave come luogo volto (1) a risolvere i fa1limentiinfo~vi della piazza del mercato (in meacuterito alle disponi~ilitagrave alle caratteristiche del prodotto alle condizioni di vendita della merce) (2) a ridimensionare lalea per agricoltori consumatori poveri artigiani del comparto alimentare (3) a sostenere i consumi e i profitti privati m funzione anticicli ca in una prospettiva Ilpn meram~nte congiunturale Si tratta in questo caso di un orshyganizzaZionepienattiCnte razio~e Che non opera in maniera saltuaria e riflessa ma in modo continuativo secondo obifttili prefissati di allocazione dei beni primari li funshyzionamento dellacanovagrave (il magazzino pubblico) si porrebbe come strumento inteshygrativo ma no~~igraventeramente so~titutivo delloperare della piazza Si tratterebbe di unaforma di mercato distinta dalla p~ del mercato considerata in seacute e per seacute cosigrave come dallegraveOOmpravendite effetttlate nei solari privati o dalla mera centrallzzazione e redistribuzione di derrate con fi~alitagrave umanitarie La canova rappresenterebbe in tal modo uno dei possibili meccaoi~ di governo delle trllls3ZIgrave~ni locali per risolvere i problemi deUapprovvigionameIto senza intaccare certi interessi di classe (dei proshyprietari ma anche del popolo grasso) S da essere prescelta da autoritagrave e gruppi domishynanti come struttura complementare della piazza del mercato incerti contestiprodutshytivi ed economici La suasacrilizzazione perciograve non esclude la possibilitagrave di un ritorno alle sole compravendite qella piazza e dei solari privati - una volta invertishytosi il trend o spirate le condizioqi economiche della sua istituzionalizzazione
La problematizzazione esorc~ una liquidazione semplicistica del problema delle scorte gran8rle in etagrave pre-industriUgravee nel nome di una loro presunta irrazionalitagrave eco- nomica per il compito di assi~ la sussistenza della popolazione
Le pagine che segUono sono rintroduzione a un lavoro in corso volto a offrire un interpretazione generale di tal~ capitolo fondamentale della politica economica dei governi
in
etagrave pre-industriale
2 SE UN MONDO SENZA SCORTE Egrave INCONGRUO cm Egrave OPPORTUNO CHE LEgrave DETENGA
Nei fatti nel settore granarlo CQni vincoli dell etagrave pre-industriale in tema diprodutshytivitagrave energia trasporti non ha s~nso ipotizzare un mondo senza scorte Se il mercato del grano egrave - come nellEuropa medievale e moderna - un sjstema tendenzialmente chiuso
ad ogni raccolto nuove offe~ aniv(erannol sul mercato mentre la domanda si mant[erragrave] relativamente costantt nel corso dellanno Qualcuno dunque [dovragrave] ~ere delle scorte che saranno elevate ~ubito dopo il raccolto e poi via via minori fino aragshygiungere un livello minimo in prpssimitagrave del successivo raccolto (HICICS [19891 31)
Nella loro forma piugrave sempliceI tali scorte saranno legate allora alla periodi~itagrave anshynuale del ciclo agricolo (che a1iplenta il movimento stagionale dei prezzi ccedilfr LAshyBROlJSSE [1933] 157-66) il loro livello saragrave elevato allindomani del principiLle racshy
501 488 Renzo P Corritore
povero ammassograve nella propria dimora scorte di grano carne ~alata sale candele ecc e la medesima cosa fece lo Stato Nel periodo feudale non venne mai meno nel castello del signore labitudine di tenere da parte grosse scorte per i periodi di emergenza Sucshycessivamente le autoritagrave comunali predisposero il magazzinaggio di grosse derrate specie di grano da rivendere a basso prezzo in periodi di emergenza e nello stesso tempo si preoccuparono di prevenire un indebito accumulo di scorte da parte di specushylatori privati Nelle economie medievali gli stock di derrate di prima necessitagrave rappreshysentarono pertanto una delle piugrave importanti forme di investimento pubblico e privato (CIPOLLA (1965] 468)
Nella prima versione del manualeacute invece fino allinserimento nel 1997 del nuovo capitolo dedicato alla politica economica nell etagrave pre-mdustriale il punto di vista preshyvalente era quello microeconomico entro il perimetro stretto dellindividualismo meshytodologico
Le scorte costano e costano doppiamente Esse implicano il costo diretto che egrave rapshypresentato dal costo del magazzinaggio edal deterioramento eventuale del pr04otto o di parte di esso Se luomo daffari finanzia la costituzione delle scorte con danaro preso a prestito il costo diretto include anche il tasso di interesse pagato Se luomo daffari finanzia con capitale proprio la costituzione delle scorte il costo delle scorte deve inshycludere un costo-opportunitagrave e cioegrave il mancato rendimento (tIllU1cato tasso dinteresse attivo) del capitale finanziario impiegato (CIPOLLA 1974 154)
Le ragioni della costituzione e del mantenimento di scorte alimentari da parte delshylautoritagrave pubblica diventavano unicamente ragioni morali (umanitarie e di buona amministrazione) o di opportunitagrave politica (la fame era la piugrave frequente ligraveausa di sommosse e furori popolari) (CIPOLLA 1974 74)
Nel 1997 si riammetteva dunque linterpretazione originaria della costituzione di scorte pubbliche come strumento di riequilibrio del mercato senza peraltro rinnegare le considerazioni sulla valenza statica di tale forma di investimento per gli agenti economici privati
In merito allutilitagrave economica e al significato delle scorte in etagrave pre-industriale Cishypolla non espresse perciograve sempre lo stesso punto di vista La rassegna delle posizioni da lui assunte anzi permette di individuare tre approcci e tre giudizi costitutivamente diversi sulla funzione delle scorte granarie nellepoca pre-industriale
In prima approssimazione laccumulazione di scorte alimentari mostra il carattere fondamentalmente difensivo delle scelte degli agenti economici pubblici e privati in etagrave pre-industriale La paura la tradizione la superstizione li induce a tabuizzare il rischio la speculazione linvestimento nella produzione e nella distribuzione dei beni essenziali alla vita e ad aderire intimamente a un ideale di economia e societagrave stazionarie aggravando con la norma sociale le istituzioni il comportamento indivishyduale e collettivo leffetto dei condizionamenti materiali delleconomia pre-industriashyle (bassa produttivitagrave agricola alti costi di v~sporto modesta efficienza energetica) esponendo ancor di piugrave la comunitagrave umana ai degravemoni della natura
La seconda interpretazione rigetta luniversale imperio dellhomo oeconomicus rishyscoprendo leteronomia dei fini dellagire economico degli uomini nelletagrave pre-inshydustriale Ia politica economica dello Stato o-delle autoritagrave non persegue puri scopi economici lintegritagrave del corpo sociale fin nelle sue cellule elementari (persone e famiglie) deve essere assicurata secondo i principi e la prassi di uneconomia morale che SOVJa5ta leconomia regolata dal mercato spersonalizzata e antipopolare Una
La costituzione di scorte grantlTie pubbliche e la poligravetigraveca economica degli stati
PuLT QUAGUA 1984 A M PULT QUAGUA Mercato dei prodotti agricoli e magistratushyre annonarie a Pisa nelletagrave moderna in Ricerche di storia moderna a cura di M Mirri voI III Pisa Pacini 1984 pp 57-141
PULT QUAGLIA 1990 A M PULT QUAGLIA Per provvedere ai popoli Il sistema anshynonario nella Toscana dei Medici Firenze Olschki 1990
SERUO 1994 S SERLIO Architettura civile Libri sesto settimo e ottavo nei manoscritshyti di Monaco e Vienna (a cura di F P Fiore) Milano TI Polifi10 1994
SIGAlIT 1985 F SIGAlIT Questions deacuteconomie agrave propos des politiques ceacutereacutealiegraveres et de stockage in Les techniques de conservation des grains agrave long terme leur rale dans la dynamique des systegravemes de cultures et des socieacuteteacutes (sous la direction de M Gast F Sigaut et C Beutler avec la collaboratlon de O Bllchsenschutz) voI III 2 Paris Eacuteditionsdu CNRS 1985 pp 597-606
SMITH [1776 A SMITH An inquiry into the nature and causes ojthe wealth ojnations London W Strahanand T Cadell 17762 volI (trad it Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni Milano A Mondadori 1977 2 volI da cui
si cita) STATlITlBoNACOLSIANI [1313] STATUTI BONACOLSlANl (a cura di E Dezza A M Lorenshy
zoni M Vaini) Mantova GArcari 2002 STATUTI GONZAGHESCHI [1404] STATUTI GONZAGHESCHI presso la Biblioteca comunale di
Mantova ms FV 11 [775]VECCHIATO 1979 F VOCCHIATO Pane e politica annonaria in Terrajerma veneta tra
secolo XV e secolo XVIII (Il caso di Verona) Verona Stamperia Zendrini 1979 ZANETTI 1963 D ZANETTl Contribution agrave leacutetude des structures eacuteconomiques lapshy
provisiQnnement de Pavie au XVI siegravecle in Annales ESC XVIII 1963 1 pp 44-62 ora in lo Fra le antiche torri Scritti di storia pavese Pavia Universitagrave di Pavia 2000 pp 165-182
ZANETTl 1964 D ZANEITI Problemi alimentari di una economia preindustriale Ceshyreali a Pavia dal 1398 al 1700 Torino P Borlnghieri 1964
ZUG TUCCI 1990 H ZUG TuCCI Le derrate agricole problemi materiali e concezioni mentali della conservazione in Lambiente vegetale nellalto Medioevo XXXVII Settimana di studio del Centro italiano di studi sullalto Medioevo (30 marzo-5 aprile 1989) Spoleto Centro italiano di studi sullalto Medioevo 1990 voI n pp 865-902
491 498 Renzo P Corritore
alla spartizione dei proventi derivanti dalla vendita e dal commercio del grano shylemolumento grandissimo - di chi doveva poi fruire della redistribuzione di tale ricchezza Tale norma avvantaggiava i possidenti cittadini e i gentiluomini privilegiashyti in grado di ottenere le tratte di esportazione Spl piano dellappropriazione essi erano in condizione di mettere fuori gioco gli altri possessori che producev~o eccedenze nel Dorilinio poicheacute si accresceva la loro forza contrattuale e la loro capacitagrave di occupare i canali commerciali piugrave redditizi Sul piano della commercializzazione gli stessi fruivashyno dello smantellamento della rete dintermediazionerappresentata dai fornai Per i rushystici significava perdere un collegamento essenziale con la cittagrave ed essere emarginati dal mercato urbano nelle campagne o sul broletto di Mantova essi non trovarono piugrave i trashydizionali interlocutori (CORRIJ9RE 2000 228231-2)
Nel caso di Bologna terra strutturalmente deficitaria e cittagrave dalla vocazione manishyfatturie1a si costringeva i fornai ad acquistareformenti terrieri presso i solari privati in cittagrave proibendogli lincetta nel contado autorizzandoli ad acquistarefornientiforeshystieri al di fuori delle mura cittadine presso rsensati da grCUlO solo a patto che fosseshyro stati smaltiti i grani cittadini a un prezzo talota superiore a quello dei grani dimshyportazione (GTlBNZl1982A 35 52-3)
Nella Toscana dei Medici il diritto allincetta nel contado venne concesso ai fornai in periodo di bassa congiuntura (in particolare dagli anni Trenta del Seicegravento) Per sostenere i prezzi interni in tal caso essi restavano gli interlocutori principali dei granshydi proprietari semplicemente spostando la loro principale fonte di approvvigionashymento dai solari dei particolari in cittagrave ai granai decentrati delle grandi aziende agrishycole oppure ai mercati rurali su cui affluiva la produzione cerealicola delle grandi fattorie (PULT QUAOUA 1984 86-9 PucrQUAGUA 1990 100 106-7)
Laddove non vi egrave come invece succede a Genova una diretta ingerenza del potere pubblico nella vita della corporazione (MAsSA 1999) i fornai di cittagrave- nonostante i lacci e lacciuoli normativi e il lavoro prevalentemente manuale svolto neUord laboshyratori - erano dei veri imprenditori dipendenti per il loro profitto - noilrinalmente stabilito per legge - dalla produttivitagrave del lavoro e dalla dotazione tecnica e finanziaria delle imprese Di ciograve fa fede la grande sperequazione esistente fra le aziende speciashylizzate nena fabbricazione del pane venale in cittagrave (AYMARD 1966 75 VBCCHIATO 1979 82-3 GTlBNZl1982A
77 segg PULT QUAGUA 1984100 102-3) NellItalia delshyletagrave moderna questi artigiani-imprenditori della filiera del grano trattavano insieme
afarinaifarinaiolifarinottifondachierifontechierifidelarijormentinari lasagneshyri maccaronari taraltari vermicellari ecc fra il 40 eil70 per centodel frumento consumato in Cittagrave nelle annate normali (CORlUTORE 2000 126 segg) e ~no alIDO per cento nelle annate di carestia (PULT QUAGUA 1984 98-9)
In una ricognizione delle asimmetrie informative del mercato non cegrave gruppo quale i fornai che possa integraverpretare la parte dellagente economico onnisciente Se dunque i regolamenti annonari tendevano a regolare minuziogravesamente la collocazione il volushyme e la durata delle loro scorte cosi come disponevano per gli altri artigiani della fishyliera era per neutralizzare il carattere potenzialmente eversivo di tale accantonamenshyto per i proprietari-venditori prima ancora che per i consumatori-acquirenti nlivello delle scorte rinforzava o attenuava il rischio di monopsonio da parte dei pistores piugrave potenti e facoltosi cosi come eventuali tentazioni da parte della categoria di esercitare un dominio egoistico sul mercato del pane (MATroZZI 1983 298)
Sarebbe quindi un errore concep~ le sccedilorte dei fornai come entrilpica allocazione di capitale che sconta lincertezza futura esse venivano gestite secondo criteri di rashyzionalitagrave economica e secondQ la migliore efficienza tecnica nonostante i vincoli imposti alla lievitazione degli stock dalle disposizioni annonarie
LA costituzione di scorre granarie pubbliche e la polilica economica degli stati
vimini paglia o canne intrecciate (come ceste stuoiecannizzi) in terracotta (addirittura anfore) piuttosto che di tessuto (i sacchi costavano troppo) (PICClNNl 1976 397 MAzzA RAvBGGI 1983 174-5 Zoo Turo 1990 893-4 CORIONESI 1991 35n-36n)
Nella casa del piccolo produttore O del titolare di un piccolo possesso il penus (la scorta domestica) difficilmente eccedeva il consumo famigliare chi fortunato raccoshyglieva piugrave dellannona famigliare e di quanto gli serviva per il campo era spinto a venderselo nei mesi immediatamente successivi alla mietitura e alla trebbiatura per necessitagrave di denaro ma anche per la difficoltagrave di stoccare e conservare il prodotto in condizioni ottimali (MEUVRET 1988 17-9 Pmr QUAGUA 1984 88) e financo per ridurre il rischio di vederselo soffiare da vagabondi e malintenzionati In questo caso in presenshyza di eccedenze (ma probabilmente anche in assenza) il bisogno di liquiditagrave e 1alea cospiravano nel ridl1rre ai minimi termini le scorte giagrave allindomani del raccolto In caso alternativo il contadino che non egrave - ripete Jean Meuvret - un homme daffaires quanshyto un homme de peur concepiva la sua riserva come un fondo di previdenza sul racshycolto futuro da non immettere sul mercato se non nel caso dellapprossimarsi di una messe sicura secondo una logica economica a contrario (MEUVRBT 1988 19 e 147)
Era Hltente la disparitagrave fra i produttori non solo fra chi era in possesso di eccedenshyze e chi non lo era ma piugrave ancora fra chi poteva scegliere - in virtugrave di una maggiore capienza economica e un adeguata dotazione tecnica - il mercato piugrave favorevole per i propri grani (il periodo di saldatura dei raccolti) e chi invece li cedeva troppo presto o in controtempo a livelli non ottimali
Nella gerarchia delle abitazioni rurali -- in quel vero e proprio saggio di sociologia che egrave il sesto libro del De Architectura di Sebastiano Serlio (scritto fra il 1537 e il 1555 inedito per tutto levo moderno) - per trovare case attrezzate di granaio occorshyreva ascendere sino alla magione del basso mercante o cittadino fuori della cittagrave (SERLIO 1994 43 segg anche per le successive informazioni) Condizione di cui non potevano fregiarsi invece i ricchi contadini in ~ssuno dei tre gradi possibili di ricshychezza al massimo la loro casa poteva es~ere attrezzata di portici per ricoverare le biade e di unaia per batterle segni di distinzione giagrave fra i mediocri contadini Fra questi perograve avrebbero potuto avvalersene soltanto i fortUIgravelati et di beni et di famishyglia (3deg grado di mediocritagrave) Dforno per cuocere il pane e una cantina per conservashyre il vino invece li si sarebbe trovati a partire dai piugrave accomodati fra i poveri contashydini cioegrave al 4deg gradino della scala sociale alla cui base erano da collocare i poveri mendichi con vil capanna (1deg grado di povertagrave) i salariati che vivevano delle [loro] fatiche avendo un puoco di terreno (2deg grado di povertagrave) i poveri con qualche beshylitiuola et massimamente de buovi possessori di una stalletta congiunta con la casa (3deg grado di povertagrave) In sintesi nelle campagne delletagrave pre-industriale pochi avevano scorte pochissimi
erano in grado di ricoverarle in un solaro privilegiatissimo chi le incanevava per speculare Dunque fra i contadJni se si esclude quanto celato nella madia o nella dishyspensa le scorte erano un pri~ilegio di pochi Il Sedio nato intorno al 1475 insiste sullimpoverimento delle class~ rurali intervenuto fra gli anni della sua giovinezza e quelli della vecchiezza in cui segraverive Sotto il titolo Dellabitazione del ricco contadishyno per tre gradi di ricchezza si preoccupa di puntualizzare
bencheacute al digrave dogi non se ne truovi piugrave de tali merceacute delle discordie et di gli animi fieri et ostinati alla vendetta onde per tal cagioni et per le continue guerre et anche pei citadini divoratori de gli altrui beni che con le usure con glinganni con le rapine gli hano impoveriti (SERllO 1994 48)
492 497 Renzo P COlTitore
Tale disparitagrave sociale si riverberava sulla struttura del conunercio cerealicolo La funzione dei piccoli conunercianti di biade (granaioibiadaiolijarinaioli balshy
zarotti cavallanti vaticali ecc) era infatti ancillare alla capacitagrave di affacciarsi sul nercato della fascia marginale dei possidenti con eccedenze Solo che nelle annate di
abbondanza si verificavano ingorghi nellofferta di grano che deprimevano i prezzi e incentivavano i piccoli produttori a smerciare direttamente le eccedenze allindomani del raccolto nellarea urbana anche al di fuori dei luoghi deputati (MA1TOZZl 1983 278 281-2 300n PULT QuAGLIA 1984 86) Mentre nelle annate di penuria si contraeshyva drasticamente proprio questo segmento dellofferta (ABEL (1966J 22-4 KULA (1962] 73-4 CATIINI 1984 111-23 PuLT QUAGLIA 1984 88) scatenando nelle campashygne una caccia al grano-merce la cui quota piugrave consistente era detenuta dai grandi proprietari dai maggiori affittuari dai percettori di canoni diritti o rendite in grano e la cui quota residua era piugrave facilmente preda di chi occupava posizioni chiave nellasshysetto terriero nella catena dei diritti nel credito alla produzione e al consumo
Tanto la distribuzione era frammentata nelle annate di abbondanza tanto in epoclshydi penuria il conunercio del grano diventava un affare di pochi In questo caso lazioshyne dei mercanti diventava dimpiccio sul mercato interno dove la coperta si restringeshyva per i proprietari e gli imprenditori agricoli (KULA (1962J 56-61 CATIINI 1984 114-8) - dove la necessitagrave di ricorrere al credito da parte dei piccoli possessori pOneva questi nelle mani degli agenti dei proprietari dei percettori di canoni diritti o rendite - dove i piccoli proprietari vedevano minacciata la loro stessa condizione da parte di chi controllava localmente in maniera capillare e decentrata il mercato del denaro e dei beni necessari alla riproduzione (sernenti strumenti cibo) La soluzione era quelshyla di precludere amministrativamente ai sensali e ai conunercianti di grani i mercati locali su istigazione dei medi possessori le cui occasioni di normale profitto agrario soffrivano un ridimensionamento e che si vedevano costretti a impegnarsi ccedilontiltte le loro forze per integrare le proprie entrate accaparrandosi le magre eccedenze disponishybili nelle campagne e nei borghi rurali (PuLT QUAGLIA 1984 84-8 PuLT QUAGLIA 1990 107-14)
Il destino dei piccoli conunercianti in grano era quindi quello di occupare una posishyzione marginale nel mercato del grano (MEUVRET 1977 30 PINTO 1978 13 MATTOZZI 1983 277) e di operare non solo a causa degli ordinamenti annonari - secondo una logica di corto respiro in cui non era contemplata neacute la conservazione di grani a lungo termine neacute lutilizzo di depositi piugrave che provvisori Come per i piccoli possidenti non si puograve parlare nel loro caso della formazione e del mantenimento di scorte consistenti (MEUVRET 1988 156-7) Non tali comunque da sostenere il reddito contadino nelle stagioni ordinarie e da esercitare sul versante cittadino unefficace azione anticonshygiunturale in caso di carestia
Peraltro in cittagrave la struttura dellofferta era anche piugrave sperequata di quella che si rishyscontra nel contado Che si tratti di Prato ne) 1339 (PlNTO 1978 129 PINTO 1982 160n e 171n) Pavia negli anni 1539 1555 1573 1602 1603 (ZANIITTI 1963) o Mantova nellultima parte del secolo XVI (CORRITORE 2000 81-9) la distribuzione delle scorte fra i privati era singolarmente ineguale Lo attesta la rilevanza nellarea urbana della povertagrave cioegrave secondo una definizione coeva di coloro che non vivono di entrate ma sono necessitati ricorrere mattina e sera alle pistorie a comprare il pane per il vitto loro e delle sue famiglie col denaro che di giorno in giorno si vanno guadagnando (MATshyTOZZI 1983 281) PUOgrave essere utile richiamare la situazione delle cittagrave tedesche nel basso Medioevo in una fase che egrave stata definita da Wilhelm Abel l epoca doro degli artigiani e del lavoro salariato si puograve stimare che almeno la metagrave degli iscritti ai
il costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica ecol1Omica degli stati
te con il principio della piazza Il mercato pubblico periodico disciplinato la spiagshygia la piazza la loggia o il recinto riservato alle contrattazioni - coesisteva confabshybriche magazzini ebotteghe La stessa piazza per funzionare al meglio secondo il principio dello scambio diretto necessitava di magazzini di supporto
4 LE SCORTE DEI FORNAI CITTADINI
Nellarea urbana e nelle relazioni tra cittagrave e campagna operavano perograve temibili conshycorrenti dei privati possessori I fornai cittadini possedevano le competenze le strutshyture tecniche le relazioni sociali e il credito per incettagravere il prodogravetto per essere inforshymati tempestivamente sul mercato del grano e potenzialmente per dispensarlo con profitto in qualunque momento Il fatto che il loro operato fosse imprigionato in un arshycaica impalcatura di norme divieti obblighi che risalivano alletagrave romana che ne fashycevano in modograve quasi istituzionalizzato il capro espiatorio delle tensioni fra produtshytori di grano povertagrave e autoritagrave non impedisce di affermare che tali vessatorie disposizio~i trovassero la loro principale ragione dessere nella parte che essi giocashyvano di interlocutorilantagonisti dei proprietari terrieri nella determinazione del prezshyzo del grano sul mercato locale e nella realizzazione della rendita terriera (GUENZI 1982 35 GUENZl 1982 297)
Nel caso di Mantova terra cornucopia a partire dal 1492 si consenti a zentilhomini cittadini et qualuncho altro di comprare biade nel Dominio per approvvigionare la cittagrave di fatto si sancigrave un diritto allincetta che mise fuori gioco i fornai a cui venne imposto di rifornirsi nei solari dei cittadini senza avere piugrave la possibilitagrave di effettuare acquisti nel contado e di ritenere a casa scorte superiori a 100 staia di frumento Lintento della disposhysizione egrave chiarissimo espresso senza reticenze dai Maestri delle Entrate che riportarono al marchese la soddisfazione dei possidenti mantovani per la riforma statutaria
tutta la Terra (cioegrave il Mantovano] ne (egrave] rimasta satisfactissima pensando che Vostra Excellentigravea pretenda ali comodi et utilitagrave universale senza dampno et preuiditio suo Vero egrave che li fumari non si contentano parendoli comegrave il vero che non si poteranno ingrnssar asuo modo come hanno facto per il passato et poterigravea Igravelchader ( ] che veneranno adolershyse et supplicar aVostra Signoria Perograve me egrave parso dargene aviso per questa nostra et farli intender che questa terra ha soliigrave due membri de li quali li cittadini soi se ne possono aiutashyre e valersene uno egrave il grano laltro egrave larte de la lana et quando se concedesse che li furshyDari potessero comprare come h~o facto li tempi passati sana un fare beneficio acinquanshytaocto dessi et dampnifichar elresto de fa republica sua quale de questo ban ordine ne receve emolumento grandissimo et se gaude in la Citagrave [percheacute] li fumari portano fuora el denaro et pretendono solo a suo benefitio (AG b 2441 lettera del 13 luglio 1492)
Egrave indubbio che il plauso della Terra fosse da attribuire piugrave alla possibilitagrave per i proshyprietari di accrescere le proprie entrate che a quella dei consumatori cittadini e dell arte della lana di trarre beneficio dalla disposizione Egrave significativo che la motivazione pro cigravevitate non accenni allesistenza di monopoli da parte dei fornai o di artificiose lievitashyzioni dei prezzi per causa loro Il loro attivismo non confiiggeva per quanto riguarda i prezzi finali della sussistenza con linteresse dei produttori cittadini E daltra parte largomento dellQ storno dal merpato cittadino dei profitti incamerati dai fornai -laccushysa consueta a proposito dei pistores egrave che fossero in gran parte stranieri (GUENZII982 22) -- era una giustificazione debole che appassionava piugrave chi concorreva direttamente
496 493
Renzo P Corritore
appare altrettanto astratto dogmatico o virtuale del principio di mercato (Market Pri1lciple) che il medesimo gli contrappone Henri Pirenne parlando della politica annonaria dei comuni medievali avverte Lapplicazione del principio della vendita diretta ebbe numerosi eccezioni (PumNNE [1933] 193n)
Nel caso di Mantova la scelta della Piazza egrave facoltativa per i terrieri COn eccedenze Gli Statuti signorili che si rifanno largamente alle raccolte statutarie comunali non sancivano alcun obbligo in proposito (v SVJUTI BONACOLSIANI [1313] libro m rubr 55 De mercato blave 253 STATlITl GoNZAOHESCHI [1404J libro m rubr 93 De mercato blave fiendo in civitate Mantue f 73v) Decreti di carattere straordinario e regolamenshytazioni transitorie correggevano il tiro Nel 1405 in piena saldatura dei raccolti si c0shy
strinse a rifornire forzosamel)~ la piazza concentrandovi tutte le contrattazioni Nel 1417 si obbligograve a riservare al mercato un terzo del frumento introdotto in cittagrave (CORRIshyTORE 2000 235-6) Ma sono atti straordinari che non sopravvissero nel migliore dei casi piugravedi qualchelustro (MANroVA 1430 88 90 181) A Mantova la Piazza era affianshycata da un granaio pubblico la Domus del mercato (altrove definito Folllico o Fonrego del mercato) in cui avrebbero dovuto prolungarsi le contrattazioni oltre lorario e i giorshyni deputati (venerdigrave o sabato) rendendo disponibile ciograve che restava invenduto e che non poteva essere ritirato per legge dal mercato Nel 1430 eminenti cittadini sollecitati dal principe lamentavano perograve lincapacitagrave del magazzino - inoperoso in tutto o in parte per il pericolo di crolli -- di rispondere ai bisogni del popolo in una situazione in cUi da parte dei possessori si protestava la difficoltagrave di non poter esitare e smerciare fuori delshyla cittagrave le eccedenze conservate nei solari privati
Item videtur quod valde utille foret civibus Mantue habentibus possessiones et quishybuscumque alijs personis de civitate Mantue aut districtu colligantibus bIada et vina in magna copia ut omni tempore ipsa bIada et vinum possent extrahere de civitate et dishystrictu Mantue et conducere ad Iaea ad que et in quibus ma vendere poterunt cum otdishynibus et dacijs competentibus ipsa tamen civitate semper remanente fulta pro usu dicte civitatis et populi eiusdem ne dieta biada marceschant super granarlis ut hactenus feceshyrunt cum maximo incomodo ipsorum civium (MANTOVA 1430 177-8)
nmedesimo fondaco abbinato al mercato operava a Verona a Ferrara a Vegravenezia a Udine a Chioggia in molte altre cittagrave (MANToVA 1430 100 FORNASIN 1999 7-9 CEshySTAR 1794)
Lintegrale e pedissequa applicazione del principio della piazza di mercato comporshytava - per i vincoli tecnici dell etagrave pre-industriale -la massima affermazione del prinshycipio della canova cioegrave del magazzino pubblico centrale Unico argine alla sua invashydenza era costituito da una distribuzione perequata ab imis del raccolto cioegrave la possibilitagrave - egrave questo il paradosso - di realizzare da parte dei produttori la massima aspirazione nelle societagrave tradizionali lautarchia domestica Piugrave avanzava invece la sperequazione nel reddito e nel patrimonio piugrave da parte dei consumatori privi di scorshyte si impetrava il principio del Magazzino pubblico nella ronna di un efficiente sisteshyma di ricovero conservazione distribuzione delle derrate a garanzia del funzionashymento della Piazza di mercato La disponibilitagrave di crescenti quote di raccolto tuttavia indirizzava i piugrave accomodati verso soluzioni piugrave ghiotte la vendita allingrosso sul mercato cittadino ai fornai o allimpresa pubblica creata a sussidio di questi (o in loro vece) Oppure allopposto lesito delle eccedenze extra muros sui grandi mercatishyemporio regionali per il tramite di mercanti o agenti diretti
Il principio del magazzino pubblico centrale cioegrave laccumulazione di riserve per lo smercio continuo o anticiclico egrave quindi alla sua origine in opposizione solo apparen-
La costirU1ione di scorre granarie pubbliche e la politica economica degli srati
ruoli fiscali non fosserograve in grado di accantonare scorte Nel 1444 a Strasburgo quattro cittadini su dieci non possedevano alcuna riserva cerealicola (DRlMBIER 1984 112)
Nelle cittagrave italiane delletagrave moderna si puograve stimare che non meno di due terzi della popolazione fosse costretta ad acquistare o consumare pane confezionato con grani e farine comperati nelle piazze nelle vie e nelle botteghe cittadine oppure ottenuti come compenso del proprio servizio nelle casate (CORRrroRE 2000 126-36 MA11oZZI 1983 27~-82) Evidentemente questa fascia di lavoratori salariati non possedeva -shyper definizione - neacute scorte neacute depositi personali e nel primo caso era strettamente dipendente dal mercatograve urbano acquistando la sua sussistenza con frequenza non piugrave che settimanale (essendo costretti a comprare il pane tutti i giorni allafinestra si dishyceva a Genova [GRENDI1986 1031])
Ma anche fra i citiOdini con possesso extra moenia la distribuzione delle scorte era tuttaltro che egalitaria A Prato nel 1339
A parte gli enti religiosi sette famiglie [ ] avevano ii disposizione piugrave di mille staia di granaglie (circa 18 tonnellate) fino a un massimo di 3500 Altri venti nuciei familiashyri avevano scorte comprese tra le 500 e le 1000 staia (PINTO 1978 129n)
A Mantova nei magazzini ducali nellultima parte del 500 erano ammassati non meno di un ottavo talora piugrave di un quarto delle riserve cittadine di grani panificabili (CoRRITORE 200081-6) A Pavia nel corso dello stesso secolo e allinizio di quello successivo nei solagraveri di una sessantina di famiglie si concentrava non meno del 40 per cento dellintera offerta cittadinIgrave di frumento(ZANBUgrave11964 70-7) Anche in questo caso egrave utile sapere che nelle cittagrave tedesche esistevano mercanti (ad Augusta RatisboshyDa Norimberga) in grado di axnPmssare riserve da 6 a 45 tonnellate e che a Francoshyforte nel 1488 due patrizi totali~zavano insieme un terzo delle scorte cerealicole dei particolari nella cittagrave alta (DnuMmER 1984113)
Ritenere tali soggetti sprovv~uti al punto di incanevare grani con il solo scopo di esorc~ i pericoli della Fstia egrave perlomeno riduttivo A grandi solari comshyspondevano vaste familiae e pIftore di servi tori e ospiti ma tali scorte eccedevano largamente la sussistenza del maggiore palazzo nobiliare o patrizio senza peraltro costituire un fondo di accantonafoento eccedente il fabbisogno della cittagrave a meno che non vi fosse la concreta possibilitagrave di commercializzare il surplus sui mercati esteri Come nota infatti Adam Smith
a meno che leccedenza non possa essere esportata in tutte le circostanze ordinarie i coltivatori staranno molto attenti a non produrre e gli importatori a non importare mai una quantitagrave maggiore di quell~ che egrave strettamente richiesta dal consumo del mercato interno Questo mercato saragrave difficilmente sovrafomito ma saragrave in generale sottoriforshyDito dato che coloro che svolgqno lattivitagrave per rifomirlo avranno in generale il timore che la loro merce possa rimanete invenduta (SMlTH [1776] 528)
Lipotesi egrave suffragata dai cas~ storici conosciuti A Bologna macrodistretto serico dellevo moderno laddove gli ipteressi manifatturieri e mercantili avrebbero dovuto consigliare una sussistenza a b~on mercato per tenere basso il costo del lavoro le istituzioni annonarie operavano per garantire con il calmiero deljorme1lto la monetizshyzazione della rendita granaria dei possidenti - strutturalmente incapace di coprire il fabbisogno della cittagrave anchea rischio della carezza dei viveri contingentando il mercato dei grani forestieri (GtJFNZl1982A 37-76) Di fatto
495 494 Renzo P Corrllnre
In ogni caso si tendeva a limitare al minimo indispensabile lemiddot importazioni di frushymento per evitare che stocks invenduti potessero turbare la collocazione dei grani tershyrieri nel nuovo anno agrario (GuENZI 1981 153)
In tutti i centri comunque la tendenza a ritardare la vendita del surplus nei mesi della saldatura lutilizzo di depositi specializzati con personale addetto alla custodia al conshydizionamento e alla commercializzazione del prodotto ponevano i grandi proprietari di biade su un gradino superiore e diverso rispetto al resto della cittagrave Laccantonamento di grani per questa cupola di possessori rispondeva al principio dellutilitagrave soggettiva atshytesa e richiedeva sia capitale fisso sia capitale circolante per raggiungere gli scopipreshyfissati un profitto speculativo la valorizzazione della rendita
In molte cittagrave i possessori non avrebbero dovuto trattenere in casa piugrave grano e farina di quantoprescritto dalla legge cioegrave il consumo mensile per bocca - fissato anchesshyso statutariamente - per arrivare al nuovo raccolto Ma i cittadini credeVano veramenshyte ai loro comandamenti Egrave lecito dubitare La norma era scolpita negli Statuti e pubshyblicamente violata con la complicitagrave dll1e autoritagrave e dei groppi professionali interessati alla distribuzione del grano nelle sue ~arie forme
Nelle annate ordinarie la quota di grano auto consumato - cioegrave non acquistata sul mercato - nelle cittagrave italiane dell evo moderno rappresentava fra il 30 e il 60 per censhyto del fabbisogno urbano di frumento
Nella capitale dei Gonzaga nel 1615 si valutava che su 27000 bocche
il terzo [di] gentilhuomini fittadri servitori et altri [ ] non comprano biada et gli duoi tenigrave tra poveri artisti mercanti fomari fondachieri hebrei et altri [bull] non possono in tutto levar sufficientemente la somma de detti dua terzi sl che saranno boshychegrave 18000 che compraranno biada (COIUUTORl 2000 126)
AVenezia a cavaliere fra XVI e XVII secolo alla mensa delle casade si dispensava circa un terzo del frumento consumato ordinariamente in cittagrave (AMARD 1966 74 MATTOZZI 1983 281) ABologna per tutto il Seicento i fornai che impastavano farine in conto lavorazione per i particolari pareggiavano piugrave o meno il numero di quelli da scqffa che smerciavano pane venale (GUENZI 1982A
27) Peraltro la proporzione a Rialto tra chi lavorava per le casade e chi vendeva pane al pubblico - 65 Jo~ri a fronte di 44-48 pistori negli anni 1583-1685 (DELLA VALBNTINA 1992 143-4 167 192-3) - fa ritenere la struttura del mercato del pane felsinea non molto dissimile da quella veneziana Nelle cittagrave liguri o toscane sei-settecentesche la porzione autocon sumata quando il raccolto era buono era anche piugrave elevata (GRENDI 1986 1024-6 1034 PuLT QUAOUA 1984 98-104 PULT QUAGUA 1990 171-2) A Napoli nel 1758 a Monasteri Luoghi pii e Particolari eta riservato il 28 per cento del consumo cittadishyno di frumento (AuFANO 1996 37n)
Lelevato numero di servi domestici persone al servizio delle casate faceva sigrave che in alcuni palazzi si concentrassero masse cospicue di grano per la spesa familiare Ma accanto ad esse gli operatori dell annona -- la stessa povertagrave -- si auguravano che vi fosse sempre anche la materia per rifornireil mercato e i forni cittadinimiddot nella fase piugrave delicata del ciclo annuale il periodo di saldatura dei raccolti Come spiegare altrimenshyti la norma che imponeva ai grossi detentori di biade (non esclusi enti e opere pie) in varie cittagrave italiane dellevo moderno la vendita straordinaria in primavera dellegrave ecshycedenze ammassate in granaio (per Pisa e la Toscana v PuLT QUAGUA 1984 88-9)
A Mantova nel 1554 si stabiliva che i patroni che avessero fruito in cittagrave di piugrave di 20 sacchi di grano come porzione dominicale avrebbero dovuto coilservare in granaio
lA costituzioni digrave scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
il 4 per cento per le necessitagrave dei consumatori dei fornai e dei Jontachieri quando fosse mancato il prodotto sulla piazza o nelle offerte deisensali Nel 1603 ci si preocshycupograve di elevare la quota al 6 per cento (CORRlTQRE 2000 237n) Beninteso le vendite sarebbero avvenute ai valori di mercato Lo stesso sistema vigeva a Cremona (6 per cento nel 1608 e nel 1612) (MERON 1957 59n 63 JACOPETl1 1965 128) ea Verona Qui una delibera consiliare del 1549 autorizzava per la prima volta
[il deputati [alle Biadel [a] tassar e comandar con quelle pene che al Clarissimo Podestagrave pareragrave quella quantitagrave di biade a ciascuno secolare o eclesiastico sia di qual grado o condittione esser si voglia che havesse biade in questa cittagrave oltre il viver suo
(VOCCHIATO 1979 145)
La tassa sarebbe stata stabilita - da11558 - per sorteggio fra le casate che avessero introdotto in cittagrave dai propri possedimenti piugrave di 70 minali per rifo1llire il Mercato delle biave Essa-venne anche incrementata nella stessa occasione dal 5 al6 per censhyto per restare in vigore fino al 1631 (VECCHIATO 1979 141-58)
Quest9 tiIfo di normativa nasce e si affiogravea in ambito amministrativo perciograve echeggia la realtagrave molto meglio della veneranda legge generale
Da tali disposizioni si deducono alcuni fatti incontrovertibili 1entro la cerchia cittadina esistevano scorte private eccedenti la spesa delle famiglie
in violazione in molti casi della legge statutaria 2il possesso della terra che solo assicurava lautarchia delle casate era il piugrave-potente
fattore di discriminazione fra i cives tanto da precipitare nel girone dei pauperes la moltitudine che acquistava correntemente la sussistenza nellarea urbana
3fra gli stessi possidenti cittadini esisteva uneacutelite che non solo conservava scorte oltre il viver suo ma che si proponeva egoisticamente di speculare ritardando limshymissione dei grani sulle piazze cittadine o che a~endeva il momento piugrave opportuno per smerciarli allesterno nelle grandi piazze frumentarie come livorno Desenzashyno Legnago Romano (di Lombardia) ecc
4lineguaglianza fra i cives tese ad aggravarsi con la metagrave del 500 poicheacute questi reshygolamenti innovano quasi sempre disposizioni generali risalenti al tardo Medioevo che sancivano lobbligo di convogliare il surplus sulla piazza cittadina segno di una distribuzione del reddito originariamente meno sbilanciata A Cremona gli Statuti del 1388 obbligavano - cosl egrave ancora nel 1510 - a vendere il
sovrappiugrave in Piazza Maggiore sul mercato pubblico dei grani (MERON 1957 59n
63)A Pisa il rescritto che imponeva di effettuare le vendite al minuto in platea bladi
risale al 1401 MALANlMA 1976 293) lobbligo era ribadito ancora nel 1548 ma nella seconda metagrave del secolo XVI si affermava la pratica di vendere fuori mercato tanto che nel 1581 il Magistrato dei Nove dovette intervenire per far vendere i grani delle comunitagrave degli enti e dei luoghimiddotpii soltanto da marzo-aprile in piccole quantitagrave sul mercato (PULT QUAGUA 1984 81-91) La disposizione per altro si applicava allinteshyro Stato (PULT QUAGUA 1984 88)
Tuttavia non egrave da pensare che il principio della concentrazione delle compravendite sulla piazza di mercato cittadina fosse universale universalmente rispettato e sopratshytutto perenne La centralizzazione del grano non significa automaticamente lobbligo di vendita diretta sulla Piazza deiformenti Affermare come Steven L Kaplan che
There was no single more important regulation concerning tbe provisioning trade tban tbe requirement tbat alI transactions occur in tbe marketplace (KAPLAN 1984 27)
494 495 Renzo P Corritore
In ogni caso si tendeva a limitare al minimo indispensabile le importazioni di frushymento per evitare che stocks invendutigrave potessero turbare )a collocaziolle dei grani tershyrieri ileI nuovo anno agrario (GUENZI 1981 153)
In tutti i centri comunque la tendenza a ritardare la vendita del surplus nei mesi della saldatura lutilizzo di depositi specializzati con personale addetto alla custodia al conshydizionamento e alla commercializzazione del prodotto ponevano i grandi proprietari di biade su un gradino superiore e diverso rispetto al resto della cittagrave Laccantonamento di grani per questa cupola di possessori rispondeva al principio dellutilitagrave soggettiva atshytesa e richiedeva sia capitale fisso sia capitale circolante per raggiungere gli scopipreshyfissati un profitto speculativo la valorizzazione della rendita
In molte cittagrave i possessori non avrebbero dovuto trattenere in casa piagrave grano e farina di quantoprescritto dalla legge cioegrave il consumo mensile per bocca ~- fissato anchesshy
so statutariamente --per arrivare al nuovo raccolto Ma i cittadini credevano veramenshyte ai loro comandamenti Egrave lecito dubitare La norma era scogravelpitagrave negli Statuti e pubshyblicamente violatamiddot con la complicitagrave dccedillle autoritagrave e dei gruppi professionali interessati alla distribuzione del grano nelle sue varie forme
Nelle annate ordinarie la quota di grano autoconsumato - cioegrave non acquistata sul mercato - nelle cittagrave italiane dell evo moderno rappresentava fra il 30 e i160 per censhyto del fabbisogno urbano di frumento
Nella capitale dei Gonzaga nel 1615 si valutava che su 27000 bocche
il terzo [di] gentilhuomini ligravettadri servitori et altri [ ] non comprano biada et gli duoi terzi tra poveri artisti mercanti fomari fondachieri hebrei et altri [ l non possono in tutto levar sufficientemente la $omma de detti dua terzi sl che saranno boshyche 18000 che compraranno biada (CoRRlTORB 2000 126)
AVenezia a cavaliere fra XVI e xvn secoioalla mensa delle casade si dispensava circa un terzo del frumento consumato ordinariamente in cittagrave (AYMARD 1966 74 MArroZZI 1983 281) A Bologna per tutto il Seicento i fornai che impastavano farine in conto lavorazione per i particolari pareggiavano piil o meno il numero di quelli da scaifa che smerciavano pane venale (GUBNZI 1982 27) Peraltro la proporzione a Rialto tra chi lavorava per le casade e chi vendeva pane al pubblico - 65 fOf7lri a fronte di 44-48 pistori negli anni 1583-1685 (DELLA VAUNTINA 1992 143-4167 192-3) - fa ritenere la struttura del mercato del pane felsinea non molto dissimile da quella veneziana Nelle cittagrave liguri o toscane sei-settecentesche la porzione autoconshysumata quando il raccolto era buono era anche piil elevata (ORENOI 1986 1024-6 1034 PuLT QUAGLIA 1984 98-104 PULT QUAOLIA 1990 171-2) A Napoli nel 1758 a Monasteri Luoghi pii e Particolari eta riservato il 28 per cento del consumo cittadishyno di frumento (AuFANO 1996 370)
Lelevato numero di servi domestici persone al servizio delle casate faceva si che in alcuni palazzi si concentrassero masse cospicue di grano per la spesa familiare Ma accanto ad esse gli operatori dellannona -lastessapovertagrave __ si auguravano che vi fosse sempre anche la materia per rifornire il mercato e i forni cittadini nella fase piil delicata del ciclo annuale il periodo di saldatura dei raccolti Come spiegare altrimenshyti la norma che imponeva ai grossi detentori digrave biade (non esclusi enti e opere piegrave) in varie cittagrave italiane dellevo moderno la vendita straordinaria in primavera delle ecshyredenze ammassate in granaio (per Pisa e la Toscana v PuLT QUAGLIA 1984 88-9)
A Mantova nel 1554 si stabiliva che i patroni che avessero fruito in cittagrave di piugrave di 20 sacchi di grano come porzione dominicale avrebbero dovuto conservare in granaio
lA costituzione di SC0114 granarie pubbliche e la politica economica degli stati
il 4 per cento per le necessitagrave dei consumatori dei fornai e dei fontachieri quando fosse mancato il prodotto sulla piazza o nelle offerte deimiddotsensati Nel 1603 ci si preocshycupograve di elevare la quota al 6 per cento (CoRRlTORE 2000 237n) Beninteso le vendite sarebbero avvenute ai valori di mercato 10 stessa sistema vigeva a Cremona (6 per cento nel 1608 e nel 1612) (MERON 1957 -59n 63 JACOPETl11965 128) ea Verona Qui una delibera consiliare del 1549 autoruzava per la prima volta
[i] deputati [alle Biade) [al tassar e comandar con quelle pene che al Clarissimo Podestagrave pareragrave quella quantitagrave di biade a ciascuno secolare o eclesiastico sia di qual grado o condittione esser si voglia che havesse biade in questa cittagrave oltre il viver suo (VBCClI1ATO 1979 145)
La tassa sarebbe stata stabilita - dal 1558 - per sorteggio fra le casate che avessero introdotto in cittagrave dai propri possedimenti piagrave di 70 minali per rifornire il Mercato delle biave Essaveane anche incrementata nella stessa occasione dal 5 al6 per censhyto per restare in vigore fino al 1631 (VECCHIATO 1979 141-58)
Questccedil tijlo di normativa nasce e si affuia in ambito amministrativo perciograve echeggia la realtagrave molto meglio della veneranda legge generale
Da tali disposizioni si deducono alcuni fatti incontrovertibili 1entro la cerchia cittadina esistevano scorte private eccedenti la spesa delle famiglie
in violazione in molti casi della legge statutaria 2il possesso della terra che solo assicurava lautarchia delle casate era il piugravemiddotpotente
fattore di discriminazione fra i cives tanto da precipitare nel girone dei pauperes la moltitudine che acquistava correntemente la sussistenza nellarea urbana
3fra gli stessi possidenti cittadini esisteva uneacutelite che non solo conservava scorte oltre il viver suo ma che si proponeva egoisticamente di speculare ritardando limshymissione dei grani sulle piazze cittadine o che a~endeva il momento piagrave opportuno per smerciarli allesterno nelle grandi piazze frumentarie come Uvorno Desenzashyno Legnago Romano di Lombardia) ecc
4lineguaglianza fra i cives tese ad aggravarsi con la metagrave del 500 poicheacute questi reshygolamenti innovano quasi sempre disposizioni generali risalenti al tardo Medioevo che sancivano lobbligo di convogliare il surplus sulla piazza cittadina segno di una distribuzione del reddito originariamente meno sbilanciata shyACremona gli Statuti del 1388 obbligavano - cosl egrave ancora nel 1510 - a vendere il
sovrappigraveagrave in Piazza Maggiore sul mercato pubblico dei grani (MERON 1957 59n 63)
A Pisa il rescritto che imponeva di effettuare le vendite al minuto in platea bladi risale al 1401 (MALANIMA 1976 293) lobbligo era ribadito ancora nel 1548 ma nella seconda metagrave del secolo XVI si affermava la pratica di vendere fuori mercato tanto che nel 1581 il Magistrato dei Nove dovette intervenire per far vendere i grani delle comunitagrave degli enti e dei luoghi pii soltanto da marzo-aprile in piccole quantitagrave sul mercato (PULT QUAGLIA 1984 8191) La disposizione per altro si applicava allinteshyro Stato (PULT QUAGLIA 1984 88)
Tuttavia non egrave da pensare che il principio della concentrazione delle compravendite sulla piazza di mercato cittadina fosse universale universalmente rispettato e sopratshytutto perenne La centralizzazione del grano non significa automaticamente lobbligo di vendita diretta sulla Piazza deiformenti Affermare come Steven L Kaplan che
There was no single more important regulation conceming the provisioning trade han the requirement that ali transactions occur in the marketplace (KAPuN 1984 27)
493 496 Renw P Corritore
appare altrettanto astratto dogmatico O virtuale del principio di mercato (Market Principle) che il medesimo gli contrappone Henri Pirenne parlando della politica annonaria dei comuni medievali avverte Lapplicazione del principio della vendita diretta ebbe numerosi eccezioni (PIRENNE [1933] 193n)
Nel caso di Mantova la scelta della Piazza egrave facoltativa per i terrieri con eccedenze GliStatuti signorili che si rifanno largamente alle raccolte statutarie comunali non sancivano alcun obbligo in proposito (v SYJI1l BONACOLSlANI [1313] libro ID rubr 55 De mercato blave 253 STATUTI GoNZAOHESCHI [1404] libro m rubr 93 De mercato blave fiendo in civitate Mantue f 73v) Decreti di carattere straordinario e regolamenshytazioni transitorie correggevano il tiro Nel 1405 in piena saldatura dei raccolti si coshystrinse a rifornire forzosamen~e la piazza concentrandovi tutte le contrattazioni Nel 1417 si obbligograve a riservare al mercato un terzo del frumento introdotto in cittagrave (CoRRIshyTORE 2000 235-6) Ma sono atti straordinari che non sopravvissero nel migliore dei casi piugrave di qualchelustro (MANToVA 1430 88 90 181) A Mantova la Piazza era affianshycata da un granaio pubblico la Domus del mercato (altrove definito Fornico o Fontego del mercato) in cui avrebbero dovuto prolungarsi le contrattazioni oltre lorario e i giorshyni deputati (venerdl o sabato) rendendo disponibile ciograve che restava invenduto e che non poteva essere ritirato per legge dal mercato Nel 1430 eminenti cittadini sollecitati dal principe lamentavano pero lincapacitagrave del magazzino - inoperoso in tutto o in ~per il pericolo di crolli - di rispondere ai bisogni del popolo in una situazione in cui da parte dei possessori si protestava la difficoltagrave di non poter esitare e smerciare fuori delshyla cittagrave le eccedenze conservate nei solari privati
ltem videtur quod valde utille foret civibus Mantue habentibus possessiones et quishybuscumque alijs personis de civitate Mantue aut districtu colligantibus bIada et vina in magna copia ut amni tempore ipsa bIada et vinum possent exttahere de civitate et dishystrictu Mantue et conducere ad Iaea ad que et in quibus illa vendere poterunt cum otdigraveshynibus et dacijs competentibus ipsa tamen civitate semper remanente fulta pro usu diete civitatis et populi eiusdem ne dicta bIada mateeschant super granariis ut hactenus fecemiddot runt cum maximo incomodo ipsorum civium (MANToVA 1430 177-8)
Il medesimo fondaco abbinato al mercato operava a Verona a Ferrara a Venezia a Udine a Chioggia in molte altre cittagrave (MANToVA 1430 100 FORNASIN 1999 7-9 CBshySTARl1794)
Lintegrale e pedissequa applicazione del principio della piazza di mercato comporshytava - per i vincoli tecnici dell etagrave pre-industriale -la massima affermazione del prinshycipio della canova cioegrave del magazzino pubblico centrale Unico argine alla sua invashydenza era costituito da una distribuzione perequata ab imis del raccolto cioegrave la possibilitagrave egrave questo il paradosso di realizzare da parte dei produttori la massima aspirazione nelle societagrave tradizionali lautarchia domestica Piugrave avanzava invecela sperequazione nel reddito e nel patrimonio piugrave da parte dei consumatori privi di scorshyte si impetrava il principio del Magazzino pubblico nella forma di un efficiente sisteshyma di ricovero conservazione distribuzione delle derrate a garanzia del funzionashymento della Piazza di mercato La disponibilitagrave di crescenti quote di raccolto tuttavia indirizzava i piugrave accomodati verso soluzioni piugrave ghiotte la vendita allingrosso sul mercato cittadino ai fornai o allimpresa pubblica creata a sussidio di questi (o in loro vece) Oppure allopposto lesito delle eccedenze extra muros sui grandi mercatishyemporio regionali per il tramite di mercanti o agenti diretti
Il principio del magazzino pubblico centrale cioegrave laccumulazione di riserve per lo smercio continuo o anticiclico egrave quindi alla sua origine in opposizione solo apparen-
La costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
ruoli fiscali non fossero in grado di accantonare scorte Nel 1444 a Strasburgo quattro cittadini su dieci non possedevano alcuna riserva cerealicola (DIIUMBIER 1984 112)
Nelle cittagrave italiane delletagrave moderna si puograve stimare che non meno di due terzi della popolazione fosse costretta ad acquistare o consumare pane confezionato con grani e farine comperati nelle piazze nelle vie e nelle botteghe cittadine oppure ottenuti come compenso del proprio servizio nelle casate (CoRRITORE 2000 126-36 MAnoZZI 1983 27~-82) Evidentemente questa fascia di lavoratori salariati non possedevashyper definizione -- neacute scorte neacute depositi personali e nel primo caso era strettamente dipendente dal mercato urbano acquistando la sua sussistenza con frequenza non piugrave che settimaIIgraveale (essendo costretti a comprare il pane tutti i giorni alla finestra si dishyceva a Genova (GRENDI 1986 1031])
Ma anche fra i citUutini con possesso extra moenia la distribuzione delle scorte era tuttaltro che egalitaria A Prato nel 1339
A patte gli enti religiosi sette famiglie [ bull ] avevano Il disposizione piugrave di mille staia di granaglie (circa 18 tonnellate) fino a un massimo di 3500 Altri venti nuclei familiashyri avevano scorte comprese tra le SOOe le 1000 staia (PINTO 1978 129n)
A Mantova nei magazzini ducali nellultima parte del 500 erano ammassati non meno di un ottavo talora piugrave di un quarto delle riserve cittadine di grani panificabili (CORRlTORE 2000 81c6) A Pavia nel corsq dello stesso secolo e allinizio di quello successivo nei sozagraveri di una sessantina di famiglie si concentrava non meno del 40 per cento dell intera offerta cittadin8 di frumentomiddot (ZANJin 1964 70-7) Anche in questo caso egrave utile sapere che nelle cittagrave tedesche esistevano mercanti (ad Augusta Ratisboshyna Norimberga) in grado di ~sare riserve da 6 a 45 tonnellate e che a Francoshyforte nel 1488 due patrizi totalizzavano insieme un terzo delle scorte cerealicole dei particolari nella cittagrave alta (DlRLMB1ER 1984113)
Ritenere tali soggetti sprovv~duti al punto di incanevare grani con il solo scopo di esorcizzare i pericoli della clarestia egrave perlomeno riduttivo A grandi solari corrishyspondevano vaste familiae e plftore di servitori e ospiti ma tali scorte eccedevano largamente la sussistenza del D-aggiore palazzo nobiliare o patrizio senza peraltro costituire un fondo di accantofilljnento eccedente il fabbisogno della cittagrave a meno che non vi fosse la concreta possibfjitagrave di commercializzare il surplus sui mercati esteri Come nota infatti Adam Smith
a meno che leccedenza non possa essere esportata in tutte le circostanze ordinarie i coltivatori staranno molto attenti a non produrre e gli importatori a non importare mai una quantitagrave maggiore di quell~ che egrave strettamente richiesta dal consumo del mercato interno Questo mercato saragrave difficilmente sovrafornito ma saragrave in generale sottomorshynito dato che coloro che svolgono lattivitagrave per mornirlo avranno in generale il timore che la loro merce possa rimane~ invenduta (SMITH[l776] 528)
Lipotesi egrave suffragata dai cas storici conosciuti A Bologna macrodistretto serico dellevo modemoladdove gli interessi manifatturieri e mercantili avrebbero dovuto consigliare una sussistenza a b~on mercato per tenere basso il costo del lavoro le istituzioni annonarie operavano per-garantire con il calmiero delformento la monetizshyzazione della rendita granaria dei possidenti - strutturalmente incapace di coprire il fabbisogno della cittagrave - anche ~ rischio della carezza dei viveri contingentando il mercato dei grani forestieri (GupaI 1982 37-76) Di fatto
492 Renzo P COITitore
Tale disparitagrave sociale si riverberava sulla struttura del commercio cerealicolo La funzione dei piccoli commercianti di biade (granaiolibull biadaiolifarinaioli balshy
zarotti cavallanti vatlcali ecc) era infatti ancillare alla capacitagrave di affacciarsi sul nercato della fascia marginale deipossidenti con eccedenze Solo che nelle annate di abbondanza si venficavano ingorghi nell offerta di grano che deprimevano i prezzi e incentivavano i piccoli produttori a smerciare direttamente le eccedenze allindomani del raccolto nellarea urbana anche al di fuori dei luoghi deputati (MATI02ZI 1983 278281-2 300n PULr QUAGLIA 1984 86) Mentre nelle annate di penuria si contraeshyva drasticamente proprio questo segmento dellofferta (ABa [1966Jmiddot 22-4 KULA [1962J 73-4 CATrINI1984 111-23 PuIr QUAGUA 1984 88) scatenando nelle campashygne una caccia al grano-merce la cui quota piugrave consistente era detenuta dai grandi proprietari dai maggiori affittuari dai percettori di canoni diritti o rendite in grano e la cui quota residua era piugrave facilmente preda di chi occupava posizioni chiave nellasshysetto terriero nella catena dei diritti nel credito alla produzione e al consumo
Tanto la distribuZione era frammentata nelle annate di abbondanza tanto in epoc~ di penuria il commercio del grano diventava un affare di pochi In questo caso lazioshyne dei mercanti diVentava dimpiccio sul mercato interno dove la coperta si restringeshyva per i proprietari e gli imprenditori agricoli (KULA [1962] 56-61 CATl1NI 1984 114-8) - dove la necessitagrave di ricorrere al credito da parte dei piccoli possessori poneva questi nelle mani degli agenti dei proprietari dei percettoridi canoni diritti o rendite - dove i piccoli proprietari vedevano minacciata la loro stessa condizione da parte di chi controllava localInente in maniera capillare e decentrata il mercato del denaro e dei beni necessari alla riproduzione (sementi strumenti cibo) La soluzione era quelshyla di precludere amministrativamente ai sensali e ai commercianti di grani i mercati locali su istigazione dei medi possessori le cui occasioni di normale profitto agrario soffrivano un ridimensionamento e che si vedevano costretti a impegnarsi ccedilon tutte le loro forze per integrare le proprie entrate accaparrandosi le magre eccedeiiZe disponishybili nelle campagne e nei borghi rurali (PuLT QUAGLIA 1984 84-8 PULT QUAGLIA 1990 lO7-14)
TI destino dei piccoli commercianti in grano era quindi quello di occupare una posishyzione margilJale nel mercato del grano (MBlNrurr 1977 30 PINTO 1978 13 MAITOZZl 1983 277) e di operare - non solo a causa degli ordinamenti annonari - secondo una logica di corto respiro in cui non era contemplata neacute la conservazione di grani a lungo termine neacute lutilizzo di depositi piugrave che provvisori Come per i piccoli possidenti non si puograve parlare ne1loro caso della formazione e del mantenimento di scorte consistenti (MBlNREr 1988 156~7) Non tali comunque da sostenere il reddito contadino nelle stagioni ordinarie e da esercitare sul versante cittadino unefficace azione anticonshygiunturale in caso di carestia
Peraltro in cittagrave la struttura dellofferta era anche piugrave sperequata di quella che si rishyscontra nel contado Che si tratti di Prato nel 1339 (PINTO 1978 129 PINTO 1982 160n e 17In) Pavia negli anni 1539 1555 1513 1602 1603 (ZANEm 1963) o Mantova nellultima parte del secolo XVI (CORRITORE 2000 81-9) la distribuzione delle scorte fra i privati era singolarmente ineguale Lo attesta la rilevanza nellarea urbana della povertagrave cioegrave secondo una definizione coeva di coloro che non vivono di entrate ma sono necessitati ricorrere mattina e sera alle pistorie a comprare il pane per iI vitto loro e delle sue famiglie col denaro che di giomo in giomo si vanno guadagnando (MATshyTOZZI 1983 281) PUOgrave essere utile richiamare la situazione delle cittagrave tedesche nel basso Medioevo in una fase che egrave stata definita da Wilhelm Abellepoca doro degli artigiani e del lavoro salariato si puograve stimare che almeno la metagrave degli iscritti ai
lA costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli statibull middot497
te con il principio della piazza TI mercato pubblico periodico disciplinatola spiagshygiala piazza la loggia o iI recinto riservato alle contrattazioni - coesis~va confabshybriche magazzini e botteghe La stessa piazza per funzionare al meglio secondo il principio dello scambio diretto necessitava di magaZzini di supporto bull
4 LE SCORTE DEI FORNAI CITTADINI
Nellarea urbanagrave e nelle relazioni tra cittagrave e campagna operavano perograve temibili conshycorrenti dei privati possessori I fornai cittadini possedevano le competenze le strutshyture tecniche le relazioni sociali e il credito per incettagravere il prodotto per essere inforshymati tempestivamentesul mercato del grano e potenzialmente per dispensarlo con profitto in qualunque momento Il fatto che il loro operato fosse imprigionato in unarshycaica impalcatura di norme divieti obblighi che risalivano alletagrave romana che ne fashycevano in modo quasi istituzionalizzato il capro espiatorio delle tensioni fra produtshytori di grano povertagrave e autotitagrave non impedisce di affermare che tali vessatorie disposiziograveD1 trovassero la loro principale ragione dessere nella parte che essi giocashyvano di interlocutorilantagonisti dei proprietari terrieri nelladeterminazione del prezshyzo del grano sul mercato locale e nella realizzazione della rendita terriera (GUENZI 19824
35 GUENZI 1982 297) Neacutel caso di Mantova terra comucopia a partire dal 1492 si consend a zentilhomini
cittadini et qualuncho altro di comprare biade nel Dominio per approvvigionare la cittagrave di fatto si sand un diritto allincetta che mise fuori gioco i fornai a cui venne imposto di rifornirsi nei solarimiddotdei cittadini senza avere piugrave la possibilitagrave di effettuare acquisti nel contado e di ritenere a casa scorte superiori amiddotl 00 staia di frumento Lintento della disposhysizione egrave chiarissimo espresso senza reticenze dai Maestri delle Entrate che riportarono al marchese la soddisfazione dei possidenti mantovani per la riforma statutaria
tutta la Terra [cioegrave il Mantovano] ne [egravel rimasta satisfactissirna pensando che Vostra Excellenilii pretenda ali comodi et utilitagrave universagrave1e senza dampno et preuiditio suo Vero egraveche li fumari non si contentano parendoli comegrave il vero che non si poteranno ingrassar a suo modo come haqno factO per il passato et poteria achader [bulll Che venetanno adolershyse et supplicar aVosUa Signoria Perograve me egrave parso d~ene aviso per ques~ nostra et farli inteni1er Che questaterril ha solii due membri de li quali li cittadini soi se ne possono aiutashyre e valersene uno egrave il grano laltro egrave larte de la lana et quando se concedesse che li furshynari potessero comprare come hapno facto li tempi passati sana un fare benefitio acinquanshytaocto dessi et dampnificharelreslO de la republicasua quale de questo bon ordine ne receve emolumento grandissimo et se gaude in la Citagrave [percheacute] li fumari portano fuora el denaro et pretendono solo a suo benefitio (AG b 2441 lettera del 13 luglio 1492)
Egrave indubbio che il plauso della Terra fosse da attribuire piugrave alla possibilitagrave per i proshyprietari di accrescere le proprie entrate che a quella dei consumagravetori cittadini e dell arte della lana di trarre beneficio daJla disposizione Egrave significativo che la motivazione pro civitate nori accenni allesistenza di monopoli da parte dei fornai o di artificiose lievitashyzioni dei prezzi per causa lOro nloro attivismograve non egraveonfliggeva per quanto riguarda i prezzi finali della sussistenza con linteresse dei produttori cittadini E daltra parte largomentodello stomo dal metFato cittadino dei profitti incamerati dai fornai -laccushysa consueta a proposito deipistores egrave che fossero in gran parte stranieri (GUBNZl 19824
22) -- era unagiustificazione debole che appassionava piugrave chi concorreva direttamente
491 498 Renzo P Comtore
alla spartizione dei proventi derivanti dalla vendita e dal commercio del grano shylemolumento grandissimo - di chi doveva poi fruire della redistribnzione di tale ricchezza Tale norma avvantaggiava i possidenti cittadini e i gentiluomini ptivilegiashyti in grado di ottenere le tratte di esportazione Sul piano dellappropriazione essi erano in condizione di mettere fuori gioco gli altri possessori che producev~o eccedenze nel Dominio poicheacute si accresceva Igravea loro forza contrattuale e la loro capacitagrave di occUpare i canall commerciali piugrave redditizi Sul piano della commercialiZzazione gli stessi fruivashyno dello smantellamento della rete dintennediazione rappresentata dai fornai Per i rushystici significava perdere un collegamento essenZiale con la cittagrave ed essere emarginati dal mercato urbano nelle campagne o sul broletto di Mantova essi non trovarono piugrave i trashydizionali interlocutori (CORBlJ9RE 2000 228 231-2)
Nel caso di Bologna terra strutturalmente deficitaria e cittagrave dalla vocaiione manishyfatturie~ si costringeva i fornai ad acquistare formenti terrieri presso i solari privati in cittagrave proibendogligrave lincetta nel contado autorizzandoli ad acquistareformentiforeshystieri al di fuori delle mura cittadine presso i sensati da grqno solo a patto che fosseshyro stati smaltiti i grani cittadini a un prezzo talora superiore a quello dei grani dimshyportazione (GUlNZI1982A35 52-3)
Nella Toscana dei Medici il diritto allincetta nel contado venne concesso ai fornai in periodo di bassa congiuntura (in particolare dagli anni Trenta del Seicegravento)Per sostenere i prezzi interni in tal caso essi restavano gli interlocutori principali dei granshydi proprietari semplicemente spostando la loro principale fonte di approvvigionashymento dai solari dei particolari in cittagrave ai granai decentrati delle grandi aziende agrishycole oppure ai mercati rurali su cui affluiva la produzione cerealicola delle grandi fattorie (PuLT QUAOUA 1984 86-9 PuLTQUAOUA 1990 100 106-7)
Laddove non vi egrave come invece succede a Genova una diretta ingerenza del potere pubblico nella vita della corporazione (MAsSA 1999) i fumai di cittagrave - nonostante i lacci e lacciuoli normativi e il lavoro prevalentePlente manuale svolto neiloro laboshyratori - erano dei veri imprenditori dipendenti per il loro profitto - noininalmente stabilito per legge - dalla produttivitagrave del lavoro e dalla dotazione tecnica e finanziaria delle imprese Di ciograve fa fede la grande sperequazione esistente fra le aziende speciashylizzate nena fabbricazione del pane venale in cittagrave (AYMARD 1966 75 VECCHltltJQ 1979 82-3 GUlNZI1982 77 segg PuLT QUAOUA 1984 100 102-3) NellItalia delshyletagrave moderna questi artigiani-imprenditori della filiera del grano trattavano insieme
afarinaifarinaiolifarinottifondachierifontechierifidelariformentinari lasagneshyri maccaronari torallari vermicellari ecc fra il 40 e il 70 per cento del frumento consumato in Cittagrave nelle annate normali (CoRRJTORE 2000 126 segg) e ~ino al 100 per cento nelle annate di carestia (Puu QUAOUA 1984 98-9)
In una ricognizione delle asimmetrie informative del mercato non cegrave gruppo quale i fornai che possa integraverpretare la parte dell agente economico onnisciente Se dunque i regolamenti annonari tendevano a regolare minuziogravesamente la collocazione il volushyme e la durata delle loro scorte cosi come disponevano per gli altri artigiani della fishyliera era per neutralizzare il carattere potenzialmente eversivo di tale accantonamenshyto per i proprietari-venditori Prima ancora che per i consumatori-acquirenti n livello delle scorte rinforzava o attenuava il rischio di monopsonio da parte dei pistores piugrave potenti e facoltosi cosigrave come eventuali tentazioni da parte della categoria di esercitare un dominio egoistico sul mercato del pane (MAITOZZl1983 298)
Sarebbe quindi un errore concepire le scorte dei fornai come entropica allocazione di capitale che sconta lincertezza futura esse venivano gestite secondo criteri di rashyzionalitagrave economica e secondo la migliore efficienza tecnica nonostante i vincoli imposti alla lievitazione degli stock dalle disposizioni annonarie
lA costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
vimini paglia o canne intrecciate (come ceste stuoiecannizzi) in terracotta (addirittura anfore) piuttosto che di tessuto (i sacchi costavano troppo) (PICCINNl1976 397 MAzzA RAvEGol 1983 174-5 Zoo Toce 1990 893-4 COIiITONES11991 35n-36n)
Nella casa del piccolo produttore o del titolare di un piccolo possesso il penw (la scorta domestica) difficilmente eccedeva il consumo famigliare chi fortunato raccoshyglieva piugrave dell annona famigliare e di quanto gli serviva per il campo era spinto a venderselo nei mesi immediatamente successivi alla mietitura e alla trebbiatura per necessitagrave di denaro ma anche per la difficoltagrave di stoccare e conservare il prodotto in condizioni ottimali (MEuvRET 1988 17-9 PuLT QUAOUA 1984 88) e figravenanco per ridurre il rischio di vederselo soffiare da vagabondi e malintenzionati In questo caso in presenshyza di eccedenze (ma probabilmente anche in assenza) il bisogno di liquiditagrave e lalea cospiravano nel ridl1ITe ai minimi termini le scorte giagrave allindomani del raccolto In caso alternativo il contadino che non egrave - ripete Jean Meuvret - un homme daffaires quanshyto un homme de peur concepiva la sua riserva come un fondo di previdenza sul racshycolto futuro da non immettere sul mercato se non nel caso dellapprossimarsi di una messe sicura secondo una logica economica a contrario (MEUVRET 1988 19 e 147)
Era Jl~tente la disparitagrave fra i produttori non solo fra chi era in possesso di eccedenshyze e chi non lo era ma piugrave anqgtra fra chi poteva scegliere in virtugrave di una maggiore capienza economica e unadeguata dotazione tecnica - il mercato piugrave favorevole per i propri grani (il periodo di saldatura dei raccolti) e chi invece li cedeva troppo presto o in controtempo a livelli non ottimali
Nella gerarchia delle abitazioni rurali -- in quel vero e proprio saggio di sociologia che egrave il sesto libro del DeArchitectura di Sebastiano Serlio (scritto fra il 1537 eil 1555 inedito per tutto levo moderno) -- per trovare case attrezzate di granaio occorshyreva ascendere sino alla magione del basso mercante o cittadino fuori della cittagrave (SERLlO 1994 43 segg anche per le successive informazioni) Condizione di cui non potevano fregiarsi invece i ricchi contadini in ~essuno dei tre gradi possibili di ricshychezza al massimo la loro casa poteva essere attrezzata di portici per ricoverare le biade e di unaia per batterle segni di distinzione giagrave fra i mediocri contadini Fra questi perograve avrebbero potuto avvalersene soltanto i fortUIgravelati et di beni et di famishyglia (3deg grado di mediocritagrave) nforno per cuocere il pane e una cantina per conservashyre il vino invece li si sarebbe trovati a partire dai piugrave accomodati fra i poveri contashydini cioegrave al 4deg gradino della scala sociale alla cui base erano da collocare i poveri mendichi con vii capanna (10 grado di povertagrave) i salariati che vivevano delle [loro] fatiche avendo un puoco di terreno (2deg grado di povertagrave) i poveri con qualche beshystiuola et massimamente de buOvi possessori di una stalletta congiunta con la casa 0deg grado di povertagrave)
In sintesi nelle campagne delletagrave pre-industriale pochi avevano scorte pochissimi erano in grado di ricoverarle in un solaro privilegiatissimo chi le incanevava per speculare Dunquefra i conta4ini se si esclude quanto celato nella madia o nella dishyspensa le scorte erano un pri~ilegio di pochi nSerlio nato intorno al 1475 insiste sullimpoverimento delle class~ rurali intervenuto fra gli anni della sua giovinezza e quelli della vecchiezza in cui scrive Sotto il titolo Dellabitazione del ricco contadishyno per tre gradi di ricchezza si preoccupa di puntualizzare
bencheacute al di dogi non se n~ truovi piugrave de tali merceacute delle discordie et di gli animi fieri et ostinati alla vendetta onde per tal cagioni et per le continue guerre et anche pei citadini divoratori de gli altrui beni che con le usure con glinganni con le rapine gli bano impoveriti (SERUO 1994 ~8)
490 RellOP CorrilOle
colto (agosto-settembre-ottobre) e invia di esaurimento almomento della saldatura dei raccolti (aprile-maggio-giugno )1A questo proposito nota Franccedilois Sigaut
Le stockage agrave court terme (moins dune campagne) reacutepond agrave la neacuteCessiteacute cIeacute concilier une offre variable et une demande constante mais toutes deux reacutegulieacuteres et preacutevisibles dans la
pratique il est consideacutereacute comme tiiisant pame du processus ordinaire de la production et ne pose agrave ce titre que desproblegravernes doptimisation assez simples (SlOAUI 1985 602)
La discussione generale sulla razionalitagrave economica delle scorte alimentari in etagrave pre-industriale puograve allora essere ridotta alla fonnulaiione e allo scioglimento di due
semplici quesiti 1 Accertato che laccantonamento digram per la periodicitagrave annuale del ciclo agricoshy
lo epet i vincoli tecnici di un rifomimento spazialmente allargato egrave inevitabile chi egrave conveniente che conservi le scorte chi produce o chi commercia il contadino o il mercante lapossidenzagrave o il popolo i particolari o il pubblico E qual egrave la realtagrave effettiva
2 Se le forme di distribUzione economicamente razionale sono plurali in quale conshytesto e in omaggio a quali interessi piugrave utile il sistema della canova rispetto al sistema delll piazza del mercato e dei solari privati
3 SULLADISTRIBUZIONE DEL GRANO NELUETAgrave PRE-INDUSTRIALE E LA STRUTTURA DELLE SCORTE NEI TERRITORI ITALIANI
Raramente le case contadine erano dotate di attrezzature per la conservazione dei cereali piugrave che elementari Nelle campagne toscane del Quattrocento dunquein unetagrave favorevole al reddito contadino in una regione fra le piugrave ricche dellEuropa pre-indushystriale
pochissime case contadine disponevano del granaio vero e proprio alcune avevano una cella che poteva servire allo stesso scopo ma la maggior parte di quelle abitazioni era priva di spazi destinabili esclugravesivamente alla conservazione dei cereali Perciograve i contenitori dei grani arche casse sacchi bugnole - dovevano trovare posto nelle cucine o nelle camere CMA= RAVEGGI 1983 174)
Le ridotte capacitagrave patrimoniali e reddituali della grande maggioranza dei produttori facevano sIgrave che fosse ampiamente invalso nella conservazione domestica dei grani limshypiego di contenitori in legno (come arche casse botti bugnole tini tinelle corbelli)in
Riguardo ai passi evidenziati di Zanetti e Cipolla egrave neCessario osservare che la principale atteshystazione sullesistenza di stock detenuti da privati che esorbitassero ilfabbisognostagionale tali da essere classificati come immobili=zione di ricchezza (Zanetti) o come beni capitale (Cipolla) a unanalisi piugrave fine si rivela fallace o non direttamente utilizzabile La propalazione dei grani effetshytuata a Pavia fra ilimiddot e il5 maggio 1555 che egrave il fondamento di entrambi i giudizinon mostra una somma di derrate realmente eccedente il fabbisogno delle famiglie per il periodo che manca allarri_ vo dei grani novelli sulla piazza pavese Daltra parte lastessa natura dellistituto della propalazioshyne dei grani cioegrave della denljncia obbligatoria delle scorte da parte dei particolari una misura demergenza decisa in momenti critici dellapprovvigionamento cittadino affiancata quellanno dalshylispezione diretta presso le case dei privati da parte di deputati straordinari avrebbe dovuto consishygliare una maggiore cautela nella sua utilizzazione per individuare regolaritagrave di carattere generale delleconomia pre-industriale
499 La costituzione di scorte granarie pubbliche e la ptlitica ecoMmica degli stati
FONTI
ABEL [1966) W ABEL Agrarkrisen undAgra~kJJnjunktur Eine Geschichte der londshy und Erniihrungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter Hamburg
und Berlin Paul Parey 19662 (la ed -1935 trad it Congiuntura agraria e crisi agrarie Storia dellagricoltura e della produzione alimentare nellEuropa centrashyle dal XIII secolo alletagrave industriale Torino Einaudi 1976 da cui si cita)
AG ARCHIVIO GoNZAGA presso lArchivio di Stato di Mantova AuFANO 1996 E AuFANO Il grano il pane e la politica annonaria a Napoli nel Setshy
tecento Napoli ESI 1996bull AYMARO 1966 M A YMARO Wmise Raguse et le commerce du bMpendant la seconde
moitieacute du XVI siegravecle Pans SEVPEN 1966 CATIINI 1984 M CATl1NI I contadini di San Felice Metamorfosi di un mondo rurale
nellEmilia delletagrave modernIgravel Torino Einaudi 1984 CESTARl 1794 p CESTARI Saggio storico dei Fondachi delle farine di Chioggia e
Pellestrina Venezia A Zatta 1794 CIPOllAJ1965] C M CIPOllA La politica economica dei governi V La penisola
italigraveana e la penisola iberica in Storia economica Cambridge m La cittagrave e la politica economica nel Medioevo Torino Einaudi 1977 (Cambridge 1965) pp 462-496
CIPollA 1974 C M CIPollA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna nMulino 1974
CIpollA 1997 C M CIPOllA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna nMUlino 1997 (6 ed riveduta)
CORRITORE 2000 R P CoRRITORE La naturale abbondanza del Montovano Produshyzione mercato e c01isumi granari a Mantova in etagrave moderna Pavia Universitagrave di Pavia 2000
CORIONBSI 1991 A CORIONBSI Sulla conservazione dei cereali nellItagravelia medioevale Lavoro e tecniche nelle tesnmonlanze laziali (secc XIII-XV) in Rivista di storia dellagricoltura XXXI 1991 l pp 33-49
DELLA VALENTINA 1992 M DELLA VALENTINA I mestieri del pane a ~nezia tra 600 e 700 in Atti dellIstituto [Veneto di Scienze Lettere ed Arti Classe di scienze morali lettere ed arti CL 1991-92 pp 113-217
DIRLMEIER 1984 U DIRLMEIER le condizioni materiali dellesistenza nelle cittagrave tedeshy sche del Basso Medioevo ~iente esterno reddito consumi in Aristocrazia citshy
tadina e ceti popolari nel tprdo Medioevo in Italia e in Germania (a cura di Reinhard Elze e Gina Fasoli) Bologna Societagrave editrice il Mulino 1984 pp 79shy122
FORNASIN 1999 A FORNASIN Il pzercatodei grani di Udine Indagine per una storia dei prew in Friuli (secoli XfI-XVIII) Nota di ricerca del Dipartimento di Scienshyze Statistiche dellUniversit4 degli Studi di Udine 4 1999 pp 1-24 ora in lo La Patria del Friuli in etagrave 1fIOderna Saggi di storia economica Udine Forum 2000 pp 33-60
GRENDI 1986 E GRENOI Lapprccedilwigionamento dei grani nella Liguria del Seicento libera pratica e annone in iMiscellanea storica ligure Studi in onore di Luigi Bulferetti XVIII 1986 2Jp 1021-1047
GUENZI 1981 A GUENZI Ilfrurnfnto e la cittagrave il caso di Bologna nelletagrave moderna in Quaderni storici XVI ~981 46 pp 153-167
GUENZI 1982 A GUENZI Pane ~fornai a Bologna in etagrave moderna Venezia Marsilio 1982
I
489 500 Renzo P CornIOle
GUBNZI1982 A GUEml Sistema annonario e egraveontrollo sociale a Bologna nei seccediloli XVII e XVIII in E SORI (a cura di) Cittagrave e controllo sociale in Italia fra XVIII e XIX secolo Milano F Angeli 1982 pp 293-306
HICKS [1989] 1 R HIClCS A narlcet theory of money Oxford Oxford Universigravety Press 1989 (trad it Una teoria di mercato della monefa Bologna li Mulino 1992 da cui sigrave cita)
JACOPBITI 1965 N L JACOPBITI Monete e prezzi a Cremona dal XVI al XVlIi secolo Cremona Athenaeum CregravemoneJlSe 1965
KAPLAN 1984S L KAPLAN Provisioning Paris Merchants and Millers in the Grain and Flour Trade during the Eighteenth Century Ithaca-London Cornell Univershysity Press 1984~middot
KULA [1962] W KULA Teoria ekonomiczna ustrojufeudalnego Proba modelu Warshyszawa-Panstwowe WydawnictwoNaukowe 1962 (trad it Teoriagrave economica del sistema feudale Proposta di un modello Tormo EinaUdi 1972 ccedilla cui si cita)
WROUSSE [1933] C-E LABRoussE Esquisse du mouvement des prix et des reverws en France au XVIII siegravecle Paris Eacuteditions des Archives Contemporaines 19842 volI (l ed Paris Librairie Dalloz 1933)
MALANtMA 1976 P MALANiMA Aspetti di mercato e prezzi del grano e della segalea Pisa dal 1548 al 1818 in Ricerche di storia moderna vaL I Pisa Pacini 1976 pp ~n
MANToVA 1430 MwroVA 1430 Pareri a Gian Francesco Gonaga per il governo (a cura di M AQrignaniA M Lorenzoni A Mortari C Mozzarelli) MUltova G~ Arcari 1990
MASSA 1999 PMAssA Annona e corporazioni del settore alimentare ~ Genova orshyganizzazione e conflittualitagrave (XVI-XVIII secolo) in A GUENZI PMAssA A MOIOshyu (a cura di) Corporazioni e gruppi professionali nellItalia moderna MilIllO F Angeli 1999 pp 390-403
MATIoZ7J 1983 1 MiJroZ7J F BOLELLI C CmAsBRA D SABBIONI Il politico e il pane a Venezia (157Q-1650) calmieri e governo della sussistenza in Societagrave e storia VI 198320 pp 271-303
MAzzI RAVEOOI 1983 M T MAzzI S RAVEOGI Gli uogravemini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento Firenze Olscbki 1983
MERONI 1957 U MERONI Cremona fedelissima Ciemona Athenaeum Cremonenshy~~~ _
MBUVRBl 1977 J MEuVRsT Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque LouisXIvI La productiograven des ceacutereacuteales dans la France du XVII et du XVIII siegravecle Paris Mouton -EacuteEHSS19772voll
MBUVRET 1988 J MBtJVRf Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque Louis XIv III Le commerce des gralns et la conjoncture Paris EacuteEHss 1988 2 volI
PtCClNNI 1976 G PtCClNNl Wta contagravedina in una capanna dei dintorni di Siena (1250) in ~Archeologia medievale m 1976 pp 395-399
PlNIO 1978 G PINTOII Libro del BiaPaiolo Carestie e annona a Firenze dalla metagrave del 200 al 1348 Fire~ Olscbki 1978
PiNTO 1982 G PtNro La Toscana nel tardo Medioevo Ambiente economia rurale societagrave Fllenze Sansoni 1982
PtRENNE [1933J H PIRENNB La civilisation occidentale au Moyen Age du XIe au mishylieu du XVe siegravecle Paris PUF 1933 (trad it Storia economica e sociale del Meshydioevo Milano Garzanti 1967 da cui si cita)
Lacostituticne di scorte granarie pubbliche e la politica economiegravea degli stati
redigravestribuzione sostenibile dei beni di sussistenza egrave ricercata in questo cielo da quegli stessi particolari che ~amaldeggiano nella produzione negli scambi nei consumi e che costituiscono il nerbo della classe di governo Le scorte pubbliche rappresenteshyrebbero in questa prospettiva un presidio civico e un risltCimento politico e morale ai cOl1ponenti della comunitagrave spossessati delbene supremo dellautarchia alimentare
Resta infine latente unidea del magazzmo pubblico come quasi-mercato cioegrave come luogo volto (1) a risolvere i fa1limentiinfo~vi della piazza del mercato (in meacuterito alle disponi~ilitagrave alle caratteristiche del prodotto alle condizioni di vendita della merce) (2) a ridimensionare lalea per agricoltori consumatori poveri artigiani del comparto alimentare (3) a sostenere i consumi e i profitti privati m funzione anticicli ca in una prospettiva Ilpn meram~nte congiunturale Si tratta in questo caso di un orshyganizzaZionepienattiCnte razio~e Che non opera in maniera saltuaria e riflessa ma in modo continuativo secondo obifttili prefissati di allocazione dei beni primari li funshyzionamento dellacanovagrave (il magazzino pubblico) si porrebbe come strumento inteshygrativo ma no~~igraventeramente so~titutivo delloperare della piazza Si tratterebbe di unaforma di mercato distinta dalla p~ del mercato considerata in seacute e per seacute cosigrave come dallegraveOOmpravendite effetttlate nei solari privati o dalla mera centrallzzazione e redistribuzione di derrate con fi~alitagrave umanitarie La canova rappresenterebbe in tal modo uno dei possibili meccaoi~ di governo delle trllls3ZIgrave~ni locali per risolvere i problemi deUapprovvigionameIto senza intaccare certi interessi di classe (dei proshyprietari ma anche del popolo grasso) S da essere prescelta da autoritagrave e gruppi domishynanti come struttura complementare della piazza del mercato incerti contestiprodutshytivi ed economici La suasacrilizzazione perciograve non esclude la possibilitagrave di un ritorno alle sole compravendite qella piazza e dei solari privati - una volta invertishytosi il trend o spirate le condizioqi economiche della sua istituzionalizzazione
La problematizzazione esorc~ una liquidazione semplicistica del problema delle scorte gran8rle in etagrave pre-industriUgravee nel nome di una loro presunta irrazionalitagrave eco- nomica per il compito di assi~ la sussistenza della popolazione
Le pagine che segUono sono rintroduzione a un lavoro in corso volto a offrire un interpretazione generale di tal~ capitolo fondamentale della politica economica dei governi
in
etagrave pre-industriale
2 SE UN MONDO SENZA SCORTE Egrave INCONGRUO cm Egrave OPPORTUNO CHE LEgrave DETENGA
Nei fatti nel settore granarlo CQni vincoli dell etagrave pre-industriale in tema diprodutshytivitagrave energia trasporti non ha s~nso ipotizzare un mondo senza scorte Se il mercato del grano egrave - come nellEuropa medievale e moderna - un sjstema tendenzialmente chiuso
ad ogni raccolto nuove offe~ aniv(erannol sul mercato mentre la domanda si mant[erragrave] relativamente costantt nel corso dellanno Qualcuno dunque [dovragrave] ~ere delle scorte che saranno elevate ~ubito dopo il raccolto e poi via via minori fino aragshygiungere un livello minimo in prpssimitagrave del successivo raccolto (HICICS [19891 31)
Nella loro forma piugrave sempliceI tali scorte saranno legate allora alla periodi~itagrave anshynuale del ciclo agricolo (che a1iplenta il movimento stagionale dei prezzi ccedilfr LAshyBROlJSSE [1933] 157-66) il loro livello saragrave elevato allindomani del principiLle racshy
501 488 Renzo P Corritore
povero ammassograve nella propria dimora scorte di grano carne ~alata sale candele ecc e la medesima cosa fece lo Stato Nel periodo feudale non venne mai meno nel castello del signore labitudine di tenere da parte grosse scorte per i periodi di emergenza Sucshycessivamente le autoritagrave comunali predisposero il magazzinaggio di grosse derrate specie di grano da rivendere a basso prezzo in periodi di emergenza e nello stesso tempo si preoccuparono di prevenire un indebito accumulo di scorte da parte di specushylatori privati Nelle economie medievali gli stock di derrate di prima necessitagrave rappreshysentarono pertanto una delle piugrave importanti forme di investimento pubblico e privato (CIPOLLA (1965] 468)
Nella prima versione del manualeacute invece fino allinserimento nel 1997 del nuovo capitolo dedicato alla politica economica nell etagrave pre-mdustriale il punto di vista preshyvalente era quello microeconomico entro il perimetro stretto dellindividualismo meshytodologico
Le scorte costano e costano doppiamente Esse implicano il costo diretto che egrave rapshypresentato dal costo del magazzinaggio edal deterioramento eventuale del pr04otto o di parte di esso Se luomo daffari finanzia la costituzione delle scorte con danaro preso a prestito il costo diretto include anche il tasso di interesse pagato Se luomo daffari finanzia con capitale proprio la costituzione delle scorte il costo delle scorte deve inshycludere un costo-opportunitagrave e cioegrave il mancato rendimento (tIllU1cato tasso dinteresse attivo) del capitale finanziario impiegato (CIPOLLA 1974 154)
Le ragioni della costituzione e del mantenimento di scorte alimentari da parte delshylautoritagrave pubblica diventavano unicamente ragioni morali (umanitarie e di buona amministrazione) o di opportunitagrave politica (la fame era la piugrave frequente ligraveausa di sommosse e furori popolari) (CIPOLLA 1974 74)
Nel 1997 si riammetteva dunque linterpretazione originaria della costituzione di scorte pubbliche come strumento di riequilibrio del mercato senza peraltro rinnegare le considerazioni sulla valenza statica di tale forma di investimento per gli agenti economici privati
In merito allutilitagrave economica e al significato delle scorte in etagrave pre-industriale Cishypolla non espresse perciograve sempre lo stesso punto di vista La rassegna delle posizioni da lui assunte anzi permette di individuare tre approcci e tre giudizi costitutivamente diversi sulla funzione delle scorte granarie nellepoca pre-industriale
In prima approssimazione laccumulazione di scorte alimentari mostra il carattere fondamentalmente difensivo delle scelte degli agenti economici pubblici e privati in etagrave pre-industriale La paura la tradizione la superstizione li induce a tabuizzare il rischio la speculazione linvestimento nella produzione e nella distribuzione dei beni essenziali alla vita e ad aderire intimamente a un ideale di economia e societagrave stazionarie aggravando con la norma sociale le istituzioni il comportamento indivishyduale e collettivo leffetto dei condizionamenti materiali delleconomia pre-industriashyle (bassa produttivitagrave agricola alti costi di v~sporto modesta efficienza energetica) esponendo ancor di piugrave la comunitagrave umana ai degravemoni della natura
La seconda interpretazione rigetta luniversale imperio dellhomo oeconomicus rishyscoprendo leteronomia dei fini dellagire economico degli uomini nelletagrave pre-inshydustriale Ia politica economica dello Stato o-delle autoritagrave non persegue puri scopi economici lintegritagrave del corpo sociale fin nelle sue cellule elementari (persone e famiglie) deve essere assicurata secondo i principi e la prassi di uneconomia morale che SOVJa5ta leconomia regolata dal mercato spersonalizzata e antipopolare Una
La costituzione di scorte grantlTie pubbliche e la poligravetigraveca economica degli stati
PuLT QUAGUA 1984 A M PULT QUAGUA Mercato dei prodotti agricoli e magistratushyre annonarie a Pisa nelletagrave moderna in Ricerche di storia moderna a cura di M Mirri voI III Pisa Pacini 1984 pp 57-141
PULT QUAGLIA 1990 A M PULT QUAGLIA Per provvedere ai popoli Il sistema anshynonario nella Toscana dei Medici Firenze Olschki 1990
SERUO 1994 S SERLIO Architettura civile Libri sesto settimo e ottavo nei manoscritshyti di Monaco e Vienna (a cura di F P Fiore) Milano TI Polifi10 1994
SIGAlIT 1985 F SIGAlIT Questions deacuteconomie agrave propos des politiques ceacutereacutealiegraveres et de stockage in Les techniques de conservation des grains agrave long terme leur rale dans la dynamique des systegravemes de cultures et des socieacuteteacutes (sous la direction de M Gast F Sigaut et C Beutler avec la collaboratlon de O Bllchsenschutz) voI III 2 Paris Eacuteditionsdu CNRS 1985 pp 597-606
SMITH [1776 A SMITH An inquiry into the nature and causes ojthe wealth ojnations London W Strahanand T Cadell 17762 volI (trad it Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni Milano A Mondadori 1977 2 volI da cui
si cita) STATlITlBoNACOLSIANI [1313] STATUTI BONACOLSlANl (a cura di E Dezza A M Lorenshy
zoni M Vaini) Mantova GArcari 2002 STATUTI GONZAGHESCHI [1404] STATUTI GONZAGHESCHI presso la Biblioteca comunale di
Mantova ms FV 11 [775]VECCHIATO 1979 F VOCCHIATO Pane e politica annonaria in Terrajerma veneta tra
secolo XV e secolo XVIII (Il caso di Verona) Verona Stamperia Zendrini 1979 ZANETTI 1963 D ZANETTl Contribution agrave leacutetude des structures eacuteconomiques lapshy
provisiQnnement de Pavie au XVI siegravecle in Annales ESC XVIII 1963 1 pp 44-62 ora in lo Fra le antiche torri Scritti di storia pavese Pavia Universitagrave di Pavia 2000 pp 165-182
ZANETTl 1964 D ZANEITI Problemi alimentari di una economia preindustriale Ceshyreali a Pavia dal 1398 al 1700 Torino P Borlnghieri 1964
ZUG TUCCI 1990 H ZUG TuCCI Le derrate agricole problemi materiali e concezioni mentali della conservazione in Lambiente vegetale nellalto Medioevo XXXVII Settimana di studio del Centro italiano di studi sullalto Medioevo (30 marzo-5 aprile 1989) Spoleto Centro italiano di studi sullalto Medioevo 1990 voI n pp 865-902
492 497 Renzo P COlTitore
Tale disparitagrave sociale si riverberava sulla struttura del conunercio cerealicolo La funzione dei piccoli conunercianti di biade (granaioibiadaiolijarinaioli balshy
zarotti cavallanti vaticali ecc) era infatti ancillare alla capacitagrave di affacciarsi sul nercato della fascia marginale dei possidenti con eccedenze Solo che nelle annate di
abbondanza si verificavano ingorghi nellofferta di grano che deprimevano i prezzi e incentivavano i piccoli produttori a smerciare direttamente le eccedenze allindomani del raccolto nellarea urbana anche al di fuori dei luoghi deputati (MA1TOZZl 1983 278 281-2 300n PULT QuAGLIA 1984 86) Mentre nelle annate di penuria si contraeshyva drasticamente proprio questo segmento dellofferta (ABEL (1966J 22-4 KULA (1962] 73-4 CATIINI 1984 111-23 PuLT QUAGLIA 1984 88) scatenando nelle campashygne una caccia al grano-merce la cui quota piugrave consistente era detenuta dai grandi proprietari dai maggiori affittuari dai percettori di canoni diritti o rendite in grano e la cui quota residua era piugrave facilmente preda di chi occupava posizioni chiave nellasshysetto terriero nella catena dei diritti nel credito alla produzione e al consumo
Tanto la distribuzione era frammentata nelle annate di abbondanza tanto in epoclshydi penuria il conunercio del grano diventava un affare di pochi In questo caso lazioshyne dei mercanti diventava dimpiccio sul mercato interno dove la coperta si restringeshyva per i proprietari e gli imprenditori agricoli (KULA (1962J 56-61 CATIINI 1984 114-8) - dove la necessitagrave di ricorrere al credito da parte dei piccoli possessori pOneva questi nelle mani degli agenti dei proprietari dei percettori di canoni diritti o rendite - dove i piccoli proprietari vedevano minacciata la loro stessa condizione da parte di chi controllava localmente in maniera capillare e decentrata il mercato del denaro e dei beni necessari alla riproduzione (sernenti strumenti cibo) La soluzione era quelshyla di precludere amministrativamente ai sensali e ai conunercianti di grani i mercati locali su istigazione dei medi possessori le cui occasioni di normale profitto agrario soffrivano un ridimensionamento e che si vedevano costretti a impegnarsi ccedilontiltte le loro forze per integrare le proprie entrate accaparrandosi le magre eccedenze disponishybili nelle campagne e nei borghi rurali (PuLT QUAGLIA 1984 84-8 PuLT QUAGLIA 1990 107-14)
Il destino dei piccoli conunercianti in grano era quindi quello di occupare una posishyzione marginale nel mercato del grano (MEUVRET 1977 30 PINTO 1978 13 MATTOZZI 1983 277) e di operare non solo a causa degli ordinamenti annonari - secondo una logica di corto respiro in cui non era contemplata neacute la conservazione di grani a lungo termine neacute lutilizzo di depositi piugrave che provvisori Come per i piccoli possidenti non si puograve parlare nel loro caso della formazione e del mantenimento di scorte consistenti (MEUVRET 1988 156-7) Non tali comunque da sostenere il reddito contadino nelle stagioni ordinarie e da esercitare sul versante cittadino unefficace azione anticonshygiunturale in caso di carestia
Peraltro in cittagrave la struttura dellofferta era anche piugrave sperequata di quella che si rishyscontra nel contado Che si tratti di Prato ne) 1339 (PlNTO 1978 129 PINTO 1982 160n e 171n) Pavia negli anni 1539 1555 1573 1602 1603 (ZANIITTI 1963) o Mantova nellultima parte del secolo XVI (CORRITORE 2000 81-9) la distribuzione delle scorte fra i privati era singolarmente ineguale Lo attesta la rilevanza nellarea urbana della povertagrave cioegrave secondo una definizione coeva di coloro che non vivono di entrate ma sono necessitati ricorrere mattina e sera alle pistorie a comprare il pane per il vitto loro e delle sue famiglie col denaro che di giorno in giorno si vanno guadagnando (MATshyTOZZI 1983 281) PUOgrave essere utile richiamare la situazione delle cittagrave tedesche nel basso Medioevo in una fase che egrave stata definita da Wilhelm Abel l epoca doro degli artigiani e del lavoro salariato si puograve stimare che almeno la metagrave degli iscritti ai
il costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica ecol1Omica degli stati
te con il principio della piazza Il mercato pubblico periodico disciplinato la spiagshygia la piazza la loggia o il recinto riservato alle contrattazioni - coesisteva confabshybriche magazzini ebotteghe La stessa piazza per funzionare al meglio secondo il principio dello scambio diretto necessitava di magazzini di supporto
4 LE SCORTE DEI FORNAI CITTADINI
Nellarea urbana e nelle relazioni tra cittagrave e campagna operavano perograve temibili conshycorrenti dei privati possessori I fornai cittadini possedevano le competenze le strutshyture tecniche le relazioni sociali e il credito per incettagravere il prodogravetto per essere inforshymati tempestivamente sul mercato del grano e potenzialmente per dispensarlo con profitto in qualunque momento Il fatto che il loro operato fosse imprigionato in un arshycaica impalcatura di norme divieti obblighi che risalivano alletagrave romana che ne fashycevano in modograve quasi istituzionalizzato il capro espiatorio delle tensioni fra produtshytori di grano povertagrave e autoritagrave non impedisce di affermare che tali vessatorie disposizio~i trovassero la loro principale ragione dessere nella parte che essi giocashyvano di interlocutorilantagonisti dei proprietari terrieri nella determinazione del prezshyzo del grano sul mercato locale e nella realizzazione della rendita terriera (GUENZI 1982 35 GUENZl 1982 297)
Nel caso di Mantova terra cornucopia a partire dal 1492 si consenti a zentilhomini cittadini et qualuncho altro di comprare biade nel Dominio per approvvigionare la cittagrave di fatto si sancigrave un diritto allincetta che mise fuori gioco i fornai a cui venne imposto di rifornirsi nei solari dei cittadini senza avere piugrave la possibilitagrave di effettuare acquisti nel contado e di ritenere a casa scorte superiori a 100 staia di frumento Lintento della disposhysizione egrave chiarissimo espresso senza reticenze dai Maestri delle Entrate che riportarono al marchese la soddisfazione dei possidenti mantovani per la riforma statutaria
tutta la Terra (cioegrave il Mantovano] ne (egrave] rimasta satisfactissima pensando che Vostra Excellentigravea pretenda ali comodi et utilitagrave universale senza dampno et preuiditio suo Vero egrave che li fumari non si contentano parendoli comegrave il vero che non si poteranno ingrnssar asuo modo come hanno facto per il passato et poterigravea Igravelchader ( ] che veneranno adolershyse et supplicar aVostra Signoria Perograve me egrave parso dargene aviso per questa nostra et farli intender che questa terra ha soliigrave due membri de li quali li cittadini soi se ne possono aiutashyre e valersene uno egrave il grano laltro egrave larte de la lana et quando se concedesse che li furshyDari potessero comprare come h~o facto li tempi passati sana un fare beneficio acinquanshytaocto dessi et dampnifichar elresto de fa republica sua quale de questo ban ordine ne receve emolumento grandissimo et se gaude in la Citagrave [percheacute] li fumari portano fuora el denaro et pretendono solo a suo benefitio (AG b 2441 lettera del 13 luglio 1492)
Egrave indubbio che il plauso della Terra fosse da attribuire piugrave alla possibilitagrave per i proshyprietari di accrescere le proprie entrate che a quella dei consumatori cittadini e dell arte della lana di trarre beneficio dalla disposizione Egrave significativo che la motivazione pro cigravevitate non accenni allesistenza di monopoli da parte dei fornai o di artificiose lievitashyzioni dei prezzi per causa loro Il loro attivismo non confiiggeva per quanto riguarda i prezzi finali della sussistenza con linteresse dei produttori cittadini E daltra parte largomento dellQ storno dal merpato cittadino dei profitti incamerati dai fornai -laccushysa consueta a proposito dei pistores egrave che fossero in gran parte stranieri (GUENZII982 22) -- era una giustificazione debole che appassionava piugrave chi concorreva direttamente
496 493
Renzo P Corritore
appare altrettanto astratto dogmatico o virtuale del principio di mercato (Market Pri1lciple) che il medesimo gli contrappone Henri Pirenne parlando della politica annonaria dei comuni medievali avverte Lapplicazione del principio della vendita diretta ebbe numerosi eccezioni (PumNNE [1933] 193n)
Nel caso di Mantova la scelta della Piazza egrave facoltativa per i terrieri COn eccedenze Gli Statuti signorili che si rifanno largamente alle raccolte statutarie comunali non sancivano alcun obbligo in proposito (v SVJUTI BONACOLSIANI [1313] libro m rubr 55 De mercato blave 253 STATlITl GoNZAOHESCHI [1404J libro m rubr 93 De mercato blave fiendo in civitate Mantue f 73v) Decreti di carattere straordinario e regolamenshytazioni transitorie correggevano il tiro Nel 1405 in piena saldatura dei raccolti si c0shy
strinse a rifornire forzosamel)~ la piazza concentrandovi tutte le contrattazioni Nel 1417 si obbligograve a riservare al mercato un terzo del frumento introdotto in cittagrave (CORRIshyTORE 2000 235-6) Ma sono atti straordinari che non sopravvissero nel migliore dei casi piugravedi qualchelustro (MANroVA 1430 88 90 181) A Mantova la Piazza era affianshycata da un granaio pubblico la Domus del mercato (altrove definito Folllico o Fonrego del mercato) in cui avrebbero dovuto prolungarsi le contrattazioni oltre lorario e i giorshyni deputati (venerdigrave o sabato) rendendo disponibile ciograve che restava invenduto e che non poteva essere ritirato per legge dal mercato Nel 1430 eminenti cittadini sollecitati dal principe lamentavano perograve lincapacitagrave del magazzino - inoperoso in tutto o in parte per il pericolo di crolli -- di rispondere ai bisogni del popolo in una situazione in cUi da parte dei possessori si protestava la difficoltagrave di non poter esitare e smerciare fuori delshyla cittagrave le eccedenze conservate nei solari privati
Item videtur quod valde utille foret civibus Mantue habentibus possessiones et quishybuscumque alijs personis de civitate Mantue aut districtu colligantibus bIada et vina in magna copia ut omni tempore ipsa bIada et vinum possent extrahere de civitate et dishystrictu Mantue et conducere ad Iaea ad que et in quibus ma vendere poterunt cum otdishynibus et dacijs competentibus ipsa tamen civitate semper remanente fulta pro usu dicte civitatis et populi eiusdem ne dieta biada marceschant super granarlis ut hactenus feceshyrunt cum maximo incomodo ipsorum civium (MANTOVA 1430 177-8)
nmedesimo fondaco abbinato al mercato operava a Verona a Ferrara a Vegravenezia a Udine a Chioggia in molte altre cittagrave (MANToVA 1430 100 FORNASIN 1999 7-9 CEshySTAR 1794)
Lintegrale e pedissequa applicazione del principio della piazza di mercato comporshytava - per i vincoli tecnici dell etagrave pre-industriale -la massima affermazione del prinshycipio della canova cioegrave del magazzino pubblico centrale Unico argine alla sua invashydenza era costituito da una distribuzione perequata ab imis del raccolto cioegrave la possibilitagrave - egrave questo il paradosso - di realizzare da parte dei produttori la massima aspirazione nelle societagrave tradizionali lautarchia domestica Piugrave avanzava invece la sperequazione nel reddito e nel patrimonio piugrave da parte dei consumatori privi di scorshyte si impetrava il principio del Magazzino pubblico nella ronna di un efficiente sisteshyma di ricovero conservazione distribuzione delle derrate a garanzia del funzionashymento della Piazza di mercato La disponibilitagrave di crescenti quote di raccolto tuttavia indirizzava i piugrave accomodati verso soluzioni piugrave ghiotte la vendita allingrosso sul mercato cittadino ai fornai o allimpresa pubblica creata a sussidio di questi (o in loro vece) Oppure allopposto lesito delle eccedenze extra muros sui grandi mercatishyemporio regionali per il tramite di mercanti o agenti diretti
Il principio del magazzino pubblico centrale cioegrave laccumulazione di riserve per lo smercio continuo o anticiclico egrave quindi alla sua origine in opposizione solo apparen-
La costirU1ione di scorre granarie pubbliche e la politica economica degli srati
ruoli fiscali non fosserograve in grado di accantonare scorte Nel 1444 a Strasburgo quattro cittadini su dieci non possedevano alcuna riserva cerealicola (DRlMBIER 1984 112)
Nelle cittagrave italiane delletagrave moderna si puograve stimare che non meno di due terzi della popolazione fosse costretta ad acquistare o consumare pane confezionato con grani e farine comperati nelle piazze nelle vie e nelle botteghe cittadine oppure ottenuti come compenso del proprio servizio nelle casate (CORRrroRE 2000 126-36 MA11oZZI 1983 27~-82) Evidentemente questa fascia di lavoratori salariati non possedeva -shyper definizione - neacute scorte neacute depositi personali e nel primo caso era strettamente dipendente dal mercatograve urbano acquistando la sua sussistenza con frequenza non piugrave che settimanale (essendo costretti a comprare il pane tutti i giorni allafinestra si dishyceva a Genova [GRENDI1986 1031])
Ma anche fra i citiOdini con possesso extra moenia la distribuzione delle scorte era tuttaltro che egalitaria A Prato nel 1339
A parte gli enti religiosi sette famiglie [ ] avevano ii disposizione piugrave di mille staia di granaglie (circa 18 tonnellate) fino a un massimo di 3500 Altri venti nuciei familiashyri avevano scorte comprese tra le 500 e le 1000 staia (PINTO 1978 129n)
A Mantova nei magazzini ducali nellultima parte del 500 erano ammassati non meno di un ottavo talora piugrave di un quarto delle riserve cittadine di grani panificabili (CoRRITORE 200081-6) A Pavia nel corso dello stesso secolo e allinizio di quello successivo nei solagraveri di una sessantina di famiglie si concentrava non meno del 40 per cento dellintera offerta cittadinIgrave di frumento(ZANBUgrave11964 70-7) Anche in questo caso egrave utile sapere che nelle cittagrave tedesche esistevano mercanti (ad Augusta RatisboshyDa Norimberga) in grado di axnPmssare riserve da 6 a 45 tonnellate e che a Francoshyforte nel 1488 due patrizi totali~zavano insieme un terzo delle scorte cerealicole dei particolari nella cittagrave alta (DnuMmER 1984113)
Ritenere tali soggetti sprovv~uti al punto di incanevare grani con il solo scopo di esorc~ i pericoli della Fstia egrave perlomeno riduttivo A grandi solari comshyspondevano vaste familiae e pIftore di servi tori e ospiti ma tali scorte eccedevano largamente la sussistenza del maggiore palazzo nobiliare o patrizio senza peraltro costituire un fondo di accantonafoento eccedente il fabbisogno della cittagrave a meno che non vi fosse la concreta possibilitagrave di commercializzare il surplus sui mercati esteri Come nota infatti Adam Smith
a meno che leccedenza non possa essere esportata in tutte le circostanze ordinarie i coltivatori staranno molto attenti a non produrre e gli importatori a non importare mai una quantitagrave maggiore di quell~ che egrave strettamente richiesta dal consumo del mercato interno Questo mercato saragrave difficilmente sovrafomito ma saragrave in generale sottoriforshyDito dato che coloro che svolgqno lattivitagrave per rifomirlo avranno in generale il timore che la loro merce possa rimanete invenduta (SMlTH [1776] 528)
Lipotesi egrave suffragata dai cas~ storici conosciuti A Bologna macrodistretto serico dellevo moderno laddove gli ipteressi manifatturieri e mercantili avrebbero dovuto consigliare una sussistenza a b~on mercato per tenere basso il costo del lavoro le istituzioni annonarie operavano per garantire con il calmiero deljorme1lto la monetizshyzazione della rendita granaria dei possidenti - strutturalmente incapace di coprire il fabbisogno della cittagrave anchea rischio della carezza dei viveri contingentando il mercato dei grani forestieri (GtJFNZl1982A 37-76) Di fatto
495 494 Renzo P Corrllnre
In ogni caso si tendeva a limitare al minimo indispensabile lemiddot importazioni di frushymento per evitare che stocks invenduti potessero turbare la collocazione dei grani tershyrieri nel nuovo anno agrario (GuENZI 1981 153)
In tutti i centri comunque la tendenza a ritardare la vendita del surplus nei mesi della saldatura lutilizzo di depositi specializzati con personale addetto alla custodia al conshydizionamento e alla commercializzazione del prodotto ponevano i grandi proprietari di biade su un gradino superiore e diverso rispetto al resto della cittagrave Laccantonamento di grani per questa cupola di possessori rispondeva al principio dellutilitagrave soggettiva atshytesa e richiedeva sia capitale fisso sia capitale circolante per raggiungere gli scopipreshyfissati un profitto speculativo la valorizzazione della rendita
In molte cittagrave i possessori non avrebbero dovuto trattenere in casa piugrave grano e farina di quantoprescritto dalla legge cioegrave il consumo mensile per bocca - fissato anchesshyso statutariamente - per arrivare al nuovo raccolto Ma i cittadini credeVano veramenshyte ai loro comandamenti Egrave lecito dubitare La norma era scolpita negli Statuti e pubshyblicamente violata con la complicitagrave dll1e autoritagrave e dei groppi professionali interessati alla distribuzione del grano nelle sue ~arie forme
Nelle annate ordinarie la quota di grano auto consumato - cioegrave non acquistata sul mercato - nelle cittagrave italiane dell evo moderno rappresentava fra il 30 e il 60 per censhyto del fabbisogno urbano di frumento
Nella capitale dei Gonzaga nel 1615 si valutava che su 27000 bocche
il terzo [di] gentilhuomini fittadri servitori et altri [ ] non comprano biada et gli duoi tenigrave tra poveri artisti mercanti fomari fondachieri hebrei et altri [bull] non possono in tutto levar sufficientemente la somma de detti dua terzi sl che saranno boshychegrave 18000 che compraranno biada (COIUUTORl 2000 126)
AVenezia a cavaliere fra XVI e XVII secolo alla mensa delle casade si dispensava circa un terzo del frumento consumato ordinariamente in cittagrave (AMARD 1966 74 MATTOZZI 1983 281) ABologna per tutto il Seicento i fornai che impastavano farine in conto lavorazione per i particolari pareggiavano piugrave o meno il numero di quelli da scqffa che smerciavano pane venale (GUENZI 1982A
27) Peraltro la proporzione a Rialto tra chi lavorava per le casade e chi vendeva pane al pubblico - 65 Jo~ri a fronte di 44-48 pistori negli anni 1583-1685 (DELLA VALBNTINA 1992 143-4 167 192-3) - fa ritenere la struttura del mercato del pane felsinea non molto dissimile da quella veneziana Nelle cittagrave liguri o toscane sei-settecentesche la porzione autocon sumata quando il raccolto era buono era anche piugrave elevata (GRENDI 1986 1024-6 1034 PuLT QUAOUA 1984 98-104 PULT QUAGUA 1990 171-2) A Napoli nel 1758 a Monasteri Luoghi pii e Particolari eta riservato il 28 per cento del consumo cittadishyno di frumento (AuFANO 1996 37n)
Lelevato numero di servi domestici persone al servizio delle casate faceva sigrave che in alcuni palazzi si concentrassero masse cospicue di grano per la spesa familiare Ma accanto ad esse gli operatori dell annona -- la stessa povertagrave -- si auguravano che vi fosse sempre anche la materia per rifornireil mercato e i forni cittadinimiddot nella fase piugrave delicata del ciclo annuale il periodo di saldatura dei raccolti Come spiegare altrimenshyti la norma che imponeva ai grossi detentori di biade (non esclusi enti e opere pie) in varie cittagrave italiane dellevo moderno la vendita straordinaria in primavera dellegrave ecshycedenze ammassate in granaio (per Pisa e la Toscana v PuLT QUAGUA 1984 88-9)
A Mantova nel 1554 si stabiliva che i patroni che avessero fruito in cittagrave di piugrave di 20 sacchi di grano come porzione dominicale avrebbero dovuto coilservare in granaio
lA costituzioni digrave scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
il 4 per cento per le necessitagrave dei consumatori dei fornai e dei Jontachieri quando fosse mancato il prodotto sulla piazza o nelle offerte deisensali Nel 1603 ci si preocshycupograve di elevare la quota al 6 per cento (CORRlTQRE 2000 237n) Beninteso le vendite sarebbero avvenute ai valori di mercato Lo stesso sistema vigeva a Cremona (6 per cento nel 1608 e nel 1612) (MERON 1957 59n 63 JACOPETl1 1965 128) ea Verona Qui una delibera consiliare del 1549 autorizzava per la prima volta
[il deputati [alle Biadel [a] tassar e comandar con quelle pene che al Clarissimo Podestagrave pareragrave quella quantitagrave di biade a ciascuno secolare o eclesiastico sia di qual grado o condittione esser si voglia che havesse biade in questa cittagrave oltre il viver suo
(VOCCHIATO 1979 145)
La tassa sarebbe stata stabilita - da11558 - per sorteggio fra le casate che avessero introdotto in cittagrave dai propri possedimenti piugrave di 70 minali per rifo1llire il Mercato delle biave Essa-venne anche incrementata nella stessa occasione dal 5 al6 per censhyto per restare in vigore fino al 1631 (VECCHIATO 1979 141-58)
Quest9 tiIfo di normativa nasce e si affiogravea in ambito amministrativo perciograve echeggia la realtagrave molto meglio della veneranda legge generale
Da tali disposizioni si deducono alcuni fatti incontrovertibili 1entro la cerchia cittadina esistevano scorte private eccedenti la spesa delle famiglie
in violazione in molti casi della legge statutaria 2il possesso della terra che solo assicurava lautarchia delle casate era il piugrave-potente
fattore di discriminazione fra i cives tanto da precipitare nel girone dei pauperes la moltitudine che acquistava correntemente la sussistenza nellarea urbana
3fra gli stessi possidenti cittadini esisteva uneacutelite che non solo conservava scorte oltre il viver suo ma che si proponeva egoisticamente di speculare ritardando limshymissione dei grani sulle piazze cittadine o che a~endeva il momento piugrave opportuno per smerciarli allesterno nelle grandi piazze frumentarie come livorno Desenzashyno Legnago Romano (di Lombardia) ecc
4lineguaglianza fra i cives tese ad aggravarsi con la metagrave del 500 poicheacute questi reshygolamenti innovano quasi sempre disposizioni generali risalenti al tardo Medioevo che sancivano lobbligo di convogliare il surplus sulla piazza cittadina segno di una distribuzione del reddito originariamente meno sbilanciata A Cremona gli Statuti del 1388 obbligavano - cosl egrave ancora nel 1510 - a vendere il
sovrappiugrave in Piazza Maggiore sul mercato pubblico dei grani (MERON 1957 59n
63)A Pisa il rescritto che imponeva di effettuare le vendite al minuto in platea bladi
risale al 1401 MALANlMA 1976 293) lobbligo era ribadito ancora nel 1548 ma nella seconda metagrave del secolo XVI si affermava la pratica di vendere fuori mercato tanto che nel 1581 il Magistrato dei Nove dovette intervenire per far vendere i grani delle comunitagrave degli enti e dei luoghimiddotpii soltanto da marzo-aprile in piccole quantitagrave sul mercato (PULT QUAGUA 1984 81-91) La disposizione per altro si applicava allinteshyro Stato (PULT QUAGUA 1984 88)
Tuttavia non egrave da pensare che il principio della concentrazione delle compravendite sulla piazza di mercato cittadina fosse universale universalmente rispettato e sopratshytutto perenne La centralizzazione del grano non significa automaticamente lobbligo di vendita diretta sulla Piazza deiformenti Affermare come Steven L Kaplan che
There was no single more important regulation concerning tbe provisioning trade tban tbe requirement tbat alI transactions occur in tbe marketplace (KAPLAN 1984 27)
494 495 Renzo P Corritore
In ogni caso si tendeva a limitare al minimo indispensabile le importazioni di frushymento per evitare che stocks invendutigrave potessero turbare )a collocaziolle dei grani tershyrieri ileI nuovo anno agrario (GUENZI 1981 153)
In tutti i centri comunque la tendenza a ritardare la vendita del surplus nei mesi della saldatura lutilizzo di depositi specializzati con personale addetto alla custodia al conshydizionamento e alla commercializzazione del prodotto ponevano i grandi proprietari di biade su un gradino superiore e diverso rispetto al resto della cittagrave Laccantonamento di grani per questa cupola di possessori rispondeva al principio dellutilitagrave soggettiva atshytesa e richiedeva sia capitale fisso sia capitale circolante per raggiungere gli scopipreshyfissati un profitto speculativo la valorizzazione della rendita
In molte cittagrave i possessori non avrebbero dovuto trattenere in casa piagrave grano e farina di quantoprescritto dalla legge cioegrave il consumo mensile per bocca ~- fissato anchesshy
so statutariamente --per arrivare al nuovo raccolto Ma i cittadini credevano veramenshyte ai loro comandamenti Egrave lecito dubitare La norma era scogravelpitagrave negli Statuti e pubshyblicamente violatamiddot con la complicitagrave dccedillle autoritagrave e dei gruppi professionali interessati alla distribuzione del grano nelle sue varie forme
Nelle annate ordinarie la quota di grano autoconsumato - cioegrave non acquistata sul mercato - nelle cittagrave italiane dell evo moderno rappresentava fra il 30 e i160 per censhyto del fabbisogno urbano di frumento
Nella capitale dei Gonzaga nel 1615 si valutava che su 27000 bocche
il terzo [di] gentilhuomini ligravettadri servitori et altri [ ] non comprano biada et gli duoi terzi tra poveri artisti mercanti fomari fondachieri hebrei et altri [ l non possono in tutto levar sufficientemente la $omma de detti dua terzi sl che saranno boshyche 18000 che compraranno biada (CoRRlTORB 2000 126)
AVenezia a cavaliere fra XVI e xvn secoioalla mensa delle casade si dispensava circa un terzo del frumento consumato ordinariamente in cittagrave (AYMARD 1966 74 MArroZZI 1983 281) A Bologna per tutto il Seicento i fornai che impastavano farine in conto lavorazione per i particolari pareggiavano piil o meno il numero di quelli da scaifa che smerciavano pane venale (GUBNZI 1982 27) Peraltro la proporzione a Rialto tra chi lavorava per le casade e chi vendeva pane al pubblico - 65 fOf7lri a fronte di 44-48 pistori negli anni 1583-1685 (DELLA VAUNTINA 1992 143-4167 192-3) - fa ritenere la struttura del mercato del pane felsinea non molto dissimile da quella veneziana Nelle cittagrave liguri o toscane sei-settecentesche la porzione autoconshysumata quando il raccolto era buono era anche piil elevata (ORENOI 1986 1024-6 1034 PuLT QUAGLIA 1984 98-104 PULT QUAOLIA 1990 171-2) A Napoli nel 1758 a Monasteri Luoghi pii e Particolari eta riservato il 28 per cento del consumo cittadishyno di frumento (AuFANO 1996 370)
Lelevato numero di servi domestici persone al servizio delle casate faceva si che in alcuni palazzi si concentrassero masse cospicue di grano per la spesa familiare Ma accanto ad esse gli operatori dellannona -lastessapovertagrave __ si auguravano che vi fosse sempre anche la materia per rifornire il mercato e i forni cittadini nella fase piil delicata del ciclo annuale il periodo di saldatura dei raccolti Come spiegare altrimenshyti la norma che imponeva ai grossi detentori digrave biade (non esclusi enti e opere piegrave) in varie cittagrave italiane dellevo moderno la vendita straordinaria in primavera delle ecshyredenze ammassate in granaio (per Pisa e la Toscana v PuLT QUAGLIA 1984 88-9)
A Mantova nel 1554 si stabiliva che i patroni che avessero fruito in cittagrave di piugrave di 20 sacchi di grano come porzione dominicale avrebbero dovuto conservare in granaio
lA costituzione di SC0114 granarie pubbliche e la politica economica degli stati
il 4 per cento per le necessitagrave dei consumatori dei fornai e dei fontachieri quando fosse mancato il prodotto sulla piazza o nelle offerte deimiddotsensati Nel 1603 ci si preocshycupograve di elevare la quota al 6 per cento (CoRRlTORE 2000 237n) Beninteso le vendite sarebbero avvenute ai valori di mercato 10 stessa sistema vigeva a Cremona (6 per cento nel 1608 e nel 1612) (MERON 1957 -59n 63 JACOPETl11965 128) ea Verona Qui una delibera consiliare del 1549 autoruzava per la prima volta
[i] deputati [alle Biade) [al tassar e comandar con quelle pene che al Clarissimo Podestagrave pareragrave quella quantitagrave di biade a ciascuno secolare o eclesiastico sia di qual grado o condittione esser si voglia che havesse biade in questa cittagrave oltre il viver suo (VBCClI1ATO 1979 145)
La tassa sarebbe stata stabilita - dal 1558 - per sorteggio fra le casate che avessero introdotto in cittagrave dai propri possedimenti piagrave di 70 minali per rifornire il Mercato delle biave Essaveane anche incrementata nella stessa occasione dal 5 al6 per censhyto per restare in vigore fino al 1631 (VECCHIATO 1979 141-58)
Questccedil tijlo di normativa nasce e si affuia in ambito amministrativo perciograve echeggia la realtagrave molto meglio della veneranda legge generale
Da tali disposizioni si deducono alcuni fatti incontrovertibili 1entro la cerchia cittadina esistevano scorte private eccedenti la spesa delle famiglie
in violazione in molti casi della legge statutaria 2il possesso della terra che solo assicurava lautarchia delle casate era il piugravemiddotpotente
fattore di discriminazione fra i cives tanto da precipitare nel girone dei pauperes la moltitudine che acquistava correntemente la sussistenza nellarea urbana
3fra gli stessi possidenti cittadini esisteva uneacutelite che non solo conservava scorte oltre il viver suo ma che si proponeva egoisticamente di speculare ritardando limshymissione dei grani sulle piazze cittadine o che a~endeva il momento piagrave opportuno per smerciarli allesterno nelle grandi piazze frumentarie come Uvorno Desenzashyno Legnago Romano di Lombardia) ecc
4lineguaglianza fra i cives tese ad aggravarsi con la metagrave del 500 poicheacute questi reshygolamenti innovano quasi sempre disposizioni generali risalenti al tardo Medioevo che sancivano lobbligo di convogliare il surplus sulla piazza cittadina segno di una distribuzione del reddito originariamente meno sbilanciata shyACremona gli Statuti del 1388 obbligavano - cosl egrave ancora nel 1510 - a vendere il
sovrappigraveagrave in Piazza Maggiore sul mercato pubblico dei grani (MERON 1957 59n 63)
A Pisa il rescritto che imponeva di effettuare le vendite al minuto in platea bladi risale al 1401 (MALANIMA 1976 293) lobbligo era ribadito ancora nel 1548 ma nella seconda metagrave del secolo XVI si affermava la pratica di vendere fuori mercato tanto che nel 1581 il Magistrato dei Nove dovette intervenire per far vendere i grani delle comunitagrave degli enti e dei luoghi pii soltanto da marzo-aprile in piccole quantitagrave sul mercato (PULT QUAGLIA 1984 8191) La disposizione per altro si applicava allinteshyro Stato (PULT QUAGLIA 1984 88)
Tuttavia non egrave da pensare che il principio della concentrazione delle compravendite sulla piazza di mercato cittadina fosse universale universalmente rispettato e sopratshytutto perenne La centralizzazione del grano non significa automaticamente lobbligo di vendita diretta sulla Piazza deiformenti Affermare come Steven L Kaplan che
There was no single more important regulation conceming the provisioning trade han the requirement that ali transactions occur in the marketplace (KAPuN 1984 27)
493 496 Renw P Corritore
appare altrettanto astratto dogmatico O virtuale del principio di mercato (Market Principle) che il medesimo gli contrappone Henri Pirenne parlando della politica annonaria dei comuni medievali avverte Lapplicazione del principio della vendita diretta ebbe numerosi eccezioni (PIRENNE [1933] 193n)
Nel caso di Mantova la scelta della Piazza egrave facoltativa per i terrieri con eccedenze GliStatuti signorili che si rifanno largamente alle raccolte statutarie comunali non sancivano alcun obbligo in proposito (v SYJI1l BONACOLSlANI [1313] libro ID rubr 55 De mercato blave 253 STATUTI GoNZAOHESCHI [1404] libro m rubr 93 De mercato blave fiendo in civitate Mantue f 73v) Decreti di carattere straordinario e regolamenshytazioni transitorie correggevano il tiro Nel 1405 in piena saldatura dei raccolti si coshystrinse a rifornire forzosamen~e la piazza concentrandovi tutte le contrattazioni Nel 1417 si obbligograve a riservare al mercato un terzo del frumento introdotto in cittagrave (CoRRIshyTORE 2000 235-6) Ma sono atti straordinari che non sopravvissero nel migliore dei casi piugrave di qualchelustro (MANToVA 1430 88 90 181) A Mantova la Piazza era affianshycata da un granaio pubblico la Domus del mercato (altrove definito Fornico o Fontego del mercato) in cui avrebbero dovuto prolungarsi le contrattazioni oltre lorario e i giorshyni deputati (venerdl o sabato) rendendo disponibile ciograve che restava invenduto e che non poteva essere ritirato per legge dal mercato Nel 1430 eminenti cittadini sollecitati dal principe lamentavano pero lincapacitagrave del magazzino - inoperoso in tutto o in ~per il pericolo di crolli - di rispondere ai bisogni del popolo in una situazione in cui da parte dei possessori si protestava la difficoltagrave di non poter esitare e smerciare fuori delshyla cittagrave le eccedenze conservate nei solari privati
ltem videtur quod valde utille foret civibus Mantue habentibus possessiones et quishybuscumque alijs personis de civitate Mantue aut districtu colligantibus bIada et vina in magna copia ut amni tempore ipsa bIada et vinum possent exttahere de civitate et dishystrictu Mantue et conducere ad Iaea ad que et in quibus illa vendere poterunt cum otdigraveshynibus et dacijs competentibus ipsa tamen civitate semper remanente fulta pro usu diete civitatis et populi eiusdem ne dicta bIada mateeschant super granariis ut hactenus fecemiddot runt cum maximo incomodo ipsorum civium (MANToVA 1430 177-8)
Il medesimo fondaco abbinato al mercato operava a Verona a Ferrara a Venezia a Udine a Chioggia in molte altre cittagrave (MANToVA 1430 100 FORNASIN 1999 7-9 CBshySTARl1794)
Lintegrale e pedissequa applicazione del principio della piazza di mercato comporshytava - per i vincoli tecnici dell etagrave pre-industriale -la massima affermazione del prinshycipio della canova cioegrave del magazzino pubblico centrale Unico argine alla sua invashydenza era costituito da una distribuzione perequata ab imis del raccolto cioegrave la possibilitagrave egrave questo il paradosso di realizzare da parte dei produttori la massima aspirazione nelle societagrave tradizionali lautarchia domestica Piugrave avanzava invecela sperequazione nel reddito e nel patrimonio piugrave da parte dei consumatori privi di scorshyte si impetrava il principio del Magazzino pubblico nella forma di un efficiente sisteshyma di ricovero conservazione distribuzione delle derrate a garanzia del funzionashymento della Piazza di mercato La disponibilitagrave di crescenti quote di raccolto tuttavia indirizzava i piugrave accomodati verso soluzioni piugrave ghiotte la vendita allingrosso sul mercato cittadino ai fornai o allimpresa pubblica creata a sussidio di questi (o in loro vece) Oppure allopposto lesito delle eccedenze extra muros sui grandi mercatishyemporio regionali per il tramite di mercanti o agenti diretti
Il principio del magazzino pubblico centrale cioegrave laccumulazione di riserve per lo smercio continuo o anticiclico egrave quindi alla sua origine in opposizione solo apparen-
La costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
ruoli fiscali non fossero in grado di accantonare scorte Nel 1444 a Strasburgo quattro cittadini su dieci non possedevano alcuna riserva cerealicola (DIIUMBIER 1984 112)
Nelle cittagrave italiane delletagrave moderna si puograve stimare che non meno di due terzi della popolazione fosse costretta ad acquistare o consumare pane confezionato con grani e farine comperati nelle piazze nelle vie e nelle botteghe cittadine oppure ottenuti come compenso del proprio servizio nelle casate (CoRRITORE 2000 126-36 MAnoZZI 1983 27~-82) Evidentemente questa fascia di lavoratori salariati non possedevashyper definizione -- neacute scorte neacute depositi personali e nel primo caso era strettamente dipendente dal mercato urbano acquistando la sua sussistenza con frequenza non piugrave che settimaIIgraveale (essendo costretti a comprare il pane tutti i giorni alla finestra si dishyceva a Genova (GRENDI 1986 1031])
Ma anche fra i citUutini con possesso extra moenia la distribuzione delle scorte era tuttaltro che egalitaria A Prato nel 1339
A patte gli enti religiosi sette famiglie [ bull ] avevano Il disposizione piugrave di mille staia di granaglie (circa 18 tonnellate) fino a un massimo di 3500 Altri venti nuclei familiashyri avevano scorte comprese tra le SOOe le 1000 staia (PINTO 1978 129n)
A Mantova nei magazzini ducali nellultima parte del 500 erano ammassati non meno di un ottavo talora piugrave di un quarto delle riserve cittadine di grani panificabili (CORRlTORE 2000 81c6) A Pavia nel corsq dello stesso secolo e allinizio di quello successivo nei sozagraveri di una sessantina di famiglie si concentrava non meno del 40 per cento dell intera offerta cittadin8 di frumentomiddot (ZANJin 1964 70-7) Anche in questo caso egrave utile sapere che nelle cittagrave tedesche esistevano mercanti (ad Augusta Ratisboshyna Norimberga) in grado di ~sare riserve da 6 a 45 tonnellate e che a Francoshyforte nel 1488 due patrizi totalizzavano insieme un terzo delle scorte cerealicole dei particolari nella cittagrave alta (DlRLMB1ER 1984113)
Ritenere tali soggetti sprovv~duti al punto di incanevare grani con il solo scopo di esorcizzare i pericoli della clarestia egrave perlomeno riduttivo A grandi solari corrishyspondevano vaste familiae e plftore di servitori e ospiti ma tali scorte eccedevano largamente la sussistenza del D-aggiore palazzo nobiliare o patrizio senza peraltro costituire un fondo di accantofilljnento eccedente il fabbisogno della cittagrave a meno che non vi fosse la concreta possibfjitagrave di commercializzare il surplus sui mercati esteri Come nota infatti Adam Smith
a meno che leccedenza non possa essere esportata in tutte le circostanze ordinarie i coltivatori staranno molto attenti a non produrre e gli importatori a non importare mai una quantitagrave maggiore di quell~ che egrave strettamente richiesta dal consumo del mercato interno Questo mercato saragrave difficilmente sovrafornito ma saragrave in generale sottomorshynito dato che coloro che svolgono lattivitagrave per mornirlo avranno in generale il timore che la loro merce possa rimane~ invenduta (SMITH[l776] 528)
Lipotesi egrave suffragata dai cas storici conosciuti A Bologna macrodistretto serico dellevo modemoladdove gli interessi manifatturieri e mercantili avrebbero dovuto consigliare una sussistenza a b~on mercato per tenere basso il costo del lavoro le istituzioni annonarie operavano per-garantire con il calmiero delformento la monetizshyzazione della rendita granaria dei possidenti - strutturalmente incapace di coprire il fabbisogno della cittagrave - anche ~ rischio della carezza dei viveri contingentando il mercato dei grani forestieri (GupaI 1982 37-76) Di fatto
492 Renzo P COITitore
Tale disparitagrave sociale si riverberava sulla struttura del commercio cerealicolo La funzione dei piccoli commercianti di biade (granaiolibull biadaiolifarinaioli balshy
zarotti cavallanti vatlcali ecc) era infatti ancillare alla capacitagrave di affacciarsi sul nercato della fascia marginale deipossidenti con eccedenze Solo che nelle annate di abbondanza si venficavano ingorghi nell offerta di grano che deprimevano i prezzi e incentivavano i piccoli produttori a smerciare direttamente le eccedenze allindomani del raccolto nellarea urbana anche al di fuori dei luoghi deputati (MATI02ZI 1983 278281-2 300n PULr QUAGLIA 1984 86) Mentre nelle annate di penuria si contraeshyva drasticamente proprio questo segmento dellofferta (ABa [1966Jmiddot 22-4 KULA [1962J 73-4 CATrINI1984 111-23 PuIr QUAGUA 1984 88) scatenando nelle campashygne una caccia al grano-merce la cui quota piugrave consistente era detenuta dai grandi proprietari dai maggiori affittuari dai percettori di canoni diritti o rendite in grano e la cui quota residua era piugrave facilmente preda di chi occupava posizioni chiave nellasshysetto terriero nella catena dei diritti nel credito alla produzione e al consumo
Tanto la distribuZione era frammentata nelle annate di abbondanza tanto in epoc~ di penuria il commercio del grano diventava un affare di pochi In questo caso lazioshyne dei mercanti diVentava dimpiccio sul mercato interno dove la coperta si restringeshyva per i proprietari e gli imprenditori agricoli (KULA [1962] 56-61 CATl1NI 1984 114-8) - dove la necessitagrave di ricorrere al credito da parte dei piccoli possessori poneva questi nelle mani degli agenti dei proprietari dei percettoridi canoni diritti o rendite - dove i piccoli proprietari vedevano minacciata la loro stessa condizione da parte di chi controllava localInente in maniera capillare e decentrata il mercato del denaro e dei beni necessari alla riproduzione (sementi strumenti cibo) La soluzione era quelshyla di precludere amministrativamente ai sensali e ai commercianti di grani i mercati locali su istigazione dei medi possessori le cui occasioni di normale profitto agrario soffrivano un ridimensionamento e che si vedevano costretti a impegnarsi ccedilon tutte le loro forze per integrare le proprie entrate accaparrandosi le magre eccedeiiZe disponishybili nelle campagne e nei borghi rurali (PuLT QUAGLIA 1984 84-8 PULT QUAGLIA 1990 lO7-14)
TI destino dei piccoli commercianti in grano era quindi quello di occupare una posishyzione margilJale nel mercato del grano (MBlNrurr 1977 30 PINTO 1978 13 MAITOZZl 1983 277) e di operare - non solo a causa degli ordinamenti annonari - secondo una logica di corto respiro in cui non era contemplata neacute la conservazione di grani a lungo termine neacute lutilizzo di depositi piugrave che provvisori Come per i piccoli possidenti non si puograve parlare ne1loro caso della formazione e del mantenimento di scorte consistenti (MBlNREr 1988 156~7) Non tali comunque da sostenere il reddito contadino nelle stagioni ordinarie e da esercitare sul versante cittadino unefficace azione anticonshygiunturale in caso di carestia
Peraltro in cittagrave la struttura dellofferta era anche piugrave sperequata di quella che si rishyscontra nel contado Che si tratti di Prato nel 1339 (PINTO 1978 129 PINTO 1982 160n e 17In) Pavia negli anni 1539 1555 1513 1602 1603 (ZANEm 1963) o Mantova nellultima parte del secolo XVI (CORRITORE 2000 81-9) la distribuzione delle scorte fra i privati era singolarmente ineguale Lo attesta la rilevanza nellarea urbana della povertagrave cioegrave secondo una definizione coeva di coloro che non vivono di entrate ma sono necessitati ricorrere mattina e sera alle pistorie a comprare il pane per iI vitto loro e delle sue famiglie col denaro che di giomo in giomo si vanno guadagnando (MATshyTOZZI 1983 281) PUOgrave essere utile richiamare la situazione delle cittagrave tedesche nel basso Medioevo in una fase che egrave stata definita da Wilhelm Abellepoca doro degli artigiani e del lavoro salariato si puograve stimare che almeno la metagrave degli iscritti ai
lA costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli statibull middot497
te con il principio della piazza TI mercato pubblico periodico disciplinatola spiagshygiala piazza la loggia o iI recinto riservato alle contrattazioni - coesis~va confabshybriche magazzini e botteghe La stessa piazza per funzionare al meglio secondo il principio dello scambio diretto necessitava di magaZzini di supporto bull
4 LE SCORTE DEI FORNAI CITTADINI
Nellarea urbanagrave e nelle relazioni tra cittagrave e campagna operavano perograve temibili conshycorrenti dei privati possessori I fornai cittadini possedevano le competenze le strutshyture tecniche le relazioni sociali e il credito per incettagravere il prodotto per essere inforshymati tempestivamentesul mercato del grano e potenzialmente per dispensarlo con profitto in qualunque momento Il fatto che il loro operato fosse imprigionato in unarshycaica impalcatura di norme divieti obblighi che risalivano alletagrave romana che ne fashycevano in modo quasi istituzionalizzato il capro espiatorio delle tensioni fra produtshytori di grano povertagrave e autotitagrave non impedisce di affermare che tali vessatorie disposiziograveD1 trovassero la loro principale ragione dessere nella parte che essi giocashyvano di interlocutorilantagonisti dei proprietari terrieri nelladeterminazione del prezshyzo del grano sul mercato locale e nella realizzazione della rendita terriera (GUENZI 19824
35 GUENZI 1982 297) Neacutel caso di Mantova terra comucopia a partire dal 1492 si consend a zentilhomini
cittadini et qualuncho altro di comprare biade nel Dominio per approvvigionare la cittagrave di fatto si sand un diritto allincetta che mise fuori gioco i fornai a cui venne imposto di rifornirsi nei solarimiddotdei cittadini senza avere piugrave la possibilitagrave di effettuare acquisti nel contado e di ritenere a casa scorte superiori amiddotl 00 staia di frumento Lintento della disposhysizione egrave chiarissimo espresso senza reticenze dai Maestri delle Entrate che riportarono al marchese la soddisfazione dei possidenti mantovani per la riforma statutaria
tutta la Terra [cioegrave il Mantovano] ne [egravel rimasta satisfactissirna pensando che Vostra Excellenilii pretenda ali comodi et utilitagrave universagrave1e senza dampno et preuiditio suo Vero egraveche li fumari non si contentano parendoli comegrave il vero che non si poteranno ingrassar a suo modo come haqno factO per il passato et poteria achader [bulll Che venetanno adolershyse et supplicar aVosUa Signoria Perograve me egrave parso d~ene aviso per ques~ nostra et farli inteni1er Che questaterril ha solii due membri de li quali li cittadini soi se ne possono aiutashyre e valersene uno egrave il grano laltro egrave larte de la lana et quando se concedesse che li furshynari potessero comprare come hapno facto li tempi passati sana un fare benefitio acinquanshytaocto dessi et dampnificharelreslO de la republicasua quale de questo bon ordine ne receve emolumento grandissimo et se gaude in la Citagrave [percheacute] li fumari portano fuora el denaro et pretendono solo a suo benefitio (AG b 2441 lettera del 13 luglio 1492)
Egrave indubbio che il plauso della Terra fosse da attribuire piugrave alla possibilitagrave per i proshyprietari di accrescere le proprie entrate che a quella dei consumagravetori cittadini e dell arte della lana di trarre beneficio daJla disposizione Egrave significativo che la motivazione pro civitate nori accenni allesistenza di monopoli da parte dei fornai o di artificiose lievitashyzioni dei prezzi per causa lOro nloro attivismograve non egraveonfliggeva per quanto riguarda i prezzi finali della sussistenza con linteresse dei produttori cittadini E daltra parte largomentodello stomo dal metFato cittadino dei profitti incamerati dai fornai -laccushysa consueta a proposito deipistores egrave che fossero in gran parte stranieri (GUBNZl 19824
22) -- era unagiustificazione debole che appassionava piugrave chi concorreva direttamente
491 498 Renzo P Comtore
alla spartizione dei proventi derivanti dalla vendita e dal commercio del grano shylemolumento grandissimo - di chi doveva poi fruire della redistribnzione di tale ricchezza Tale norma avvantaggiava i possidenti cittadini e i gentiluomini ptivilegiashyti in grado di ottenere le tratte di esportazione Sul piano dellappropriazione essi erano in condizione di mettere fuori gioco gli altri possessori che producev~o eccedenze nel Dominio poicheacute si accresceva Igravea loro forza contrattuale e la loro capacitagrave di occUpare i canall commerciali piugrave redditizi Sul piano della commercialiZzazione gli stessi fruivashyno dello smantellamento della rete dintennediazione rappresentata dai fornai Per i rushystici significava perdere un collegamento essenZiale con la cittagrave ed essere emarginati dal mercato urbano nelle campagne o sul broletto di Mantova essi non trovarono piugrave i trashydizionali interlocutori (CORBlJ9RE 2000 228 231-2)
Nel caso di Bologna terra strutturalmente deficitaria e cittagrave dalla vocaiione manishyfatturie~ si costringeva i fornai ad acquistare formenti terrieri presso i solari privati in cittagrave proibendogligrave lincetta nel contado autorizzandoli ad acquistareformentiforeshystieri al di fuori delle mura cittadine presso i sensati da grqno solo a patto che fosseshyro stati smaltiti i grani cittadini a un prezzo talora superiore a quello dei grani dimshyportazione (GUlNZI1982A35 52-3)
Nella Toscana dei Medici il diritto allincetta nel contado venne concesso ai fornai in periodo di bassa congiuntura (in particolare dagli anni Trenta del Seicegravento)Per sostenere i prezzi interni in tal caso essi restavano gli interlocutori principali dei granshydi proprietari semplicemente spostando la loro principale fonte di approvvigionashymento dai solari dei particolari in cittagrave ai granai decentrati delle grandi aziende agrishycole oppure ai mercati rurali su cui affluiva la produzione cerealicola delle grandi fattorie (PuLT QUAOUA 1984 86-9 PuLTQUAOUA 1990 100 106-7)
Laddove non vi egrave come invece succede a Genova una diretta ingerenza del potere pubblico nella vita della corporazione (MAsSA 1999) i fumai di cittagrave - nonostante i lacci e lacciuoli normativi e il lavoro prevalentePlente manuale svolto neiloro laboshyratori - erano dei veri imprenditori dipendenti per il loro profitto - noininalmente stabilito per legge - dalla produttivitagrave del lavoro e dalla dotazione tecnica e finanziaria delle imprese Di ciograve fa fede la grande sperequazione esistente fra le aziende speciashylizzate nena fabbricazione del pane venale in cittagrave (AYMARD 1966 75 VECCHltltJQ 1979 82-3 GUlNZI1982 77 segg PuLT QUAOUA 1984 100 102-3) NellItalia delshyletagrave moderna questi artigiani-imprenditori della filiera del grano trattavano insieme
afarinaifarinaiolifarinottifondachierifontechierifidelariformentinari lasagneshyri maccaronari torallari vermicellari ecc fra il 40 e il 70 per cento del frumento consumato in Cittagrave nelle annate normali (CoRRJTORE 2000 126 segg) e ~ino al 100 per cento nelle annate di carestia (Puu QUAOUA 1984 98-9)
In una ricognizione delle asimmetrie informative del mercato non cegrave gruppo quale i fornai che possa integraverpretare la parte dell agente economico onnisciente Se dunque i regolamenti annonari tendevano a regolare minuziogravesamente la collocazione il volushyme e la durata delle loro scorte cosi come disponevano per gli altri artigiani della fishyliera era per neutralizzare il carattere potenzialmente eversivo di tale accantonamenshyto per i proprietari-venditori Prima ancora che per i consumatori-acquirenti n livello delle scorte rinforzava o attenuava il rischio di monopsonio da parte dei pistores piugrave potenti e facoltosi cosigrave come eventuali tentazioni da parte della categoria di esercitare un dominio egoistico sul mercato del pane (MAITOZZl1983 298)
Sarebbe quindi un errore concepire le scorte dei fornai come entropica allocazione di capitale che sconta lincertezza futura esse venivano gestite secondo criteri di rashyzionalitagrave economica e secondo la migliore efficienza tecnica nonostante i vincoli imposti alla lievitazione degli stock dalle disposizioni annonarie
lA costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
vimini paglia o canne intrecciate (come ceste stuoiecannizzi) in terracotta (addirittura anfore) piuttosto che di tessuto (i sacchi costavano troppo) (PICCINNl1976 397 MAzzA RAvEGol 1983 174-5 Zoo Toce 1990 893-4 COIiITONES11991 35n-36n)
Nella casa del piccolo produttore o del titolare di un piccolo possesso il penw (la scorta domestica) difficilmente eccedeva il consumo famigliare chi fortunato raccoshyglieva piugrave dell annona famigliare e di quanto gli serviva per il campo era spinto a venderselo nei mesi immediatamente successivi alla mietitura e alla trebbiatura per necessitagrave di denaro ma anche per la difficoltagrave di stoccare e conservare il prodotto in condizioni ottimali (MEuvRET 1988 17-9 PuLT QUAOUA 1984 88) e figravenanco per ridurre il rischio di vederselo soffiare da vagabondi e malintenzionati In questo caso in presenshyza di eccedenze (ma probabilmente anche in assenza) il bisogno di liquiditagrave e lalea cospiravano nel ridl1ITe ai minimi termini le scorte giagrave allindomani del raccolto In caso alternativo il contadino che non egrave - ripete Jean Meuvret - un homme daffaires quanshyto un homme de peur concepiva la sua riserva come un fondo di previdenza sul racshycolto futuro da non immettere sul mercato se non nel caso dellapprossimarsi di una messe sicura secondo una logica economica a contrario (MEUVRET 1988 19 e 147)
Era Jl~tente la disparitagrave fra i produttori non solo fra chi era in possesso di eccedenshyze e chi non lo era ma piugrave anqgtra fra chi poteva scegliere in virtugrave di una maggiore capienza economica e unadeguata dotazione tecnica - il mercato piugrave favorevole per i propri grani (il periodo di saldatura dei raccolti) e chi invece li cedeva troppo presto o in controtempo a livelli non ottimali
Nella gerarchia delle abitazioni rurali -- in quel vero e proprio saggio di sociologia che egrave il sesto libro del DeArchitectura di Sebastiano Serlio (scritto fra il 1537 eil 1555 inedito per tutto levo moderno) -- per trovare case attrezzate di granaio occorshyreva ascendere sino alla magione del basso mercante o cittadino fuori della cittagrave (SERLlO 1994 43 segg anche per le successive informazioni) Condizione di cui non potevano fregiarsi invece i ricchi contadini in ~essuno dei tre gradi possibili di ricshychezza al massimo la loro casa poteva essere attrezzata di portici per ricoverare le biade e di unaia per batterle segni di distinzione giagrave fra i mediocri contadini Fra questi perograve avrebbero potuto avvalersene soltanto i fortUIgravelati et di beni et di famishyglia (3deg grado di mediocritagrave) nforno per cuocere il pane e una cantina per conservashyre il vino invece li si sarebbe trovati a partire dai piugrave accomodati fra i poveri contashydini cioegrave al 4deg gradino della scala sociale alla cui base erano da collocare i poveri mendichi con vii capanna (10 grado di povertagrave) i salariati che vivevano delle [loro] fatiche avendo un puoco di terreno (2deg grado di povertagrave) i poveri con qualche beshystiuola et massimamente de buOvi possessori di una stalletta congiunta con la casa 0deg grado di povertagrave)
In sintesi nelle campagne delletagrave pre-industriale pochi avevano scorte pochissimi erano in grado di ricoverarle in un solaro privilegiatissimo chi le incanevava per speculare Dunquefra i conta4ini se si esclude quanto celato nella madia o nella dishyspensa le scorte erano un pri~ilegio di pochi nSerlio nato intorno al 1475 insiste sullimpoverimento delle class~ rurali intervenuto fra gli anni della sua giovinezza e quelli della vecchiezza in cui scrive Sotto il titolo Dellabitazione del ricco contadishyno per tre gradi di ricchezza si preoccupa di puntualizzare
bencheacute al di dogi non se n~ truovi piugrave de tali merceacute delle discordie et di gli animi fieri et ostinati alla vendetta onde per tal cagioni et per le continue guerre et anche pei citadini divoratori de gli altrui beni che con le usure con glinganni con le rapine gli bano impoveriti (SERUO 1994 ~8)
490 RellOP CorrilOle
colto (agosto-settembre-ottobre) e invia di esaurimento almomento della saldatura dei raccolti (aprile-maggio-giugno )1A questo proposito nota Franccedilois Sigaut
Le stockage agrave court terme (moins dune campagne) reacutepond agrave la neacuteCessiteacute cIeacute concilier une offre variable et une demande constante mais toutes deux reacutegulieacuteres et preacutevisibles dans la
pratique il est consideacutereacute comme tiiisant pame du processus ordinaire de la production et ne pose agrave ce titre que desproblegravernes doptimisation assez simples (SlOAUI 1985 602)
La discussione generale sulla razionalitagrave economica delle scorte alimentari in etagrave pre-industriale puograve allora essere ridotta alla fonnulaiione e allo scioglimento di due
semplici quesiti 1 Accertato che laccantonamento digram per la periodicitagrave annuale del ciclo agricoshy
lo epet i vincoli tecnici di un rifomimento spazialmente allargato egrave inevitabile chi egrave conveniente che conservi le scorte chi produce o chi commercia il contadino o il mercante lapossidenzagrave o il popolo i particolari o il pubblico E qual egrave la realtagrave effettiva
2 Se le forme di distribUzione economicamente razionale sono plurali in quale conshytesto e in omaggio a quali interessi piugrave utile il sistema della canova rispetto al sistema delll piazza del mercato e dei solari privati
3 SULLADISTRIBUZIONE DEL GRANO NELUETAgrave PRE-INDUSTRIALE E LA STRUTTURA DELLE SCORTE NEI TERRITORI ITALIANI
Raramente le case contadine erano dotate di attrezzature per la conservazione dei cereali piugrave che elementari Nelle campagne toscane del Quattrocento dunquein unetagrave favorevole al reddito contadino in una regione fra le piugrave ricche dellEuropa pre-indushystriale
pochissime case contadine disponevano del granaio vero e proprio alcune avevano una cella che poteva servire allo stesso scopo ma la maggior parte di quelle abitazioni era priva di spazi destinabili esclugravesivamente alla conservazione dei cereali Perciograve i contenitori dei grani arche casse sacchi bugnole - dovevano trovare posto nelle cucine o nelle camere CMA= RAVEGGI 1983 174)
Le ridotte capacitagrave patrimoniali e reddituali della grande maggioranza dei produttori facevano sIgrave che fosse ampiamente invalso nella conservazione domestica dei grani limshypiego di contenitori in legno (come arche casse botti bugnole tini tinelle corbelli)in
Riguardo ai passi evidenziati di Zanetti e Cipolla egrave neCessario osservare che la principale atteshystazione sullesistenza di stock detenuti da privati che esorbitassero ilfabbisognostagionale tali da essere classificati come immobili=zione di ricchezza (Zanetti) o come beni capitale (Cipolla) a unanalisi piugrave fine si rivela fallace o non direttamente utilizzabile La propalazione dei grani effetshytuata a Pavia fra ilimiddot e il5 maggio 1555 che egrave il fondamento di entrambi i giudizinon mostra una somma di derrate realmente eccedente il fabbisogno delle famiglie per il periodo che manca allarri_ vo dei grani novelli sulla piazza pavese Daltra parte lastessa natura dellistituto della propalazioshyne dei grani cioegrave della denljncia obbligatoria delle scorte da parte dei particolari una misura demergenza decisa in momenti critici dellapprovvigionamento cittadino affiancata quellanno dalshylispezione diretta presso le case dei privati da parte di deputati straordinari avrebbe dovuto consishygliare una maggiore cautela nella sua utilizzazione per individuare regolaritagrave di carattere generale delleconomia pre-industriale
499 La costituzione di scorte granarie pubbliche e la ptlitica ecoMmica degli stati
FONTI
ABEL [1966) W ABEL Agrarkrisen undAgra~kJJnjunktur Eine Geschichte der londshy und Erniihrungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter Hamburg
und Berlin Paul Parey 19662 (la ed -1935 trad it Congiuntura agraria e crisi agrarie Storia dellagricoltura e della produzione alimentare nellEuropa centrashyle dal XIII secolo alletagrave industriale Torino Einaudi 1976 da cui si cita)
AG ARCHIVIO GoNZAGA presso lArchivio di Stato di Mantova AuFANO 1996 E AuFANO Il grano il pane e la politica annonaria a Napoli nel Setshy
tecento Napoli ESI 1996bull AYMARO 1966 M A YMARO Wmise Raguse et le commerce du bMpendant la seconde
moitieacute du XVI siegravecle Pans SEVPEN 1966 CATIINI 1984 M CATl1NI I contadini di San Felice Metamorfosi di un mondo rurale
nellEmilia delletagrave modernIgravel Torino Einaudi 1984 CESTARl 1794 p CESTARI Saggio storico dei Fondachi delle farine di Chioggia e
Pellestrina Venezia A Zatta 1794 CIPOllAJ1965] C M CIPOllA La politica economica dei governi V La penisola
italigraveana e la penisola iberica in Storia economica Cambridge m La cittagrave e la politica economica nel Medioevo Torino Einaudi 1977 (Cambridge 1965) pp 462-496
CIPollA 1974 C M CIPollA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna nMulino 1974
CIpollA 1997 C M CIPOllA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna nMUlino 1997 (6 ed riveduta)
CORRITORE 2000 R P CoRRITORE La naturale abbondanza del Montovano Produshyzione mercato e c01isumi granari a Mantova in etagrave moderna Pavia Universitagrave di Pavia 2000
CORIONBSI 1991 A CORIONBSI Sulla conservazione dei cereali nellItagravelia medioevale Lavoro e tecniche nelle tesnmonlanze laziali (secc XIII-XV) in Rivista di storia dellagricoltura XXXI 1991 l pp 33-49
DELLA VALENTINA 1992 M DELLA VALENTINA I mestieri del pane a ~nezia tra 600 e 700 in Atti dellIstituto [Veneto di Scienze Lettere ed Arti Classe di scienze morali lettere ed arti CL 1991-92 pp 113-217
DIRLMEIER 1984 U DIRLMEIER le condizioni materiali dellesistenza nelle cittagrave tedeshy sche del Basso Medioevo ~iente esterno reddito consumi in Aristocrazia citshy
tadina e ceti popolari nel tprdo Medioevo in Italia e in Germania (a cura di Reinhard Elze e Gina Fasoli) Bologna Societagrave editrice il Mulino 1984 pp 79shy122
FORNASIN 1999 A FORNASIN Il pzercatodei grani di Udine Indagine per una storia dei prew in Friuli (secoli XfI-XVIII) Nota di ricerca del Dipartimento di Scienshyze Statistiche dellUniversit4 degli Studi di Udine 4 1999 pp 1-24 ora in lo La Patria del Friuli in etagrave 1fIOderna Saggi di storia economica Udine Forum 2000 pp 33-60
GRENDI 1986 E GRENOI Lapprccedilwigionamento dei grani nella Liguria del Seicento libera pratica e annone in iMiscellanea storica ligure Studi in onore di Luigi Bulferetti XVIII 1986 2Jp 1021-1047
GUENZI 1981 A GUENZI Ilfrurnfnto e la cittagrave il caso di Bologna nelletagrave moderna in Quaderni storici XVI ~981 46 pp 153-167
GUENZI 1982 A GUENZI Pane ~fornai a Bologna in etagrave moderna Venezia Marsilio 1982
I
489 500 Renzo P CornIOle
GUBNZI1982 A GUEml Sistema annonario e egraveontrollo sociale a Bologna nei seccediloli XVII e XVIII in E SORI (a cura di) Cittagrave e controllo sociale in Italia fra XVIII e XIX secolo Milano F Angeli 1982 pp 293-306
HICKS [1989] 1 R HIClCS A narlcet theory of money Oxford Oxford Universigravety Press 1989 (trad it Una teoria di mercato della monefa Bologna li Mulino 1992 da cui sigrave cita)
JACOPBITI 1965 N L JACOPBITI Monete e prezzi a Cremona dal XVI al XVlIi secolo Cremona Athenaeum CregravemoneJlSe 1965
KAPLAN 1984S L KAPLAN Provisioning Paris Merchants and Millers in the Grain and Flour Trade during the Eighteenth Century Ithaca-London Cornell Univershysity Press 1984~middot
KULA [1962] W KULA Teoria ekonomiczna ustrojufeudalnego Proba modelu Warshyszawa-Panstwowe WydawnictwoNaukowe 1962 (trad it Teoriagrave economica del sistema feudale Proposta di un modello Tormo EinaUdi 1972 ccedilla cui si cita)
WROUSSE [1933] C-E LABRoussE Esquisse du mouvement des prix et des reverws en France au XVIII siegravecle Paris Eacuteditions des Archives Contemporaines 19842 volI (l ed Paris Librairie Dalloz 1933)
MALANtMA 1976 P MALANiMA Aspetti di mercato e prezzi del grano e della segalea Pisa dal 1548 al 1818 in Ricerche di storia moderna vaL I Pisa Pacini 1976 pp ~n
MANToVA 1430 MwroVA 1430 Pareri a Gian Francesco Gonaga per il governo (a cura di M AQrignaniA M Lorenzoni A Mortari C Mozzarelli) MUltova G~ Arcari 1990
MASSA 1999 PMAssA Annona e corporazioni del settore alimentare ~ Genova orshyganizzazione e conflittualitagrave (XVI-XVIII secolo) in A GUENZI PMAssA A MOIOshyu (a cura di) Corporazioni e gruppi professionali nellItalia moderna MilIllO F Angeli 1999 pp 390-403
MATIoZ7J 1983 1 MiJroZ7J F BOLELLI C CmAsBRA D SABBIONI Il politico e il pane a Venezia (157Q-1650) calmieri e governo della sussistenza in Societagrave e storia VI 198320 pp 271-303
MAzzI RAVEOOI 1983 M T MAzzI S RAVEOGI Gli uogravemini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento Firenze Olscbki 1983
MERONI 1957 U MERONI Cremona fedelissima Ciemona Athenaeum Cremonenshy~~~ _
MBUVRBl 1977 J MEuVRsT Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque LouisXIvI La productiograven des ceacutereacuteales dans la France du XVII et du XVIII siegravecle Paris Mouton -EacuteEHSS19772voll
MBUVRET 1988 J MBtJVRf Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque Louis XIv III Le commerce des gralns et la conjoncture Paris EacuteEHss 1988 2 volI
PtCClNNI 1976 G PtCClNNl Wta contagravedina in una capanna dei dintorni di Siena (1250) in ~Archeologia medievale m 1976 pp 395-399
PlNIO 1978 G PINTOII Libro del BiaPaiolo Carestie e annona a Firenze dalla metagrave del 200 al 1348 Fire~ Olscbki 1978
PiNTO 1982 G PtNro La Toscana nel tardo Medioevo Ambiente economia rurale societagrave Fllenze Sansoni 1982
PtRENNE [1933J H PIRENNB La civilisation occidentale au Moyen Age du XIe au mishylieu du XVe siegravecle Paris PUF 1933 (trad it Storia economica e sociale del Meshydioevo Milano Garzanti 1967 da cui si cita)
Lacostituticne di scorte granarie pubbliche e la politica economiegravea degli stati
redigravestribuzione sostenibile dei beni di sussistenza egrave ricercata in questo cielo da quegli stessi particolari che ~amaldeggiano nella produzione negli scambi nei consumi e che costituiscono il nerbo della classe di governo Le scorte pubbliche rappresenteshyrebbero in questa prospettiva un presidio civico e un risltCimento politico e morale ai cOl1ponenti della comunitagrave spossessati delbene supremo dellautarchia alimentare
Resta infine latente unidea del magazzmo pubblico come quasi-mercato cioegrave come luogo volto (1) a risolvere i fa1limentiinfo~vi della piazza del mercato (in meacuterito alle disponi~ilitagrave alle caratteristiche del prodotto alle condizioni di vendita della merce) (2) a ridimensionare lalea per agricoltori consumatori poveri artigiani del comparto alimentare (3) a sostenere i consumi e i profitti privati m funzione anticicli ca in una prospettiva Ilpn meram~nte congiunturale Si tratta in questo caso di un orshyganizzaZionepienattiCnte razio~e Che non opera in maniera saltuaria e riflessa ma in modo continuativo secondo obifttili prefissati di allocazione dei beni primari li funshyzionamento dellacanovagrave (il magazzino pubblico) si porrebbe come strumento inteshygrativo ma no~~igraventeramente so~titutivo delloperare della piazza Si tratterebbe di unaforma di mercato distinta dalla p~ del mercato considerata in seacute e per seacute cosigrave come dallegraveOOmpravendite effetttlate nei solari privati o dalla mera centrallzzazione e redistribuzione di derrate con fi~alitagrave umanitarie La canova rappresenterebbe in tal modo uno dei possibili meccaoi~ di governo delle trllls3ZIgrave~ni locali per risolvere i problemi deUapprovvigionameIto senza intaccare certi interessi di classe (dei proshyprietari ma anche del popolo grasso) S da essere prescelta da autoritagrave e gruppi domishynanti come struttura complementare della piazza del mercato incerti contestiprodutshytivi ed economici La suasacrilizzazione perciograve non esclude la possibilitagrave di un ritorno alle sole compravendite qella piazza e dei solari privati - una volta invertishytosi il trend o spirate le condizioqi economiche della sua istituzionalizzazione
La problematizzazione esorc~ una liquidazione semplicistica del problema delle scorte gran8rle in etagrave pre-industriUgravee nel nome di una loro presunta irrazionalitagrave eco- nomica per il compito di assi~ la sussistenza della popolazione
Le pagine che segUono sono rintroduzione a un lavoro in corso volto a offrire un interpretazione generale di tal~ capitolo fondamentale della politica economica dei governi
in
etagrave pre-industriale
2 SE UN MONDO SENZA SCORTE Egrave INCONGRUO cm Egrave OPPORTUNO CHE LEgrave DETENGA
Nei fatti nel settore granarlo CQni vincoli dell etagrave pre-industriale in tema diprodutshytivitagrave energia trasporti non ha s~nso ipotizzare un mondo senza scorte Se il mercato del grano egrave - come nellEuropa medievale e moderna - un sjstema tendenzialmente chiuso
ad ogni raccolto nuove offe~ aniv(erannol sul mercato mentre la domanda si mant[erragrave] relativamente costantt nel corso dellanno Qualcuno dunque [dovragrave] ~ere delle scorte che saranno elevate ~ubito dopo il raccolto e poi via via minori fino aragshygiungere un livello minimo in prpssimitagrave del successivo raccolto (HICICS [19891 31)
Nella loro forma piugrave sempliceI tali scorte saranno legate allora alla periodi~itagrave anshynuale del ciclo agricolo (che a1iplenta il movimento stagionale dei prezzi ccedilfr LAshyBROlJSSE [1933] 157-66) il loro livello saragrave elevato allindomani del principiLle racshy
501 488 Renzo P Corritore
povero ammassograve nella propria dimora scorte di grano carne ~alata sale candele ecc e la medesima cosa fece lo Stato Nel periodo feudale non venne mai meno nel castello del signore labitudine di tenere da parte grosse scorte per i periodi di emergenza Sucshycessivamente le autoritagrave comunali predisposero il magazzinaggio di grosse derrate specie di grano da rivendere a basso prezzo in periodi di emergenza e nello stesso tempo si preoccuparono di prevenire un indebito accumulo di scorte da parte di specushylatori privati Nelle economie medievali gli stock di derrate di prima necessitagrave rappreshysentarono pertanto una delle piugrave importanti forme di investimento pubblico e privato (CIPOLLA (1965] 468)
Nella prima versione del manualeacute invece fino allinserimento nel 1997 del nuovo capitolo dedicato alla politica economica nell etagrave pre-mdustriale il punto di vista preshyvalente era quello microeconomico entro il perimetro stretto dellindividualismo meshytodologico
Le scorte costano e costano doppiamente Esse implicano il costo diretto che egrave rapshypresentato dal costo del magazzinaggio edal deterioramento eventuale del pr04otto o di parte di esso Se luomo daffari finanzia la costituzione delle scorte con danaro preso a prestito il costo diretto include anche il tasso di interesse pagato Se luomo daffari finanzia con capitale proprio la costituzione delle scorte il costo delle scorte deve inshycludere un costo-opportunitagrave e cioegrave il mancato rendimento (tIllU1cato tasso dinteresse attivo) del capitale finanziario impiegato (CIPOLLA 1974 154)
Le ragioni della costituzione e del mantenimento di scorte alimentari da parte delshylautoritagrave pubblica diventavano unicamente ragioni morali (umanitarie e di buona amministrazione) o di opportunitagrave politica (la fame era la piugrave frequente ligraveausa di sommosse e furori popolari) (CIPOLLA 1974 74)
Nel 1997 si riammetteva dunque linterpretazione originaria della costituzione di scorte pubbliche come strumento di riequilibrio del mercato senza peraltro rinnegare le considerazioni sulla valenza statica di tale forma di investimento per gli agenti economici privati
In merito allutilitagrave economica e al significato delle scorte in etagrave pre-industriale Cishypolla non espresse perciograve sempre lo stesso punto di vista La rassegna delle posizioni da lui assunte anzi permette di individuare tre approcci e tre giudizi costitutivamente diversi sulla funzione delle scorte granarie nellepoca pre-industriale
In prima approssimazione laccumulazione di scorte alimentari mostra il carattere fondamentalmente difensivo delle scelte degli agenti economici pubblici e privati in etagrave pre-industriale La paura la tradizione la superstizione li induce a tabuizzare il rischio la speculazione linvestimento nella produzione e nella distribuzione dei beni essenziali alla vita e ad aderire intimamente a un ideale di economia e societagrave stazionarie aggravando con la norma sociale le istituzioni il comportamento indivishyduale e collettivo leffetto dei condizionamenti materiali delleconomia pre-industriashyle (bassa produttivitagrave agricola alti costi di v~sporto modesta efficienza energetica) esponendo ancor di piugrave la comunitagrave umana ai degravemoni della natura
La seconda interpretazione rigetta luniversale imperio dellhomo oeconomicus rishyscoprendo leteronomia dei fini dellagire economico degli uomini nelletagrave pre-inshydustriale Ia politica economica dello Stato o-delle autoritagrave non persegue puri scopi economici lintegritagrave del corpo sociale fin nelle sue cellule elementari (persone e famiglie) deve essere assicurata secondo i principi e la prassi di uneconomia morale che SOVJa5ta leconomia regolata dal mercato spersonalizzata e antipopolare Una
La costituzione di scorte grantlTie pubbliche e la poligravetigraveca economica degli stati
PuLT QUAGUA 1984 A M PULT QUAGUA Mercato dei prodotti agricoli e magistratushyre annonarie a Pisa nelletagrave moderna in Ricerche di storia moderna a cura di M Mirri voI III Pisa Pacini 1984 pp 57-141
PULT QUAGLIA 1990 A M PULT QUAGLIA Per provvedere ai popoli Il sistema anshynonario nella Toscana dei Medici Firenze Olschki 1990
SERUO 1994 S SERLIO Architettura civile Libri sesto settimo e ottavo nei manoscritshyti di Monaco e Vienna (a cura di F P Fiore) Milano TI Polifi10 1994
SIGAlIT 1985 F SIGAlIT Questions deacuteconomie agrave propos des politiques ceacutereacutealiegraveres et de stockage in Les techniques de conservation des grains agrave long terme leur rale dans la dynamique des systegravemes de cultures et des socieacuteteacutes (sous la direction de M Gast F Sigaut et C Beutler avec la collaboratlon de O Bllchsenschutz) voI III 2 Paris Eacuteditionsdu CNRS 1985 pp 597-606
SMITH [1776 A SMITH An inquiry into the nature and causes ojthe wealth ojnations London W Strahanand T Cadell 17762 volI (trad it Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni Milano A Mondadori 1977 2 volI da cui
si cita) STATlITlBoNACOLSIANI [1313] STATUTI BONACOLSlANl (a cura di E Dezza A M Lorenshy
zoni M Vaini) Mantova GArcari 2002 STATUTI GONZAGHESCHI [1404] STATUTI GONZAGHESCHI presso la Biblioteca comunale di
Mantova ms FV 11 [775]VECCHIATO 1979 F VOCCHIATO Pane e politica annonaria in Terrajerma veneta tra
secolo XV e secolo XVIII (Il caso di Verona) Verona Stamperia Zendrini 1979 ZANETTI 1963 D ZANETTl Contribution agrave leacutetude des structures eacuteconomiques lapshy
provisiQnnement de Pavie au XVI siegravecle in Annales ESC XVIII 1963 1 pp 44-62 ora in lo Fra le antiche torri Scritti di storia pavese Pavia Universitagrave di Pavia 2000 pp 165-182
ZANETTl 1964 D ZANEITI Problemi alimentari di una economia preindustriale Ceshyreali a Pavia dal 1398 al 1700 Torino P Borlnghieri 1964
ZUG TUCCI 1990 H ZUG TuCCI Le derrate agricole problemi materiali e concezioni mentali della conservazione in Lambiente vegetale nellalto Medioevo XXXVII Settimana di studio del Centro italiano di studi sullalto Medioevo (30 marzo-5 aprile 1989) Spoleto Centro italiano di studi sullalto Medioevo 1990 voI n pp 865-902
496 493
Renzo P Corritore
appare altrettanto astratto dogmatico o virtuale del principio di mercato (Market Pri1lciple) che il medesimo gli contrappone Henri Pirenne parlando della politica annonaria dei comuni medievali avverte Lapplicazione del principio della vendita diretta ebbe numerosi eccezioni (PumNNE [1933] 193n)
Nel caso di Mantova la scelta della Piazza egrave facoltativa per i terrieri COn eccedenze Gli Statuti signorili che si rifanno largamente alle raccolte statutarie comunali non sancivano alcun obbligo in proposito (v SVJUTI BONACOLSIANI [1313] libro m rubr 55 De mercato blave 253 STATlITl GoNZAOHESCHI [1404J libro m rubr 93 De mercato blave fiendo in civitate Mantue f 73v) Decreti di carattere straordinario e regolamenshytazioni transitorie correggevano il tiro Nel 1405 in piena saldatura dei raccolti si c0shy
strinse a rifornire forzosamel)~ la piazza concentrandovi tutte le contrattazioni Nel 1417 si obbligograve a riservare al mercato un terzo del frumento introdotto in cittagrave (CORRIshyTORE 2000 235-6) Ma sono atti straordinari che non sopravvissero nel migliore dei casi piugravedi qualchelustro (MANroVA 1430 88 90 181) A Mantova la Piazza era affianshycata da un granaio pubblico la Domus del mercato (altrove definito Folllico o Fonrego del mercato) in cui avrebbero dovuto prolungarsi le contrattazioni oltre lorario e i giorshyni deputati (venerdigrave o sabato) rendendo disponibile ciograve che restava invenduto e che non poteva essere ritirato per legge dal mercato Nel 1430 eminenti cittadini sollecitati dal principe lamentavano perograve lincapacitagrave del magazzino - inoperoso in tutto o in parte per il pericolo di crolli -- di rispondere ai bisogni del popolo in una situazione in cUi da parte dei possessori si protestava la difficoltagrave di non poter esitare e smerciare fuori delshyla cittagrave le eccedenze conservate nei solari privati
Item videtur quod valde utille foret civibus Mantue habentibus possessiones et quishybuscumque alijs personis de civitate Mantue aut districtu colligantibus bIada et vina in magna copia ut omni tempore ipsa bIada et vinum possent extrahere de civitate et dishystrictu Mantue et conducere ad Iaea ad que et in quibus ma vendere poterunt cum otdishynibus et dacijs competentibus ipsa tamen civitate semper remanente fulta pro usu dicte civitatis et populi eiusdem ne dieta biada marceschant super granarlis ut hactenus feceshyrunt cum maximo incomodo ipsorum civium (MANTOVA 1430 177-8)
nmedesimo fondaco abbinato al mercato operava a Verona a Ferrara a Vegravenezia a Udine a Chioggia in molte altre cittagrave (MANToVA 1430 100 FORNASIN 1999 7-9 CEshySTAR 1794)
Lintegrale e pedissequa applicazione del principio della piazza di mercato comporshytava - per i vincoli tecnici dell etagrave pre-industriale -la massima affermazione del prinshycipio della canova cioegrave del magazzino pubblico centrale Unico argine alla sua invashydenza era costituito da una distribuzione perequata ab imis del raccolto cioegrave la possibilitagrave - egrave questo il paradosso - di realizzare da parte dei produttori la massima aspirazione nelle societagrave tradizionali lautarchia domestica Piugrave avanzava invece la sperequazione nel reddito e nel patrimonio piugrave da parte dei consumatori privi di scorshyte si impetrava il principio del Magazzino pubblico nella ronna di un efficiente sisteshyma di ricovero conservazione distribuzione delle derrate a garanzia del funzionashymento della Piazza di mercato La disponibilitagrave di crescenti quote di raccolto tuttavia indirizzava i piugrave accomodati verso soluzioni piugrave ghiotte la vendita allingrosso sul mercato cittadino ai fornai o allimpresa pubblica creata a sussidio di questi (o in loro vece) Oppure allopposto lesito delle eccedenze extra muros sui grandi mercatishyemporio regionali per il tramite di mercanti o agenti diretti
Il principio del magazzino pubblico centrale cioegrave laccumulazione di riserve per lo smercio continuo o anticiclico egrave quindi alla sua origine in opposizione solo apparen-
La costirU1ione di scorre granarie pubbliche e la politica economica degli srati
ruoli fiscali non fosserograve in grado di accantonare scorte Nel 1444 a Strasburgo quattro cittadini su dieci non possedevano alcuna riserva cerealicola (DRlMBIER 1984 112)
Nelle cittagrave italiane delletagrave moderna si puograve stimare che non meno di due terzi della popolazione fosse costretta ad acquistare o consumare pane confezionato con grani e farine comperati nelle piazze nelle vie e nelle botteghe cittadine oppure ottenuti come compenso del proprio servizio nelle casate (CORRrroRE 2000 126-36 MA11oZZI 1983 27~-82) Evidentemente questa fascia di lavoratori salariati non possedeva -shyper definizione - neacute scorte neacute depositi personali e nel primo caso era strettamente dipendente dal mercatograve urbano acquistando la sua sussistenza con frequenza non piugrave che settimanale (essendo costretti a comprare il pane tutti i giorni allafinestra si dishyceva a Genova [GRENDI1986 1031])
Ma anche fra i citiOdini con possesso extra moenia la distribuzione delle scorte era tuttaltro che egalitaria A Prato nel 1339
A parte gli enti religiosi sette famiglie [ ] avevano ii disposizione piugrave di mille staia di granaglie (circa 18 tonnellate) fino a un massimo di 3500 Altri venti nuciei familiashyri avevano scorte comprese tra le 500 e le 1000 staia (PINTO 1978 129n)
A Mantova nei magazzini ducali nellultima parte del 500 erano ammassati non meno di un ottavo talora piugrave di un quarto delle riserve cittadine di grani panificabili (CoRRITORE 200081-6) A Pavia nel corso dello stesso secolo e allinizio di quello successivo nei solagraveri di una sessantina di famiglie si concentrava non meno del 40 per cento dellintera offerta cittadinIgrave di frumento(ZANBUgrave11964 70-7) Anche in questo caso egrave utile sapere che nelle cittagrave tedesche esistevano mercanti (ad Augusta RatisboshyDa Norimberga) in grado di axnPmssare riserve da 6 a 45 tonnellate e che a Francoshyforte nel 1488 due patrizi totali~zavano insieme un terzo delle scorte cerealicole dei particolari nella cittagrave alta (DnuMmER 1984113)
Ritenere tali soggetti sprovv~uti al punto di incanevare grani con il solo scopo di esorc~ i pericoli della Fstia egrave perlomeno riduttivo A grandi solari comshyspondevano vaste familiae e pIftore di servi tori e ospiti ma tali scorte eccedevano largamente la sussistenza del maggiore palazzo nobiliare o patrizio senza peraltro costituire un fondo di accantonafoento eccedente il fabbisogno della cittagrave a meno che non vi fosse la concreta possibilitagrave di commercializzare il surplus sui mercati esteri Come nota infatti Adam Smith
a meno che leccedenza non possa essere esportata in tutte le circostanze ordinarie i coltivatori staranno molto attenti a non produrre e gli importatori a non importare mai una quantitagrave maggiore di quell~ che egrave strettamente richiesta dal consumo del mercato interno Questo mercato saragrave difficilmente sovrafomito ma saragrave in generale sottoriforshyDito dato che coloro che svolgqno lattivitagrave per rifomirlo avranno in generale il timore che la loro merce possa rimanete invenduta (SMlTH [1776] 528)
Lipotesi egrave suffragata dai cas~ storici conosciuti A Bologna macrodistretto serico dellevo moderno laddove gli ipteressi manifatturieri e mercantili avrebbero dovuto consigliare una sussistenza a b~on mercato per tenere basso il costo del lavoro le istituzioni annonarie operavano per garantire con il calmiero deljorme1lto la monetizshyzazione della rendita granaria dei possidenti - strutturalmente incapace di coprire il fabbisogno della cittagrave anchea rischio della carezza dei viveri contingentando il mercato dei grani forestieri (GtJFNZl1982A 37-76) Di fatto
495 494 Renzo P Corrllnre
In ogni caso si tendeva a limitare al minimo indispensabile lemiddot importazioni di frushymento per evitare che stocks invenduti potessero turbare la collocazione dei grani tershyrieri nel nuovo anno agrario (GuENZI 1981 153)
In tutti i centri comunque la tendenza a ritardare la vendita del surplus nei mesi della saldatura lutilizzo di depositi specializzati con personale addetto alla custodia al conshydizionamento e alla commercializzazione del prodotto ponevano i grandi proprietari di biade su un gradino superiore e diverso rispetto al resto della cittagrave Laccantonamento di grani per questa cupola di possessori rispondeva al principio dellutilitagrave soggettiva atshytesa e richiedeva sia capitale fisso sia capitale circolante per raggiungere gli scopipreshyfissati un profitto speculativo la valorizzazione della rendita
In molte cittagrave i possessori non avrebbero dovuto trattenere in casa piugrave grano e farina di quantoprescritto dalla legge cioegrave il consumo mensile per bocca - fissato anchesshyso statutariamente - per arrivare al nuovo raccolto Ma i cittadini credeVano veramenshyte ai loro comandamenti Egrave lecito dubitare La norma era scolpita negli Statuti e pubshyblicamente violata con la complicitagrave dll1e autoritagrave e dei groppi professionali interessati alla distribuzione del grano nelle sue ~arie forme
Nelle annate ordinarie la quota di grano auto consumato - cioegrave non acquistata sul mercato - nelle cittagrave italiane dell evo moderno rappresentava fra il 30 e il 60 per censhyto del fabbisogno urbano di frumento
Nella capitale dei Gonzaga nel 1615 si valutava che su 27000 bocche
il terzo [di] gentilhuomini fittadri servitori et altri [ ] non comprano biada et gli duoi tenigrave tra poveri artisti mercanti fomari fondachieri hebrei et altri [bull] non possono in tutto levar sufficientemente la somma de detti dua terzi sl che saranno boshychegrave 18000 che compraranno biada (COIUUTORl 2000 126)
AVenezia a cavaliere fra XVI e XVII secolo alla mensa delle casade si dispensava circa un terzo del frumento consumato ordinariamente in cittagrave (AMARD 1966 74 MATTOZZI 1983 281) ABologna per tutto il Seicento i fornai che impastavano farine in conto lavorazione per i particolari pareggiavano piugrave o meno il numero di quelli da scqffa che smerciavano pane venale (GUENZI 1982A
27) Peraltro la proporzione a Rialto tra chi lavorava per le casade e chi vendeva pane al pubblico - 65 Jo~ri a fronte di 44-48 pistori negli anni 1583-1685 (DELLA VALBNTINA 1992 143-4 167 192-3) - fa ritenere la struttura del mercato del pane felsinea non molto dissimile da quella veneziana Nelle cittagrave liguri o toscane sei-settecentesche la porzione autocon sumata quando il raccolto era buono era anche piugrave elevata (GRENDI 1986 1024-6 1034 PuLT QUAOUA 1984 98-104 PULT QUAGUA 1990 171-2) A Napoli nel 1758 a Monasteri Luoghi pii e Particolari eta riservato il 28 per cento del consumo cittadishyno di frumento (AuFANO 1996 37n)
Lelevato numero di servi domestici persone al servizio delle casate faceva sigrave che in alcuni palazzi si concentrassero masse cospicue di grano per la spesa familiare Ma accanto ad esse gli operatori dell annona -- la stessa povertagrave -- si auguravano che vi fosse sempre anche la materia per rifornireil mercato e i forni cittadinimiddot nella fase piugrave delicata del ciclo annuale il periodo di saldatura dei raccolti Come spiegare altrimenshyti la norma che imponeva ai grossi detentori di biade (non esclusi enti e opere pie) in varie cittagrave italiane dellevo moderno la vendita straordinaria in primavera dellegrave ecshycedenze ammassate in granaio (per Pisa e la Toscana v PuLT QUAGUA 1984 88-9)
A Mantova nel 1554 si stabiliva che i patroni che avessero fruito in cittagrave di piugrave di 20 sacchi di grano come porzione dominicale avrebbero dovuto coilservare in granaio
lA costituzioni digrave scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
il 4 per cento per le necessitagrave dei consumatori dei fornai e dei Jontachieri quando fosse mancato il prodotto sulla piazza o nelle offerte deisensali Nel 1603 ci si preocshycupograve di elevare la quota al 6 per cento (CORRlTQRE 2000 237n) Beninteso le vendite sarebbero avvenute ai valori di mercato Lo stesso sistema vigeva a Cremona (6 per cento nel 1608 e nel 1612) (MERON 1957 59n 63 JACOPETl1 1965 128) ea Verona Qui una delibera consiliare del 1549 autorizzava per la prima volta
[il deputati [alle Biadel [a] tassar e comandar con quelle pene che al Clarissimo Podestagrave pareragrave quella quantitagrave di biade a ciascuno secolare o eclesiastico sia di qual grado o condittione esser si voglia che havesse biade in questa cittagrave oltre il viver suo
(VOCCHIATO 1979 145)
La tassa sarebbe stata stabilita - da11558 - per sorteggio fra le casate che avessero introdotto in cittagrave dai propri possedimenti piugrave di 70 minali per rifo1llire il Mercato delle biave Essa-venne anche incrementata nella stessa occasione dal 5 al6 per censhyto per restare in vigore fino al 1631 (VECCHIATO 1979 141-58)
Quest9 tiIfo di normativa nasce e si affiogravea in ambito amministrativo perciograve echeggia la realtagrave molto meglio della veneranda legge generale
Da tali disposizioni si deducono alcuni fatti incontrovertibili 1entro la cerchia cittadina esistevano scorte private eccedenti la spesa delle famiglie
in violazione in molti casi della legge statutaria 2il possesso della terra che solo assicurava lautarchia delle casate era il piugrave-potente
fattore di discriminazione fra i cives tanto da precipitare nel girone dei pauperes la moltitudine che acquistava correntemente la sussistenza nellarea urbana
3fra gli stessi possidenti cittadini esisteva uneacutelite che non solo conservava scorte oltre il viver suo ma che si proponeva egoisticamente di speculare ritardando limshymissione dei grani sulle piazze cittadine o che a~endeva il momento piugrave opportuno per smerciarli allesterno nelle grandi piazze frumentarie come livorno Desenzashyno Legnago Romano (di Lombardia) ecc
4lineguaglianza fra i cives tese ad aggravarsi con la metagrave del 500 poicheacute questi reshygolamenti innovano quasi sempre disposizioni generali risalenti al tardo Medioevo che sancivano lobbligo di convogliare il surplus sulla piazza cittadina segno di una distribuzione del reddito originariamente meno sbilanciata A Cremona gli Statuti del 1388 obbligavano - cosl egrave ancora nel 1510 - a vendere il
sovrappiugrave in Piazza Maggiore sul mercato pubblico dei grani (MERON 1957 59n
63)A Pisa il rescritto che imponeva di effettuare le vendite al minuto in platea bladi
risale al 1401 MALANlMA 1976 293) lobbligo era ribadito ancora nel 1548 ma nella seconda metagrave del secolo XVI si affermava la pratica di vendere fuori mercato tanto che nel 1581 il Magistrato dei Nove dovette intervenire per far vendere i grani delle comunitagrave degli enti e dei luoghimiddotpii soltanto da marzo-aprile in piccole quantitagrave sul mercato (PULT QUAGUA 1984 81-91) La disposizione per altro si applicava allinteshyro Stato (PULT QUAGUA 1984 88)
Tuttavia non egrave da pensare che il principio della concentrazione delle compravendite sulla piazza di mercato cittadina fosse universale universalmente rispettato e sopratshytutto perenne La centralizzazione del grano non significa automaticamente lobbligo di vendita diretta sulla Piazza deiformenti Affermare come Steven L Kaplan che
There was no single more important regulation concerning tbe provisioning trade tban tbe requirement tbat alI transactions occur in tbe marketplace (KAPLAN 1984 27)
494 495 Renzo P Corritore
In ogni caso si tendeva a limitare al minimo indispensabile le importazioni di frushymento per evitare che stocks invendutigrave potessero turbare )a collocaziolle dei grani tershyrieri ileI nuovo anno agrario (GUENZI 1981 153)
In tutti i centri comunque la tendenza a ritardare la vendita del surplus nei mesi della saldatura lutilizzo di depositi specializzati con personale addetto alla custodia al conshydizionamento e alla commercializzazione del prodotto ponevano i grandi proprietari di biade su un gradino superiore e diverso rispetto al resto della cittagrave Laccantonamento di grani per questa cupola di possessori rispondeva al principio dellutilitagrave soggettiva atshytesa e richiedeva sia capitale fisso sia capitale circolante per raggiungere gli scopipreshyfissati un profitto speculativo la valorizzazione della rendita
In molte cittagrave i possessori non avrebbero dovuto trattenere in casa piagrave grano e farina di quantoprescritto dalla legge cioegrave il consumo mensile per bocca ~- fissato anchesshy
so statutariamente --per arrivare al nuovo raccolto Ma i cittadini credevano veramenshyte ai loro comandamenti Egrave lecito dubitare La norma era scogravelpitagrave negli Statuti e pubshyblicamente violatamiddot con la complicitagrave dccedillle autoritagrave e dei gruppi professionali interessati alla distribuzione del grano nelle sue varie forme
Nelle annate ordinarie la quota di grano autoconsumato - cioegrave non acquistata sul mercato - nelle cittagrave italiane dell evo moderno rappresentava fra il 30 e i160 per censhyto del fabbisogno urbano di frumento
Nella capitale dei Gonzaga nel 1615 si valutava che su 27000 bocche
il terzo [di] gentilhuomini ligravettadri servitori et altri [ ] non comprano biada et gli duoi terzi tra poveri artisti mercanti fomari fondachieri hebrei et altri [ l non possono in tutto levar sufficientemente la $omma de detti dua terzi sl che saranno boshyche 18000 che compraranno biada (CoRRlTORB 2000 126)
AVenezia a cavaliere fra XVI e xvn secoioalla mensa delle casade si dispensava circa un terzo del frumento consumato ordinariamente in cittagrave (AYMARD 1966 74 MArroZZI 1983 281) A Bologna per tutto il Seicento i fornai che impastavano farine in conto lavorazione per i particolari pareggiavano piil o meno il numero di quelli da scaifa che smerciavano pane venale (GUBNZI 1982 27) Peraltro la proporzione a Rialto tra chi lavorava per le casade e chi vendeva pane al pubblico - 65 fOf7lri a fronte di 44-48 pistori negli anni 1583-1685 (DELLA VAUNTINA 1992 143-4167 192-3) - fa ritenere la struttura del mercato del pane felsinea non molto dissimile da quella veneziana Nelle cittagrave liguri o toscane sei-settecentesche la porzione autoconshysumata quando il raccolto era buono era anche piil elevata (ORENOI 1986 1024-6 1034 PuLT QUAGLIA 1984 98-104 PULT QUAOLIA 1990 171-2) A Napoli nel 1758 a Monasteri Luoghi pii e Particolari eta riservato il 28 per cento del consumo cittadishyno di frumento (AuFANO 1996 370)
Lelevato numero di servi domestici persone al servizio delle casate faceva si che in alcuni palazzi si concentrassero masse cospicue di grano per la spesa familiare Ma accanto ad esse gli operatori dellannona -lastessapovertagrave __ si auguravano che vi fosse sempre anche la materia per rifornire il mercato e i forni cittadini nella fase piil delicata del ciclo annuale il periodo di saldatura dei raccolti Come spiegare altrimenshyti la norma che imponeva ai grossi detentori digrave biade (non esclusi enti e opere piegrave) in varie cittagrave italiane dellevo moderno la vendita straordinaria in primavera delle ecshyredenze ammassate in granaio (per Pisa e la Toscana v PuLT QUAGLIA 1984 88-9)
A Mantova nel 1554 si stabiliva che i patroni che avessero fruito in cittagrave di piugrave di 20 sacchi di grano come porzione dominicale avrebbero dovuto conservare in granaio
lA costituzione di SC0114 granarie pubbliche e la politica economica degli stati
il 4 per cento per le necessitagrave dei consumatori dei fornai e dei fontachieri quando fosse mancato il prodotto sulla piazza o nelle offerte deimiddotsensati Nel 1603 ci si preocshycupograve di elevare la quota al 6 per cento (CoRRlTORE 2000 237n) Beninteso le vendite sarebbero avvenute ai valori di mercato 10 stessa sistema vigeva a Cremona (6 per cento nel 1608 e nel 1612) (MERON 1957 -59n 63 JACOPETl11965 128) ea Verona Qui una delibera consiliare del 1549 autoruzava per la prima volta
[i] deputati [alle Biade) [al tassar e comandar con quelle pene che al Clarissimo Podestagrave pareragrave quella quantitagrave di biade a ciascuno secolare o eclesiastico sia di qual grado o condittione esser si voglia che havesse biade in questa cittagrave oltre il viver suo (VBCClI1ATO 1979 145)
La tassa sarebbe stata stabilita - dal 1558 - per sorteggio fra le casate che avessero introdotto in cittagrave dai propri possedimenti piagrave di 70 minali per rifornire il Mercato delle biave Essaveane anche incrementata nella stessa occasione dal 5 al6 per censhyto per restare in vigore fino al 1631 (VECCHIATO 1979 141-58)
Questccedil tijlo di normativa nasce e si affuia in ambito amministrativo perciograve echeggia la realtagrave molto meglio della veneranda legge generale
Da tali disposizioni si deducono alcuni fatti incontrovertibili 1entro la cerchia cittadina esistevano scorte private eccedenti la spesa delle famiglie
in violazione in molti casi della legge statutaria 2il possesso della terra che solo assicurava lautarchia delle casate era il piugravemiddotpotente
fattore di discriminazione fra i cives tanto da precipitare nel girone dei pauperes la moltitudine che acquistava correntemente la sussistenza nellarea urbana
3fra gli stessi possidenti cittadini esisteva uneacutelite che non solo conservava scorte oltre il viver suo ma che si proponeva egoisticamente di speculare ritardando limshymissione dei grani sulle piazze cittadine o che a~endeva il momento piagrave opportuno per smerciarli allesterno nelle grandi piazze frumentarie come Uvorno Desenzashyno Legnago Romano di Lombardia) ecc
4lineguaglianza fra i cives tese ad aggravarsi con la metagrave del 500 poicheacute questi reshygolamenti innovano quasi sempre disposizioni generali risalenti al tardo Medioevo che sancivano lobbligo di convogliare il surplus sulla piazza cittadina segno di una distribuzione del reddito originariamente meno sbilanciata shyACremona gli Statuti del 1388 obbligavano - cosl egrave ancora nel 1510 - a vendere il
sovrappigraveagrave in Piazza Maggiore sul mercato pubblico dei grani (MERON 1957 59n 63)
A Pisa il rescritto che imponeva di effettuare le vendite al minuto in platea bladi risale al 1401 (MALANIMA 1976 293) lobbligo era ribadito ancora nel 1548 ma nella seconda metagrave del secolo XVI si affermava la pratica di vendere fuori mercato tanto che nel 1581 il Magistrato dei Nove dovette intervenire per far vendere i grani delle comunitagrave degli enti e dei luoghi pii soltanto da marzo-aprile in piccole quantitagrave sul mercato (PULT QUAGLIA 1984 8191) La disposizione per altro si applicava allinteshyro Stato (PULT QUAGLIA 1984 88)
Tuttavia non egrave da pensare che il principio della concentrazione delle compravendite sulla piazza di mercato cittadina fosse universale universalmente rispettato e sopratshytutto perenne La centralizzazione del grano non significa automaticamente lobbligo di vendita diretta sulla Piazza deiformenti Affermare come Steven L Kaplan che
There was no single more important regulation conceming the provisioning trade han the requirement that ali transactions occur in the marketplace (KAPuN 1984 27)
493 496 Renw P Corritore
appare altrettanto astratto dogmatico O virtuale del principio di mercato (Market Principle) che il medesimo gli contrappone Henri Pirenne parlando della politica annonaria dei comuni medievali avverte Lapplicazione del principio della vendita diretta ebbe numerosi eccezioni (PIRENNE [1933] 193n)
Nel caso di Mantova la scelta della Piazza egrave facoltativa per i terrieri con eccedenze GliStatuti signorili che si rifanno largamente alle raccolte statutarie comunali non sancivano alcun obbligo in proposito (v SYJI1l BONACOLSlANI [1313] libro ID rubr 55 De mercato blave 253 STATUTI GoNZAOHESCHI [1404] libro m rubr 93 De mercato blave fiendo in civitate Mantue f 73v) Decreti di carattere straordinario e regolamenshytazioni transitorie correggevano il tiro Nel 1405 in piena saldatura dei raccolti si coshystrinse a rifornire forzosamen~e la piazza concentrandovi tutte le contrattazioni Nel 1417 si obbligograve a riservare al mercato un terzo del frumento introdotto in cittagrave (CoRRIshyTORE 2000 235-6) Ma sono atti straordinari che non sopravvissero nel migliore dei casi piugrave di qualchelustro (MANToVA 1430 88 90 181) A Mantova la Piazza era affianshycata da un granaio pubblico la Domus del mercato (altrove definito Fornico o Fontego del mercato) in cui avrebbero dovuto prolungarsi le contrattazioni oltre lorario e i giorshyni deputati (venerdl o sabato) rendendo disponibile ciograve che restava invenduto e che non poteva essere ritirato per legge dal mercato Nel 1430 eminenti cittadini sollecitati dal principe lamentavano pero lincapacitagrave del magazzino - inoperoso in tutto o in ~per il pericolo di crolli - di rispondere ai bisogni del popolo in una situazione in cui da parte dei possessori si protestava la difficoltagrave di non poter esitare e smerciare fuori delshyla cittagrave le eccedenze conservate nei solari privati
ltem videtur quod valde utille foret civibus Mantue habentibus possessiones et quishybuscumque alijs personis de civitate Mantue aut districtu colligantibus bIada et vina in magna copia ut amni tempore ipsa bIada et vinum possent exttahere de civitate et dishystrictu Mantue et conducere ad Iaea ad que et in quibus illa vendere poterunt cum otdigraveshynibus et dacijs competentibus ipsa tamen civitate semper remanente fulta pro usu diete civitatis et populi eiusdem ne dicta bIada mateeschant super granariis ut hactenus fecemiddot runt cum maximo incomodo ipsorum civium (MANToVA 1430 177-8)
Il medesimo fondaco abbinato al mercato operava a Verona a Ferrara a Venezia a Udine a Chioggia in molte altre cittagrave (MANToVA 1430 100 FORNASIN 1999 7-9 CBshySTARl1794)
Lintegrale e pedissequa applicazione del principio della piazza di mercato comporshytava - per i vincoli tecnici dell etagrave pre-industriale -la massima affermazione del prinshycipio della canova cioegrave del magazzino pubblico centrale Unico argine alla sua invashydenza era costituito da una distribuzione perequata ab imis del raccolto cioegrave la possibilitagrave egrave questo il paradosso di realizzare da parte dei produttori la massima aspirazione nelle societagrave tradizionali lautarchia domestica Piugrave avanzava invecela sperequazione nel reddito e nel patrimonio piugrave da parte dei consumatori privi di scorshyte si impetrava il principio del Magazzino pubblico nella forma di un efficiente sisteshyma di ricovero conservazione distribuzione delle derrate a garanzia del funzionashymento della Piazza di mercato La disponibilitagrave di crescenti quote di raccolto tuttavia indirizzava i piugrave accomodati verso soluzioni piugrave ghiotte la vendita allingrosso sul mercato cittadino ai fornai o allimpresa pubblica creata a sussidio di questi (o in loro vece) Oppure allopposto lesito delle eccedenze extra muros sui grandi mercatishyemporio regionali per il tramite di mercanti o agenti diretti
Il principio del magazzino pubblico centrale cioegrave laccumulazione di riserve per lo smercio continuo o anticiclico egrave quindi alla sua origine in opposizione solo apparen-
La costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
ruoli fiscali non fossero in grado di accantonare scorte Nel 1444 a Strasburgo quattro cittadini su dieci non possedevano alcuna riserva cerealicola (DIIUMBIER 1984 112)
Nelle cittagrave italiane delletagrave moderna si puograve stimare che non meno di due terzi della popolazione fosse costretta ad acquistare o consumare pane confezionato con grani e farine comperati nelle piazze nelle vie e nelle botteghe cittadine oppure ottenuti come compenso del proprio servizio nelle casate (CoRRITORE 2000 126-36 MAnoZZI 1983 27~-82) Evidentemente questa fascia di lavoratori salariati non possedevashyper definizione -- neacute scorte neacute depositi personali e nel primo caso era strettamente dipendente dal mercato urbano acquistando la sua sussistenza con frequenza non piugrave che settimaIIgraveale (essendo costretti a comprare il pane tutti i giorni alla finestra si dishyceva a Genova (GRENDI 1986 1031])
Ma anche fra i citUutini con possesso extra moenia la distribuzione delle scorte era tuttaltro che egalitaria A Prato nel 1339
A patte gli enti religiosi sette famiglie [ bull ] avevano Il disposizione piugrave di mille staia di granaglie (circa 18 tonnellate) fino a un massimo di 3500 Altri venti nuclei familiashyri avevano scorte comprese tra le SOOe le 1000 staia (PINTO 1978 129n)
A Mantova nei magazzini ducali nellultima parte del 500 erano ammassati non meno di un ottavo talora piugrave di un quarto delle riserve cittadine di grani panificabili (CORRlTORE 2000 81c6) A Pavia nel corsq dello stesso secolo e allinizio di quello successivo nei sozagraveri di una sessantina di famiglie si concentrava non meno del 40 per cento dell intera offerta cittadin8 di frumentomiddot (ZANJin 1964 70-7) Anche in questo caso egrave utile sapere che nelle cittagrave tedesche esistevano mercanti (ad Augusta Ratisboshyna Norimberga) in grado di ~sare riserve da 6 a 45 tonnellate e che a Francoshyforte nel 1488 due patrizi totalizzavano insieme un terzo delle scorte cerealicole dei particolari nella cittagrave alta (DlRLMB1ER 1984113)
Ritenere tali soggetti sprovv~duti al punto di incanevare grani con il solo scopo di esorcizzare i pericoli della clarestia egrave perlomeno riduttivo A grandi solari corrishyspondevano vaste familiae e plftore di servitori e ospiti ma tali scorte eccedevano largamente la sussistenza del D-aggiore palazzo nobiliare o patrizio senza peraltro costituire un fondo di accantofilljnento eccedente il fabbisogno della cittagrave a meno che non vi fosse la concreta possibfjitagrave di commercializzare il surplus sui mercati esteri Come nota infatti Adam Smith
a meno che leccedenza non possa essere esportata in tutte le circostanze ordinarie i coltivatori staranno molto attenti a non produrre e gli importatori a non importare mai una quantitagrave maggiore di quell~ che egrave strettamente richiesta dal consumo del mercato interno Questo mercato saragrave difficilmente sovrafornito ma saragrave in generale sottomorshynito dato che coloro che svolgono lattivitagrave per mornirlo avranno in generale il timore che la loro merce possa rimane~ invenduta (SMITH[l776] 528)
Lipotesi egrave suffragata dai cas storici conosciuti A Bologna macrodistretto serico dellevo modemoladdove gli interessi manifatturieri e mercantili avrebbero dovuto consigliare una sussistenza a b~on mercato per tenere basso il costo del lavoro le istituzioni annonarie operavano per-garantire con il calmiero delformento la monetizshyzazione della rendita granaria dei possidenti - strutturalmente incapace di coprire il fabbisogno della cittagrave - anche ~ rischio della carezza dei viveri contingentando il mercato dei grani forestieri (GupaI 1982 37-76) Di fatto
492 Renzo P COITitore
Tale disparitagrave sociale si riverberava sulla struttura del commercio cerealicolo La funzione dei piccoli commercianti di biade (granaiolibull biadaiolifarinaioli balshy
zarotti cavallanti vatlcali ecc) era infatti ancillare alla capacitagrave di affacciarsi sul nercato della fascia marginale deipossidenti con eccedenze Solo che nelle annate di abbondanza si venficavano ingorghi nell offerta di grano che deprimevano i prezzi e incentivavano i piccoli produttori a smerciare direttamente le eccedenze allindomani del raccolto nellarea urbana anche al di fuori dei luoghi deputati (MATI02ZI 1983 278281-2 300n PULr QUAGLIA 1984 86) Mentre nelle annate di penuria si contraeshyva drasticamente proprio questo segmento dellofferta (ABa [1966Jmiddot 22-4 KULA [1962J 73-4 CATrINI1984 111-23 PuIr QUAGUA 1984 88) scatenando nelle campashygne una caccia al grano-merce la cui quota piugrave consistente era detenuta dai grandi proprietari dai maggiori affittuari dai percettori di canoni diritti o rendite in grano e la cui quota residua era piugrave facilmente preda di chi occupava posizioni chiave nellasshysetto terriero nella catena dei diritti nel credito alla produzione e al consumo
Tanto la distribuZione era frammentata nelle annate di abbondanza tanto in epoc~ di penuria il commercio del grano diventava un affare di pochi In questo caso lazioshyne dei mercanti diVentava dimpiccio sul mercato interno dove la coperta si restringeshyva per i proprietari e gli imprenditori agricoli (KULA [1962] 56-61 CATl1NI 1984 114-8) - dove la necessitagrave di ricorrere al credito da parte dei piccoli possessori poneva questi nelle mani degli agenti dei proprietari dei percettoridi canoni diritti o rendite - dove i piccoli proprietari vedevano minacciata la loro stessa condizione da parte di chi controllava localInente in maniera capillare e decentrata il mercato del denaro e dei beni necessari alla riproduzione (sementi strumenti cibo) La soluzione era quelshyla di precludere amministrativamente ai sensali e ai commercianti di grani i mercati locali su istigazione dei medi possessori le cui occasioni di normale profitto agrario soffrivano un ridimensionamento e che si vedevano costretti a impegnarsi ccedilon tutte le loro forze per integrare le proprie entrate accaparrandosi le magre eccedeiiZe disponishybili nelle campagne e nei borghi rurali (PuLT QUAGLIA 1984 84-8 PULT QUAGLIA 1990 lO7-14)
TI destino dei piccoli commercianti in grano era quindi quello di occupare una posishyzione margilJale nel mercato del grano (MBlNrurr 1977 30 PINTO 1978 13 MAITOZZl 1983 277) e di operare - non solo a causa degli ordinamenti annonari - secondo una logica di corto respiro in cui non era contemplata neacute la conservazione di grani a lungo termine neacute lutilizzo di depositi piugrave che provvisori Come per i piccoli possidenti non si puograve parlare ne1loro caso della formazione e del mantenimento di scorte consistenti (MBlNREr 1988 156~7) Non tali comunque da sostenere il reddito contadino nelle stagioni ordinarie e da esercitare sul versante cittadino unefficace azione anticonshygiunturale in caso di carestia
Peraltro in cittagrave la struttura dellofferta era anche piugrave sperequata di quella che si rishyscontra nel contado Che si tratti di Prato nel 1339 (PINTO 1978 129 PINTO 1982 160n e 17In) Pavia negli anni 1539 1555 1513 1602 1603 (ZANEm 1963) o Mantova nellultima parte del secolo XVI (CORRITORE 2000 81-9) la distribuzione delle scorte fra i privati era singolarmente ineguale Lo attesta la rilevanza nellarea urbana della povertagrave cioegrave secondo una definizione coeva di coloro che non vivono di entrate ma sono necessitati ricorrere mattina e sera alle pistorie a comprare il pane per iI vitto loro e delle sue famiglie col denaro che di giomo in giomo si vanno guadagnando (MATshyTOZZI 1983 281) PUOgrave essere utile richiamare la situazione delle cittagrave tedesche nel basso Medioevo in una fase che egrave stata definita da Wilhelm Abellepoca doro degli artigiani e del lavoro salariato si puograve stimare che almeno la metagrave degli iscritti ai
lA costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli statibull middot497
te con il principio della piazza TI mercato pubblico periodico disciplinatola spiagshygiala piazza la loggia o iI recinto riservato alle contrattazioni - coesis~va confabshybriche magazzini e botteghe La stessa piazza per funzionare al meglio secondo il principio dello scambio diretto necessitava di magaZzini di supporto bull
4 LE SCORTE DEI FORNAI CITTADINI
Nellarea urbanagrave e nelle relazioni tra cittagrave e campagna operavano perograve temibili conshycorrenti dei privati possessori I fornai cittadini possedevano le competenze le strutshyture tecniche le relazioni sociali e il credito per incettagravere il prodotto per essere inforshymati tempestivamentesul mercato del grano e potenzialmente per dispensarlo con profitto in qualunque momento Il fatto che il loro operato fosse imprigionato in unarshycaica impalcatura di norme divieti obblighi che risalivano alletagrave romana che ne fashycevano in modo quasi istituzionalizzato il capro espiatorio delle tensioni fra produtshytori di grano povertagrave e autotitagrave non impedisce di affermare che tali vessatorie disposiziograveD1 trovassero la loro principale ragione dessere nella parte che essi giocashyvano di interlocutorilantagonisti dei proprietari terrieri nelladeterminazione del prezshyzo del grano sul mercato locale e nella realizzazione della rendita terriera (GUENZI 19824
35 GUENZI 1982 297) Neacutel caso di Mantova terra comucopia a partire dal 1492 si consend a zentilhomini
cittadini et qualuncho altro di comprare biade nel Dominio per approvvigionare la cittagrave di fatto si sand un diritto allincetta che mise fuori gioco i fornai a cui venne imposto di rifornirsi nei solarimiddotdei cittadini senza avere piugrave la possibilitagrave di effettuare acquisti nel contado e di ritenere a casa scorte superiori amiddotl 00 staia di frumento Lintento della disposhysizione egrave chiarissimo espresso senza reticenze dai Maestri delle Entrate che riportarono al marchese la soddisfazione dei possidenti mantovani per la riforma statutaria
tutta la Terra [cioegrave il Mantovano] ne [egravel rimasta satisfactissirna pensando che Vostra Excellenilii pretenda ali comodi et utilitagrave universagrave1e senza dampno et preuiditio suo Vero egraveche li fumari non si contentano parendoli comegrave il vero che non si poteranno ingrassar a suo modo come haqno factO per il passato et poteria achader [bulll Che venetanno adolershyse et supplicar aVosUa Signoria Perograve me egrave parso d~ene aviso per ques~ nostra et farli inteni1er Che questaterril ha solii due membri de li quali li cittadini soi se ne possono aiutashyre e valersene uno egrave il grano laltro egrave larte de la lana et quando se concedesse che li furshynari potessero comprare come hapno facto li tempi passati sana un fare benefitio acinquanshytaocto dessi et dampnificharelreslO de la republicasua quale de questo bon ordine ne receve emolumento grandissimo et se gaude in la Citagrave [percheacute] li fumari portano fuora el denaro et pretendono solo a suo benefitio (AG b 2441 lettera del 13 luglio 1492)
Egrave indubbio che il plauso della Terra fosse da attribuire piugrave alla possibilitagrave per i proshyprietari di accrescere le proprie entrate che a quella dei consumagravetori cittadini e dell arte della lana di trarre beneficio daJla disposizione Egrave significativo che la motivazione pro civitate nori accenni allesistenza di monopoli da parte dei fornai o di artificiose lievitashyzioni dei prezzi per causa lOro nloro attivismograve non egraveonfliggeva per quanto riguarda i prezzi finali della sussistenza con linteresse dei produttori cittadini E daltra parte largomentodello stomo dal metFato cittadino dei profitti incamerati dai fornai -laccushysa consueta a proposito deipistores egrave che fossero in gran parte stranieri (GUBNZl 19824
22) -- era unagiustificazione debole che appassionava piugrave chi concorreva direttamente
491 498 Renzo P Comtore
alla spartizione dei proventi derivanti dalla vendita e dal commercio del grano shylemolumento grandissimo - di chi doveva poi fruire della redistribnzione di tale ricchezza Tale norma avvantaggiava i possidenti cittadini e i gentiluomini ptivilegiashyti in grado di ottenere le tratte di esportazione Sul piano dellappropriazione essi erano in condizione di mettere fuori gioco gli altri possessori che producev~o eccedenze nel Dominio poicheacute si accresceva Igravea loro forza contrattuale e la loro capacitagrave di occUpare i canall commerciali piugrave redditizi Sul piano della commercialiZzazione gli stessi fruivashyno dello smantellamento della rete dintennediazione rappresentata dai fornai Per i rushystici significava perdere un collegamento essenZiale con la cittagrave ed essere emarginati dal mercato urbano nelle campagne o sul broletto di Mantova essi non trovarono piugrave i trashydizionali interlocutori (CORBlJ9RE 2000 228 231-2)
Nel caso di Bologna terra strutturalmente deficitaria e cittagrave dalla vocaiione manishyfatturie~ si costringeva i fornai ad acquistare formenti terrieri presso i solari privati in cittagrave proibendogligrave lincetta nel contado autorizzandoli ad acquistareformentiforeshystieri al di fuori delle mura cittadine presso i sensati da grqno solo a patto che fosseshyro stati smaltiti i grani cittadini a un prezzo talora superiore a quello dei grani dimshyportazione (GUlNZI1982A35 52-3)
Nella Toscana dei Medici il diritto allincetta nel contado venne concesso ai fornai in periodo di bassa congiuntura (in particolare dagli anni Trenta del Seicegravento)Per sostenere i prezzi interni in tal caso essi restavano gli interlocutori principali dei granshydi proprietari semplicemente spostando la loro principale fonte di approvvigionashymento dai solari dei particolari in cittagrave ai granai decentrati delle grandi aziende agrishycole oppure ai mercati rurali su cui affluiva la produzione cerealicola delle grandi fattorie (PuLT QUAOUA 1984 86-9 PuLTQUAOUA 1990 100 106-7)
Laddove non vi egrave come invece succede a Genova una diretta ingerenza del potere pubblico nella vita della corporazione (MAsSA 1999) i fumai di cittagrave - nonostante i lacci e lacciuoli normativi e il lavoro prevalentePlente manuale svolto neiloro laboshyratori - erano dei veri imprenditori dipendenti per il loro profitto - noininalmente stabilito per legge - dalla produttivitagrave del lavoro e dalla dotazione tecnica e finanziaria delle imprese Di ciograve fa fede la grande sperequazione esistente fra le aziende speciashylizzate nena fabbricazione del pane venale in cittagrave (AYMARD 1966 75 VECCHltltJQ 1979 82-3 GUlNZI1982 77 segg PuLT QUAOUA 1984 100 102-3) NellItalia delshyletagrave moderna questi artigiani-imprenditori della filiera del grano trattavano insieme
afarinaifarinaiolifarinottifondachierifontechierifidelariformentinari lasagneshyri maccaronari torallari vermicellari ecc fra il 40 e il 70 per cento del frumento consumato in Cittagrave nelle annate normali (CoRRJTORE 2000 126 segg) e ~ino al 100 per cento nelle annate di carestia (Puu QUAOUA 1984 98-9)
In una ricognizione delle asimmetrie informative del mercato non cegrave gruppo quale i fornai che possa integraverpretare la parte dell agente economico onnisciente Se dunque i regolamenti annonari tendevano a regolare minuziogravesamente la collocazione il volushyme e la durata delle loro scorte cosi come disponevano per gli altri artigiani della fishyliera era per neutralizzare il carattere potenzialmente eversivo di tale accantonamenshyto per i proprietari-venditori Prima ancora che per i consumatori-acquirenti n livello delle scorte rinforzava o attenuava il rischio di monopsonio da parte dei pistores piugrave potenti e facoltosi cosigrave come eventuali tentazioni da parte della categoria di esercitare un dominio egoistico sul mercato del pane (MAITOZZl1983 298)
Sarebbe quindi un errore concepire le scorte dei fornai come entropica allocazione di capitale che sconta lincertezza futura esse venivano gestite secondo criteri di rashyzionalitagrave economica e secondo la migliore efficienza tecnica nonostante i vincoli imposti alla lievitazione degli stock dalle disposizioni annonarie
lA costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
vimini paglia o canne intrecciate (come ceste stuoiecannizzi) in terracotta (addirittura anfore) piuttosto che di tessuto (i sacchi costavano troppo) (PICCINNl1976 397 MAzzA RAvEGol 1983 174-5 Zoo Toce 1990 893-4 COIiITONES11991 35n-36n)
Nella casa del piccolo produttore o del titolare di un piccolo possesso il penw (la scorta domestica) difficilmente eccedeva il consumo famigliare chi fortunato raccoshyglieva piugrave dell annona famigliare e di quanto gli serviva per il campo era spinto a venderselo nei mesi immediatamente successivi alla mietitura e alla trebbiatura per necessitagrave di denaro ma anche per la difficoltagrave di stoccare e conservare il prodotto in condizioni ottimali (MEuvRET 1988 17-9 PuLT QUAOUA 1984 88) e figravenanco per ridurre il rischio di vederselo soffiare da vagabondi e malintenzionati In questo caso in presenshyza di eccedenze (ma probabilmente anche in assenza) il bisogno di liquiditagrave e lalea cospiravano nel ridl1ITe ai minimi termini le scorte giagrave allindomani del raccolto In caso alternativo il contadino che non egrave - ripete Jean Meuvret - un homme daffaires quanshyto un homme de peur concepiva la sua riserva come un fondo di previdenza sul racshycolto futuro da non immettere sul mercato se non nel caso dellapprossimarsi di una messe sicura secondo una logica economica a contrario (MEUVRET 1988 19 e 147)
Era Jl~tente la disparitagrave fra i produttori non solo fra chi era in possesso di eccedenshyze e chi non lo era ma piugrave anqgtra fra chi poteva scegliere in virtugrave di una maggiore capienza economica e unadeguata dotazione tecnica - il mercato piugrave favorevole per i propri grani (il periodo di saldatura dei raccolti) e chi invece li cedeva troppo presto o in controtempo a livelli non ottimali
Nella gerarchia delle abitazioni rurali -- in quel vero e proprio saggio di sociologia che egrave il sesto libro del DeArchitectura di Sebastiano Serlio (scritto fra il 1537 eil 1555 inedito per tutto levo moderno) -- per trovare case attrezzate di granaio occorshyreva ascendere sino alla magione del basso mercante o cittadino fuori della cittagrave (SERLlO 1994 43 segg anche per le successive informazioni) Condizione di cui non potevano fregiarsi invece i ricchi contadini in ~essuno dei tre gradi possibili di ricshychezza al massimo la loro casa poteva essere attrezzata di portici per ricoverare le biade e di unaia per batterle segni di distinzione giagrave fra i mediocri contadini Fra questi perograve avrebbero potuto avvalersene soltanto i fortUIgravelati et di beni et di famishyglia (3deg grado di mediocritagrave) nforno per cuocere il pane e una cantina per conservashyre il vino invece li si sarebbe trovati a partire dai piugrave accomodati fra i poveri contashydini cioegrave al 4deg gradino della scala sociale alla cui base erano da collocare i poveri mendichi con vii capanna (10 grado di povertagrave) i salariati che vivevano delle [loro] fatiche avendo un puoco di terreno (2deg grado di povertagrave) i poveri con qualche beshystiuola et massimamente de buOvi possessori di una stalletta congiunta con la casa 0deg grado di povertagrave)
In sintesi nelle campagne delletagrave pre-industriale pochi avevano scorte pochissimi erano in grado di ricoverarle in un solaro privilegiatissimo chi le incanevava per speculare Dunquefra i conta4ini se si esclude quanto celato nella madia o nella dishyspensa le scorte erano un pri~ilegio di pochi nSerlio nato intorno al 1475 insiste sullimpoverimento delle class~ rurali intervenuto fra gli anni della sua giovinezza e quelli della vecchiezza in cui scrive Sotto il titolo Dellabitazione del ricco contadishyno per tre gradi di ricchezza si preoccupa di puntualizzare
bencheacute al di dogi non se n~ truovi piugrave de tali merceacute delle discordie et di gli animi fieri et ostinati alla vendetta onde per tal cagioni et per le continue guerre et anche pei citadini divoratori de gli altrui beni che con le usure con glinganni con le rapine gli bano impoveriti (SERUO 1994 ~8)
490 RellOP CorrilOle
colto (agosto-settembre-ottobre) e invia di esaurimento almomento della saldatura dei raccolti (aprile-maggio-giugno )1A questo proposito nota Franccedilois Sigaut
Le stockage agrave court terme (moins dune campagne) reacutepond agrave la neacuteCessiteacute cIeacute concilier une offre variable et une demande constante mais toutes deux reacutegulieacuteres et preacutevisibles dans la
pratique il est consideacutereacute comme tiiisant pame du processus ordinaire de la production et ne pose agrave ce titre que desproblegravernes doptimisation assez simples (SlOAUI 1985 602)
La discussione generale sulla razionalitagrave economica delle scorte alimentari in etagrave pre-industriale puograve allora essere ridotta alla fonnulaiione e allo scioglimento di due
semplici quesiti 1 Accertato che laccantonamento digram per la periodicitagrave annuale del ciclo agricoshy
lo epet i vincoli tecnici di un rifomimento spazialmente allargato egrave inevitabile chi egrave conveniente che conservi le scorte chi produce o chi commercia il contadino o il mercante lapossidenzagrave o il popolo i particolari o il pubblico E qual egrave la realtagrave effettiva
2 Se le forme di distribUzione economicamente razionale sono plurali in quale conshytesto e in omaggio a quali interessi piugrave utile il sistema della canova rispetto al sistema delll piazza del mercato e dei solari privati
3 SULLADISTRIBUZIONE DEL GRANO NELUETAgrave PRE-INDUSTRIALE E LA STRUTTURA DELLE SCORTE NEI TERRITORI ITALIANI
Raramente le case contadine erano dotate di attrezzature per la conservazione dei cereali piugrave che elementari Nelle campagne toscane del Quattrocento dunquein unetagrave favorevole al reddito contadino in una regione fra le piugrave ricche dellEuropa pre-indushystriale
pochissime case contadine disponevano del granaio vero e proprio alcune avevano una cella che poteva servire allo stesso scopo ma la maggior parte di quelle abitazioni era priva di spazi destinabili esclugravesivamente alla conservazione dei cereali Perciograve i contenitori dei grani arche casse sacchi bugnole - dovevano trovare posto nelle cucine o nelle camere CMA= RAVEGGI 1983 174)
Le ridotte capacitagrave patrimoniali e reddituali della grande maggioranza dei produttori facevano sIgrave che fosse ampiamente invalso nella conservazione domestica dei grani limshypiego di contenitori in legno (come arche casse botti bugnole tini tinelle corbelli)in
Riguardo ai passi evidenziati di Zanetti e Cipolla egrave neCessario osservare che la principale atteshystazione sullesistenza di stock detenuti da privati che esorbitassero ilfabbisognostagionale tali da essere classificati come immobili=zione di ricchezza (Zanetti) o come beni capitale (Cipolla) a unanalisi piugrave fine si rivela fallace o non direttamente utilizzabile La propalazione dei grani effetshytuata a Pavia fra ilimiddot e il5 maggio 1555 che egrave il fondamento di entrambi i giudizinon mostra una somma di derrate realmente eccedente il fabbisogno delle famiglie per il periodo che manca allarri_ vo dei grani novelli sulla piazza pavese Daltra parte lastessa natura dellistituto della propalazioshyne dei grani cioegrave della denljncia obbligatoria delle scorte da parte dei particolari una misura demergenza decisa in momenti critici dellapprovvigionamento cittadino affiancata quellanno dalshylispezione diretta presso le case dei privati da parte di deputati straordinari avrebbe dovuto consishygliare una maggiore cautela nella sua utilizzazione per individuare regolaritagrave di carattere generale delleconomia pre-industriale
499 La costituzione di scorte granarie pubbliche e la ptlitica ecoMmica degli stati
FONTI
ABEL [1966) W ABEL Agrarkrisen undAgra~kJJnjunktur Eine Geschichte der londshy und Erniihrungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter Hamburg
und Berlin Paul Parey 19662 (la ed -1935 trad it Congiuntura agraria e crisi agrarie Storia dellagricoltura e della produzione alimentare nellEuropa centrashyle dal XIII secolo alletagrave industriale Torino Einaudi 1976 da cui si cita)
AG ARCHIVIO GoNZAGA presso lArchivio di Stato di Mantova AuFANO 1996 E AuFANO Il grano il pane e la politica annonaria a Napoli nel Setshy
tecento Napoli ESI 1996bull AYMARO 1966 M A YMARO Wmise Raguse et le commerce du bMpendant la seconde
moitieacute du XVI siegravecle Pans SEVPEN 1966 CATIINI 1984 M CATl1NI I contadini di San Felice Metamorfosi di un mondo rurale
nellEmilia delletagrave modernIgravel Torino Einaudi 1984 CESTARl 1794 p CESTARI Saggio storico dei Fondachi delle farine di Chioggia e
Pellestrina Venezia A Zatta 1794 CIPOllAJ1965] C M CIPOllA La politica economica dei governi V La penisola
italigraveana e la penisola iberica in Storia economica Cambridge m La cittagrave e la politica economica nel Medioevo Torino Einaudi 1977 (Cambridge 1965) pp 462-496
CIPollA 1974 C M CIPollA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna nMulino 1974
CIpollA 1997 C M CIPOllA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna nMUlino 1997 (6 ed riveduta)
CORRITORE 2000 R P CoRRITORE La naturale abbondanza del Montovano Produshyzione mercato e c01isumi granari a Mantova in etagrave moderna Pavia Universitagrave di Pavia 2000
CORIONBSI 1991 A CORIONBSI Sulla conservazione dei cereali nellItagravelia medioevale Lavoro e tecniche nelle tesnmonlanze laziali (secc XIII-XV) in Rivista di storia dellagricoltura XXXI 1991 l pp 33-49
DELLA VALENTINA 1992 M DELLA VALENTINA I mestieri del pane a ~nezia tra 600 e 700 in Atti dellIstituto [Veneto di Scienze Lettere ed Arti Classe di scienze morali lettere ed arti CL 1991-92 pp 113-217
DIRLMEIER 1984 U DIRLMEIER le condizioni materiali dellesistenza nelle cittagrave tedeshy sche del Basso Medioevo ~iente esterno reddito consumi in Aristocrazia citshy
tadina e ceti popolari nel tprdo Medioevo in Italia e in Germania (a cura di Reinhard Elze e Gina Fasoli) Bologna Societagrave editrice il Mulino 1984 pp 79shy122
FORNASIN 1999 A FORNASIN Il pzercatodei grani di Udine Indagine per una storia dei prew in Friuli (secoli XfI-XVIII) Nota di ricerca del Dipartimento di Scienshyze Statistiche dellUniversit4 degli Studi di Udine 4 1999 pp 1-24 ora in lo La Patria del Friuli in etagrave 1fIOderna Saggi di storia economica Udine Forum 2000 pp 33-60
GRENDI 1986 E GRENOI Lapprccedilwigionamento dei grani nella Liguria del Seicento libera pratica e annone in iMiscellanea storica ligure Studi in onore di Luigi Bulferetti XVIII 1986 2Jp 1021-1047
GUENZI 1981 A GUENZI Ilfrurnfnto e la cittagrave il caso di Bologna nelletagrave moderna in Quaderni storici XVI ~981 46 pp 153-167
GUENZI 1982 A GUENZI Pane ~fornai a Bologna in etagrave moderna Venezia Marsilio 1982
I
489 500 Renzo P CornIOle
GUBNZI1982 A GUEml Sistema annonario e egraveontrollo sociale a Bologna nei seccediloli XVII e XVIII in E SORI (a cura di) Cittagrave e controllo sociale in Italia fra XVIII e XIX secolo Milano F Angeli 1982 pp 293-306
HICKS [1989] 1 R HIClCS A narlcet theory of money Oxford Oxford Universigravety Press 1989 (trad it Una teoria di mercato della monefa Bologna li Mulino 1992 da cui sigrave cita)
JACOPBITI 1965 N L JACOPBITI Monete e prezzi a Cremona dal XVI al XVlIi secolo Cremona Athenaeum CregravemoneJlSe 1965
KAPLAN 1984S L KAPLAN Provisioning Paris Merchants and Millers in the Grain and Flour Trade during the Eighteenth Century Ithaca-London Cornell Univershysity Press 1984~middot
KULA [1962] W KULA Teoria ekonomiczna ustrojufeudalnego Proba modelu Warshyszawa-Panstwowe WydawnictwoNaukowe 1962 (trad it Teoriagrave economica del sistema feudale Proposta di un modello Tormo EinaUdi 1972 ccedilla cui si cita)
WROUSSE [1933] C-E LABRoussE Esquisse du mouvement des prix et des reverws en France au XVIII siegravecle Paris Eacuteditions des Archives Contemporaines 19842 volI (l ed Paris Librairie Dalloz 1933)
MALANtMA 1976 P MALANiMA Aspetti di mercato e prezzi del grano e della segalea Pisa dal 1548 al 1818 in Ricerche di storia moderna vaL I Pisa Pacini 1976 pp ~n
MANToVA 1430 MwroVA 1430 Pareri a Gian Francesco Gonaga per il governo (a cura di M AQrignaniA M Lorenzoni A Mortari C Mozzarelli) MUltova G~ Arcari 1990
MASSA 1999 PMAssA Annona e corporazioni del settore alimentare ~ Genova orshyganizzazione e conflittualitagrave (XVI-XVIII secolo) in A GUENZI PMAssA A MOIOshyu (a cura di) Corporazioni e gruppi professionali nellItalia moderna MilIllO F Angeli 1999 pp 390-403
MATIoZ7J 1983 1 MiJroZ7J F BOLELLI C CmAsBRA D SABBIONI Il politico e il pane a Venezia (157Q-1650) calmieri e governo della sussistenza in Societagrave e storia VI 198320 pp 271-303
MAzzI RAVEOOI 1983 M T MAzzI S RAVEOGI Gli uogravemini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento Firenze Olscbki 1983
MERONI 1957 U MERONI Cremona fedelissima Ciemona Athenaeum Cremonenshy~~~ _
MBUVRBl 1977 J MEuVRsT Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque LouisXIvI La productiograven des ceacutereacuteales dans la France du XVII et du XVIII siegravecle Paris Mouton -EacuteEHSS19772voll
MBUVRET 1988 J MBtJVRf Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque Louis XIv III Le commerce des gralns et la conjoncture Paris EacuteEHss 1988 2 volI
PtCClNNI 1976 G PtCClNNl Wta contagravedina in una capanna dei dintorni di Siena (1250) in ~Archeologia medievale m 1976 pp 395-399
PlNIO 1978 G PINTOII Libro del BiaPaiolo Carestie e annona a Firenze dalla metagrave del 200 al 1348 Fire~ Olscbki 1978
PiNTO 1982 G PtNro La Toscana nel tardo Medioevo Ambiente economia rurale societagrave Fllenze Sansoni 1982
PtRENNE [1933J H PIRENNB La civilisation occidentale au Moyen Age du XIe au mishylieu du XVe siegravecle Paris PUF 1933 (trad it Storia economica e sociale del Meshydioevo Milano Garzanti 1967 da cui si cita)
Lacostituticne di scorte granarie pubbliche e la politica economiegravea degli stati
redigravestribuzione sostenibile dei beni di sussistenza egrave ricercata in questo cielo da quegli stessi particolari che ~amaldeggiano nella produzione negli scambi nei consumi e che costituiscono il nerbo della classe di governo Le scorte pubbliche rappresenteshyrebbero in questa prospettiva un presidio civico e un risltCimento politico e morale ai cOl1ponenti della comunitagrave spossessati delbene supremo dellautarchia alimentare
Resta infine latente unidea del magazzmo pubblico come quasi-mercato cioegrave come luogo volto (1) a risolvere i fa1limentiinfo~vi della piazza del mercato (in meacuterito alle disponi~ilitagrave alle caratteristiche del prodotto alle condizioni di vendita della merce) (2) a ridimensionare lalea per agricoltori consumatori poveri artigiani del comparto alimentare (3) a sostenere i consumi e i profitti privati m funzione anticicli ca in una prospettiva Ilpn meram~nte congiunturale Si tratta in questo caso di un orshyganizzaZionepienattiCnte razio~e Che non opera in maniera saltuaria e riflessa ma in modo continuativo secondo obifttili prefissati di allocazione dei beni primari li funshyzionamento dellacanovagrave (il magazzino pubblico) si porrebbe come strumento inteshygrativo ma no~~igraventeramente so~titutivo delloperare della piazza Si tratterebbe di unaforma di mercato distinta dalla p~ del mercato considerata in seacute e per seacute cosigrave come dallegraveOOmpravendite effetttlate nei solari privati o dalla mera centrallzzazione e redistribuzione di derrate con fi~alitagrave umanitarie La canova rappresenterebbe in tal modo uno dei possibili meccaoi~ di governo delle trllls3ZIgrave~ni locali per risolvere i problemi deUapprovvigionameIto senza intaccare certi interessi di classe (dei proshyprietari ma anche del popolo grasso) S da essere prescelta da autoritagrave e gruppi domishynanti come struttura complementare della piazza del mercato incerti contestiprodutshytivi ed economici La suasacrilizzazione perciograve non esclude la possibilitagrave di un ritorno alle sole compravendite qella piazza e dei solari privati - una volta invertishytosi il trend o spirate le condizioqi economiche della sua istituzionalizzazione
La problematizzazione esorc~ una liquidazione semplicistica del problema delle scorte gran8rle in etagrave pre-industriUgravee nel nome di una loro presunta irrazionalitagrave eco- nomica per il compito di assi~ la sussistenza della popolazione
Le pagine che segUono sono rintroduzione a un lavoro in corso volto a offrire un interpretazione generale di tal~ capitolo fondamentale della politica economica dei governi
in
etagrave pre-industriale
2 SE UN MONDO SENZA SCORTE Egrave INCONGRUO cm Egrave OPPORTUNO CHE LEgrave DETENGA
Nei fatti nel settore granarlo CQni vincoli dell etagrave pre-industriale in tema diprodutshytivitagrave energia trasporti non ha s~nso ipotizzare un mondo senza scorte Se il mercato del grano egrave - come nellEuropa medievale e moderna - un sjstema tendenzialmente chiuso
ad ogni raccolto nuove offe~ aniv(erannol sul mercato mentre la domanda si mant[erragrave] relativamente costantt nel corso dellanno Qualcuno dunque [dovragrave] ~ere delle scorte che saranno elevate ~ubito dopo il raccolto e poi via via minori fino aragshygiungere un livello minimo in prpssimitagrave del successivo raccolto (HICICS [19891 31)
Nella loro forma piugrave sempliceI tali scorte saranno legate allora alla periodi~itagrave anshynuale del ciclo agricolo (che a1iplenta il movimento stagionale dei prezzi ccedilfr LAshyBROlJSSE [1933] 157-66) il loro livello saragrave elevato allindomani del principiLle racshy
501 488 Renzo P Corritore
povero ammassograve nella propria dimora scorte di grano carne ~alata sale candele ecc e la medesima cosa fece lo Stato Nel periodo feudale non venne mai meno nel castello del signore labitudine di tenere da parte grosse scorte per i periodi di emergenza Sucshycessivamente le autoritagrave comunali predisposero il magazzinaggio di grosse derrate specie di grano da rivendere a basso prezzo in periodi di emergenza e nello stesso tempo si preoccuparono di prevenire un indebito accumulo di scorte da parte di specushylatori privati Nelle economie medievali gli stock di derrate di prima necessitagrave rappreshysentarono pertanto una delle piugrave importanti forme di investimento pubblico e privato (CIPOLLA (1965] 468)
Nella prima versione del manualeacute invece fino allinserimento nel 1997 del nuovo capitolo dedicato alla politica economica nell etagrave pre-mdustriale il punto di vista preshyvalente era quello microeconomico entro il perimetro stretto dellindividualismo meshytodologico
Le scorte costano e costano doppiamente Esse implicano il costo diretto che egrave rapshypresentato dal costo del magazzinaggio edal deterioramento eventuale del pr04otto o di parte di esso Se luomo daffari finanzia la costituzione delle scorte con danaro preso a prestito il costo diretto include anche il tasso di interesse pagato Se luomo daffari finanzia con capitale proprio la costituzione delle scorte il costo delle scorte deve inshycludere un costo-opportunitagrave e cioegrave il mancato rendimento (tIllU1cato tasso dinteresse attivo) del capitale finanziario impiegato (CIPOLLA 1974 154)
Le ragioni della costituzione e del mantenimento di scorte alimentari da parte delshylautoritagrave pubblica diventavano unicamente ragioni morali (umanitarie e di buona amministrazione) o di opportunitagrave politica (la fame era la piugrave frequente ligraveausa di sommosse e furori popolari) (CIPOLLA 1974 74)
Nel 1997 si riammetteva dunque linterpretazione originaria della costituzione di scorte pubbliche come strumento di riequilibrio del mercato senza peraltro rinnegare le considerazioni sulla valenza statica di tale forma di investimento per gli agenti economici privati
In merito allutilitagrave economica e al significato delle scorte in etagrave pre-industriale Cishypolla non espresse perciograve sempre lo stesso punto di vista La rassegna delle posizioni da lui assunte anzi permette di individuare tre approcci e tre giudizi costitutivamente diversi sulla funzione delle scorte granarie nellepoca pre-industriale
In prima approssimazione laccumulazione di scorte alimentari mostra il carattere fondamentalmente difensivo delle scelte degli agenti economici pubblici e privati in etagrave pre-industriale La paura la tradizione la superstizione li induce a tabuizzare il rischio la speculazione linvestimento nella produzione e nella distribuzione dei beni essenziali alla vita e ad aderire intimamente a un ideale di economia e societagrave stazionarie aggravando con la norma sociale le istituzioni il comportamento indivishyduale e collettivo leffetto dei condizionamenti materiali delleconomia pre-industriashyle (bassa produttivitagrave agricola alti costi di v~sporto modesta efficienza energetica) esponendo ancor di piugrave la comunitagrave umana ai degravemoni della natura
La seconda interpretazione rigetta luniversale imperio dellhomo oeconomicus rishyscoprendo leteronomia dei fini dellagire economico degli uomini nelletagrave pre-inshydustriale Ia politica economica dello Stato o-delle autoritagrave non persegue puri scopi economici lintegritagrave del corpo sociale fin nelle sue cellule elementari (persone e famiglie) deve essere assicurata secondo i principi e la prassi di uneconomia morale che SOVJa5ta leconomia regolata dal mercato spersonalizzata e antipopolare Una
La costituzione di scorte grantlTie pubbliche e la poligravetigraveca economica degli stati
PuLT QUAGUA 1984 A M PULT QUAGUA Mercato dei prodotti agricoli e magistratushyre annonarie a Pisa nelletagrave moderna in Ricerche di storia moderna a cura di M Mirri voI III Pisa Pacini 1984 pp 57-141
PULT QUAGLIA 1990 A M PULT QUAGLIA Per provvedere ai popoli Il sistema anshynonario nella Toscana dei Medici Firenze Olschki 1990
SERUO 1994 S SERLIO Architettura civile Libri sesto settimo e ottavo nei manoscritshyti di Monaco e Vienna (a cura di F P Fiore) Milano TI Polifi10 1994
SIGAlIT 1985 F SIGAlIT Questions deacuteconomie agrave propos des politiques ceacutereacutealiegraveres et de stockage in Les techniques de conservation des grains agrave long terme leur rale dans la dynamique des systegravemes de cultures et des socieacuteteacutes (sous la direction de M Gast F Sigaut et C Beutler avec la collaboratlon de O Bllchsenschutz) voI III 2 Paris Eacuteditionsdu CNRS 1985 pp 597-606
SMITH [1776 A SMITH An inquiry into the nature and causes ojthe wealth ojnations London W Strahanand T Cadell 17762 volI (trad it Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni Milano A Mondadori 1977 2 volI da cui
si cita) STATlITlBoNACOLSIANI [1313] STATUTI BONACOLSlANl (a cura di E Dezza A M Lorenshy
zoni M Vaini) Mantova GArcari 2002 STATUTI GONZAGHESCHI [1404] STATUTI GONZAGHESCHI presso la Biblioteca comunale di
Mantova ms FV 11 [775]VECCHIATO 1979 F VOCCHIATO Pane e politica annonaria in Terrajerma veneta tra
secolo XV e secolo XVIII (Il caso di Verona) Verona Stamperia Zendrini 1979 ZANETTI 1963 D ZANETTl Contribution agrave leacutetude des structures eacuteconomiques lapshy
provisiQnnement de Pavie au XVI siegravecle in Annales ESC XVIII 1963 1 pp 44-62 ora in lo Fra le antiche torri Scritti di storia pavese Pavia Universitagrave di Pavia 2000 pp 165-182
ZANETTl 1964 D ZANEITI Problemi alimentari di una economia preindustriale Ceshyreali a Pavia dal 1398 al 1700 Torino P Borlnghieri 1964
ZUG TUCCI 1990 H ZUG TuCCI Le derrate agricole problemi materiali e concezioni mentali della conservazione in Lambiente vegetale nellalto Medioevo XXXVII Settimana di studio del Centro italiano di studi sullalto Medioevo (30 marzo-5 aprile 1989) Spoleto Centro italiano di studi sullalto Medioevo 1990 voI n pp 865-902
495 494 Renzo P Corrllnre
In ogni caso si tendeva a limitare al minimo indispensabile lemiddot importazioni di frushymento per evitare che stocks invenduti potessero turbare la collocazione dei grani tershyrieri nel nuovo anno agrario (GuENZI 1981 153)
In tutti i centri comunque la tendenza a ritardare la vendita del surplus nei mesi della saldatura lutilizzo di depositi specializzati con personale addetto alla custodia al conshydizionamento e alla commercializzazione del prodotto ponevano i grandi proprietari di biade su un gradino superiore e diverso rispetto al resto della cittagrave Laccantonamento di grani per questa cupola di possessori rispondeva al principio dellutilitagrave soggettiva atshytesa e richiedeva sia capitale fisso sia capitale circolante per raggiungere gli scopipreshyfissati un profitto speculativo la valorizzazione della rendita
In molte cittagrave i possessori non avrebbero dovuto trattenere in casa piugrave grano e farina di quantoprescritto dalla legge cioegrave il consumo mensile per bocca - fissato anchesshyso statutariamente - per arrivare al nuovo raccolto Ma i cittadini credeVano veramenshyte ai loro comandamenti Egrave lecito dubitare La norma era scolpita negli Statuti e pubshyblicamente violata con la complicitagrave dll1e autoritagrave e dei groppi professionali interessati alla distribuzione del grano nelle sue ~arie forme
Nelle annate ordinarie la quota di grano auto consumato - cioegrave non acquistata sul mercato - nelle cittagrave italiane dell evo moderno rappresentava fra il 30 e il 60 per censhyto del fabbisogno urbano di frumento
Nella capitale dei Gonzaga nel 1615 si valutava che su 27000 bocche
il terzo [di] gentilhuomini fittadri servitori et altri [ ] non comprano biada et gli duoi tenigrave tra poveri artisti mercanti fomari fondachieri hebrei et altri [bull] non possono in tutto levar sufficientemente la somma de detti dua terzi sl che saranno boshychegrave 18000 che compraranno biada (COIUUTORl 2000 126)
AVenezia a cavaliere fra XVI e XVII secolo alla mensa delle casade si dispensava circa un terzo del frumento consumato ordinariamente in cittagrave (AMARD 1966 74 MATTOZZI 1983 281) ABologna per tutto il Seicento i fornai che impastavano farine in conto lavorazione per i particolari pareggiavano piugrave o meno il numero di quelli da scqffa che smerciavano pane venale (GUENZI 1982A
27) Peraltro la proporzione a Rialto tra chi lavorava per le casade e chi vendeva pane al pubblico - 65 Jo~ri a fronte di 44-48 pistori negli anni 1583-1685 (DELLA VALBNTINA 1992 143-4 167 192-3) - fa ritenere la struttura del mercato del pane felsinea non molto dissimile da quella veneziana Nelle cittagrave liguri o toscane sei-settecentesche la porzione autocon sumata quando il raccolto era buono era anche piugrave elevata (GRENDI 1986 1024-6 1034 PuLT QUAOUA 1984 98-104 PULT QUAGUA 1990 171-2) A Napoli nel 1758 a Monasteri Luoghi pii e Particolari eta riservato il 28 per cento del consumo cittadishyno di frumento (AuFANO 1996 37n)
Lelevato numero di servi domestici persone al servizio delle casate faceva sigrave che in alcuni palazzi si concentrassero masse cospicue di grano per la spesa familiare Ma accanto ad esse gli operatori dell annona -- la stessa povertagrave -- si auguravano che vi fosse sempre anche la materia per rifornireil mercato e i forni cittadinimiddot nella fase piugrave delicata del ciclo annuale il periodo di saldatura dei raccolti Come spiegare altrimenshyti la norma che imponeva ai grossi detentori di biade (non esclusi enti e opere pie) in varie cittagrave italiane dellevo moderno la vendita straordinaria in primavera dellegrave ecshycedenze ammassate in granaio (per Pisa e la Toscana v PuLT QUAGUA 1984 88-9)
A Mantova nel 1554 si stabiliva che i patroni che avessero fruito in cittagrave di piugrave di 20 sacchi di grano come porzione dominicale avrebbero dovuto coilservare in granaio
lA costituzioni digrave scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
il 4 per cento per le necessitagrave dei consumatori dei fornai e dei Jontachieri quando fosse mancato il prodotto sulla piazza o nelle offerte deisensali Nel 1603 ci si preocshycupograve di elevare la quota al 6 per cento (CORRlTQRE 2000 237n) Beninteso le vendite sarebbero avvenute ai valori di mercato Lo stesso sistema vigeva a Cremona (6 per cento nel 1608 e nel 1612) (MERON 1957 59n 63 JACOPETl1 1965 128) ea Verona Qui una delibera consiliare del 1549 autorizzava per la prima volta
[il deputati [alle Biadel [a] tassar e comandar con quelle pene che al Clarissimo Podestagrave pareragrave quella quantitagrave di biade a ciascuno secolare o eclesiastico sia di qual grado o condittione esser si voglia che havesse biade in questa cittagrave oltre il viver suo
(VOCCHIATO 1979 145)
La tassa sarebbe stata stabilita - da11558 - per sorteggio fra le casate che avessero introdotto in cittagrave dai propri possedimenti piugrave di 70 minali per rifo1llire il Mercato delle biave Essa-venne anche incrementata nella stessa occasione dal 5 al6 per censhyto per restare in vigore fino al 1631 (VECCHIATO 1979 141-58)
Quest9 tiIfo di normativa nasce e si affiogravea in ambito amministrativo perciograve echeggia la realtagrave molto meglio della veneranda legge generale
Da tali disposizioni si deducono alcuni fatti incontrovertibili 1entro la cerchia cittadina esistevano scorte private eccedenti la spesa delle famiglie
in violazione in molti casi della legge statutaria 2il possesso della terra che solo assicurava lautarchia delle casate era il piugrave-potente
fattore di discriminazione fra i cives tanto da precipitare nel girone dei pauperes la moltitudine che acquistava correntemente la sussistenza nellarea urbana
3fra gli stessi possidenti cittadini esisteva uneacutelite che non solo conservava scorte oltre il viver suo ma che si proponeva egoisticamente di speculare ritardando limshymissione dei grani sulle piazze cittadine o che a~endeva il momento piugrave opportuno per smerciarli allesterno nelle grandi piazze frumentarie come livorno Desenzashyno Legnago Romano (di Lombardia) ecc
4lineguaglianza fra i cives tese ad aggravarsi con la metagrave del 500 poicheacute questi reshygolamenti innovano quasi sempre disposizioni generali risalenti al tardo Medioevo che sancivano lobbligo di convogliare il surplus sulla piazza cittadina segno di una distribuzione del reddito originariamente meno sbilanciata A Cremona gli Statuti del 1388 obbligavano - cosl egrave ancora nel 1510 - a vendere il
sovrappiugrave in Piazza Maggiore sul mercato pubblico dei grani (MERON 1957 59n
63)A Pisa il rescritto che imponeva di effettuare le vendite al minuto in platea bladi
risale al 1401 MALANlMA 1976 293) lobbligo era ribadito ancora nel 1548 ma nella seconda metagrave del secolo XVI si affermava la pratica di vendere fuori mercato tanto che nel 1581 il Magistrato dei Nove dovette intervenire per far vendere i grani delle comunitagrave degli enti e dei luoghimiddotpii soltanto da marzo-aprile in piccole quantitagrave sul mercato (PULT QUAGUA 1984 81-91) La disposizione per altro si applicava allinteshyro Stato (PULT QUAGUA 1984 88)
Tuttavia non egrave da pensare che il principio della concentrazione delle compravendite sulla piazza di mercato cittadina fosse universale universalmente rispettato e sopratshytutto perenne La centralizzazione del grano non significa automaticamente lobbligo di vendita diretta sulla Piazza deiformenti Affermare come Steven L Kaplan che
There was no single more important regulation concerning tbe provisioning trade tban tbe requirement tbat alI transactions occur in tbe marketplace (KAPLAN 1984 27)
494 495 Renzo P Corritore
In ogni caso si tendeva a limitare al minimo indispensabile le importazioni di frushymento per evitare che stocks invendutigrave potessero turbare )a collocaziolle dei grani tershyrieri ileI nuovo anno agrario (GUENZI 1981 153)
In tutti i centri comunque la tendenza a ritardare la vendita del surplus nei mesi della saldatura lutilizzo di depositi specializzati con personale addetto alla custodia al conshydizionamento e alla commercializzazione del prodotto ponevano i grandi proprietari di biade su un gradino superiore e diverso rispetto al resto della cittagrave Laccantonamento di grani per questa cupola di possessori rispondeva al principio dellutilitagrave soggettiva atshytesa e richiedeva sia capitale fisso sia capitale circolante per raggiungere gli scopipreshyfissati un profitto speculativo la valorizzazione della rendita
In molte cittagrave i possessori non avrebbero dovuto trattenere in casa piagrave grano e farina di quantoprescritto dalla legge cioegrave il consumo mensile per bocca ~- fissato anchesshy
so statutariamente --per arrivare al nuovo raccolto Ma i cittadini credevano veramenshyte ai loro comandamenti Egrave lecito dubitare La norma era scogravelpitagrave negli Statuti e pubshyblicamente violatamiddot con la complicitagrave dccedillle autoritagrave e dei gruppi professionali interessati alla distribuzione del grano nelle sue varie forme
Nelle annate ordinarie la quota di grano autoconsumato - cioegrave non acquistata sul mercato - nelle cittagrave italiane dell evo moderno rappresentava fra il 30 e i160 per censhyto del fabbisogno urbano di frumento
Nella capitale dei Gonzaga nel 1615 si valutava che su 27000 bocche
il terzo [di] gentilhuomini ligravettadri servitori et altri [ ] non comprano biada et gli duoi terzi tra poveri artisti mercanti fomari fondachieri hebrei et altri [ l non possono in tutto levar sufficientemente la $omma de detti dua terzi sl che saranno boshyche 18000 che compraranno biada (CoRRlTORB 2000 126)
AVenezia a cavaliere fra XVI e xvn secoioalla mensa delle casade si dispensava circa un terzo del frumento consumato ordinariamente in cittagrave (AYMARD 1966 74 MArroZZI 1983 281) A Bologna per tutto il Seicento i fornai che impastavano farine in conto lavorazione per i particolari pareggiavano piil o meno il numero di quelli da scaifa che smerciavano pane venale (GUBNZI 1982 27) Peraltro la proporzione a Rialto tra chi lavorava per le casade e chi vendeva pane al pubblico - 65 fOf7lri a fronte di 44-48 pistori negli anni 1583-1685 (DELLA VAUNTINA 1992 143-4167 192-3) - fa ritenere la struttura del mercato del pane felsinea non molto dissimile da quella veneziana Nelle cittagrave liguri o toscane sei-settecentesche la porzione autoconshysumata quando il raccolto era buono era anche piil elevata (ORENOI 1986 1024-6 1034 PuLT QUAGLIA 1984 98-104 PULT QUAOLIA 1990 171-2) A Napoli nel 1758 a Monasteri Luoghi pii e Particolari eta riservato il 28 per cento del consumo cittadishyno di frumento (AuFANO 1996 370)
Lelevato numero di servi domestici persone al servizio delle casate faceva si che in alcuni palazzi si concentrassero masse cospicue di grano per la spesa familiare Ma accanto ad esse gli operatori dellannona -lastessapovertagrave __ si auguravano che vi fosse sempre anche la materia per rifornire il mercato e i forni cittadini nella fase piil delicata del ciclo annuale il periodo di saldatura dei raccolti Come spiegare altrimenshyti la norma che imponeva ai grossi detentori digrave biade (non esclusi enti e opere piegrave) in varie cittagrave italiane dellevo moderno la vendita straordinaria in primavera delle ecshyredenze ammassate in granaio (per Pisa e la Toscana v PuLT QUAGLIA 1984 88-9)
A Mantova nel 1554 si stabiliva che i patroni che avessero fruito in cittagrave di piugrave di 20 sacchi di grano come porzione dominicale avrebbero dovuto conservare in granaio
lA costituzione di SC0114 granarie pubbliche e la politica economica degli stati
il 4 per cento per le necessitagrave dei consumatori dei fornai e dei fontachieri quando fosse mancato il prodotto sulla piazza o nelle offerte deimiddotsensati Nel 1603 ci si preocshycupograve di elevare la quota al 6 per cento (CoRRlTORE 2000 237n) Beninteso le vendite sarebbero avvenute ai valori di mercato 10 stessa sistema vigeva a Cremona (6 per cento nel 1608 e nel 1612) (MERON 1957 -59n 63 JACOPETl11965 128) ea Verona Qui una delibera consiliare del 1549 autoruzava per la prima volta
[i] deputati [alle Biade) [al tassar e comandar con quelle pene che al Clarissimo Podestagrave pareragrave quella quantitagrave di biade a ciascuno secolare o eclesiastico sia di qual grado o condittione esser si voglia che havesse biade in questa cittagrave oltre il viver suo (VBCClI1ATO 1979 145)
La tassa sarebbe stata stabilita - dal 1558 - per sorteggio fra le casate che avessero introdotto in cittagrave dai propri possedimenti piagrave di 70 minali per rifornire il Mercato delle biave Essaveane anche incrementata nella stessa occasione dal 5 al6 per censhyto per restare in vigore fino al 1631 (VECCHIATO 1979 141-58)
Questccedil tijlo di normativa nasce e si affuia in ambito amministrativo perciograve echeggia la realtagrave molto meglio della veneranda legge generale
Da tali disposizioni si deducono alcuni fatti incontrovertibili 1entro la cerchia cittadina esistevano scorte private eccedenti la spesa delle famiglie
in violazione in molti casi della legge statutaria 2il possesso della terra che solo assicurava lautarchia delle casate era il piugravemiddotpotente
fattore di discriminazione fra i cives tanto da precipitare nel girone dei pauperes la moltitudine che acquistava correntemente la sussistenza nellarea urbana
3fra gli stessi possidenti cittadini esisteva uneacutelite che non solo conservava scorte oltre il viver suo ma che si proponeva egoisticamente di speculare ritardando limshymissione dei grani sulle piazze cittadine o che a~endeva il momento piagrave opportuno per smerciarli allesterno nelle grandi piazze frumentarie come Uvorno Desenzashyno Legnago Romano di Lombardia) ecc
4lineguaglianza fra i cives tese ad aggravarsi con la metagrave del 500 poicheacute questi reshygolamenti innovano quasi sempre disposizioni generali risalenti al tardo Medioevo che sancivano lobbligo di convogliare il surplus sulla piazza cittadina segno di una distribuzione del reddito originariamente meno sbilanciata shyACremona gli Statuti del 1388 obbligavano - cosl egrave ancora nel 1510 - a vendere il
sovrappigraveagrave in Piazza Maggiore sul mercato pubblico dei grani (MERON 1957 59n 63)
A Pisa il rescritto che imponeva di effettuare le vendite al minuto in platea bladi risale al 1401 (MALANIMA 1976 293) lobbligo era ribadito ancora nel 1548 ma nella seconda metagrave del secolo XVI si affermava la pratica di vendere fuori mercato tanto che nel 1581 il Magistrato dei Nove dovette intervenire per far vendere i grani delle comunitagrave degli enti e dei luoghi pii soltanto da marzo-aprile in piccole quantitagrave sul mercato (PULT QUAGLIA 1984 8191) La disposizione per altro si applicava allinteshyro Stato (PULT QUAGLIA 1984 88)
Tuttavia non egrave da pensare che il principio della concentrazione delle compravendite sulla piazza di mercato cittadina fosse universale universalmente rispettato e sopratshytutto perenne La centralizzazione del grano non significa automaticamente lobbligo di vendita diretta sulla Piazza deiformenti Affermare come Steven L Kaplan che
There was no single more important regulation conceming the provisioning trade han the requirement that ali transactions occur in the marketplace (KAPuN 1984 27)
493 496 Renw P Corritore
appare altrettanto astratto dogmatico O virtuale del principio di mercato (Market Principle) che il medesimo gli contrappone Henri Pirenne parlando della politica annonaria dei comuni medievali avverte Lapplicazione del principio della vendita diretta ebbe numerosi eccezioni (PIRENNE [1933] 193n)
Nel caso di Mantova la scelta della Piazza egrave facoltativa per i terrieri con eccedenze GliStatuti signorili che si rifanno largamente alle raccolte statutarie comunali non sancivano alcun obbligo in proposito (v SYJI1l BONACOLSlANI [1313] libro ID rubr 55 De mercato blave 253 STATUTI GoNZAOHESCHI [1404] libro m rubr 93 De mercato blave fiendo in civitate Mantue f 73v) Decreti di carattere straordinario e regolamenshytazioni transitorie correggevano il tiro Nel 1405 in piena saldatura dei raccolti si coshystrinse a rifornire forzosamen~e la piazza concentrandovi tutte le contrattazioni Nel 1417 si obbligograve a riservare al mercato un terzo del frumento introdotto in cittagrave (CoRRIshyTORE 2000 235-6) Ma sono atti straordinari che non sopravvissero nel migliore dei casi piugrave di qualchelustro (MANToVA 1430 88 90 181) A Mantova la Piazza era affianshycata da un granaio pubblico la Domus del mercato (altrove definito Fornico o Fontego del mercato) in cui avrebbero dovuto prolungarsi le contrattazioni oltre lorario e i giorshyni deputati (venerdl o sabato) rendendo disponibile ciograve che restava invenduto e che non poteva essere ritirato per legge dal mercato Nel 1430 eminenti cittadini sollecitati dal principe lamentavano pero lincapacitagrave del magazzino - inoperoso in tutto o in ~per il pericolo di crolli - di rispondere ai bisogni del popolo in una situazione in cui da parte dei possessori si protestava la difficoltagrave di non poter esitare e smerciare fuori delshyla cittagrave le eccedenze conservate nei solari privati
ltem videtur quod valde utille foret civibus Mantue habentibus possessiones et quishybuscumque alijs personis de civitate Mantue aut districtu colligantibus bIada et vina in magna copia ut amni tempore ipsa bIada et vinum possent exttahere de civitate et dishystrictu Mantue et conducere ad Iaea ad que et in quibus illa vendere poterunt cum otdigraveshynibus et dacijs competentibus ipsa tamen civitate semper remanente fulta pro usu diete civitatis et populi eiusdem ne dicta bIada mateeschant super granariis ut hactenus fecemiddot runt cum maximo incomodo ipsorum civium (MANToVA 1430 177-8)
Il medesimo fondaco abbinato al mercato operava a Verona a Ferrara a Venezia a Udine a Chioggia in molte altre cittagrave (MANToVA 1430 100 FORNASIN 1999 7-9 CBshySTARl1794)
Lintegrale e pedissequa applicazione del principio della piazza di mercato comporshytava - per i vincoli tecnici dell etagrave pre-industriale -la massima affermazione del prinshycipio della canova cioegrave del magazzino pubblico centrale Unico argine alla sua invashydenza era costituito da una distribuzione perequata ab imis del raccolto cioegrave la possibilitagrave egrave questo il paradosso di realizzare da parte dei produttori la massima aspirazione nelle societagrave tradizionali lautarchia domestica Piugrave avanzava invecela sperequazione nel reddito e nel patrimonio piugrave da parte dei consumatori privi di scorshyte si impetrava il principio del Magazzino pubblico nella forma di un efficiente sisteshyma di ricovero conservazione distribuzione delle derrate a garanzia del funzionashymento della Piazza di mercato La disponibilitagrave di crescenti quote di raccolto tuttavia indirizzava i piugrave accomodati verso soluzioni piugrave ghiotte la vendita allingrosso sul mercato cittadino ai fornai o allimpresa pubblica creata a sussidio di questi (o in loro vece) Oppure allopposto lesito delle eccedenze extra muros sui grandi mercatishyemporio regionali per il tramite di mercanti o agenti diretti
Il principio del magazzino pubblico centrale cioegrave laccumulazione di riserve per lo smercio continuo o anticiclico egrave quindi alla sua origine in opposizione solo apparen-
La costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
ruoli fiscali non fossero in grado di accantonare scorte Nel 1444 a Strasburgo quattro cittadini su dieci non possedevano alcuna riserva cerealicola (DIIUMBIER 1984 112)
Nelle cittagrave italiane delletagrave moderna si puograve stimare che non meno di due terzi della popolazione fosse costretta ad acquistare o consumare pane confezionato con grani e farine comperati nelle piazze nelle vie e nelle botteghe cittadine oppure ottenuti come compenso del proprio servizio nelle casate (CoRRITORE 2000 126-36 MAnoZZI 1983 27~-82) Evidentemente questa fascia di lavoratori salariati non possedevashyper definizione -- neacute scorte neacute depositi personali e nel primo caso era strettamente dipendente dal mercato urbano acquistando la sua sussistenza con frequenza non piugrave che settimaIIgraveale (essendo costretti a comprare il pane tutti i giorni alla finestra si dishyceva a Genova (GRENDI 1986 1031])
Ma anche fra i citUutini con possesso extra moenia la distribuzione delle scorte era tuttaltro che egalitaria A Prato nel 1339
A patte gli enti religiosi sette famiglie [ bull ] avevano Il disposizione piugrave di mille staia di granaglie (circa 18 tonnellate) fino a un massimo di 3500 Altri venti nuclei familiashyri avevano scorte comprese tra le SOOe le 1000 staia (PINTO 1978 129n)
A Mantova nei magazzini ducali nellultima parte del 500 erano ammassati non meno di un ottavo talora piugrave di un quarto delle riserve cittadine di grani panificabili (CORRlTORE 2000 81c6) A Pavia nel corsq dello stesso secolo e allinizio di quello successivo nei sozagraveri di una sessantina di famiglie si concentrava non meno del 40 per cento dell intera offerta cittadin8 di frumentomiddot (ZANJin 1964 70-7) Anche in questo caso egrave utile sapere che nelle cittagrave tedesche esistevano mercanti (ad Augusta Ratisboshyna Norimberga) in grado di ~sare riserve da 6 a 45 tonnellate e che a Francoshyforte nel 1488 due patrizi totalizzavano insieme un terzo delle scorte cerealicole dei particolari nella cittagrave alta (DlRLMB1ER 1984113)
Ritenere tali soggetti sprovv~duti al punto di incanevare grani con il solo scopo di esorcizzare i pericoli della clarestia egrave perlomeno riduttivo A grandi solari corrishyspondevano vaste familiae e plftore di servitori e ospiti ma tali scorte eccedevano largamente la sussistenza del D-aggiore palazzo nobiliare o patrizio senza peraltro costituire un fondo di accantofilljnento eccedente il fabbisogno della cittagrave a meno che non vi fosse la concreta possibfjitagrave di commercializzare il surplus sui mercati esteri Come nota infatti Adam Smith
a meno che leccedenza non possa essere esportata in tutte le circostanze ordinarie i coltivatori staranno molto attenti a non produrre e gli importatori a non importare mai una quantitagrave maggiore di quell~ che egrave strettamente richiesta dal consumo del mercato interno Questo mercato saragrave difficilmente sovrafornito ma saragrave in generale sottomorshynito dato che coloro che svolgono lattivitagrave per mornirlo avranno in generale il timore che la loro merce possa rimane~ invenduta (SMITH[l776] 528)
Lipotesi egrave suffragata dai cas storici conosciuti A Bologna macrodistretto serico dellevo modemoladdove gli interessi manifatturieri e mercantili avrebbero dovuto consigliare una sussistenza a b~on mercato per tenere basso il costo del lavoro le istituzioni annonarie operavano per-garantire con il calmiero delformento la monetizshyzazione della rendita granaria dei possidenti - strutturalmente incapace di coprire il fabbisogno della cittagrave - anche ~ rischio della carezza dei viveri contingentando il mercato dei grani forestieri (GupaI 1982 37-76) Di fatto
492 Renzo P COITitore
Tale disparitagrave sociale si riverberava sulla struttura del commercio cerealicolo La funzione dei piccoli commercianti di biade (granaiolibull biadaiolifarinaioli balshy
zarotti cavallanti vatlcali ecc) era infatti ancillare alla capacitagrave di affacciarsi sul nercato della fascia marginale deipossidenti con eccedenze Solo che nelle annate di abbondanza si venficavano ingorghi nell offerta di grano che deprimevano i prezzi e incentivavano i piccoli produttori a smerciare direttamente le eccedenze allindomani del raccolto nellarea urbana anche al di fuori dei luoghi deputati (MATI02ZI 1983 278281-2 300n PULr QUAGLIA 1984 86) Mentre nelle annate di penuria si contraeshyva drasticamente proprio questo segmento dellofferta (ABa [1966Jmiddot 22-4 KULA [1962J 73-4 CATrINI1984 111-23 PuIr QUAGUA 1984 88) scatenando nelle campashygne una caccia al grano-merce la cui quota piugrave consistente era detenuta dai grandi proprietari dai maggiori affittuari dai percettori di canoni diritti o rendite in grano e la cui quota residua era piugrave facilmente preda di chi occupava posizioni chiave nellasshysetto terriero nella catena dei diritti nel credito alla produzione e al consumo
Tanto la distribuZione era frammentata nelle annate di abbondanza tanto in epoc~ di penuria il commercio del grano diventava un affare di pochi In questo caso lazioshyne dei mercanti diVentava dimpiccio sul mercato interno dove la coperta si restringeshyva per i proprietari e gli imprenditori agricoli (KULA [1962] 56-61 CATl1NI 1984 114-8) - dove la necessitagrave di ricorrere al credito da parte dei piccoli possessori poneva questi nelle mani degli agenti dei proprietari dei percettoridi canoni diritti o rendite - dove i piccoli proprietari vedevano minacciata la loro stessa condizione da parte di chi controllava localInente in maniera capillare e decentrata il mercato del denaro e dei beni necessari alla riproduzione (sementi strumenti cibo) La soluzione era quelshyla di precludere amministrativamente ai sensali e ai commercianti di grani i mercati locali su istigazione dei medi possessori le cui occasioni di normale profitto agrario soffrivano un ridimensionamento e che si vedevano costretti a impegnarsi ccedilon tutte le loro forze per integrare le proprie entrate accaparrandosi le magre eccedeiiZe disponishybili nelle campagne e nei borghi rurali (PuLT QUAGLIA 1984 84-8 PULT QUAGLIA 1990 lO7-14)
TI destino dei piccoli commercianti in grano era quindi quello di occupare una posishyzione margilJale nel mercato del grano (MBlNrurr 1977 30 PINTO 1978 13 MAITOZZl 1983 277) e di operare - non solo a causa degli ordinamenti annonari - secondo una logica di corto respiro in cui non era contemplata neacute la conservazione di grani a lungo termine neacute lutilizzo di depositi piugrave che provvisori Come per i piccoli possidenti non si puograve parlare ne1loro caso della formazione e del mantenimento di scorte consistenti (MBlNREr 1988 156~7) Non tali comunque da sostenere il reddito contadino nelle stagioni ordinarie e da esercitare sul versante cittadino unefficace azione anticonshygiunturale in caso di carestia
Peraltro in cittagrave la struttura dellofferta era anche piugrave sperequata di quella che si rishyscontra nel contado Che si tratti di Prato nel 1339 (PINTO 1978 129 PINTO 1982 160n e 17In) Pavia negli anni 1539 1555 1513 1602 1603 (ZANEm 1963) o Mantova nellultima parte del secolo XVI (CORRITORE 2000 81-9) la distribuzione delle scorte fra i privati era singolarmente ineguale Lo attesta la rilevanza nellarea urbana della povertagrave cioegrave secondo una definizione coeva di coloro che non vivono di entrate ma sono necessitati ricorrere mattina e sera alle pistorie a comprare il pane per iI vitto loro e delle sue famiglie col denaro che di giomo in giomo si vanno guadagnando (MATshyTOZZI 1983 281) PUOgrave essere utile richiamare la situazione delle cittagrave tedesche nel basso Medioevo in una fase che egrave stata definita da Wilhelm Abellepoca doro degli artigiani e del lavoro salariato si puograve stimare che almeno la metagrave degli iscritti ai
lA costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli statibull middot497
te con il principio della piazza TI mercato pubblico periodico disciplinatola spiagshygiala piazza la loggia o iI recinto riservato alle contrattazioni - coesis~va confabshybriche magazzini e botteghe La stessa piazza per funzionare al meglio secondo il principio dello scambio diretto necessitava di magaZzini di supporto bull
4 LE SCORTE DEI FORNAI CITTADINI
Nellarea urbanagrave e nelle relazioni tra cittagrave e campagna operavano perograve temibili conshycorrenti dei privati possessori I fornai cittadini possedevano le competenze le strutshyture tecniche le relazioni sociali e il credito per incettagravere il prodotto per essere inforshymati tempestivamentesul mercato del grano e potenzialmente per dispensarlo con profitto in qualunque momento Il fatto che il loro operato fosse imprigionato in unarshycaica impalcatura di norme divieti obblighi che risalivano alletagrave romana che ne fashycevano in modo quasi istituzionalizzato il capro espiatorio delle tensioni fra produtshytori di grano povertagrave e autotitagrave non impedisce di affermare che tali vessatorie disposiziograveD1 trovassero la loro principale ragione dessere nella parte che essi giocashyvano di interlocutorilantagonisti dei proprietari terrieri nelladeterminazione del prezshyzo del grano sul mercato locale e nella realizzazione della rendita terriera (GUENZI 19824
35 GUENZI 1982 297) Neacutel caso di Mantova terra comucopia a partire dal 1492 si consend a zentilhomini
cittadini et qualuncho altro di comprare biade nel Dominio per approvvigionare la cittagrave di fatto si sand un diritto allincetta che mise fuori gioco i fornai a cui venne imposto di rifornirsi nei solarimiddotdei cittadini senza avere piugrave la possibilitagrave di effettuare acquisti nel contado e di ritenere a casa scorte superiori amiddotl 00 staia di frumento Lintento della disposhysizione egrave chiarissimo espresso senza reticenze dai Maestri delle Entrate che riportarono al marchese la soddisfazione dei possidenti mantovani per la riforma statutaria
tutta la Terra [cioegrave il Mantovano] ne [egravel rimasta satisfactissirna pensando che Vostra Excellenilii pretenda ali comodi et utilitagrave universagrave1e senza dampno et preuiditio suo Vero egraveche li fumari non si contentano parendoli comegrave il vero che non si poteranno ingrassar a suo modo come haqno factO per il passato et poteria achader [bulll Che venetanno adolershyse et supplicar aVosUa Signoria Perograve me egrave parso d~ene aviso per ques~ nostra et farli inteni1er Che questaterril ha solii due membri de li quali li cittadini soi se ne possono aiutashyre e valersene uno egrave il grano laltro egrave larte de la lana et quando se concedesse che li furshynari potessero comprare come hapno facto li tempi passati sana un fare benefitio acinquanshytaocto dessi et dampnificharelreslO de la republicasua quale de questo bon ordine ne receve emolumento grandissimo et se gaude in la Citagrave [percheacute] li fumari portano fuora el denaro et pretendono solo a suo benefitio (AG b 2441 lettera del 13 luglio 1492)
Egrave indubbio che il plauso della Terra fosse da attribuire piugrave alla possibilitagrave per i proshyprietari di accrescere le proprie entrate che a quella dei consumagravetori cittadini e dell arte della lana di trarre beneficio daJla disposizione Egrave significativo che la motivazione pro civitate nori accenni allesistenza di monopoli da parte dei fornai o di artificiose lievitashyzioni dei prezzi per causa lOro nloro attivismograve non egraveonfliggeva per quanto riguarda i prezzi finali della sussistenza con linteresse dei produttori cittadini E daltra parte largomentodello stomo dal metFato cittadino dei profitti incamerati dai fornai -laccushysa consueta a proposito deipistores egrave che fossero in gran parte stranieri (GUBNZl 19824
22) -- era unagiustificazione debole che appassionava piugrave chi concorreva direttamente
491 498 Renzo P Comtore
alla spartizione dei proventi derivanti dalla vendita e dal commercio del grano shylemolumento grandissimo - di chi doveva poi fruire della redistribnzione di tale ricchezza Tale norma avvantaggiava i possidenti cittadini e i gentiluomini ptivilegiashyti in grado di ottenere le tratte di esportazione Sul piano dellappropriazione essi erano in condizione di mettere fuori gioco gli altri possessori che producev~o eccedenze nel Dominio poicheacute si accresceva Igravea loro forza contrattuale e la loro capacitagrave di occUpare i canall commerciali piugrave redditizi Sul piano della commercialiZzazione gli stessi fruivashyno dello smantellamento della rete dintennediazione rappresentata dai fornai Per i rushystici significava perdere un collegamento essenZiale con la cittagrave ed essere emarginati dal mercato urbano nelle campagne o sul broletto di Mantova essi non trovarono piugrave i trashydizionali interlocutori (CORBlJ9RE 2000 228 231-2)
Nel caso di Bologna terra strutturalmente deficitaria e cittagrave dalla vocaiione manishyfatturie~ si costringeva i fornai ad acquistare formenti terrieri presso i solari privati in cittagrave proibendogligrave lincetta nel contado autorizzandoli ad acquistareformentiforeshystieri al di fuori delle mura cittadine presso i sensati da grqno solo a patto che fosseshyro stati smaltiti i grani cittadini a un prezzo talora superiore a quello dei grani dimshyportazione (GUlNZI1982A35 52-3)
Nella Toscana dei Medici il diritto allincetta nel contado venne concesso ai fornai in periodo di bassa congiuntura (in particolare dagli anni Trenta del Seicegravento)Per sostenere i prezzi interni in tal caso essi restavano gli interlocutori principali dei granshydi proprietari semplicemente spostando la loro principale fonte di approvvigionashymento dai solari dei particolari in cittagrave ai granai decentrati delle grandi aziende agrishycole oppure ai mercati rurali su cui affluiva la produzione cerealicola delle grandi fattorie (PuLT QUAOUA 1984 86-9 PuLTQUAOUA 1990 100 106-7)
Laddove non vi egrave come invece succede a Genova una diretta ingerenza del potere pubblico nella vita della corporazione (MAsSA 1999) i fumai di cittagrave - nonostante i lacci e lacciuoli normativi e il lavoro prevalentePlente manuale svolto neiloro laboshyratori - erano dei veri imprenditori dipendenti per il loro profitto - noininalmente stabilito per legge - dalla produttivitagrave del lavoro e dalla dotazione tecnica e finanziaria delle imprese Di ciograve fa fede la grande sperequazione esistente fra le aziende speciashylizzate nena fabbricazione del pane venale in cittagrave (AYMARD 1966 75 VECCHltltJQ 1979 82-3 GUlNZI1982 77 segg PuLT QUAOUA 1984 100 102-3) NellItalia delshyletagrave moderna questi artigiani-imprenditori della filiera del grano trattavano insieme
afarinaifarinaiolifarinottifondachierifontechierifidelariformentinari lasagneshyri maccaronari torallari vermicellari ecc fra il 40 e il 70 per cento del frumento consumato in Cittagrave nelle annate normali (CoRRJTORE 2000 126 segg) e ~ino al 100 per cento nelle annate di carestia (Puu QUAOUA 1984 98-9)
In una ricognizione delle asimmetrie informative del mercato non cegrave gruppo quale i fornai che possa integraverpretare la parte dell agente economico onnisciente Se dunque i regolamenti annonari tendevano a regolare minuziogravesamente la collocazione il volushyme e la durata delle loro scorte cosi come disponevano per gli altri artigiani della fishyliera era per neutralizzare il carattere potenzialmente eversivo di tale accantonamenshyto per i proprietari-venditori Prima ancora che per i consumatori-acquirenti n livello delle scorte rinforzava o attenuava il rischio di monopsonio da parte dei pistores piugrave potenti e facoltosi cosigrave come eventuali tentazioni da parte della categoria di esercitare un dominio egoistico sul mercato del pane (MAITOZZl1983 298)
Sarebbe quindi un errore concepire le scorte dei fornai come entropica allocazione di capitale che sconta lincertezza futura esse venivano gestite secondo criteri di rashyzionalitagrave economica e secondo la migliore efficienza tecnica nonostante i vincoli imposti alla lievitazione degli stock dalle disposizioni annonarie
lA costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
vimini paglia o canne intrecciate (come ceste stuoiecannizzi) in terracotta (addirittura anfore) piuttosto che di tessuto (i sacchi costavano troppo) (PICCINNl1976 397 MAzzA RAvEGol 1983 174-5 Zoo Toce 1990 893-4 COIiITONES11991 35n-36n)
Nella casa del piccolo produttore o del titolare di un piccolo possesso il penw (la scorta domestica) difficilmente eccedeva il consumo famigliare chi fortunato raccoshyglieva piugrave dell annona famigliare e di quanto gli serviva per il campo era spinto a venderselo nei mesi immediatamente successivi alla mietitura e alla trebbiatura per necessitagrave di denaro ma anche per la difficoltagrave di stoccare e conservare il prodotto in condizioni ottimali (MEuvRET 1988 17-9 PuLT QUAOUA 1984 88) e figravenanco per ridurre il rischio di vederselo soffiare da vagabondi e malintenzionati In questo caso in presenshyza di eccedenze (ma probabilmente anche in assenza) il bisogno di liquiditagrave e lalea cospiravano nel ridl1ITe ai minimi termini le scorte giagrave allindomani del raccolto In caso alternativo il contadino che non egrave - ripete Jean Meuvret - un homme daffaires quanshyto un homme de peur concepiva la sua riserva come un fondo di previdenza sul racshycolto futuro da non immettere sul mercato se non nel caso dellapprossimarsi di una messe sicura secondo una logica economica a contrario (MEUVRET 1988 19 e 147)
Era Jl~tente la disparitagrave fra i produttori non solo fra chi era in possesso di eccedenshyze e chi non lo era ma piugrave anqgtra fra chi poteva scegliere in virtugrave di una maggiore capienza economica e unadeguata dotazione tecnica - il mercato piugrave favorevole per i propri grani (il periodo di saldatura dei raccolti) e chi invece li cedeva troppo presto o in controtempo a livelli non ottimali
Nella gerarchia delle abitazioni rurali -- in quel vero e proprio saggio di sociologia che egrave il sesto libro del DeArchitectura di Sebastiano Serlio (scritto fra il 1537 eil 1555 inedito per tutto levo moderno) -- per trovare case attrezzate di granaio occorshyreva ascendere sino alla magione del basso mercante o cittadino fuori della cittagrave (SERLlO 1994 43 segg anche per le successive informazioni) Condizione di cui non potevano fregiarsi invece i ricchi contadini in ~essuno dei tre gradi possibili di ricshychezza al massimo la loro casa poteva essere attrezzata di portici per ricoverare le biade e di unaia per batterle segni di distinzione giagrave fra i mediocri contadini Fra questi perograve avrebbero potuto avvalersene soltanto i fortUIgravelati et di beni et di famishyglia (3deg grado di mediocritagrave) nforno per cuocere il pane e una cantina per conservashyre il vino invece li si sarebbe trovati a partire dai piugrave accomodati fra i poveri contashydini cioegrave al 4deg gradino della scala sociale alla cui base erano da collocare i poveri mendichi con vii capanna (10 grado di povertagrave) i salariati che vivevano delle [loro] fatiche avendo un puoco di terreno (2deg grado di povertagrave) i poveri con qualche beshystiuola et massimamente de buOvi possessori di una stalletta congiunta con la casa 0deg grado di povertagrave)
In sintesi nelle campagne delletagrave pre-industriale pochi avevano scorte pochissimi erano in grado di ricoverarle in un solaro privilegiatissimo chi le incanevava per speculare Dunquefra i conta4ini se si esclude quanto celato nella madia o nella dishyspensa le scorte erano un pri~ilegio di pochi nSerlio nato intorno al 1475 insiste sullimpoverimento delle class~ rurali intervenuto fra gli anni della sua giovinezza e quelli della vecchiezza in cui scrive Sotto il titolo Dellabitazione del ricco contadishyno per tre gradi di ricchezza si preoccupa di puntualizzare
bencheacute al di dogi non se n~ truovi piugrave de tali merceacute delle discordie et di gli animi fieri et ostinati alla vendetta onde per tal cagioni et per le continue guerre et anche pei citadini divoratori de gli altrui beni che con le usure con glinganni con le rapine gli bano impoveriti (SERUO 1994 ~8)
490 RellOP CorrilOle
colto (agosto-settembre-ottobre) e invia di esaurimento almomento della saldatura dei raccolti (aprile-maggio-giugno )1A questo proposito nota Franccedilois Sigaut
Le stockage agrave court terme (moins dune campagne) reacutepond agrave la neacuteCessiteacute cIeacute concilier une offre variable et une demande constante mais toutes deux reacutegulieacuteres et preacutevisibles dans la
pratique il est consideacutereacute comme tiiisant pame du processus ordinaire de la production et ne pose agrave ce titre que desproblegravernes doptimisation assez simples (SlOAUI 1985 602)
La discussione generale sulla razionalitagrave economica delle scorte alimentari in etagrave pre-industriale puograve allora essere ridotta alla fonnulaiione e allo scioglimento di due
semplici quesiti 1 Accertato che laccantonamento digram per la periodicitagrave annuale del ciclo agricoshy
lo epet i vincoli tecnici di un rifomimento spazialmente allargato egrave inevitabile chi egrave conveniente che conservi le scorte chi produce o chi commercia il contadino o il mercante lapossidenzagrave o il popolo i particolari o il pubblico E qual egrave la realtagrave effettiva
2 Se le forme di distribUzione economicamente razionale sono plurali in quale conshytesto e in omaggio a quali interessi piugrave utile il sistema della canova rispetto al sistema delll piazza del mercato e dei solari privati
3 SULLADISTRIBUZIONE DEL GRANO NELUETAgrave PRE-INDUSTRIALE E LA STRUTTURA DELLE SCORTE NEI TERRITORI ITALIANI
Raramente le case contadine erano dotate di attrezzature per la conservazione dei cereali piugrave che elementari Nelle campagne toscane del Quattrocento dunquein unetagrave favorevole al reddito contadino in una regione fra le piugrave ricche dellEuropa pre-indushystriale
pochissime case contadine disponevano del granaio vero e proprio alcune avevano una cella che poteva servire allo stesso scopo ma la maggior parte di quelle abitazioni era priva di spazi destinabili esclugravesivamente alla conservazione dei cereali Perciograve i contenitori dei grani arche casse sacchi bugnole - dovevano trovare posto nelle cucine o nelle camere CMA= RAVEGGI 1983 174)
Le ridotte capacitagrave patrimoniali e reddituali della grande maggioranza dei produttori facevano sIgrave che fosse ampiamente invalso nella conservazione domestica dei grani limshypiego di contenitori in legno (come arche casse botti bugnole tini tinelle corbelli)in
Riguardo ai passi evidenziati di Zanetti e Cipolla egrave neCessario osservare che la principale atteshystazione sullesistenza di stock detenuti da privati che esorbitassero ilfabbisognostagionale tali da essere classificati come immobili=zione di ricchezza (Zanetti) o come beni capitale (Cipolla) a unanalisi piugrave fine si rivela fallace o non direttamente utilizzabile La propalazione dei grani effetshytuata a Pavia fra ilimiddot e il5 maggio 1555 che egrave il fondamento di entrambi i giudizinon mostra una somma di derrate realmente eccedente il fabbisogno delle famiglie per il periodo che manca allarri_ vo dei grani novelli sulla piazza pavese Daltra parte lastessa natura dellistituto della propalazioshyne dei grani cioegrave della denljncia obbligatoria delle scorte da parte dei particolari una misura demergenza decisa in momenti critici dellapprovvigionamento cittadino affiancata quellanno dalshylispezione diretta presso le case dei privati da parte di deputati straordinari avrebbe dovuto consishygliare una maggiore cautela nella sua utilizzazione per individuare regolaritagrave di carattere generale delleconomia pre-industriale
499 La costituzione di scorte granarie pubbliche e la ptlitica ecoMmica degli stati
FONTI
ABEL [1966) W ABEL Agrarkrisen undAgra~kJJnjunktur Eine Geschichte der londshy und Erniihrungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter Hamburg
und Berlin Paul Parey 19662 (la ed -1935 trad it Congiuntura agraria e crisi agrarie Storia dellagricoltura e della produzione alimentare nellEuropa centrashyle dal XIII secolo alletagrave industriale Torino Einaudi 1976 da cui si cita)
AG ARCHIVIO GoNZAGA presso lArchivio di Stato di Mantova AuFANO 1996 E AuFANO Il grano il pane e la politica annonaria a Napoli nel Setshy
tecento Napoli ESI 1996bull AYMARO 1966 M A YMARO Wmise Raguse et le commerce du bMpendant la seconde
moitieacute du XVI siegravecle Pans SEVPEN 1966 CATIINI 1984 M CATl1NI I contadini di San Felice Metamorfosi di un mondo rurale
nellEmilia delletagrave modernIgravel Torino Einaudi 1984 CESTARl 1794 p CESTARI Saggio storico dei Fondachi delle farine di Chioggia e
Pellestrina Venezia A Zatta 1794 CIPOllAJ1965] C M CIPOllA La politica economica dei governi V La penisola
italigraveana e la penisola iberica in Storia economica Cambridge m La cittagrave e la politica economica nel Medioevo Torino Einaudi 1977 (Cambridge 1965) pp 462-496
CIPollA 1974 C M CIPollA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna nMulino 1974
CIpollA 1997 C M CIPOllA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna nMUlino 1997 (6 ed riveduta)
CORRITORE 2000 R P CoRRITORE La naturale abbondanza del Montovano Produshyzione mercato e c01isumi granari a Mantova in etagrave moderna Pavia Universitagrave di Pavia 2000
CORIONBSI 1991 A CORIONBSI Sulla conservazione dei cereali nellItagravelia medioevale Lavoro e tecniche nelle tesnmonlanze laziali (secc XIII-XV) in Rivista di storia dellagricoltura XXXI 1991 l pp 33-49
DELLA VALENTINA 1992 M DELLA VALENTINA I mestieri del pane a ~nezia tra 600 e 700 in Atti dellIstituto [Veneto di Scienze Lettere ed Arti Classe di scienze morali lettere ed arti CL 1991-92 pp 113-217
DIRLMEIER 1984 U DIRLMEIER le condizioni materiali dellesistenza nelle cittagrave tedeshy sche del Basso Medioevo ~iente esterno reddito consumi in Aristocrazia citshy
tadina e ceti popolari nel tprdo Medioevo in Italia e in Germania (a cura di Reinhard Elze e Gina Fasoli) Bologna Societagrave editrice il Mulino 1984 pp 79shy122
FORNASIN 1999 A FORNASIN Il pzercatodei grani di Udine Indagine per una storia dei prew in Friuli (secoli XfI-XVIII) Nota di ricerca del Dipartimento di Scienshyze Statistiche dellUniversit4 degli Studi di Udine 4 1999 pp 1-24 ora in lo La Patria del Friuli in etagrave 1fIOderna Saggi di storia economica Udine Forum 2000 pp 33-60
GRENDI 1986 E GRENOI Lapprccedilwigionamento dei grani nella Liguria del Seicento libera pratica e annone in iMiscellanea storica ligure Studi in onore di Luigi Bulferetti XVIII 1986 2Jp 1021-1047
GUENZI 1981 A GUENZI Ilfrurnfnto e la cittagrave il caso di Bologna nelletagrave moderna in Quaderni storici XVI ~981 46 pp 153-167
GUENZI 1982 A GUENZI Pane ~fornai a Bologna in etagrave moderna Venezia Marsilio 1982
I
489 500 Renzo P CornIOle
GUBNZI1982 A GUEml Sistema annonario e egraveontrollo sociale a Bologna nei seccediloli XVII e XVIII in E SORI (a cura di) Cittagrave e controllo sociale in Italia fra XVIII e XIX secolo Milano F Angeli 1982 pp 293-306
HICKS [1989] 1 R HIClCS A narlcet theory of money Oxford Oxford Universigravety Press 1989 (trad it Una teoria di mercato della monefa Bologna li Mulino 1992 da cui sigrave cita)
JACOPBITI 1965 N L JACOPBITI Monete e prezzi a Cremona dal XVI al XVlIi secolo Cremona Athenaeum CregravemoneJlSe 1965
KAPLAN 1984S L KAPLAN Provisioning Paris Merchants and Millers in the Grain and Flour Trade during the Eighteenth Century Ithaca-London Cornell Univershysity Press 1984~middot
KULA [1962] W KULA Teoria ekonomiczna ustrojufeudalnego Proba modelu Warshyszawa-Panstwowe WydawnictwoNaukowe 1962 (trad it Teoriagrave economica del sistema feudale Proposta di un modello Tormo EinaUdi 1972 ccedilla cui si cita)
WROUSSE [1933] C-E LABRoussE Esquisse du mouvement des prix et des reverws en France au XVIII siegravecle Paris Eacuteditions des Archives Contemporaines 19842 volI (l ed Paris Librairie Dalloz 1933)
MALANtMA 1976 P MALANiMA Aspetti di mercato e prezzi del grano e della segalea Pisa dal 1548 al 1818 in Ricerche di storia moderna vaL I Pisa Pacini 1976 pp ~n
MANToVA 1430 MwroVA 1430 Pareri a Gian Francesco Gonaga per il governo (a cura di M AQrignaniA M Lorenzoni A Mortari C Mozzarelli) MUltova G~ Arcari 1990
MASSA 1999 PMAssA Annona e corporazioni del settore alimentare ~ Genova orshyganizzazione e conflittualitagrave (XVI-XVIII secolo) in A GUENZI PMAssA A MOIOshyu (a cura di) Corporazioni e gruppi professionali nellItalia moderna MilIllO F Angeli 1999 pp 390-403
MATIoZ7J 1983 1 MiJroZ7J F BOLELLI C CmAsBRA D SABBIONI Il politico e il pane a Venezia (157Q-1650) calmieri e governo della sussistenza in Societagrave e storia VI 198320 pp 271-303
MAzzI RAVEOOI 1983 M T MAzzI S RAVEOGI Gli uogravemini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento Firenze Olscbki 1983
MERONI 1957 U MERONI Cremona fedelissima Ciemona Athenaeum Cremonenshy~~~ _
MBUVRBl 1977 J MEuVRsT Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque LouisXIvI La productiograven des ceacutereacuteales dans la France du XVII et du XVIII siegravecle Paris Mouton -EacuteEHSS19772voll
MBUVRET 1988 J MBtJVRf Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque Louis XIv III Le commerce des gralns et la conjoncture Paris EacuteEHss 1988 2 volI
PtCClNNI 1976 G PtCClNNl Wta contagravedina in una capanna dei dintorni di Siena (1250) in ~Archeologia medievale m 1976 pp 395-399
PlNIO 1978 G PINTOII Libro del BiaPaiolo Carestie e annona a Firenze dalla metagrave del 200 al 1348 Fire~ Olscbki 1978
PiNTO 1982 G PtNro La Toscana nel tardo Medioevo Ambiente economia rurale societagrave Fllenze Sansoni 1982
PtRENNE [1933J H PIRENNB La civilisation occidentale au Moyen Age du XIe au mishylieu du XVe siegravecle Paris PUF 1933 (trad it Storia economica e sociale del Meshydioevo Milano Garzanti 1967 da cui si cita)
Lacostituticne di scorte granarie pubbliche e la politica economiegravea degli stati
redigravestribuzione sostenibile dei beni di sussistenza egrave ricercata in questo cielo da quegli stessi particolari che ~amaldeggiano nella produzione negli scambi nei consumi e che costituiscono il nerbo della classe di governo Le scorte pubbliche rappresenteshyrebbero in questa prospettiva un presidio civico e un risltCimento politico e morale ai cOl1ponenti della comunitagrave spossessati delbene supremo dellautarchia alimentare
Resta infine latente unidea del magazzmo pubblico come quasi-mercato cioegrave come luogo volto (1) a risolvere i fa1limentiinfo~vi della piazza del mercato (in meacuterito alle disponi~ilitagrave alle caratteristiche del prodotto alle condizioni di vendita della merce) (2) a ridimensionare lalea per agricoltori consumatori poveri artigiani del comparto alimentare (3) a sostenere i consumi e i profitti privati m funzione anticicli ca in una prospettiva Ilpn meram~nte congiunturale Si tratta in questo caso di un orshyganizzaZionepienattiCnte razio~e Che non opera in maniera saltuaria e riflessa ma in modo continuativo secondo obifttili prefissati di allocazione dei beni primari li funshyzionamento dellacanovagrave (il magazzino pubblico) si porrebbe come strumento inteshygrativo ma no~~igraventeramente so~titutivo delloperare della piazza Si tratterebbe di unaforma di mercato distinta dalla p~ del mercato considerata in seacute e per seacute cosigrave come dallegraveOOmpravendite effetttlate nei solari privati o dalla mera centrallzzazione e redistribuzione di derrate con fi~alitagrave umanitarie La canova rappresenterebbe in tal modo uno dei possibili meccaoi~ di governo delle trllls3ZIgrave~ni locali per risolvere i problemi deUapprovvigionameIto senza intaccare certi interessi di classe (dei proshyprietari ma anche del popolo grasso) S da essere prescelta da autoritagrave e gruppi domishynanti come struttura complementare della piazza del mercato incerti contestiprodutshytivi ed economici La suasacrilizzazione perciograve non esclude la possibilitagrave di un ritorno alle sole compravendite qella piazza e dei solari privati - una volta invertishytosi il trend o spirate le condizioqi economiche della sua istituzionalizzazione
La problematizzazione esorc~ una liquidazione semplicistica del problema delle scorte gran8rle in etagrave pre-industriUgravee nel nome di una loro presunta irrazionalitagrave eco- nomica per il compito di assi~ la sussistenza della popolazione
Le pagine che segUono sono rintroduzione a un lavoro in corso volto a offrire un interpretazione generale di tal~ capitolo fondamentale della politica economica dei governi
in
etagrave pre-industriale
2 SE UN MONDO SENZA SCORTE Egrave INCONGRUO cm Egrave OPPORTUNO CHE LEgrave DETENGA
Nei fatti nel settore granarlo CQni vincoli dell etagrave pre-industriale in tema diprodutshytivitagrave energia trasporti non ha s~nso ipotizzare un mondo senza scorte Se il mercato del grano egrave - come nellEuropa medievale e moderna - un sjstema tendenzialmente chiuso
ad ogni raccolto nuove offe~ aniv(erannol sul mercato mentre la domanda si mant[erragrave] relativamente costantt nel corso dellanno Qualcuno dunque [dovragrave] ~ere delle scorte che saranno elevate ~ubito dopo il raccolto e poi via via minori fino aragshygiungere un livello minimo in prpssimitagrave del successivo raccolto (HICICS [19891 31)
Nella loro forma piugrave sempliceI tali scorte saranno legate allora alla periodi~itagrave anshynuale del ciclo agricolo (che a1iplenta il movimento stagionale dei prezzi ccedilfr LAshyBROlJSSE [1933] 157-66) il loro livello saragrave elevato allindomani del principiLle racshy
501 488 Renzo P Corritore
povero ammassograve nella propria dimora scorte di grano carne ~alata sale candele ecc e la medesima cosa fece lo Stato Nel periodo feudale non venne mai meno nel castello del signore labitudine di tenere da parte grosse scorte per i periodi di emergenza Sucshycessivamente le autoritagrave comunali predisposero il magazzinaggio di grosse derrate specie di grano da rivendere a basso prezzo in periodi di emergenza e nello stesso tempo si preoccuparono di prevenire un indebito accumulo di scorte da parte di specushylatori privati Nelle economie medievali gli stock di derrate di prima necessitagrave rappreshysentarono pertanto una delle piugrave importanti forme di investimento pubblico e privato (CIPOLLA (1965] 468)
Nella prima versione del manualeacute invece fino allinserimento nel 1997 del nuovo capitolo dedicato alla politica economica nell etagrave pre-mdustriale il punto di vista preshyvalente era quello microeconomico entro il perimetro stretto dellindividualismo meshytodologico
Le scorte costano e costano doppiamente Esse implicano il costo diretto che egrave rapshypresentato dal costo del magazzinaggio edal deterioramento eventuale del pr04otto o di parte di esso Se luomo daffari finanzia la costituzione delle scorte con danaro preso a prestito il costo diretto include anche il tasso di interesse pagato Se luomo daffari finanzia con capitale proprio la costituzione delle scorte il costo delle scorte deve inshycludere un costo-opportunitagrave e cioegrave il mancato rendimento (tIllU1cato tasso dinteresse attivo) del capitale finanziario impiegato (CIPOLLA 1974 154)
Le ragioni della costituzione e del mantenimento di scorte alimentari da parte delshylautoritagrave pubblica diventavano unicamente ragioni morali (umanitarie e di buona amministrazione) o di opportunitagrave politica (la fame era la piugrave frequente ligraveausa di sommosse e furori popolari) (CIPOLLA 1974 74)
Nel 1997 si riammetteva dunque linterpretazione originaria della costituzione di scorte pubbliche come strumento di riequilibrio del mercato senza peraltro rinnegare le considerazioni sulla valenza statica di tale forma di investimento per gli agenti economici privati
In merito allutilitagrave economica e al significato delle scorte in etagrave pre-industriale Cishypolla non espresse perciograve sempre lo stesso punto di vista La rassegna delle posizioni da lui assunte anzi permette di individuare tre approcci e tre giudizi costitutivamente diversi sulla funzione delle scorte granarie nellepoca pre-industriale
In prima approssimazione laccumulazione di scorte alimentari mostra il carattere fondamentalmente difensivo delle scelte degli agenti economici pubblici e privati in etagrave pre-industriale La paura la tradizione la superstizione li induce a tabuizzare il rischio la speculazione linvestimento nella produzione e nella distribuzione dei beni essenziali alla vita e ad aderire intimamente a un ideale di economia e societagrave stazionarie aggravando con la norma sociale le istituzioni il comportamento indivishyduale e collettivo leffetto dei condizionamenti materiali delleconomia pre-industriashyle (bassa produttivitagrave agricola alti costi di v~sporto modesta efficienza energetica) esponendo ancor di piugrave la comunitagrave umana ai degravemoni della natura
La seconda interpretazione rigetta luniversale imperio dellhomo oeconomicus rishyscoprendo leteronomia dei fini dellagire economico degli uomini nelletagrave pre-inshydustriale Ia politica economica dello Stato o-delle autoritagrave non persegue puri scopi economici lintegritagrave del corpo sociale fin nelle sue cellule elementari (persone e famiglie) deve essere assicurata secondo i principi e la prassi di uneconomia morale che SOVJa5ta leconomia regolata dal mercato spersonalizzata e antipopolare Una
La costituzione di scorte grantlTie pubbliche e la poligravetigraveca economica degli stati
PuLT QUAGUA 1984 A M PULT QUAGUA Mercato dei prodotti agricoli e magistratushyre annonarie a Pisa nelletagrave moderna in Ricerche di storia moderna a cura di M Mirri voI III Pisa Pacini 1984 pp 57-141
PULT QUAGLIA 1990 A M PULT QUAGLIA Per provvedere ai popoli Il sistema anshynonario nella Toscana dei Medici Firenze Olschki 1990
SERUO 1994 S SERLIO Architettura civile Libri sesto settimo e ottavo nei manoscritshyti di Monaco e Vienna (a cura di F P Fiore) Milano TI Polifi10 1994
SIGAlIT 1985 F SIGAlIT Questions deacuteconomie agrave propos des politiques ceacutereacutealiegraveres et de stockage in Les techniques de conservation des grains agrave long terme leur rale dans la dynamique des systegravemes de cultures et des socieacuteteacutes (sous la direction de M Gast F Sigaut et C Beutler avec la collaboratlon de O Bllchsenschutz) voI III 2 Paris Eacuteditionsdu CNRS 1985 pp 597-606
SMITH [1776 A SMITH An inquiry into the nature and causes ojthe wealth ojnations London W Strahanand T Cadell 17762 volI (trad it Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni Milano A Mondadori 1977 2 volI da cui
si cita) STATlITlBoNACOLSIANI [1313] STATUTI BONACOLSlANl (a cura di E Dezza A M Lorenshy
zoni M Vaini) Mantova GArcari 2002 STATUTI GONZAGHESCHI [1404] STATUTI GONZAGHESCHI presso la Biblioteca comunale di
Mantova ms FV 11 [775]VECCHIATO 1979 F VOCCHIATO Pane e politica annonaria in Terrajerma veneta tra
secolo XV e secolo XVIII (Il caso di Verona) Verona Stamperia Zendrini 1979 ZANETTI 1963 D ZANETTl Contribution agrave leacutetude des structures eacuteconomiques lapshy
provisiQnnement de Pavie au XVI siegravecle in Annales ESC XVIII 1963 1 pp 44-62 ora in lo Fra le antiche torri Scritti di storia pavese Pavia Universitagrave di Pavia 2000 pp 165-182
ZANETTl 1964 D ZANEITI Problemi alimentari di una economia preindustriale Ceshyreali a Pavia dal 1398 al 1700 Torino P Borlnghieri 1964
ZUG TUCCI 1990 H ZUG TuCCI Le derrate agricole problemi materiali e concezioni mentali della conservazione in Lambiente vegetale nellalto Medioevo XXXVII Settimana di studio del Centro italiano di studi sullalto Medioevo (30 marzo-5 aprile 1989) Spoleto Centro italiano di studi sullalto Medioevo 1990 voI n pp 865-902
494 495 Renzo P Corritore
In ogni caso si tendeva a limitare al minimo indispensabile le importazioni di frushymento per evitare che stocks invendutigrave potessero turbare )a collocaziolle dei grani tershyrieri ileI nuovo anno agrario (GUENZI 1981 153)
In tutti i centri comunque la tendenza a ritardare la vendita del surplus nei mesi della saldatura lutilizzo di depositi specializzati con personale addetto alla custodia al conshydizionamento e alla commercializzazione del prodotto ponevano i grandi proprietari di biade su un gradino superiore e diverso rispetto al resto della cittagrave Laccantonamento di grani per questa cupola di possessori rispondeva al principio dellutilitagrave soggettiva atshytesa e richiedeva sia capitale fisso sia capitale circolante per raggiungere gli scopipreshyfissati un profitto speculativo la valorizzazione della rendita
In molte cittagrave i possessori non avrebbero dovuto trattenere in casa piagrave grano e farina di quantoprescritto dalla legge cioegrave il consumo mensile per bocca ~- fissato anchesshy
so statutariamente --per arrivare al nuovo raccolto Ma i cittadini credevano veramenshyte ai loro comandamenti Egrave lecito dubitare La norma era scogravelpitagrave negli Statuti e pubshyblicamente violatamiddot con la complicitagrave dccedillle autoritagrave e dei gruppi professionali interessati alla distribuzione del grano nelle sue varie forme
Nelle annate ordinarie la quota di grano autoconsumato - cioegrave non acquistata sul mercato - nelle cittagrave italiane dell evo moderno rappresentava fra il 30 e i160 per censhyto del fabbisogno urbano di frumento
Nella capitale dei Gonzaga nel 1615 si valutava che su 27000 bocche
il terzo [di] gentilhuomini ligravettadri servitori et altri [ ] non comprano biada et gli duoi terzi tra poveri artisti mercanti fomari fondachieri hebrei et altri [ l non possono in tutto levar sufficientemente la $omma de detti dua terzi sl che saranno boshyche 18000 che compraranno biada (CoRRlTORB 2000 126)
AVenezia a cavaliere fra XVI e xvn secoioalla mensa delle casade si dispensava circa un terzo del frumento consumato ordinariamente in cittagrave (AYMARD 1966 74 MArroZZI 1983 281) A Bologna per tutto il Seicento i fornai che impastavano farine in conto lavorazione per i particolari pareggiavano piil o meno il numero di quelli da scaifa che smerciavano pane venale (GUBNZI 1982 27) Peraltro la proporzione a Rialto tra chi lavorava per le casade e chi vendeva pane al pubblico - 65 fOf7lri a fronte di 44-48 pistori negli anni 1583-1685 (DELLA VAUNTINA 1992 143-4167 192-3) - fa ritenere la struttura del mercato del pane felsinea non molto dissimile da quella veneziana Nelle cittagrave liguri o toscane sei-settecentesche la porzione autoconshysumata quando il raccolto era buono era anche piil elevata (ORENOI 1986 1024-6 1034 PuLT QUAGLIA 1984 98-104 PULT QUAOLIA 1990 171-2) A Napoli nel 1758 a Monasteri Luoghi pii e Particolari eta riservato il 28 per cento del consumo cittadishyno di frumento (AuFANO 1996 370)
Lelevato numero di servi domestici persone al servizio delle casate faceva si che in alcuni palazzi si concentrassero masse cospicue di grano per la spesa familiare Ma accanto ad esse gli operatori dellannona -lastessapovertagrave __ si auguravano che vi fosse sempre anche la materia per rifornire il mercato e i forni cittadini nella fase piil delicata del ciclo annuale il periodo di saldatura dei raccolti Come spiegare altrimenshyti la norma che imponeva ai grossi detentori digrave biade (non esclusi enti e opere piegrave) in varie cittagrave italiane dellevo moderno la vendita straordinaria in primavera delle ecshyredenze ammassate in granaio (per Pisa e la Toscana v PuLT QUAGLIA 1984 88-9)
A Mantova nel 1554 si stabiliva che i patroni che avessero fruito in cittagrave di piugrave di 20 sacchi di grano come porzione dominicale avrebbero dovuto conservare in granaio
lA costituzione di SC0114 granarie pubbliche e la politica economica degli stati
il 4 per cento per le necessitagrave dei consumatori dei fornai e dei fontachieri quando fosse mancato il prodotto sulla piazza o nelle offerte deimiddotsensati Nel 1603 ci si preocshycupograve di elevare la quota al 6 per cento (CoRRlTORE 2000 237n) Beninteso le vendite sarebbero avvenute ai valori di mercato 10 stessa sistema vigeva a Cremona (6 per cento nel 1608 e nel 1612) (MERON 1957 -59n 63 JACOPETl11965 128) ea Verona Qui una delibera consiliare del 1549 autoruzava per la prima volta
[i] deputati [alle Biade) [al tassar e comandar con quelle pene che al Clarissimo Podestagrave pareragrave quella quantitagrave di biade a ciascuno secolare o eclesiastico sia di qual grado o condittione esser si voglia che havesse biade in questa cittagrave oltre il viver suo (VBCClI1ATO 1979 145)
La tassa sarebbe stata stabilita - dal 1558 - per sorteggio fra le casate che avessero introdotto in cittagrave dai propri possedimenti piagrave di 70 minali per rifornire il Mercato delle biave Essaveane anche incrementata nella stessa occasione dal 5 al6 per censhyto per restare in vigore fino al 1631 (VECCHIATO 1979 141-58)
Questccedil tijlo di normativa nasce e si affuia in ambito amministrativo perciograve echeggia la realtagrave molto meglio della veneranda legge generale
Da tali disposizioni si deducono alcuni fatti incontrovertibili 1entro la cerchia cittadina esistevano scorte private eccedenti la spesa delle famiglie
in violazione in molti casi della legge statutaria 2il possesso della terra che solo assicurava lautarchia delle casate era il piugravemiddotpotente
fattore di discriminazione fra i cives tanto da precipitare nel girone dei pauperes la moltitudine che acquistava correntemente la sussistenza nellarea urbana
3fra gli stessi possidenti cittadini esisteva uneacutelite che non solo conservava scorte oltre il viver suo ma che si proponeva egoisticamente di speculare ritardando limshymissione dei grani sulle piazze cittadine o che a~endeva il momento piagrave opportuno per smerciarli allesterno nelle grandi piazze frumentarie come Uvorno Desenzashyno Legnago Romano di Lombardia) ecc
4lineguaglianza fra i cives tese ad aggravarsi con la metagrave del 500 poicheacute questi reshygolamenti innovano quasi sempre disposizioni generali risalenti al tardo Medioevo che sancivano lobbligo di convogliare il surplus sulla piazza cittadina segno di una distribuzione del reddito originariamente meno sbilanciata shyACremona gli Statuti del 1388 obbligavano - cosl egrave ancora nel 1510 - a vendere il
sovrappigraveagrave in Piazza Maggiore sul mercato pubblico dei grani (MERON 1957 59n 63)
A Pisa il rescritto che imponeva di effettuare le vendite al minuto in platea bladi risale al 1401 (MALANIMA 1976 293) lobbligo era ribadito ancora nel 1548 ma nella seconda metagrave del secolo XVI si affermava la pratica di vendere fuori mercato tanto che nel 1581 il Magistrato dei Nove dovette intervenire per far vendere i grani delle comunitagrave degli enti e dei luoghi pii soltanto da marzo-aprile in piccole quantitagrave sul mercato (PULT QUAGLIA 1984 8191) La disposizione per altro si applicava allinteshyro Stato (PULT QUAGLIA 1984 88)
Tuttavia non egrave da pensare che il principio della concentrazione delle compravendite sulla piazza di mercato cittadina fosse universale universalmente rispettato e sopratshytutto perenne La centralizzazione del grano non significa automaticamente lobbligo di vendita diretta sulla Piazza deiformenti Affermare come Steven L Kaplan che
There was no single more important regulation conceming the provisioning trade han the requirement that ali transactions occur in the marketplace (KAPuN 1984 27)
493 496 Renw P Corritore
appare altrettanto astratto dogmatico O virtuale del principio di mercato (Market Principle) che il medesimo gli contrappone Henri Pirenne parlando della politica annonaria dei comuni medievali avverte Lapplicazione del principio della vendita diretta ebbe numerosi eccezioni (PIRENNE [1933] 193n)
Nel caso di Mantova la scelta della Piazza egrave facoltativa per i terrieri con eccedenze GliStatuti signorili che si rifanno largamente alle raccolte statutarie comunali non sancivano alcun obbligo in proposito (v SYJI1l BONACOLSlANI [1313] libro ID rubr 55 De mercato blave 253 STATUTI GoNZAOHESCHI [1404] libro m rubr 93 De mercato blave fiendo in civitate Mantue f 73v) Decreti di carattere straordinario e regolamenshytazioni transitorie correggevano il tiro Nel 1405 in piena saldatura dei raccolti si coshystrinse a rifornire forzosamen~e la piazza concentrandovi tutte le contrattazioni Nel 1417 si obbligograve a riservare al mercato un terzo del frumento introdotto in cittagrave (CoRRIshyTORE 2000 235-6) Ma sono atti straordinari che non sopravvissero nel migliore dei casi piugrave di qualchelustro (MANToVA 1430 88 90 181) A Mantova la Piazza era affianshycata da un granaio pubblico la Domus del mercato (altrove definito Fornico o Fontego del mercato) in cui avrebbero dovuto prolungarsi le contrattazioni oltre lorario e i giorshyni deputati (venerdl o sabato) rendendo disponibile ciograve che restava invenduto e che non poteva essere ritirato per legge dal mercato Nel 1430 eminenti cittadini sollecitati dal principe lamentavano pero lincapacitagrave del magazzino - inoperoso in tutto o in ~per il pericolo di crolli - di rispondere ai bisogni del popolo in una situazione in cui da parte dei possessori si protestava la difficoltagrave di non poter esitare e smerciare fuori delshyla cittagrave le eccedenze conservate nei solari privati
ltem videtur quod valde utille foret civibus Mantue habentibus possessiones et quishybuscumque alijs personis de civitate Mantue aut districtu colligantibus bIada et vina in magna copia ut amni tempore ipsa bIada et vinum possent exttahere de civitate et dishystrictu Mantue et conducere ad Iaea ad que et in quibus illa vendere poterunt cum otdigraveshynibus et dacijs competentibus ipsa tamen civitate semper remanente fulta pro usu diete civitatis et populi eiusdem ne dicta bIada mateeschant super granariis ut hactenus fecemiddot runt cum maximo incomodo ipsorum civium (MANToVA 1430 177-8)
Il medesimo fondaco abbinato al mercato operava a Verona a Ferrara a Venezia a Udine a Chioggia in molte altre cittagrave (MANToVA 1430 100 FORNASIN 1999 7-9 CBshySTARl1794)
Lintegrale e pedissequa applicazione del principio della piazza di mercato comporshytava - per i vincoli tecnici dell etagrave pre-industriale -la massima affermazione del prinshycipio della canova cioegrave del magazzino pubblico centrale Unico argine alla sua invashydenza era costituito da una distribuzione perequata ab imis del raccolto cioegrave la possibilitagrave egrave questo il paradosso di realizzare da parte dei produttori la massima aspirazione nelle societagrave tradizionali lautarchia domestica Piugrave avanzava invecela sperequazione nel reddito e nel patrimonio piugrave da parte dei consumatori privi di scorshyte si impetrava il principio del Magazzino pubblico nella forma di un efficiente sisteshyma di ricovero conservazione distribuzione delle derrate a garanzia del funzionashymento della Piazza di mercato La disponibilitagrave di crescenti quote di raccolto tuttavia indirizzava i piugrave accomodati verso soluzioni piugrave ghiotte la vendita allingrosso sul mercato cittadino ai fornai o allimpresa pubblica creata a sussidio di questi (o in loro vece) Oppure allopposto lesito delle eccedenze extra muros sui grandi mercatishyemporio regionali per il tramite di mercanti o agenti diretti
Il principio del magazzino pubblico centrale cioegrave laccumulazione di riserve per lo smercio continuo o anticiclico egrave quindi alla sua origine in opposizione solo apparen-
La costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
ruoli fiscali non fossero in grado di accantonare scorte Nel 1444 a Strasburgo quattro cittadini su dieci non possedevano alcuna riserva cerealicola (DIIUMBIER 1984 112)
Nelle cittagrave italiane delletagrave moderna si puograve stimare che non meno di due terzi della popolazione fosse costretta ad acquistare o consumare pane confezionato con grani e farine comperati nelle piazze nelle vie e nelle botteghe cittadine oppure ottenuti come compenso del proprio servizio nelle casate (CoRRITORE 2000 126-36 MAnoZZI 1983 27~-82) Evidentemente questa fascia di lavoratori salariati non possedevashyper definizione -- neacute scorte neacute depositi personali e nel primo caso era strettamente dipendente dal mercato urbano acquistando la sua sussistenza con frequenza non piugrave che settimaIIgraveale (essendo costretti a comprare il pane tutti i giorni alla finestra si dishyceva a Genova (GRENDI 1986 1031])
Ma anche fra i citUutini con possesso extra moenia la distribuzione delle scorte era tuttaltro che egalitaria A Prato nel 1339
A patte gli enti religiosi sette famiglie [ bull ] avevano Il disposizione piugrave di mille staia di granaglie (circa 18 tonnellate) fino a un massimo di 3500 Altri venti nuclei familiashyri avevano scorte comprese tra le SOOe le 1000 staia (PINTO 1978 129n)
A Mantova nei magazzini ducali nellultima parte del 500 erano ammassati non meno di un ottavo talora piugrave di un quarto delle riserve cittadine di grani panificabili (CORRlTORE 2000 81c6) A Pavia nel corsq dello stesso secolo e allinizio di quello successivo nei sozagraveri di una sessantina di famiglie si concentrava non meno del 40 per cento dell intera offerta cittadin8 di frumentomiddot (ZANJin 1964 70-7) Anche in questo caso egrave utile sapere che nelle cittagrave tedesche esistevano mercanti (ad Augusta Ratisboshyna Norimberga) in grado di ~sare riserve da 6 a 45 tonnellate e che a Francoshyforte nel 1488 due patrizi totalizzavano insieme un terzo delle scorte cerealicole dei particolari nella cittagrave alta (DlRLMB1ER 1984113)
Ritenere tali soggetti sprovv~duti al punto di incanevare grani con il solo scopo di esorcizzare i pericoli della clarestia egrave perlomeno riduttivo A grandi solari corrishyspondevano vaste familiae e plftore di servitori e ospiti ma tali scorte eccedevano largamente la sussistenza del D-aggiore palazzo nobiliare o patrizio senza peraltro costituire un fondo di accantofilljnento eccedente il fabbisogno della cittagrave a meno che non vi fosse la concreta possibfjitagrave di commercializzare il surplus sui mercati esteri Come nota infatti Adam Smith
a meno che leccedenza non possa essere esportata in tutte le circostanze ordinarie i coltivatori staranno molto attenti a non produrre e gli importatori a non importare mai una quantitagrave maggiore di quell~ che egrave strettamente richiesta dal consumo del mercato interno Questo mercato saragrave difficilmente sovrafornito ma saragrave in generale sottomorshynito dato che coloro che svolgono lattivitagrave per mornirlo avranno in generale il timore che la loro merce possa rimane~ invenduta (SMITH[l776] 528)
Lipotesi egrave suffragata dai cas storici conosciuti A Bologna macrodistretto serico dellevo modemoladdove gli interessi manifatturieri e mercantili avrebbero dovuto consigliare una sussistenza a b~on mercato per tenere basso il costo del lavoro le istituzioni annonarie operavano per-garantire con il calmiero delformento la monetizshyzazione della rendita granaria dei possidenti - strutturalmente incapace di coprire il fabbisogno della cittagrave - anche ~ rischio della carezza dei viveri contingentando il mercato dei grani forestieri (GupaI 1982 37-76) Di fatto
492 Renzo P COITitore
Tale disparitagrave sociale si riverberava sulla struttura del commercio cerealicolo La funzione dei piccoli commercianti di biade (granaiolibull biadaiolifarinaioli balshy
zarotti cavallanti vatlcali ecc) era infatti ancillare alla capacitagrave di affacciarsi sul nercato della fascia marginale deipossidenti con eccedenze Solo che nelle annate di abbondanza si venficavano ingorghi nell offerta di grano che deprimevano i prezzi e incentivavano i piccoli produttori a smerciare direttamente le eccedenze allindomani del raccolto nellarea urbana anche al di fuori dei luoghi deputati (MATI02ZI 1983 278281-2 300n PULr QUAGLIA 1984 86) Mentre nelle annate di penuria si contraeshyva drasticamente proprio questo segmento dellofferta (ABa [1966Jmiddot 22-4 KULA [1962J 73-4 CATrINI1984 111-23 PuIr QUAGUA 1984 88) scatenando nelle campashygne una caccia al grano-merce la cui quota piugrave consistente era detenuta dai grandi proprietari dai maggiori affittuari dai percettori di canoni diritti o rendite in grano e la cui quota residua era piugrave facilmente preda di chi occupava posizioni chiave nellasshysetto terriero nella catena dei diritti nel credito alla produzione e al consumo
Tanto la distribuZione era frammentata nelle annate di abbondanza tanto in epoc~ di penuria il commercio del grano diventava un affare di pochi In questo caso lazioshyne dei mercanti diVentava dimpiccio sul mercato interno dove la coperta si restringeshyva per i proprietari e gli imprenditori agricoli (KULA [1962] 56-61 CATl1NI 1984 114-8) - dove la necessitagrave di ricorrere al credito da parte dei piccoli possessori poneva questi nelle mani degli agenti dei proprietari dei percettoridi canoni diritti o rendite - dove i piccoli proprietari vedevano minacciata la loro stessa condizione da parte di chi controllava localInente in maniera capillare e decentrata il mercato del denaro e dei beni necessari alla riproduzione (sementi strumenti cibo) La soluzione era quelshyla di precludere amministrativamente ai sensali e ai commercianti di grani i mercati locali su istigazione dei medi possessori le cui occasioni di normale profitto agrario soffrivano un ridimensionamento e che si vedevano costretti a impegnarsi ccedilon tutte le loro forze per integrare le proprie entrate accaparrandosi le magre eccedeiiZe disponishybili nelle campagne e nei borghi rurali (PuLT QUAGLIA 1984 84-8 PULT QUAGLIA 1990 lO7-14)
TI destino dei piccoli commercianti in grano era quindi quello di occupare una posishyzione margilJale nel mercato del grano (MBlNrurr 1977 30 PINTO 1978 13 MAITOZZl 1983 277) e di operare - non solo a causa degli ordinamenti annonari - secondo una logica di corto respiro in cui non era contemplata neacute la conservazione di grani a lungo termine neacute lutilizzo di depositi piugrave che provvisori Come per i piccoli possidenti non si puograve parlare ne1loro caso della formazione e del mantenimento di scorte consistenti (MBlNREr 1988 156~7) Non tali comunque da sostenere il reddito contadino nelle stagioni ordinarie e da esercitare sul versante cittadino unefficace azione anticonshygiunturale in caso di carestia
Peraltro in cittagrave la struttura dellofferta era anche piugrave sperequata di quella che si rishyscontra nel contado Che si tratti di Prato nel 1339 (PINTO 1978 129 PINTO 1982 160n e 17In) Pavia negli anni 1539 1555 1513 1602 1603 (ZANEm 1963) o Mantova nellultima parte del secolo XVI (CORRITORE 2000 81-9) la distribuzione delle scorte fra i privati era singolarmente ineguale Lo attesta la rilevanza nellarea urbana della povertagrave cioegrave secondo una definizione coeva di coloro che non vivono di entrate ma sono necessitati ricorrere mattina e sera alle pistorie a comprare il pane per iI vitto loro e delle sue famiglie col denaro che di giomo in giomo si vanno guadagnando (MATshyTOZZI 1983 281) PUOgrave essere utile richiamare la situazione delle cittagrave tedesche nel basso Medioevo in una fase che egrave stata definita da Wilhelm Abellepoca doro degli artigiani e del lavoro salariato si puograve stimare che almeno la metagrave degli iscritti ai
lA costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli statibull middot497
te con il principio della piazza TI mercato pubblico periodico disciplinatola spiagshygiala piazza la loggia o iI recinto riservato alle contrattazioni - coesis~va confabshybriche magazzini e botteghe La stessa piazza per funzionare al meglio secondo il principio dello scambio diretto necessitava di magaZzini di supporto bull
4 LE SCORTE DEI FORNAI CITTADINI
Nellarea urbanagrave e nelle relazioni tra cittagrave e campagna operavano perograve temibili conshycorrenti dei privati possessori I fornai cittadini possedevano le competenze le strutshyture tecniche le relazioni sociali e il credito per incettagravere il prodotto per essere inforshymati tempestivamentesul mercato del grano e potenzialmente per dispensarlo con profitto in qualunque momento Il fatto che il loro operato fosse imprigionato in unarshycaica impalcatura di norme divieti obblighi che risalivano alletagrave romana che ne fashycevano in modo quasi istituzionalizzato il capro espiatorio delle tensioni fra produtshytori di grano povertagrave e autotitagrave non impedisce di affermare che tali vessatorie disposiziograveD1 trovassero la loro principale ragione dessere nella parte che essi giocashyvano di interlocutorilantagonisti dei proprietari terrieri nelladeterminazione del prezshyzo del grano sul mercato locale e nella realizzazione della rendita terriera (GUENZI 19824
35 GUENZI 1982 297) Neacutel caso di Mantova terra comucopia a partire dal 1492 si consend a zentilhomini
cittadini et qualuncho altro di comprare biade nel Dominio per approvvigionare la cittagrave di fatto si sand un diritto allincetta che mise fuori gioco i fornai a cui venne imposto di rifornirsi nei solarimiddotdei cittadini senza avere piugrave la possibilitagrave di effettuare acquisti nel contado e di ritenere a casa scorte superiori amiddotl 00 staia di frumento Lintento della disposhysizione egrave chiarissimo espresso senza reticenze dai Maestri delle Entrate che riportarono al marchese la soddisfazione dei possidenti mantovani per la riforma statutaria
tutta la Terra [cioegrave il Mantovano] ne [egravel rimasta satisfactissirna pensando che Vostra Excellenilii pretenda ali comodi et utilitagrave universagrave1e senza dampno et preuiditio suo Vero egraveche li fumari non si contentano parendoli comegrave il vero che non si poteranno ingrassar a suo modo come haqno factO per il passato et poteria achader [bulll Che venetanno adolershyse et supplicar aVosUa Signoria Perograve me egrave parso d~ene aviso per ques~ nostra et farli inteni1er Che questaterril ha solii due membri de li quali li cittadini soi se ne possono aiutashyre e valersene uno egrave il grano laltro egrave larte de la lana et quando se concedesse che li furshynari potessero comprare come hapno facto li tempi passati sana un fare benefitio acinquanshytaocto dessi et dampnificharelreslO de la republicasua quale de questo bon ordine ne receve emolumento grandissimo et se gaude in la Citagrave [percheacute] li fumari portano fuora el denaro et pretendono solo a suo benefitio (AG b 2441 lettera del 13 luglio 1492)
Egrave indubbio che il plauso della Terra fosse da attribuire piugrave alla possibilitagrave per i proshyprietari di accrescere le proprie entrate che a quella dei consumagravetori cittadini e dell arte della lana di trarre beneficio daJla disposizione Egrave significativo che la motivazione pro civitate nori accenni allesistenza di monopoli da parte dei fornai o di artificiose lievitashyzioni dei prezzi per causa lOro nloro attivismograve non egraveonfliggeva per quanto riguarda i prezzi finali della sussistenza con linteresse dei produttori cittadini E daltra parte largomentodello stomo dal metFato cittadino dei profitti incamerati dai fornai -laccushysa consueta a proposito deipistores egrave che fossero in gran parte stranieri (GUBNZl 19824
22) -- era unagiustificazione debole che appassionava piugrave chi concorreva direttamente
491 498 Renzo P Comtore
alla spartizione dei proventi derivanti dalla vendita e dal commercio del grano shylemolumento grandissimo - di chi doveva poi fruire della redistribnzione di tale ricchezza Tale norma avvantaggiava i possidenti cittadini e i gentiluomini ptivilegiashyti in grado di ottenere le tratte di esportazione Sul piano dellappropriazione essi erano in condizione di mettere fuori gioco gli altri possessori che producev~o eccedenze nel Dominio poicheacute si accresceva Igravea loro forza contrattuale e la loro capacitagrave di occUpare i canall commerciali piugrave redditizi Sul piano della commercialiZzazione gli stessi fruivashyno dello smantellamento della rete dintennediazione rappresentata dai fornai Per i rushystici significava perdere un collegamento essenZiale con la cittagrave ed essere emarginati dal mercato urbano nelle campagne o sul broletto di Mantova essi non trovarono piugrave i trashydizionali interlocutori (CORBlJ9RE 2000 228 231-2)
Nel caso di Bologna terra strutturalmente deficitaria e cittagrave dalla vocaiione manishyfatturie~ si costringeva i fornai ad acquistare formenti terrieri presso i solari privati in cittagrave proibendogligrave lincetta nel contado autorizzandoli ad acquistareformentiforeshystieri al di fuori delle mura cittadine presso i sensati da grqno solo a patto che fosseshyro stati smaltiti i grani cittadini a un prezzo talora superiore a quello dei grani dimshyportazione (GUlNZI1982A35 52-3)
Nella Toscana dei Medici il diritto allincetta nel contado venne concesso ai fornai in periodo di bassa congiuntura (in particolare dagli anni Trenta del Seicegravento)Per sostenere i prezzi interni in tal caso essi restavano gli interlocutori principali dei granshydi proprietari semplicemente spostando la loro principale fonte di approvvigionashymento dai solari dei particolari in cittagrave ai granai decentrati delle grandi aziende agrishycole oppure ai mercati rurali su cui affluiva la produzione cerealicola delle grandi fattorie (PuLT QUAOUA 1984 86-9 PuLTQUAOUA 1990 100 106-7)
Laddove non vi egrave come invece succede a Genova una diretta ingerenza del potere pubblico nella vita della corporazione (MAsSA 1999) i fumai di cittagrave - nonostante i lacci e lacciuoli normativi e il lavoro prevalentePlente manuale svolto neiloro laboshyratori - erano dei veri imprenditori dipendenti per il loro profitto - noininalmente stabilito per legge - dalla produttivitagrave del lavoro e dalla dotazione tecnica e finanziaria delle imprese Di ciograve fa fede la grande sperequazione esistente fra le aziende speciashylizzate nena fabbricazione del pane venale in cittagrave (AYMARD 1966 75 VECCHltltJQ 1979 82-3 GUlNZI1982 77 segg PuLT QUAOUA 1984 100 102-3) NellItalia delshyletagrave moderna questi artigiani-imprenditori della filiera del grano trattavano insieme
afarinaifarinaiolifarinottifondachierifontechierifidelariformentinari lasagneshyri maccaronari torallari vermicellari ecc fra il 40 e il 70 per cento del frumento consumato in Cittagrave nelle annate normali (CoRRJTORE 2000 126 segg) e ~ino al 100 per cento nelle annate di carestia (Puu QUAOUA 1984 98-9)
In una ricognizione delle asimmetrie informative del mercato non cegrave gruppo quale i fornai che possa integraverpretare la parte dell agente economico onnisciente Se dunque i regolamenti annonari tendevano a regolare minuziogravesamente la collocazione il volushyme e la durata delle loro scorte cosi come disponevano per gli altri artigiani della fishyliera era per neutralizzare il carattere potenzialmente eversivo di tale accantonamenshyto per i proprietari-venditori Prima ancora che per i consumatori-acquirenti n livello delle scorte rinforzava o attenuava il rischio di monopsonio da parte dei pistores piugrave potenti e facoltosi cosigrave come eventuali tentazioni da parte della categoria di esercitare un dominio egoistico sul mercato del pane (MAITOZZl1983 298)
Sarebbe quindi un errore concepire le scorte dei fornai come entropica allocazione di capitale che sconta lincertezza futura esse venivano gestite secondo criteri di rashyzionalitagrave economica e secondo la migliore efficienza tecnica nonostante i vincoli imposti alla lievitazione degli stock dalle disposizioni annonarie
lA costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
vimini paglia o canne intrecciate (come ceste stuoiecannizzi) in terracotta (addirittura anfore) piuttosto che di tessuto (i sacchi costavano troppo) (PICCINNl1976 397 MAzzA RAvEGol 1983 174-5 Zoo Toce 1990 893-4 COIiITONES11991 35n-36n)
Nella casa del piccolo produttore o del titolare di un piccolo possesso il penw (la scorta domestica) difficilmente eccedeva il consumo famigliare chi fortunato raccoshyglieva piugrave dell annona famigliare e di quanto gli serviva per il campo era spinto a venderselo nei mesi immediatamente successivi alla mietitura e alla trebbiatura per necessitagrave di denaro ma anche per la difficoltagrave di stoccare e conservare il prodotto in condizioni ottimali (MEuvRET 1988 17-9 PuLT QUAOUA 1984 88) e figravenanco per ridurre il rischio di vederselo soffiare da vagabondi e malintenzionati In questo caso in presenshyza di eccedenze (ma probabilmente anche in assenza) il bisogno di liquiditagrave e lalea cospiravano nel ridl1ITe ai minimi termini le scorte giagrave allindomani del raccolto In caso alternativo il contadino che non egrave - ripete Jean Meuvret - un homme daffaires quanshyto un homme de peur concepiva la sua riserva come un fondo di previdenza sul racshycolto futuro da non immettere sul mercato se non nel caso dellapprossimarsi di una messe sicura secondo una logica economica a contrario (MEUVRET 1988 19 e 147)
Era Jl~tente la disparitagrave fra i produttori non solo fra chi era in possesso di eccedenshyze e chi non lo era ma piugrave anqgtra fra chi poteva scegliere in virtugrave di una maggiore capienza economica e unadeguata dotazione tecnica - il mercato piugrave favorevole per i propri grani (il periodo di saldatura dei raccolti) e chi invece li cedeva troppo presto o in controtempo a livelli non ottimali
Nella gerarchia delle abitazioni rurali -- in quel vero e proprio saggio di sociologia che egrave il sesto libro del DeArchitectura di Sebastiano Serlio (scritto fra il 1537 eil 1555 inedito per tutto levo moderno) -- per trovare case attrezzate di granaio occorshyreva ascendere sino alla magione del basso mercante o cittadino fuori della cittagrave (SERLlO 1994 43 segg anche per le successive informazioni) Condizione di cui non potevano fregiarsi invece i ricchi contadini in ~essuno dei tre gradi possibili di ricshychezza al massimo la loro casa poteva essere attrezzata di portici per ricoverare le biade e di unaia per batterle segni di distinzione giagrave fra i mediocri contadini Fra questi perograve avrebbero potuto avvalersene soltanto i fortUIgravelati et di beni et di famishyglia (3deg grado di mediocritagrave) nforno per cuocere il pane e una cantina per conservashyre il vino invece li si sarebbe trovati a partire dai piugrave accomodati fra i poveri contashydini cioegrave al 4deg gradino della scala sociale alla cui base erano da collocare i poveri mendichi con vii capanna (10 grado di povertagrave) i salariati che vivevano delle [loro] fatiche avendo un puoco di terreno (2deg grado di povertagrave) i poveri con qualche beshystiuola et massimamente de buOvi possessori di una stalletta congiunta con la casa 0deg grado di povertagrave)
In sintesi nelle campagne delletagrave pre-industriale pochi avevano scorte pochissimi erano in grado di ricoverarle in un solaro privilegiatissimo chi le incanevava per speculare Dunquefra i conta4ini se si esclude quanto celato nella madia o nella dishyspensa le scorte erano un pri~ilegio di pochi nSerlio nato intorno al 1475 insiste sullimpoverimento delle class~ rurali intervenuto fra gli anni della sua giovinezza e quelli della vecchiezza in cui scrive Sotto il titolo Dellabitazione del ricco contadishyno per tre gradi di ricchezza si preoccupa di puntualizzare
bencheacute al di dogi non se n~ truovi piugrave de tali merceacute delle discordie et di gli animi fieri et ostinati alla vendetta onde per tal cagioni et per le continue guerre et anche pei citadini divoratori de gli altrui beni che con le usure con glinganni con le rapine gli bano impoveriti (SERUO 1994 ~8)
490 RellOP CorrilOle
colto (agosto-settembre-ottobre) e invia di esaurimento almomento della saldatura dei raccolti (aprile-maggio-giugno )1A questo proposito nota Franccedilois Sigaut
Le stockage agrave court terme (moins dune campagne) reacutepond agrave la neacuteCessiteacute cIeacute concilier une offre variable et une demande constante mais toutes deux reacutegulieacuteres et preacutevisibles dans la
pratique il est consideacutereacute comme tiiisant pame du processus ordinaire de la production et ne pose agrave ce titre que desproblegravernes doptimisation assez simples (SlOAUI 1985 602)
La discussione generale sulla razionalitagrave economica delle scorte alimentari in etagrave pre-industriale puograve allora essere ridotta alla fonnulaiione e allo scioglimento di due
semplici quesiti 1 Accertato che laccantonamento digram per la periodicitagrave annuale del ciclo agricoshy
lo epet i vincoli tecnici di un rifomimento spazialmente allargato egrave inevitabile chi egrave conveniente che conservi le scorte chi produce o chi commercia il contadino o il mercante lapossidenzagrave o il popolo i particolari o il pubblico E qual egrave la realtagrave effettiva
2 Se le forme di distribUzione economicamente razionale sono plurali in quale conshytesto e in omaggio a quali interessi piugrave utile il sistema della canova rispetto al sistema delll piazza del mercato e dei solari privati
3 SULLADISTRIBUZIONE DEL GRANO NELUETAgrave PRE-INDUSTRIALE E LA STRUTTURA DELLE SCORTE NEI TERRITORI ITALIANI
Raramente le case contadine erano dotate di attrezzature per la conservazione dei cereali piugrave che elementari Nelle campagne toscane del Quattrocento dunquein unetagrave favorevole al reddito contadino in una regione fra le piugrave ricche dellEuropa pre-indushystriale
pochissime case contadine disponevano del granaio vero e proprio alcune avevano una cella che poteva servire allo stesso scopo ma la maggior parte di quelle abitazioni era priva di spazi destinabili esclugravesivamente alla conservazione dei cereali Perciograve i contenitori dei grani arche casse sacchi bugnole - dovevano trovare posto nelle cucine o nelle camere CMA= RAVEGGI 1983 174)
Le ridotte capacitagrave patrimoniali e reddituali della grande maggioranza dei produttori facevano sIgrave che fosse ampiamente invalso nella conservazione domestica dei grani limshypiego di contenitori in legno (come arche casse botti bugnole tini tinelle corbelli)in
Riguardo ai passi evidenziati di Zanetti e Cipolla egrave neCessario osservare che la principale atteshystazione sullesistenza di stock detenuti da privati che esorbitassero ilfabbisognostagionale tali da essere classificati come immobili=zione di ricchezza (Zanetti) o come beni capitale (Cipolla) a unanalisi piugrave fine si rivela fallace o non direttamente utilizzabile La propalazione dei grani effetshytuata a Pavia fra ilimiddot e il5 maggio 1555 che egrave il fondamento di entrambi i giudizinon mostra una somma di derrate realmente eccedente il fabbisogno delle famiglie per il periodo che manca allarri_ vo dei grani novelli sulla piazza pavese Daltra parte lastessa natura dellistituto della propalazioshyne dei grani cioegrave della denljncia obbligatoria delle scorte da parte dei particolari una misura demergenza decisa in momenti critici dellapprovvigionamento cittadino affiancata quellanno dalshylispezione diretta presso le case dei privati da parte di deputati straordinari avrebbe dovuto consishygliare una maggiore cautela nella sua utilizzazione per individuare regolaritagrave di carattere generale delleconomia pre-industriale
499 La costituzione di scorte granarie pubbliche e la ptlitica ecoMmica degli stati
FONTI
ABEL [1966) W ABEL Agrarkrisen undAgra~kJJnjunktur Eine Geschichte der londshy und Erniihrungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter Hamburg
und Berlin Paul Parey 19662 (la ed -1935 trad it Congiuntura agraria e crisi agrarie Storia dellagricoltura e della produzione alimentare nellEuropa centrashyle dal XIII secolo alletagrave industriale Torino Einaudi 1976 da cui si cita)
AG ARCHIVIO GoNZAGA presso lArchivio di Stato di Mantova AuFANO 1996 E AuFANO Il grano il pane e la politica annonaria a Napoli nel Setshy
tecento Napoli ESI 1996bull AYMARO 1966 M A YMARO Wmise Raguse et le commerce du bMpendant la seconde
moitieacute du XVI siegravecle Pans SEVPEN 1966 CATIINI 1984 M CATl1NI I contadini di San Felice Metamorfosi di un mondo rurale
nellEmilia delletagrave modernIgravel Torino Einaudi 1984 CESTARl 1794 p CESTARI Saggio storico dei Fondachi delle farine di Chioggia e
Pellestrina Venezia A Zatta 1794 CIPOllAJ1965] C M CIPOllA La politica economica dei governi V La penisola
italigraveana e la penisola iberica in Storia economica Cambridge m La cittagrave e la politica economica nel Medioevo Torino Einaudi 1977 (Cambridge 1965) pp 462-496
CIPollA 1974 C M CIPollA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna nMulino 1974
CIpollA 1997 C M CIPOllA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna nMUlino 1997 (6 ed riveduta)
CORRITORE 2000 R P CoRRITORE La naturale abbondanza del Montovano Produshyzione mercato e c01isumi granari a Mantova in etagrave moderna Pavia Universitagrave di Pavia 2000
CORIONBSI 1991 A CORIONBSI Sulla conservazione dei cereali nellItagravelia medioevale Lavoro e tecniche nelle tesnmonlanze laziali (secc XIII-XV) in Rivista di storia dellagricoltura XXXI 1991 l pp 33-49
DELLA VALENTINA 1992 M DELLA VALENTINA I mestieri del pane a ~nezia tra 600 e 700 in Atti dellIstituto [Veneto di Scienze Lettere ed Arti Classe di scienze morali lettere ed arti CL 1991-92 pp 113-217
DIRLMEIER 1984 U DIRLMEIER le condizioni materiali dellesistenza nelle cittagrave tedeshy sche del Basso Medioevo ~iente esterno reddito consumi in Aristocrazia citshy
tadina e ceti popolari nel tprdo Medioevo in Italia e in Germania (a cura di Reinhard Elze e Gina Fasoli) Bologna Societagrave editrice il Mulino 1984 pp 79shy122
FORNASIN 1999 A FORNASIN Il pzercatodei grani di Udine Indagine per una storia dei prew in Friuli (secoli XfI-XVIII) Nota di ricerca del Dipartimento di Scienshyze Statistiche dellUniversit4 degli Studi di Udine 4 1999 pp 1-24 ora in lo La Patria del Friuli in etagrave 1fIOderna Saggi di storia economica Udine Forum 2000 pp 33-60
GRENDI 1986 E GRENOI Lapprccedilwigionamento dei grani nella Liguria del Seicento libera pratica e annone in iMiscellanea storica ligure Studi in onore di Luigi Bulferetti XVIII 1986 2Jp 1021-1047
GUENZI 1981 A GUENZI Ilfrurnfnto e la cittagrave il caso di Bologna nelletagrave moderna in Quaderni storici XVI ~981 46 pp 153-167
GUENZI 1982 A GUENZI Pane ~fornai a Bologna in etagrave moderna Venezia Marsilio 1982
I
489 500 Renzo P CornIOle
GUBNZI1982 A GUEml Sistema annonario e egraveontrollo sociale a Bologna nei seccediloli XVII e XVIII in E SORI (a cura di) Cittagrave e controllo sociale in Italia fra XVIII e XIX secolo Milano F Angeli 1982 pp 293-306
HICKS [1989] 1 R HIClCS A narlcet theory of money Oxford Oxford Universigravety Press 1989 (trad it Una teoria di mercato della monefa Bologna li Mulino 1992 da cui sigrave cita)
JACOPBITI 1965 N L JACOPBITI Monete e prezzi a Cremona dal XVI al XVlIi secolo Cremona Athenaeum CregravemoneJlSe 1965
KAPLAN 1984S L KAPLAN Provisioning Paris Merchants and Millers in the Grain and Flour Trade during the Eighteenth Century Ithaca-London Cornell Univershysity Press 1984~middot
KULA [1962] W KULA Teoria ekonomiczna ustrojufeudalnego Proba modelu Warshyszawa-Panstwowe WydawnictwoNaukowe 1962 (trad it Teoriagrave economica del sistema feudale Proposta di un modello Tormo EinaUdi 1972 ccedilla cui si cita)
WROUSSE [1933] C-E LABRoussE Esquisse du mouvement des prix et des reverws en France au XVIII siegravecle Paris Eacuteditions des Archives Contemporaines 19842 volI (l ed Paris Librairie Dalloz 1933)
MALANtMA 1976 P MALANiMA Aspetti di mercato e prezzi del grano e della segalea Pisa dal 1548 al 1818 in Ricerche di storia moderna vaL I Pisa Pacini 1976 pp ~n
MANToVA 1430 MwroVA 1430 Pareri a Gian Francesco Gonaga per il governo (a cura di M AQrignaniA M Lorenzoni A Mortari C Mozzarelli) MUltova G~ Arcari 1990
MASSA 1999 PMAssA Annona e corporazioni del settore alimentare ~ Genova orshyganizzazione e conflittualitagrave (XVI-XVIII secolo) in A GUENZI PMAssA A MOIOshyu (a cura di) Corporazioni e gruppi professionali nellItalia moderna MilIllO F Angeli 1999 pp 390-403
MATIoZ7J 1983 1 MiJroZ7J F BOLELLI C CmAsBRA D SABBIONI Il politico e il pane a Venezia (157Q-1650) calmieri e governo della sussistenza in Societagrave e storia VI 198320 pp 271-303
MAzzI RAVEOOI 1983 M T MAzzI S RAVEOGI Gli uogravemini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento Firenze Olscbki 1983
MERONI 1957 U MERONI Cremona fedelissima Ciemona Athenaeum Cremonenshy~~~ _
MBUVRBl 1977 J MEuVRsT Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque LouisXIvI La productiograven des ceacutereacuteales dans la France du XVII et du XVIII siegravecle Paris Mouton -EacuteEHSS19772voll
MBUVRET 1988 J MBtJVRf Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque Louis XIv III Le commerce des gralns et la conjoncture Paris EacuteEHss 1988 2 volI
PtCClNNI 1976 G PtCClNNl Wta contagravedina in una capanna dei dintorni di Siena (1250) in ~Archeologia medievale m 1976 pp 395-399
PlNIO 1978 G PINTOII Libro del BiaPaiolo Carestie e annona a Firenze dalla metagrave del 200 al 1348 Fire~ Olscbki 1978
PiNTO 1982 G PtNro La Toscana nel tardo Medioevo Ambiente economia rurale societagrave Fllenze Sansoni 1982
PtRENNE [1933J H PIRENNB La civilisation occidentale au Moyen Age du XIe au mishylieu du XVe siegravecle Paris PUF 1933 (trad it Storia economica e sociale del Meshydioevo Milano Garzanti 1967 da cui si cita)
Lacostituticne di scorte granarie pubbliche e la politica economiegravea degli stati
redigravestribuzione sostenibile dei beni di sussistenza egrave ricercata in questo cielo da quegli stessi particolari che ~amaldeggiano nella produzione negli scambi nei consumi e che costituiscono il nerbo della classe di governo Le scorte pubbliche rappresenteshyrebbero in questa prospettiva un presidio civico e un risltCimento politico e morale ai cOl1ponenti della comunitagrave spossessati delbene supremo dellautarchia alimentare
Resta infine latente unidea del magazzmo pubblico come quasi-mercato cioegrave come luogo volto (1) a risolvere i fa1limentiinfo~vi della piazza del mercato (in meacuterito alle disponi~ilitagrave alle caratteristiche del prodotto alle condizioni di vendita della merce) (2) a ridimensionare lalea per agricoltori consumatori poveri artigiani del comparto alimentare (3) a sostenere i consumi e i profitti privati m funzione anticicli ca in una prospettiva Ilpn meram~nte congiunturale Si tratta in questo caso di un orshyganizzaZionepienattiCnte razio~e Che non opera in maniera saltuaria e riflessa ma in modo continuativo secondo obifttili prefissati di allocazione dei beni primari li funshyzionamento dellacanovagrave (il magazzino pubblico) si porrebbe come strumento inteshygrativo ma no~~igraventeramente so~titutivo delloperare della piazza Si tratterebbe di unaforma di mercato distinta dalla p~ del mercato considerata in seacute e per seacute cosigrave come dallegraveOOmpravendite effetttlate nei solari privati o dalla mera centrallzzazione e redistribuzione di derrate con fi~alitagrave umanitarie La canova rappresenterebbe in tal modo uno dei possibili meccaoi~ di governo delle trllls3ZIgrave~ni locali per risolvere i problemi deUapprovvigionameIto senza intaccare certi interessi di classe (dei proshyprietari ma anche del popolo grasso) S da essere prescelta da autoritagrave e gruppi domishynanti come struttura complementare della piazza del mercato incerti contestiprodutshytivi ed economici La suasacrilizzazione perciograve non esclude la possibilitagrave di un ritorno alle sole compravendite qella piazza e dei solari privati - una volta invertishytosi il trend o spirate le condizioqi economiche della sua istituzionalizzazione
La problematizzazione esorc~ una liquidazione semplicistica del problema delle scorte gran8rle in etagrave pre-industriUgravee nel nome di una loro presunta irrazionalitagrave eco- nomica per il compito di assi~ la sussistenza della popolazione
Le pagine che segUono sono rintroduzione a un lavoro in corso volto a offrire un interpretazione generale di tal~ capitolo fondamentale della politica economica dei governi
in
etagrave pre-industriale
2 SE UN MONDO SENZA SCORTE Egrave INCONGRUO cm Egrave OPPORTUNO CHE LEgrave DETENGA
Nei fatti nel settore granarlo CQni vincoli dell etagrave pre-industriale in tema diprodutshytivitagrave energia trasporti non ha s~nso ipotizzare un mondo senza scorte Se il mercato del grano egrave - come nellEuropa medievale e moderna - un sjstema tendenzialmente chiuso
ad ogni raccolto nuove offe~ aniv(erannol sul mercato mentre la domanda si mant[erragrave] relativamente costantt nel corso dellanno Qualcuno dunque [dovragrave] ~ere delle scorte che saranno elevate ~ubito dopo il raccolto e poi via via minori fino aragshygiungere un livello minimo in prpssimitagrave del successivo raccolto (HICICS [19891 31)
Nella loro forma piugrave sempliceI tali scorte saranno legate allora alla periodi~itagrave anshynuale del ciclo agricolo (che a1iplenta il movimento stagionale dei prezzi ccedilfr LAshyBROlJSSE [1933] 157-66) il loro livello saragrave elevato allindomani del principiLle racshy
501 488 Renzo P Corritore
povero ammassograve nella propria dimora scorte di grano carne ~alata sale candele ecc e la medesima cosa fece lo Stato Nel periodo feudale non venne mai meno nel castello del signore labitudine di tenere da parte grosse scorte per i periodi di emergenza Sucshycessivamente le autoritagrave comunali predisposero il magazzinaggio di grosse derrate specie di grano da rivendere a basso prezzo in periodi di emergenza e nello stesso tempo si preoccuparono di prevenire un indebito accumulo di scorte da parte di specushylatori privati Nelle economie medievali gli stock di derrate di prima necessitagrave rappreshysentarono pertanto una delle piugrave importanti forme di investimento pubblico e privato (CIPOLLA (1965] 468)
Nella prima versione del manualeacute invece fino allinserimento nel 1997 del nuovo capitolo dedicato alla politica economica nell etagrave pre-mdustriale il punto di vista preshyvalente era quello microeconomico entro il perimetro stretto dellindividualismo meshytodologico
Le scorte costano e costano doppiamente Esse implicano il costo diretto che egrave rapshypresentato dal costo del magazzinaggio edal deterioramento eventuale del pr04otto o di parte di esso Se luomo daffari finanzia la costituzione delle scorte con danaro preso a prestito il costo diretto include anche il tasso di interesse pagato Se luomo daffari finanzia con capitale proprio la costituzione delle scorte il costo delle scorte deve inshycludere un costo-opportunitagrave e cioegrave il mancato rendimento (tIllU1cato tasso dinteresse attivo) del capitale finanziario impiegato (CIPOLLA 1974 154)
Le ragioni della costituzione e del mantenimento di scorte alimentari da parte delshylautoritagrave pubblica diventavano unicamente ragioni morali (umanitarie e di buona amministrazione) o di opportunitagrave politica (la fame era la piugrave frequente ligraveausa di sommosse e furori popolari) (CIPOLLA 1974 74)
Nel 1997 si riammetteva dunque linterpretazione originaria della costituzione di scorte pubbliche come strumento di riequilibrio del mercato senza peraltro rinnegare le considerazioni sulla valenza statica di tale forma di investimento per gli agenti economici privati
In merito allutilitagrave economica e al significato delle scorte in etagrave pre-industriale Cishypolla non espresse perciograve sempre lo stesso punto di vista La rassegna delle posizioni da lui assunte anzi permette di individuare tre approcci e tre giudizi costitutivamente diversi sulla funzione delle scorte granarie nellepoca pre-industriale
In prima approssimazione laccumulazione di scorte alimentari mostra il carattere fondamentalmente difensivo delle scelte degli agenti economici pubblici e privati in etagrave pre-industriale La paura la tradizione la superstizione li induce a tabuizzare il rischio la speculazione linvestimento nella produzione e nella distribuzione dei beni essenziali alla vita e ad aderire intimamente a un ideale di economia e societagrave stazionarie aggravando con la norma sociale le istituzioni il comportamento indivishyduale e collettivo leffetto dei condizionamenti materiali delleconomia pre-industriashyle (bassa produttivitagrave agricola alti costi di v~sporto modesta efficienza energetica) esponendo ancor di piugrave la comunitagrave umana ai degravemoni della natura
La seconda interpretazione rigetta luniversale imperio dellhomo oeconomicus rishyscoprendo leteronomia dei fini dellagire economico degli uomini nelletagrave pre-inshydustriale Ia politica economica dello Stato o-delle autoritagrave non persegue puri scopi economici lintegritagrave del corpo sociale fin nelle sue cellule elementari (persone e famiglie) deve essere assicurata secondo i principi e la prassi di uneconomia morale che SOVJa5ta leconomia regolata dal mercato spersonalizzata e antipopolare Una
La costituzione di scorte grantlTie pubbliche e la poligravetigraveca economica degli stati
PuLT QUAGUA 1984 A M PULT QUAGUA Mercato dei prodotti agricoli e magistratushyre annonarie a Pisa nelletagrave moderna in Ricerche di storia moderna a cura di M Mirri voI III Pisa Pacini 1984 pp 57-141
PULT QUAGLIA 1990 A M PULT QUAGLIA Per provvedere ai popoli Il sistema anshynonario nella Toscana dei Medici Firenze Olschki 1990
SERUO 1994 S SERLIO Architettura civile Libri sesto settimo e ottavo nei manoscritshyti di Monaco e Vienna (a cura di F P Fiore) Milano TI Polifi10 1994
SIGAlIT 1985 F SIGAlIT Questions deacuteconomie agrave propos des politiques ceacutereacutealiegraveres et de stockage in Les techniques de conservation des grains agrave long terme leur rale dans la dynamique des systegravemes de cultures et des socieacuteteacutes (sous la direction de M Gast F Sigaut et C Beutler avec la collaboratlon de O Bllchsenschutz) voI III 2 Paris Eacuteditionsdu CNRS 1985 pp 597-606
SMITH [1776 A SMITH An inquiry into the nature and causes ojthe wealth ojnations London W Strahanand T Cadell 17762 volI (trad it Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni Milano A Mondadori 1977 2 volI da cui
si cita) STATlITlBoNACOLSIANI [1313] STATUTI BONACOLSlANl (a cura di E Dezza A M Lorenshy
zoni M Vaini) Mantova GArcari 2002 STATUTI GONZAGHESCHI [1404] STATUTI GONZAGHESCHI presso la Biblioteca comunale di
Mantova ms FV 11 [775]VECCHIATO 1979 F VOCCHIATO Pane e politica annonaria in Terrajerma veneta tra
secolo XV e secolo XVIII (Il caso di Verona) Verona Stamperia Zendrini 1979 ZANETTI 1963 D ZANETTl Contribution agrave leacutetude des structures eacuteconomiques lapshy
provisiQnnement de Pavie au XVI siegravecle in Annales ESC XVIII 1963 1 pp 44-62 ora in lo Fra le antiche torri Scritti di storia pavese Pavia Universitagrave di Pavia 2000 pp 165-182
ZANETTl 1964 D ZANEITI Problemi alimentari di una economia preindustriale Ceshyreali a Pavia dal 1398 al 1700 Torino P Borlnghieri 1964
ZUG TUCCI 1990 H ZUG TuCCI Le derrate agricole problemi materiali e concezioni mentali della conservazione in Lambiente vegetale nellalto Medioevo XXXVII Settimana di studio del Centro italiano di studi sullalto Medioevo (30 marzo-5 aprile 1989) Spoleto Centro italiano di studi sullalto Medioevo 1990 voI n pp 865-902
493 496 Renw P Corritore
appare altrettanto astratto dogmatico O virtuale del principio di mercato (Market Principle) che il medesimo gli contrappone Henri Pirenne parlando della politica annonaria dei comuni medievali avverte Lapplicazione del principio della vendita diretta ebbe numerosi eccezioni (PIRENNE [1933] 193n)
Nel caso di Mantova la scelta della Piazza egrave facoltativa per i terrieri con eccedenze GliStatuti signorili che si rifanno largamente alle raccolte statutarie comunali non sancivano alcun obbligo in proposito (v SYJI1l BONACOLSlANI [1313] libro ID rubr 55 De mercato blave 253 STATUTI GoNZAOHESCHI [1404] libro m rubr 93 De mercato blave fiendo in civitate Mantue f 73v) Decreti di carattere straordinario e regolamenshytazioni transitorie correggevano il tiro Nel 1405 in piena saldatura dei raccolti si coshystrinse a rifornire forzosamen~e la piazza concentrandovi tutte le contrattazioni Nel 1417 si obbligograve a riservare al mercato un terzo del frumento introdotto in cittagrave (CoRRIshyTORE 2000 235-6) Ma sono atti straordinari che non sopravvissero nel migliore dei casi piugrave di qualchelustro (MANToVA 1430 88 90 181) A Mantova la Piazza era affianshycata da un granaio pubblico la Domus del mercato (altrove definito Fornico o Fontego del mercato) in cui avrebbero dovuto prolungarsi le contrattazioni oltre lorario e i giorshyni deputati (venerdl o sabato) rendendo disponibile ciograve che restava invenduto e che non poteva essere ritirato per legge dal mercato Nel 1430 eminenti cittadini sollecitati dal principe lamentavano pero lincapacitagrave del magazzino - inoperoso in tutto o in ~per il pericolo di crolli - di rispondere ai bisogni del popolo in una situazione in cui da parte dei possessori si protestava la difficoltagrave di non poter esitare e smerciare fuori delshyla cittagrave le eccedenze conservate nei solari privati
ltem videtur quod valde utille foret civibus Mantue habentibus possessiones et quishybuscumque alijs personis de civitate Mantue aut districtu colligantibus bIada et vina in magna copia ut amni tempore ipsa bIada et vinum possent exttahere de civitate et dishystrictu Mantue et conducere ad Iaea ad que et in quibus illa vendere poterunt cum otdigraveshynibus et dacijs competentibus ipsa tamen civitate semper remanente fulta pro usu diete civitatis et populi eiusdem ne dicta bIada mateeschant super granariis ut hactenus fecemiddot runt cum maximo incomodo ipsorum civium (MANToVA 1430 177-8)
Il medesimo fondaco abbinato al mercato operava a Verona a Ferrara a Venezia a Udine a Chioggia in molte altre cittagrave (MANToVA 1430 100 FORNASIN 1999 7-9 CBshySTARl1794)
Lintegrale e pedissequa applicazione del principio della piazza di mercato comporshytava - per i vincoli tecnici dell etagrave pre-industriale -la massima affermazione del prinshycipio della canova cioegrave del magazzino pubblico centrale Unico argine alla sua invashydenza era costituito da una distribuzione perequata ab imis del raccolto cioegrave la possibilitagrave egrave questo il paradosso di realizzare da parte dei produttori la massima aspirazione nelle societagrave tradizionali lautarchia domestica Piugrave avanzava invecela sperequazione nel reddito e nel patrimonio piugrave da parte dei consumatori privi di scorshyte si impetrava il principio del Magazzino pubblico nella forma di un efficiente sisteshyma di ricovero conservazione distribuzione delle derrate a garanzia del funzionashymento della Piazza di mercato La disponibilitagrave di crescenti quote di raccolto tuttavia indirizzava i piugrave accomodati verso soluzioni piugrave ghiotte la vendita allingrosso sul mercato cittadino ai fornai o allimpresa pubblica creata a sussidio di questi (o in loro vece) Oppure allopposto lesito delle eccedenze extra muros sui grandi mercatishyemporio regionali per il tramite di mercanti o agenti diretti
Il principio del magazzino pubblico centrale cioegrave laccumulazione di riserve per lo smercio continuo o anticiclico egrave quindi alla sua origine in opposizione solo apparen-
La costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
ruoli fiscali non fossero in grado di accantonare scorte Nel 1444 a Strasburgo quattro cittadini su dieci non possedevano alcuna riserva cerealicola (DIIUMBIER 1984 112)
Nelle cittagrave italiane delletagrave moderna si puograve stimare che non meno di due terzi della popolazione fosse costretta ad acquistare o consumare pane confezionato con grani e farine comperati nelle piazze nelle vie e nelle botteghe cittadine oppure ottenuti come compenso del proprio servizio nelle casate (CoRRITORE 2000 126-36 MAnoZZI 1983 27~-82) Evidentemente questa fascia di lavoratori salariati non possedevashyper definizione -- neacute scorte neacute depositi personali e nel primo caso era strettamente dipendente dal mercato urbano acquistando la sua sussistenza con frequenza non piugrave che settimaIIgraveale (essendo costretti a comprare il pane tutti i giorni alla finestra si dishyceva a Genova (GRENDI 1986 1031])
Ma anche fra i citUutini con possesso extra moenia la distribuzione delle scorte era tuttaltro che egalitaria A Prato nel 1339
A patte gli enti religiosi sette famiglie [ bull ] avevano Il disposizione piugrave di mille staia di granaglie (circa 18 tonnellate) fino a un massimo di 3500 Altri venti nuclei familiashyri avevano scorte comprese tra le SOOe le 1000 staia (PINTO 1978 129n)
A Mantova nei magazzini ducali nellultima parte del 500 erano ammassati non meno di un ottavo talora piugrave di un quarto delle riserve cittadine di grani panificabili (CORRlTORE 2000 81c6) A Pavia nel corsq dello stesso secolo e allinizio di quello successivo nei sozagraveri di una sessantina di famiglie si concentrava non meno del 40 per cento dell intera offerta cittadin8 di frumentomiddot (ZANJin 1964 70-7) Anche in questo caso egrave utile sapere che nelle cittagrave tedesche esistevano mercanti (ad Augusta Ratisboshyna Norimberga) in grado di ~sare riserve da 6 a 45 tonnellate e che a Francoshyforte nel 1488 due patrizi totalizzavano insieme un terzo delle scorte cerealicole dei particolari nella cittagrave alta (DlRLMB1ER 1984113)
Ritenere tali soggetti sprovv~duti al punto di incanevare grani con il solo scopo di esorcizzare i pericoli della clarestia egrave perlomeno riduttivo A grandi solari corrishyspondevano vaste familiae e plftore di servitori e ospiti ma tali scorte eccedevano largamente la sussistenza del D-aggiore palazzo nobiliare o patrizio senza peraltro costituire un fondo di accantofilljnento eccedente il fabbisogno della cittagrave a meno che non vi fosse la concreta possibfjitagrave di commercializzare il surplus sui mercati esteri Come nota infatti Adam Smith
a meno che leccedenza non possa essere esportata in tutte le circostanze ordinarie i coltivatori staranno molto attenti a non produrre e gli importatori a non importare mai una quantitagrave maggiore di quell~ che egrave strettamente richiesta dal consumo del mercato interno Questo mercato saragrave difficilmente sovrafornito ma saragrave in generale sottomorshynito dato che coloro che svolgono lattivitagrave per mornirlo avranno in generale il timore che la loro merce possa rimane~ invenduta (SMITH[l776] 528)
Lipotesi egrave suffragata dai cas storici conosciuti A Bologna macrodistretto serico dellevo modemoladdove gli interessi manifatturieri e mercantili avrebbero dovuto consigliare una sussistenza a b~on mercato per tenere basso il costo del lavoro le istituzioni annonarie operavano per-garantire con il calmiero delformento la monetizshyzazione della rendita granaria dei possidenti - strutturalmente incapace di coprire il fabbisogno della cittagrave - anche ~ rischio della carezza dei viveri contingentando il mercato dei grani forestieri (GupaI 1982 37-76) Di fatto
492 Renzo P COITitore
Tale disparitagrave sociale si riverberava sulla struttura del commercio cerealicolo La funzione dei piccoli commercianti di biade (granaiolibull biadaiolifarinaioli balshy
zarotti cavallanti vatlcali ecc) era infatti ancillare alla capacitagrave di affacciarsi sul nercato della fascia marginale deipossidenti con eccedenze Solo che nelle annate di abbondanza si venficavano ingorghi nell offerta di grano che deprimevano i prezzi e incentivavano i piccoli produttori a smerciare direttamente le eccedenze allindomani del raccolto nellarea urbana anche al di fuori dei luoghi deputati (MATI02ZI 1983 278281-2 300n PULr QUAGLIA 1984 86) Mentre nelle annate di penuria si contraeshyva drasticamente proprio questo segmento dellofferta (ABa [1966Jmiddot 22-4 KULA [1962J 73-4 CATrINI1984 111-23 PuIr QUAGUA 1984 88) scatenando nelle campashygne una caccia al grano-merce la cui quota piugrave consistente era detenuta dai grandi proprietari dai maggiori affittuari dai percettori di canoni diritti o rendite in grano e la cui quota residua era piugrave facilmente preda di chi occupava posizioni chiave nellasshysetto terriero nella catena dei diritti nel credito alla produzione e al consumo
Tanto la distribuZione era frammentata nelle annate di abbondanza tanto in epoc~ di penuria il commercio del grano diventava un affare di pochi In questo caso lazioshyne dei mercanti diVentava dimpiccio sul mercato interno dove la coperta si restringeshyva per i proprietari e gli imprenditori agricoli (KULA [1962] 56-61 CATl1NI 1984 114-8) - dove la necessitagrave di ricorrere al credito da parte dei piccoli possessori poneva questi nelle mani degli agenti dei proprietari dei percettoridi canoni diritti o rendite - dove i piccoli proprietari vedevano minacciata la loro stessa condizione da parte di chi controllava localInente in maniera capillare e decentrata il mercato del denaro e dei beni necessari alla riproduzione (sementi strumenti cibo) La soluzione era quelshyla di precludere amministrativamente ai sensali e ai commercianti di grani i mercati locali su istigazione dei medi possessori le cui occasioni di normale profitto agrario soffrivano un ridimensionamento e che si vedevano costretti a impegnarsi ccedilon tutte le loro forze per integrare le proprie entrate accaparrandosi le magre eccedeiiZe disponishybili nelle campagne e nei borghi rurali (PuLT QUAGLIA 1984 84-8 PULT QUAGLIA 1990 lO7-14)
TI destino dei piccoli commercianti in grano era quindi quello di occupare una posishyzione margilJale nel mercato del grano (MBlNrurr 1977 30 PINTO 1978 13 MAITOZZl 1983 277) e di operare - non solo a causa degli ordinamenti annonari - secondo una logica di corto respiro in cui non era contemplata neacute la conservazione di grani a lungo termine neacute lutilizzo di depositi piugrave che provvisori Come per i piccoli possidenti non si puograve parlare ne1loro caso della formazione e del mantenimento di scorte consistenti (MBlNREr 1988 156~7) Non tali comunque da sostenere il reddito contadino nelle stagioni ordinarie e da esercitare sul versante cittadino unefficace azione anticonshygiunturale in caso di carestia
Peraltro in cittagrave la struttura dellofferta era anche piugrave sperequata di quella che si rishyscontra nel contado Che si tratti di Prato nel 1339 (PINTO 1978 129 PINTO 1982 160n e 17In) Pavia negli anni 1539 1555 1513 1602 1603 (ZANEm 1963) o Mantova nellultima parte del secolo XVI (CORRITORE 2000 81-9) la distribuzione delle scorte fra i privati era singolarmente ineguale Lo attesta la rilevanza nellarea urbana della povertagrave cioegrave secondo una definizione coeva di coloro che non vivono di entrate ma sono necessitati ricorrere mattina e sera alle pistorie a comprare il pane per iI vitto loro e delle sue famiglie col denaro che di giomo in giomo si vanno guadagnando (MATshyTOZZI 1983 281) PUOgrave essere utile richiamare la situazione delle cittagrave tedesche nel basso Medioevo in una fase che egrave stata definita da Wilhelm Abellepoca doro degli artigiani e del lavoro salariato si puograve stimare che almeno la metagrave degli iscritti ai
lA costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli statibull middot497
te con il principio della piazza TI mercato pubblico periodico disciplinatola spiagshygiala piazza la loggia o iI recinto riservato alle contrattazioni - coesis~va confabshybriche magazzini e botteghe La stessa piazza per funzionare al meglio secondo il principio dello scambio diretto necessitava di magaZzini di supporto bull
4 LE SCORTE DEI FORNAI CITTADINI
Nellarea urbanagrave e nelle relazioni tra cittagrave e campagna operavano perograve temibili conshycorrenti dei privati possessori I fornai cittadini possedevano le competenze le strutshyture tecniche le relazioni sociali e il credito per incettagravere il prodotto per essere inforshymati tempestivamentesul mercato del grano e potenzialmente per dispensarlo con profitto in qualunque momento Il fatto che il loro operato fosse imprigionato in unarshycaica impalcatura di norme divieti obblighi che risalivano alletagrave romana che ne fashycevano in modo quasi istituzionalizzato il capro espiatorio delle tensioni fra produtshytori di grano povertagrave e autotitagrave non impedisce di affermare che tali vessatorie disposiziograveD1 trovassero la loro principale ragione dessere nella parte che essi giocashyvano di interlocutorilantagonisti dei proprietari terrieri nelladeterminazione del prezshyzo del grano sul mercato locale e nella realizzazione della rendita terriera (GUENZI 19824
35 GUENZI 1982 297) Neacutel caso di Mantova terra comucopia a partire dal 1492 si consend a zentilhomini
cittadini et qualuncho altro di comprare biade nel Dominio per approvvigionare la cittagrave di fatto si sand un diritto allincetta che mise fuori gioco i fornai a cui venne imposto di rifornirsi nei solarimiddotdei cittadini senza avere piugrave la possibilitagrave di effettuare acquisti nel contado e di ritenere a casa scorte superiori amiddotl 00 staia di frumento Lintento della disposhysizione egrave chiarissimo espresso senza reticenze dai Maestri delle Entrate che riportarono al marchese la soddisfazione dei possidenti mantovani per la riforma statutaria
tutta la Terra [cioegrave il Mantovano] ne [egravel rimasta satisfactissirna pensando che Vostra Excellenilii pretenda ali comodi et utilitagrave universagrave1e senza dampno et preuiditio suo Vero egraveche li fumari non si contentano parendoli comegrave il vero che non si poteranno ingrassar a suo modo come haqno factO per il passato et poteria achader [bulll Che venetanno adolershyse et supplicar aVosUa Signoria Perograve me egrave parso d~ene aviso per ques~ nostra et farli inteni1er Che questaterril ha solii due membri de li quali li cittadini soi se ne possono aiutashyre e valersene uno egrave il grano laltro egrave larte de la lana et quando se concedesse che li furshynari potessero comprare come hapno facto li tempi passati sana un fare benefitio acinquanshytaocto dessi et dampnificharelreslO de la republicasua quale de questo bon ordine ne receve emolumento grandissimo et se gaude in la Citagrave [percheacute] li fumari portano fuora el denaro et pretendono solo a suo benefitio (AG b 2441 lettera del 13 luglio 1492)
Egrave indubbio che il plauso della Terra fosse da attribuire piugrave alla possibilitagrave per i proshyprietari di accrescere le proprie entrate che a quella dei consumagravetori cittadini e dell arte della lana di trarre beneficio daJla disposizione Egrave significativo che la motivazione pro civitate nori accenni allesistenza di monopoli da parte dei fornai o di artificiose lievitashyzioni dei prezzi per causa lOro nloro attivismograve non egraveonfliggeva per quanto riguarda i prezzi finali della sussistenza con linteresse dei produttori cittadini E daltra parte largomentodello stomo dal metFato cittadino dei profitti incamerati dai fornai -laccushysa consueta a proposito deipistores egrave che fossero in gran parte stranieri (GUBNZl 19824
22) -- era unagiustificazione debole che appassionava piugrave chi concorreva direttamente
491 498 Renzo P Comtore
alla spartizione dei proventi derivanti dalla vendita e dal commercio del grano shylemolumento grandissimo - di chi doveva poi fruire della redistribnzione di tale ricchezza Tale norma avvantaggiava i possidenti cittadini e i gentiluomini ptivilegiashyti in grado di ottenere le tratte di esportazione Sul piano dellappropriazione essi erano in condizione di mettere fuori gioco gli altri possessori che producev~o eccedenze nel Dominio poicheacute si accresceva Igravea loro forza contrattuale e la loro capacitagrave di occUpare i canall commerciali piugrave redditizi Sul piano della commercialiZzazione gli stessi fruivashyno dello smantellamento della rete dintennediazione rappresentata dai fornai Per i rushystici significava perdere un collegamento essenZiale con la cittagrave ed essere emarginati dal mercato urbano nelle campagne o sul broletto di Mantova essi non trovarono piugrave i trashydizionali interlocutori (CORBlJ9RE 2000 228 231-2)
Nel caso di Bologna terra strutturalmente deficitaria e cittagrave dalla vocaiione manishyfatturie~ si costringeva i fornai ad acquistare formenti terrieri presso i solari privati in cittagrave proibendogligrave lincetta nel contado autorizzandoli ad acquistareformentiforeshystieri al di fuori delle mura cittadine presso i sensati da grqno solo a patto che fosseshyro stati smaltiti i grani cittadini a un prezzo talora superiore a quello dei grani dimshyportazione (GUlNZI1982A35 52-3)
Nella Toscana dei Medici il diritto allincetta nel contado venne concesso ai fornai in periodo di bassa congiuntura (in particolare dagli anni Trenta del Seicegravento)Per sostenere i prezzi interni in tal caso essi restavano gli interlocutori principali dei granshydi proprietari semplicemente spostando la loro principale fonte di approvvigionashymento dai solari dei particolari in cittagrave ai granai decentrati delle grandi aziende agrishycole oppure ai mercati rurali su cui affluiva la produzione cerealicola delle grandi fattorie (PuLT QUAOUA 1984 86-9 PuLTQUAOUA 1990 100 106-7)
Laddove non vi egrave come invece succede a Genova una diretta ingerenza del potere pubblico nella vita della corporazione (MAsSA 1999) i fumai di cittagrave - nonostante i lacci e lacciuoli normativi e il lavoro prevalentePlente manuale svolto neiloro laboshyratori - erano dei veri imprenditori dipendenti per il loro profitto - noininalmente stabilito per legge - dalla produttivitagrave del lavoro e dalla dotazione tecnica e finanziaria delle imprese Di ciograve fa fede la grande sperequazione esistente fra le aziende speciashylizzate nena fabbricazione del pane venale in cittagrave (AYMARD 1966 75 VECCHltltJQ 1979 82-3 GUlNZI1982 77 segg PuLT QUAOUA 1984 100 102-3) NellItalia delshyletagrave moderna questi artigiani-imprenditori della filiera del grano trattavano insieme
afarinaifarinaiolifarinottifondachierifontechierifidelariformentinari lasagneshyri maccaronari torallari vermicellari ecc fra il 40 e il 70 per cento del frumento consumato in Cittagrave nelle annate normali (CoRRJTORE 2000 126 segg) e ~ino al 100 per cento nelle annate di carestia (Puu QUAOUA 1984 98-9)
In una ricognizione delle asimmetrie informative del mercato non cegrave gruppo quale i fornai che possa integraverpretare la parte dell agente economico onnisciente Se dunque i regolamenti annonari tendevano a regolare minuziogravesamente la collocazione il volushyme e la durata delle loro scorte cosi come disponevano per gli altri artigiani della fishyliera era per neutralizzare il carattere potenzialmente eversivo di tale accantonamenshyto per i proprietari-venditori Prima ancora che per i consumatori-acquirenti n livello delle scorte rinforzava o attenuava il rischio di monopsonio da parte dei pistores piugrave potenti e facoltosi cosigrave come eventuali tentazioni da parte della categoria di esercitare un dominio egoistico sul mercato del pane (MAITOZZl1983 298)
Sarebbe quindi un errore concepire le scorte dei fornai come entropica allocazione di capitale che sconta lincertezza futura esse venivano gestite secondo criteri di rashyzionalitagrave economica e secondo la migliore efficienza tecnica nonostante i vincoli imposti alla lievitazione degli stock dalle disposizioni annonarie
lA costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
vimini paglia o canne intrecciate (come ceste stuoiecannizzi) in terracotta (addirittura anfore) piuttosto che di tessuto (i sacchi costavano troppo) (PICCINNl1976 397 MAzzA RAvEGol 1983 174-5 Zoo Toce 1990 893-4 COIiITONES11991 35n-36n)
Nella casa del piccolo produttore o del titolare di un piccolo possesso il penw (la scorta domestica) difficilmente eccedeva il consumo famigliare chi fortunato raccoshyglieva piugrave dell annona famigliare e di quanto gli serviva per il campo era spinto a venderselo nei mesi immediatamente successivi alla mietitura e alla trebbiatura per necessitagrave di denaro ma anche per la difficoltagrave di stoccare e conservare il prodotto in condizioni ottimali (MEuvRET 1988 17-9 PuLT QUAOUA 1984 88) e figravenanco per ridurre il rischio di vederselo soffiare da vagabondi e malintenzionati In questo caso in presenshyza di eccedenze (ma probabilmente anche in assenza) il bisogno di liquiditagrave e lalea cospiravano nel ridl1ITe ai minimi termini le scorte giagrave allindomani del raccolto In caso alternativo il contadino che non egrave - ripete Jean Meuvret - un homme daffaires quanshyto un homme de peur concepiva la sua riserva come un fondo di previdenza sul racshycolto futuro da non immettere sul mercato se non nel caso dellapprossimarsi di una messe sicura secondo una logica economica a contrario (MEUVRET 1988 19 e 147)
Era Jl~tente la disparitagrave fra i produttori non solo fra chi era in possesso di eccedenshyze e chi non lo era ma piugrave anqgtra fra chi poteva scegliere in virtugrave di una maggiore capienza economica e unadeguata dotazione tecnica - il mercato piugrave favorevole per i propri grani (il periodo di saldatura dei raccolti) e chi invece li cedeva troppo presto o in controtempo a livelli non ottimali
Nella gerarchia delle abitazioni rurali -- in quel vero e proprio saggio di sociologia che egrave il sesto libro del DeArchitectura di Sebastiano Serlio (scritto fra il 1537 eil 1555 inedito per tutto levo moderno) -- per trovare case attrezzate di granaio occorshyreva ascendere sino alla magione del basso mercante o cittadino fuori della cittagrave (SERLlO 1994 43 segg anche per le successive informazioni) Condizione di cui non potevano fregiarsi invece i ricchi contadini in ~essuno dei tre gradi possibili di ricshychezza al massimo la loro casa poteva essere attrezzata di portici per ricoverare le biade e di unaia per batterle segni di distinzione giagrave fra i mediocri contadini Fra questi perograve avrebbero potuto avvalersene soltanto i fortUIgravelati et di beni et di famishyglia (3deg grado di mediocritagrave) nforno per cuocere il pane e una cantina per conservashyre il vino invece li si sarebbe trovati a partire dai piugrave accomodati fra i poveri contashydini cioegrave al 4deg gradino della scala sociale alla cui base erano da collocare i poveri mendichi con vii capanna (10 grado di povertagrave) i salariati che vivevano delle [loro] fatiche avendo un puoco di terreno (2deg grado di povertagrave) i poveri con qualche beshystiuola et massimamente de buOvi possessori di una stalletta congiunta con la casa 0deg grado di povertagrave)
In sintesi nelle campagne delletagrave pre-industriale pochi avevano scorte pochissimi erano in grado di ricoverarle in un solaro privilegiatissimo chi le incanevava per speculare Dunquefra i conta4ini se si esclude quanto celato nella madia o nella dishyspensa le scorte erano un pri~ilegio di pochi nSerlio nato intorno al 1475 insiste sullimpoverimento delle class~ rurali intervenuto fra gli anni della sua giovinezza e quelli della vecchiezza in cui scrive Sotto il titolo Dellabitazione del ricco contadishyno per tre gradi di ricchezza si preoccupa di puntualizzare
bencheacute al di dogi non se n~ truovi piugrave de tali merceacute delle discordie et di gli animi fieri et ostinati alla vendetta onde per tal cagioni et per le continue guerre et anche pei citadini divoratori de gli altrui beni che con le usure con glinganni con le rapine gli bano impoveriti (SERUO 1994 ~8)
490 RellOP CorrilOle
colto (agosto-settembre-ottobre) e invia di esaurimento almomento della saldatura dei raccolti (aprile-maggio-giugno )1A questo proposito nota Franccedilois Sigaut
Le stockage agrave court terme (moins dune campagne) reacutepond agrave la neacuteCessiteacute cIeacute concilier une offre variable et une demande constante mais toutes deux reacutegulieacuteres et preacutevisibles dans la
pratique il est consideacutereacute comme tiiisant pame du processus ordinaire de la production et ne pose agrave ce titre que desproblegravernes doptimisation assez simples (SlOAUI 1985 602)
La discussione generale sulla razionalitagrave economica delle scorte alimentari in etagrave pre-industriale puograve allora essere ridotta alla fonnulaiione e allo scioglimento di due
semplici quesiti 1 Accertato che laccantonamento digram per la periodicitagrave annuale del ciclo agricoshy
lo epet i vincoli tecnici di un rifomimento spazialmente allargato egrave inevitabile chi egrave conveniente che conservi le scorte chi produce o chi commercia il contadino o il mercante lapossidenzagrave o il popolo i particolari o il pubblico E qual egrave la realtagrave effettiva
2 Se le forme di distribUzione economicamente razionale sono plurali in quale conshytesto e in omaggio a quali interessi piugrave utile il sistema della canova rispetto al sistema delll piazza del mercato e dei solari privati
3 SULLADISTRIBUZIONE DEL GRANO NELUETAgrave PRE-INDUSTRIALE E LA STRUTTURA DELLE SCORTE NEI TERRITORI ITALIANI
Raramente le case contadine erano dotate di attrezzature per la conservazione dei cereali piugrave che elementari Nelle campagne toscane del Quattrocento dunquein unetagrave favorevole al reddito contadino in una regione fra le piugrave ricche dellEuropa pre-indushystriale
pochissime case contadine disponevano del granaio vero e proprio alcune avevano una cella che poteva servire allo stesso scopo ma la maggior parte di quelle abitazioni era priva di spazi destinabili esclugravesivamente alla conservazione dei cereali Perciograve i contenitori dei grani arche casse sacchi bugnole - dovevano trovare posto nelle cucine o nelle camere CMA= RAVEGGI 1983 174)
Le ridotte capacitagrave patrimoniali e reddituali della grande maggioranza dei produttori facevano sIgrave che fosse ampiamente invalso nella conservazione domestica dei grani limshypiego di contenitori in legno (come arche casse botti bugnole tini tinelle corbelli)in
Riguardo ai passi evidenziati di Zanetti e Cipolla egrave neCessario osservare che la principale atteshystazione sullesistenza di stock detenuti da privati che esorbitassero ilfabbisognostagionale tali da essere classificati come immobili=zione di ricchezza (Zanetti) o come beni capitale (Cipolla) a unanalisi piugrave fine si rivela fallace o non direttamente utilizzabile La propalazione dei grani effetshytuata a Pavia fra ilimiddot e il5 maggio 1555 che egrave il fondamento di entrambi i giudizinon mostra una somma di derrate realmente eccedente il fabbisogno delle famiglie per il periodo che manca allarri_ vo dei grani novelli sulla piazza pavese Daltra parte lastessa natura dellistituto della propalazioshyne dei grani cioegrave della denljncia obbligatoria delle scorte da parte dei particolari una misura demergenza decisa in momenti critici dellapprovvigionamento cittadino affiancata quellanno dalshylispezione diretta presso le case dei privati da parte di deputati straordinari avrebbe dovuto consishygliare una maggiore cautela nella sua utilizzazione per individuare regolaritagrave di carattere generale delleconomia pre-industriale
499 La costituzione di scorte granarie pubbliche e la ptlitica ecoMmica degli stati
FONTI
ABEL [1966) W ABEL Agrarkrisen undAgra~kJJnjunktur Eine Geschichte der londshy und Erniihrungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter Hamburg
und Berlin Paul Parey 19662 (la ed -1935 trad it Congiuntura agraria e crisi agrarie Storia dellagricoltura e della produzione alimentare nellEuropa centrashyle dal XIII secolo alletagrave industriale Torino Einaudi 1976 da cui si cita)
AG ARCHIVIO GoNZAGA presso lArchivio di Stato di Mantova AuFANO 1996 E AuFANO Il grano il pane e la politica annonaria a Napoli nel Setshy
tecento Napoli ESI 1996bull AYMARO 1966 M A YMARO Wmise Raguse et le commerce du bMpendant la seconde
moitieacute du XVI siegravecle Pans SEVPEN 1966 CATIINI 1984 M CATl1NI I contadini di San Felice Metamorfosi di un mondo rurale
nellEmilia delletagrave modernIgravel Torino Einaudi 1984 CESTARl 1794 p CESTARI Saggio storico dei Fondachi delle farine di Chioggia e
Pellestrina Venezia A Zatta 1794 CIPOllAJ1965] C M CIPOllA La politica economica dei governi V La penisola
italigraveana e la penisola iberica in Storia economica Cambridge m La cittagrave e la politica economica nel Medioevo Torino Einaudi 1977 (Cambridge 1965) pp 462-496
CIPollA 1974 C M CIPollA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna nMulino 1974
CIpollA 1997 C M CIPOllA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna nMUlino 1997 (6 ed riveduta)
CORRITORE 2000 R P CoRRITORE La naturale abbondanza del Montovano Produshyzione mercato e c01isumi granari a Mantova in etagrave moderna Pavia Universitagrave di Pavia 2000
CORIONBSI 1991 A CORIONBSI Sulla conservazione dei cereali nellItagravelia medioevale Lavoro e tecniche nelle tesnmonlanze laziali (secc XIII-XV) in Rivista di storia dellagricoltura XXXI 1991 l pp 33-49
DELLA VALENTINA 1992 M DELLA VALENTINA I mestieri del pane a ~nezia tra 600 e 700 in Atti dellIstituto [Veneto di Scienze Lettere ed Arti Classe di scienze morali lettere ed arti CL 1991-92 pp 113-217
DIRLMEIER 1984 U DIRLMEIER le condizioni materiali dellesistenza nelle cittagrave tedeshy sche del Basso Medioevo ~iente esterno reddito consumi in Aristocrazia citshy
tadina e ceti popolari nel tprdo Medioevo in Italia e in Germania (a cura di Reinhard Elze e Gina Fasoli) Bologna Societagrave editrice il Mulino 1984 pp 79shy122
FORNASIN 1999 A FORNASIN Il pzercatodei grani di Udine Indagine per una storia dei prew in Friuli (secoli XfI-XVIII) Nota di ricerca del Dipartimento di Scienshyze Statistiche dellUniversit4 degli Studi di Udine 4 1999 pp 1-24 ora in lo La Patria del Friuli in etagrave 1fIOderna Saggi di storia economica Udine Forum 2000 pp 33-60
GRENDI 1986 E GRENOI Lapprccedilwigionamento dei grani nella Liguria del Seicento libera pratica e annone in iMiscellanea storica ligure Studi in onore di Luigi Bulferetti XVIII 1986 2Jp 1021-1047
GUENZI 1981 A GUENZI Ilfrurnfnto e la cittagrave il caso di Bologna nelletagrave moderna in Quaderni storici XVI ~981 46 pp 153-167
GUENZI 1982 A GUENZI Pane ~fornai a Bologna in etagrave moderna Venezia Marsilio 1982
I
489 500 Renzo P CornIOle
GUBNZI1982 A GUEml Sistema annonario e egraveontrollo sociale a Bologna nei seccediloli XVII e XVIII in E SORI (a cura di) Cittagrave e controllo sociale in Italia fra XVIII e XIX secolo Milano F Angeli 1982 pp 293-306
HICKS [1989] 1 R HIClCS A narlcet theory of money Oxford Oxford Universigravety Press 1989 (trad it Una teoria di mercato della monefa Bologna li Mulino 1992 da cui sigrave cita)
JACOPBITI 1965 N L JACOPBITI Monete e prezzi a Cremona dal XVI al XVlIi secolo Cremona Athenaeum CregravemoneJlSe 1965
KAPLAN 1984S L KAPLAN Provisioning Paris Merchants and Millers in the Grain and Flour Trade during the Eighteenth Century Ithaca-London Cornell Univershysity Press 1984~middot
KULA [1962] W KULA Teoria ekonomiczna ustrojufeudalnego Proba modelu Warshyszawa-Panstwowe WydawnictwoNaukowe 1962 (trad it Teoriagrave economica del sistema feudale Proposta di un modello Tormo EinaUdi 1972 ccedilla cui si cita)
WROUSSE [1933] C-E LABRoussE Esquisse du mouvement des prix et des reverws en France au XVIII siegravecle Paris Eacuteditions des Archives Contemporaines 19842 volI (l ed Paris Librairie Dalloz 1933)
MALANtMA 1976 P MALANiMA Aspetti di mercato e prezzi del grano e della segalea Pisa dal 1548 al 1818 in Ricerche di storia moderna vaL I Pisa Pacini 1976 pp ~n
MANToVA 1430 MwroVA 1430 Pareri a Gian Francesco Gonaga per il governo (a cura di M AQrignaniA M Lorenzoni A Mortari C Mozzarelli) MUltova G~ Arcari 1990
MASSA 1999 PMAssA Annona e corporazioni del settore alimentare ~ Genova orshyganizzazione e conflittualitagrave (XVI-XVIII secolo) in A GUENZI PMAssA A MOIOshyu (a cura di) Corporazioni e gruppi professionali nellItalia moderna MilIllO F Angeli 1999 pp 390-403
MATIoZ7J 1983 1 MiJroZ7J F BOLELLI C CmAsBRA D SABBIONI Il politico e il pane a Venezia (157Q-1650) calmieri e governo della sussistenza in Societagrave e storia VI 198320 pp 271-303
MAzzI RAVEOOI 1983 M T MAzzI S RAVEOGI Gli uogravemini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento Firenze Olscbki 1983
MERONI 1957 U MERONI Cremona fedelissima Ciemona Athenaeum Cremonenshy~~~ _
MBUVRBl 1977 J MEuVRsT Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque LouisXIvI La productiograven des ceacutereacuteales dans la France du XVII et du XVIII siegravecle Paris Mouton -EacuteEHSS19772voll
MBUVRET 1988 J MBtJVRf Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque Louis XIv III Le commerce des gralns et la conjoncture Paris EacuteEHss 1988 2 volI
PtCClNNI 1976 G PtCClNNl Wta contagravedina in una capanna dei dintorni di Siena (1250) in ~Archeologia medievale m 1976 pp 395-399
PlNIO 1978 G PINTOII Libro del BiaPaiolo Carestie e annona a Firenze dalla metagrave del 200 al 1348 Fire~ Olscbki 1978
PiNTO 1982 G PtNro La Toscana nel tardo Medioevo Ambiente economia rurale societagrave Fllenze Sansoni 1982
PtRENNE [1933J H PIRENNB La civilisation occidentale au Moyen Age du XIe au mishylieu du XVe siegravecle Paris PUF 1933 (trad it Storia economica e sociale del Meshydioevo Milano Garzanti 1967 da cui si cita)
Lacostituticne di scorte granarie pubbliche e la politica economiegravea degli stati
redigravestribuzione sostenibile dei beni di sussistenza egrave ricercata in questo cielo da quegli stessi particolari che ~amaldeggiano nella produzione negli scambi nei consumi e che costituiscono il nerbo della classe di governo Le scorte pubbliche rappresenteshyrebbero in questa prospettiva un presidio civico e un risltCimento politico e morale ai cOl1ponenti della comunitagrave spossessati delbene supremo dellautarchia alimentare
Resta infine latente unidea del magazzmo pubblico come quasi-mercato cioegrave come luogo volto (1) a risolvere i fa1limentiinfo~vi della piazza del mercato (in meacuterito alle disponi~ilitagrave alle caratteristiche del prodotto alle condizioni di vendita della merce) (2) a ridimensionare lalea per agricoltori consumatori poveri artigiani del comparto alimentare (3) a sostenere i consumi e i profitti privati m funzione anticicli ca in una prospettiva Ilpn meram~nte congiunturale Si tratta in questo caso di un orshyganizzaZionepienattiCnte razio~e Che non opera in maniera saltuaria e riflessa ma in modo continuativo secondo obifttili prefissati di allocazione dei beni primari li funshyzionamento dellacanovagrave (il magazzino pubblico) si porrebbe come strumento inteshygrativo ma no~~igraventeramente so~titutivo delloperare della piazza Si tratterebbe di unaforma di mercato distinta dalla p~ del mercato considerata in seacute e per seacute cosigrave come dallegraveOOmpravendite effetttlate nei solari privati o dalla mera centrallzzazione e redistribuzione di derrate con fi~alitagrave umanitarie La canova rappresenterebbe in tal modo uno dei possibili meccaoi~ di governo delle trllls3ZIgrave~ni locali per risolvere i problemi deUapprovvigionameIto senza intaccare certi interessi di classe (dei proshyprietari ma anche del popolo grasso) S da essere prescelta da autoritagrave e gruppi domishynanti come struttura complementare della piazza del mercato incerti contestiprodutshytivi ed economici La suasacrilizzazione perciograve non esclude la possibilitagrave di un ritorno alle sole compravendite qella piazza e dei solari privati - una volta invertishytosi il trend o spirate le condizioqi economiche della sua istituzionalizzazione
La problematizzazione esorc~ una liquidazione semplicistica del problema delle scorte gran8rle in etagrave pre-industriUgravee nel nome di una loro presunta irrazionalitagrave eco- nomica per il compito di assi~ la sussistenza della popolazione
Le pagine che segUono sono rintroduzione a un lavoro in corso volto a offrire un interpretazione generale di tal~ capitolo fondamentale della politica economica dei governi
in
etagrave pre-industriale
2 SE UN MONDO SENZA SCORTE Egrave INCONGRUO cm Egrave OPPORTUNO CHE LEgrave DETENGA
Nei fatti nel settore granarlo CQni vincoli dell etagrave pre-industriale in tema diprodutshytivitagrave energia trasporti non ha s~nso ipotizzare un mondo senza scorte Se il mercato del grano egrave - come nellEuropa medievale e moderna - un sjstema tendenzialmente chiuso
ad ogni raccolto nuove offe~ aniv(erannol sul mercato mentre la domanda si mant[erragrave] relativamente costantt nel corso dellanno Qualcuno dunque [dovragrave] ~ere delle scorte che saranno elevate ~ubito dopo il raccolto e poi via via minori fino aragshygiungere un livello minimo in prpssimitagrave del successivo raccolto (HICICS [19891 31)
Nella loro forma piugrave sempliceI tali scorte saranno legate allora alla periodi~itagrave anshynuale del ciclo agricolo (che a1iplenta il movimento stagionale dei prezzi ccedilfr LAshyBROlJSSE [1933] 157-66) il loro livello saragrave elevato allindomani del principiLle racshy
501 488 Renzo P Corritore
povero ammassograve nella propria dimora scorte di grano carne ~alata sale candele ecc e la medesima cosa fece lo Stato Nel periodo feudale non venne mai meno nel castello del signore labitudine di tenere da parte grosse scorte per i periodi di emergenza Sucshycessivamente le autoritagrave comunali predisposero il magazzinaggio di grosse derrate specie di grano da rivendere a basso prezzo in periodi di emergenza e nello stesso tempo si preoccuparono di prevenire un indebito accumulo di scorte da parte di specushylatori privati Nelle economie medievali gli stock di derrate di prima necessitagrave rappreshysentarono pertanto una delle piugrave importanti forme di investimento pubblico e privato (CIPOLLA (1965] 468)
Nella prima versione del manualeacute invece fino allinserimento nel 1997 del nuovo capitolo dedicato alla politica economica nell etagrave pre-mdustriale il punto di vista preshyvalente era quello microeconomico entro il perimetro stretto dellindividualismo meshytodologico
Le scorte costano e costano doppiamente Esse implicano il costo diretto che egrave rapshypresentato dal costo del magazzinaggio edal deterioramento eventuale del pr04otto o di parte di esso Se luomo daffari finanzia la costituzione delle scorte con danaro preso a prestito il costo diretto include anche il tasso di interesse pagato Se luomo daffari finanzia con capitale proprio la costituzione delle scorte il costo delle scorte deve inshycludere un costo-opportunitagrave e cioegrave il mancato rendimento (tIllU1cato tasso dinteresse attivo) del capitale finanziario impiegato (CIPOLLA 1974 154)
Le ragioni della costituzione e del mantenimento di scorte alimentari da parte delshylautoritagrave pubblica diventavano unicamente ragioni morali (umanitarie e di buona amministrazione) o di opportunitagrave politica (la fame era la piugrave frequente ligraveausa di sommosse e furori popolari) (CIPOLLA 1974 74)
Nel 1997 si riammetteva dunque linterpretazione originaria della costituzione di scorte pubbliche come strumento di riequilibrio del mercato senza peraltro rinnegare le considerazioni sulla valenza statica di tale forma di investimento per gli agenti economici privati
In merito allutilitagrave economica e al significato delle scorte in etagrave pre-industriale Cishypolla non espresse perciograve sempre lo stesso punto di vista La rassegna delle posizioni da lui assunte anzi permette di individuare tre approcci e tre giudizi costitutivamente diversi sulla funzione delle scorte granarie nellepoca pre-industriale
In prima approssimazione laccumulazione di scorte alimentari mostra il carattere fondamentalmente difensivo delle scelte degli agenti economici pubblici e privati in etagrave pre-industriale La paura la tradizione la superstizione li induce a tabuizzare il rischio la speculazione linvestimento nella produzione e nella distribuzione dei beni essenziali alla vita e ad aderire intimamente a un ideale di economia e societagrave stazionarie aggravando con la norma sociale le istituzioni il comportamento indivishyduale e collettivo leffetto dei condizionamenti materiali delleconomia pre-industriashyle (bassa produttivitagrave agricola alti costi di v~sporto modesta efficienza energetica) esponendo ancor di piugrave la comunitagrave umana ai degravemoni della natura
La seconda interpretazione rigetta luniversale imperio dellhomo oeconomicus rishyscoprendo leteronomia dei fini dellagire economico degli uomini nelletagrave pre-inshydustriale Ia politica economica dello Stato o-delle autoritagrave non persegue puri scopi economici lintegritagrave del corpo sociale fin nelle sue cellule elementari (persone e famiglie) deve essere assicurata secondo i principi e la prassi di uneconomia morale che SOVJa5ta leconomia regolata dal mercato spersonalizzata e antipopolare Una
La costituzione di scorte grantlTie pubbliche e la poligravetigraveca economica degli stati
PuLT QUAGUA 1984 A M PULT QUAGUA Mercato dei prodotti agricoli e magistratushyre annonarie a Pisa nelletagrave moderna in Ricerche di storia moderna a cura di M Mirri voI III Pisa Pacini 1984 pp 57-141
PULT QUAGLIA 1990 A M PULT QUAGLIA Per provvedere ai popoli Il sistema anshynonario nella Toscana dei Medici Firenze Olschki 1990
SERUO 1994 S SERLIO Architettura civile Libri sesto settimo e ottavo nei manoscritshyti di Monaco e Vienna (a cura di F P Fiore) Milano TI Polifi10 1994
SIGAlIT 1985 F SIGAlIT Questions deacuteconomie agrave propos des politiques ceacutereacutealiegraveres et de stockage in Les techniques de conservation des grains agrave long terme leur rale dans la dynamique des systegravemes de cultures et des socieacuteteacutes (sous la direction de M Gast F Sigaut et C Beutler avec la collaboratlon de O Bllchsenschutz) voI III 2 Paris Eacuteditionsdu CNRS 1985 pp 597-606
SMITH [1776 A SMITH An inquiry into the nature and causes ojthe wealth ojnations London W Strahanand T Cadell 17762 volI (trad it Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni Milano A Mondadori 1977 2 volI da cui
si cita) STATlITlBoNACOLSIANI [1313] STATUTI BONACOLSlANl (a cura di E Dezza A M Lorenshy
zoni M Vaini) Mantova GArcari 2002 STATUTI GONZAGHESCHI [1404] STATUTI GONZAGHESCHI presso la Biblioteca comunale di
Mantova ms FV 11 [775]VECCHIATO 1979 F VOCCHIATO Pane e politica annonaria in Terrajerma veneta tra
secolo XV e secolo XVIII (Il caso di Verona) Verona Stamperia Zendrini 1979 ZANETTI 1963 D ZANETTl Contribution agrave leacutetude des structures eacuteconomiques lapshy
provisiQnnement de Pavie au XVI siegravecle in Annales ESC XVIII 1963 1 pp 44-62 ora in lo Fra le antiche torri Scritti di storia pavese Pavia Universitagrave di Pavia 2000 pp 165-182
ZANETTl 1964 D ZANEITI Problemi alimentari di una economia preindustriale Ceshyreali a Pavia dal 1398 al 1700 Torino P Borlnghieri 1964
ZUG TUCCI 1990 H ZUG TuCCI Le derrate agricole problemi materiali e concezioni mentali della conservazione in Lambiente vegetale nellalto Medioevo XXXVII Settimana di studio del Centro italiano di studi sullalto Medioevo (30 marzo-5 aprile 1989) Spoleto Centro italiano di studi sullalto Medioevo 1990 voI n pp 865-902
492 Renzo P COITitore
Tale disparitagrave sociale si riverberava sulla struttura del commercio cerealicolo La funzione dei piccoli commercianti di biade (granaiolibull biadaiolifarinaioli balshy
zarotti cavallanti vatlcali ecc) era infatti ancillare alla capacitagrave di affacciarsi sul nercato della fascia marginale deipossidenti con eccedenze Solo che nelle annate di abbondanza si venficavano ingorghi nell offerta di grano che deprimevano i prezzi e incentivavano i piccoli produttori a smerciare direttamente le eccedenze allindomani del raccolto nellarea urbana anche al di fuori dei luoghi deputati (MATI02ZI 1983 278281-2 300n PULr QUAGLIA 1984 86) Mentre nelle annate di penuria si contraeshyva drasticamente proprio questo segmento dellofferta (ABa [1966Jmiddot 22-4 KULA [1962J 73-4 CATrINI1984 111-23 PuIr QUAGUA 1984 88) scatenando nelle campashygne una caccia al grano-merce la cui quota piugrave consistente era detenuta dai grandi proprietari dai maggiori affittuari dai percettori di canoni diritti o rendite in grano e la cui quota residua era piugrave facilmente preda di chi occupava posizioni chiave nellasshysetto terriero nella catena dei diritti nel credito alla produzione e al consumo
Tanto la distribuZione era frammentata nelle annate di abbondanza tanto in epoc~ di penuria il commercio del grano diventava un affare di pochi In questo caso lazioshyne dei mercanti diVentava dimpiccio sul mercato interno dove la coperta si restringeshyva per i proprietari e gli imprenditori agricoli (KULA [1962] 56-61 CATl1NI 1984 114-8) - dove la necessitagrave di ricorrere al credito da parte dei piccoli possessori poneva questi nelle mani degli agenti dei proprietari dei percettoridi canoni diritti o rendite - dove i piccoli proprietari vedevano minacciata la loro stessa condizione da parte di chi controllava localInente in maniera capillare e decentrata il mercato del denaro e dei beni necessari alla riproduzione (sementi strumenti cibo) La soluzione era quelshyla di precludere amministrativamente ai sensali e ai commercianti di grani i mercati locali su istigazione dei medi possessori le cui occasioni di normale profitto agrario soffrivano un ridimensionamento e che si vedevano costretti a impegnarsi ccedilon tutte le loro forze per integrare le proprie entrate accaparrandosi le magre eccedeiiZe disponishybili nelle campagne e nei borghi rurali (PuLT QUAGLIA 1984 84-8 PULT QUAGLIA 1990 lO7-14)
TI destino dei piccoli commercianti in grano era quindi quello di occupare una posishyzione margilJale nel mercato del grano (MBlNrurr 1977 30 PINTO 1978 13 MAITOZZl 1983 277) e di operare - non solo a causa degli ordinamenti annonari - secondo una logica di corto respiro in cui non era contemplata neacute la conservazione di grani a lungo termine neacute lutilizzo di depositi piugrave che provvisori Come per i piccoli possidenti non si puograve parlare ne1loro caso della formazione e del mantenimento di scorte consistenti (MBlNREr 1988 156~7) Non tali comunque da sostenere il reddito contadino nelle stagioni ordinarie e da esercitare sul versante cittadino unefficace azione anticonshygiunturale in caso di carestia
Peraltro in cittagrave la struttura dellofferta era anche piugrave sperequata di quella che si rishyscontra nel contado Che si tratti di Prato nel 1339 (PINTO 1978 129 PINTO 1982 160n e 17In) Pavia negli anni 1539 1555 1513 1602 1603 (ZANEm 1963) o Mantova nellultima parte del secolo XVI (CORRITORE 2000 81-9) la distribuzione delle scorte fra i privati era singolarmente ineguale Lo attesta la rilevanza nellarea urbana della povertagrave cioegrave secondo una definizione coeva di coloro che non vivono di entrate ma sono necessitati ricorrere mattina e sera alle pistorie a comprare il pane per iI vitto loro e delle sue famiglie col denaro che di giomo in giomo si vanno guadagnando (MATshyTOZZI 1983 281) PUOgrave essere utile richiamare la situazione delle cittagrave tedesche nel basso Medioevo in una fase che egrave stata definita da Wilhelm Abellepoca doro degli artigiani e del lavoro salariato si puograve stimare che almeno la metagrave degli iscritti ai
lA costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli statibull middot497
te con il principio della piazza TI mercato pubblico periodico disciplinatola spiagshygiala piazza la loggia o iI recinto riservato alle contrattazioni - coesis~va confabshybriche magazzini e botteghe La stessa piazza per funzionare al meglio secondo il principio dello scambio diretto necessitava di magaZzini di supporto bull
4 LE SCORTE DEI FORNAI CITTADINI
Nellarea urbanagrave e nelle relazioni tra cittagrave e campagna operavano perograve temibili conshycorrenti dei privati possessori I fornai cittadini possedevano le competenze le strutshyture tecniche le relazioni sociali e il credito per incettagravere il prodotto per essere inforshymati tempestivamentesul mercato del grano e potenzialmente per dispensarlo con profitto in qualunque momento Il fatto che il loro operato fosse imprigionato in unarshycaica impalcatura di norme divieti obblighi che risalivano alletagrave romana che ne fashycevano in modo quasi istituzionalizzato il capro espiatorio delle tensioni fra produtshytori di grano povertagrave e autotitagrave non impedisce di affermare che tali vessatorie disposiziograveD1 trovassero la loro principale ragione dessere nella parte che essi giocashyvano di interlocutorilantagonisti dei proprietari terrieri nelladeterminazione del prezshyzo del grano sul mercato locale e nella realizzazione della rendita terriera (GUENZI 19824
35 GUENZI 1982 297) Neacutel caso di Mantova terra comucopia a partire dal 1492 si consend a zentilhomini
cittadini et qualuncho altro di comprare biade nel Dominio per approvvigionare la cittagrave di fatto si sand un diritto allincetta che mise fuori gioco i fornai a cui venne imposto di rifornirsi nei solarimiddotdei cittadini senza avere piugrave la possibilitagrave di effettuare acquisti nel contado e di ritenere a casa scorte superiori amiddotl 00 staia di frumento Lintento della disposhysizione egrave chiarissimo espresso senza reticenze dai Maestri delle Entrate che riportarono al marchese la soddisfazione dei possidenti mantovani per la riforma statutaria
tutta la Terra [cioegrave il Mantovano] ne [egravel rimasta satisfactissirna pensando che Vostra Excellenilii pretenda ali comodi et utilitagrave universagrave1e senza dampno et preuiditio suo Vero egraveche li fumari non si contentano parendoli comegrave il vero che non si poteranno ingrassar a suo modo come haqno factO per il passato et poteria achader [bulll Che venetanno adolershyse et supplicar aVosUa Signoria Perograve me egrave parso d~ene aviso per ques~ nostra et farli inteni1er Che questaterril ha solii due membri de li quali li cittadini soi se ne possono aiutashyre e valersene uno egrave il grano laltro egrave larte de la lana et quando se concedesse che li furshynari potessero comprare come hapno facto li tempi passati sana un fare benefitio acinquanshytaocto dessi et dampnificharelreslO de la republicasua quale de questo bon ordine ne receve emolumento grandissimo et se gaude in la Citagrave [percheacute] li fumari portano fuora el denaro et pretendono solo a suo benefitio (AG b 2441 lettera del 13 luglio 1492)
Egrave indubbio che il plauso della Terra fosse da attribuire piugrave alla possibilitagrave per i proshyprietari di accrescere le proprie entrate che a quella dei consumagravetori cittadini e dell arte della lana di trarre beneficio daJla disposizione Egrave significativo che la motivazione pro civitate nori accenni allesistenza di monopoli da parte dei fornai o di artificiose lievitashyzioni dei prezzi per causa lOro nloro attivismograve non egraveonfliggeva per quanto riguarda i prezzi finali della sussistenza con linteresse dei produttori cittadini E daltra parte largomentodello stomo dal metFato cittadino dei profitti incamerati dai fornai -laccushysa consueta a proposito deipistores egrave che fossero in gran parte stranieri (GUBNZl 19824
22) -- era unagiustificazione debole che appassionava piugrave chi concorreva direttamente
491 498 Renzo P Comtore
alla spartizione dei proventi derivanti dalla vendita e dal commercio del grano shylemolumento grandissimo - di chi doveva poi fruire della redistribnzione di tale ricchezza Tale norma avvantaggiava i possidenti cittadini e i gentiluomini ptivilegiashyti in grado di ottenere le tratte di esportazione Sul piano dellappropriazione essi erano in condizione di mettere fuori gioco gli altri possessori che producev~o eccedenze nel Dominio poicheacute si accresceva Igravea loro forza contrattuale e la loro capacitagrave di occUpare i canall commerciali piugrave redditizi Sul piano della commercialiZzazione gli stessi fruivashyno dello smantellamento della rete dintennediazione rappresentata dai fornai Per i rushystici significava perdere un collegamento essenZiale con la cittagrave ed essere emarginati dal mercato urbano nelle campagne o sul broletto di Mantova essi non trovarono piugrave i trashydizionali interlocutori (CORBlJ9RE 2000 228 231-2)
Nel caso di Bologna terra strutturalmente deficitaria e cittagrave dalla vocaiione manishyfatturie~ si costringeva i fornai ad acquistare formenti terrieri presso i solari privati in cittagrave proibendogligrave lincetta nel contado autorizzandoli ad acquistareformentiforeshystieri al di fuori delle mura cittadine presso i sensati da grqno solo a patto che fosseshyro stati smaltiti i grani cittadini a un prezzo talora superiore a quello dei grani dimshyportazione (GUlNZI1982A35 52-3)
Nella Toscana dei Medici il diritto allincetta nel contado venne concesso ai fornai in periodo di bassa congiuntura (in particolare dagli anni Trenta del Seicegravento)Per sostenere i prezzi interni in tal caso essi restavano gli interlocutori principali dei granshydi proprietari semplicemente spostando la loro principale fonte di approvvigionashymento dai solari dei particolari in cittagrave ai granai decentrati delle grandi aziende agrishycole oppure ai mercati rurali su cui affluiva la produzione cerealicola delle grandi fattorie (PuLT QUAOUA 1984 86-9 PuLTQUAOUA 1990 100 106-7)
Laddove non vi egrave come invece succede a Genova una diretta ingerenza del potere pubblico nella vita della corporazione (MAsSA 1999) i fumai di cittagrave - nonostante i lacci e lacciuoli normativi e il lavoro prevalentePlente manuale svolto neiloro laboshyratori - erano dei veri imprenditori dipendenti per il loro profitto - noininalmente stabilito per legge - dalla produttivitagrave del lavoro e dalla dotazione tecnica e finanziaria delle imprese Di ciograve fa fede la grande sperequazione esistente fra le aziende speciashylizzate nena fabbricazione del pane venale in cittagrave (AYMARD 1966 75 VECCHltltJQ 1979 82-3 GUlNZI1982 77 segg PuLT QUAOUA 1984 100 102-3) NellItalia delshyletagrave moderna questi artigiani-imprenditori della filiera del grano trattavano insieme
afarinaifarinaiolifarinottifondachierifontechierifidelariformentinari lasagneshyri maccaronari torallari vermicellari ecc fra il 40 e il 70 per cento del frumento consumato in Cittagrave nelle annate normali (CoRRJTORE 2000 126 segg) e ~ino al 100 per cento nelle annate di carestia (Puu QUAOUA 1984 98-9)
In una ricognizione delle asimmetrie informative del mercato non cegrave gruppo quale i fornai che possa integraverpretare la parte dell agente economico onnisciente Se dunque i regolamenti annonari tendevano a regolare minuziogravesamente la collocazione il volushyme e la durata delle loro scorte cosi come disponevano per gli altri artigiani della fishyliera era per neutralizzare il carattere potenzialmente eversivo di tale accantonamenshyto per i proprietari-venditori Prima ancora che per i consumatori-acquirenti n livello delle scorte rinforzava o attenuava il rischio di monopsonio da parte dei pistores piugrave potenti e facoltosi cosigrave come eventuali tentazioni da parte della categoria di esercitare un dominio egoistico sul mercato del pane (MAITOZZl1983 298)
Sarebbe quindi un errore concepire le scorte dei fornai come entropica allocazione di capitale che sconta lincertezza futura esse venivano gestite secondo criteri di rashyzionalitagrave economica e secondo la migliore efficienza tecnica nonostante i vincoli imposti alla lievitazione degli stock dalle disposizioni annonarie
lA costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
vimini paglia o canne intrecciate (come ceste stuoiecannizzi) in terracotta (addirittura anfore) piuttosto che di tessuto (i sacchi costavano troppo) (PICCINNl1976 397 MAzzA RAvEGol 1983 174-5 Zoo Toce 1990 893-4 COIiITONES11991 35n-36n)
Nella casa del piccolo produttore o del titolare di un piccolo possesso il penw (la scorta domestica) difficilmente eccedeva il consumo famigliare chi fortunato raccoshyglieva piugrave dell annona famigliare e di quanto gli serviva per il campo era spinto a venderselo nei mesi immediatamente successivi alla mietitura e alla trebbiatura per necessitagrave di denaro ma anche per la difficoltagrave di stoccare e conservare il prodotto in condizioni ottimali (MEuvRET 1988 17-9 PuLT QUAOUA 1984 88) e figravenanco per ridurre il rischio di vederselo soffiare da vagabondi e malintenzionati In questo caso in presenshyza di eccedenze (ma probabilmente anche in assenza) il bisogno di liquiditagrave e lalea cospiravano nel ridl1ITe ai minimi termini le scorte giagrave allindomani del raccolto In caso alternativo il contadino che non egrave - ripete Jean Meuvret - un homme daffaires quanshyto un homme de peur concepiva la sua riserva come un fondo di previdenza sul racshycolto futuro da non immettere sul mercato se non nel caso dellapprossimarsi di una messe sicura secondo una logica economica a contrario (MEUVRET 1988 19 e 147)
Era Jl~tente la disparitagrave fra i produttori non solo fra chi era in possesso di eccedenshyze e chi non lo era ma piugrave anqgtra fra chi poteva scegliere in virtugrave di una maggiore capienza economica e unadeguata dotazione tecnica - il mercato piugrave favorevole per i propri grani (il periodo di saldatura dei raccolti) e chi invece li cedeva troppo presto o in controtempo a livelli non ottimali
Nella gerarchia delle abitazioni rurali -- in quel vero e proprio saggio di sociologia che egrave il sesto libro del DeArchitectura di Sebastiano Serlio (scritto fra il 1537 eil 1555 inedito per tutto levo moderno) -- per trovare case attrezzate di granaio occorshyreva ascendere sino alla magione del basso mercante o cittadino fuori della cittagrave (SERLlO 1994 43 segg anche per le successive informazioni) Condizione di cui non potevano fregiarsi invece i ricchi contadini in ~essuno dei tre gradi possibili di ricshychezza al massimo la loro casa poteva essere attrezzata di portici per ricoverare le biade e di unaia per batterle segni di distinzione giagrave fra i mediocri contadini Fra questi perograve avrebbero potuto avvalersene soltanto i fortUIgravelati et di beni et di famishyglia (3deg grado di mediocritagrave) nforno per cuocere il pane e una cantina per conservashyre il vino invece li si sarebbe trovati a partire dai piugrave accomodati fra i poveri contashydini cioegrave al 4deg gradino della scala sociale alla cui base erano da collocare i poveri mendichi con vii capanna (10 grado di povertagrave) i salariati che vivevano delle [loro] fatiche avendo un puoco di terreno (2deg grado di povertagrave) i poveri con qualche beshystiuola et massimamente de buOvi possessori di una stalletta congiunta con la casa 0deg grado di povertagrave)
In sintesi nelle campagne delletagrave pre-industriale pochi avevano scorte pochissimi erano in grado di ricoverarle in un solaro privilegiatissimo chi le incanevava per speculare Dunquefra i conta4ini se si esclude quanto celato nella madia o nella dishyspensa le scorte erano un pri~ilegio di pochi nSerlio nato intorno al 1475 insiste sullimpoverimento delle class~ rurali intervenuto fra gli anni della sua giovinezza e quelli della vecchiezza in cui scrive Sotto il titolo Dellabitazione del ricco contadishyno per tre gradi di ricchezza si preoccupa di puntualizzare
bencheacute al di dogi non se n~ truovi piugrave de tali merceacute delle discordie et di gli animi fieri et ostinati alla vendetta onde per tal cagioni et per le continue guerre et anche pei citadini divoratori de gli altrui beni che con le usure con glinganni con le rapine gli bano impoveriti (SERUO 1994 ~8)
490 RellOP CorrilOle
colto (agosto-settembre-ottobre) e invia di esaurimento almomento della saldatura dei raccolti (aprile-maggio-giugno )1A questo proposito nota Franccedilois Sigaut
Le stockage agrave court terme (moins dune campagne) reacutepond agrave la neacuteCessiteacute cIeacute concilier une offre variable et une demande constante mais toutes deux reacutegulieacuteres et preacutevisibles dans la
pratique il est consideacutereacute comme tiiisant pame du processus ordinaire de la production et ne pose agrave ce titre que desproblegravernes doptimisation assez simples (SlOAUI 1985 602)
La discussione generale sulla razionalitagrave economica delle scorte alimentari in etagrave pre-industriale puograve allora essere ridotta alla fonnulaiione e allo scioglimento di due
semplici quesiti 1 Accertato che laccantonamento digram per la periodicitagrave annuale del ciclo agricoshy
lo epet i vincoli tecnici di un rifomimento spazialmente allargato egrave inevitabile chi egrave conveniente che conservi le scorte chi produce o chi commercia il contadino o il mercante lapossidenzagrave o il popolo i particolari o il pubblico E qual egrave la realtagrave effettiva
2 Se le forme di distribUzione economicamente razionale sono plurali in quale conshytesto e in omaggio a quali interessi piugrave utile il sistema della canova rispetto al sistema delll piazza del mercato e dei solari privati
3 SULLADISTRIBUZIONE DEL GRANO NELUETAgrave PRE-INDUSTRIALE E LA STRUTTURA DELLE SCORTE NEI TERRITORI ITALIANI
Raramente le case contadine erano dotate di attrezzature per la conservazione dei cereali piugrave che elementari Nelle campagne toscane del Quattrocento dunquein unetagrave favorevole al reddito contadino in una regione fra le piugrave ricche dellEuropa pre-indushystriale
pochissime case contadine disponevano del granaio vero e proprio alcune avevano una cella che poteva servire allo stesso scopo ma la maggior parte di quelle abitazioni era priva di spazi destinabili esclugravesivamente alla conservazione dei cereali Perciograve i contenitori dei grani arche casse sacchi bugnole - dovevano trovare posto nelle cucine o nelle camere CMA= RAVEGGI 1983 174)
Le ridotte capacitagrave patrimoniali e reddituali della grande maggioranza dei produttori facevano sIgrave che fosse ampiamente invalso nella conservazione domestica dei grani limshypiego di contenitori in legno (come arche casse botti bugnole tini tinelle corbelli)in
Riguardo ai passi evidenziati di Zanetti e Cipolla egrave neCessario osservare che la principale atteshystazione sullesistenza di stock detenuti da privati che esorbitassero ilfabbisognostagionale tali da essere classificati come immobili=zione di ricchezza (Zanetti) o come beni capitale (Cipolla) a unanalisi piugrave fine si rivela fallace o non direttamente utilizzabile La propalazione dei grani effetshytuata a Pavia fra ilimiddot e il5 maggio 1555 che egrave il fondamento di entrambi i giudizinon mostra una somma di derrate realmente eccedente il fabbisogno delle famiglie per il periodo che manca allarri_ vo dei grani novelli sulla piazza pavese Daltra parte lastessa natura dellistituto della propalazioshyne dei grani cioegrave della denljncia obbligatoria delle scorte da parte dei particolari una misura demergenza decisa in momenti critici dellapprovvigionamento cittadino affiancata quellanno dalshylispezione diretta presso le case dei privati da parte di deputati straordinari avrebbe dovuto consishygliare una maggiore cautela nella sua utilizzazione per individuare regolaritagrave di carattere generale delleconomia pre-industriale
499 La costituzione di scorte granarie pubbliche e la ptlitica ecoMmica degli stati
FONTI
ABEL [1966) W ABEL Agrarkrisen undAgra~kJJnjunktur Eine Geschichte der londshy und Erniihrungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter Hamburg
und Berlin Paul Parey 19662 (la ed -1935 trad it Congiuntura agraria e crisi agrarie Storia dellagricoltura e della produzione alimentare nellEuropa centrashyle dal XIII secolo alletagrave industriale Torino Einaudi 1976 da cui si cita)
AG ARCHIVIO GoNZAGA presso lArchivio di Stato di Mantova AuFANO 1996 E AuFANO Il grano il pane e la politica annonaria a Napoli nel Setshy
tecento Napoli ESI 1996bull AYMARO 1966 M A YMARO Wmise Raguse et le commerce du bMpendant la seconde
moitieacute du XVI siegravecle Pans SEVPEN 1966 CATIINI 1984 M CATl1NI I contadini di San Felice Metamorfosi di un mondo rurale
nellEmilia delletagrave modernIgravel Torino Einaudi 1984 CESTARl 1794 p CESTARI Saggio storico dei Fondachi delle farine di Chioggia e
Pellestrina Venezia A Zatta 1794 CIPOllAJ1965] C M CIPOllA La politica economica dei governi V La penisola
italigraveana e la penisola iberica in Storia economica Cambridge m La cittagrave e la politica economica nel Medioevo Torino Einaudi 1977 (Cambridge 1965) pp 462-496
CIPollA 1974 C M CIPollA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna nMulino 1974
CIpollA 1997 C M CIPOllA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna nMUlino 1997 (6 ed riveduta)
CORRITORE 2000 R P CoRRITORE La naturale abbondanza del Montovano Produshyzione mercato e c01isumi granari a Mantova in etagrave moderna Pavia Universitagrave di Pavia 2000
CORIONBSI 1991 A CORIONBSI Sulla conservazione dei cereali nellItagravelia medioevale Lavoro e tecniche nelle tesnmonlanze laziali (secc XIII-XV) in Rivista di storia dellagricoltura XXXI 1991 l pp 33-49
DELLA VALENTINA 1992 M DELLA VALENTINA I mestieri del pane a ~nezia tra 600 e 700 in Atti dellIstituto [Veneto di Scienze Lettere ed Arti Classe di scienze morali lettere ed arti CL 1991-92 pp 113-217
DIRLMEIER 1984 U DIRLMEIER le condizioni materiali dellesistenza nelle cittagrave tedeshy sche del Basso Medioevo ~iente esterno reddito consumi in Aristocrazia citshy
tadina e ceti popolari nel tprdo Medioevo in Italia e in Germania (a cura di Reinhard Elze e Gina Fasoli) Bologna Societagrave editrice il Mulino 1984 pp 79shy122
FORNASIN 1999 A FORNASIN Il pzercatodei grani di Udine Indagine per una storia dei prew in Friuli (secoli XfI-XVIII) Nota di ricerca del Dipartimento di Scienshyze Statistiche dellUniversit4 degli Studi di Udine 4 1999 pp 1-24 ora in lo La Patria del Friuli in etagrave 1fIOderna Saggi di storia economica Udine Forum 2000 pp 33-60
GRENDI 1986 E GRENOI Lapprccedilwigionamento dei grani nella Liguria del Seicento libera pratica e annone in iMiscellanea storica ligure Studi in onore di Luigi Bulferetti XVIII 1986 2Jp 1021-1047
GUENZI 1981 A GUENZI Ilfrurnfnto e la cittagrave il caso di Bologna nelletagrave moderna in Quaderni storici XVI ~981 46 pp 153-167
GUENZI 1982 A GUENZI Pane ~fornai a Bologna in etagrave moderna Venezia Marsilio 1982
I
489 500 Renzo P CornIOle
GUBNZI1982 A GUEml Sistema annonario e egraveontrollo sociale a Bologna nei seccediloli XVII e XVIII in E SORI (a cura di) Cittagrave e controllo sociale in Italia fra XVIII e XIX secolo Milano F Angeli 1982 pp 293-306
HICKS [1989] 1 R HIClCS A narlcet theory of money Oxford Oxford Universigravety Press 1989 (trad it Una teoria di mercato della monefa Bologna li Mulino 1992 da cui sigrave cita)
JACOPBITI 1965 N L JACOPBITI Monete e prezzi a Cremona dal XVI al XVlIi secolo Cremona Athenaeum CregravemoneJlSe 1965
KAPLAN 1984S L KAPLAN Provisioning Paris Merchants and Millers in the Grain and Flour Trade during the Eighteenth Century Ithaca-London Cornell Univershysity Press 1984~middot
KULA [1962] W KULA Teoria ekonomiczna ustrojufeudalnego Proba modelu Warshyszawa-Panstwowe WydawnictwoNaukowe 1962 (trad it Teoriagrave economica del sistema feudale Proposta di un modello Tormo EinaUdi 1972 ccedilla cui si cita)
WROUSSE [1933] C-E LABRoussE Esquisse du mouvement des prix et des reverws en France au XVIII siegravecle Paris Eacuteditions des Archives Contemporaines 19842 volI (l ed Paris Librairie Dalloz 1933)
MALANtMA 1976 P MALANiMA Aspetti di mercato e prezzi del grano e della segalea Pisa dal 1548 al 1818 in Ricerche di storia moderna vaL I Pisa Pacini 1976 pp ~n
MANToVA 1430 MwroVA 1430 Pareri a Gian Francesco Gonaga per il governo (a cura di M AQrignaniA M Lorenzoni A Mortari C Mozzarelli) MUltova G~ Arcari 1990
MASSA 1999 PMAssA Annona e corporazioni del settore alimentare ~ Genova orshyganizzazione e conflittualitagrave (XVI-XVIII secolo) in A GUENZI PMAssA A MOIOshyu (a cura di) Corporazioni e gruppi professionali nellItalia moderna MilIllO F Angeli 1999 pp 390-403
MATIoZ7J 1983 1 MiJroZ7J F BOLELLI C CmAsBRA D SABBIONI Il politico e il pane a Venezia (157Q-1650) calmieri e governo della sussistenza in Societagrave e storia VI 198320 pp 271-303
MAzzI RAVEOOI 1983 M T MAzzI S RAVEOGI Gli uogravemini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento Firenze Olscbki 1983
MERONI 1957 U MERONI Cremona fedelissima Ciemona Athenaeum Cremonenshy~~~ _
MBUVRBl 1977 J MEuVRsT Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque LouisXIvI La productiograven des ceacutereacuteales dans la France du XVII et du XVIII siegravecle Paris Mouton -EacuteEHSS19772voll
MBUVRET 1988 J MBtJVRf Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque Louis XIv III Le commerce des gralns et la conjoncture Paris EacuteEHss 1988 2 volI
PtCClNNI 1976 G PtCClNNl Wta contagravedina in una capanna dei dintorni di Siena (1250) in ~Archeologia medievale m 1976 pp 395-399
PlNIO 1978 G PINTOII Libro del BiaPaiolo Carestie e annona a Firenze dalla metagrave del 200 al 1348 Fire~ Olscbki 1978
PiNTO 1982 G PtNro La Toscana nel tardo Medioevo Ambiente economia rurale societagrave Fllenze Sansoni 1982
PtRENNE [1933J H PIRENNB La civilisation occidentale au Moyen Age du XIe au mishylieu du XVe siegravecle Paris PUF 1933 (trad it Storia economica e sociale del Meshydioevo Milano Garzanti 1967 da cui si cita)
Lacostituticne di scorte granarie pubbliche e la politica economiegravea degli stati
redigravestribuzione sostenibile dei beni di sussistenza egrave ricercata in questo cielo da quegli stessi particolari che ~amaldeggiano nella produzione negli scambi nei consumi e che costituiscono il nerbo della classe di governo Le scorte pubbliche rappresenteshyrebbero in questa prospettiva un presidio civico e un risltCimento politico e morale ai cOl1ponenti della comunitagrave spossessati delbene supremo dellautarchia alimentare
Resta infine latente unidea del magazzmo pubblico come quasi-mercato cioegrave come luogo volto (1) a risolvere i fa1limentiinfo~vi della piazza del mercato (in meacuterito alle disponi~ilitagrave alle caratteristiche del prodotto alle condizioni di vendita della merce) (2) a ridimensionare lalea per agricoltori consumatori poveri artigiani del comparto alimentare (3) a sostenere i consumi e i profitti privati m funzione anticicli ca in una prospettiva Ilpn meram~nte congiunturale Si tratta in questo caso di un orshyganizzaZionepienattiCnte razio~e Che non opera in maniera saltuaria e riflessa ma in modo continuativo secondo obifttili prefissati di allocazione dei beni primari li funshyzionamento dellacanovagrave (il magazzino pubblico) si porrebbe come strumento inteshygrativo ma no~~igraventeramente so~titutivo delloperare della piazza Si tratterebbe di unaforma di mercato distinta dalla p~ del mercato considerata in seacute e per seacute cosigrave come dallegraveOOmpravendite effetttlate nei solari privati o dalla mera centrallzzazione e redistribuzione di derrate con fi~alitagrave umanitarie La canova rappresenterebbe in tal modo uno dei possibili meccaoi~ di governo delle trllls3ZIgrave~ni locali per risolvere i problemi deUapprovvigionameIto senza intaccare certi interessi di classe (dei proshyprietari ma anche del popolo grasso) S da essere prescelta da autoritagrave e gruppi domishynanti come struttura complementare della piazza del mercato incerti contestiprodutshytivi ed economici La suasacrilizzazione perciograve non esclude la possibilitagrave di un ritorno alle sole compravendite qella piazza e dei solari privati - una volta invertishytosi il trend o spirate le condizioqi economiche della sua istituzionalizzazione
La problematizzazione esorc~ una liquidazione semplicistica del problema delle scorte gran8rle in etagrave pre-industriUgravee nel nome di una loro presunta irrazionalitagrave eco- nomica per il compito di assi~ la sussistenza della popolazione
Le pagine che segUono sono rintroduzione a un lavoro in corso volto a offrire un interpretazione generale di tal~ capitolo fondamentale della politica economica dei governi
in
etagrave pre-industriale
2 SE UN MONDO SENZA SCORTE Egrave INCONGRUO cm Egrave OPPORTUNO CHE LEgrave DETENGA
Nei fatti nel settore granarlo CQni vincoli dell etagrave pre-industriale in tema diprodutshytivitagrave energia trasporti non ha s~nso ipotizzare un mondo senza scorte Se il mercato del grano egrave - come nellEuropa medievale e moderna - un sjstema tendenzialmente chiuso
ad ogni raccolto nuove offe~ aniv(erannol sul mercato mentre la domanda si mant[erragrave] relativamente costantt nel corso dellanno Qualcuno dunque [dovragrave] ~ere delle scorte che saranno elevate ~ubito dopo il raccolto e poi via via minori fino aragshygiungere un livello minimo in prpssimitagrave del successivo raccolto (HICICS [19891 31)
Nella loro forma piugrave sempliceI tali scorte saranno legate allora alla periodi~itagrave anshynuale del ciclo agricolo (che a1iplenta il movimento stagionale dei prezzi ccedilfr LAshyBROlJSSE [1933] 157-66) il loro livello saragrave elevato allindomani del principiLle racshy
501 488 Renzo P Corritore
povero ammassograve nella propria dimora scorte di grano carne ~alata sale candele ecc e la medesima cosa fece lo Stato Nel periodo feudale non venne mai meno nel castello del signore labitudine di tenere da parte grosse scorte per i periodi di emergenza Sucshycessivamente le autoritagrave comunali predisposero il magazzinaggio di grosse derrate specie di grano da rivendere a basso prezzo in periodi di emergenza e nello stesso tempo si preoccuparono di prevenire un indebito accumulo di scorte da parte di specushylatori privati Nelle economie medievali gli stock di derrate di prima necessitagrave rappreshysentarono pertanto una delle piugrave importanti forme di investimento pubblico e privato (CIPOLLA (1965] 468)
Nella prima versione del manualeacute invece fino allinserimento nel 1997 del nuovo capitolo dedicato alla politica economica nell etagrave pre-mdustriale il punto di vista preshyvalente era quello microeconomico entro il perimetro stretto dellindividualismo meshytodologico
Le scorte costano e costano doppiamente Esse implicano il costo diretto che egrave rapshypresentato dal costo del magazzinaggio edal deterioramento eventuale del pr04otto o di parte di esso Se luomo daffari finanzia la costituzione delle scorte con danaro preso a prestito il costo diretto include anche il tasso di interesse pagato Se luomo daffari finanzia con capitale proprio la costituzione delle scorte il costo delle scorte deve inshycludere un costo-opportunitagrave e cioegrave il mancato rendimento (tIllU1cato tasso dinteresse attivo) del capitale finanziario impiegato (CIPOLLA 1974 154)
Le ragioni della costituzione e del mantenimento di scorte alimentari da parte delshylautoritagrave pubblica diventavano unicamente ragioni morali (umanitarie e di buona amministrazione) o di opportunitagrave politica (la fame era la piugrave frequente ligraveausa di sommosse e furori popolari) (CIPOLLA 1974 74)
Nel 1997 si riammetteva dunque linterpretazione originaria della costituzione di scorte pubbliche come strumento di riequilibrio del mercato senza peraltro rinnegare le considerazioni sulla valenza statica di tale forma di investimento per gli agenti economici privati
In merito allutilitagrave economica e al significato delle scorte in etagrave pre-industriale Cishypolla non espresse perciograve sempre lo stesso punto di vista La rassegna delle posizioni da lui assunte anzi permette di individuare tre approcci e tre giudizi costitutivamente diversi sulla funzione delle scorte granarie nellepoca pre-industriale
In prima approssimazione laccumulazione di scorte alimentari mostra il carattere fondamentalmente difensivo delle scelte degli agenti economici pubblici e privati in etagrave pre-industriale La paura la tradizione la superstizione li induce a tabuizzare il rischio la speculazione linvestimento nella produzione e nella distribuzione dei beni essenziali alla vita e ad aderire intimamente a un ideale di economia e societagrave stazionarie aggravando con la norma sociale le istituzioni il comportamento indivishyduale e collettivo leffetto dei condizionamenti materiali delleconomia pre-industriashyle (bassa produttivitagrave agricola alti costi di v~sporto modesta efficienza energetica) esponendo ancor di piugrave la comunitagrave umana ai degravemoni della natura
La seconda interpretazione rigetta luniversale imperio dellhomo oeconomicus rishyscoprendo leteronomia dei fini dellagire economico degli uomini nelletagrave pre-inshydustriale Ia politica economica dello Stato o-delle autoritagrave non persegue puri scopi economici lintegritagrave del corpo sociale fin nelle sue cellule elementari (persone e famiglie) deve essere assicurata secondo i principi e la prassi di uneconomia morale che SOVJa5ta leconomia regolata dal mercato spersonalizzata e antipopolare Una
La costituzione di scorte grantlTie pubbliche e la poligravetigraveca economica degli stati
PuLT QUAGUA 1984 A M PULT QUAGUA Mercato dei prodotti agricoli e magistratushyre annonarie a Pisa nelletagrave moderna in Ricerche di storia moderna a cura di M Mirri voI III Pisa Pacini 1984 pp 57-141
PULT QUAGLIA 1990 A M PULT QUAGLIA Per provvedere ai popoli Il sistema anshynonario nella Toscana dei Medici Firenze Olschki 1990
SERUO 1994 S SERLIO Architettura civile Libri sesto settimo e ottavo nei manoscritshyti di Monaco e Vienna (a cura di F P Fiore) Milano TI Polifi10 1994
SIGAlIT 1985 F SIGAlIT Questions deacuteconomie agrave propos des politiques ceacutereacutealiegraveres et de stockage in Les techniques de conservation des grains agrave long terme leur rale dans la dynamique des systegravemes de cultures et des socieacuteteacutes (sous la direction de M Gast F Sigaut et C Beutler avec la collaboratlon de O Bllchsenschutz) voI III 2 Paris Eacuteditionsdu CNRS 1985 pp 597-606
SMITH [1776 A SMITH An inquiry into the nature and causes ojthe wealth ojnations London W Strahanand T Cadell 17762 volI (trad it Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni Milano A Mondadori 1977 2 volI da cui
si cita) STATlITlBoNACOLSIANI [1313] STATUTI BONACOLSlANl (a cura di E Dezza A M Lorenshy
zoni M Vaini) Mantova GArcari 2002 STATUTI GONZAGHESCHI [1404] STATUTI GONZAGHESCHI presso la Biblioteca comunale di
Mantova ms FV 11 [775]VECCHIATO 1979 F VOCCHIATO Pane e politica annonaria in Terrajerma veneta tra
secolo XV e secolo XVIII (Il caso di Verona) Verona Stamperia Zendrini 1979 ZANETTI 1963 D ZANETTl Contribution agrave leacutetude des structures eacuteconomiques lapshy
provisiQnnement de Pavie au XVI siegravecle in Annales ESC XVIII 1963 1 pp 44-62 ora in lo Fra le antiche torri Scritti di storia pavese Pavia Universitagrave di Pavia 2000 pp 165-182
ZANETTl 1964 D ZANEITI Problemi alimentari di una economia preindustriale Ceshyreali a Pavia dal 1398 al 1700 Torino P Borlnghieri 1964
ZUG TUCCI 1990 H ZUG TuCCI Le derrate agricole problemi materiali e concezioni mentali della conservazione in Lambiente vegetale nellalto Medioevo XXXVII Settimana di studio del Centro italiano di studi sullalto Medioevo (30 marzo-5 aprile 1989) Spoleto Centro italiano di studi sullalto Medioevo 1990 voI n pp 865-902
491 498 Renzo P Comtore
alla spartizione dei proventi derivanti dalla vendita e dal commercio del grano shylemolumento grandissimo - di chi doveva poi fruire della redistribnzione di tale ricchezza Tale norma avvantaggiava i possidenti cittadini e i gentiluomini ptivilegiashyti in grado di ottenere le tratte di esportazione Sul piano dellappropriazione essi erano in condizione di mettere fuori gioco gli altri possessori che producev~o eccedenze nel Dominio poicheacute si accresceva Igravea loro forza contrattuale e la loro capacitagrave di occUpare i canall commerciali piugrave redditizi Sul piano della commercialiZzazione gli stessi fruivashyno dello smantellamento della rete dintennediazione rappresentata dai fornai Per i rushystici significava perdere un collegamento essenZiale con la cittagrave ed essere emarginati dal mercato urbano nelle campagne o sul broletto di Mantova essi non trovarono piugrave i trashydizionali interlocutori (CORBlJ9RE 2000 228 231-2)
Nel caso di Bologna terra strutturalmente deficitaria e cittagrave dalla vocaiione manishyfatturie~ si costringeva i fornai ad acquistare formenti terrieri presso i solari privati in cittagrave proibendogligrave lincetta nel contado autorizzandoli ad acquistareformentiforeshystieri al di fuori delle mura cittadine presso i sensati da grqno solo a patto che fosseshyro stati smaltiti i grani cittadini a un prezzo talora superiore a quello dei grani dimshyportazione (GUlNZI1982A35 52-3)
Nella Toscana dei Medici il diritto allincetta nel contado venne concesso ai fornai in periodo di bassa congiuntura (in particolare dagli anni Trenta del Seicegravento)Per sostenere i prezzi interni in tal caso essi restavano gli interlocutori principali dei granshydi proprietari semplicemente spostando la loro principale fonte di approvvigionashymento dai solari dei particolari in cittagrave ai granai decentrati delle grandi aziende agrishycole oppure ai mercati rurali su cui affluiva la produzione cerealicola delle grandi fattorie (PuLT QUAOUA 1984 86-9 PuLTQUAOUA 1990 100 106-7)
Laddove non vi egrave come invece succede a Genova una diretta ingerenza del potere pubblico nella vita della corporazione (MAsSA 1999) i fumai di cittagrave - nonostante i lacci e lacciuoli normativi e il lavoro prevalentePlente manuale svolto neiloro laboshyratori - erano dei veri imprenditori dipendenti per il loro profitto - noininalmente stabilito per legge - dalla produttivitagrave del lavoro e dalla dotazione tecnica e finanziaria delle imprese Di ciograve fa fede la grande sperequazione esistente fra le aziende speciashylizzate nena fabbricazione del pane venale in cittagrave (AYMARD 1966 75 VECCHltltJQ 1979 82-3 GUlNZI1982 77 segg PuLT QUAOUA 1984 100 102-3) NellItalia delshyletagrave moderna questi artigiani-imprenditori della filiera del grano trattavano insieme
afarinaifarinaiolifarinottifondachierifontechierifidelariformentinari lasagneshyri maccaronari torallari vermicellari ecc fra il 40 e il 70 per cento del frumento consumato in Cittagrave nelle annate normali (CoRRJTORE 2000 126 segg) e ~ino al 100 per cento nelle annate di carestia (Puu QUAOUA 1984 98-9)
In una ricognizione delle asimmetrie informative del mercato non cegrave gruppo quale i fornai che possa integraverpretare la parte dell agente economico onnisciente Se dunque i regolamenti annonari tendevano a regolare minuziogravesamente la collocazione il volushyme e la durata delle loro scorte cosi come disponevano per gli altri artigiani della fishyliera era per neutralizzare il carattere potenzialmente eversivo di tale accantonamenshyto per i proprietari-venditori Prima ancora che per i consumatori-acquirenti n livello delle scorte rinforzava o attenuava il rischio di monopsonio da parte dei pistores piugrave potenti e facoltosi cosigrave come eventuali tentazioni da parte della categoria di esercitare un dominio egoistico sul mercato del pane (MAITOZZl1983 298)
Sarebbe quindi un errore concepire le scorte dei fornai come entropica allocazione di capitale che sconta lincertezza futura esse venivano gestite secondo criteri di rashyzionalitagrave economica e secondo la migliore efficienza tecnica nonostante i vincoli imposti alla lievitazione degli stock dalle disposizioni annonarie
lA costituzione di scorte granarie pubbliche e la politica economica degli stati
vimini paglia o canne intrecciate (come ceste stuoiecannizzi) in terracotta (addirittura anfore) piuttosto che di tessuto (i sacchi costavano troppo) (PICCINNl1976 397 MAzzA RAvEGol 1983 174-5 Zoo Toce 1990 893-4 COIiITONES11991 35n-36n)
Nella casa del piccolo produttore o del titolare di un piccolo possesso il penw (la scorta domestica) difficilmente eccedeva il consumo famigliare chi fortunato raccoshyglieva piugrave dell annona famigliare e di quanto gli serviva per il campo era spinto a venderselo nei mesi immediatamente successivi alla mietitura e alla trebbiatura per necessitagrave di denaro ma anche per la difficoltagrave di stoccare e conservare il prodotto in condizioni ottimali (MEuvRET 1988 17-9 PuLT QUAOUA 1984 88) e figravenanco per ridurre il rischio di vederselo soffiare da vagabondi e malintenzionati In questo caso in presenshyza di eccedenze (ma probabilmente anche in assenza) il bisogno di liquiditagrave e lalea cospiravano nel ridl1ITe ai minimi termini le scorte giagrave allindomani del raccolto In caso alternativo il contadino che non egrave - ripete Jean Meuvret - un homme daffaires quanshyto un homme de peur concepiva la sua riserva come un fondo di previdenza sul racshycolto futuro da non immettere sul mercato se non nel caso dellapprossimarsi di una messe sicura secondo una logica economica a contrario (MEUVRET 1988 19 e 147)
Era Jl~tente la disparitagrave fra i produttori non solo fra chi era in possesso di eccedenshyze e chi non lo era ma piugrave anqgtra fra chi poteva scegliere in virtugrave di una maggiore capienza economica e unadeguata dotazione tecnica - il mercato piugrave favorevole per i propri grani (il periodo di saldatura dei raccolti) e chi invece li cedeva troppo presto o in controtempo a livelli non ottimali
Nella gerarchia delle abitazioni rurali -- in quel vero e proprio saggio di sociologia che egrave il sesto libro del DeArchitectura di Sebastiano Serlio (scritto fra il 1537 eil 1555 inedito per tutto levo moderno) -- per trovare case attrezzate di granaio occorshyreva ascendere sino alla magione del basso mercante o cittadino fuori della cittagrave (SERLlO 1994 43 segg anche per le successive informazioni) Condizione di cui non potevano fregiarsi invece i ricchi contadini in ~essuno dei tre gradi possibili di ricshychezza al massimo la loro casa poteva essere attrezzata di portici per ricoverare le biade e di unaia per batterle segni di distinzione giagrave fra i mediocri contadini Fra questi perograve avrebbero potuto avvalersene soltanto i fortUIgravelati et di beni et di famishyglia (3deg grado di mediocritagrave) nforno per cuocere il pane e una cantina per conservashyre il vino invece li si sarebbe trovati a partire dai piugrave accomodati fra i poveri contashydini cioegrave al 4deg gradino della scala sociale alla cui base erano da collocare i poveri mendichi con vii capanna (10 grado di povertagrave) i salariati che vivevano delle [loro] fatiche avendo un puoco di terreno (2deg grado di povertagrave) i poveri con qualche beshystiuola et massimamente de buOvi possessori di una stalletta congiunta con la casa 0deg grado di povertagrave)
In sintesi nelle campagne delletagrave pre-industriale pochi avevano scorte pochissimi erano in grado di ricoverarle in un solaro privilegiatissimo chi le incanevava per speculare Dunquefra i conta4ini se si esclude quanto celato nella madia o nella dishyspensa le scorte erano un pri~ilegio di pochi nSerlio nato intorno al 1475 insiste sullimpoverimento delle class~ rurali intervenuto fra gli anni della sua giovinezza e quelli della vecchiezza in cui scrive Sotto il titolo Dellabitazione del ricco contadishyno per tre gradi di ricchezza si preoccupa di puntualizzare
bencheacute al di dogi non se n~ truovi piugrave de tali merceacute delle discordie et di gli animi fieri et ostinati alla vendetta onde per tal cagioni et per le continue guerre et anche pei citadini divoratori de gli altrui beni che con le usure con glinganni con le rapine gli bano impoveriti (SERUO 1994 ~8)
490 RellOP CorrilOle
colto (agosto-settembre-ottobre) e invia di esaurimento almomento della saldatura dei raccolti (aprile-maggio-giugno )1A questo proposito nota Franccedilois Sigaut
Le stockage agrave court terme (moins dune campagne) reacutepond agrave la neacuteCessiteacute cIeacute concilier une offre variable et une demande constante mais toutes deux reacutegulieacuteres et preacutevisibles dans la
pratique il est consideacutereacute comme tiiisant pame du processus ordinaire de la production et ne pose agrave ce titre que desproblegravernes doptimisation assez simples (SlOAUI 1985 602)
La discussione generale sulla razionalitagrave economica delle scorte alimentari in etagrave pre-industriale puograve allora essere ridotta alla fonnulaiione e allo scioglimento di due
semplici quesiti 1 Accertato che laccantonamento digram per la periodicitagrave annuale del ciclo agricoshy
lo epet i vincoli tecnici di un rifomimento spazialmente allargato egrave inevitabile chi egrave conveniente che conservi le scorte chi produce o chi commercia il contadino o il mercante lapossidenzagrave o il popolo i particolari o il pubblico E qual egrave la realtagrave effettiva
2 Se le forme di distribUzione economicamente razionale sono plurali in quale conshytesto e in omaggio a quali interessi piugrave utile il sistema della canova rispetto al sistema delll piazza del mercato e dei solari privati
3 SULLADISTRIBUZIONE DEL GRANO NELUETAgrave PRE-INDUSTRIALE E LA STRUTTURA DELLE SCORTE NEI TERRITORI ITALIANI
Raramente le case contadine erano dotate di attrezzature per la conservazione dei cereali piugrave che elementari Nelle campagne toscane del Quattrocento dunquein unetagrave favorevole al reddito contadino in una regione fra le piugrave ricche dellEuropa pre-indushystriale
pochissime case contadine disponevano del granaio vero e proprio alcune avevano una cella che poteva servire allo stesso scopo ma la maggior parte di quelle abitazioni era priva di spazi destinabili esclugravesivamente alla conservazione dei cereali Perciograve i contenitori dei grani arche casse sacchi bugnole - dovevano trovare posto nelle cucine o nelle camere CMA= RAVEGGI 1983 174)
Le ridotte capacitagrave patrimoniali e reddituali della grande maggioranza dei produttori facevano sIgrave che fosse ampiamente invalso nella conservazione domestica dei grani limshypiego di contenitori in legno (come arche casse botti bugnole tini tinelle corbelli)in
Riguardo ai passi evidenziati di Zanetti e Cipolla egrave neCessario osservare che la principale atteshystazione sullesistenza di stock detenuti da privati che esorbitassero ilfabbisognostagionale tali da essere classificati come immobili=zione di ricchezza (Zanetti) o come beni capitale (Cipolla) a unanalisi piugrave fine si rivela fallace o non direttamente utilizzabile La propalazione dei grani effetshytuata a Pavia fra ilimiddot e il5 maggio 1555 che egrave il fondamento di entrambi i giudizinon mostra una somma di derrate realmente eccedente il fabbisogno delle famiglie per il periodo che manca allarri_ vo dei grani novelli sulla piazza pavese Daltra parte lastessa natura dellistituto della propalazioshyne dei grani cioegrave della denljncia obbligatoria delle scorte da parte dei particolari una misura demergenza decisa in momenti critici dellapprovvigionamento cittadino affiancata quellanno dalshylispezione diretta presso le case dei privati da parte di deputati straordinari avrebbe dovuto consishygliare una maggiore cautela nella sua utilizzazione per individuare regolaritagrave di carattere generale delleconomia pre-industriale
499 La costituzione di scorte granarie pubbliche e la ptlitica ecoMmica degli stati
FONTI
ABEL [1966) W ABEL Agrarkrisen undAgra~kJJnjunktur Eine Geschichte der londshy und Erniihrungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter Hamburg
und Berlin Paul Parey 19662 (la ed -1935 trad it Congiuntura agraria e crisi agrarie Storia dellagricoltura e della produzione alimentare nellEuropa centrashyle dal XIII secolo alletagrave industriale Torino Einaudi 1976 da cui si cita)
AG ARCHIVIO GoNZAGA presso lArchivio di Stato di Mantova AuFANO 1996 E AuFANO Il grano il pane e la politica annonaria a Napoli nel Setshy
tecento Napoli ESI 1996bull AYMARO 1966 M A YMARO Wmise Raguse et le commerce du bMpendant la seconde
moitieacute du XVI siegravecle Pans SEVPEN 1966 CATIINI 1984 M CATl1NI I contadini di San Felice Metamorfosi di un mondo rurale
nellEmilia delletagrave modernIgravel Torino Einaudi 1984 CESTARl 1794 p CESTARI Saggio storico dei Fondachi delle farine di Chioggia e
Pellestrina Venezia A Zatta 1794 CIPOllAJ1965] C M CIPOllA La politica economica dei governi V La penisola
italigraveana e la penisola iberica in Storia economica Cambridge m La cittagrave e la politica economica nel Medioevo Torino Einaudi 1977 (Cambridge 1965) pp 462-496
CIPollA 1974 C M CIPollA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna nMulino 1974
CIpollA 1997 C M CIPOllA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna nMUlino 1997 (6 ed riveduta)
CORRITORE 2000 R P CoRRITORE La naturale abbondanza del Montovano Produshyzione mercato e c01isumi granari a Mantova in etagrave moderna Pavia Universitagrave di Pavia 2000
CORIONBSI 1991 A CORIONBSI Sulla conservazione dei cereali nellItagravelia medioevale Lavoro e tecniche nelle tesnmonlanze laziali (secc XIII-XV) in Rivista di storia dellagricoltura XXXI 1991 l pp 33-49
DELLA VALENTINA 1992 M DELLA VALENTINA I mestieri del pane a ~nezia tra 600 e 700 in Atti dellIstituto [Veneto di Scienze Lettere ed Arti Classe di scienze morali lettere ed arti CL 1991-92 pp 113-217
DIRLMEIER 1984 U DIRLMEIER le condizioni materiali dellesistenza nelle cittagrave tedeshy sche del Basso Medioevo ~iente esterno reddito consumi in Aristocrazia citshy
tadina e ceti popolari nel tprdo Medioevo in Italia e in Germania (a cura di Reinhard Elze e Gina Fasoli) Bologna Societagrave editrice il Mulino 1984 pp 79shy122
FORNASIN 1999 A FORNASIN Il pzercatodei grani di Udine Indagine per una storia dei prew in Friuli (secoli XfI-XVIII) Nota di ricerca del Dipartimento di Scienshyze Statistiche dellUniversit4 degli Studi di Udine 4 1999 pp 1-24 ora in lo La Patria del Friuli in etagrave 1fIOderna Saggi di storia economica Udine Forum 2000 pp 33-60
GRENDI 1986 E GRENOI Lapprccedilwigionamento dei grani nella Liguria del Seicento libera pratica e annone in iMiscellanea storica ligure Studi in onore di Luigi Bulferetti XVIII 1986 2Jp 1021-1047
GUENZI 1981 A GUENZI Ilfrurnfnto e la cittagrave il caso di Bologna nelletagrave moderna in Quaderni storici XVI ~981 46 pp 153-167
GUENZI 1982 A GUENZI Pane ~fornai a Bologna in etagrave moderna Venezia Marsilio 1982
I
489 500 Renzo P CornIOle
GUBNZI1982 A GUEml Sistema annonario e egraveontrollo sociale a Bologna nei seccediloli XVII e XVIII in E SORI (a cura di) Cittagrave e controllo sociale in Italia fra XVIII e XIX secolo Milano F Angeli 1982 pp 293-306
HICKS [1989] 1 R HIClCS A narlcet theory of money Oxford Oxford Universigravety Press 1989 (trad it Una teoria di mercato della monefa Bologna li Mulino 1992 da cui sigrave cita)
JACOPBITI 1965 N L JACOPBITI Monete e prezzi a Cremona dal XVI al XVlIi secolo Cremona Athenaeum CregravemoneJlSe 1965
KAPLAN 1984S L KAPLAN Provisioning Paris Merchants and Millers in the Grain and Flour Trade during the Eighteenth Century Ithaca-London Cornell Univershysity Press 1984~middot
KULA [1962] W KULA Teoria ekonomiczna ustrojufeudalnego Proba modelu Warshyszawa-Panstwowe WydawnictwoNaukowe 1962 (trad it Teoriagrave economica del sistema feudale Proposta di un modello Tormo EinaUdi 1972 ccedilla cui si cita)
WROUSSE [1933] C-E LABRoussE Esquisse du mouvement des prix et des reverws en France au XVIII siegravecle Paris Eacuteditions des Archives Contemporaines 19842 volI (l ed Paris Librairie Dalloz 1933)
MALANtMA 1976 P MALANiMA Aspetti di mercato e prezzi del grano e della segalea Pisa dal 1548 al 1818 in Ricerche di storia moderna vaL I Pisa Pacini 1976 pp ~n
MANToVA 1430 MwroVA 1430 Pareri a Gian Francesco Gonaga per il governo (a cura di M AQrignaniA M Lorenzoni A Mortari C Mozzarelli) MUltova G~ Arcari 1990
MASSA 1999 PMAssA Annona e corporazioni del settore alimentare ~ Genova orshyganizzazione e conflittualitagrave (XVI-XVIII secolo) in A GUENZI PMAssA A MOIOshyu (a cura di) Corporazioni e gruppi professionali nellItalia moderna MilIllO F Angeli 1999 pp 390-403
MATIoZ7J 1983 1 MiJroZ7J F BOLELLI C CmAsBRA D SABBIONI Il politico e il pane a Venezia (157Q-1650) calmieri e governo della sussistenza in Societagrave e storia VI 198320 pp 271-303
MAzzI RAVEOOI 1983 M T MAzzI S RAVEOGI Gli uogravemini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento Firenze Olscbki 1983
MERONI 1957 U MERONI Cremona fedelissima Ciemona Athenaeum Cremonenshy~~~ _
MBUVRBl 1977 J MEuVRsT Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque LouisXIvI La productiograven des ceacutereacuteales dans la France du XVII et du XVIII siegravecle Paris Mouton -EacuteEHSS19772voll
MBUVRET 1988 J MBtJVRf Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque Louis XIv III Le commerce des gralns et la conjoncture Paris EacuteEHss 1988 2 volI
PtCClNNI 1976 G PtCClNNl Wta contagravedina in una capanna dei dintorni di Siena (1250) in ~Archeologia medievale m 1976 pp 395-399
PlNIO 1978 G PINTOII Libro del BiaPaiolo Carestie e annona a Firenze dalla metagrave del 200 al 1348 Fire~ Olscbki 1978
PiNTO 1982 G PtNro La Toscana nel tardo Medioevo Ambiente economia rurale societagrave Fllenze Sansoni 1982
PtRENNE [1933J H PIRENNB La civilisation occidentale au Moyen Age du XIe au mishylieu du XVe siegravecle Paris PUF 1933 (trad it Storia economica e sociale del Meshydioevo Milano Garzanti 1967 da cui si cita)
Lacostituticne di scorte granarie pubbliche e la politica economiegravea degli stati
redigravestribuzione sostenibile dei beni di sussistenza egrave ricercata in questo cielo da quegli stessi particolari che ~amaldeggiano nella produzione negli scambi nei consumi e che costituiscono il nerbo della classe di governo Le scorte pubbliche rappresenteshyrebbero in questa prospettiva un presidio civico e un risltCimento politico e morale ai cOl1ponenti della comunitagrave spossessati delbene supremo dellautarchia alimentare
Resta infine latente unidea del magazzmo pubblico come quasi-mercato cioegrave come luogo volto (1) a risolvere i fa1limentiinfo~vi della piazza del mercato (in meacuterito alle disponi~ilitagrave alle caratteristiche del prodotto alle condizioni di vendita della merce) (2) a ridimensionare lalea per agricoltori consumatori poveri artigiani del comparto alimentare (3) a sostenere i consumi e i profitti privati m funzione anticicli ca in una prospettiva Ilpn meram~nte congiunturale Si tratta in questo caso di un orshyganizzaZionepienattiCnte razio~e Che non opera in maniera saltuaria e riflessa ma in modo continuativo secondo obifttili prefissati di allocazione dei beni primari li funshyzionamento dellacanovagrave (il magazzino pubblico) si porrebbe come strumento inteshygrativo ma no~~igraventeramente so~titutivo delloperare della piazza Si tratterebbe di unaforma di mercato distinta dalla p~ del mercato considerata in seacute e per seacute cosigrave come dallegraveOOmpravendite effetttlate nei solari privati o dalla mera centrallzzazione e redistribuzione di derrate con fi~alitagrave umanitarie La canova rappresenterebbe in tal modo uno dei possibili meccaoi~ di governo delle trllls3ZIgrave~ni locali per risolvere i problemi deUapprovvigionameIto senza intaccare certi interessi di classe (dei proshyprietari ma anche del popolo grasso) S da essere prescelta da autoritagrave e gruppi domishynanti come struttura complementare della piazza del mercato incerti contestiprodutshytivi ed economici La suasacrilizzazione perciograve non esclude la possibilitagrave di un ritorno alle sole compravendite qella piazza e dei solari privati - una volta invertishytosi il trend o spirate le condizioqi economiche della sua istituzionalizzazione
La problematizzazione esorc~ una liquidazione semplicistica del problema delle scorte gran8rle in etagrave pre-industriUgravee nel nome di una loro presunta irrazionalitagrave eco- nomica per il compito di assi~ la sussistenza della popolazione
Le pagine che segUono sono rintroduzione a un lavoro in corso volto a offrire un interpretazione generale di tal~ capitolo fondamentale della politica economica dei governi
in
etagrave pre-industriale
2 SE UN MONDO SENZA SCORTE Egrave INCONGRUO cm Egrave OPPORTUNO CHE LEgrave DETENGA
Nei fatti nel settore granarlo CQni vincoli dell etagrave pre-industriale in tema diprodutshytivitagrave energia trasporti non ha s~nso ipotizzare un mondo senza scorte Se il mercato del grano egrave - come nellEuropa medievale e moderna - un sjstema tendenzialmente chiuso
ad ogni raccolto nuove offe~ aniv(erannol sul mercato mentre la domanda si mant[erragrave] relativamente costantt nel corso dellanno Qualcuno dunque [dovragrave] ~ere delle scorte che saranno elevate ~ubito dopo il raccolto e poi via via minori fino aragshygiungere un livello minimo in prpssimitagrave del successivo raccolto (HICICS [19891 31)
Nella loro forma piugrave sempliceI tali scorte saranno legate allora alla periodi~itagrave anshynuale del ciclo agricolo (che a1iplenta il movimento stagionale dei prezzi ccedilfr LAshyBROlJSSE [1933] 157-66) il loro livello saragrave elevato allindomani del principiLle racshy
501 488 Renzo P Corritore
povero ammassograve nella propria dimora scorte di grano carne ~alata sale candele ecc e la medesima cosa fece lo Stato Nel periodo feudale non venne mai meno nel castello del signore labitudine di tenere da parte grosse scorte per i periodi di emergenza Sucshycessivamente le autoritagrave comunali predisposero il magazzinaggio di grosse derrate specie di grano da rivendere a basso prezzo in periodi di emergenza e nello stesso tempo si preoccuparono di prevenire un indebito accumulo di scorte da parte di specushylatori privati Nelle economie medievali gli stock di derrate di prima necessitagrave rappreshysentarono pertanto una delle piugrave importanti forme di investimento pubblico e privato (CIPOLLA (1965] 468)
Nella prima versione del manualeacute invece fino allinserimento nel 1997 del nuovo capitolo dedicato alla politica economica nell etagrave pre-mdustriale il punto di vista preshyvalente era quello microeconomico entro il perimetro stretto dellindividualismo meshytodologico
Le scorte costano e costano doppiamente Esse implicano il costo diretto che egrave rapshypresentato dal costo del magazzinaggio edal deterioramento eventuale del pr04otto o di parte di esso Se luomo daffari finanzia la costituzione delle scorte con danaro preso a prestito il costo diretto include anche il tasso di interesse pagato Se luomo daffari finanzia con capitale proprio la costituzione delle scorte il costo delle scorte deve inshycludere un costo-opportunitagrave e cioegrave il mancato rendimento (tIllU1cato tasso dinteresse attivo) del capitale finanziario impiegato (CIPOLLA 1974 154)
Le ragioni della costituzione e del mantenimento di scorte alimentari da parte delshylautoritagrave pubblica diventavano unicamente ragioni morali (umanitarie e di buona amministrazione) o di opportunitagrave politica (la fame era la piugrave frequente ligraveausa di sommosse e furori popolari) (CIPOLLA 1974 74)
Nel 1997 si riammetteva dunque linterpretazione originaria della costituzione di scorte pubbliche come strumento di riequilibrio del mercato senza peraltro rinnegare le considerazioni sulla valenza statica di tale forma di investimento per gli agenti economici privati
In merito allutilitagrave economica e al significato delle scorte in etagrave pre-industriale Cishypolla non espresse perciograve sempre lo stesso punto di vista La rassegna delle posizioni da lui assunte anzi permette di individuare tre approcci e tre giudizi costitutivamente diversi sulla funzione delle scorte granarie nellepoca pre-industriale
In prima approssimazione laccumulazione di scorte alimentari mostra il carattere fondamentalmente difensivo delle scelte degli agenti economici pubblici e privati in etagrave pre-industriale La paura la tradizione la superstizione li induce a tabuizzare il rischio la speculazione linvestimento nella produzione e nella distribuzione dei beni essenziali alla vita e ad aderire intimamente a un ideale di economia e societagrave stazionarie aggravando con la norma sociale le istituzioni il comportamento indivishyduale e collettivo leffetto dei condizionamenti materiali delleconomia pre-industriashyle (bassa produttivitagrave agricola alti costi di v~sporto modesta efficienza energetica) esponendo ancor di piugrave la comunitagrave umana ai degravemoni della natura
La seconda interpretazione rigetta luniversale imperio dellhomo oeconomicus rishyscoprendo leteronomia dei fini dellagire economico degli uomini nelletagrave pre-inshydustriale Ia politica economica dello Stato o-delle autoritagrave non persegue puri scopi economici lintegritagrave del corpo sociale fin nelle sue cellule elementari (persone e famiglie) deve essere assicurata secondo i principi e la prassi di uneconomia morale che SOVJa5ta leconomia regolata dal mercato spersonalizzata e antipopolare Una
La costituzione di scorte grantlTie pubbliche e la poligravetigraveca economica degli stati
PuLT QUAGUA 1984 A M PULT QUAGUA Mercato dei prodotti agricoli e magistratushyre annonarie a Pisa nelletagrave moderna in Ricerche di storia moderna a cura di M Mirri voI III Pisa Pacini 1984 pp 57-141
PULT QUAGLIA 1990 A M PULT QUAGLIA Per provvedere ai popoli Il sistema anshynonario nella Toscana dei Medici Firenze Olschki 1990
SERUO 1994 S SERLIO Architettura civile Libri sesto settimo e ottavo nei manoscritshyti di Monaco e Vienna (a cura di F P Fiore) Milano TI Polifi10 1994
SIGAlIT 1985 F SIGAlIT Questions deacuteconomie agrave propos des politiques ceacutereacutealiegraveres et de stockage in Les techniques de conservation des grains agrave long terme leur rale dans la dynamique des systegravemes de cultures et des socieacuteteacutes (sous la direction de M Gast F Sigaut et C Beutler avec la collaboratlon de O Bllchsenschutz) voI III 2 Paris Eacuteditionsdu CNRS 1985 pp 597-606
SMITH [1776 A SMITH An inquiry into the nature and causes ojthe wealth ojnations London W Strahanand T Cadell 17762 volI (trad it Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni Milano A Mondadori 1977 2 volI da cui
si cita) STATlITlBoNACOLSIANI [1313] STATUTI BONACOLSlANl (a cura di E Dezza A M Lorenshy
zoni M Vaini) Mantova GArcari 2002 STATUTI GONZAGHESCHI [1404] STATUTI GONZAGHESCHI presso la Biblioteca comunale di
Mantova ms FV 11 [775]VECCHIATO 1979 F VOCCHIATO Pane e politica annonaria in Terrajerma veneta tra
secolo XV e secolo XVIII (Il caso di Verona) Verona Stamperia Zendrini 1979 ZANETTI 1963 D ZANETTl Contribution agrave leacutetude des structures eacuteconomiques lapshy
provisiQnnement de Pavie au XVI siegravecle in Annales ESC XVIII 1963 1 pp 44-62 ora in lo Fra le antiche torri Scritti di storia pavese Pavia Universitagrave di Pavia 2000 pp 165-182
ZANETTl 1964 D ZANEITI Problemi alimentari di una economia preindustriale Ceshyreali a Pavia dal 1398 al 1700 Torino P Borlnghieri 1964
ZUG TUCCI 1990 H ZUG TuCCI Le derrate agricole problemi materiali e concezioni mentali della conservazione in Lambiente vegetale nellalto Medioevo XXXVII Settimana di studio del Centro italiano di studi sullalto Medioevo (30 marzo-5 aprile 1989) Spoleto Centro italiano di studi sullalto Medioevo 1990 voI n pp 865-902
490 RellOP CorrilOle
colto (agosto-settembre-ottobre) e invia di esaurimento almomento della saldatura dei raccolti (aprile-maggio-giugno )1A questo proposito nota Franccedilois Sigaut
Le stockage agrave court terme (moins dune campagne) reacutepond agrave la neacuteCessiteacute cIeacute concilier une offre variable et une demande constante mais toutes deux reacutegulieacuteres et preacutevisibles dans la
pratique il est consideacutereacute comme tiiisant pame du processus ordinaire de la production et ne pose agrave ce titre que desproblegravernes doptimisation assez simples (SlOAUI 1985 602)
La discussione generale sulla razionalitagrave economica delle scorte alimentari in etagrave pre-industriale puograve allora essere ridotta alla fonnulaiione e allo scioglimento di due
semplici quesiti 1 Accertato che laccantonamento digram per la periodicitagrave annuale del ciclo agricoshy
lo epet i vincoli tecnici di un rifomimento spazialmente allargato egrave inevitabile chi egrave conveniente che conservi le scorte chi produce o chi commercia il contadino o il mercante lapossidenzagrave o il popolo i particolari o il pubblico E qual egrave la realtagrave effettiva
2 Se le forme di distribUzione economicamente razionale sono plurali in quale conshytesto e in omaggio a quali interessi piugrave utile il sistema della canova rispetto al sistema delll piazza del mercato e dei solari privati
3 SULLADISTRIBUZIONE DEL GRANO NELUETAgrave PRE-INDUSTRIALE E LA STRUTTURA DELLE SCORTE NEI TERRITORI ITALIANI
Raramente le case contadine erano dotate di attrezzature per la conservazione dei cereali piugrave che elementari Nelle campagne toscane del Quattrocento dunquein unetagrave favorevole al reddito contadino in una regione fra le piugrave ricche dellEuropa pre-indushystriale
pochissime case contadine disponevano del granaio vero e proprio alcune avevano una cella che poteva servire allo stesso scopo ma la maggior parte di quelle abitazioni era priva di spazi destinabili esclugravesivamente alla conservazione dei cereali Perciograve i contenitori dei grani arche casse sacchi bugnole - dovevano trovare posto nelle cucine o nelle camere CMA= RAVEGGI 1983 174)
Le ridotte capacitagrave patrimoniali e reddituali della grande maggioranza dei produttori facevano sIgrave che fosse ampiamente invalso nella conservazione domestica dei grani limshypiego di contenitori in legno (come arche casse botti bugnole tini tinelle corbelli)in
Riguardo ai passi evidenziati di Zanetti e Cipolla egrave neCessario osservare che la principale atteshystazione sullesistenza di stock detenuti da privati che esorbitassero ilfabbisognostagionale tali da essere classificati come immobili=zione di ricchezza (Zanetti) o come beni capitale (Cipolla) a unanalisi piugrave fine si rivela fallace o non direttamente utilizzabile La propalazione dei grani effetshytuata a Pavia fra ilimiddot e il5 maggio 1555 che egrave il fondamento di entrambi i giudizinon mostra una somma di derrate realmente eccedente il fabbisogno delle famiglie per il periodo che manca allarri_ vo dei grani novelli sulla piazza pavese Daltra parte lastessa natura dellistituto della propalazioshyne dei grani cioegrave della denljncia obbligatoria delle scorte da parte dei particolari una misura demergenza decisa in momenti critici dellapprovvigionamento cittadino affiancata quellanno dalshylispezione diretta presso le case dei privati da parte di deputati straordinari avrebbe dovuto consishygliare una maggiore cautela nella sua utilizzazione per individuare regolaritagrave di carattere generale delleconomia pre-industriale
499 La costituzione di scorte granarie pubbliche e la ptlitica ecoMmica degli stati
FONTI
ABEL [1966) W ABEL Agrarkrisen undAgra~kJJnjunktur Eine Geschichte der londshy und Erniihrungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter Hamburg
und Berlin Paul Parey 19662 (la ed -1935 trad it Congiuntura agraria e crisi agrarie Storia dellagricoltura e della produzione alimentare nellEuropa centrashyle dal XIII secolo alletagrave industriale Torino Einaudi 1976 da cui si cita)
AG ARCHIVIO GoNZAGA presso lArchivio di Stato di Mantova AuFANO 1996 E AuFANO Il grano il pane e la politica annonaria a Napoli nel Setshy
tecento Napoli ESI 1996bull AYMARO 1966 M A YMARO Wmise Raguse et le commerce du bMpendant la seconde
moitieacute du XVI siegravecle Pans SEVPEN 1966 CATIINI 1984 M CATl1NI I contadini di San Felice Metamorfosi di un mondo rurale
nellEmilia delletagrave modernIgravel Torino Einaudi 1984 CESTARl 1794 p CESTARI Saggio storico dei Fondachi delle farine di Chioggia e
Pellestrina Venezia A Zatta 1794 CIPOllAJ1965] C M CIPOllA La politica economica dei governi V La penisola
italigraveana e la penisola iberica in Storia economica Cambridge m La cittagrave e la politica economica nel Medioevo Torino Einaudi 1977 (Cambridge 1965) pp 462-496
CIPollA 1974 C M CIPollA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna nMulino 1974
CIpollA 1997 C M CIPOllA Storia economica dellEuropa pre-industriale Boloshygna nMUlino 1997 (6 ed riveduta)
CORRITORE 2000 R P CoRRITORE La naturale abbondanza del Montovano Produshyzione mercato e c01isumi granari a Mantova in etagrave moderna Pavia Universitagrave di Pavia 2000
CORIONBSI 1991 A CORIONBSI Sulla conservazione dei cereali nellItagravelia medioevale Lavoro e tecniche nelle tesnmonlanze laziali (secc XIII-XV) in Rivista di storia dellagricoltura XXXI 1991 l pp 33-49
DELLA VALENTINA 1992 M DELLA VALENTINA I mestieri del pane a ~nezia tra 600 e 700 in Atti dellIstituto [Veneto di Scienze Lettere ed Arti Classe di scienze morali lettere ed arti CL 1991-92 pp 113-217
DIRLMEIER 1984 U DIRLMEIER le condizioni materiali dellesistenza nelle cittagrave tedeshy sche del Basso Medioevo ~iente esterno reddito consumi in Aristocrazia citshy
tadina e ceti popolari nel tprdo Medioevo in Italia e in Germania (a cura di Reinhard Elze e Gina Fasoli) Bologna Societagrave editrice il Mulino 1984 pp 79shy122
FORNASIN 1999 A FORNASIN Il pzercatodei grani di Udine Indagine per una storia dei prew in Friuli (secoli XfI-XVIII) Nota di ricerca del Dipartimento di Scienshyze Statistiche dellUniversit4 degli Studi di Udine 4 1999 pp 1-24 ora in lo La Patria del Friuli in etagrave 1fIOderna Saggi di storia economica Udine Forum 2000 pp 33-60
GRENDI 1986 E GRENOI Lapprccedilwigionamento dei grani nella Liguria del Seicento libera pratica e annone in iMiscellanea storica ligure Studi in onore di Luigi Bulferetti XVIII 1986 2Jp 1021-1047
GUENZI 1981 A GUENZI Ilfrurnfnto e la cittagrave il caso di Bologna nelletagrave moderna in Quaderni storici XVI ~981 46 pp 153-167
GUENZI 1982 A GUENZI Pane ~fornai a Bologna in etagrave moderna Venezia Marsilio 1982
I
489 500 Renzo P CornIOle
GUBNZI1982 A GUEml Sistema annonario e egraveontrollo sociale a Bologna nei seccediloli XVII e XVIII in E SORI (a cura di) Cittagrave e controllo sociale in Italia fra XVIII e XIX secolo Milano F Angeli 1982 pp 293-306
HICKS [1989] 1 R HIClCS A narlcet theory of money Oxford Oxford Universigravety Press 1989 (trad it Una teoria di mercato della monefa Bologna li Mulino 1992 da cui sigrave cita)
JACOPBITI 1965 N L JACOPBITI Monete e prezzi a Cremona dal XVI al XVlIi secolo Cremona Athenaeum CregravemoneJlSe 1965
KAPLAN 1984S L KAPLAN Provisioning Paris Merchants and Millers in the Grain and Flour Trade during the Eighteenth Century Ithaca-London Cornell Univershysity Press 1984~middot
KULA [1962] W KULA Teoria ekonomiczna ustrojufeudalnego Proba modelu Warshyszawa-Panstwowe WydawnictwoNaukowe 1962 (trad it Teoriagrave economica del sistema feudale Proposta di un modello Tormo EinaUdi 1972 ccedilla cui si cita)
WROUSSE [1933] C-E LABRoussE Esquisse du mouvement des prix et des reverws en France au XVIII siegravecle Paris Eacuteditions des Archives Contemporaines 19842 volI (l ed Paris Librairie Dalloz 1933)
MALANtMA 1976 P MALANiMA Aspetti di mercato e prezzi del grano e della segalea Pisa dal 1548 al 1818 in Ricerche di storia moderna vaL I Pisa Pacini 1976 pp ~n
MANToVA 1430 MwroVA 1430 Pareri a Gian Francesco Gonaga per il governo (a cura di M AQrignaniA M Lorenzoni A Mortari C Mozzarelli) MUltova G~ Arcari 1990
MASSA 1999 PMAssA Annona e corporazioni del settore alimentare ~ Genova orshyganizzazione e conflittualitagrave (XVI-XVIII secolo) in A GUENZI PMAssA A MOIOshyu (a cura di) Corporazioni e gruppi professionali nellItalia moderna MilIllO F Angeli 1999 pp 390-403
MATIoZ7J 1983 1 MiJroZ7J F BOLELLI C CmAsBRA D SABBIONI Il politico e il pane a Venezia (157Q-1650) calmieri e governo della sussistenza in Societagrave e storia VI 198320 pp 271-303
MAzzI RAVEOOI 1983 M T MAzzI S RAVEOGI Gli uogravemini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento Firenze Olscbki 1983
MERONI 1957 U MERONI Cremona fedelissima Ciemona Athenaeum Cremonenshy~~~ _
MBUVRBl 1977 J MEuVRsT Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque LouisXIvI La productiograven des ceacutereacuteales dans la France du XVII et du XVIII siegravecle Paris Mouton -EacuteEHSS19772voll
MBUVRET 1988 J MBtJVRf Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque Louis XIv III Le commerce des gralns et la conjoncture Paris EacuteEHss 1988 2 volI
PtCClNNI 1976 G PtCClNNl Wta contagravedina in una capanna dei dintorni di Siena (1250) in ~Archeologia medievale m 1976 pp 395-399
PlNIO 1978 G PINTOII Libro del BiaPaiolo Carestie e annona a Firenze dalla metagrave del 200 al 1348 Fire~ Olscbki 1978
PiNTO 1982 G PtNro La Toscana nel tardo Medioevo Ambiente economia rurale societagrave Fllenze Sansoni 1982
PtRENNE [1933J H PIRENNB La civilisation occidentale au Moyen Age du XIe au mishylieu du XVe siegravecle Paris PUF 1933 (trad it Storia economica e sociale del Meshydioevo Milano Garzanti 1967 da cui si cita)
Lacostituticne di scorte granarie pubbliche e la politica economiegravea degli stati
redigravestribuzione sostenibile dei beni di sussistenza egrave ricercata in questo cielo da quegli stessi particolari che ~amaldeggiano nella produzione negli scambi nei consumi e che costituiscono il nerbo della classe di governo Le scorte pubbliche rappresenteshyrebbero in questa prospettiva un presidio civico e un risltCimento politico e morale ai cOl1ponenti della comunitagrave spossessati delbene supremo dellautarchia alimentare
Resta infine latente unidea del magazzmo pubblico come quasi-mercato cioegrave come luogo volto (1) a risolvere i fa1limentiinfo~vi della piazza del mercato (in meacuterito alle disponi~ilitagrave alle caratteristiche del prodotto alle condizioni di vendita della merce) (2) a ridimensionare lalea per agricoltori consumatori poveri artigiani del comparto alimentare (3) a sostenere i consumi e i profitti privati m funzione anticicli ca in una prospettiva Ilpn meram~nte congiunturale Si tratta in questo caso di un orshyganizzaZionepienattiCnte razio~e Che non opera in maniera saltuaria e riflessa ma in modo continuativo secondo obifttili prefissati di allocazione dei beni primari li funshyzionamento dellacanovagrave (il magazzino pubblico) si porrebbe come strumento inteshygrativo ma no~~igraventeramente so~titutivo delloperare della piazza Si tratterebbe di unaforma di mercato distinta dalla p~ del mercato considerata in seacute e per seacute cosigrave come dallegraveOOmpravendite effetttlate nei solari privati o dalla mera centrallzzazione e redistribuzione di derrate con fi~alitagrave umanitarie La canova rappresenterebbe in tal modo uno dei possibili meccaoi~ di governo delle trllls3ZIgrave~ni locali per risolvere i problemi deUapprovvigionameIto senza intaccare certi interessi di classe (dei proshyprietari ma anche del popolo grasso) S da essere prescelta da autoritagrave e gruppi domishynanti come struttura complementare della piazza del mercato incerti contestiprodutshytivi ed economici La suasacrilizzazione perciograve non esclude la possibilitagrave di un ritorno alle sole compravendite qella piazza e dei solari privati - una volta invertishytosi il trend o spirate le condizioqi economiche della sua istituzionalizzazione
La problematizzazione esorc~ una liquidazione semplicistica del problema delle scorte gran8rle in etagrave pre-industriUgravee nel nome di una loro presunta irrazionalitagrave eco- nomica per il compito di assi~ la sussistenza della popolazione
Le pagine che segUono sono rintroduzione a un lavoro in corso volto a offrire un interpretazione generale di tal~ capitolo fondamentale della politica economica dei governi
in
etagrave pre-industriale
2 SE UN MONDO SENZA SCORTE Egrave INCONGRUO cm Egrave OPPORTUNO CHE LEgrave DETENGA
Nei fatti nel settore granarlo CQni vincoli dell etagrave pre-industriale in tema diprodutshytivitagrave energia trasporti non ha s~nso ipotizzare un mondo senza scorte Se il mercato del grano egrave - come nellEuropa medievale e moderna - un sjstema tendenzialmente chiuso
ad ogni raccolto nuove offe~ aniv(erannol sul mercato mentre la domanda si mant[erragrave] relativamente costantt nel corso dellanno Qualcuno dunque [dovragrave] ~ere delle scorte che saranno elevate ~ubito dopo il raccolto e poi via via minori fino aragshygiungere un livello minimo in prpssimitagrave del successivo raccolto (HICICS [19891 31)
Nella loro forma piugrave sempliceI tali scorte saranno legate allora alla periodi~itagrave anshynuale del ciclo agricolo (che a1iplenta il movimento stagionale dei prezzi ccedilfr LAshyBROlJSSE [1933] 157-66) il loro livello saragrave elevato allindomani del principiLle racshy
501 488 Renzo P Corritore
povero ammassograve nella propria dimora scorte di grano carne ~alata sale candele ecc e la medesima cosa fece lo Stato Nel periodo feudale non venne mai meno nel castello del signore labitudine di tenere da parte grosse scorte per i periodi di emergenza Sucshycessivamente le autoritagrave comunali predisposero il magazzinaggio di grosse derrate specie di grano da rivendere a basso prezzo in periodi di emergenza e nello stesso tempo si preoccuparono di prevenire un indebito accumulo di scorte da parte di specushylatori privati Nelle economie medievali gli stock di derrate di prima necessitagrave rappreshysentarono pertanto una delle piugrave importanti forme di investimento pubblico e privato (CIPOLLA (1965] 468)
Nella prima versione del manualeacute invece fino allinserimento nel 1997 del nuovo capitolo dedicato alla politica economica nell etagrave pre-mdustriale il punto di vista preshyvalente era quello microeconomico entro il perimetro stretto dellindividualismo meshytodologico
Le scorte costano e costano doppiamente Esse implicano il costo diretto che egrave rapshypresentato dal costo del magazzinaggio edal deterioramento eventuale del pr04otto o di parte di esso Se luomo daffari finanzia la costituzione delle scorte con danaro preso a prestito il costo diretto include anche il tasso di interesse pagato Se luomo daffari finanzia con capitale proprio la costituzione delle scorte il costo delle scorte deve inshycludere un costo-opportunitagrave e cioegrave il mancato rendimento (tIllU1cato tasso dinteresse attivo) del capitale finanziario impiegato (CIPOLLA 1974 154)
Le ragioni della costituzione e del mantenimento di scorte alimentari da parte delshylautoritagrave pubblica diventavano unicamente ragioni morali (umanitarie e di buona amministrazione) o di opportunitagrave politica (la fame era la piugrave frequente ligraveausa di sommosse e furori popolari) (CIPOLLA 1974 74)
Nel 1997 si riammetteva dunque linterpretazione originaria della costituzione di scorte pubbliche come strumento di riequilibrio del mercato senza peraltro rinnegare le considerazioni sulla valenza statica di tale forma di investimento per gli agenti economici privati
In merito allutilitagrave economica e al significato delle scorte in etagrave pre-industriale Cishypolla non espresse perciograve sempre lo stesso punto di vista La rassegna delle posizioni da lui assunte anzi permette di individuare tre approcci e tre giudizi costitutivamente diversi sulla funzione delle scorte granarie nellepoca pre-industriale
In prima approssimazione laccumulazione di scorte alimentari mostra il carattere fondamentalmente difensivo delle scelte degli agenti economici pubblici e privati in etagrave pre-industriale La paura la tradizione la superstizione li induce a tabuizzare il rischio la speculazione linvestimento nella produzione e nella distribuzione dei beni essenziali alla vita e ad aderire intimamente a un ideale di economia e societagrave stazionarie aggravando con la norma sociale le istituzioni il comportamento indivishyduale e collettivo leffetto dei condizionamenti materiali delleconomia pre-industriashyle (bassa produttivitagrave agricola alti costi di v~sporto modesta efficienza energetica) esponendo ancor di piugrave la comunitagrave umana ai degravemoni della natura
La seconda interpretazione rigetta luniversale imperio dellhomo oeconomicus rishyscoprendo leteronomia dei fini dellagire economico degli uomini nelletagrave pre-inshydustriale Ia politica economica dello Stato o-delle autoritagrave non persegue puri scopi economici lintegritagrave del corpo sociale fin nelle sue cellule elementari (persone e famiglie) deve essere assicurata secondo i principi e la prassi di uneconomia morale che SOVJa5ta leconomia regolata dal mercato spersonalizzata e antipopolare Una
La costituzione di scorte grantlTie pubbliche e la poligravetigraveca economica degli stati
PuLT QUAGUA 1984 A M PULT QUAGUA Mercato dei prodotti agricoli e magistratushyre annonarie a Pisa nelletagrave moderna in Ricerche di storia moderna a cura di M Mirri voI III Pisa Pacini 1984 pp 57-141
PULT QUAGLIA 1990 A M PULT QUAGLIA Per provvedere ai popoli Il sistema anshynonario nella Toscana dei Medici Firenze Olschki 1990
SERUO 1994 S SERLIO Architettura civile Libri sesto settimo e ottavo nei manoscritshyti di Monaco e Vienna (a cura di F P Fiore) Milano TI Polifi10 1994
SIGAlIT 1985 F SIGAlIT Questions deacuteconomie agrave propos des politiques ceacutereacutealiegraveres et de stockage in Les techniques de conservation des grains agrave long terme leur rale dans la dynamique des systegravemes de cultures et des socieacuteteacutes (sous la direction de M Gast F Sigaut et C Beutler avec la collaboratlon de O Bllchsenschutz) voI III 2 Paris Eacuteditionsdu CNRS 1985 pp 597-606
SMITH [1776 A SMITH An inquiry into the nature and causes ojthe wealth ojnations London W Strahanand T Cadell 17762 volI (trad it Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni Milano A Mondadori 1977 2 volI da cui
si cita) STATlITlBoNACOLSIANI [1313] STATUTI BONACOLSlANl (a cura di E Dezza A M Lorenshy
zoni M Vaini) Mantova GArcari 2002 STATUTI GONZAGHESCHI [1404] STATUTI GONZAGHESCHI presso la Biblioteca comunale di
Mantova ms FV 11 [775]VECCHIATO 1979 F VOCCHIATO Pane e politica annonaria in Terrajerma veneta tra
secolo XV e secolo XVIII (Il caso di Verona) Verona Stamperia Zendrini 1979 ZANETTI 1963 D ZANETTl Contribution agrave leacutetude des structures eacuteconomiques lapshy
provisiQnnement de Pavie au XVI siegravecle in Annales ESC XVIII 1963 1 pp 44-62 ora in lo Fra le antiche torri Scritti di storia pavese Pavia Universitagrave di Pavia 2000 pp 165-182
ZANETTl 1964 D ZANEITI Problemi alimentari di una economia preindustriale Ceshyreali a Pavia dal 1398 al 1700 Torino P Borlnghieri 1964
ZUG TUCCI 1990 H ZUG TuCCI Le derrate agricole problemi materiali e concezioni mentali della conservazione in Lambiente vegetale nellalto Medioevo XXXVII Settimana di studio del Centro italiano di studi sullalto Medioevo (30 marzo-5 aprile 1989) Spoleto Centro italiano di studi sullalto Medioevo 1990 voI n pp 865-902
489 500 Renzo P CornIOle
GUBNZI1982 A GUEml Sistema annonario e egraveontrollo sociale a Bologna nei seccediloli XVII e XVIII in E SORI (a cura di) Cittagrave e controllo sociale in Italia fra XVIII e XIX secolo Milano F Angeli 1982 pp 293-306
HICKS [1989] 1 R HIClCS A narlcet theory of money Oxford Oxford Universigravety Press 1989 (trad it Una teoria di mercato della monefa Bologna li Mulino 1992 da cui sigrave cita)
JACOPBITI 1965 N L JACOPBITI Monete e prezzi a Cremona dal XVI al XVlIi secolo Cremona Athenaeum CregravemoneJlSe 1965
KAPLAN 1984S L KAPLAN Provisioning Paris Merchants and Millers in the Grain and Flour Trade during the Eighteenth Century Ithaca-London Cornell Univershysity Press 1984~middot
KULA [1962] W KULA Teoria ekonomiczna ustrojufeudalnego Proba modelu Warshyszawa-Panstwowe WydawnictwoNaukowe 1962 (trad it Teoriagrave economica del sistema feudale Proposta di un modello Tormo EinaUdi 1972 ccedilla cui si cita)
WROUSSE [1933] C-E LABRoussE Esquisse du mouvement des prix et des reverws en France au XVIII siegravecle Paris Eacuteditions des Archives Contemporaines 19842 volI (l ed Paris Librairie Dalloz 1933)
MALANtMA 1976 P MALANiMA Aspetti di mercato e prezzi del grano e della segalea Pisa dal 1548 al 1818 in Ricerche di storia moderna vaL I Pisa Pacini 1976 pp ~n
MANToVA 1430 MwroVA 1430 Pareri a Gian Francesco Gonaga per il governo (a cura di M AQrignaniA M Lorenzoni A Mortari C Mozzarelli) MUltova G~ Arcari 1990
MASSA 1999 PMAssA Annona e corporazioni del settore alimentare ~ Genova orshyganizzazione e conflittualitagrave (XVI-XVIII secolo) in A GUENZI PMAssA A MOIOshyu (a cura di) Corporazioni e gruppi professionali nellItalia moderna MilIllO F Angeli 1999 pp 390-403
MATIoZ7J 1983 1 MiJroZ7J F BOLELLI C CmAsBRA D SABBIONI Il politico e il pane a Venezia (157Q-1650) calmieri e governo della sussistenza in Societagrave e storia VI 198320 pp 271-303
MAzzI RAVEOOI 1983 M T MAzzI S RAVEOGI Gli uogravemini e le cose nelle campagne fiorentine del Quattrocento Firenze Olscbki 1983
MERONI 1957 U MERONI Cremona fedelissima Ciemona Athenaeum Cremonenshy~~~ _
MBUVRBl 1977 J MEuVRsT Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque LouisXIvI La productiograven des ceacutereacuteales dans la France du XVII et du XVIII siegravecle Paris Mouton -EacuteEHSS19772voll
MBUVRET 1988 J MBtJVRf Le problegraveme des subsistances agrave leacutepoque Louis XIv III Le commerce des gralns et la conjoncture Paris EacuteEHss 1988 2 volI
PtCClNNI 1976 G PtCClNNl Wta contagravedina in una capanna dei dintorni di Siena (1250) in ~Archeologia medievale m 1976 pp 395-399
PlNIO 1978 G PINTOII Libro del BiaPaiolo Carestie e annona a Firenze dalla metagrave del 200 al 1348 Fire~ Olscbki 1978
PiNTO 1982 G PtNro La Toscana nel tardo Medioevo Ambiente economia rurale societagrave Fllenze Sansoni 1982
PtRENNE [1933J H PIRENNB La civilisation occidentale au Moyen Age du XIe au mishylieu du XVe siegravecle Paris PUF 1933 (trad it Storia economica e sociale del Meshydioevo Milano Garzanti 1967 da cui si cita)
Lacostituticne di scorte granarie pubbliche e la politica economiegravea degli stati
redigravestribuzione sostenibile dei beni di sussistenza egrave ricercata in questo cielo da quegli stessi particolari che ~amaldeggiano nella produzione negli scambi nei consumi e che costituiscono il nerbo della classe di governo Le scorte pubbliche rappresenteshyrebbero in questa prospettiva un presidio civico e un risltCimento politico e morale ai cOl1ponenti della comunitagrave spossessati delbene supremo dellautarchia alimentare
Resta infine latente unidea del magazzmo pubblico come quasi-mercato cioegrave come luogo volto (1) a risolvere i fa1limentiinfo~vi della piazza del mercato (in meacuterito alle disponi~ilitagrave alle caratteristiche del prodotto alle condizioni di vendita della merce) (2) a ridimensionare lalea per agricoltori consumatori poveri artigiani del comparto alimentare (3) a sostenere i consumi e i profitti privati m funzione anticicli ca in una prospettiva Ilpn meram~nte congiunturale Si tratta in questo caso di un orshyganizzaZionepienattiCnte razio~e Che non opera in maniera saltuaria e riflessa ma in modo continuativo secondo obifttili prefissati di allocazione dei beni primari li funshyzionamento dellacanovagrave (il magazzino pubblico) si porrebbe come strumento inteshygrativo ma no~~igraventeramente so~titutivo delloperare della piazza Si tratterebbe di unaforma di mercato distinta dalla p~ del mercato considerata in seacute e per seacute cosigrave come dallegraveOOmpravendite effetttlate nei solari privati o dalla mera centrallzzazione e redistribuzione di derrate con fi~alitagrave umanitarie La canova rappresenterebbe in tal modo uno dei possibili meccaoi~ di governo delle trllls3ZIgrave~ni locali per risolvere i problemi deUapprovvigionameIto senza intaccare certi interessi di classe (dei proshyprietari ma anche del popolo grasso) S da essere prescelta da autoritagrave e gruppi domishynanti come struttura complementare della piazza del mercato incerti contestiprodutshytivi ed economici La suasacrilizzazione perciograve non esclude la possibilitagrave di un ritorno alle sole compravendite qella piazza e dei solari privati - una volta invertishytosi il trend o spirate le condizioqi economiche della sua istituzionalizzazione
La problematizzazione esorc~ una liquidazione semplicistica del problema delle scorte gran8rle in etagrave pre-industriUgravee nel nome di una loro presunta irrazionalitagrave eco- nomica per il compito di assi~ la sussistenza della popolazione
Le pagine che segUono sono rintroduzione a un lavoro in corso volto a offrire un interpretazione generale di tal~ capitolo fondamentale della politica economica dei governi
in
etagrave pre-industriale
2 SE UN MONDO SENZA SCORTE Egrave INCONGRUO cm Egrave OPPORTUNO CHE LEgrave DETENGA
Nei fatti nel settore granarlo CQni vincoli dell etagrave pre-industriale in tema diprodutshytivitagrave energia trasporti non ha s~nso ipotizzare un mondo senza scorte Se il mercato del grano egrave - come nellEuropa medievale e moderna - un sjstema tendenzialmente chiuso
ad ogni raccolto nuove offe~ aniv(erannol sul mercato mentre la domanda si mant[erragrave] relativamente costantt nel corso dellanno Qualcuno dunque [dovragrave] ~ere delle scorte che saranno elevate ~ubito dopo il raccolto e poi via via minori fino aragshygiungere un livello minimo in prpssimitagrave del successivo raccolto (HICICS [19891 31)
Nella loro forma piugrave sempliceI tali scorte saranno legate allora alla periodi~itagrave anshynuale del ciclo agricolo (che a1iplenta il movimento stagionale dei prezzi ccedilfr LAshyBROlJSSE [1933] 157-66) il loro livello saragrave elevato allindomani del principiLle racshy
501 488 Renzo P Corritore
povero ammassograve nella propria dimora scorte di grano carne ~alata sale candele ecc e la medesima cosa fece lo Stato Nel periodo feudale non venne mai meno nel castello del signore labitudine di tenere da parte grosse scorte per i periodi di emergenza Sucshycessivamente le autoritagrave comunali predisposero il magazzinaggio di grosse derrate specie di grano da rivendere a basso prezzo in periodi di emergenza e nello stesso tempo si preoccuparono di prevenire un indebito accumulo di scorte da parte di specushylatori privati Nelle economie medievali gli stock di derrate di prima necessitagrave rappreshysentarono pertanto una delle piugrave importanti forme di investimento pubblico e privato (CIPOLLA (1965] 468)
Nella prima versione del manualeacute invece fino allinserimento nel 1997 del nuovo capitolo dedicato alla politica economica nell etagrave pre-mdustriale il punto di vista preshyvalente era quello microeconomico entro il perimetro stretto dellindividualismo meshytodologico
Le scorte costano e costano doppiamente Esse implicano il costo diretto che egrave rapshypresentato dal costo del magazzinaggio edal deterioramento eventuale del pr04otto o di parte di esso Se luomo daffari finanzia la costituzione delle scorte con danaro preso a prestito il costo diretto include anche il tasso di interesse pagato Se luomo daffari finanzia con capitale proprio la costituzione delle scorte il costo delle scorte deve inshycludere un costo-opportunitagrave e cioegrave il mancato rendimento (tIllU1cato tasso dinteresse attivo) del capitale finanziario impiegato (CIPOLLA 1974 154)
Le ragioni della costituzione e del mantenimento di scorte alimentari da parte delshylautoritagrave pubblica diventavano unicamente ragioni morali (umanitarie e di buona amministrazione) o di opportunitagrave politica (la fame era la piugrave frequente ligraveausa di sommosse e furori popolari) (CIPOLLA 1974 74)
Nel 1997 si riammetteva dunque linterpretazione originaria della costituzione di scorte pubbliche come strumento di riequilibrio del mercato senza peraltro rinnegare le considerazioni sulla valenza statica di tale forma di investimento per gli agenti economici privati
In merito allutilitagrave economica e al significato delle scorte in etagrave pre-industriale Cishypolla non espresse perciograve sempre lo stesso punto di vista La rassegna delle posizioni da lui assunte anzi permette di individuare tre approcci e tre giudizi costitutivamente diversi sulla funzione delle scorte granarie nellepoca pre-industriale
In prima approssimazione laccumulazione di scorte alimentari mostra il carattere fondamentalmente difensivo delle scelte degli agenti economici pubblici e privati in etagrave pre-industriale La paura la tradizione la superstizione li induce a tabuizzare il rischio la speculazione linvestimento nella produzione e nella distribuzione dei beni essenziali alla vita e ad aderire intimamente a un ideale di economia e societagrave stazionarie aggravando con la norma sociale le istituzioni il comportamento indivishyduale e collettivo leffetto dei condizionamenti materiali delleconomia pre-industriashyle (bassa produttivitagrave agricola alti costi di v~sporto modesta efficienza energetica) esponendo ancor di piugrave la comunitagrave umana ai degravemoni della natura
La seconda interpretazione rigetta luniversale imperio dellhomo oeconomicus rishyscoprendo leteronomia dei fini dellagire economico degli uomini nelletagrave pre-inshydustriale Ia politica economica dello Stato o-delle autoritagrave non persegue puri scopi economici lintegritagrave del corpo sociale fin nelle sue cellule elementari (persone e famiglie) deve essere assicurata secondo i principi e la prassi di uneconomia morale che SOVJa5ta leconomia regolata dal mercato spersonalizzata e antipopolare Una
La costituzione di scorte grantlTie pubbliche e la poligravetigraveca economica degli stati
PuLT QUAGUA 1984 A M PULT QUAGUA Mercato dei prodotti agricoli e magistratushyre annonarie a Pisa nelletagrave moderna in Ricerche di storia moderna a cura di M Mirri voI III Pisa Pacini 1984 pp 57-141
PULT QUAGLIA 1990 A M PULT QUAGLIA Per provvedere ai popoli Il sistema anshynonario nella Toscana dei Medici Firenze Olschki 1990
SERUO 1994 S SERLIO Architettura civile Libri sesto settimo e ottavo nei manoscritshyti di Monaco e Vienna (a cura di F P Fiore) Milano TI Polifi10 1994
SIGAlIT 1985 F SIGAlIT Questions deacuteconomie agrave propos des politiques ceacutereacutealiegraveres et de stockage in Les techniques de conservation des grains agrave long terme leur rale dans la dynamique des systegravemes de cultures et des socieacuteteacutes (sous la direction de M Gast F Sigaut et C Beutler avec la collaboratlon de O Bllchsenschutz) voI III 2 Paris Eacuteditionsdu CNRS 1985 pp 597-606
SMITH [1776 A SMITH An inquiry into the nature and causes ojthe wealth ojnations London W Strahanand T Cadell 17762 volI (trad it Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni Milano A Mondadori 1977 2 volI da cui
si cita) STATlITlBoNACOLSIANI [1313] STATUTI BONACOLSlANl (a cura di E Dezza A M Lorenshy
zoni M Vaini) Mantova GArcari 2002 STATUTI GONZAGHESCHI [1404] STATUTI GONZAGHESCHI presso la Biblioteca comunale di
Mantova ms FV 11 [775]VECCHIATO 1979 F VOCCHIATO Pane e politica annonaria in Terrajerma veneta tra
secolo XV e secolo XVIII (Il caso di Verona) Verona Stamperia Zendrini 1979 ZANETTI 1963 D ZANETTl Contribution agrave leacutetude des structures eacuteconomiques lapshy
provisiQnnement de Pavie au XVI siegravecle in Annales ESC XVIII 1963 1 pp 44-62 ora in lo Fra le antiche torri Scritti di storia pavese Pavia Universitagrave di Pavia 2000 pp 165-182
ZANETTl 1964 D ZANEITI Problemi alimentari di una economia preindustriale Ceshyreali a Pavia dal 1398 al 1700 Torino P Borlnghieri 1964
ZUG TUCCI 1990 H ZUG TuCCI Le derrate agricole problemi materiali e concezioni mentali della conservazione in Lambiente vegetale nellalto Medioevo XXXVII Settimana di studio del Centro italiano di studi sullalto Medioevo (30 marzo-5 aprile 1989) Spoleto Centro italiano di studi sullalto Medioevo 1990 voI n pp 865-902
501 488 Renzo P Corritore
povero ammassograve nella propria dimora scorte di grano carne ~alata sale candele ecc e la medesima cosa fece lo Stato Nel periodo feudale non venne mai meno nel castello del signore labitudine di tenere da parte grosse scorte per i periodi di emergenza Sucshycessivamente le autoritagrave comunali predisposero il magazzinaggio di grosse derrate specie di grano da rivendere a basso prezzo in periodi di emergenza e nello stesso tempo si preoccuparono di prevenire un indebito accumulo di scorte da parte di specushylatori privati Nelle economie medievali gli stock di derrate di prima necessitagrave rappreshysentarono pertanto una delle piugrave importanti forme di investimento pubblico e privato (CIPOLLA (1965] 468)
Nella prima versione del manualeacute invece fino allinserimento nel 1997 del nuovo capitolo dedicato alla politica economica nell etagrave pre-mdustriale il punto di vista preshyvalente era quello microeconomico entro il perimetro stretto dellindividualismo meshytodologico
Le scorte costano e costano doppiamente Esse implicano il costo diretto che egrave rapshypresentato dal costo del magazzinaggio edal deterioramento eventuale del pr04otto o di parte di esso Se luomo daffari finanzia la costituzione delle scorte con danaro preso a prestito il costo diretto include anche il tasso di interesse pagato Se luomo daffari finanzia con capitale proprio la costituzione delle scorte il costo delle scorte deve inshycludere un costo-opportunitagrave e cioegrave il mancato rendimento (tIllU1cato tasso dinteresse attivo) del capitale finanziario impiegato (CIPOLLA 1974 154)
Le ragioni della costituzione e del mantenimento di scorte alimentari da parte delshylautoritagrave pubblica diventavano unicamente ragioni morali (umanitarie e di buona amministrazione) o di opportunitagrave politica (la fame era la piugrave frequente ligraveausa di sommosse e furori popolari) (CIPOLLA 1974 74)
Nel 1997 si riammetteva dunque linterpretazione originaria della costituzione di scorte pubbliche come strumento di riequilibrio del mercato senza peraltro rinnegare le considerazioni sulla valenza statica di tale forma di investimento per gli agenti economici privati
In merito allutilitagrave economica e al significato delle scorte in etagrave pre-industriale Cishypolla non espresse perciograve sempre lo stesso punto di vista La rassegna delle posizioni da lui assunte anzi permette di individuare tre approcci e tre giudizi costitutivamente diversi sulla funzione delle scorte granarie nellepoca pre-industriale
In prima approssimazione laccumulazione di scorte alimentari mostra il carattere fondamentalmente difensivo delle scelte degli agenti economici pubblici e privati in etagrave pre-industriale La paura la tradizione la superstizione li induce a tabuizzare il rischio la speculazione linvestimento nella produzione e nella distribuzione dei beni essenziali alla vita e ad aderire intimamente a un ideale di economia e societagrave stazionarie aggravando con la norma sociale le istituzioni il comportamento indivishyduale e collettivo leffetto dei condizionamenti materiali delleconomia pre-industriashyle (bassa produttivitagrave agricola alti costi di v~sporto modesta efficienza energetica) esponendo ancor di piugrave la comunitagrave umana ai degravemoni della natura
La seconda interpretazione rigetta luniversale imperio dellhomo oeconomicus rishyscoprendo leteronomia dei fini dellagire economico degli uomini nelletagrave pre-inshydustriale Ia politica economica dello Stato o-delle autoritagrave non persegue puri scopi economici lintegritagrave del corpo sociale fin nelle sue cellule elementari (persone e famiglie) deve essere assicurata secondo i principi e la prassi di uneconomia morale che SOVJa5ta leconomia regolata dal mercato spersonalizzata e antipopolare Una
La costituzione di scorte grantlTie pubbliche e la poligravetigraveca economica degli stati
PuLT QUAGUA 1984 A M PULT QUAGUA Mercato dei prodotti agricoli e magistratushyre annonarie a Pisa nelletagrave moderna in Ricerche di storia moderna a cura di M Mirri voI III Pisa Pacini 1984 pp 57-141
PULT QUAGLIA 1990 A M PULT QUAGLIA Per provvedere ai popoli Il sistema anshynonario nella Toscana dei Medici Firenze Olschki 1990
SERUO 1994 S SERLIO Architettura civile Libri sesto settimo e ottavo nei manoscritshyti di Monaco e Vienna (a cura di F P Fiore) Milano TI Polifi10 1994
SIGAlIT 1985 F SIGAlIT Questions deacuteconomie agrave propos des politiques ceacutereacutealiegraveres et de stockage in Les techniques de conservation des grains agrave long terme leur rale dans la dynamique des systegravemes de cultures et des socieacuteteacutes (sous la direction de M Gast F Sigaut et C Beutler avec la collaboratlon de O Bllchsenschutz) voI III 2 Paris Eacuteditionsdu CNRS 1985 pp 597-606
SMITH [1776 A SMITH An inquiry into the nature and causes ojthe wealth ojnations London W Strahanand T Cadell 17762 volI (trad it Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni Milano A Mondadori 1977 2 volI da cui
si cita) STATlITlBoNACOLSIANI [1313] STATUTI BONACOLSlANl (a cura di E Dezza A M Lorenshy
zoni M Vaini) Mantova GArcari 2002 STATUTI GONZAGHESCHI [1404] STATUTI GONZAGHESCHI presso la Biblioteca comunale di
Mantova ms FV 11 [775]VECCHIATO 1979 F VOCCHIATO Pane e politica annonaria in Terrajerma veneta tra
secolo XV e secolo XVIII (Il caso di Verona) Verona Stamperia Zendrini 1979 ZANETTI 1963 D ZANETTl Contribution agrave leacutetude des structures eacuteconomiques lapshy
provisiQnnement de Pavie au XVI siegravecle in Annales ESC XVIII 1963 1 pp 44-62 ora in lo Fra le antiche torri Scritti di storia pavese Pavia Universitagrave di Pavia 2000 pp 165-182
ZANETTl 1964 D ZANEITI Problemi alimentari di una economia preindustriale Ceshyreali a Pavia dal 1398 al 1700 Torino P Borlnghieri 1964
ZUG TUCCI 1990 H ZUG TuCCI Le derrate agricole problemi materiali e concezioni mentali della conservazione in Lambiente vegetale nellalto Medioevo XXXVII Settimana di studio del Centro italiano di studi sullalto Medioevo (30 marzo-5 aprile 1989) Spoleto Centro italiano di studi sullalto Medioevo 1990 voI n pp 865-902