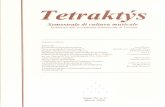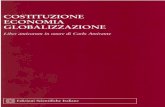La Tavola di Trinitapoli : una nuova costituzione di Valentiniano I
Transcript of La Tavola di Trinitapoli : una nuova costituzione di Valentiniano I
Andrea GiardinaFrancesco Grelle
La Tavola di Trinitapoli : una nuova costituzione di Valentiniano IIn: Mélanges de l'Ecole française de Rome. Antiquité T. 95, N°1. 1983. pp. 249-303.
RiassuntoAndrea Giardina et Francesco Grelle, La Tavola di Trinitapoli : una nuova costituzione di Valentiniano I, p. 249-303.
Pubblicazione di un testo epigrafico inedito trovato nella campagna di Trinitapoli, in provincia di Foggia. L'epigrafe conserva iltesto di un atto normativo imperiale, che si autodefinisce lex o decretum, indirizzato dall'imperatore Valentiniano I al prefetto alpretorio Sex. Claudius Petronius Probus, prefetto per la prima volta dal 368 al 375 (6). Diretto a proteggere i contribuenti dallacollusione tra funzionari provinciali e tabularii, l'intervento di Valentiniano costruisce un sistema di registrazioni e di controlli cheintegra, e nello stesso tempo corregge, per alcuni aspetti determinanti, la disciplina tracciata dalla legislazione anteriore. Ilmeccanismo di controvo trova il suo momento più alto nell'adventus del governatore dei pagi e nella sua personale inquisitio. Lenorme sui pagi e sui loro preposti rivelano infine, per la prima volta, il ruolo di questo istituto nel riordinamento territoriale dellaprefettura d'Italia.
Citer ce document / Cite this document :
Giardina Andrea, Grelle Francesco. La Tavola di Trinitapoli : una nuova costituzione di Valentiniano I. In: Mélanges de l'Ecolefrançaise de Rome. Antiquité T. 95, N°1. 1983. pp. 249-303.
doi : 10.3406/mefr.1983.1364
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mefr_0223-5102_1983_num_95_1_1364
ANDREA GIARDINA E FRANCESCO GRELLE
LA TAVOLA DI TRINITAPOLI : UNA NUOVA COSTITUZIONE DI VALENTINIANO I *
1 - La scoperta, ι luoghi, il monumento
II comune di Trinitapoli, in provincia di Foggia, conserva nella sede provvisoria in cui gli uffici dell'amministrazione locale si sono trasferiti dopo il terremoto del 1980 una lastra di marmo iscritta, già affissa nell'androne del palazzo di città, ora in restauro (fig. 1).
Il marmo è del tipo bianco-azzurrastro, a scaglie grosse, proveniente dall'isola di Proconneso, celebre nel mondo antico per le sue cave. La lapide fu ritrovata per caso, a circa un metro di profondità, durante i
* La nuova costituzione epigrafica da Trinitapoli è stata presentata il 10 giugno 1982 in un seminario organizzato dall'École française de Rome : ringraziarne» sentitamente G. Vallet e M. Gras per averci offerto la possibilità di un'importante discussione. A tutti gli intervenuti nel dibattito (G.G. Archi, Ch. Boulvert, J.- M. Carrié, A. Chastagnol, M. Corbier, E. Gabba, G. Lanata, S. Panciera, A. Pe- trucci, A. Schiavone, M. Talamanca, D. Vera, E. Volterra) dobbiamo infatti critiche e suggerimenti preziosi.
Gli autori hanno avuto la possibilità di discutere il testo anche in seminari presso l'Istituto di Diritto romano della Facoltà di Giurisprudenza di Genova e l'Istituto di Storia antica della Facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna : si ringraziano tutti i colleghi che hanno partecipato, e soprattutto i prof. M. Amelotti e F. De Marini Avonzo (Genova), G. Susini e C. Donati (Bologna). A G. Foti Talamanca e P. Pensabene dobbiamo informazioni su punti specifici del lavoro. Il gruppo di ricerca sulle testimonianze epigrafiche di Canosa, e in particolare R. Gaeta, V. Morizio, M. Pani, ha in vario modo agevolato il nostro impegno.
Ma un ringraziamento del tutto particolare va al prof. S. Mazzarino, per l'aiuto che ci ha dato, anche in rapporto alla lettura (p. es. a tabulis id eris a 1. 21); e al prof. S. Panciera, con cui questo lavoro è stato discusso più volte, prima e dopo il seminario di Roma.
La pubblicazione della Tavola di Trinitapoli rientra in un progetto di ricerca (Univ. di Palermo e di Bari) finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Il presente lavoro è il frutto della collaborazione e dell'impegno comune tra i due autori; anche la responsabilità, pertanto, ne è comune. A. Giardina ha scritto i §§ 4-7, F. Grelle i §§ 1, 3, 8. La trascrizione (§ 2) è stata effettuata insieme nel corso di sopralluoghi svoltisi tra il maggio 1980 e il maggio 1982.
MEFRA - 95 - 1983 - 1, p. 249-303.
Illustration non autorisée à la diffusion
250 ANDREA GIARDINA E FRANCESCO GRELLE
Fig. 1 - La Tavola di Trinitapoli.
LA TAVOLA DI TRINITAPOLI 251
lavori di scasso per l'impianto di una vigna, una quindicina di anni fa; venne rinvenuta in aperta campagna, all'estremo confine occidentale del territorio comunale, in località Chiavicella Grande, non lontano dalla stazione di Candida della ferrovia Bari-Foggia (fig. 4).
Secondo il contadino che la rinvenne, la lastra copriva una tomba terragna in cui erano visibili i resti di uno scheletro e i frammenti di una spada, andati poi dispersi. Intorno, due ο tre sepolture dello stesso tipo, coperte da tegoloni, senza alcun corredo1. Profondamente alterata dalla ristrutturazione produttiva che ha sostituito i mandorleti preesistenti con i vigneti, l'area non offre più alcun elemento utile allo studio del piccolo gruppo di deposizioni.
Al momento della scoperta la lastra, rettangolare, si presentava frantumata in quattro parti dai contorni irregolari, diverse per forma e ampiezza; era incompleta lungo uno dei lati corti del rettangolo, dove il frammento maggiore si allunga in una breve cuspide. La superficie iscritta, rovesciata verso l'interno della fossa, era coperta da incrostazioni saline, ma in buone condizioni. Consegnata alle autorità comunali, la lapide fu ricomposta da un muratore del luogo, che adoperò per legare insieme i frammenti un mastice plastico tenacissimo ; debordando oltre le fratture il mastice ha in parte coperto le lettere vicine rendendole illeggibili. Per di più, il muratore sottopose la faccia iscritta a una levigatura meccanica, nell'intento di eliminare i depositi che vi si erano raccolti. Naturalmente, i risultati furono disastrosi per il campo epigrafico, la cui superficie assunse forse allora l'andamento ondulatorio che la caratterizza (fig. 3). Solo tre piccole 'isole', scampate alla smerigliatura, conservano l'aspetto e il livello originari (fig. 2).
La lapide ha, come si è detto, la forma di un rettangolo cuspidato verso l'alto. Al vertice misura cm 140; lungo gli spigoli verticali rispettivamente cm 126 e cm 120; lungo i lati minori cm 72. Lo spessore varia da cm 5 a cm 2,5.
La faccia anepigrafa, rozzamente scalpellata, conserva tracce ruggi- nose, ma non presenta alcuna predisposizione per ganci ο cavicchi.
L'iscrizione, parallela al lato corto del rettangolo, è disposta, nella parte superiore della lastra, per un'altezza di cm 85, calcolati alla cuspide; si sviluppa per 34 linee, delle quali le prime nove sono più ο meno gravemente mutilate dell'inizio e della fine. Pesantissime abrasioni rendo-
1 Dobbiamo queste informazioni alla cortesia del proprietario del fondo, sig. Michele Putignani.
Illustration non autorisée à la diffusion
252 ANDREA GIARDINA E FRANCESCO GRELLE
Fig. 2 - Le «isole» scampate alla smerigliatura.
Illustration non autorisée à la diffusion
LA TAVOLA DI TRINITAPOLI 253
Fig. 3 - L'andamento «ondulatorio» della superficie.
no in buona misura illeggibili le quattro linee finali, sulle quali si è accanita la levigatrice (fig. 5).
Il campo epigrafico non è riquadrato; le lettere si affollano spesso all'estremo margine a destra. I segni, abbastanza regolari, sono alti in media due centimetri; ogni linea ne contiene da 65 a 75.
L'epigrafe conserva il testo di un atto normativo imperiale che si autodefinisce lex ο decretum, secondo un uso indifferenziato dei due termini non infrequente nelle costituzioni del IV e del V secolo2. Destinata alla pubblicazione del provvedimento, la lapide fu poi sottratta alla destinazione originaria e finì, non sappiamo attraverso quali vicende, nel piccolo sepolcreto in cui è stata rinvenuta, riutilizzata come lastra tombale.
2L. 19: decretum; 1. 28 : lex. Per questa terminologia, cf. G. G. Archi, Teodosio II e la sua codificazione, Napoli, 1976, pp. 59 sgg. (in particolare n. 24, per riserve sulla diversa opinione del De Martino), 109 sgg.
254 ANDREA GIARDINA E FRANCESCO GRELLE
La distruzione delle tombe e lo smarrimento dei reperti hanno cancellato ogni indizio utile a ricostruire le circostanze e le modalità del reimpiego. È tuttavia assai probabile che le sepolture vadano ricondotte al popolamento rurale avviato in tutta la Puglia dalla seconda colonizzazione bizantina, e drasticamente ridotto, in particolare in questa area, qualche secolo più tardi, in coincidenza col nuovo sviluppo della pastorizia transumante3. Fino al XIV secolo infatti, quando le campagne circostanti il Monte di Salpi vennero progressivamente abbandonate alle paludi e al pascolo, il paesaggio del rinvenimento appare alla nostra documentazione animato da vivaci presenze di proprietari fondiari, di organizzazioni ecclesiastiche, di amministratori regi. Come altri, il toponimo Chiavicella è attestato già in età normanna, per localizzare fondi rustici in atti di vendita4. In questa stessa epoca il centro urbano di Salpi, nella cui diocesi ricade la località in cui è riapparsa l'epigrafe, presenta un'attività edilizia che avrà anch'essa contribuito a promuovere il saccheggio degli edifici antichi, e la circolazione dei materiali di spoglio5. Un insediamento rurale avrà dunque utilizzato per qualque tempo, in un periodo che non
3 Un rapido ma denso e articolato disegno delle trasformazioni che investono la geografia antropica della Puglia fra IX e XI secolo è tracciato da A. Guillou, La Puglia e Bisanzio, in Civiltà e culture in Puglia, II, Milano, 1980, p. 15 sgg.; cf. anche, per gli sviluppi successivi, fino alla sistemazione aragonese, R. Licinio, L'organizzazione del territorio fra XIII e XIV secolo, ivi, III, Milano, 1981, p. 247 sgg·
4 Codice Diplomatico Barese, X, Le pergamene di Barletta del R. Archivio di Napoli, a cura di R. Filangieri di Candida, Bari, 1927, p. 28, n° 17, 1, 12 : petacio- nem. . . in loco qui dicitur Clavicella (24 dicembre 1157). Cfr. Codice Diplomatico Barese, Vili, Le pergamene di Barletta dell'archivio capitolare, a cura di F. Nitti di Vito, Bari, 1914, p. 96, 98, 99, 110.
5 Salpi sopravvive oggi solo come toponimo, ma fu centro urbano di qualche rilievo tra l'XI e il XIII secolo. Documenti di età angioina ricordano la cattedrale e altre chiese, il fondaco del sale, un palazzo regio costruito da Federico II e restaurato dopo un incendio da Carlo I d'Angiò, casali e masserie : / registri della cancelleria angioina ricostruiti da R. Filangieri, VI, Napoli, 1954, p. 361, reg. 22 n° 1881; XI, 1958, p. 179, reg. 58, n° 6; XII, 1959, p. 98, reg. 63, n° 365; XX, 1966, p. 160, reg. 86, n° 8, etc. É comune opinione che il nucleo urbano medievale perpetuasse quello della Salapia romana: Meluta D. Marin, // problema delle tre «Salapia», in ASP, XXVI, 1973, p. 365-388, in particolare p. 370. Sede di diocesi fino al 1544, quando fu unita a Trani (R. Filangieri, m Codice Diplomatico Barese, X, cit., p. XI- XII), si ricollegava nell'organizzazione ecclesiastica all'episcopato della Salapia tar- doantica (cf. infra, n. 7), scomparso con la conquista longobarda, e ripristinato fra X e XI secolo. Per i confini della diocesi, D. Vendola, Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV. Apulia-Lucania, Calabria, Città del Vaticano, 1939, p. 38 e foglio 1.
Illustration non autorisée à la diffusion
LA TAVOLA DI TRINITAPOLI 255
Fig. 4 - Fogli 165 e 176 della carta d'Italia dell'IGM. È in evidenza il toponimo Chiavicella Grande. Una linea marcata indica il percorso della strada Salapia-
Canusium, secondo la ricostruzione di G. Alvisi.
256 ANDREA GIARDINA E FRANCESCO GRELLE
possiamo meglio precisare, le tombe ora distrutte, riadoperando in esse elementi di provenienza diversa, recuperati in un raggio piuttosto ampio. Nella geografia amministrativa di età tardoantica, la contrada si colloca infatti al confine fra i territori delle civitates di Salapia a nord e di Canu- sium a sud, e non ha conservato traccia, né lasciato memoria, di nuclei abitati di qualche rilievo. Ma l'iscrizione, come afferma la stessa legge in una delle sue clausole finali, era destinata ad perpetuitatem provisionis et gratiae celeberrimis [in] locis u[rbiu]m singularum 6 : il luogo di affissione andrà perciò ricercato in una delle due città vicine.
Distanti una ventina di chilometri in linea d'aria, Salapia7 e Canu- sium erano collegate in età romana da una strada pressocché rettilinea le cui tracce, ben evidenti alla fotografia aerea e sul terreno, tagliano contrada Chiavicella Grande. Lungo questo itinerario, in parte ancora per- corribile, e certamente praticato fino a quando Salapia, nella toponomastica medioevale Salpi, rimase un luogo abitato, la tavola marmorea sarà stata trasportata per dare maggior pregio ο sicurezza a una sepoltura rurale. La pratica dello spoglio e del reimpiego trova d'altra parte cospicui esempi nel territorio circostante, in particolare nella cittadella normanna di Canne e nella cattedrale romanica di Trani. A Canne e a Trani i materiali riutilizzati sono prevalentemente, anche se non esclusivamente, di provenienza canosina, sottratti agli edifici del nucleo urbano8. Anche
6 L. 20-21 (cf. infra, p. 285 con n. 140). 7 1 complessi problemi posti dalla topografia del territorio di Salapia e dalla
dislocazione stessa dei centri urbani indicati dalle fonti con questo toponimo sono stati affrontati più volte da Meluta D. Marin, da ultimo in // problema delle tre «Salapia», cit. La Marin colloca la Salapia dauna in località Torretta dei Monaci, dubita della sua identificazione con la'EXmaç straboniana, riafferma l'identificazione della Salapia romana con la fase antica dell'insediamento di Monte di Salpi, senza soluzione di continuità con l'abitato medioevale scomparso nel XVII secolo. Un saggio di scavo di A. Geniola, Saggi di scavo nel settore nord-occidentale di Salapia, in ASP, XXVI, 1973, p. 489-606, conforta quest'ultima ipotesi, comune peraltro fra gli studiosi di topografia antica : Giovanna Alvisi, La viabilità romana della Daunia, Bari s.d. (ma 1970), p. 98sgg. riconduce a Monte di Salpi le strade che riferisce a Salapia e, fra di esse, quella per Canusium.
8 L'origine canosina della maggior parte del materiale epigrafico e architettonico scoperto a Canne è segnalata da F. Bertocchi, Iscrizioni recentemente scoperte a Canne, in Atti del III Congresso Internazionale di Epigrafia, Roma 1957, Roma 1959, p. 203 sgg. Per le vicende militari e politiche della seconda metà del secolo XI, che sembrano intrecciarsi strettamente con lo sviluppo dell'edilizia locale, e quindi con il reimpiego di materiali di spoglio, cf. M. C. Ventrella, Note sulla contea di Canne, in ASP, XXVIII, 1975, p. 277 sgg. Già A. Degrassi, Consularis Apuliae et Calabriae, in Athenaeum, XXXIV, 1956, p. 97 sgg. = Scritti vari di antichità, I,
LA TAVOLA DI TRINITAPOLI 257
per la Tavola di Trinitapoli un'originaria collocazione a Canusium sembra ipotesi più convincente che non quella di una esposizione a Salapia. Sede del corrector, e più tardi del consularis Apuliae et Calabriae9, attraversata dalla via Traiana, che costituisce l'asse stradale della regione10, centro manifatturiero ancora di notevole rilievo11, Canosa doveva essere, fra IV e V secolo, la sede più adatta alla propositio di una costituzione imperiale, certo molto più adatta di quel che non fosse la piccola città delle saline 12. Un ostacolo a questa ipotesi non è costituito dalla maggiore lunghezza del percorso Canosa — Chiavicella Grande (circa dodici km) nei confronti di quello Salapia — Chiavicella Grande (circa sette km) : i miliari della via Traiana raccolti a Canne e soprattutto a Trani per essere riutilizzati nelle costruzioni medioevali mostrano come lo spoglio e il recupero si siano estesi ben oltre i venti km, fino a trenta in qualche caso, per lo meno dove sussistessero idonei raccordi stradali13.
A Canusium, la lastra marmorea doveva essere apposta al rivestimento dello zoccolo di un edificio, come mostra la posizione del campo epigrafico, che lascia scoperta la parte inferiore della superficie disponibile per cm 55, oltre un terzo, nelle dimensioni attuali. Se la trascrizione si
Roma, 1962, p. 645 sgg., aveva attribuito a Canosa una base di statua ritrovata nelle fondazioni del campanile della cattedrale di Trani e, con essa, altre simili rinvenute a Canne. Per i miliari dell'area canosina raccolti a Canne e a Trani, F. Bertoc- chi, op. cit.
9 A. Degrassi, op. cit. 10 G. Alvisi, op. cit., p. 31 sgg.; R. Gelsomino, L'«Itinerarium Burdigalense » e la
Puglia, in Puglia paleocristiana, Galatina, 1970, p. 205 sgg. 11 Cfr. F. Grelle, Canosa. Le istituzioni, la società, in Società romana e produz
ione schiavistica, a cura di A. Giardina e A. Schiavone, I, Roma-Bari, 1981, p. 219 sgg. Verso la fine del IV secolo (nel 398, come sembra) Paolino da Noia ripropone (Carni. 17, 21 sgg.) la celebrazione della porpora canosina, assumendo la produzione laniera a elemento caratterizzante l'intera Apulia.
12 Tagliata fuori così dalla via Traiana come dalla litoranea (Meluta D. Marin, op. cit., p. 386-387), Salapia non lascia quasi traccia nelle fonti letterarie del principato e della tarda antichità. L'istituzione della diocesi, sicura per il V secolo, è ora ricondotta agli inizi del IV da G. Otranto, Pardo vescovo di Salpi, non di Arpi, in VetChr, XIX, 1982, p. 159 sgg.; a Canosa, la diocesi è attestata nella prima metà del IV secolo (P. F. Kehr, Regesta pontificum Romanorum. Italia pontificia, IX, Berlin 1962, p. 315 sgg.; 337 sgg.).
13 Cf. la cartina della distribuzione dei miliari tracciata da F. Bertocchi, op. cit., tav. XXVIII : il miliario LXXXIII (CIL, IX, 6024), ora a Trani nella villa pubblica, era collocato, come sembra, immediatamente a ovest di Canusium, presso l'Ofanto, a trentuno chilometri di distanza in linea d'aria.
MEFRA 1983, 1. 17
258 ANDREA Gì ARDIN A E FRANCESCO GRELLE
proponeva di offrire qualche possibilità di lettura all'osservatore, si dovrà ritenere che la tavola non poggiasse direttamente sul piano di calpestio, e che non si prolungasse di troppo verso l'alto, oltre la frattura che oggi la delimita. Un confronto utile è offerto dalle lapidi che a Efeso conservano due epistole di Valente, inviate l'una al proconsole d'Asia Eutropio14 e l'altra al suo successore Festo15: si tratta infatti di epigrafi pressocché coeve della tavola di Trinitapoli, che riproduce, come si vedrà, una costituzione di Valentiniano I, e destinate anch'esse alla pubblicazione e alla conservazione di atti normativi imperiali. Affisse al podio del cosiddetto Ottagono, un monumento funerario ellenistico lungo la via dei Cureti, le lapidi efesine sono alte cm 159 e poggiano su una base riccamente modulata. La trascrizione della lettera a Eutropio si ferma ad una quarantina di cm dal margine inferiore delle lastre, quella della lettera a Festo, bilingue, porta il testo greco, posposto al latino, fino all'estremità.
Le iscrizioni di Efeso si distendono su più lastre verticali senza interruzioni; a Canosa, l'epigrafe era probabilmente disposta in colonne, e aveva inizio su una prima lastra, andata perduta. I frammenti a noi giunti conservano infatti le ultime disposizioni e l'epilogo di una costituzione che si intuisce lunga e complessa, e che sembra pertanto improbabile fosse contenuta tutta nella sola Tavola di Trinitapoli. Il frammento disperso avrebbe dovuto in tal caso riprodurre non solo buona parte dei precetti e l'intero preambolo, ma anche ì'inscriptio della lex, presumibilmente in forme grafiche più ampie di quelle usate per il testo.
La presenza, non improbabile, dell'editto di pubblicazione del prefetto ο del governatore 16, attestato da espliciti ordini imperiali e da subscrip- tiones di costituzioni pervenute attraverso la tradizione letteraria, potrebbe spiegare il silenzio sulla data e il luogo di emanazione del provvedimento17. L'ultima linea dell'epigrafe infatti, per quanto è possibile dedur-
14 Die Inschriften von Ephesos, 1 a, ed. Η. Wankel, Bonn 1979, n° 42 e tav. 33 = FIRA, F, n° 108.
15 Die Inschriften, cit., n° 43 e tav. 34. 16 Cf. 1. 18-19, riferite al prefetto al pretorio : Igitur praecelsa sublim[itas t]ua
innotescere omnibus faciat tam salutare decretum (ma editti prefettizi non escludono editti dei governatori di provincia : S. Mazzarino, Antico, tardoantico ed era co
stantiniana, I, Roma, 1974, p. 314). Per l'uso della formula, che caratterizza le leges générales secondo la classificazione di Valentiniano III in CI., I 14,3 pr.. (7 novembre 426), Franca De Marini Avonzo, La politica legislativa di Valentiniano III e Teodosio II, Torino, 1975, p. 91 sgg. (cf. anche infra, p. 285 con n. 140).
17 Fra gli esempi più interessanti vd. la subscriptio di Nov. Val. XXIII : proposi- ta in foro Traiani Vili id. April, antelata edicto Albini v.inl.p.p. et patricii. L'ordine dei documenti in essa indicato si ritrova anche nelle subscriptiones di Nov. Val. XXI
LA TAVOLA DI TRINITAPOLI 259
re dai segni scampati all'abrasione, non aveva alcun elemento di tal genere18. Si potrebbe cioè pensare che, riprodotta la data dell'editto, parte integrante della pubblicazione, sia apparso superfluo trascrivere anche gli elementi relativi alla datio (che peraltro mancano, per esempio, nelle due iscrizioni efesine).
2 - II testo
Z1 [ ]+rum s+ [ ] /2 [ ] +NET niim ager [ ] Ρ [ ] +ae invidia reos INDIV+ [ ]/4 [ ] +s s<a>nctionè ut intra provin[-c--] /5 [ ] ++natim exponäntur omnem reliquam [. .]/6 [ dei]nceps a{d} praepositis pagoruìn vel a'b' his quos Π [-cj4-]e cura con- plectitur mestrui{s} breves fideliter deligerfìerq(ue) /8 [-c-10- offijcio conpetenti a + + tabulano civitatis scribtüra tradatûr qua praes++QVE /9 [- -4- cogjnosci quàrftum et in qua specie diebus singulis singuli quiq(ue) dissolverin<t> quid/10yè ab uhoquoq(ue) trahatur iri^eliquis turn V[-Ci-4-]S+ rectores provinciarum quibus forma /u stiidioq(ue) [p]ostuietur nullus honerosus videri [- -6-] excurssus ac instructionè percebta /12 ad certiim aliquem locum per litteras super adventus VI [-c--6-]premissra"ls possesori/13bus exvo[c]atis eant ultro citroq(ue) per pagos et via[s]++DE++S rerum cum adnotationes/^concordte]? adpareärft viri- tim unumquemque super ratiocin[-c--6-] consulanî+-i--i-+/15 secûrita- [te]m ab universis adq(ue) inHicia functionis efflagiteriTcleincle ut pos- tquirn /16 praesentès [in]quisitionè conperere quid ab unoquoq(ue) fuerit ex[o]lutum adtentissimè /17 mox requ[ira]nt utruîh nullajm} suìhma spe- cie<r>uih recondeta sit quid a'verssorr1um fuerit /18 supputent [ex]amini- bus Probe parens carissirnè adq(ue) amantissiine igitür praecelsa /19 sublim[itas t]uà continuo innotescere omnibus faciat tam salutare
le di Nov. Val. XXV. Per Nov. Val. XXVII la subscriptio attesta invece : proposita in foro Traiani XIII KaLAug. sub edicto Firmini viri inl.p.p., con una sequenza analoga a quella che si può ipotizzare per la tavola di Trinitapoli. Cf. anche Sirm. 12, dove l'editto è sostituito dal programma del proconsole d'Africa. Il tema è sviluppato da O. Seeck, Regesten der Kaiser und Päpste, Stuttgart, 1919, p. 9 sgg., anche in riferimento alla divulgazione attraverso le epistulae del prefetto del pretorio; S. Maz- zarino, op. cit., p. 313 sg., lo ripropone per il nuovo editto di Emiliano consularis Campaniae (su cui infra, p. 277 sgg.).
18 La 1. 34 è leggibile per circa metà della sua lunghezza. La frase conservata, incompleta, non può in alcun modo riferirsi a una subscriptio : nec posse publicam admonitionem . . . (fig. 5).
260 ANDREA GIARDINA E FRANCESCO GRELLE
decretimi /20 quip[pe c]iim ad perpetuitatem provisionis et gratiae cele- berrimis [in] /21locis u[rbiu]m singularum tabulis id eris incidat hoc [t]a[nt]um enim remedio provi/22debitur [ill]arum frauâium quàe adtenus conpulso[ribus] perfidie officiisq(ue) p[er] /23 versis ube[r]rime profueruììt collubionè submota E+ S + ++ tanter accédât quid [publi/24cis] horrei[s p]ossessor invexerit nulla umqua<m> reliqua subtraha[n]tur nèmini super/25adeiciat gr[ava]men alienum sub nomine âutem quid per singulos quosq(ue) veter+i-0^ - /26 -c^-]ionis [per]solutuïh sit nominatori breves mera luce significent nullum /27+x[-c--]EM+S [-c--] gere quod non inultiim [sit] iudex autem concordiäm habitet /2S [et] gratiàïh+ + + post hanc nostrae mànsuetuxlinis legem publicis adq(ue) privatis fo++/29+ + + consulen[t]em et ++và+ibus quoq(ue) titulis con- secrataìh vel cohibent+ + +/30+A [-c--]daverit vel çuïh aliqua ex his+ + inproba+ + + + +s fuerint+ + + + prae/31 + +ens [-c--]+ sed nihilomi- nus denuntiamus adq(ue) [ ] ultima/32 eum severitate [in]pl[e]ctenduïn qui vel ++r+tum vel his pl[ ] /33 M+ + + ++EN++ damnatione degnis- simus est qui [ ] /34 nec posse publi[c]am admonitionem
6 Β pro D correcta fuisse videtur 7 mestruis pro menstrui lapis n honerosus pro onerosus excurssus pro excursus ac pro hac u V pro A possesori- bus pro possessoribus 17 averssosum pro aversorum 22 adtenus pro eate- nus 24 25 superadeiciat pro superadiciat 26 A pro Ο
Le forme grafiche del testo19 sono per il momento prive di riscontro nell'epigrafia locale. Le legature, comprendenti talvolta anche tre lettere, sono frequentissime, ma appaiono senza alcuna uniformità. La congiunzione -que risulta regolarmente abbreviata in q(ue), tranne in un caso alla 1. 14 (unumquemque) ; un'altra abbreviazione è intuibile nelle due lettere prima di tabulano alla 1. 8. Non mancano inoltre anomalie ortografiche, alcune forse dipendenti da un procedimento di dettatura della minuta burocratica in una fase precedente l'incisione : si noti per esempio la caduta della η in mestrui (1. 7), della t in dissolventi (1. 9), della m in umqua (1. 24), della h in ac (1. 11), il raddoppiamento della s in excurssus (1. 1 1) e averssosum per aversorum (1. 17); si noti anche la b in luogo della ρ in scribtura (1. 8) e percebta (1. 11), e in luogo della ν in collubione
19 Che qui si trascrive secondo i criteri indicati da H. Krummrey-S. Panciera, Criteri di edizione e segni diacritici, in Tituli, 2, 1980, p. 205-215; cf. anche S. Panciera, Segni diacritici, in Supplementa Italica, n.s., 1, 1981, p. 13-19.
LA TAVOLA DI TRINITAPOLI 261
(1. 23). Frequente inoltre, come ovvio in documenti di quest'epoca, la e al posto della i : deligenterq(ue) (1. 7), recondeta (1. 17), degnissimus (1. 3); il dittongo ae è normalmente indicato, tranne in premissas (1. 12) e eris (1. 21); si noti anche superadeiciat per superadiciat. Non mancano errori : us per os nell'accusativo plurale per attrazione da un precedente us (1. 12), am per a nel nominativo singolare (1. 24), a per ο in nominatari (1. 26), oppure banali cadute di lettere come in snctione (1. 4). Almeno in un caso il lapicida è intervenuto sulle lettere già incise per modificarle (1. 6). Particolare attenzione merita il disegno della lettera H, che nella capitale libraria non si ritroverebbe prima del V secolo20. La confusione della Β con la D alla 1. 6 e della V con la A alla 1. 12 potrebbe far pensare alla trascrizione da una minuta stesa nella corsiva nuova burocratica, adottata dai funzionari dell'amministrazione tardoantica.
3 - Le norme
Le prime cinque linee dell'epigrafe non sembrano permettere convincenti ipotesi di restituzione. Va comunque rilevato il riferimento alle province nella 1. 4 che potrebbe integrarsi intra provin\_ciam ο provin[cias, oppure intra provin[ciae ο provin[ciarum fines (come p. es. in C.Th. V 6, 3), e nella successiva, quello a un'accurata esposizione (nomQnatim expo- nantur, secondo l'ipotesi più aderente al senso complessivo del documento), forse di elenchi relativi ad arretrati, se omnem reliquam sono attributi di un sostantivo indicante prestazioni fiscali.
Le 1. 6-10 conservano una minuziosa disciplina delle registrazioni che accompagnano i prelievi di tributi in natura. Alcune frasi sono andate smarrite ο restano illeggibili, ma le lacune non sembrano compromettere il senso complessivo del discorso. La costituzione prevede che rendiconti mensili (menstrui breves) siano compilati dai praepositi pagorum e da quanti altri assumano una cura il cui oggetto era indicato nella parte smarrita della 1. 7, ma che sembra comunque potersi identificare con la sorveglianza degli horrea publica. L'associazione dei praepositi dei pagi a quelli degli horrea ritorna infatti nelle due sole costituzioni che nel Teodo- siano tracciano una disciplina della praepositura pagorum, proprio perché i compiti degli uni e degli altri appaiono assai simili e strettamente intrec-
20 Cf. A. Pratesi, Appunti per la datazione del Terenzio Bembino, in Palaeogra- phica Diplomatica et Archivistica, Studi in onore di G. Battelli, 1, Roma 1979, p. 71- 84.
262 ANDREA GIARDINA E FRANCESCO GRELLE
ciati, nell'organizzazione del sistema tributario21. D'altra parte un riferimento agli horrea si incontra alla 1. 24, in un contesto che sembra riassumere i punti salienti della normativa introdotta dalla costituzione, e che documenta pertanto come essa regolasse in qualche modo anche le attività dei praepositi horreorum. Alla 1. 8, la lacuna iniziale doveva contenere una forma verbale passiva, per indicare l'operazione di cui sono oggetto i breves22, e una formula che collegasse la prima fase del procedimento di registrazione alla seconda, descritta nella proposizione che segue. Il tabu- larius civitatis è chiamato infatti a coordinare i dati raccolti nei breves relativi ai singoli pagi, e a riproporli in una relazione scritta sull'andamento complessivo del prelievo delle imposte nel territorio della civitas, da trasmettere all'ufficio del governatore provinciale. Una ricostruzione del passo può essere tentata in questi termini : deQnceps a praepositis pagorum vel ab his quos/\horreorum maxim\e cura conplectitur menstrui breves fideliter deligenterq(ue)/[subdantur et offi]cio conpetenti a + + tabulano civitatis scribtura tradatur qua praes[to] que/\_atur cog]nosci quantum et in qua specie diebus singulis singuli qui{que) dissolverint, quid/ve ab unoquoq{ue) trahatur in reliquis23. In questa ipotesi breves subdantur alluderebbe alla lettera di trasmissione cui i rendiconti andrebbero allegati, con una formulazione simile a quella di CTh., XIII 4, 2 (2 agosto 337) : artium brevi subdito comprehensarum. Lo spazio disponibile sulla pietra permette, in alternativa, d'integrare commeent, con un'espressione che si ritrova in CTh., I 16,3 (24 ottobre 318 Seeck) : breves omnium negotiorum ab officio tuo descripti commeent ad scrinia eminentissimae praefecturae. Officio conpetenti è integrazione palmare, confermata dalla fraseologia di altre costituzioni, CTh., Vili 1,3 (5 maggio 333) : conpetentia officia, CTh., I 14,1 (17 febbraio 386): officia iudicum conpetentium. Difficoltà notevoli presenta l'integrazione delle due lettere fra a e tabularlo; assai probabilmente si nasconde qui un'indicazione di rango ο un epiteto, ridotti a una
21 Cf. CTh. VII 4, 1 : (19 ottobre 325) : ut procuratores seu susceptores vel praepositi pagorum et horreorum earn [seil, annonarii] comparent; C.Th. XII 6,8 (30 luglio 365) nominatores susceptorum et eorum qui ad praeposituram horreorum et pagorum creantur. Per la storia della praepositura pagorum nel IV secolo, infra, §8.
22 Sui breves nell'organizzazione amministrativa tardoantica infra, p. 278-282. 23 Altre integrazioni, non facili a prospettarsi, potrebbero in teoria identificare
la scribtura con i breves, e riconoscere nel tabularius il destinatario della trasmissione, riducendone il compito alla ricezione e alla custodia dei rendiconti. Ma in questa ipotesi sarebbe assai difficile spiegare il successivo riferimento a una instruetio (1. 11) che invece sembra richiamare proprio la relazione del tabularius.
LA TAVOLA DI TRINITAPOLI 263
sigla, per la quale non sembra opportuno proporre ipotesi, nell'assenza di adeguati riscontri nei documenti coevi24.
Le 1. 10-17 tracciano, in un passo la cui struttura formale resta in qualche misura incerta, uno schema di regolamento per i controlli che i governatori provinciali sono chiamati a compiere, ricevuta la relazione del tabularius : Turn u[niver]s[i]?? redores provinciarum, quibus forma/ studioq{ue) [p]ostuletur nullus honerosus videri — excurssus, ac in- structione percebta,/ad certum aliquem locum per litteras super adven- tus<s>ui [tempore] premissas25 possesori/bus exvo\c\atis, eant ultro ci- troqiue) per pagos et via[s]. L'instructio dei subalterni, come momento iniziale di un procedimento complesso, è ricordata di frequente nelle costituzioni del Teodosiano : così in CTh. I 12,2 (26 dicembre 319) : si fidelis èst ea instructio, in CTh. XIV 4,2 (11 aprile 324 Seeck) : instructione hac a tua gravitate perpensa, e altre26. Sollecitato da essa, il governatore percorrerà i pagi, curando che la visita non risulti onerosa per gli amministrati, e promuoverà incontri con i possessori locali, convocati in luoghi predeterminati attraverso la preventiva comunicazione del momento delì'adven- tus27, in lettere inviate alle autorità competenti (delle civitates, e dei pagi, probabilmente28). L'abrasione al centro della 1. 13 ha cancellato il collegamento fra queste disposizioni e le successive, articolate, come sembra,
24 Va qui sottolineato un aspetto che dovrebbe assumere un carattere di metodo nello studio di testi epigrafici che hanno subito il particolare tipo di alterazione occorso alla Tavola di Trinitapoli. Proposte d'integrazione sono sempre teoricamente possibili, ma in certi casi (p. es. prima di tabularius) non sembrano pienamente accordarsi con taluni segni che s'intravedono alla luce radente, e che, pur non componendosi in lettere complete, sembrano non conciliarsi del tutto con le lettere proponibili in integrazione. A chi legge resta pertanto il dubbio se si tratti di lettere precedentemente scolpite e poi corrette dal lapicida, portate infine in superficie dalla smerigliatura recente del testo, da segni casuali causati dalla smerigliatura stessa ο di vere e proprie tracce della scrittura definitiva. Certo è che risulta difficile, in questo luogo, e in altri della nostra epigrafe, operare come se il testo fosse totalmente lacunoso.
25 Nelle costituzioni del Teodosiano, super è di solito usato con l'ablativo : solo in tre attestazioni, sulle oltre cento complessive, regge l'accusativo. Per litterae praemissae super, cf. Th.l.L., s.v. 'luterà'.
26 Cf. CTh. XI 1,13 (18 ottobre 365). 27 Per X'adventus e l'excursus del governatore, cf. § 7. 28 L'invio di lettere ai praepositi pagorum da parte dei governatori provinciali è
previsto dalla clausola di pubblicazione dell'epistula di Sabino, prefetto del pretorio di Massimino, nel 311 : Eus., Hist.eccl. IX 1,6 : γράψαι τοιγαροΰν προς τους λογι- στας και τους στρατηγούς καί τους πραιποσίτους του πάγου εκάστης πόλεως ή σή έπιστρέφεια οφείλει. Cf. infra, §8.
264 ANDREA GIARDINA E FRANCESCO GRELLE
in più periodi : — rerum cum adnotationes /concordas adpareant, viritim unumquemque super ratiocin\iis — consulant — securita\te]m ab universis adq(ue) indicia functionis efflagitent deinde ut, postquam/praesentes \in\quisitione conperere quid ab unoquoq(ue) fuerit exolutum, adtentissi- me/mox requ[ira\nt utrum nulla summa specierum recondeta sit. Il governatore dovrà interrogare i possessores che abbiano provveduto al conferimento dell'imposta in natura, e verificaré la corrispondenza fra le loro dichiarazioni e le quote registrate a loro nome nei conteggi dal tabularius civitatis29. Allo stesso modo nel 372 una costituzione di Valentiniano I richiede al governatore provinciale un controllo dei ratiocinia : si quando ex allectis vel susceptoribus aut tabulants quispiam ratiocinio sive fraude perhibetur obnoxius (CTh. I 15,6). Il controllo si estenderà anche alle quietanze, e analizzerà ogni altra prova (indicia) che il contribuente potrà addurre a conferma dell'adempimento della prestazione (functionis) : si accerterà così se le species conferite non siano state in qualche misura occultate30.
Le 1. 17 e 18 introducono l'indirizzo a un altissimo funzionario di nome Probus, che l'imperatore qualifica come parens, e la cui identificazione consente di datare il documento31; segue la clausola di stile che sollecita la pubblicazione dell'atto imperiale32. Nel passo, in cui il redattore addensa le formule dell'encomiastica celebranti la provvidenza imperiale, si legge : quid aversorum fuerit/[scì\. rectores provinciarum] supputent [ex]aminibus, Probe parens carissime adq(ue) amantissime. Igitur praecel- sa/sublim[itas t]ua continuo innotescere omnibus faciat tam salutare decre- tum,/quip[pe c\um ad perpetuitatem provisionis et gratiae celeberrimis [inVlocis u\rbiu\m singularum tabulis id eris incidat. L'uso di tavole bronzee costituisce una prescrizione ricorrente negli atti normativi di quest'epoca, di fatto non sempre rispettata. La nostra costituzione, tra-
29 Cfr. n. 23. 30 Le linee della politica istituzionale che ispira e sorregge questo sistema di
controlli sono esaminate infra, § 5. 31 Per l'identificazione del Probus qui ricordato, e le vicende della sua carriera
(in particolare della sua prima prefettura, che costituisce il terminus post quern della Tavola di Trinitapoli), cf. § 4.
32 Raccoglie e studia le formule conservate in particolare dalle novelle post- teodosiane, F. von Schwind, Zur Frage der Publikation im römischen Recht, München, 1940, p. 177 sgg. ; cf. A. J. Fridh, Terminologie et formules dans les Variae de Cassiodorus, Stockholm, 1956, p. 162 sgg.; N. van der Wal, Edictum und lex edic- talis. Form und Inhalt der Kaisergesetze im spätrömischen Reich, in RIDA, XXVIII 1981, p. 277 sgg.
LA TAVOLA DI TRINITAPOLI 265
scritta su marmo a Canusium, potrebbe comunque essere stata riprodotta su bronzo in altre città. Il riferimento a urbes singulae, in un contesto diverso, si ritrova anche nell'epistola di Valente a Eutropio già ricordata33.
L'epilogo si prolunga nelle linee successive, in forma articolata e complessa, singolare se la si pone a raffronto con quella che presentano le clausole finali delle costituzioni tramandate dalle raccolte legislative tardoantiche, anche nei casi in cui il processo di «massimazione» non ha alterato significativamente la redazione originaria. La pubblicazione del provvedimento imperiale, si afferma perentoriamente, porrà rimedio alle frodi che hanno arricchito esattori e funzionari degli uffici provinciali, considerati evidentemente in collusione abituale con i praepositi pagorum e i tabularli civitatum : Hoc [t]a[nt]um enim remedio provi/ debitur \ilÎ]arum fraudium quae eatenus34 conpulso\ribus] perfidis officiisq{ue) p[er\/versis uber[r]ime pro[f]uerunt. Il rapido richiamo all'intreccio di interessi e di complicità fra il personale degli uffici e gli addetti agli archivi cittadini implica una più diffusa analisi, svolta forse nel prologo, ο comunque in una delle parti del documento smarrite. Il discorso prosegue quindi con una costruzione paratattica che sottolinea per ciascuna fase del procedimento di riscossione i benefici apportati dalla nuova legge : collubione submota — accédât quid [publi/cis] horrei\_s possessor inve- xerit. Nulla umquam reliqua subir aha[n]ur. Nemini super /adeiciat gr[ava]men alienum. Sub nomine autem quid per singulos quosque veter[is cuiusq{ue)/conlati]onis [per]solutum sit, nominatori breves mera luce signi- ficent. L'integrazione publicis horreis alle 1. 23-24 è da considerarsi sicura : così infatti in CTh. VII 4, 32 (del 419), in CTh. XI 28, 16 (del 433), e in altre costituzioni. Ipotesi diverse, come fiscalibus horreis 35, ο ex suis horreis36, sono da escludersi la prima perché eccedente, la seconda perché
»Cf. urbium singularum di CTh. XVI 2,40 (25 maggio 412), 1. 3; Nov.Val. Ili (28 agosto 439), 1. 2; Nov.Maior. Ili (8 maggio 458), 1. 17; l'espressione può essere avvicinata a civitates singulae di CTh. XI 1,2 (8 novembre 313: per la data, O. Seeck, Regesten, cit., p. 78) ο di Cassiod., Var. XII 18,3. Per le forme e i materiali ai quali si fa ricorso nella pubblicazione degli atti imperiali nella prassi tardoan- tica, cf. infra, n. 140.
34 Un uso simile di eatenus si ritrova, p. es. in CTh. XIII 5,20 (12 aprile 392) : Eum qui agentum in rebus militiam adeptus est, certis et debitis, eatenus navicula- riae inquietudinis suspicione submota, fruì privilegiis non vetamus; cf. anche Symm., Ep. VII 27.
35 Cf. p.es. CTh. VII 4,16 (8 aprile 368). 36 Cf. p.es. CTh. XI 1,2, cit. a n. 33.
LA TAVOLA DI TRINITAPOLI 267
inadeguata allo spazio disponibile sulla pietra. Nessuna di esse, in ogni caso, altererebbe il senso complessivo del periodo. Il cenno ai reliqua, alla 1. 24, allude a frodi praticate sugli arretrati, denunciate evidentemente nella parte del documento che non ci è pervenuta, forse in immediata connessione con le prime linee del testo tradito, se una traccia di quella trattazione può scorgersi nella frammentaria 1. 5. Alla 1. 25, la lettura di gravamen è confortata da un uso costante della cancelleria, a partire dall'età tetrarchica37. I nominatorii breves della 1. 26 ricordano i breves debitorum predisposti nominatim dal tabularius civitatis, secondo il dettato di una costituzione costantiniana del 313 (CTh. XI 1,2); l'espressione, nella forma nominatorii breves, ritorna nel Teodosiano in due sole costituzioni, più tarde del nostro documento38.
Alla fine della 1. 26 ha inizio una clausola sanzionatoria sviluppata in più periodi, che si prolunga fino al termine del testo epigrafico : le miserevoli condizioni della superficie iscritta rendono disperato ogni tentativo di restituzione integrale del discorso. È comunque possibile cogliere le linee generali del passo, che sembra alternare esortazioni e minacce di pene severe, in un contesto di elaborata costruzione retorica : — quod non inultwn [sit]. Index autem concordiam habitet/\et\ gratiam — post hanc nostrae mansuetudinis legem publicis adq(ue) privatis fo[rt/unis~\ con- sulen[t]em et [di\va\t\ibus quoque titulis consecratam — Sed nihilominus denuntiamus adqiue) — ultima/eum severitate — [in\pl[e]ctendum qui vel — vel — damnatione degnissimus est qui — nec posse publi\c\am admoni- tionem. Alla 1. 29 divalibus è integrazione confortata da un uso ricorrente del termine per qualificare i precetti imperiali: CTh. Vili 1,5 (6 maggio 357): divalla statuta; CTh. XI 16,17: divali lege (11 dicembre 385), e molte altre attestazioni. In questa ipotesi, tituli potrebbe forse indicare, per traslato, i capitoli del documento. Ma altre interpretazioni sono senz'altro proponibili, in quanto titulus presenta in vari contesti un ventaglio alquanto instabile di significati39.
37 Cf. CI. IV 49,9: gravamen functionis (18 giugno 293 Mommsen); CI. IV 49,13 : functionum gravamen (2 dicembre 294); cf. anche n. 99.
38 Cf. CTh. XI 28,3 (25 giugno 401): ordinarii indices nominatorios breves absque ulta conscribtos fraude transmutant ; CTh. I 10,8 (28 febbraio 428): neque nominatorios breves [seil, palatinus] a tabulano postulabit.
39 Cf. p.es. CTh. XIV 16,1 (10 maggio 409 : per la data, O. Seeck, Regesten, cit., p. 92): Quingentas auri libras... huic titulo consecramus ; ma anche CTh. X 9,1 (29 marzo 369).
268 ANDREA GIARDINA E FRANCESCO GRELLE
4 - La prima prefettura di Sex. Clavdivs Petronivs Probus
II documento è databile a partire dalla formula di saluto della 1. 18 : Probe parens carissime adqiue) amantissime. Mai conservate nel Teodosia- no e nel Giustiniano, formule di saluto così complete ricorrono invece frequentemente nei testi più vicini, per forma e contenuto, agli originali delle cancellerie centrali : le Sirmondianae, le Novellae, e naturalmente le costituzioni pervenute per via epigrafica 40. Rivolte quasi sempre ai prefetti al pretorio41, ai prefetti urbani42, ai magistri militum43, tutti definiti parentes dell'imperatore, queste formule riguardano anche, ma con la significativa modifica di parens in frater, funzionar! quali i magistri offi-
40 In generale, sulle formule di saluto, E. Volterra, // problema del testo delle costituzioni imperiali, in Atti del II Congresso Internazionale della Società italiana di storia del diritto , Venezia 1967, Firenze, 1971, p. 948-951 ; N. van der Wal, op. cit., p. 281 sg.
41 Elenco per anno. 333 : Sirm. 1 ; 336: Sirm. 4; 380 : Sirm. 7; 405 : Sirm. 2; 407 : Sirm. 12; 408 : Sirm. 9; 16; 409 : Sirm. 14; 438 : Nov.Th. I; III; IV; Nov.Val. I 1; 439: Nov.Th. V 2; VII 1; VIII; IX; X 1; X 2; XI; XII; XIII; XIV; XVI; XVII 1; XVIII; Nov.Val. III; 440: Nov.Th. VII 2; VII 3; XX; Nov.Val. IV; VII 1; 440/441 : Nov.Val. I 2; 441 : Nov.Th. V 3; Nov. Val. X; 442 : Nov.Th. XXII 1 ; Nov.Val. II 2; VII 2; 443 : Nov.Th. XXII 2; XXIII; Nov.Val. II 3; VI 2; XII; 444 : Nov.Th. XV 2; XVII 2; XXVI; Nov.Val. XIV; 445 : Nov.Val XIII; XVIII; 446: Nov.Val. XXI 1; XXI 2; XXII; 447 : Nov.Val. XXIII; XXV; 448 : Nov.Val. XXVI; 449 : Nov.Val. XXVII; 450 : Nov.Marc. II; 451 : Nov.Val. XXXI; XXXII; XXXIV; Nov. Marc. III; 452: XXXV; XXXVI; 454 : Nov.Val. II 4; Nov.Marc. IV; 455 : Nov.Marc. V; 458 : Nov.Maior. II; VI; VII; 463 : Nov.Sev., I; 468 : NovAnth. I; II. — II titolo ai parens dell'imperatore ê già connesso alla prefettura al pretorio nella posizione di Ulpiano (ad Domitium Ulpianum praefectum praetorio et parentem meum: CI. IV 65,4, anno 222); cf. anche, nella Historia Augusta, la lettera di Valeriano a Ragonius Clarus, che è detto praefectus Illyrici et Galliarum e parens (SHA, Tyr. Trig. 18,5). In CIL III 352 e 7000 = ILS 6091 = FIRA P, n° 95 il prefetto al pretorio Ablabius è detto carissimus (col. I, 1. 8) e carissimus et iucundissimus (col. II, 1. 16), senza ulteriori appellativi.
42 Nov.Val. Vili 1 (440); Vili 2 (441); XI (443); XX (445); XXIX (450); Nov.Maior. IV (458). Cf. anche la famosa epistola di Valeriano al prefetto urbano Ceionius Albinus, sulle competenze di Aureliano (SHA, A. 9,6) : S. Mazzarino, // pensiero storico classico, II 2, Bari, 1966, p. 307. - Petronius Maximus, ex prefetto urbano e al pretorio, nel 445 è detto parens e vir inlustris patricius (Nov.Val. XIX; cfr. PLRE, II p. 750).
43 Nov. Val. VI 1 (440); Nov.Th. VII 4 (441); Nov.Val. XVII (445); XXXIII (451). In FIRA I2, n° 93, 1. 4 e 8 il magister militum Dalmatius è detto ancora semplicemente carissimus. - Per la problematica di parens principum in età stiliconiana, J. Sträub, Regeneratio imperii, Darmstadt, 1972, p. 220-239.
LA TAVOLA DI TRINITAPOLI 269
ciorum44, i comités rerum privatarum45, i comités sacrarum largitionum46, e con l'assenza di qualsiasi appellativo familiare (il semplice epiteto carissime) funzionari quali i consulares47 e i vicarii4*. Anche all'interno di iden- tiche categorie di rango sembra dunque delinearsi una sottile distinzione tra parentes dell'imperatore e fratres : un aspetto questo, degno di una certa considerazione. L'uso di epiteti attinti al lessico familiare nelle formule imperiali di saluto alle alte gerarchle civili e militari si presenta infatti con una tendenza alla precisione che introduce elementi di ulteriore formalismo nell'universo, già così formale, dei ranghi e degli onori tar- doantichi. Un magtster officiorum, per esempio, condivideva con il prefetto al pretorio il rango di vir illustris49, ma era, nei testi citati a n. 44, soltanto frater, non parens dell'imperatore : l'ascesa degli uffici centrali nella gerarchla degli onori, espressione del potere crescente di un ceto di amministratori specializzati, veniva in qualche modo temperata anche col ricorso a distinzioni sofisticate, che proprio nella loro apparente innocuità rivelano la presenza di una non sopita tensione.
Il Probus che è detto parens nella formula di saluto della Tavola di Trinitapoli è identificabile nella persona di Sex. Claudius Petronius Pro- bus, il più famoso prefetto al pretorio della tarda antichità. Che di un prefetto al pretorio debba trattarsi è certo non tanto per le considerazioni svolte precedentemente sulla qualifica di parens (che pure sembra avere, come si è visto, una sua 'tecnicità', raf forzabile per altro con l'osservazione che sublim[itas t]ua alla 1. 19 è anch'essa un'espressione riservata a personaggi di massimo rango50), ma per il fatto che il destinatario appare
«Nov.Th. XXI (441); XXIV (443); XXV (444); Nov.Val. XXVIII (449); XXX (450).
45 Nov.Th. V 1 ; VI (438); XIX (440); Nov.Maior. V (458). 46 Nov.Val. VI 3 (444); VII 3; XXIV (447). 47 Nov.Maior. IX (459). - Al tempo di Cassiodoro il rector era detto frater; la
precisazione di Cassiod., Var. VI 21 (a principe frater vocaris) conferma la linea di tendenza all'uso tecnico (connesso cioè prima alla carica che alla persona) di tali formule.
48 Se è un vicario l'Antiochinus di Sirm. 8 (386) : PLRE I, p. 70. - Per altri esempi di formule di saluto (IV secolo) ad alti funzionari col solo appellativo carissime, cf. CI. Ili 12, 1 (305); X 72,7 (383); si osservi tuttavia che in quest'ultimo caso la formula di saluto è nell inscriptio, il che non esclude una ripetizione più ampia all'interno del testo originario della costituzione, ο in fine.
49 M. Clauss, Der magister officiorum in der Spatantike (4. -6. Jahrhundert), München, 1980, p. 100-102.
50 Cf. i riferimenti e le osservazioni di S. Roda, Commento storico al libro IX dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco, Pisa, 1981, p. 201-202, 224. Il rafforzamento
270 ANDREA GIARDINA E FRANCESCO GRELLE
dotato di competenze sui redores provinciarum (1. 10). D'altro canto l'unico prefetto al pretorio d'Italia dal diacritico Probus a noi noto è appunto Sex. Claudius Petronius Probus51. Egli fu prefetto al pretorio Italiae, Illy- rici, Africae, Galliarum quattro volte : nel 368-375 (6), nel 380, nel 383/4, nel 387. La prima e più lunga delle sue prefetture, che dal 368 al 370 si cumulò col proconsolato d'Africa (come attesta una nuova epigrafe capuana52) e nel 371 col consolato ordinano, ebbe inizio, come si è accennato, nel 368; quell'anno infatti, secondo la precisa testimonianza di Am- miano, Probo fu chiamato a succedere a Vulcacio Rufino : Per haec tem- pora Vulcacio Rufino absoluto vita, dum administrât, ad regendam praefec- turam praetorianam ab urbe Probus accitus . ..."; per haec tempora si riferisce alle vicende della campagna alamannica del 368, e questa data coincide con il fatto che l'ultima costituzione trasmessa a Rufino si data al 19 maggio 367 54. Lo stesso Ammiano afferma che nell'estate del 375 Probo ricopriva ancora la prima prefettura : hic praefecturam praetorio lune
di sublimitas con praecelsa è da cf., p. es., con praecelsa magnificentia di un testo come Sirm. 10.
51 II console del 310, Pompeius Probus, fu prefetto al pretorio in Oriente, tra il 310 e il 314 (PLRE I, p. 740); di altri Probi prefetti non abbiamo notizia, nemmeno nel secolo successivo, né abbiamo notizia di governatori di tale nome operanti in Italia. - Per l'ulteriore storia degli Anicii, ora soprattutto S. Mazzarino, Conv. Int. Passaggio dal mondo antico al medio evo da Teodosio a S. Gregorio Magno, Roma 1977, Conv. Lincei 45 (1980), p. 269, n. 63; Ch. Pietri, Une aristocratie provinciale et la mission chrétienne: l'exemple de la Venetia, in AntAltoadr, XXII, 1982, p. Ili sgg.
52 G. Barbieri, Nuove iscrizioni di Capua, in Terza miscellanea greca e romana, Roma, 1971, p. 298-304 = AE 1972, 76; per il testo, cf. S. Mazzarino, Antico, tar- doantico ed èra costantiniana, I, Bari, 1974, p. 334-338 : Claudio Petronio Probo v(iro) [chiarissimo)],/ proconsuli Africae et s{acra) [yiice) iudiicanti)], / uno eodemque tempore (e)t [inde?] / praetorio prefectura pol[lenti], /consult ordinario, nobilitale] / munificentiaque praestanti, / originali patrono, regiones / collegia posuerunt. Una diversa integrazione della 1. 4 che eliminerebbe di fatto la contemporaneità tra proconsolato e prefettura, è stata recentemente proposta da A. Chastagnol, L'inscription de Petronius Probus à Capoue, in Tituli, 4, 1982 {Atti del Colloquio Epigrafia e ordine senatorio), p. 547-550 : è però impossibile integrare 7 lettere alla 1. 4 (pol[lenti et]) e solo due alla 1. precedente ([in]) se lo spazio mancante è identico; l'alternativa, proposta dallo stesso Chastagnol, d'intendere uno eodemque tempore senza il duplice et ma comunque collegante la seconda e la terza carica (la prefettura e il consolato) trova ancora minori possibilità di riscontro nell'articolazione complessiva del testo epigrafico : cf. A. Giardina, in Tituli, 4, 1982, cit., p. 550 sgg.; Id., Lettura epigrafica e carriere aristocratiche : il caso di Petronio Probo, in corso di stampa su RIFC 1983.
«Amm. XXVII 11,1. 54 C.Th. X 15,4. Sulla carriera di Rufinus, PLRE I, p. 782-783.
LA TAVOLA DI TRINITAPOLI 27 1
primitus nanctus, eamque multis atque utinam probabilibus modis in Ion- gum proferre gestiens55. . . È dunque chiaro che in nessun caso potranno attribuirsi a Probo altre prefetture prima del 368 : la vecchia ipotesi di Seeck56, recentemente ripresa57, di una prefettura gallica nel 367 è smentita dalla dedica romana di Veneti adque Histri databile con esattezza ali '8 agosto 378; qui infatti non si ricorda nessuna prefettura gallica, ma una prefettura per Illyricum Italiani et Africani 58. Questa convergenza di testimonianze eterogenee vale dunque a fissare con certezza la data d'inizio della prima prefettura di Probo, e con essa il terminus post quem della Tavola di Trinitapoli.
In questa prima prefettura a Probo risultano indirizzate quaranta costituzioni, nelle altre tre, tutte di brevissima durata, soltanto quattro59. Più che da questo dato puramente numerico (anche se non trascurabile) la connessione tra la nuova epigrafe e la prima prefettura di Probo emerge da alcune considerazioni di carattere generale, riguardanti la politica fiscale degli imperatori che da Valentiniano I a Teodosio affidarono a Probo una prefettura italica (tutte e quattro le prefetture di Probo compresero infatti, variamente connessa, l'Italia60). Una soluzione al proble-
55 Amm. XXX 5,4 : sull'inutilità e inammissibilità di correzioni quali haud primitus ο <ηοη> tutte primitus, osservazioni decisive in S. Mazzarino, op. cit., p. 329.
56 0. Seeck, Regesten, cit., p. 128. 57 Ma con anticipazione di un anno : cf. η. sg. 58 CIL VI 1751 = ILS 1265, 1. 8-14 : v(iro) c(larissimó) proconsuli Africae / prae-
fecto praetorio/ per Illyricum Italiani et Africani, / consult ordinario,/ ob insignia erga se remediorum genera / Veneti adque Histri peculiares eius, /patrono praestan- tissimo. . . (cf. S. Mazzarino, op. cit., p. 338, n. 23 e infra, p. 293). - L'impostazione della carriera di Probo in PLRE I, p. 736-740 è pertanto errata : oltre a una prefettura gallica nel 366 essa mantiene anche una prefettura d'Illirico nel 364; quest'ultima sarebbe attestata da un'unica costituzione (C.Th. I 29,1) che già Seeck (Regesten, cit., p. 91) datava al 368 (riprendendo un'osservazione di Mommsen, ad L, ritrattata tuttavia ad C.Th. XI 1,15); che il consolato di questa costituzione sia errato è evidente dalle testimonianze sopra esaminate, le quali, è bene sottolinearlo, si integrano a vicenda ed escludono qualsiasi prefettura di Probo prima del 368. - Come già osservava Seeck (p. 92), I 29,1 sembra in ogni caso precedente a I 29,3 e 4, ambedue del novembre 368 : essa andrà dunque datata al 27 aprile 368. Quanto a XI 1,15, anch'essa, per i motivi già detti, andrà datata non prima del 368, anche se non è possibile precisare un anno che sia probabile.
59 Per un primo riscontro, O. Seeck, Regesten, cit., p. 461. 60Com'è evidente dall'insieme della documentazione e in particolare dalla
dedica veronese CIL V 3344 = ILS 1266, che applica un criterio territoriale e definisce quindi Probo praef. /praetorio Illyrici,/ praef.praet. Gal /liar. II, praef.praet./Italiae atque Africae/IIII (da non correggersi in /// : S. Mazzarino, op.
272 ANDREA GIARDINA E FRANCESCO GRELLE
ma della datazione potrà in altre parole venire soltanto da un inquadramento della normativa espressa nel nostro testo in tutta la politica fiscale di questi decenni quale risulta dalle costituzioni pervenute nelle consolidazioni e in altri testi epigrafici.
5 - La politica fiscale di Valentiniano I
II decennio di Valentiniano e Valente Augusti occupa, nella storia dell'economia e del diritto tardoromani, una posizione «particolare». Questa osservazione61 illumina la specifica caratteristica di esperienze amministrative convergenti nella particolare attenzione rivolta al problema dell'esosità fiscale quale risultato di gravosi procedimenti di riscossione. Si tratta di una politica in certa misura lontana dai sofferti eccessi che qualificano l'immagine giulianea dell'impero, ma forse ancor più distante dalle radicali conseguenze delle esperienze che accompagnarono e immediatamente seguirono la «rivoluzione» costantiniana.
Più che nella riduzione del divario tra prezzi di adaeratio e prezzi di coemptio62, più che nell'abbassamento dell'ammontare della capitazione63 e nella fissazione di calmieri64, l'aspetto radicale della politica giulianea in campo fiscale si riscontra in disposizioni quali quella relativa al reclutamento degli esattori : a dire di Ammiano, Giuliano, già quando era Cesare in Gallia, inpetraverat a praefecto ut secundae Belgicae multiformibus malis oppressae disposino sibi committeretur ea videlicet lege, ut nec prae- fectianus nec praesidalis apparitor ad solvendum quendam urger et^; il reclutamento degli esattori non più tra gli impiegati dell'ufficio prefetti-
cit., p. 330-331). - Sull'ultima prefettura di Probo cf. ora le precisazioni di D. Vera, Commento storico alle relationes di Quinto Aurelio Simmaco, Pisa, 1981, p. LI, n. 15.
61 S. Mazzarino, op. cit., p. 315. 62 Amm., XVII 3,4; S. Mazzarino, Aspetti sociali del quarto secolo, Roma, 1951,
p. 178-179. "Amm., XVI 5,14. 64 Iulian., Misopogon, 350 sg. ; da ultimo A. Giardina, Aristocrazie terriere e pic
cola mercatura. Sui rapporti tra potere politico e formazione dei prezzi nel tardo impero romano, in QUCC, 36, 1981, p. 136-138.
65 Amm. XVII 3,6. Il radicalismo di Giuliano si valuterà, p.es., in rapporto a provvedimenti come C.Th. XI 7,8 (2 settembre 356: per la data O. Seeck, Rege- sten, cit., p. 69) con cui Costanzo si era limitato a escludere i maiores indices dalle exactiones provinciarum, mantenendo le competenze di rectores, praefecti annonae, rationales (cf. A. Déléage, La capitation du bas-empire, Mâcon, 1945, p. 238 sgg.).
LA TAVOLA DI TRINITAPOLI 273
zio o presidale ma unicamente tra i curiali fu poi confermato da Giuliano Augusto, ed elevato a criterio generale, sicuramente per la prefettura d'Italia, Illirico e Africa66, forse per l'impero tutto. La scelta di esattori estratti dalle curie va certamente intesa come l'aspetto di una visione «tradizionalista» che esalta il ruolo delle civitates e la loro autonomia, ma sotto il profilo della prassi strettamente tributaria esprime l'assunzione di principio secondo la quale officiates soient esse provincialibus perniciosi. Questo riconoscimento, nella visione intrinsecamente etica che della res- publica aveva l'imperatore Giuliano, comportava di per sé un'opzione irri- nunciabile, che identificava, secondo la medesima formulazione del de rebus bellicis, le collatorum utilitates e il risanamento dell'impero (respu- blica moribus ditata61).
Si possono facilmente immaginare le conseguenze della politica giu- lianea sulla situazione finanziaria dell'impero : se è vero che il curiale ha minori possibilità di vessare il contribuente, è anche vero che il suo debole potere coercitivo amplifica le possibilità di resistenza dei collator es6% . In questa chiave va interpretata l'immediata reazione di Valentiniano che già nel 364, in una costituzione indirizzata a Mamertino, prefetto al pretorio d'Italia Illirico e Africa, fissò il principio che ad susceptionem specie- rum veniant qui ante omnia sciant se decuriones non esse69. Come chiarisce una costituzione di pochi mesi successiva, l'imperatore intendeva tuttavia mantenere l'esclusione dei praefectiani , a proposito dei quali poteva dire, parafrasando quasi i toni della legislazione giulianea, che la loro
66 Come si ricava dall'espressione contra vetitum di C.Th, XII 10,1 (18 novembre 364 : per la data, 0. Seeck, Regesten, cit., p. 36) ; cf. anche oltre, n. 70, ma soprattutto C.Th. XI 23,2 (13 marzo 362): Prototypias et exactiones in capitatione plebeia curialiwn munera et quidem inferiora esse minime dubitatur, atque ideo a senatoriis easdem domibus submoveri oportet. La prospettiva di un'applicazione capillare risalta particolarmente da C.Th. XIV 4,3 (9 dicembre 363), relativa alla prestazione delle porcinae species; anche qui vale il principio della sostituzione degli officiates dei maiores iudices con la categoria, meno pericolosa per i contribuenti, dei curiales : Nam quia maiorwn potestatum officiates soient esse provincialibus perniciosi, per ordinarios iudices adque curias etiam hanc exactionem convenu celebrari (1. 5-7). Cf. S. Mazzarino, Aspetti sociali, cit., pp. 185-187.
67 De rebus bellicis, 4. 68 Cf. p. es. A. GiARDiNA, Aspetti del fiscalismo tardoantico, in Studi Storici, 1977,
3, p. 151-161. 69 C.Th. XII 6,7 (4 agosto 364: per la data O. Seeck, Regesten, cit., p. 85); cf.
anche XII 6,6 (18 aprile 365 : 0. Seeck, op. cit., p. 31); S. Mazzarino, Aspetti sociali, cit., p. 187.
MEFRA 1983, 1. 18
274 ANDREA GIARDINA E FRANCESCO GRELLE
attività si svolgeva ad perniciem provincialium70. Una soluzione intermedia dunque, che reagendo al radicalismo giulianeo ne recepiva però (secondo un'istanza che era stata già di Costanzo II71), la condanna ferma degli officiates dei maiores indices, ritenuti giustamente molto più pericolosi per i contribuenti degli apparitores dei minores indices (osserviamo in sostanza quasi una gerarchla dell'esosità fiscale, dal curiale all1 apparitor, aìì'officialis). Si è pensato72, che il provvedimento con cui Valentiniano affidò la percezione delle imposte agli impiegati dei governatori nuocesse agli interessi degli impiegati stessi e che su loro pressione («les officia résistèrent de toutes leurs forces»73) Teodosio fosse costretto, nel 386, a revocarlo74. Un'analisi sistematica dei testi fiscali di età valentinianea, dominati ossessivamente dal tema delle fraudes e dei lucra degli esattori, porta alla conclusione opposta : l'esazione poteva essere, in certi casi, un munus svantaggioso per i curiali, non certo, in generale., per gli impiegati, detentori di un potere coercitivo di gran lunga superiore, e quindi maggiormente in grado di conseguire, per esempio, i guadagni derivanti da pratiche speculative volte a ricavare interpretia tra adaeratio e coemptio15.
70 C.Th. XII 10,1 cit.; cf. η. 66, anche il riferimento a XIV 4,3. In C.Th. XII 6,9 (31 agosto 365 : per la data O. Seeck, p. 32) Valentiniano conservò alle curie africane la prerogativa loro assegnata dalla vetus consuetudo : S. Mazzarino, Aspetti sociali, cit., p. 188; per i riflessi africani, in particolare, C. Lepelley, Les cités de l'Afrique romaine au bas-empire, I, Paris, 1979, pp. 213 sgg.
71 Cfr. supra, n. 65. 72 A. Piganiol, L'empire chrétien, Paris, 19722, p. 377. 73 Ibidem. 74 C.Th. XII 6,20 = CI. X 72,8 (27 ottobre 386); cfr. anche A. Déléage, op. cit.,
p.es. p. 139. 75 II «caso limite dello svantaggio dei provinciales» è offerto dalY adaer atio dei
cavalli : S. Mazzarino, Antico, tardo antico, cit., I, pp. 255-266 [cf. Convegno Int. Passaggio dal mondo antico al medio evo da Teodosio a S. Gregorio Magno, Roma 1977, Convegni Lincei 45 (1980), p. 18 s.]; l'autore individua come causa degli enormia pretta di aderazione, la ricerca, da parte dell'amministrazione imperiale, di cavalli di razza eccellente, adatti all'accresciuto prestigio militare della cavalleria nel basso impero ; a essa si aggiungeva il fatto che non si trattava di « aderazione di beni il cui ciclo di produzione fosse definitivamente chiuso : un cavallo va addestrato, allenato; richiede un trattamento, può ammalarsi, deve essere curato ...» ; d'altro canto \' equorum coemptio era un esempio eminente tra i lucra dei funzionari {de rebus bellicis, 4 : cfr. S. Mazzarino, ivi, p. 212; di recente, D. Vera, Commento storico, cit., p. 113 sg.); dovrebbero dunque superarsi le perplessità di J.-M. Carrié, L'Egypte au IVe siècle : fiscalité, économie, société, in Proceedings of
LA TAVOLA DI TRINITAPOLI 275
L'impostazione del problema è stata probabilmente viziata dalla particolare attenzione riservata76 a testi in cui si parla di nominationis iniuria77 : ma in essi si tratta di appartenenti agli officia dei magistri equitum ac peditum e dunque di militari, per i quali la susceptio, nella prospettiva di Valentiniano, poteva essere appunto ritenuta una iniuria ; non era questo il caso degli appartenenti agli uffici civili, per i quali i compiti di esazione erano una sorta di «premio». In tale tematica assume particolare rilievo un altro testo valentinianeo degli stessi anni, in cui si limita fortemente il commercio di stationes compiuto da principes et cornicularii79 . Tradizionalmente intese come «posti occupati dai funzionari» nell'organico dell'ufficio, queste stationes sono apparse come oggetto di transazioni rientranti nel fenomeno del commercio delle cariche79; in realtà con stationes devono intendersi senza dubbio le stationes fisci80, e il documento deve essere pertanto acquisito, con una posizione di rilievo, al dossier complessivo del fiscalismo tardoantico ; per il discorso che qui si è iniziato, basterà osservare come l'incarico fiscale appaia in questa costituzione conferito con piena dignità e meritatamente (merito) a principes e cornicularii, nella linea quindi delle altre costituzioni sopra ricordate riguardanti gli officiates civili ( e in contrasto con quelle riguardanti i militari, per i quali la susceptio è iniuria), ma con l'importante precisazione che lo stesso potere centrale era ben consapevole della rilevanza economica che ogni incarico di esazione assumeva per i responsabili, e che questa consa-
the XVI Congr. of Papyrology, p. 436 estr.). - Per un inquadramento generale, E. Gabba, Considerazioni sugli ordinamenti militari del tardo impero, ora in Per la storia dell'esercito romano in età imperiale, Bologna, 1974, p. 42-74.
76 P.es. A. Piganiol, op. cit., p. 377 η. 8. 77 C.Th. Vili 3,1 (19 settembre 364) : Qui sese in officiis magistrorum equitum ac
peditum militasse ac militare monstraverint, ab omni nominationis iniuria excusen- tur. Eligendi autem erunt susceptores e diversis officiis, etiam ex largitionalibus civi- tatum, qui utique extra palatium degunt.
78 C.Th. Vili 4,10 (30 marzo 365). 79 P.es. J. Godefroy, adi.; A.E.R. Boak, RE XVII 2 (1937), col. 2054,41;
E. Stein, Untersuchungen über das Officium der Prätorianerpräfektur seit Diokletian, Amsterdam, 19622, p. 23; W. Ensslin, RE XXII 2 (1954) col. 2486; da ultimo J. Gaudemet, Les constitutions au vicaire Dracontius, in Mélanges Seston, Paris, 1974, p. 197-205 = Études de droit romain, I, Camerino, 1979, p. 239-249; W. Schuller, Grenzen des spätromischen Staates : Staatspolizei und Korruption, in ZPE, 16, 1975, Heft 1, p. 10, n. 21 ; 16, n. 37; A. Cerati, Caractère annonaire et assiette de l'impôt foncier au bas-empire, Paris, 1975, p. 145 η. 122.
80 Per la dimostrazione, A. Giardina, Aspetti della burocrazia nel basso impero, Roma, 1977, p. 75-80.
276 ANDREA GIARDINA E FRANCESCO GRELLE
pevolezza si spingeva a tal punto da consentirne, sia pur tra moltissime limitazioni, la vendita81.
Il problema, come risulterà ormai chiaro, consisteva nella conciliazione tra le esigenze finanziarie dell'impero e il rispetto dei collator es. Un problema difficile, forse insolubile in compagini come quella tardoantica, dove efficienza dell'amministrazione significava fatalmente arbitrio e strapotere degli apparitores. Un problema che Valentiniano si pose indubbiamente con una lucidità pari all'incapacità di risolverlo. In effetti egli è l'imperatore che riconsegnò il sistema fiscale nelle mani degli apparitores, ma è anche l'imperatore che istituì il defensor plebis*2, che stabilì un calmiere per l'aderazione destinata all'annona militare83, che odiò con un'ira feroce Petronio Probo (incitato petebat odio Probum 84) per la sua amministrazione troppo avida, che lottò più di ogni altro contro le frodi degli esattori. Due aspetti di una stessa politica, due aspetti irrisolti ma non ambigui : a ben guardare li ritroviamo, come vedremo meglio in seguito (§ 7), nella stessa Tavola di Trinitapoli, filtrati attraverso una normativa complessa.
Nella lotta di Valentiniano contro i lucra degli esattori, il problema dell'aderazione riveste un particolare rilievo. L'imperatore cercò di affrontarlo da varie prospettive : in una generalis lex de specierum praebitio- ne, perduta ma citata in una costituzione di età stiliconiana85, egli fissò, come si è accennato, un calmiere per l'aderazione richiesta da soldati nella riscossione dell'annona militaris. In una costituzione provocata dal consularis Anatolio che aveva represso e segnalato le tabulariorum fraudes per suburbicarias regiones (il particolare geografico non è privo d'importanza per una piena valutazione del nuovo testo di Trinitapoli), l'imperatore stabilì precise norme relative al trasporto delle species, che doveva svolgersi ab unoquoque oppido certo ac denuntiato tempore86, al fine di
81 La vendita era consentita a principes e cornicularii soltanto dopo il pastus primipili, soltanto a favore degli adiutores e in particolare di quegli adiutores che non avessero mai ricoperto simili incarichi.
82 O. Seeck, RE, IV, 2, 1901, coli. 2365 sgg. 83 Cf. oltre, n. 85. 84 Amm. XXX 5,4-10; cf. A. Giardina, Claudii e Probi, in Helikon, XV-XVI, 1975-
1976, p. 309 con n. 4 e bibliografia ivi cit. 85 C.Th. VII 4,22 (30 maggio 396): cf. S. Mazzarino, Aspetti sociali, cit.,
p. 193 sg.; Antico, tardoantico, cit., p. 316-327. 86 C.Th. XI 1,9 (6 marzo 365); cf. Lellia Ruggini, Economia e società nell'« Italia
annonaria», Milano, 1961, p. 55 sg.
LA TAVOLA DI TRINITAPOLI 277
consentire un'efficace organizzazione dei percorsi ed evitare quelle richieste di aderazione che proprio dalle difficoltà di trasporto traevano la più forte giustificazione. In questa lotta contro le pratiche aderative rientrano anche provvedimenti riguardanti i dispendia pro rotis et pro angariisi, assimilabili, nell'eventualità di una richiesta aderata, alla conversione in denaro di tributa richiesti in ipsis speciebus66. Un'altra lex generalis di Valentiniano è ricordata nell'importante editto del consularis. Campa- niae Virius Audentius Aemilianus trovato a Casamari89 : essa riguardava in particolare il problema della apochandi licentia, già affrontato dall'imperatore in una costituzione del 364 (Scias inhibitam esse apochandi licen- tiam, ita ut ne ex praesenti aut futuro vel praeterito sub hoc titulo nummus a provincìalibus postuletur90) e più volte ripresa nello stesso anno91 e successivamente92. L' apochandi licentia in quanto aspetto tecnico fondamentale delle riscossioni aderate può essere considerata il filo che lega le innumerevoli frodi praticate dagli esattori : di apochae e securitates si par-
%1 C.Th. Vili 5,21 (19 settembre 364 : per la data, O. Seeck, Regesten, p. 216>; altri frammenti della stessa costituzione : I 16,9; VI 35,6; Vili 3,1.
88 S. Mazzarino, Antico, tardoantico, cit., p. 323 sg. 89 S. Panciera, 'Ex auctoritate Audenti Aemiliani viri clarissimi consularis Cam-
paniae', in Studi Volterra, II, Milano, 1971, p. 267-279; riferimento a una lex generalis alla 1. 7, secondo la proposta di S. Mazzarino, op. cit., p. 317-327.
90C.Th. XI 2,1. La datazione tramandata è del 12 agosto 365 (data della propo- sitió), ma è molto probabile, quasi sicura, una datazione all'anno precedente, per due considerazioni che si rafforzano a vicenda : accettando la datazione al 365 dobbiamo infatti ritenere che tra l'emissione a Milano, avvenuta non dopo il 3 aprile (il 4 aprile il destinatario Symmachus Phosphorius sicuramente non era più prefetto urbano, essendo attestato in carica il suo successore Volusianus : A. Chasta- gnol, Les Fastes de la Préfecture de Rome au Bas-Empire, Paris, 1962, p. 164; PLRE I, p. 864) e la propositio a Roma siano trascorsi più di quattro mesi : il che è davvero poco credibile (S. Mazzarino, op. cit., p. 312 η. 32; 323 η. 70). D'altro canto, anche se considerazioni di ordine stilistico vanno avanzate con la massima cautela, appare indubbio, in questo caso particolare, che il tono di XI 2,1 (Scias inhibitam esse apochandi Hcentiam, ita ut ne ex praesenti aut futuro vel praeterito sub hoc titulo nummo a provincìalibus postuletur) sia concepibile soltanto come precedente le disposizioni di XI 2,2 (Commoda cogitantes urbis aeternae vini speciem ita provinciales statuimus conportare ut apochandi praesumptione damnata vina Romam portentur), databile con sicurezza al 23 ottobre 364 sulla base del destinatario e del luogo, anche se il consolato è del 365 (O. Seeck, Regesten, cit., p. 85), e che la sua promulgazione non sia avvenuta in giorni troppo lontani da una costituzione dell '8 giugno 364 in cui si afferma che Nemini aurum pro speciebus urbis Romae liceat exigere de futuro (C.Th. XI 1,8).
91 C.Th. XI 1,8 e XI 2,2, già ricordate alla n. precedente. 92 P. es. C.Th. XII 6,16, cit. a n. 95.
278 ANDREA GIARDINA E FRANCESCO GRELLE
la nelle costituzioni valentinianee pervenute nei Codici, si parla nell'epigrafe di Casamari93, nella Tavola di Trinitapoli (1. 15 : securita[té]m ab universis adq(ue) indicia functionis efflagitent).
Il problema delle ricevute non si esaurisce ovviamente nel fenomeno dell'aderazione, ma è comprensibile che nella Tavola l'esigenza di registrazioni (e quindi di ricevute) impeccabili appaia connessa all'organizzazione dei magazzini pubblici (1. 23-24 : [publi/cis] horrei[s94) e a percezioni in natura : un particolare che andrà interpretato alla luce di costituzioni come quella, sempre di Valentiniano, in cui si ordina l'immediata registrazione dei versamenti di frumenta fiscalia (Frumenta quae horreis infe- runtur, pro inlationis modo ilico apocharum cautionibus annotentur95), come quella di Graziano in cui si prescrive l'immediata riscossione delle prestazioni vinarie {vinum, quod sollemnis expressio popularibus commo- dis ex provincialium collectione desiderai, ilico suscipiatur advectum, ut erogationis pro tempore cura praestetur96); nel caso del vino, una rapida susceptio era raccomandata anche per le esigenze di derrate quae natura sua processum temporis ferre non possunt97, ma s'inquadrava, più in generale, com'è comprensibile, in una politica antiaderativa riguardante tutte le species senza alcuna distinzione98. E appare in effetti quanto mai significativo che la repressione degli abusi dei funzionari, la «sottrazione» di reliqua e l'imposizione di un gravamen alienum appaiano in stretto collegamento con la scrupolosa accessio, l'accessione in carico, nei registri, di quanto il possessor ha portato nei pubblici granai (1. 23-25) : l'obbligo di questa scrupolosa accessio proibiva in sostanza l'occultamento (totale ο parziale) di quanto versato dal contribuente a titolo di arretrato e la parallela attribuzione di somme maggiori del dovuto attraverso il cumulo di reliqua propri e altrui {gravamen alienum), a chi fosse in debito per arretrati. Veniamo in tal modo a conoscenza di un altro genus rapinarum aut fraudium " praticato dai funzionari : una frode le cui modalità trovavano modo di espletarsi proprio in rapporto a quella percezione di reliqua
93 S. Panciera, op. cit., p. 277. sg.; S. Mazzarino, op. cit., p. 309-312. 94 Per questa integrazione, che è da considerarsi sicura, cf. supra, p. 265. 95 C.Th. XII 6,16 (9 aprile 375). 96 C.Th. XI 2,3 (17 settembre 377). 97 Ibidem. 98 S. Mazzarino, op. cit., p. 309. 99 Secondo l'espressione di C.Th. Vili 5,21. Gravamen alienum della 1. 5 richi
ama l'indebitum munus imposto secondo Simmaco da principales et tabularli ad alcuni contribuenti (Ep. IX 10: cf. S. Roda, Commento storico, cit., p. 112 sgg.).
LA TAVOLA DI TRINITAPOLI 279
che per la sua indeterminatezza temporale favoriva più di ogni altra lo spregiudicato comportamento dei funzionari.
Il presupposto elementare di qualsiasi efficienza fiscale è l'accurata redazione dei registri dei contribuenti, dei versamenti da loro effettuati e delle somme dovute a titolo di reliqua. Tali registri, ο breves, ritornano più volte nella legislazione in materia, come elemento qualificante ogni azione repressiva degli abusi e delle frodi commesse dal personale addetto alla percezione. I breves sono infatti l'unico strumento che consente il riscontro tra i vari uffici dissipando (lin. 26 :' nominatori breves mera luce significent) queM'obscuritas che avvolge e favorisce gli ingiusti lucra degli impiegati100. La Tavola di Trinitapoli è l'unica costituzione che attesti l'esistenza di registri mensili {me<n>strui breves : 1. 7) : una circostanza che a prima vista parrebbe in contrasto con quanto sappiamo intorno ai quadrimenstrui breves, i registri deWinlatio tripertita, nuovo sistema di percezione inaugurato da Valentiniano I già agli esordi del suo regno101.
100 II tema dell' obscuritas che occulta le frodi degli impiegati e dei nominatori breves che riportano la luce, può considerarsi un topos della legislazione in materia : cf. p.es. C.Th. XI 28,3 (25 giugno 401), 1. 10 sg. : iudices nominatorios breves absque ulta conscribtos fraude transmutant, quibus aperte liqueat. . . ; Cassiod., Var. XII 16,4 : Expensarum quoque fidelem notitiam per quaternos menses ad scrinia nostra sollemniter destinabis, ut totius erroris obscuritate detersa rationibus publicis veritas elucescat. - Per mera luce di 1. 26, cf. Tert., anim. 53,6: erumpit... ad meram et puram et suam lucetn.
101 Come si deduce senza ombra di dubbio dal tono stesso delle ordinanze di Valentiniano in merito : C.Th. XI 19,3 (12 settembre 364) : Ab enfyteuticariis posses- soribus annonariam quidem solutionem per quattuor menses ita statuimus procura- ri. . .; C.Th. XI 1,15 (per la data cf. supra, η. 58) : Unusquisque annonarias species pro modo capitationis et sortium praebiturus per quaternos menses anni curriculo distributo tribus vicibus summan conlationis implebit; per V 15,20 (19 maggio 366), cf. η. Ill; C.Th. XII 6,15 (7 gennaio 369): A possessoribus per très vices petatur annona; ma soprattutto C.Th. XI, 7,11 (25 maggio 365): Illud etiam moderationi adiecimus, ut tripertita esset inlatio fiscalium pensionum; non è di Valente C.Th. XI 1,16, che risulta emessa il 25 ottobre 367 a Nicomedia, ma è indirizzata al vicario d'Africa Dracontius ; d'altro canto lo stesso Valente, che mai avrebbe potuto inviare una costituzione a quel governatore, in quel periodo non si trovava a Nicomedia, ma era impegnato nella campagna gotica, tra Marcianopoli {C.Th. XI 17,1) e Doro- storum {C.Th. X 1,11 ; XII 6,14). È dunque errata l'indicazione del luogo (così già J. Godefroy e Th. Mommsen, ad l.) che non è tuttavia opportuno cercare di ricostruire attraverso congetture filologiche alquanto ardite, come fa O. Seeck proponendo Novaesiae, che secondo lui «von Nicomedia sowohl graphisch als auch phonetisch nicht gar zu sehr unterscheidet» {Regesten, cit., p. 107). - Per il periodo successivo all'età di Valentiniano, cf. i testi cit. alle note sgg.
280 ANDREA GIARDINA E FRANCESCO GRELLE
Quadrimenstrui breves compaiono nell'omonimo titolo del Teodosiano, contenente un'unica costituzione datata al 393 102, in altre costituzioni successive 103, in una novella di Maioriano del 438 104 e nel titolo del Giustinia- no contenente anch'esso un solo testo sui τετραμηνιαΐα βρέβια105; la lunga permanenza del sistema della percezione quadrimestrale 106 è confermata, per l'Occidente, da quanto dice Cassiodoro sulla fidelis notitia trasmessa agli scrinia centrali per quaternos menses 107, ma esso risale come già si è detto, ad alcuni interventi di Valentiniano I in cui il pagamento dell'annona è fissato per quaternos menses anni curriculo distributo tribus vici- bus109.
L'attestazione contemporanea di breves menstrui e quadrimenstrui può spiegarsi senza difficoltà se ipotizziamo che al livello più basso, quello dei praepositi pagorum e degli altri addetti alla susceptio (probabilmente i praepositi horreorum 109) si praticasse una trasmissione mensile di bre- ves che confluivano poi nei quadrimenstrui breves elaborati dagli uffici superiori. Un'ipotesi questa, che ben s'inquadra nell'esigenza di quell'estrema precisione delle indicazioni contenute nei breves che nel nuovo documento si spinge fino all'annotazione dei singoli giorni in cui i singoli contribuenti hanno versato l'imposta, delle species versate, di quanto hanno versato e di quello che si deve come arretrato (1. 9-10: quantum et in qua specie diebus singulis singuli quiq{ue) dissolverin<t> quid/ve ab unoquoqiue) trahatur in reliquis), e che ritorna in costituzioni successive110; la necessità di una registrazione mensile sarà stata tanto
™C.Th. XI 25,1. ™C.Th. XII 6,27 (31 dicembre 400); C.Th. I 10,7 (27 febbraio 401); C.Th. XII
1,173 (26 agosto 409 : per la data, O. Seeck, Regesten, cit., p. 87). 104 Nov. Maior. II 3 (10 marzo 458). 105 C.I. I 42. 106 In generale soprattutto J. Godefroy, ad. 1. XI 25,1 ; cfr. anche 0. Seeck, RE
III 1 (1897), col. 832; A. H. M. Jones, The Later Roman Empire, I, Oxford 1964, p. 405. - Sulla trimestris instructio dei ruoli relativi alla gleba senatoria, compiuta daW'offictum censuale, cf. J. Karayannopulos, Das Finanzwesen des jrübyzantini- schen Staates, München, 1958, p. 127 sg. ; D. Vera, Commento storico, cit. p. 337.
1(" Cassiod. Var., XII 16,4; cf. XII 2,6 e XI 7,4. 108 L'espressione è nella già cit. C. Th. XI 1,15. 109 Per questa ipotesi, che è da considerarsi quasi sicura, cf. supra p. 261-262 110 Cf. p.es. C.Th. XII 6,18 (10 maggio 383) : et quid et in qua specie et ex quibus
titulis et pro qua indictione videatur accepisse rescribserit ; XII 1,173 = CI. X 22,1 (26 agosto 409) : Sed et aurum, quod ex huiusmodi contributione redigitur, ita débet susceptori aurario consignari, ut securitatibus nomen inferentis, dies consul mensis, causa et summa comprehendatur : per in qua specie . . . dissolverint (1. 9) cf. p.es.
LA TAVOLA DI TRINITAPOLI 281
più avvertita proprio in rapporto al problema cruciale del pagamento dei reliqua111. Menstrui breves potevano dunque coesistere con quadrimen- strui breves, come questi ultimi (nella stessa età valentinianea che vide il primo esperimento di inlatio tripertita) coesistevano, secondo le esigenze, con breves trasmessi per singulos quosque annos, come stabilisce una costituzione del 365 in merito ai reliqua dei possessores africani residenti a Roma112. Del resto la redazione di registri quadrimestrali appare sempre connessa alle superiori competenze dei duces113 e dei indices114, che li trasmettevano al prefetto al pretorio115 ο al magister militumllb i quali a loro volta li inviavano agli uffici centrali117, mentre nel nuovo testo epigrafico i registri mensili sono redatti, come si è detto, a livello molto più basso dell'organizzazione fiscale, quello appunto dei praepositi. Se identificassimo quei tabularli che in C.Th. XII 6,27 = CI. X 72,12 hanno il compito di pubblicare quadrimenstrui breves con i tabularli delle civitates, individueremmo anche nella Tavola di Trinitapoli i successivi meccanismi che portano da menstrui breves (livello dei praepositi) a quadrimenstrui breves (livello del tabularius civitatis); ma è molto più probabile che i tabularli di C.Th. XII 6,27 fossero integrati all'organizzazione vera e propria degli officia, e fossero pertanto diversi dai tabularli civitatum.
speciem... dissolvere della costituzione valentinianea C.Th. XIV 4,4 (8 ottobre 367); per trahatur in reliquis (1. 10) cf. p.es. trahatur in debitis di C.Th. XI 15,2 (31 gennaio 384). - Sul problema delle indulgentiae di debiti, cf. ora S. Mazzarino, Computo e date di condono dei reliqua : da Costantino al 5° secolo, in Romanitas- Christianitas. Untersuchungen zur Geschichte und Literatur der römischen Kaiserzeit Johannes Sträub . . . gewidmet, Berlin-New York, p. 375-395.
111 Anche prima dell'introduzione del nuovo sistema, quando la percezione era annuale, esistevano norme che prevedevano il versamento, da parte dei conlatores, di species. . . ex horreis suis ad civitates singulas per menses singulos (C.Th. XI 1,2 dell'8 novembre 313 : per la data, O. Seeck, Regesten, cit., p. 78). Ancor più interessante, per l'interpretazione che qui si propone, è l'autorizzazione, da parte di Valentiniano, ai possessores dei fondi enfiteutici e patrimoniali, di versare quanto dovuto quo potuerint tempore . . . dummodo non amplius quam in tribus per singulos annos vicibus (C.Th. V 15,20).
112 C.Th. XI 1,13 (18 ottobre 365). "*C.Th. XI 25,1 (21 maggio 393). n*C.Th. I 10,7 (27 febbraio 401); in particolare, per il proconsole d'Africa,
C.Th. XII 6,27 (31 dicembre 400); cf. anche CI. I 42, cit.; X 23,3 (25 luglio 468) e Cassiod., cit. supra, n. 107.
115 C.Th. XI 25,1, cit. 116 C.Th. VII 4,24 (25 marzo 398). 117 C.Th. XII 1,173; VII 4,24, cit.
282 ANDREA GIARDINA E FRANCESCO GRELLE
II passaggio dalla riscossione effettuata una sola volta all'anno alla riscossione effettuata ogni quattro mesi venne presentato dal suo ideatore, l'imperatore Valentiniano I, come espressione di quella moderano che egli amava proporre come tratto caratteristico della propria opera di governo : Illud edam moderationi adiecimus, ut tripertita esset inlatio fiscalium pensionum118. E in effetti il versamento frazionato poteva in molti casi alleggerire la pressione sul contribuente consentendogli una vendita dei propri prodotti più vantaggiosa perché meno legata a una contingenza immediata e urgente, mentre sotto il profilo delle esigenze finanziarie dell'impero la percezione frazionata di species in natura non era certo più svantaggiosa della percezione in un'unica soluzione119, e rispondeva anzi a esigenze di maggiore razionalità, soprattutto in rapporto all'immagazzinamento. Ma in altri casi, in rapporto a generi e circostanze particolari, essa poteva tradursi in un ulteriore onere per il contribuente, che avrebbe senz'altro preferito pagare le imposte in un'unica soluzione piuttosto che vedersi costretto, per esempio, a una prestazione aderata : in tal senso andranno interpretate quelle norme che appunto concedono ai contribuenti Y arbitrium in adcelerandis necessitatibus 120.
6 - MODERATIO E MaNSUETUDO
Moderatio è una delle parole-chiave nell'ideologia esplicita che guida l'azione di Valentiniano nei confronti dei provinciales ; lo stesso Ammiano sottolinea tale aspetto {in provinciales admodum parcus, tributorum ubi-
llgC.Th. XI 7,11. 119 Cf. quanto osserva Libanio contro la richiesta del consularis Syriae Tisame-
nus, che esigeva di riscuotere interamente il phoros «al quarto mese dell'anno», adducendo a pretesto il danno che l'imperatore avrebbe tratto da una riscossione frazionata : Και τούτο το δίκαιον εν τε τοϊς άλλοις κάν τω φόρφ. μην μεν γαρ ούτο- σί τω ετει τέταρτος, το τρίτον του ένιαυτοΰ μέρος, ήδικήσθάι δε τον βασιλέα φησίν ού τοΰ παντός είσενηνεγμένου. πώς, ώ καταγέλαστε; και γαρ έν άγροΐς κείμενον εκειτ αν ομοίως τω βασιλεΐ και ούκ αν ην ελαττον. ουδέ γαρ ενταύθα κείμενον πλέον, τω φέροντι δε ούκ ίσον ή τήμερον απαν ή μεμερισμένον είς μήνας είσενεγ- κεΐν. ού δη κέρδος έκείνω, ζημίαν δε ήμΐν προξένων το ταχύ τοΰτο ζητεί. {Or. XXXIII 19). Sull'episodio, P. Petit, Libanius et la vie municipale à Antioche au IVe siècle après J.-C, Paris, 1955, p. 153; J.H.W.G. Liebeschuetz, Antioch. City and Imperial Administration in the Later Roman Empire, Oxford, 1972, p. 164. - Lamenti per immatura compulsio ancora al tempo di Cassiodoro {Var. XII 16,3).
u0C.Th. XI 1,15. L'opposto di quanto ritiene A. Cerati, op. cit., p. 173.
LA TAVOLA DI TRINITAPOLI 283
que molliens sarcinas 121) secondo una valutazione che il grande Godef roy, convinto ammiratore di quel principe, fece poi completamente propria122. L'imperatore vi insiste spesso (e il suo collega Valente lo riprende123) proponendo l'immagine di un principe pronto più a mitigare che a inasprire : ne abbiamo già visto i riflessi nell'inaugurazione del sistema àe\Y intatto tripertita 124, ma si potrebbe anche per altri aspetti ripercorrere il filo che a vari livelli lega interventi qualificati, per esempio, come nostrae delibe- rationis moderamen 12S, e in cui la moderatio si carica dei pieni valori della tradizione (salva scilicet iuris antiqui moderatione 126) ; non è del resto privo d'implicazioni il fatto che proprio in quest'epoca si rafforzi l'uso, molto antico ma fino a quel momento abbastanza raro127, del termine moderator per indicare il iudex : un'espressione come urbis moderator in Am- miano Marcellino sta per praefectus urbi 128, come in alcune relazioni sim- machiane moderator Campanus ο moderator Apulus stanno per consularis Campaniae e corrector Apuliae129', parallelamente nelle costituzioni imperiali l'uso di moderatores provinciarum tende a sostituire, con una notevole frequenza, l'espressione redores provinciarum (si tratta dunque di un modello « speculare » : la virtù del buon amministratore si specchia in quella del buon imperatore130).
Si diceva di Valentiniano, e il principe era il primo ad accreditare questa immagine, quello che il redattore della Historia Augusta diceva dell'ottimo principe Severo Alessandro : il suo equilibrio, la sua modera-
121 Amm. XXX 9,1. Una moderatio, si badi bene, che si espletava pienamente in campo fiscale, nel settore cioè che più di ogni altro qualificava i rapporti tra il principe e i provinciales; non la ritroveremmo tale e quale in altri momenti dell'opera di governo di Valentiniano, il quale affermava, sempre a dire di Ammia- no, che livorem severitatis rectae potestatis esse individuarti, sociam.
122 Comm. ad C.Th., passim. l2ìC.Th. IX 21,8 (21 maggio 374); su Valentiniano come 'modello' di Valente,
cf. S. Mazzarino, Aspetti sociali, cit., p. 191 ; cf. anche infra, p. 285 e η. 184. 124 Cf. supra, con particolare riferimento a C.Th. XI 7,11. 125 C.Th. XIV 6,3 (6 agosto 365). i26C.Th. XI 36,18 (20 dicembre 364 : per la data O. Seeck, p. 85). 127 Cf. Th.l.L, s.v., e n.sg. 128 Amm. XXVII 3,5; C.Th. I 10,4 (15 aprile 391) : praefecturae urbanae modera-
mine; in generale W. Ensslin, RE XV 2 (1932) col. 2315 sg. 129Symm., Rei. 38,2; 40,1; cf. D. Vera, Commento storico, cit., p. 289; 298. 130 La moderatio compare tra le virtù dei tetrarchi in SHA, Car. 18,4. Per le
ulteriori attestazioni cf. gli Indici del Gradenwitz e del Mayr. Per Petronio Probo, CIL VI 1751 = ILS 1265, cit. an. 58; cf. da ultimo V. Neri, L'elogio della cultura e l'elogio delle virtù politiche nell'epigrafia latina del IV secolo d.C, in Epigraphica, XLIII, 1981, p. 175-201.
284 ANDREA GIARDINA E FRANCESCO GRELLE
zione erano profondi, ma non scadevano in eccessi tali da compromettere le finanze pubbliche : dies denique numquam transiti, quando non aliquid mansuetum, civile, pium fecit, sed ita ut aerarium non everteret131 II campo di azione entro cui più fortemente si espletano gli effetti della moderano del principe e le virtù che a essa appaiono collegate, è infatti quello fiscale : accanto a indulgentia principis, un concetto altrettanto importante, che si neutralizza ben presto in un uso 'tecnico' connesso alle indul- gentiae reliquorum 132, moderano e altri termini ancora, sui quali andrebbe condotta un'indagine sistematica133, costituiscono un punto focale nel lessico politico tardoantico : hanno alle spalle una forte tradizione, che segue percorsi diversi, ma tendono a consacrarsi e giustapporsi definitivamente dopo la metà del IV secolo. Valentiniano non fu l'unico responsabile di questa trasformazione ma certamente si deve all'attività della sua cancelleria un decisivo impulso al consolidamento di un determinato sistema di valori connesso al modello dell'ottimo principe, che avrà una solida fortuna lungo tutta l'ulteriore storia dell'impero.
Quella che potremmo quindi definire l'ideologia del principe moderato è presente, con un accento più marcato, nella nuova epigrafe di Trini- tapoli, e precisamente nel termine mansuetudo (1. 28 : post hanc nostrae mansuetudinis legem), che presenta, nelle costituzioni, un tracciato parallelo a quello di moderano : attestato sporadicamente prima della metà del IV secolo, la sua frequenza s'infittisce nell'età di Valentiniano e diventa sempre più serrata nei decenni successivi134. Oltre che in costituzioni valentinianee pervenute nei Codici135 mansuetudo è presente (e la circo-
131 SHA, Al.Sev. 20 ,4 (cf. anche 20,1 : Moderationis tantae fuit. . .). Cf. soprattutto J. Sträub, Heidnische Geschichtsapologetik in der christlichen Spätantike, Bonn, 1963, p. 50 sg.
132 J. Gaudemet, Indulgentia principis, in Conferenze romanistiche, II, Milano 1967, p. 3 sgg. = Études, cit., p. 235 sgg. Si tratta di un indulgentia che genera laetitia : indulgentiarum laetitia, C.Th. XII 13,4 del IO agosto 379; cf. S. Mazzarino, 'Annunci ' e 'publica laetitia ' : l'iscrizione romana di Fausto e altri testi, in Antico, tardoantico, cit., p. 245.
133 Nella linea già tracciata, per taluni aspetti fondamentali, da J. Sträub, Von Herrscherideal in der Spätantike, Stuttgart 1939 (rist. 1964), e sulla base dei materiali raccolti, p.es., da R. M. Honig, Humanitas und Rhetorik, Göttingen, 1960. Per i riflessi nella Historia Augusta, un inquadramento generale, p.es., in B. Mouchovä, Crudelitas principis optimi, in Historia Augusta Colloquium 1970, Bonn, 1972, p. 167 sgg.; J. Béranger, L'idéologie impériale dans l'Histoire Auguste, ivi, 1972/1974, Bonn, 1976, p. 29 sgg.
134 Cf. Th.l.L, s.v. col. 1207 sg. dove si noterà la grande fortuna della parola a partire dal IV secolo, in contesti attinenti la respublica.
135 Cf. gli Indici del Gradenwitz e del Mayr.
LA TAVOLA DI TRINITAPOLI 285
stanza è notevole) anche in una costituzione di Valente pervenuta per via epigrafica, la cosiddetta epistula de moenibus instaurandis et de reditibus fundorum civitatum Asiae136. Ma nella Tavola di Trinitapoli nostrae man- suetudinis legem richiama altri concetti analoghi e complementari, con un effetto che somma la varietà a un'insistenza quasi martellante : la qualifica di salutare attribuita al decretum 137, la provisio 138 e la grada 139 imperiali (destinate a eterna testimonianza da un monumento che si vorrebbe bronzeo140 e dalla lettura a tutti accessibile141, anche se la sua realizza-
1Ì6FIRA I2, n° 108, 1. 13 (= Die Inschriften von Ephesos, cit., n° 42) : mansuetu- do nostra cognovit; 1. 23 : mansuetudini nostrae. . .nunties.
137 Da cf., p.es., con leges salutares di SHA.A 35,3; cf. anche C.Th. X 10,29 (8 luglio 421) : nisi huius salubre decretum perpétuant exsecutione servaverit.
138 Per provisio, cf. S. Mazzarino, Antico tardoantico, cit., p. 206 sg. (con riferimento a un particolare tipo di provisiones).
139 Per gratia, cf. anche p. sg. 140 Un'incisione che s'intende regolarmente, come nella legge di Trinitapoli, su
tavole di bronzo che ne assicurino la perpetuità, secondo un topos ricorrente in una pluralità di testimonianze (non solo epigraf iche : Adelina Arnaldi, // motivo della «perpetuitas» nella monetazione di Costantino, in RIN, LXXX, 1978, ρ. Ι ΠΙ 31) che presentano perifrasi e termini analoghi : dalla ricca formula con cui nella Tavola di Brigezio Costantino ordina la promulgazione dell'epistola sui privilegi dei soldati e dei veterani (FIRA I2, n° 93, 1. 30-32 : ut sempiterna dispositionis nostrae provisio obtineat firmitatem, volumus teno/rem huius indulgentiae nostrae de- scribtum per singulaqueque castra aput signa in ta/bula aerea consecrari; da cf., per taluni particolari, con C.Th. XIV 16,3, del 26 novembre 434 : legisque huius tenorem aeneis tabulis incidi), ad altre più concise (C.Th. XII 5,2, del 21 maggio 337: Quod ut perpetua observatione firmetur, legem hanc incisam aeneis tabulis iussimus publicari; da cf. p.es. con C.Th. XIV 17,5 del 1 agosto 369 : titu- lus figendus est aeneus in quem... debebit incidi; C.Th. XIV 4,4 dell'8 ottobre 367 : Haec autem omnia aeneae tabulae . . . ad aeternam memoriam opor- tebit insculpi); molti altri esempi potrebbero addursi, ma basterà qui osservare come questa formula, di uso tradizionale, ricorra nella tarda antichità in atti pubblici anche al di fuori delle costituzioni imperiali, come nell'orbo sa/lutationis fac- tus et ita at perpetui/tatis memoriam aere incisus a Timgad (A. Chastagnol, L'album municipal de Timgad, Bonn, 1978, p. 75; 77). Per le tabulae aereae o aeneae patronatus, p.es. CIL IX 10 = ILS 6113 (anno 341), da cf. con altri esempi più risalenti (p.es. CIL XI 5149 = ILS 7221 ; CIL XI 970 = ILS 7216; CIL IX 3429 = ILS 6110; ecc.) - Nella maggior parte dei casi l'ordine di pubblicare mediante tavole di bronzo evocava il prestigio, la solennità, la durevolezza dell'ae5 rispetto ad altri materiali, che nella pratica erano però quelli più frequentemente usati, anche quando si prevedevano, appunto, tabulae aere incisae (e lo stesso esempio di Trinitapoli è un'evidente conferma). Rispetto a tali formulazioni appaiono pertanto più ' realistiche ' le prescrizioni d'incidere tabulae marmoreae (Cassiod., Var. IX 16,3: Verum ut principale beneficium et praesentibus haereat saeculis et futuris, tam defi-
286 ANDREA GIARDINA E FRANCESCO GRELLE
zione, nel territorio di Canosa prefigura, per taluni aspetti, la «tipologia scarsamente articolata delle testimonianze grafiche altomedievali»142). A sua volta la gratia dell'imperatore è ripresa dalla gratia del index, secondo quel modello «speculare» cui si è già accennato (27-28 : index autem con- cordiam habitet / let] gratiam).
7 - L'ADVENTUS DEL GOVERNATORE
Si è già visto per taluni aspetti, come la nostra epigrafe possa inquadrarsi in quegli anni critici per la storia tardoantica in cui Valentiniano cerca la difficile conciliazione tra le esigenze finanziarie dell'impero e la tutela dei collatores. Ma i rapporti tra la Tavola di Trinitapoli e la legislazione fiscale di Valentiniano appaiono ben più profondi di quelle, pur significative, connessioni. Lo si può dimostrare proprio per il tema centrale dell'epigrafe : quelYadventus del rector che appare come il fondamentale dispositivo di verifica di regolarità dell'esazione e di tutela dei collatores.
Il nuovo documento non è pervenuto, nella forma in cui fu pubblicato nell'area canosina, né nel Codice di Teodosio né in quello di Giustinia-
nita nostra quam senatus consulta tabulis marmoreis praecipimus decenter incidi) ο tabulae senza alcuna specificazione (C.Th. XIV 13,1 del 4 agosto 373 : Concessi igitur gratia benefica publicis actibus intimetur et incisa tabulis debita sollemnita- te permaneat), nella prospettiva anche di una promulgazione che valga comunque, su qualsiasi materiale incisa ο scritta {C.Th. XI 27,1 del 13 maggio 329, per la data O. Seeck, Regesten, cit., p. 54 : aereis tabulis vel cerussatis aut linteis mappts scribta per omnes civitates Italiae proponatur lex). In tale tendenza verso quello che abbiamo chiamato il ' realismo ' delle ordinanze di pubblicazione si spiega la progressiva scomparsa del riferimento all'aes, documentabile in modo assai consistente sulla base delle Novellae post-teodosiane, che insistono semplicemente su edicta sollem- niter (o ex more) proposais e simili. Cf. supra, n. 32.
141 L. 18-19 : praecelsa/sublim[itas t]ua continuo innotescere omnibus faciat tam salutare decretum, che dev'essere affisso celeberrimis [in] / locis delle singole città (1. 20-21) : così la formula di rito. Ma questo aspetto dev'essere naturalmente inquadrato in quello, più ampio, dell'alfabetismo nell'area in questione, sulla linea dell'impostazione generale tracciata da G. Cavallo, p.es. in Dal segno incompiuto al segno negato. Linee per una ricerca su alfabetismo, produzione e circolazione di cultura scritta in Italia nei primi secoli dell'impero, in Atti del seminario Alfabetismo e cultura scritta nella storia della società italiana, Perugia 1977, Perugia 1978, p. 119-144.
142 A. Petrucci, La scrittura fra ideologia e rappresentazione, in Storia dell'arte italiana, 9,1, Torino 1980, p. 5 sgg.
LA TAVOLA DI TRINITAPOLI 287
no. Ma poiché si tratta di un documento incompleto, è necessario domandarsi se esso non possa essere considerato come parte non tramandata di una costituzione pervenuta frammentaria attraverso la tradizione indiretta, oppure se non possa ritrovarsi nei Codici sotto forma di riassunto. Ipotesi di questo genere conducono, come vedremo, a risultati di notevole interesse.
Il frammento di una costituzione di Valentiniano I indirizzata a Petronio Probo nel 369 e inserita nel titolo de officio rectoris provinciae fissa l'obbligo, per i governatori di provincia, di compiere personalmente una ricognizione al fine di raccogliere eventuali lamentele dei possessores contro i conpulsores : Provinciis praesidentes per omnium villas sensim atque usitatim vicosque cunctos discurrant et ultro rimentur a singulis, quid unusquisque conpulsor insolenter egisset aut cupide. Is enim de quo aliqua ad nos querella pervenerit, ad ultimam poenam rapietur (C.Th. I 16,11). La somiglianzà tra questo brevissimo frammento e il contenuto centrale della Tavola, in particolare le 1. 10 sgg., è molto forte : a) ambedue i testi sono infatti indirizzati a Probo; b) in ambedue si parla di frodi praticate dai conpulsores; e) in ambedue infine l'excursus del governatore {discurrant nel frammento del Teodosiano) è presentato come momento fondamentale nell'individuazione della frode. Il frammento del Teodosiano è naturalmente di gran lunga più sintetico e generico, ma proprio questa genericità può essere la spia di un rapporto forte tra i documenti, se la si inquadra nel problema fondamentale del testo delle costituzioni imperiali e del ruolo svolto dai compilatori nella sistemazione e trasformazione del loro materiale. Il confronto tra le costituzioni geminate, ο tra le costituzioni pervenute nei Codici e in altre raccolte ο per via epigrafica, ha messo in luce come i compilatori non si limitassero a espungere ampie parti delle disposizioni originarie e a ricomporne i frammenti da loro conservati, ma si spingessero a riproporne il contenuto con parole proprie e in forma semplificata ; attraverso questi interventi si riduceva in massime il dettato normativo, in una generalizzazione che ne favoriva l'applicabilità a decenni di distanza dalla prima emanazione143. Queste tecniche di lavoro, fondandosi su autorizzazioni come quella contenuta nella costituzione del 20 dicembre 435 {Quod ut brevitate constrictum cla- ritate luceat, adgressuris hoc opus et demendi supervacanea verba et adi- ciendi necessaria et demutandi ambigua et emendandi incongrua tribuimus potestatem, scilicet ut his modis unaquaeque inlustrata constitutio e<mine-
143 II materiale è stato sistematicamente studiato, con risultati definitivi, da E. Volterra, II problema del testo, cit. ; da ultimo Id., Intorno alla formazione del Codice Teodosiano, in BIDR, LXXXIII, 1979, p. 109 sgg., in particolare 133 sgg.
288 ANDREA GIARDINA E FRANCESCO GRELLE
αί>144) presupponevano un'ampia gamma di possibilità offerte ai contexto- res, da espletarsi in rapporto alle caratteristiche delle costituzioni quali risultavano nella formulazione originaria ο nell'esemplare loro disponibile : si oscilla da un massimo di fedeltà all'originale (una 'fedeltà' tutta relativa naturalmente, perché presuppone tagli più ο meno ampi ma sempre considerevoli), a un massimo d'infedeltà, che finisce addirittura per stravolgere il contenuto145. Nel caso di C.Th. I 16,11 avremmo un intervento fortemente semplificante : il primo periodo del frammento riassumerebbe in sostanza la parte centrale della Tavola (1. 10 sgg. : excursus del rector e operazioni di controllo), il secondo ne riprenderebbe la sanzione (1. 31 sgg.).
Tuttavia è altresì probabile, in linea di principio, che il frammento del Teodosiano e la Tavola siano due interventi iterati 146 : Probo avrebbe ricevuto in questo caso durante la sua prima prefettura due costituzioni sullo stesso argomento, una pervenutaci sotto forma più generica, e parzialmente aggiornata 147, l'altra dalla normativa più particolareggiata (non sarebbe comunque possibile stabilire una precedenza)148. Alla luce delle considerazioni svolte nel complesso di questo lavoro e delle osservazioni, più particolari, attinenti la palingenesi delle consolidazioni e il confronto tra la Tavola e C.Th. I 16,11 si può in altre parole prospettare una datazione sicura della Tavola agli anni 368-375, con una certa possibilità per il 369.
I due aspetti fondamentali della politica fiscale di Valentiniano si ritrovano, a ben guardare, nella Tavola di Trinitapoli. Quella tensione
144 C.Th. I 1,6 (20 dicembre 435). 145 Cf. E. Volterra, // problema del testo, cit., in particolare p. 1030 sgg. 146 Sull'iterazione degli interventi legislativi in quest'epoca, da ultimo J. Gaude-
met, Recherches sur la législation du Bas-Empire, in Studi Scherillo, II, Milano, 1972, p. 693 sgg.; in particolare, per l'età di Valentiniano, p. 704 sgg.
147 Per tale aspetto, in particolare, infra, p. 294. 148 Questa seconda ipotesi, che qui si propone in alternativa, escluderebbe dec
isamente la prima qualora ritenessimo con Godefroy {ad 1. I 7,5 = 16,11) che la costituzione de officio rectoris provinciae indirizzata a Probo il 1 aprile 369 fosse parte della stessa costituzione indirizzata al prefetto al pretorio delle Gallie Viven- tius lo stesso giorno (C.Th. I 16,12): cosa che in verità non è dimostrabile, come sembra ritenere lo stesso Seeck (Regesten, cit., p. 236), solitamente tutt'altro che cauto nel proporre ' cuciture ' tra più frammenti pervenuti nel Teodosiano. D'altro canto due temi come l'excursus del rector finalizzato al controllo della regolarità fiscale (trattato in I 16,11) e i luoghi delle sue residenze (trattato in I 16,12) non necessariamente dovevano coesistere nella stessa costituzione.
LA TAVOLA DI TRINITAPOLI 289
spesso aspra tra le esigenze di una percezione tributaria affidata ad amministratori imperiali e il rispetto dei diritti del contribuente, si racchiude infatti nel tema centrale dell'epigrafe : Yadventus del rector. Un tema che merita approfondimenti da molti punti di vista : le ideologie del potere, le forme dell'antagonismo e delle alleanze nelle campagne, l'organizzazione tecnica e finanziaria degli spostamenti. Esso ci sarebbe praticamente ignoto se non avessimo la nuova epigrafe : il riassunto presente in C.Th. I 16,11 è passato infatti inosservato per la sua eccessiva concisione, che trasse in inganno lo stesso estensore dell' interpretatio 149 e che fa pensare a una banale dichiarazione di principio; il commento di Gode- froy150 del resto, pur contenendo alcune preziose indicazioni, ha condiviso una sorte analoga. Ma la nostra maggiore conoscenza del problema consente adesso di ritrovare, tra le pieghe dei Codici e di altre fonti, alcuni interessanti riferimenti alla normativa in questione : si pensi in particolare alle disposizioni relative alla residenza degli ordinarii indices in remous ab aggere publico civitatibus 151 , oppure all'aspetto, assai rilevante, delle conseguenze economiche deìì'adventus dei governatori : Teodorico evocava con enfasi antiche disposizioni volte appunto a limitare l'esosità di questi spostamenti : Index vero Romanus pr opter expensas provincia- lium, quae gravare pauperes suggeruntur, per annum in unumquodque municipium semel accédât : cui non amplius quam triduanae praebeantur annonae, sicut legum cauta tribuerunt. Maiores enim nostri discursus iudicum non oneri, sed compendio provincialibus esse volue- runt152; lo stesso Cassiodoro non mancava di far riferimento a quei vete- ra constituta in base ai quali leges. . . administrantes remedio, non oneri esse volueruntl5ì. La precisazione della legge di Trinitapoli sulle virtù che devono guidare i governatori nell'evitare che i loro spostamenti siano gra-
149 II quale ritenne che la pena prevista per il conpulsor si riferisse ai indices : Indices provinciarum opérant dare debebunt, ut per singulos agros et loca sollicita inquisitione discurrant et per se, qualiter in solutione publici debiti cum possessori- bus agatur, agnoscant. Cuius rei curam si inplere neglexerint, querellant civium non dubitent in se severissime vindicandam.
15° Adi. I 7,5 (= I 16,11). 151 C.Th. VII 10,2 (23 novembre 407), con cui si consente agli ordinarii indices,
in modifica a quanto sostenuto in VII 10,1 (10 luglio 405) la permanenza in aedi- bus, etiamsi palatii nomine nuncupentur. - Sulle έπιδημίαι dei governatori in Egitto, p.es., Jacqueline Lallemand, L'administration civile de l'Egypte de l'avènement de Dioclétien à la création du diocèse (284-382), Bruxelles, 1964, p. 75 sg.
152 Cassiod., Var. V 14,7. 153 Cassiod., Var. XII 15,7.
MEFRA 1983, 1. 19
290 ANDREA GIARDINA E FRANCESCO GRELLE
vosi (1. 10-11 : turn — rector es provinciarum quibus forma / studioq(ue) \_p\ostuletur nullus honerosus videri — excursus 154), e si noterà la significativa coincidenza col testo di Cassiodoro {discursus /excursus, onus/honero- sus), inserisce a pieno titolo la nuova costituzione tra quei vetera constitu- ta di cui ancora si manteneva il ricordo nell'Italia teodoriciana. Ma l'aspetto della continuità nella normativa riguardante l'excursus del governatore non si esaurisce tra IV e VI d.C. e si presenta anzi come un punto di grande forza nel tradizionalismo dei modelli di governo provinciale : anche il proconsole, in età classica, doveva massimamente curare che nessun hospitium fosse gravoso per i provinciali : lo osservava già Ulpiano nel primo libro de officio proconsuìis155. Era molto importante, per la prospettiva entro cui queste norme si collocano, che quella sorta di parusia del governatore (fosse essa connessa al primo adventus nella provincia ο a successive peregrinationes), carica, dalla parte dei provinciali, di attese e di consapevole orgoglio, non fosse immediatamente sentita come un onere economico156 : non si doveva dire, di questi adventus, quello che il redattore della Historia Augusta dice del comitatus del principe : gravent esse provincialibus comitatum principis, etiam nimis parci157.
La storia tardoantica ci abitua tuttavia a un intreccio, talvolta sottile, di tradizione e mutamento : quella apparizione del proconsole che la con- suetudine non concepisce se non in un contesto urbano158, si arricchisce nel testo di Trinitapoli, e proprio in quell'Italia cha più di ogni altra è terra di civitates, di quella forma particolare di adventus che è X adventus attraverso i pagi. La polarità città-campagna, tra l'universo distante dei pagi e le singulae urbes 159, tra i campi dei possessores e le città dei tabula- rii, degli exactor es, degli officia, poteva superarsi, nella prospettiva del potere centrale, attraverso il contatto diretto tra il più alto rappresentante del potere stesso in ambito provinciale (il rector) e i possessores, per mezzo
154 Excursus nel senso di discursus, profectio, iter, expeditio, è un hapax nelle costituzioni imperiali, ma è frequentemente attestato dal latino classico a quello tardo : Th.l.L. V 2, col. 1295 sg.; cfr. 1291 sgg.
155 Ulp. I de off. proc, Dig. I 16,4. 156 Ο non suscitasse comunque riserve di ordine 'morale', in rapporto, p.es.,
alla presenza della moglie del proconsole al momento ae\\' adventus : Lucia Faniz- za, II senato e la prevenzione del «crimen repetundarum » in età tiberiana, in Labeo, 23, 1977, p. 199-214.
157 SHA, AP 7,11 sg. 158 P.es. Ulp. I de off. proc, Dig. I 16,7 : Si in aliquam celebrem civitatem vel
provinciae caput advenerit. . . Ma cf. in generale tutto I 16. 159 Cf. supra, p. 265 con η. 33.
LA TAVOLA DI TRINITAPOLI 291
di quéll'inquisitio (1. 16 : praesentes [irì]quisitione160) che nel nostro testo si qualifica come un vero e proprio confronto tra le parti. In tale contesto il rector assume il ruolo di unico garante. Le implicazioni ideologiche del risalto attribuito a tale ruolo, s'intendono appieno se si riflette sul tono che caratterizza le polemiche tardoantiche contro l'organizzazione imperiale, e la loro espressione in un testo come il de rebus bellicis : Ad haec igitur incommoda, quae provincias avaritiae artibus vexant, accedit edam iudicum execranda cupiditas, collatorum utilitatibus inimica. Nam hi, de- specta reverenda dignitatum, velut mercatores in provincias se missos exi- stimant, eo graviores quod ab his procedit iniquitas unde debuit sperari medicina; et tamquam sua sufficere non possit iniquitas, exactor es in pro- fligandis rebus huiusmodi dirigit unusquisque qui diversis rapinarum arti- bus collatorum vires exhauriant; videlicet quasi parum notabiles haberen- tur si soli peccarent 161 . Una polemica come questa, «esemplare» per l'intuibile posizione dell'anonimo autore e la sua evidente profonda conoscenza dei meccanismi di governo e dei loro riflessi sociali, s'incentra sulla stretta complicità tra gli iudices e gli exactores da loro inviati 162 : « pensano certo, questi governatori, di non distinguersi abbastanza, se restano soli nelle loro colpe».
La prospettiva che nel de rebus bellicis contrappone iudices ed exactores da una parte, possessores dall'altra, appare radicalmente mutata nella nuova costituzione di Trinitapoli : qui la presenza fisica dei governatori durante l'inchiesta (1. 16) ha lo scopo di verificare con la massima attenzione (1. 16-17 : adtentissime/mox requ[ira]nt 163) l'eventuale occultamento, a opera dei funzionari, dei versamenti ο la loro sottrazione. Il governatore dunque quasi come unico garante della correttezza fiscale, che con la sua presenza smaschera (1. 23 : collubione submota 164), al cospetto dei contri-
160 per inquisitio in campo fiscale, cf. Cassiod., Var. VI 8,6; ma per l'età valenti- nianea è significativo il confronto con ispectione alla 1. 3 della lex di Casamari (cf. S. Panciera, op. cit.., p. 275 sg.; forse discussorum?] ispectione: S. Mazzarino, Antico, tardoantico, I, cit., p. 327, n. 79).
161 De rebus bellicis, 4; cf. S. Mazzarino, op. cit., p. 224. 162 Exactores . . . dirigit unusquisque [seil, iudex] è espressione tecnica, da cf., e
il particolare non è privo d'importanza, con espressioni come qui. . . ad gubernan- da officia diriguntur di C.Th. VI 28,6 (12 novembre 399).
163 L'espressione ha un solo riscontro nei Codici, in C.Th. I 15,6 : requirat attente [seil, vicarius Africae], emessa il 27 febbraio 372 da Valentiniano I. Cf. n. sg.
164 Un'espressione da cf. p. es., con ab hac debent conluvione secerni di C.Th. XIII 3,7, indirizzata a Petronio Probo il 19 gennaio 369 ( una data che ci riporta quindi ancora una volta alla cancelleria di Valentiniano I, nello stesso periodo in cui presumiamo sia stata emessa la costituzione di Trinitapoli). Per la costruzione dell'abl. assoluto di submoveo in fine periodo, cf. C.Th. XI 1,35.
292 ANDREA GIARDINA E FRANCESCO GRELLE
buenti, le frodi e gli abusi compiuti congiuntamente dagli esattori e dagli uffici : 1. 22 : conpulso[ribus] perfidis officiisq{ué) p[er]/versis.
Sono molte le riflessioni che tutto questo suscita. Potremmo chiederci fino a che punto nei suoi anni di governo, un rector fosse in grado di (o più semplicemente volesse) percorrere tutti i pagi della sua circoscrizione territoriale e interrogare tutti i possessor es. Ma entreremmo in un campo dove l'incertezza è d'obbligo : i lettori del Teodosiano sanno che i desideri del potere finiscono spesso per assumere un valore quasi esclusivamente ideologico : esprimono simboli sotto forma di accurate normative, timori sotto forma di severe condanne. Quello che più importa è invece sottolineare come la normativa riguardante Yadventus e Yinquisitio del rector comporti il riconoscimento ufficiale dell'incapacità del potere di controllare i « perfidi » f unzionari 16S : le possibilità di controllo sono offerte unicamente dalle eventuali proteste dei possessores inoltrate personalmente (questo è un punto fondamentale) al rector ο dall'oggettivo confronto tra le parti. Questa implicita ammissione è tuttavia più evidente per l'osservatore di oggi, abituato alle consolidate immagini dello stato moderno, che per gli stessi amministratori e legislatori antichi, i quali si trovavano a operare in schemi istituzionali profondamente diversi, entro cui era appunto possibile concepire le alte funzioni del rector quasi in contrapposizione all'organizzazione degli officia da lui, nella sostanza, dipendenti, e la tutela del contribuente come possibile soltanto mediante un rapporto personale tra il contribuente stesso e il suo governatore : una sorta di «dono» dell'equità e della correttezza amministrativa elargito personalmente. Basterebbe questo a allontanare — pur riguardo a una compagine altamente strutturata sotto il profilo dell'organizzazione istituzionale come quella tardoantica — le immagini dello stato moderno dalle realizzazioni antiche.
Sotto un profilo diverso, queste stesse considerazioni consentono di riconoscere nella nuova legge di Trinitapoli una delle testimonianze più
165 La perfidia, qualità tipica degli eretici, (p.es. C.Th. XVI 5,6; 12; 37; ecc), ma anche dei Iudaei e, più in generale degli infidèles (Christine Mohrmann, Études sur le latin des chrétiens, II, Roma, 1961, p. 29) in una costituzione del 385 è attribuita anche agli apparitores e contrapposta ai publica commoda : Ne diu apparito- rum prava admodum venalisque perfidia in publica impune commoda desaeviret . . . (C.Th. IX 40,14), come nell'epigrafe di Trinitapoli alla perfidia dei conpulsores pone rimedio la lex che giova publicis adque privatis fortunis. In Nov.Val. VII 1 (440) il comportamento dei conpulsores è associato a termini come calliditas e aviditas (1. 15). — Perversis della 1. 22, riferito a officiis può essere confrontato con perversi iudices di C.Th. XI 7,3 (31 gennaio 320).
LA TAVOLA DI TRINITAPOLI 293
significative sulla storia sociale dell'epoca. Quella particolare distribuzione dei ruoli (il possessor, il conpulsor, il index) sulla scena di una rappresentazione a suo modo 'drammatica' dell'incontro tra i contadini e il potere, assume infatti un implicito valore paradigmatico : mette in luce l'antagonismo dominante, quello tra piccoli collatores ed esattori, ed esalta al tempo stesso le funzioni del index quale tutore d'intere comunità. Ma anche sul versante dell'alleanza tra domini e coloni, che caratterizza profondamente, insieme all'antagonismo tra coloni ed esattori, la compagine sociale tardoantica 166, sarebbe senza dubbio limitativo non cogliere il nesso tra le funzioni formali e tecniche del rector il cui adventus ripristina l'ordine sovvertito, e le funzioni, pur solidamente (anche se in modo assai meno formale) costituite, del patrono che lega a sé la devozione delle collettività, talvolta delle regioni intere. La costituzione che oggi leggiamo a Trinitapoli sarà forse stata affissa nelle terre di qui Veneti adque Histri che si dicevano peculiares di Petronio Probo 167, ο in Campania, dove gli Anicii erano originales patroni 168 e indices di altissimo prestigio, tanto da poter un giorno affermare di avere elevato, nella propria persona, il rango della provincia169. Attraverso un'articolazione di piani molto complessa si costruisce dunque la solidarietà tra le popolazioni contadine e le aristocrazie terriere : nelle funzioni di redores gli esponenti delle grandi gen- tes difendono i possessores dagli abusi degli officia e si fanno tutori dei supremi valori degli ordinamenti, nel ruolo di domini proteggono dal fiscalismo chi si pone sotto il loro patrocinio, e procacciano immunità. La forma tarda della clientela conosce percorsi intrecciati ma convergenti.
Del resto, quegli stessi aristocratici che nel modello proposto dalla lex di Trinitapoli appaiono, in quanto rectores, come coloro che operano una saldatura tra i possessores organizzati in pagi e le città, agiscono invece di fatto, in quanto domini, come i maggiori oppositori dei rari tentativi compiuti in questo periodo per dare forma e organizzazione alla solidarietà dei convicani. L'istituto che garantiva la preferenza nelle vendite ai convi- cani, derivante dall'antica usanza che assicurava ai consortes la prelazione 170, fissato per legge nel IV secolo, si scontrò ripetutamente con la resi-
166 Da ultimo, A. Giardina, Lavoro e storia sociale : antagonismi e alleanze dall'ellenismo al tardoantico, in Opus, I, 1982, p. 131-133; ma soprattutto S. Mazza- rino, Antico, tardoantico, cit., II, p. 431-445.
167 Cf. supra, p. 271 con n. 58. l6*AE 1972, 75 b; 76. 169 AE 1972, 75 b; cf., DArch, 9-10, 1976-1977, p. 672. 170 E. Levy, West Roman Vulgar Law. The Law of Property, Philadelphia, 1951
p. 158 sgg.
294 ANDREA GIARDINA E FRANCESCO GRELLE
stenza dei domini (si pensi al caso del podere comprato da Simmaco ab antiquissìmo possessore contro il diritto di prelazione di un tale Leo171), che in queste forme di solidarietà giustamente vedevano un ostacolo all'espansione del latifondo172, e con gli alterni ripensamenti del legislatore173. Ed è proprio dal sistema delle villae che provengono segnali di distacco e rifiuto anche su un terreno specifico come quello dell'excursus del rector : una novella di Maioriano, quasi un secolo dopo la Tavola di Trinitapoli, registra il comportamento riprovevole degli actores potentium personarum i quali si sottraggono al cospetto del governatore quando percorre la provincia (iudici per provinciam discurrenti) ; essi si trattengono come «contumaci» nei praedia e non entrano nemmeno in contatto col rappresentante del potere174. Ma già la costituzione di Valentiniano I (C.Th. I 16,11) di cui si è sopra proposto un collegamento con la Tavola di Trinitapoli introduce l'elemento della villa che non compare invece nel testo epigrafico175: per omnium villas... vicosque cunctos discurrant. Questa aggiunta può essere spiegata variamente; come aggiornamento da parte dei compilatori di un contenuto quanto mai inadeguato a render conto di una tensione tra forme d'insediamento diverse, le prime tradizionali e indebolite, le altre ormai dominanti, oppure (preferibilmente) nei seguenti due modi : come variante derivata da parte non pervenuta dell'epigrafe ο come complemento proposto nella stessa età di Valenti-
171 Symm., Ep., IX 30. Cf. S. Roda, Commento storico, cit., p. 153 sg. 172 S. Mazzarino, L'impero romano, Roma, 19562, p. 328 n.l. 173 Questo diritto fu abolito con C.Th. Ili 1,6 (27 maggio 391) : Dudum proximis
consortibusque concessum erat, ut extraneos ab emptione removerent neque homines suo arbitratu vendenda distraherent. Sed quia gravis haec videtur iniuria, quae inani honestatis colore velatur, ut homines de rebus suis facere aliquid cogantur inviti, superiore lege cassata unusquisque suo arbitratu quaerere vel probare possit empto- rem. Esso però fu parzialmente ripristinato nel V secolo : C.Th. XI 24,6 (3 dicembre 415); CI. XI 56,1 (1 settembre 468).
174 Nov.Maior. II 4 (10 marzo 458) : Habenda sane ratio est potentium persona- rum, quarum actores per provincias solutionem fiscalium neglegunt, dum pro sui terrore fastidii minime perurguentur ac se in praediis retinent contumaces, ne ad eos praeceptum iudicis possit aut conventio pervenire : et idcirco clarissimarum domo- rum vel potentium iubemus actores seu procuratores in his civitatibus iudici per provinciam discurrenti sui facere et exhibere praesentiam, in quarum territoriis praedia suorum sciant esse patronorum et tamdiu publicis inhaerere conspectibus, quamdiu in eodem oppido morari viderint cognitorem; quod etiam sacrae domus nostrae observare iubemus actores.
175 L'unico luogo della parte tramandata del testo epigrafico dove poteva esservi un riferimento alle villae è immediatamente dopo pagos alla 1.13 ma una lettura come et villas è senz'altro da escludersi.
LA TAVOLA DI TRINITAPOLI 295
niano con una ordinanza iterata sull'excursus del rector176. Essa è comunque quanto mai significativa di una dialettica nella quale si riassume, per tanti aspetti, la storia sociale delle campagne tardoantiche.
8 - L'ORGANIZZAZIONE PAGANICA
Diretto a proteggere i contribuenti dalla collusione fra funzionari provinciali e tabularli cittadini, l'intervento di Valentiniano costruisce un sistema di registrazioni e di controlli che integra e nello stesso tempo corregge, per alcuni aspetti determinanti, la disciplina tracciata dalla legislazione anteriore. Per quanto ci è dato di conoscere attraverso i testi massi- mati delle compilazioni, i provvedimenti imperiali erano venuti definendo negli anni tempi e modalità della susceptio delle imposte in natura per l'arca prefettizia; avevano fissato le norme sulla nomina dei susceptores, dei praepositi dei pagi e degli horrea, dei tabularti ; avevano organizzato meccanismi di controllo e di coazione per il recupero degli arretrati177. Pur nella diversità degli obiettivi che di volta in volta si erano proposte, le indicazioni legislative avevano tuttavia trascurato di tracciare modelli uniformi e cogenti per le procedure secondo le quali il contribuente provvedeva in ciascuna civitas all'adempimento della prestazione fiscale 178. La disciplina di queste procedure manca persino nell'ampio e minuzioso provvedimento con cui Costantino riorganizza, nel novembre del 313, l'amministrazione della provincia d'Africa179. Divisa dai compilatori del Teodosiano in sei frammenti ripartiti tra cinque titoli, la costituzione regola anche gli aspetti tributari del governo provinciale, attraverso un complesso di norme che è fra i più minuziosi a noi conservati dalle compilazioni 180. Si prevede infatti che i contribuenti facciano registrare dai
176 Cf. supra, p. 288. 177 Le linee del sistema di istituzioni e di apparati che dall'età dioclezianea
curano l'imposizione e l'esazione dei tributi per l'annona sono ricostruite da A.H.M. Jones, The later Roman Empire, Oxford, 1964, 1, p. 456 sgg., II, p. 726 sgg., e da F. De Martino, Storia della costituzione romana, V, Napoli, 1975, p. 390 sgg., in particolare 423 sgg. Una rapida analisi delle fonti legislative è tracciata da J. Karayannopulos, op. cit., p. 84 sgg.; ma cf. sempre A. Déléage, La capitation, cit., passim.
178 Cf. in particolare F. De Martino, op. cit., p. 422, 516 sgg. "9C.Th. I 12,1; 3; Vili 10,1; X 15, 1; XI 1,2; XI 7,1 (8 novembre 313): cf.
Ο. Seeck, Regesten, p. 88, 161. 180 Cf soprattutto C.Th. XI 1,2 : Possessores cum satisfecerint publicae conlationi,
cautiones suas ad tabularios publicos déférant ut eas tabularli sive sexagenarii peri-
296 ANDREA GIARDINA E FRANCESCO GRELLE
tabularli civitatum le ricevute dei versamenti effettuati, e che i funzionari inviati a esigere il tributo dai renitenti operino su indicazione dei tabularli stessi, che prepareranno elenchi nominativi dei ritardatari. Per quanto è possibile dedurre dai frammenti pervenutici, la costituzione disciplinava quindi gli atti e i procedimenti relativi al gettito tributario della civitas, assunta come unità di base per il conferimento delle imposte ; trascurava invece di regolare le forme dei rapporti fra contribuenti ed esattori cittadini, lasciate evidentemente all'autonomia organizzativa delle civitates. Il provvedimento di Valentiniano interviene proprio in questo spazio, imponendo ai praepositi pagorum, e ai praepositi horreorum, forme e modalità di registrazione simili a quelle che Costantino aveva richiesto al tabularius per l'intera civitas. La nuova disciplina vincola il tabularius al coordinamento dei dati proposti dai breves per i singoli pagi, interponendo fra pos- sessores e tabularli la mediazione, necessaria e formalizzata, dei praepositi, e affida al governatore stesso funzioni di controllo, dirette a smascherare omissioni e abusi nella tenuta dei registri cittadini come a sorvegliare le operazioni del prelievo tributario nei pagi. Il disegno organizzativo sotteso al provvedimento sembra così rivendicare all'amministrazione provinciale compiti tradizionalmente svolti dalla civitas attraverso i mezzi e con le modalità proprie all'autogoverno locale, mentre assume il pagus come distretto di base per l'esazione delle imposte, e raccorda all'apparato dei funzionari imperiali, in termini che restano non del tutto chiari, gli addetti agli archivi cittadini e i preposti ai distretti rurali, sottraendoli alla dipendenza dalle curie181. Per questo aspetto, le norme conservateci dalla tavola di Trinitapoli vengono così a precisare e integrare una linea di politica istituzionale già osservata in costituzioni pervenute attraverso il Teodosiano, una linea per cui, fra il 364 e il 365, susceptores e praepositi horreorum si dispone provengano ex praesidali officio 182.
culi sui memores suscipiant a conlatoribus ipsas species quae debentur ex horreis suis ad civitates singulas per menses singulos perlaturis, ne inlatio tributorum ex solis apochis falsis vel imaginants cognoscatur ; XI 7,1 : Ducenarii et centenarii sive sexagenarii non prius debent aliquem ex debitoribus convenire quam a tabulano civitatis nominatim breves accipiant debitorum . . .
181 Cf. supra, § 5. 182 Cf. C.Th. XII 6,7 (4 agosto 364 : per la data, Ο. Seeck, Regesten, cit., p. 85);
C.Th. VIII 3,1 (19 settembre 364); C.Th. XII 1,70 (30 gennaio 365, che già il Gode- froy collegava a VIII 7,8); C.Th. XII 6,4 (18 aprile 365 : Ο. Seeck, Regesten, p. 31 la collega a XII 6,6); C.Th. XII 6,9 (31 agosto 365); C.Th. XII 6,5 (2 novembre 365 : 0. Seeck, Regesten, p. 33). Per un esame complessivo, S. Mazzarino, Aspetti sociali, cit., pp. 187 sgg. ; cf. anche A. Déléage, op. cit., p. 35 sgg. ; 206 sgg. ; 224 sgg.
LA TAVOLA DI TRINITAPOLI 297
L'apporto più interessante offerto dal nostro documento alla conoscenza delle forme istituzionali attraverso le quali si costruisce e si sviluppa la riorganizzazione di Valentiniano I è forse costituito dalle norme sui pagi e i loro praepositi. Nella legislazione imperiale del IV secolo, accanto a un riferimento indiretto negli atti di un dibattito processuale, interventi sull'assetto organizzativo di questi distretti rurali erano attestati da due costituzioni. La prima, un'epistola costantiniana, inviata nel 325 a un certo Felice di cui non conosciamo né la funzione esercitata, né l'area territoriale di esercizio, disponeva che susceptores, praepositi pagorum e praepositi horreorum fossero tutelati nei confronti di arbitrarie richieste di adaeratio, avanzate dai preposti a corpi militari 183. La seconda, indirizzata da Valente nel 365 al prefetto del pretorio d'Oriente Saturninius Secun- dus Salutius riconfermava la responsabilità dei nominatores per l'inidoneità dei susceptores, dei praepositi pagorum e dei praepositi horreorum da essi designati, iuxta inveteratas leges194. A queste due testimonianze si è proposto di aggiungere una terza, sostituendo praepositi . . . pagi a praepositi. . . pacis in una costituzione di Costanzo inviata nel 361 a Flavius Taurus, prefetto del pretorio d'Italia e d'Africa : ma si tratta di un emendamento assai discutibile, e che urta tra l'altro contro la frequenza con cui è ricordato, ancora in quest'epoca, il munus irenarchae 185.
1S3C.Th. VII 4,1 : Imp. Constantinus A. Have Felix k(arissime) n(obis). Tribunos sive praepositos qui milites nostros curant annonas per dies singulos scribtionis indi- ciò sibi débitas in horreis derelinquere non oportet, ut procuratores seu susceptores vel praepositi pagorum et horreorum earn comparent (19 ottobre 325). Il Mommsen, ad /., propone di considerare Felix prefetto del pretorio; in PLRE I, p. 331, il personaggio è detto vicario d'Africa, ma non si adduce alcun documento a sostegno dell'ipotesi. Per l'inquadramento, S. Mazzarino, Aspetti sociali, cit., p. 169-177.
184 C.Th. XII 6,8 : Iuxta inveteratas leges nominatores susceptorum et eorum qui ad praeposituram horreorum et pagorum creantur, teneantur obnoxii si minus idonei sint qui ab eisdem fuerint nominati (30 luglio 365). Cfr. A. Déléage, op. cit., p. 36; S. Mazzarino, op. cit., p. 408, η. 65, che riferisce l'intervento a una situazione in cui Valente non aveva ancora introdotto nelle province orientali i mutamenti nella susceptio già avviati da Valentiniano in Occidente (cfr. §. 5).
185 C.Th. XII 1,49(2): si praepositi horreorum iique, qui suscepturi sunt tnagi- stratum, praepositi edam pacis seu susceptores diversarum specierum ad ecclesiam crediderint adspirandum, postquam officia impositae sollicitudinis aut honoris ad- gressi sunt, ipsos primum antistites supernae legis conveniet reluctari ipsisque pri- mum adnìtentibus eosdem ad obsequia congrua revocari (29 agosto 361). La lettura della costituzione, conservata da un solo codice, il Vaticanus Reginae 886, è sicura per il passo che ci interessa. La correzione, proposta da A. H. M. Jones, op. cit., III, p. 328 η. 29, riprendendo J. Godefroy, ad l., implicherebbe la dipendenza del singolare pagi dal plurale praepositi, determinando uno stridente contrasto con l'uso
298 ANDREA GIARDINA E FRANCESCO GRELLE
Lo stato delle fonti non permetteva dunque di cogliere l'estensione del ricorso ai praepositi pagorum nell'assetto amministrativo tardoantico, né di valutarne la rilevanza per la storia istituzionale. I rari documenti che attestano la permanenza di un'organizzazione paganica nelle province occidentali186 sembravano difficilmente raccordabili alle notizie sui compiti e le attività del praepositus pagi nella prefettura d'Oriente. In questo ambito territoriale, il praepositus è ricordato già nella clausola di pubblicazione dell'epistola con la quale Sabinus, prefetto del pretorio di Mas- simino Daia, comunica ai governatori delle province orientali le disposizioni sulla tolleranza verso i cristiani previste dall'editto di Galerio, nel 311 187. La documentazione papirologica attesta peraltro come l'istituto fosse stato introdotto nell'ordinamento amministrativo dell'Egitto nel 308, portando a termine la trasformazione del nomos in territorio della metropoli, secondo la linea proposta un secolo avanti dalle riforme severia- nei88 pjù tardi, il praepositus è ricordato incidentalmente nei verbali di un procedimento giurisdizionale svoltosi innanzi a Costantino, fra parti grecoloquenti 189. Infine, l'unica delle costituzioni disciplinanti l'istituto di cui si conoscesse il destinatario è, come si è visto, indirizzata a un prefetto del pretorio d'Oriente190. Introdotto da provvedimenti normativi imperiali risalenti al primo decennio del secolo, il riassetto organizzativo che aveva regolato e generalizzato le funzioni del praepositus pagi sembrava pertanto avesse investito solo le civitates delle province orientali. Ora, la tavola di Trinitapoli attesta invece che l'istituto ha avuto uno spazio non
del plurale per gli horrea, alle dipendenze anch'essi di praepositi, ricordati all'inizio della clausola. Al munus irenarchae è tra l'altro dedicato il titolo XII 14 del Teodo- siano.
186 II catasto di Volcei nei Bruttii attesta come il territorio della civitas nel 323 fosse ripartito in pagi : CIL X 407 = // III 1,17. Una costituzione di Giuliano, C.Th. Vili 5,16 (25 novembre 362 : per la data 0. Seeck, Regesten, cit., p. 94) attesta incidentalmente l'organizzazione in pagi delle campagne sarde : In provincia Sardinia . . . memoratum cursum penitus amputavi oportere decernimus, quem maxime rustica plebs, id est pagi, contra publicum decus tolerarunt. Su questi documenti ha richiamato di recente l'attenzione M. Frederiksen, Changes in the Patterns of Settlements, in Hellenismus in Mittelitalien, Kolloquium in Göttingen vom 5 bis 9 juni 1974, II, Göttingen, 1976, p. 341 sgg.
187 Cf. supra, n. 28. 188 Cf. J. Lallemand, L'administration civile, cit., p. 96 sgg.; 131 sg. ; A.K. Bow
man, The Town Councils of Roman Egypt, Toronto, 1971, p. 15 sgg.; 123 sgg. 189 C.Th. VIII 15,1 (1.5): Agrippina dixit : του τόπου εκείνου πραιπόσιτος ούκ
ην. 190 C.Th. XII 6,8, cit. a n. 184.
LA TAVOLA DI TRINITAPOLI 299
irrilevante nell'ordinamento territoriale della prefettura d'Italia, per lo meno nelle iniziative legislative di Valentiniano I. Risulta anche confermata l'intuizione degli studiosi dell'organizzazione rurale romana, per cui l'assetto in pagi si conserverebbe in qualche modo latente nella sistemazione in municipio., e riemergerebbe in età tardoantica191.
Allo stato attuale della nostra documentazione va tuttavia osservato che sarebbe arbitrario proporre un'immediata continuità istituzionale fra i praepositi pagorum della legislazione tardoantica e i magistri dei pagi dell'età della municipalizzazione della penisola192. Il provvedimento di Valentiniano sembra piuttosto rimandare a esperienze organizzative proprie delle civitates delle province egiziane. In particolare, la prescrizione di breves mensili compilati dai preposti ai distretti rurali per aggiornare il tabularius civitatis sull'andamento del gettito tributario riconduce alle minuziose procedure di registrazione conservate dalla documentazione papirologica. Si riscontra infatti in essa un'articolata morfologia di registrazioni κατ' άνδρα, con frequenza mensile e annuale, compiute da litur- ghi di funzioni e livello diversi. Così, un papiro di Theadelphia193 proveniente dall'archivio di Aurelio Sakaon attesta una εϊσπραξις di grano ai sitologi, compiuta il giorno ι del mese έπίφ : i sitologi operano alle dipendenze del praepositus pagi, al quale inviano rendiconti annuali (come quello conservato in P. Cairo Isid. 9). Registrazioni del tipo di quella attestata dal documento dell'archivio di Sakaon, datato al 322 dal primo editore, ma ora posticipato al 352, potrebbero avere offerto gli elementi necessari a un rendiconto mensile con indicazioni giornaliere dei versamenti ricevuti; dei dati richiesti dalla costituzione di Valentiniano si omette solo di segnalare quid. . . trahatur in reliquis.
Nelle province egiziane, i praepositi pagorum erano stati istituiti in connessione col riordinamento di quei territori in civitates, per adattare in qualche misura lo schema organizzativo romano-italico alle peculiarità locali. In Italia, l'istituto può essere stato introdotto proprio da Valentiniano, nell'ambito della vasta riforma che egli propone e avvia per la
191 Cfr. M. Frederiksen, op. cit., che riprende e aggiorna per questa parte le conclusioni del saggio di G. P. Bognetti, Sulle origini dei comuni rurali nel medioevo, in Studi nelle scienze giuridiche e sociali 10 e 11, Pavia, 1926, = Studi sulle origini del comune rurale, Milano, 1978, p. 3 sgg. ; in particolare 21 sgg. ; 71 sgg.
192 L'intuizione della discontinuità già in G. P. Bognetti, op. cit., p. 81. l9ìP.Thead. 30 = P. Sakaon 10, su cui A. Déléage, op. cit., p. 82. - Per i compiti
del praepositus pagi in Egitto, N. Lewis, Two Editions for Recovery, in JJP, II, 1948, p. 54 sgg.; J. Lallemand, op. cit., p. 131 sgg.
300 ANDREA GIARDINA E FRANCESCO GRELLE
susceptio specierum 194. I provvedimenti di Valentiniano infatti intervengono fra l'altro a definire meticolosamente le procedure di esazione, precisando tempi e modi dei rapporti intercorrenti fra i piccoli possessores e gli addetti alla contabilità dei tributi e alla conservazione delle derrate, come attesta la lex conservata dalla Tavola di Trinitapoli. Nella stessa prospettiva, la riforma può avere conferito l'organizzazione e la sorveglianza della susceptio nei pagi a preposti designati forse dalle curie, ma operanti in stretto collegamento con i funzionari provinciali195: l'antico assetto paganico della penisola sarebbe stato ora rimodellato secondo la formula già elaborata da Massimino per l'Egitto. I riferimenti del Codice Teodosiano, rari, sporadici e pertinenti tutti come si è visto, alla prefettura d'Oriente, sembrano confermare questa ipotesi; essi implicano infatti un'applicazione territorialmente limitata della formula stessa, ignota ο di ridotta incidenza al di fuori delle province egiziane, prima della riforma.
Abbia istituito per la prima volta i praepositi pagorum in alcuni dei territori affidati alle cure di Probo, ο ne abbia più semplicemente ridisegnato compiti e responsabilità nell'esazione delle imposte in natura, la riforma di Valentiniano avrà comunque incontrato, per ciò che attiene al riordinamento dei pagi, ostacoli non minori di quelli frapposti alle norme sulla designazione dei susceptores e dei praepositi horreorum. L'ostilità delle curie cittadine e la resistenza dei contribuenti stessi, sensibili ai benefici della connivenza con i principales locali e all'attenuazione dell'intervento dei funzionari provinciali, condanna a una più ο meno rapida decadenza le nuove procedure e l'intero assetto organizzativo che le sostiene. La lunga costituzione con cui Onorio regola, nell'aprile del 397, il prelievo dell'annona e l'approvvigionaamento dell'urbe ignora la norma per cui i susceptores dovrebbero essere scelti fra gli officiales, li attesta electi . . . de curiis196. Il dato si riferisce assai verosimilmente all'Italia suburbicaria; nell'Illirico orientale, a suo tempo anch'esso investito dalla riforma, un provvedimento di Teodosio II interviene nel 412 a tutelare i procuratores curiarum nella gestione delle annonae e delle species cella-
194 Cf. § 5. 195 Come in Egitto: Jacqueline Lallemand, op. cit., p. 132. 196 C. Th. XII 6,24 (15 aprile 397). Altri frammenti della stessa costituzione
sono conservati in C. Th. VI 2,17; VI 2,18; VI 4,31; XIII 5,27; XIII 9,5; XIV 15,3; C. I. IV 40,3 : cf. Ο. Seeck, Regesten, cit., p. 292. Il confronto tra C. Th. XII 6,24 e XIII 9,5 chiarisce che il praefectus annonae e il vicarius ricordati nella prima svolgono le loro funzioni in urbe: diversam. A. Chastagnol, La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire, Paris, 1960, p. 302 η. 4.
LA TAVOLA DI TRINITAPOLI 30 1
rienses dovute ai funzionari provinciali197, e implica pertanto un coinvolgimento degli amministratori cittadini anche nella susceptio. Per i praepo- siti pagorum, il Codice Teodosiano non offre indicazioni, dopo il 365 : la legge riemersa a Trinitapoli è esclusa dalla raccolta, non sappiamo per quali motivi 198, ο vi si conserva in forme pressocché irriconoscibili, ridotta alle sole norme sull'excursus del governatore 199.
Il silenzio del Codice Teodosiano non comporta tuttavia di necessità l'abrogazione implicita delle norme che avevano previsto e disciplinato i compiti dei praepositi nella susceptio, e la conseguente scomparsa dell'assetto da esse introdotto. La novella con la quale Teodosio II, il 15 febbraio 438, dispone che lo ius principale sia documentato esclusivamente dal Codice, e connota di falso i provvedimenti tramandati al di fuori della raccolta, prevede infatti alcune rilevanti eccezioni200. La presunzione di inautenticità viene esplicitamente esclusa per i documenti conservati negli archivi dei comandi militari e degli uffici imperiali. In forma confusa e sfuggente, ponendo l'accento sulle modalità di conservazione degli atti piuttosto che sui loro destinatari e sul loro contenuto normativo, Teodosio riconosce comunque la necessità d'integrare la disciplina legislativa consolidata dai compilatori con i provvedimenti da essi tralasciati ο ignorati, per definire l'ordinamento degli eserciti non meno che l'organizzazione e le procedure degli apparati di governo201. Per questi settori del sistema imperiale, l'esigenza di rendere esaustivo il Codice trova un ostacolo insormontabile nel frazionamento territoriale e per gruppi e categorie secondo cui si scompone il potere politico, solo f ormalmente unitario. Come un secolo più tardi Giustiniano stesso nella Summa rei publicae202,
197 C. Th. VII 4,32 (17 agosto 412). L'Illirico orientale aveva fatto parte dei ter- ritori affidati a Probo, prima di essere separato dell'Illirico occidentale (S. Mazza- rino, Stilicone. La crisi imperiale dopo Teodosio, Roma, 1942, cap. I). Nella prefettura d'Oriente le riforme di Valentiniano, introdotte con qualche ritardo da Valente, erano già cadute in disuso per opera di Teodosio I: cf. supra, p. 274 con η. 74.
198 Si può pensare che gli archivi occidentali avessero trascurato di inviare il documento ai commissari di Teodosio Π, ο lo avessero smarrito: ma quest'ultima ipotesi sembra meno probabile.
199 Cf. § 7. zoo Nov. Th., I. Su questo documento, e sui problemi posti dalla pubblicazione
del Codice, cf. Franca De Marini Avonzo, La politica legislativa, cit., p. 124 sgg. 201 Nov. Th., 16: ... falsitatis nota damnandis quae ex tempore definito Theodo-
siano non referuntur in codice, exceptis his, quae habentur apud militum sacra principia vel de titulis publicis expensarum aliarumque rerum gratia quae in regestis diversorum officiorum relata sunt.
202 4: ... sed et si qua regesta in tui culminis indicio vel in aliis indiciis civilibus
302 ANDREA GIARDINA E FRANCESCO GRELLE
così Teodosio II rinuncia a proporre attraverso la compilazione modelli onnicomprensivi e uniformi per i meccanismi di governo, con un cedimento che è forse il più significativo nei confronti del progetto di un codice magisterium vitae203.
La recezione del Codice nei territori di Valentiniano III avrà conosciuto modalità e limiti non diversi da quelli indicati nella novella teodo- siana. In ogni caso, nemmeno in essi i provvedimenti rimasti fuori della compilazione avranno perso efficacia, ove esigenze particolari ne imponessero la conservazione per impedire fratture ο turbamenti nella disciplina degli eserciti e nell'attività degli apparati amministrativi.
L'assetto organizzativo aeìì'Apulia et Calabria fra IV e V secolo è troppo poco noto nelle sue articolazioni minori perché si possa senz'altro asserire un radicamento in quest'area del sistema di esazione costruito da Valentiniano I, e la sua sopravvivenza alla recezione del Codice Teodosia- no. Più indizi concorrono tuttavia nel sottolineare il rilievo che nella geografia antropica della regione, se non immediatamente in quella amministrativa, vengono ora acquistando insediamenti rurali che gravitano intorno a centri di più ο meno antica e consistente urbanizzazione. Il rilievo di questi vici, e delle strutture paganiche che li sostengono, sembra in espansione soprattutto lungo il versante adriatico della provincia, dove il fenomeno si propone con significativa evidenza nel territorio canosino. Qui, il confronto fra gli itinerari più antichi e la Tabula Peutingeriana sottolinea la trasformazione ο la sostituzione di anonime stationes con insediamenti rurali di qualche consistenza, designati con toponimi. A ovest di Canusium infatti, lungo l'Appia Traiana, alla mutatio Undeci- mum dell'Itinerarium Burdigalense subentra Furfana, la cui denominazione fa pensare a un prediale derivato dall'onomastica canusina, passato poi a indicare un vicus204; a est, lungo la stessa via, Ad Quintodecimo è sostituito da Rudas. Sulla costa, la Tabula ricorda immediatamente a nord della foce dell'Ofanto un Aufinum, che può essere identificato con l'Aufidena dell'Itinerarium Antonini; a sud del fiume, Bardulos e successivamente, a nove miglia, Turenum. Per Turenum, un toponimo che non ha riscontro in altre fonti, ma che è concordemente identificato con il
vel militaribus vel apud principia numerorum pro publicis expensis vel quibuscum- que titulis ad publicum pertinentibus posila sunt, ea etiam, prout communis rei com- moditas exigit, firma esse censemus.
203 Sul codice magisterium vitae cf. G. G. Archi, Teodosio II e la sua codificazione, cit., p. 27 sgg.
204 Una Furfonia è attestata a Canusium: D. Morrà, Canosa e suoi dintorni, Canosa, 1902, p. 96 sg.
LA TAVOLA DI TRINITAPOLI 303
Tranum dei documenti altomedioevali, l'esistenza di una ecclesia Tranen- sis, affidata alle cure di un Eutichius episcopus agli inizi del VI secolo205, è oggi confermata dai ritrovamenti archeologici al di sotto della cattedrale romanica206, e suggerisce l'ipotesi dell'insediamento nel vicus di un vescovo di campagna207, con lo sviluppo della cristianizzazione della civi- tas canosina. Infine Cannae, ignobilis vicus Apuliae nella considerazione di Fioro, in età adrianea, è ricordato ancora da Procopio in uno spunto erudito che sembra attestare comunque la permanenza dell'insediamento, durante la guerra greco-gotica208. I movimenti di popolazione contadina osservati da Paolino da Noia agli inizi del V secolo, dalla Campania verso la Daunia209, confermano la ricchezza di questa vita rurale e la complessità della sua organizzazione produttiva, che non si esaurisce nelle forme del latifondo imperiale e privato, né si riduce alle sole attività connesse alla transumanza, ma sostiene anche una cerealicoltura di crescente rilievo nell'economia della penisola.
In un contesto di tal genere, il sistema di esazione disegnato da Valentiniano I, così minuziosamente attento al prelievo e alla custodia dei cereali per l'annona, e preoccupato di contemperare le esigenze del fisco con quelle dei piccoli possessores, può essere sopravvissuto a lungo, per il suo stretto intreccio con le strutture produttive. Anche la conservazione e la perdurante visibilità dell'iscrizione a Canusium, assicurata come sembra fino all'alto medioevo, potrebbe così assumere un suo significato.
Università di Palermo Andrea Giardina Università di Bari Francesco Grelle
205 Cf. P. F. Kehr, Regesta pontificum Romanorum. Italia pontificia, IX, cit., p. 288 sgg.
206 R. Mola, Scavi e ricerche sotto la cattedrale di Trani, in Puglia paleocristiana, II, Galatina, 1974, p. 189 sgg.
207 Sull'istituto, J. Gaudemet, L'Église dans l'empire romain, Paris, 1958, p. 324 sgg·
2°8 Cf. Flor., Ep., II 6,15; Procop., Bell., VII 18,19. 209 Paul. Nol., Carm., 20,312 sgg., 377 sg.