Le necropoli romane della pianura bresciana: i dati della Carta Archeologica e aggiornamenti
Divisioni agrarie romane e occupazione del territorio nella piana nocerino-sarnese
Transcript of Divisioni agrarie romane e occupazione del territorio nella piana nocerino-sarnese
AGER CAMPANUS LA STORIA DELL'AGER CAMPANUS
I PROBLEM I DELLA LIMITATIO E SUA LETTURA ATTUALE
a cura di
GENNARO FRANCIOSI
ESTRATTO
JOVENE EDITORE • 2002
GIAN LUCA SORICELU
DIVISIONI AGRARIE ROMANE E OCCUPAZIONE DEL TERRITORIO
NELLA PlANA NOCERINO-SARNESE
Circoscritta dal Vesuvio, dai monti del Sarno e dai Lattari la piana nocerino-sarnese costituisce l'estremo lembo meridionale della pianura campana. In eta antica si presentava caratterizzata da una fitta rete idrica superficiale, con acque abbondanti e costanti, suoli vulcanici particolarmente fertili, favorevoli condizioni climatiche.
Si ritiene, in genere, che queste favorevoli condizioni per l'insediamento umano siano venute a cessare con l'eruzione del 79 d.C. e che ad essa abbia fatto seguito un lungo periodo di abbandono del territorio: si sarebbe dovuto aspettare, infatti, fino al III secolo per osservare una nuova e sporadica occupazione delle campagne vesuviane1.
A questa sfiducia nelle capacita di un rapido recupero del territorio vesuviano all'inJomani dell'eruzione pliniana e Forse da attribuire 10 scarso interesse prestato alIa ricerca catastale: considerate Ie alterazioni prodotte sull' assetto Fisico del territorio e i lunghi periodi di abbandono, non piu che scarse dovevano essere Ie tracce superstiti delle sistemazioni fondiarie romane e, soprattutto, da datare al periodo precedente l'eruzione del 79 d.C.2
1 In questa prosperriva cfr. U. PAPPALARDO, Vewvio. Gral/di eruziolli e reinsediamento, in F. SENATORE (a cura di), PompeI; il Vesuvio e La Penisola Sorrentina (1999) 233257 .
2 Sulle divisioni agrarie della piana nocerino-sarnese v. F. CASTAGNOLI, Tracce di centuriazioni nei territori di Nocera, Pompei, Nola, Ali/e, in RAL. 11 (1956) 373-374; E. ESPOSITO, Indagini arcbeologiche in agI'o nocerillo: Ull bilancia, in RSS. 4 (1985) 238-243; 10., La valle del Sarno: U.l'O del territorio e viabilitd, in Nuceria AI/atema e il suo territorio. Datta /ondazione ai Longobardi (1994) I 17; G . O -IOUQUER - M. CUWEL LEVEQUE - F. FAVORY - J.P. VAL-
La documentazione letteraria e archeologica disponibile suggerisce che, in realta, si sia cercato di recuperare i territori devastati negli anni che immediatamente seguirono l'eruzione3, ed una ulteriore conferma in tal senso e offerta dalla documentazione cartografica. Quest'ultima, non ancora sistematicamente sfruttata a riguardo, permette di cogliere, fossilizzati nel paesaggio agrario attuale, i resti di piu sistemi centuriali e, da essi, di proporre una lettura della storia fondiaria dell' agro nocerino-sarnese in eta romana, mostrando da un lato il carattere razionale della pianificazione territoriale, dalI' aItro la rapidita con cui all'indomani dell'eruzione del 79 d.C. si pose mana al recupero della reglOne.
Agli inizi del I secolo a.c. il territorio della pian a del Sarno era suddiviso tra Nuceria, Pompeii e 5tabiae. Tale assetto fu alterato dagli esiti della guerra sociale: la scelta di 5tabiae di appoggiare i ribelli italici si rivel6 infatti fatale per la cina, espugnata e distrutta da Silla nell'89 a.c.; il suo territorio fu probabilmente attribuito a Nuceria, divenuta municipium e che, al contrario, era rin1asta Fedele a Roma4. Anche Pompeii, che aveva aderito
LAT, Structures agraires en Italie celltro-meridionale. Cadastres et paysage ruraux (1987) 212-214.
3 Su tempi e modi di recupero della regione vesuviana dopo l'eruzione del 79 d.C. v. G. SORICELLI, La reg/one vesllvial1a dopo l'eruzione del 79 d.C, in Atbenaeum 85 (1997) 139-154.
4 Sulla partecipazione di Stabiae alla guerra sociale e Ie conseguenze per la citta v. da ultimo F. SENATORE, Stabiae: storia deltimediamCllto, in D. CAMARDO - A. FERIlJ\RA (a cura di), Stabiae dai Borboni aile Zlitime scoperte (2001) 29-.30; l'ipotesi che il suo territorio sia stato attribuito a Nuceria, formulata gia da K.]. BELOCI-J, Campa
124
60
ClAN LUCA SORlCELLI
alia causa degli insorti italici, fu punita con la deduzione, neli'80, di una colonia di veterani sillanP.
Qua1che decennio piLI tardi, in eta triumvirale 0 augustea, una nuova colonia di veterani fu dedotta a Nuceria6, e an cora questa
nien. Geschichte und Topographie des antiken Neapel und seiner Umgebung 08902, tr. it. 1989) 277 e 282, trova sostegno in iscrizioni provenienti dal terri torio stabiano e riferentisi a magistrati nucerini (CIL. 10.1081; CIL. 10.772: dr. F. SENATORE, op. cit . 30-31). A. OETrEL, Fundkontexte romischer Vesuvvillen im Gebiet um Pompeji (1996) 163165 avanza l'ipotesi che Ie ville orientate tra 7 e 15 0 W possano riflettere una divisione agraria pre-sillana, considerata la cronologia di almeno due degli impianti considerati: eda osservare, a riguardo, che la villa rustica in prop. Malafronte [Po MINIERO, Ricerche sull'Ager Stabianus, in RJ. CURTIS (ed.), Studia Pompeiana & Classica in honor 0/ Wilhelmina F. Jashemski (1989) 23 7, n. 8] presenta strutture orientate 11 0 W nella prima fase (datata al IV-III sec. a.c.) , intorno ai 4/10 0 E nella seconda fase (datata al II sec. a.c.), dr. P. MINIERO - V. DI GIOVANNI - G . GASPERETrI, Insediamenti di eta repubblicana !Iell'agerStabianus, in RSP. 5 (1991-92) 17-66; anche la villa collegata aile strutture poste in luce a Casola (P. MINIERO, Ricerche 241-242, n. 26: orientate ca. W) eorientata11 0
W [dr. A.M. SODO, Cenni sulfa villa presillana scoperta a Casola di Napoli, in Cultura e Territorio 10 (1993) 61-70J.
5 Sulla colonia sillana dedotta a Pompeii V. E. Lo CASCIO, Pompei dalfa citta sannitica alla colonia sillana: Ie vicende istituzionali, in Les elites mlmicipales de !'Ita lie peninsulaire des Gracques a Neron (1996) 111-123, con bib!. prec.; per una disamina della documentazione archeologica V. F. ZEVI, Pompei dalla citta sannitica alla colonia sillana: per un'interpretazione dei dati archeologici, in Les elites 125-138. In generale, sulla colonizzazione sill ana in Campania V. G. CAMODECA, La colonizzazione romana dal II sec. a.c. L'eta romana , in Storia del Mezzogiorno 1.2 (1991) 25-31.
6 Secondo Appian. b. civ. 4.3 .11 Nuceria sarebbe stata scelta dOli triumviri, nel 43 a.c., quale sede di una delle diciotto colonie destinate ad accogliere i loro veterani; secondo Lib. colon. 1 Lach. 235, 236, la colonia sarebbe stata invece dedotta da Augusto (Nuceria Constantia, muro ducta colonia, deducta iussu imp. Augllsti. Iter populo debetur ped. LX. Ager eius in limltibus Iulianis lege Augustiana eJt adJignatus, et alibi in abJOluto resedit). L'ipotesi di una deduzione in eta trium virale accoglie maggiori consensi (dr., tra gli altri, K]. BELOCH, op. cit. 277; F. SARTORl, Problemi di storza costituzionale italiota (1953) 155; L. KEPPlE, Colonisation and veteran settlement in Italy. 47-14 b.C. (1983) 151; G. CHOUQUER - M. CLAVEL LEVlOQuE - F. FAVORY - J.P. VALLAT, op. cit. 228, nt. 398; G. CAMODECA, op. cit. 34-35, che ipotizza una ripresa delle attivita di deduzione e centuriazione dopo Azio) tut
citta fu scelta per nuove deduzioni coloniarie nel57 d.C,7
Le vicende po1itico-amministrative appena sintetizzate dovettero determinare trasformazioni piLI 0 meno profonde sull'assetto fondiario della regione.
Quale sia stato l'impatto della colonizzazione si1lana sull' organizzazione del territorio di Pompeii resta ancora un prob1ema aperto. Esaminando l'orientamento delle ville dell'agro pompeiano, e stata osservata la presenza di a1cuni orientamenti privilegiati nei quali A. Oettel ha voluto vedere il riflesso di tre diverse divisioni agrarie: Ie ville orientate tra i 22 e i 30° W rifletterebbero una divisione agraria di eta sannitica; quelle orientate tra gli 8° e i 15° W rifletterebbero la divisione agraria relativa alla deduzione colonia ria siliana e, infine, quelle orientate tra i 5° e i 16° E rifletterebbero una divisione agraria di eta triumvirale8. Con la prima di queste ipotetiche divisioni agrarie potrebbe accordarsi un lunge tratto di strada orientato ca. 65° E, scavato in loco Tre Ponti, a nord-est di Pomped') , mentre con la seconda potrebbe accordarsi un tratto di parcellare orientato ca. 1r W scavato in loco S. Abbondio lO •
tavia, come osserva P.A. BRUNT, Italian Manpower (1971) 609, la presenza di Nuceria nella lista appianea delle citta destinate ai veterani triumvirali non implica necessariamente che cia sia poi realmente awenuto. Una conferma che la citta sia stata interessata dall' attivitit agraria dei triumviri eofferta, in ogni caso , dall'indicazione del Liber colonia rum secondo cui, in occasione della deduzione augustea, il territorio sarebbe stato assegnato in limitibus Iufranis. Se nei limites Iulrani eda riconoscere un intervento agrimensorio di eta triumvirale si potrebbe ipotizzare per questa eta la sistemazione di un primo nueleo di veterani, non necessariamente comportante la deduzione di una colonia, cui avrebbe fatto seguito, negli anni successivi, un secondo e definitivo intervento, con il completamento dell'operazione agrimensoria e la deduzione di una colonia.
7 Tac. ann. 13 .31.2 . 8 A. OETTEL, op. cit. 147-162. 9 M. DE' SPACNOLIS CONTICELLO, It ritrovamento in
localita Tre Ponti di Sca/ati e la via extraurbana PompeiSarno, in RSP 3 (1989) 41-52.
10 M. MASTROROBERTO, Pompei e la riva deItra del Sarno, in A. DE SIMONE - S.c. NAPPO (a cura di), Mitis Sarni Opes (2000) 32, nt. 21 e fig. a pp. 142-143; ringra
125 DIVISION I AGRARIE ROMANE E OCCUPAZIONE DEL TERRITORIO NELLA PlANA NOCERINO·SARl'lESE
Per quanta riguarda, invece, Nuceria la situazione appare piLI chiararnente definibile. L'esame della cartografia IGM permette, infatti, di individuare almeno quattro trame parcellari attribuibili all' eta romana, ben fossilizzate nel paesaggio agrario attuale (Fig. 1: tav. f.t . V). La tabella che segue ne riporta l'orientamento, il modulo e la corrispondenza con Ie cen turiazioni individuate nell' agro nocerino da G. Chouquer e F. Favoryll:
"Nuceria A" 4r E 14 x 16 actus = "Nola IV - Sarnum"
"Nuceria ;S"
1°50' E 20 x 20 actus (710 m) ="Nuceria I" "Nuceria e"
12"50' \Y/ 20 x 20 actus (710 m) = "Nuceria II " "Nuceria 0 "
19°40' \y/ 20 x 20 actus (708 m)
n quadro delle divisioni agrarie che hanno interessato l'agro nocerino-sarnese si completa con un quinto sistema, inedito, che sembra interessare la parte meridionale del territo rio nolano, tra Ie localita attuali di Ottaviano e Palma Campania, spingendosi verso sud in quello che era stato il territorio di Pompeii (Fig. 2: tav. f.t. VI). Questo sistema, "Nola D", risulta orientato ca. 23°30' E e costruito utilizzando un modulo di 20 x 20 actus di 710 m. I resti piLI densi sono visibili tra Terzigno, Poggiomarino e Scafati, ove il sistema, che a est non sembra oltrepassare il corso del Sarno, sembra arrestarsi lungo l' attuale via Tre Ponti (che potrebbe perpetuare, per una lunghezza di circa 4 centurie, uno dei limites principa1i), a ca. 1 km dalla citta sepolta.
Diversi elementi aiutano a fissare la O"onologia, sia assoluta che relativa, di questi cinque catasti. Innanzi tutto, sono da tenere presenti i rapporti organici che sembrano sussistere tra i sistemi fin qui simeticamente de
zio la dott.ssa Mastroroberto per Ie informazioni relative
allo scavo e all'orientamento dei salehi di coltivazione.
11 Per una descrizione sintetica di questi quattro si
stemi v. G. SORlCELLl, Divisioni agrarie romane e viabilita nella piana nocerino-sarnese, in F. SENATORE (a cura di),
Pompei tra Sorrento e Sarno (2001) 299-319.
scritti e la strada che univa Nuceria con Pomperi. La sistemazione di quest'ultima, che a Pompei potrebbe aver compreso anche la risistemazione della via urbana che scendeva a Porta Nocera, puo collocarsi, orientativamente, negli anni immediatamente successivi alla deduzione della colonia sillana a Pompei, nel quadro probabilmente di un generale miglioramento della rete via ria della regione. Il rapporto geometrico che sembrerebbe esistere tra "Nuceria A" e il troncone nucerino della Nuceria - Pompeios, con quest'ultimo che potrebbe costituire la diagonale di rettangoli di 6 x 7 centurie del primo, potrebbe peraltro suggerire un utilizzo della maglia centuriale per la costruzione della strada. In ogni caso, i mensore.l che operano nel territorio nocerino sfruttano i vantaggi offerti da questa lungo rettilineo utilizzandolo come decumano massimo per Ia realizzazione di "Nuceria B", oppure come limes diagonalis (applicando un metodo che consentiva alta precisione e un sensibile risparmio in termini di tempo)12, per la costruzione di "Nuceria C", di "Nuceria D" e di "Nola D" . Con il primo, "Nuceria C", la strada viene ad articolarsi costituendo la diagonale di rettangoli di 1 x 4 centurie; in rapporto a "Nuceria D", la via costituisce 1a diagonale di rettangoli di 2 x 5 centurie e analoga articolazione sembra sussistere con "Nola D" (Fig. 3: tav. f.t. VII).
Un preciso terminus post quem per la realizzazione di "Nuceria A" e ricavabile dalla sua presenza nel territorio stabiano (da notare, ad esempio, come la villa del Petraro, non anteriore al I sec. a.c., presenti il medesimo orientamento della maglia centuriale e sia posta lungo il tracciato teorico di uno dei limites) I3, il che conduce ad una datazione
12 Su questo particolare metodo di costruzione dei re
ticoli centuriati v. A. PEREZ, Les cadaxtres antiques en Narbonnaise occidentale. Enai sur la politique coloniale romaine en Gaule du Slid (ne s. avo I-C - IF S. ap. I-C), (995) 51·65 e A. ROTI-I-CONGES , Modalites pratiques d'implantation des cadastres romains: quelques aspects, in
MEFRA. 108 (1996) 299-421. 13 G. SORlCELLl, Divisioni agrarie 309 (Fig. 6: tav. f.t.
X); sulla villa del Petraro V. S . DE CARO, Villa rustica in localita Petraro (Stabiae), in RIASA. 10 (1987) 5-89.
126 ClAN LUCA SORJCELLI
posteriore alIa guerra sociale; e da rilevare, inoltre, Ia cronologia alta di aleune delle strutture edilizie che ne seguono l'orientamen to: una datazione alIa fine del II -inizi I secolo a.c. estata suggerita per il teatro in 10calita Foce a Sarno14 , posto Iungo uno dei limites e orientato secondo Ia maglia centuriale, mentre una datazione entro la seconda meta del II secolo a.c. e stata proposta per due ville scavate l'una a Poggiomarino, l'altra nell'immediato suburbio orientale di Nuceria, orientate circa 48°/49° E15. La realizzazione del catasto sembra aver promosso in maniera significativa ~o sviiuppo dell' abitato rurale: se si considera la distribuzione delle ville rustiche nel territorio di Sarno, ova meglio conservata appare la trama di "Nuceria A" e risultano assen ti resti attribuibili agli altri sistemi che organizzano il territorio nucerino, si puo osservare come queste risultino impian tate lungo i limites principali 0 gli intercisivi che bipartivano la centuria e, in un caso, all'intersezione tra essi (Fig. 4: tav. f.t. VIII)16.
E forse possibile, peraltro, che il sistema abbia strutturato anche il territorio pompeiano: alcuni elementi della viabilita odierna, immediatamente a nord e a nord-ovest di Pompeii, paiono infatti coincidere, per tratti relativamente estesi, con limites della maglia teorica di "Nuceria A". L'orientamento della maglia centuriale e inoltre ripreso da aleune delle ville scavate nell'ager Pompeianus, parte delle quali verrebbero a trovarsi lungo i limites principali 0 aUa loro intersezione. Significativa, a tale riguardo, la posizione della villa cd. del Cimitero e della villa B sotto il Canale Conte Sarno, orientate entrambe ca. 50° E,
14 Sui tearro v. da ultimo M. DE' SPAGNOLIS CONTICELLO, La terra dei Sarrasti. Archeologia nell'agra nocerino-sarnese (2000) 104-107.
15 Poggiomarino: C. CICIRELLI, Comune di Poggiomarino. Localita Ceraw, in RSP 7 (1995-1996) 178-182. Nuceria: A. ALBERO - T. FORTUNATO, Nocera Superiore (Salerno). LocaHta Cam Canale, in BA. 4 (1990) 85-9l.
16 Per la dist[ibuzione delle presenze archeologiche nel te[rito[io cii Sarno v. la carra archeologica in Guida al territorio di Sarno (1994) e dr. nello stesso volume, M. DE' SPAGNOLIS CONTICELLO, Testimonianze archeologiche in Sarno 15-23.
che risulterebbero co locate agli angoli di una stessa centuria l7 , della villa delle Argenterie, orientata 41 ° W, che verrebbe a trovarsi Iungo un intercisivus di meta centuria l8 , e ancora, almeno della viUa 2 in Ioc. Cava Ranieri a Terzigno, il cui impianto e stato collocato verso la fine del II - inizi I secolo a.C. 19: orientata 44° E verrebbe a trovarsi all' in tersezione di due limites teorici (Fig. 5: tav. f. t. IX). Infine, e da rilevare come porzioni piLI 0 meno estese di parcellare rurale sepolto daIl' eruzione del 79 d. C. riflettano un analogo orientamento: una limitata porzione di campi coltivati orientati intorno ai 40/45° E estata scavata nei pressi della villa B sotto il Canale Conte Sarn020 , mentre piLI ampie superfici con solehi orientati 4Y E sono state scavate in loc. S. Abbondi02l .
"Nuceria B" e certamente anteriore all'eruzione: di recente sono stati scavati due limites, sepolti dai prodotti piroclastici e non piG riattivati, che ben si integrerebbero nella trama centuriale22 ; la sua parziale riattivazione all'indomani dell'eruzione del 79 edimostrata, oltre che dalla sua sopravvivenza nel paesaggio agrario odierno, daUo scavo recente di un breve tratto del suo decumanus, che ha evidenziato Ia presenza di due strati di battuto stradali, 1'uno coperto dai prodotti piroclastici del 79 d.C., l'altro realizzato al di sopra di questj23. Elementi di parcellare che paiono riflettere l' orientamento di questa sistema sono stati posti in luce a Poggiomarino
17 Villa del Cimitero: A. VARONE , Comune di Pompei. Via Nolana, area a nord del Cimitera, in RSP 1 (1987) 159161; Villa B del Canale Conte Sarno: G. STEFANI (a cura di), Casali di ieri, Casali di oggi (2000) 55-57 .
18 G. STEFANI, op. cit. 65-68 . 19 Sulle ville di Cava Ranieri V. i contributi di C. O CI
RELLI in G. STEFANI , op. cit. 71-83 con altra bib!. 20 G. STEFANI, op. cit. 55-56, fig. 28. 21 M. MASTROROBERTO, Pompei e la riva 32, n. 22 e fig.
a pp. 142-143; ring[azio la dott.ssa Masrroroberro per Ie informazioni relative allo scavo e all'orienramenro dei solchi cii colrivazione.
22 M. DE' SPAGNOLIS CONTICELLO, II pons Sarni e fa via Nuceria - Pompeios (1994) 54, 65 e 74, figg. 47 e 60, tav. 1, nn. 38 e 43.
23 M. DE' SPAGNOLIS CONTICELLO, I! pons Sarni 53, figg. 45-46, tav. 1, n. 36.
127 DIVISIONI AGRARlE ROMANE E OCCUPAZIONE DEL TERRITORIO NELLA PlANA NOCERINO-SARI\lESE
(ove una parte della villa orientata secondo "Nuceria A" viene demolita e l'area occupata con coltivazioni) e a Casola di N apoli24.
Anche "Nuceria C" deve essere stato realizzato prima dell' eruzione pliniana, e cia in considerazione del fatto che non sembra estendersi oltre 1a linea di costa del 79 d.C.; il rapporto geometrico che sussiste con la Nuceria - Pompeios sembra peraltro presupporre un'anteriorita della strada. Sono stati scavati elementi di parcellare orientato (campi lavorati ed un cipresseto, ocientati ca. 15° W in loc. Bagni ad Angri)25 e ville che si dispongono lungo gli assi del sistema 0 ne riprendono l'orientament026; tra queste, e da segnalare la villa di loc. Carmiano, neH'agro stabiano, orientata ca. 15° W, per il cui impian to e stato proposto l'ultimo quarto del I sec. a.c. 27 Anche "Nuceria C" deve essere stato riattivato all'indomani dell'eruzione rna non e possibile dire al momenta se Ie dense
24 Poggiomarino: C. CICIRELLI, Comulle di Poggiomarino. Loealita Ceraso, in RSP 7 (1995-1996) 178-182; Casola: A.M. SODO, Cenni suLla villa presiLlana seopata a Casola di Napoli 61-70.
25 M. DE' SPAGNOLIS CONTICELLO, II pons Sami 5455, figg. 47-52, tav. 1, n. 38.
26 Eil casu della villa scavata in loc. Pontoni I (M. DE' SPAGNOLIS CONTICELLO, II pons Sami 64-65, tav. I, n. 42; Ie strutture sono orientate 13° \'(1), c dell~ville in localita Messigno (scavo Matrone: NSA. 1923,271-274; P. MINIERO, Rieerehe 255, n. 74; l'orientamcnto eca. 15° W) e Ponti cello [prop. Carotenuto; per la sua localizzazione V.
RB. VAN DER POEL, Corpus Topographicum Pompeianum. V' Cartography (1981) 23, n. 34].
27 P. MINIERO, Rieerehe 240, n. 20; G. BONIT:ACIO, La villa in localita Carmiallo, in Stabiano. Cultura e Areheologia da Stabiae: la citta e il territorio tra l'eta areaiea e l' eta romana (2001) 35-37 . L'orientamento di 16° W si ricava dall'ultima delle planimetrie edite della villa (G. BONIFACIO, art. cit. 35) mentre in queUe precedenti risultava di ca. 12° E; e da ritenere pili affidabile il primo dei due orientamenti, evidcntemente calcolato in occasione dei recenti lavori di scavo e documentazione che hanno preceduto il reinterro del complesso, cfr. G. BONIFACIO, Gragnallo loc. Carmiano. 5. Maria La Carita Lac. Call11eto: interventi di reinterro, in RSP 9 (1998) 256. E peraltro da notare come anche Ie altre due ville scavate in localita Carmiano (P. MINIERO, Rieerehe 241, n. 21 e 247 -248, n. 45), si dispongano lungo il medesimo Limes con la pili meridionale che viene a porsi giusto all'intersezione con un asse E-W.
tracce intorno Pompeii testimonino la sua estensione nel territorio della citta distrutta all'indomani della catastrofe 0 se, invece, esso sia stato progettato fin da subito per strutturare anche il territorio pompeiano. Verso questa second a soluzione potrebbero far propendere sia gli dementi di parcellare orientati circa 12° W scavati in loc. S. Abbondio, sia la posizione e l'orientamento di alcune delle strutture scavate nel suburbio meridionale di Pompei: intorno ai 10° W e orientato l'edificio di Murecine recentemente scavato, 14° W Ie strutture in via Colle S. Bartolomeo nei pressi del Santuario a Pompei28 . Ville orientate tra i 10° e i 15° W sono documentate anche a est e a nord di Pompeii e alcune di esse verrebbero a trovarsi lungo il tracciato teorico dei limiter: tra esse e la villa di contrada Spinelli, orientata circa 15° W29. Orientata ca. 9° W/ e, infine, la villa cd. di Popidio Floro, un ambiente della quale risultava decorato in II stile30 .
"Nuceria D" e invece da collocare senz'altro all'indomani dell'eruzione del 79 d.C. considerato che si estende al di la della linea di costa pre-eruzione. Esso moltre presuppone la ricostruzione della Nuceria - Pompeios utilizzata come limes diagonalis per la sua costruzione. Un preciso terminus ante quem ecostituito dal miliario rinvenuto lungo il troncone della Nuceria - Stabias che, nel tratto interessato, si sovrappone al suo decumano principale. 11 milia rio e databile al
28 Edificio di Murecine: A. DE SIMONE - S.c. NAPPO, op. cit. 32; strutture di via Colle S. Bartolomeo: M. DE' SPAGNOLIS CONTICELLO, II pOliS Sami 24 tav. 1, n. 10.
29 NSA. (1923) 280-284. M. DE' SPAGNOLIS CONTICELLO, Di due viLLe rustiehe ril1venute a Sca/ati (SA), in via SpineLLi ed in via Poggiomarillo, in RSP 5-6 (1993-1994) 13 7-141 identifica con la villa scavata dal Matrone Ie strutture da lei rinvenute a Scafati in via Spinelli: etuttavia da osservare che, oltre ad essere diversamente orientate (15° W la villa dello scavo Matrone, 32° W Ie strutture di recente rinvenimento), sembrerebbe di diversa lunghezza il muro settentrionale (14 mil corpo sporgente della villa dello scavo Matrone, ca. 20 m il lato settentrionale della struttura sClIVata da M. De' Spagnolis, almeno a giudicare dalla fig. 1) .
30 NSA. (1921) 442-460.
128 ClAN LUCA SORlCELLI
120/121 e, dunque, entro tale data deve essere stato realizzato anche il catast031 .
Anche "Nola D" e da collocare all'indomani deIl'eruzione del 79. Solo COS1 infatti risulta comprensibile la sua· presenza oltre che in territorio nolano anche nel euore di queUo che costituiva l'ager Pompeianus considerato che Ie sue ultime tracce visibili sono a poco pill di 1 km dal perimetro delle mura di Pompeii.
Sulla base di quanta fin qui esposto, lasequenza degli interventi fondiari che hanno interessato [a piana nocerino-sarnese puo essere ricostruita come segue:
negli anni immediatamente successivi alIa fine della guerra sociale si realizza "N uceria A", mediante cui si procede alIa destrutturazione del territorio stabiano ed alIa riorganizzazione del territorio nucerino, ampliato a spese di Stabiae. L'operazione agrimensoria potrebbe aver interes
. sato anche il territorio di Pompeii ove, se COS1, "Nuceria A" (0, forse meglio, "Nuceria A 1 Pompeii B"32) potrebbe aver costituito il quadro di riferimento per !e assegnazioni ai veterani sillani dedotti nella nuova cotonia; in eta triumvirale, con la deduzione della colonia a Nuceria, si procede a nuove opere di catastazione; resta al momenta incerto se in tale occcasione sia stata realizzata "Nuceria B" 0, piuttosto, "Nuceria C". Tuttavia, se 1'operazione agrimensoria ha interessato oltre che il territorio di Nuceria anche il territorio di Pompeii, e se con tale operazione sono in relazione la villa di Carmiano nell'agro stabiano (impiantata verso la fine del I secolo a.c.) e la villa di Popidio Floro nell'agro pompeiano (che ha restituito, come si edetto, affreschi in II stile), si potrebbe riconoscere in "Nuceria C" la divisione agraria che ha permesso
31 SuI miliario v. A. VARONE, Un miliario del Museo dell'Agro Nocerino e la via da Nocera al porto di Stabia (e al Capo Ateneo), in Apollo 5 (1965/1984) 59-85.
32 Come "Pompeii An e da intendcre la divisione agraria di eta sannitica; su di essa si tomera in aItra sede.
l'insediamento dei coloni triumvirali: la sua estensione nel territorio di Pompeii (in tal caso sarebbe preferibile parlare di "Nuceria C 1 Pompeii C") potrebbe essere stata una conseguenza della posizione filopompeiana assunta da una parte della elite cittadina nello scontro tra Cesare e Pompeo33 . In questa caso "Nuceria B" dovrebbe essere necessariamente posteriore, e si potrebbe pensare ad una datazione compresa tra l'eta augustea (nell'ipotesi della deduzione di nuovi coloni ad opera di Augusto)34 e, al piu tardi, l'eta neroniana al
33 La presenza di sostenitori della causa pompeiana potrebbe ricavarsi da un non chiaro episodio che ha come protagonista Cicerone [Cic. ad lam. 7.3; (/d Att. 10.16.4; cfr. P. CASTREN, Ordo PopuluJque Polt/peianllS (1975) 91]: neI 49 a.e., fermatosi a Pompeii mentre era in viaggio per raggiungere Pompeo, riceve I'offerta - per il tramite di un suo amico, Ninnius - di assumere iI controIIo della citta e delle tre coorti ivi di stanza con Ia compIicita dei centurioni che ne avevano iI comando. Sebbene Cicerone, dopo un colloquio con un aItro suo amico e membro delI'ordo cittadino, M. Marius, non abbia accettato, stimando insufficienti per munire e difendere Ia citta Ie truppe offertegli e temendo una trappoIa, I'episodio dimostra Ia presenza, tra Ie elites cittadine, di simpatie fiIo-pompeiane, peraItro ben diffuse neI resto deLia Campania (efr. Cic. TlISc. disp. 1.35.86 circa Ie manifestazioni di giubilo, nel 50 a.e., per la guarigione di Pompeo da lIna grave maIattia a Neapolis, Puteoli e in altre cittl! non specificate della Campania). Un possibiIe indizio a favore deLia sistemazione a Pompeii di veterani (senza la formale deduzione di una colonia) negli anni 40 del I secoIo a.e. potrebbe ricavarsi daIl'a~rivo di L. Tillius, appartenente ad una del gruppo di famiglie che secondo il Castren, op. cit. 92-94, giungerebbero. nella citta intorno aI 50 a.e. L. Tillius, che nella citta vesuviana ha rivestito iI duovirato, secondo l'iscrizione che corona Ia tomba di famiglia [A. D'AMBROSIO - S. DE CARO, Un impegno per Pompei. Fotopiano e documentazione della necropoli di Porta Nocera, in 05. (1983) 17], databile per la tipologia architettonica tra la tarda eta cesarian a e la prima eta augustea, aveva militato (insieme al fratello, pure ricordato nell'iscrizione) come trtbunus militum della legio X Equestris, legione agli ordini prima di Cesare, poi di Antonio, e daI dittatore, secondo il Castren, potrebbe essere stato congedato, ottenendo come premio per il servizio un lotto di terra a Pompeii [L. KEPPlE, Colonisation and veteran settlement in Italy 107 ritiene che i due fratelli possano essere stati congedati dopo Azio]: non sarebbe da escludere, tuttavia, la possibilita di un congedo dopo la sconfitta dei cesaricidi.
34 In questa caso, un possibile riflesso del catasto nell'assetto urbanistico della citta potrebbe esserc rappre
129 DIVISIONI AGRARlE ROMANE E OCCUPAZIONE DEL TERRITORIO NELLA PlANA NOCEIUNO-SAHJ'JESE
lorche, secondo Tacito, sarebbero stati dedotti nella citta nuovi coloni; negli anni che fanno immediatamente seguito all'eruzione si procede alIa parziale riattivazione delle divisioni agrarie preesistenti, per ridefinire i limiti fQndiari e permettere una ripresa della produzione agricola. Tale azione deve aver costituito il compito principale dei funzionari imperiali (i curatores restituendae Campaniae) nominati daB'imperatore per soccorrere Ie citta campane e la cui attivita edocumentata da una serie di iscrizioni databili tra 1'80 e 1'82 d.C. rinvenute a Napoli, Nola, Nocera, Sorrento e Salerno, nelle guali si ricorda il restauro di monumenti pubblici cittadini danneggiati a terrae motibus, con riferimento ai fenomeni tellurici che avevano accompagnato l'eruzione35 ;
nei primissimi anni dd regno di Addano, infine, si interviene nuovamente: la realiz
•
sen tato dalla risistemazione che conosce il teatro, collo
cato di fronte atla porta da cui entrava da nord la via Popilia, che in eta augustea viene ingrandito e ]'asse della ca
yea spostato a est rendendolo pressoche isocline a "Nuceria E", v. G. SORICELLI, Divisioni agrarie 310.
35 Cfr. G. SORICELLI, La regione vesuviana 142 con bib!.
zazione di "Nuceria D" viene a costituire l'ultimo atto del processo di recupero dell'area, con la sistemazione di guei terreni, idrologicamente instabili, formatisi a ovest della vecchia linea di costa e la ristrutturazione della rete viaria. Piu problematica e la datazione precisa di "Nola D", senz'altro posteriore aI 79 d.C. e da porre in rapporto con la divisione, tra Nola e Nuceria , di guello che era stato l'antico ager Pompeianus. I due catasti, "Nuceria D" e "Nola D", si disputano una fascia di territorio larga ca. 2 km e cia esclude che possano essere stati realizzati nel medesimo tempo. Le tracce superstiti dei due sistemi non permettono di avanzare ipotesi circa la cronologia relativa ma senz' altro ri£lettono una ridefinizione dei limiti territoriali tra Nola e Nuceria avvenuta in eta adrianea 0 successivamen te36.
36Qualora "Nola D" Fosse anteriore a "Nuceria D", la sua realizzazione dovl'ebbe collocarsi tra l'attivita svoJta dai due curatores e la realizzazione del nuovo catasto nucerino, e dunque in eta tal'do-flavia 0 proto-anton ina. Po
trebbe, quindi, avere una l'elazione con l'iscrizione CIL. 10.1263, oggi perduta, se il nome dell'imperatore diviniz
zato che Jeduce a Nola un vetel'ano della legio XV Apollinan's Fosse realmente Nelva (cosl come proposto neI CIL.; cEr. K.]. BELOCI-I, op. cit . 448), e non Vespasiano (come invece si tende a preferire: da ultimo in questo senso L. KEPPlE, Colonisation and veteran settlement in Italy, in PBSR. 52 (1984) 95; cfr. G. CAMODECA, op. cit. 28-29). Nel caso in cui "Nola D" fosse posteriore, eda osservare come questa espansione del territoritlm di Nola verso sud vcnga a coincidcre con il limite meridionale del'Ja Jjocesi nolan a cosl come inJicato in una bolla di In
nocenzo III del 1215 (oo. usque in insulam Rubel/ianam, et a insula Rubel/iana per Ilumen Draconcellum et per Tercisam et pel' Teeletam usque ad Pratum et Forum de Fine oo., cfr. K.]. BELOCI-I, op. cit. 461-462).
T fWll l..i\ VI
Rillevo b•••to sui '0911 IGM (1 : 25.000)~185 III NO (B05corea'.) 185 III HE (Sarno) 185 IV SO (5. Giu••ppe Ve8uviano) 185 IV SE (Lauro)
curve dl Uvello 09ni 100m
2 ,5 km
G IA1\ Luc'\ SORl CELLI
Fig. 2 . Divisioni agrarie nell a parte meridionale del rerrirorio nolano.
T,\VOJ-t\ V II
Nuceria C
Nuceria 0
Nola E
G J;\ N Luc,\ SURJ<TLLi Fig, 3. Ani colazinn c geometri c<I tra In via Nli ceri a . Pompeios e i sisteilli " Nuccria C" , " N l.I ccl'ia D " e "Nola E",
T IWOLA VIII
" , /
" /y/
" / "
":" '/~~ ' . ' ,"'-:" ',," " , " // ,
/
/
"
"
"
, '/
"-. /
...
" , Q)
U
tl'
.g;." , ' \
" , ctl \ , ::J ' / ' cr ~. '
, u " r'
/ «
."
/'
~'
/••
"
,,/ /
/
'. / /
/' " ~
'> "" ./
" /'" /
" " ''.
G IAN L UCA SORJC EU. I
Fi g. 4. Vi lle rustichc ncl territo rio di Sarno .
"
" ./
"
No Teatro in loc. Foce Sarno
• Ville (distribuzione secondo AA .VV. 1994)
intercisivi di meta centuria
o 2,5 km
'Lwol.,\ IX
Pompeii
• Ville (n , 1 =villa della Pisanella ; n. 5 = villa del Cimitero; n. 20 = villa B del Canale Conte Sarno; n. 50 = Cava Ranieri. villa 1; n. 51 = Cava Ranieri , villa 2; n. 52 =Cava Ranieri , villa 6).
intercisivi di meta centuria
o 2,5 km
GI I\ ~ Luc\ SURICE I.I.I
Fig. 5. Ville rustichc ncl territorio di Pompei.
T AVOLA X
linea di costa pre - 79
Del Sarno e indicato il corso precedente la rettifica del 1858
• o
ville (n. 38 =v. Colle S. Bartolomeo; n. 40 =contr. Messigno; n. 42 =c~ntro
Ponticello ; n. 44 = loc. Cappella degli Impisi ; nn. 47-49 = loc. Carmiano; n. 54 = edificio di Murecine)
2,5 km
N
ClAN LUCA SORJCELLI
Fig. 6. Ville rus tiche nel rerritorio del Sarno.

















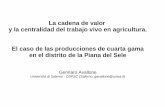




![Slovo v 'Romane' [Word/Discourse in 'Roman']](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6320b784c5de3ed8a70ddab7/slovo-v-romane-worddiscourse-in-roman.jpg)











