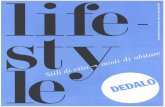Riflessi di edifici parigini in residenze romane del tardo Seicento: i palazzi Muti Papazzurri alla...
Transcript of Riflessi di edifici parigini in residenze romane del tardo Seicento: i palazzi Muti Papazzurri alla...
QUADERNI DELL’ISTITUTO DI STORIA DELL’ARCHITETTURADIPARTIMENTO DI STORIA, DISEGNO E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA
NUOVA SERIE, FASCICOLI 60-62 / 2013-2014
SAPIENZA- UNIVERSITÀ DI ROMA
GIORNATE DI STUDIOIN ONORE DI ARNALDO BRUSCHI
VOLUME IIRoma, Facoltà di Architettura, 5, 6, 7 maggio 2011
A CURA DI
FLAVIA CANTATOREFRANCESCO PAOLO FIORE
MAURIZIO RICCIAUGUSTO ROCA DE AMICIS
PAOLA ZAMPA
BONSIGNORI EDITORE2014
DIPARTIMENTO DI STORIA, DISEGNO E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA
GIORNATE DI STUDIO IN ONORE DI ARNALDO BRUSCHIRoma, Facoltà di Architettura, 5, 6, 7 maggio 2011
BONSIGNORI EDITORE
QUADERNI DELL’ISTITUTO DI STORIA DELL’ARCHITETTURASAPIENZA- UNIVERSITÀ DI ROMA
DirettoreFrancesco Paolo Fiore (responsabile)
Consiglio scientifico Daniela Esposito, Paolo Fancelli, Donatella Fiorani,Francesco Paolo Fiore, Antonella Greco, Giorgio Muratore,Augusto Roca De Amicis, Paolo Rocchi, Maria Piera Sette, Alessandro Viscogliosi.
Comitato direttivo Lia Barelli, Clementina Barucci, Calogero Bellanca, Simona Benedetti,Maurizio Caperna, Tancredi Carunchio, Annarosa Cerutti, Piero Cimbolli Spagnesi,Fabrizio De Cesaris, Daniela Esposito, Paolo Fancelli, Donatella Fiorani, Francesco Paolo Fiore,Daniela Fonti, Antonella Greco, Giorgio Muratore, Susanna Pasquali,Maurizio Ricci, Augusto Roca De Amicis, Paolo Rocchi, Maria Piera Sette,Maria Grazia Turco, Alessandro Viscogliosi, Paola Zampa.
Redazione Flavia Cantatore (coordinatore)
Ogni contributo viene sottoposto ad almeno due revisori scelti fra i membri del Dipartimentoin base alle loro specifiche competenze nel settore della Storia e Restauro dell’architettura;tali pareri sono integrati da pareri di studiosi italiani e stranieri esperti nei temi affrontati.
Traduzione in inglese Erika G. Young
Grafica e impaginazione Roberto steve Gobesso
Stampa CTS Grafica S.r.l., via Vito Vincenti 23, località Cerbara 06011 Città di Castello (PG) - telefono 075.8511555
Corrispondenza e norme editorialiDipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’ArchitetturaPiazza Borghese 9, 00186 Roma - telefono 06.49918825 - fax 06.6878169 - www.uniroma1.it/storiarch
Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 131/87 del 06/03/1987
Il presente fascicolo è stampato con il parziale contributo di SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA
Abbonamenti e distribuzioneBonsignori Editore s.r.l., via Giuseppe Tornielli 16, 00153 Romatelefono 06.99709447 - [email protected] - www.bonsignori.it
PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA
© 2014Bonsignori Editore s.r.l., via Giuseppe Tornielli 16, 00153 Roma© 2014Sapienza - Università di RomaDipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, piazza Borghese 9, 00186 Roma
ISBN 978-88-7597-431-2ISSN 0485-4152
SAPIENZA- UNIVERSITÀ DI ROMA
NUOVA SERIE, FASCICOLI 60-62 / 2013-2014
QUADERNI DELL’ISTITUTO DI STORIA DELL’ARCHITETTURADIPARTIMENTO DI STORIA, DISEGNO E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA
Luciano PatettaIL RINASCIMENTO: DALLA PRIMA CRITICA OPERATIVAALL’AFFERMAZIONE CHE I MODERNI EGUAGLIANOE TALVOLTA SUPERANO GLI ANTICHIFausta GualdiATTIVITÀ INEDITA PER PIO IIDEL «MINIATORE DI SUA SANTITÀ» NICCOLÒ POLANI,FORMAZIONE E TARDA OPEROSITÀSilvia CatittiBALAUSTRO E BALAUSTRATATRA METÀ QUATTROCENTO E PRIMO CINQUECENTORossana NicolòARCHITETTURA E COSTRUZIONEDEL BELVEDERE DI INNOCENZO VIII (1484-1492) IN VATICANOFernando MaríasLA FAMILIA MENDOZA Y LA INTRODUCCIÓNDEL RENACIMIENTO ENTRE ITALIA Y ESPAÑANatalina ManninoARCHITETTURE E ARCHITETTI DI CASA CHIGINEL PRIMO RINASCIMENTO ALTOLAZIALE Pier Nicola PagliaraUNA FONTE A LUNGO IGNORATAPER UN’ARCHITETTURA DI BRAMANTEFrancesco Paolo FioreBRAMANTE E LA ROCCA GIULIA DI CIVITAVECCHIALuisa GiordanoPER IL DORICO IN ACCEZIONE LOMBARDA: QUALCHE ESEMPIOMaria Cristina LoiMILANO DOPO BRAMANTE: LA TORRE DI PALAZZO STAMPAE IL TIBURIO DI SANTA MARIA DELLA PASSIONEChristoph Luitpold FrommelRAFFAELLO, ROMA E L’ANTICO Gianfranco SpagnesiNOTE SUALCUNI PALAZZI ROMANI DEL PRIMO CINQUECENTOJean GuillaumeAUTRES IONIQUES MODERNES: SANSOVINO, BULLANT, LE VAUAntonio RussoANTONIO DA SANGALLO IL GIOVANEE LA CASA «DE’ CENTELLI» A ROMA
5
11
21
33
51
61
73
79
89
95
105
115
121
127
PAG
RIASSUNTI / ABSTRACTS
135
147
155
169
183
195
205
225
235
243
255
263
PAGAntonella FestaLA VILLA DI SANTA COLOMBA PRESSO SIENASandro BenedettiGIACOMO DEL DUCA:LA MANIFESTAZIONE DEL SACRO CRISTIANO Giovanna CurcioMADERNO, BORROMINI, BERNINI: I DUE PROGETTI PER I CAMPANILI DEL PANTHEONAloisio AntinoriRIFLESSI DI EDIFICI PARIGINIIN RESIDENZE ROMANE DEL TARDO SEICENTO:I PALAZZI MUTI PAPAZZURRI ALLA PILOTTA E MANCINIMichela CascasiGABRIELE VALVASSORI «ARCHITETTO DEL CONVENTO»DI SANT’ONOFRIO AL GIANICOLO Angela MarinoSTORIA DI UN GIORNO NELLA FABBRICA DI SAN PIETROSimona BenedettiL’ECO DELLA STORIANEI PROGETTI DI CHIESE DI GUSTAVO GIOVANNONIMarzia MarandolaRICCARDO MORANDI E COLLEFERRO:UNA CITTÀ OPERAIA D’AUTOREPER LA BOMBRINI PARODI DELFINO
IL RESTAURO ARCHITETTONICOStefano GizziARNALDO BRUSCHI: IDEE PER IL RESTAURO DEI MONUMENTICalogero BellancaLA FABBRICA DI SAN PIETRO.SPIGOLATURE TRA LA FINE DELL’OTTOCENTOE I PRIMI DEL NOVECENTODonatella FioraniCONSIDERAZIONISU METODO STORIOGRAFICO E RESTAURONELL’EPOCA DELLA VALORIZZAZIONE DEI MONUMENTI
169QUADERNI DELL’ISTITUTO DI STORIA DELL’ARCHITETTURA . 60-62/2013-2014
Nell’aprile del 1667 Jean-Baptiste Col-bert decise di affidare l’annosa que-
stione del rinnovamento del Louvre a unacommissione o Petit Conseil di architetti,composta da Louis Le Vau, Charles Le Brune Claude Perrault. Con questa iniziativa, ilministro di Luigi XIV sanciva l’accantona-mento definitivo anche dell’ultimo proget-to di Bernini per la reggia parigina, intornoal quale Mattia De Rossi, trasferitosi nellacapitale francese, stava lavorando da quasiun anno. La missione in Francia che il piùcelebre artista italiano aveva affrontato nel1665 dopo aver tante volte declinato l’invi-to1, e durante la quale aveva ricevuto un’ac-coglienza trionfale e reverenti manifestazio-ni di stima, si concludeva così, meno di dueanni più tardi, in un totale fallimento.
Tra le cause di questa inopinata débacle,un certo peso dovettero avere certamente,
com’è stato più volte sostenuto, la dissimu-lata ostilità e il desiderio di rivalsa degli ar-chitetti francesi, umiliati dal successo che ilmaestro italiano aveva conseguito a corte epresso lo stesso sovrano. E tuttavia il sensodella sconfitta di Bernini non può esserecompreso appieno se non in relazione a unacontingenza di ben altra portata storica,cioè il processo di emancipazione della cul-tura artistica francese dal sentimento disudditanza con il quale fin dal Rinascimen-to aveva guardato all’Italia e a Roma. Unprocesso che la politica di Luigi XIV e diColbert accelerò e portò a compimento, alpunto che molti intellettuali francesi giun-sero in quegli anni a proclamare l’ormairaggiunta supremazia dell’arte francese suquella italiana.
Per quanto attiene specificamente all’ar-chitettura, una posizione orientata verso un
classicismo rigoroso e dogmatico, e perciòimplicitamente ostile al principio d’inven-zione proprio del Barocco romano, era so-stenuta già nel 1650 nel Parallèle de l’archi-tecture antique et de la moderne di RolandFréart de Chambray, un autore che cono-sceva bene l’architettura contemporaneanella città papale, perché vi aveva soggior-nato più volte e per lunghi periodi frequen-tando Nicolas Poussin e Charles Errard, ilfuturo fondatore dell’Accademia di Fran-cia a Roma. Ma il discorso sull’architetturadi Fréart, sviluppato su un piano di astrat-ta teoria, non tocca mai direttamente laquestione del rapporto tra Parigi e Roma.
La situazione mutò radicalmente e inmodo alquanto repentino nel settimo de-cennio del secolo, subito dopo la morte diMazzarino, con l’assunzione effettiva delpotere da parte di Luigi XIV e l’avvio della
RIFLESSI DI EDIFICI PARIGINIIN RESIDENZE ROMANE
DEL TARDO SEICENTO: I PALAZZIMUTI PAPAZZURRI ALLA PILOTTA E MANCINI
di ALOISIO ANTINORI
Fig. 1 - Alessandro Specchi, veduta del palazzo Muti Papazzurri in piazza della Pilotta, incisione(da Il Quarto Libro del Nuovo Teatro delli Palazzi in Prospettiva di Roma Moderna).
lamo I Muti Papazzurri, anch’egli di nomeGirolamo (1592-1662), ottenne dai Mastridi Strade la licenza14 di poter «fabricare lasua casa che ha rincontro il convento deSanto Apostolo». Le domunculaee il grana-io in piazza dell’Olmo furono dunque ac-corpati in un’unica residenza a partire daquella data15. Nel 1626, mentre ancora si la-vorava alla fabbrica del nuovo palazzo, Gi-rolamo II acquistò anche l’unica casa nonancora di sua proprietà nell’isolato, così chequesto, nel censimento degli Stati delle Ani-me del 1630, cominciò ad essere indicatotout court come «insula Hieronymi Muti»16.
Dopo aver avviato alla carriera ecclesia-stica il figlio primogenito Giovanni (1629-1706) e concluso per l’erede laico Pompeo(1630-1713) un vantaggioso matrimoniocon Isabella Massimo (31 maggio 1660),Girolamo II Muti Papazzurri cessò di vive-re nel 1662. Tre anni più tardi, Giovanni ePompeo Muti Papazzurri decisero di avvia-re un grande intervento di trasformazionee ampliamento della dimora di famiglia na-ta circa quarant’anni prima dall’accorpa-mento delle casette in piazza dell’Olmo.Per realizzare questo progetto, Giovannichiese ad Alessandro VII di poter acquista-re dalla Camera Apostolica una non picco-la porzione – 35,5 canne quadre – del suo-lo pubblico della piazza. Il papa accolse larichiesta in un chirografo del 4 luglio 1665,e il passaggio di proprietà venne formaliz-zato il 15 gennaio 166617. Il disegno allega-to al chirografo (fig. 2) ci permette di cono-scere sia l’esatta configurazione planimetri-ca dell’edificio di primo Seicento, sia le in-tenzioni che animavano Giovanni e Pom-peo Muti Papazzurri nel momento in cuidiedero avvio alla nuova fabbrica. Il palaz-zo realizzato da Girolamo negli anni venti
occupava, su una pianta alquanto irregola-re, la maggior parte dell’isolato. Infatti ilsuo perimetro era rettilineo sul lato occi-dentale (verso l’insula maior) e su quellosettentrionale (verso le case delle famiglieCiogni e Pedacchia), mentre il fronte meri-dionale dell’edificio (verso il convento deiSanti Apostoli) si manteneva rettilineo finoa una distanza di circa ottanta palmi dall’at-tuale via dell’Archetto, per poi arretrarebruscamente di oltre venti palmi secondoun angolo di 90°. Sul lato orientale, infine,ossia verso piazza dell’Olmo, l’edificio con-finava con una «casa» indipendente affian-cata da un «giardino»: certamente la domuscon viridarium che Girolamo II Muti Pa-pazzurri aveva acquistato nel 1626 dai fra-telli Domenico e Girolamo Branchi18.
La porzione di suolo pubblico che Gio-vanni Muti Papazzurri chiese e ottenne diacquistare per l’ampliamento del palazzoaveva la forma di un quadrilatero irregola-re. Mentre il suo lato settentrionale conti-nuava il filo dell’isolato esistente, quelloorientale, vale a dire il nuovo limite verso lapiazza, fu determinato prolungando in li-nea retta – al di là della strada che separa ledue insulae – il filo del lato est della casaCiogni. È evidente che si mirava a regola-rizzare il perimetro e dunque l’immaginedella piazza. Allo stesso intento rispose an-che la decisione di tracciare il quarto latodell’addizione, quello verso il convento deiSanti Apostoli, senza seguire alcuno dei fi-li esistenti, ma invece deviando di circa 45°dalla linea del limite meridionale dell’isola-to. Ciò che si voleva ottenere era che l’im-bocco della stretta strada che separaval’isolato dei Muti Papazzurri dal conventoe quello della strada assai più larga tra lostesso isolato e la casa Ciogni avessero, co-
m’è infatti indicato nel disegno, la stessaampiezza di 38 palmi. In questo modo ilprospetto del nuovo palazzo, lungo 91 pal-mi, sarebbe apparso esattamente al centrodel lato occidentale di piazza dell’Olmo.
Sebbene il chirografo di Alessandro VIIprescrivesse esplicitamente di terminare ilnuovo edificio entro un anno, questa sca-denza non venne rispettata. La documen-tazione relativa alla fabbrica non è stata fi-nora rinvenuta, ma la cronologia dei lavoripuò essere stabilita per via indiretta.
Nel settembre 1668 i Muti Papazzurri siassicurarono che il palazzo in costruzionepotesse disporre di un’oncia d’acqua Feli-ce, e questa quantità fu poi accresciuta nel167219. Tra l’agosto del 1678 e l’aprile del1679 i Mastri di Strade – uno dei quali era,nel 1678, lo stesso Pompeo – concessero seiautorizzazioni per lavori all’esterno del pa-lazzo20. Si tratta per lo più di opere di con-solidamento e adeguamento funzionale delcorpo preesistente, con particolare atten-zione al prospetto verso il convento deiSanti Apostoli. In particolare una delle seilicenze, rilasciata il 20 dicembre 1678, è re-lativa a dieci «colonnelle» paracarro daporre ai «sei cantoni» del palazzo, nonché«dalle due bande per di fori della porta cheriguarda verso la piazza detta dell’Olmo[...] lontane dalla faccia dell’adornam[en]to di essa porta p[al]mi dui e mezzo», e in-fine «dalle due bande per di fori della por-ta che riguarda incontro il palazzo [...] Cio-gni». Il fatto che l’edificio risulti avere seispigoli esposti al traffico stradale e il riferi-mento alla veste architettonica («adorna-mento») del portale su piazza dell’Olmo,inducono a ritenere che allo scadere del1678 il palazzo avesse già raggiunto la suaconfigurazione finale: circostanza confer-
171QUADERNI DELL’ISTITUTO DI STORIA DELL’ARCHITETTURA . 60-62/2013-2014
nuova politica colbertiana di controllo as-soluto della cultura e delle arti in funzionecelebrativa.
Il concetto di una translatio imperii arti-stica da Roma a Parigi cominciò ad affac-ciarsi nel pensiero dello stesso Fréart deChambray, che nella sua Idée de la perfec-tion de la peinture del 1662 discute – comeha rilevato Tomaso Montanari2 – di una«jalousie naturelle aux Italiens, qui ne veu-lent pas souffrir que la peinture face part deses bonnes grâces à d’autres que de leur na-tion», alla quale non aveva fatto mai riferi-mento nel Parallèle. Analogamente, affer-mazioni sempre meno sommesse circa il va-lore autonomo e finanche la supremaziadell’arte e dell’architettura francese si sus-seguirono nel corso degli anni sessanta ne-gli scritti di numerosi autori più o meno vi-cini a Colbert3: da André Félibien desAvaux, più tardi segretario della AcadémieRoyale d’Architecture, al poeta e criticoJean Chapelain, fino all’autorevole gesuitaDominique Bouhours. Basterà qui ricorda-re il passo estremamente significativo in cuiCharles Perrault, nel suo poema su La Pein-ture del 1668, esorta la Francia a prenderecoscienza del primato ormai raggiunto evo-cando l’infruttuosa visita di Bernini (vicen-da peraltro cruciale anche nella carriera disuo fratello Claude): «Mais à quelque de-gré que cette gloire monte, / Rien ne peutempescher que Rome n’ait la honte / Mal-gré tout son orgueil de voir avec douleur /Passer chez ses voisins ce haut comble d’-honneur: / Lorsque par les beaux arts nonmoins que par la guerre / La France devien-dra l’ornement de la terre. / Elle aura quel-que temps ce precieux tresor / Qu’elle necroira pas le posseder encor, / Mais quandpour eslever un Palais qui réponde / A l’au-guste splendeur du plus grand Roy dumonde / L’homme, en qui tous les arts sem-bleront ramassez, / Du Tibre glorieux lesbords aura laissez / Elle verra qu’en vain deces lieux elle appelle / La science, & les Artsqui sont déjà chez elle»4.
Nel 1671, quando la costruzione teoricaeretta a supporto della sua politica dovevaapparirgli ormai salda, Colbert ritenne giun-to il momento di passare dalle rivendicazio-ni alle iniziative concrete. Promosse così inquell’anno un grande concorso per la crea-zione di un nuovo ordine architettonicofrancese da utilizzare al terzo livello dellaCour Carréedel Louvre5, e subito dopo isti-tuì l’Académie Royale d’Architecture, affi-dandone la direzione a François Blondel6.
A Roma, di questa vague di nazionali-smo culturale suscitata da Colbert non siebbe nei primi anni una chiara percezione,anche perché la fondazione di un’Académiede France nella città papale, della quale fuincaricato Charles Errard nel 1666, venneposta ufficialmente sotto il patrocinio diBernini, e presentata perciò come un tribu-
to, in linea con la tradizione, all’egemoniaartistica della capitale pontificia.
Forse fu proprio Bernini – a giudicaredalla distanza che, nonostante il compensoappositamente assegnatogli, mantenne neiconfronti della nuova istituzione7 – l’unicoa sospettare che l’apertura di una sede cul-turale francese a Roma non servisse soltan-to a migliorare la formazione degli artistid’oltralpe. Nella mente di Colbert, infatti,l’insediamento dell’Académie sul Tevereera l’atto iniziale di una strategia mirante aporre progressivamente anche le istituzio-ni artistiche romane, in particolare l’Acca-demia di San Luca, sotto il controllo dellamonarchia francese. Ma per raggiungerequest’obiettivo, i Francesi dovettero atten-dere il pontificato di Clemente X.
Il 22 dicembre 1670, otto mesi dopo lasua elezione al soglio, l’anziano Emilio Al-tieri nominò cardinale Camillo Massimo eaffidò a lui la politica culturale del suo pon-tificato. Nato nel 1620, Camillo Massimoera entrato fin da ragazzo nell’entourage delcardinale Francesco Barberini, caratteriz-zato da una raffinata cultura di orientamen-to classicista e da tendenze politiche filo-francesi. In quell’ambiente aveva conosciu-to Nicolas Poussin e più tardi Giovan Pie-tro Bellori, con il quale aveva stabilitoun’intesa culturale profonda e duratura.Nella posizione eminente assegnatagli daClemente X, Camillo Massimo cominciòdunque ad avvalersi dei consigli di Bellori– a sua volta nominato commissario alleAntichità – e ciò determinò subito profon-di mutamenti sia sulla scena romana, sia neirapporti con la Francia8.
Il ruolo di protagonista nelle iniziativeartistiche papali fu definitivamente sottrat-to a Gian Lorenzo Bernini – un artista cheBellori non aveva mai apprezzato – e passòa Carlo Maratti. Nel segno dell’ideale clas-sicista, quest’ultimo divenne così il pittorecentrale della committenza Altieri, rag-giungendo ben presto una fama che lo por-tò a ottenere nel 1681, dopo aver dipintoper Luigi XIV la tela con l’Apollo e Dafneoggi a Bruxelles, il titolo di peintre du Roi.Anche nelle relazioni con Parigi si aprì unafase nuova e delicata in cui Camillo Massi-mo e Bellori, mentre mostravano di ricono-scere il primato ormai raggiunto anche incampo artistico dalla potenza d’oltralpe(verso la quale si susseguirono gli omaggi:nel 1672 Bellori pubblicò le Vite dedican-dole a Colbert, mentre la sua Colonna Tra-iana del 1673 fu offerta a Luigi XIV), s’im-pegnarono tuttavia per impedire che i suoirappresentanti sottraessero da Roma ope-re d’arte antica.
Questo mutato contesto si presentava aColbert come il più favorevole all’attuazio-ne del suo progetto di egemonia sull’Acca-demia di San Luca. Così al vertice di quel-l’istituzione fu eletto nel 1672 Charles Er-
rard, vale a dire il rappresentante del re So-le a Roma per gli affari culturali, e nel 1675Carlo Maratti, con una sorta di colpo dimano attuato tra il 15 e il 17 dicembre, pro-pose Charles Le Brun – «pittore appressoil re Cristianissimo» – prima come accade-mico di merito e poi direttamente comeprincipe per l’anno successivo9, «ancorche– è costretto a precisare Maratti – repugniin qualche parte alli nostri Statuti, ma-giorm[en]te stante l’assenza del sud[ett]o.Il che si può togliere con la viva voce e colcommune assenso». Accettate dunque peracclamazione, l’elezione del lontano LeBrun al principato e quella di Errard qualesuo vicario a Roma vennero più tardi con-fermate anche per il 167710, mentre nel1678 il principato tornò a Charles Errard11.
I casi di studio di cui si tratta nelle pagi-ne che seguono, si situano cronologicamen-te nel quindicennio successivo alla ‘conqui-sta’ dell’Accademia di San Luca da parte diesponenti dell’arte di Stato francese. Il pri-mo dei due episodi appare in rapporto di-retto con quella vicenda, nella quale l’archi-tetto Mattia De Rossi è figura centrale; nelsecondo assumono rilievo la personalità ela biografia del committente. In entrambi,come si cercherà di dimostrare, opere del-l’architettura francese furono prese a mo-dello per importanti edifici romani: un’in-versione di ruoli senza precedenti (fatto sal-vo il caso eccezionale e tuttora problemati-co di palazzo Barberini), che non può tro-vare spiegazione fuori del quadro storicoqui sommariamente delineato.
Mattia De Rossi, il palazzo Muti Papazzurriin piazza della Pilotta e l’hôtelde La Vrillière in rue des Petits-Champs
Il palazzo Muti Papazzurri nell’anticapiazza dell’Olmo, poi piazza della Pilotta,occupa la minore delle due insulaeche l’an-tica famiglia romana aveva acquisito nelrione Trevi nel corso del tardo Medioevo12.All’inizio del XVI secolo queste proprietàrisultano già divise tra due distinti rami delcasato. La maggior parte di entrambe le in-sulae apparteneva al ramo principale, quel-lo di Prospero, caratterizzato dall’uso deldoppio cognome. Il ramo minore di Gio-vanni, che utilizzava il solo cognome Muti,era proprietario invece di una parte dell’in-sula maior. Nel 1536, dopo la morte di Pro-spero Muti Papazzurri, il suo vasto patri-monio – comprendente anche altre case inTrevi e in tutta la città, oltre a casali, vignee terreni – era stato diviso, al termine di unacontroversia legale, tra i due figli MarcoAntonio e Girolamo. A quest’ultimo eranotoccati alcuni degli immobili urbani, tra cuidue case e un granaio alle spalle del «palaz-zo grande» in Trevi, nei quali si riconosce ilprimo nucleo della futura insula minornel-la platea Ulmi 13.
Nel gennaio 1619 il pronipote di Giro-
170 Aloisio Antinori . RIFLESSI DI EDIFICI PARIGINI IN RESIDENZE ROMANE DEL TARDO SEICENTO
Fig. 2 - Progetto di ampliamento del palazzo Muti Papazzurri in piazza della Pilotta a Roma, allegato al chirografo papale del 4 luglio 1665che concede l’acquisto di una porzione di suolo pubblico, disegno (ASR, Notai del Tribunale delle acque e strade, 93, cc. 14r-16v).
to diversa, perché in quel caso i due avan-corpi sono tra loro molto più distanti, e al-lo spazio che delimitano, completamenteaperto verso l’esterno, è attribuita in modoassai meno esplicito la funzione di cortile.
Il tipo del palazzo con corpo residenzia-le centrale e corte antistante contenuta traavancorpi e separata dalla strada per mez-zo di un diaframma murario o un basso fab-bricato, era invece radicato nella cultura ar-chitettonica francese fin dal XVI secolo,tanto che già Jacques Androuet du Cerce-au ne propone alcuni notevoli esempi nelsuo Livre d’Architecturedel 1559. E d’altraparte il riferimento all’architettura france-se appare pienamente pertinente nel casodi Mattia De Rossi, che, com’è ben noto,aveva soggiornato a Parigi per due lunghiperiodi: la prima volta come assistente diBernini dal 2 giugno al 20 ottobre 1665, laseconda da solo per quasi un anno, dagli ul-timi giorni di maggio del 1666 al 21 maggio1667, con l’incarico di elaborare in formaesecutiva le proposte del suo maestro per ilLouvre.
Appare dunque molto probabile che nelprogettare l’ampliamento del palazzo Mu-ti Papazzurri alla Pilotta, Mattia De Rossiabbia pensato, più che al palazzo Barberi-ni, agli hôtels particuliersparigini che cono-sceva altrettanto bene. Si potrebbe anzisupporre che, nel riferirsi al tipo dell’hôtelcon cour d’honneur tra avancorpi, l’archi-tetto romano avesse in mente un edificio inparticolare.
Durante il suo primo soggiorno in Fran-cia al fianco di Bernini, uno dei palazzi chemaggiormente avevano attratto l’attenzio-ne dei due architetti era stato quello del Se-gretario di Stato Louis Phélypeaux de LaVrillière in rue des Petits-Champs32. Co-
struito su progetto di François Mansart apartire dal 1635, quest’edificio aveva subi-to riscosso una generale ammirazione, di-venendo, come sottolineò Blunt33, un mo-dello di hôtel particulier per molti decennia seguire. E non è in dubbio che fosse con-siderato una delle più belle residenze dellacittà ancora al tempo dei soggiorni parigi-ni di Mattia De Rossi. Che quest’ultimo co-noscesse e apprezzasse l’hôtel de La Vrilliè-re, ci è del resto confermato da Paul Fréartde Chantelou, che il 22 settembre 1665scrisse nel suo diario: «Étant devant le lo-gis de M. de la Vrillière, nous y sommes de-scendus. Le signor Mattia m’a dit, entrésdans la cour, qu’il jugeait qu’il était du des-sin de Mansart, qu’il avait ouï dire qu’iln’avait jamais été à Rome; que s’il y avaitété, il fût devenu un grand homme»34. Al dilà dell’orgogliosa rivendicazione del prima-
to dell’architettura romana (ribadita men-tre a Parigi tale primato era ormai contesta-to), le parole di De Rossi esprimono l’inte-resse e l’ammirazione suscitati in lui dal pa-lazzo. L’11 ottobre anche Bernini era statoaccompagnato da Chantelou a visitare l’hô-tel de la Vrillière e la collezione d’arte chevi era conservata. In quell’occasione il mae-stro italiano aveva «trouvé la maison belle»,e uscendo aveva affermato «qu’il lui sem-blait être dans un des palais de Rome»35.
Proponendo dunque a Pompeo e Gio-vanni Muti Papazzurri un palazzo conpianta aperta alla francese (fig.1), De Ros-si indicò loro verosimilmente quale model-lo per la nuova dimora proprio il celebrehôtel de La Vrillière (figg. 5 e 6), universal-mente ritenuto uno dei più prestigiosiesempi del tipo. Va notato infatti che, oltreche nell’impianto, i due edifici presentanouna certa affinità anche nella configurazio-ne del monumentale ingresso alla courd’honneur, anche se il portale dorico delladimora parigina, particolarmente apprez-zato dai contemporanei e riprodotto daJean Marot , è inquadrato da due colonneabbinate a paraste (fig.7), mentre quello delpalazzo Muti Papazzurri, d’invenzione piùcomplessa, presenta due coppie di colon-ne libere di ordine tuscanico, alle quali cor-rispondono sulla parete retrostante duecoppie di paraste più una terza parasta iso-lata per parte. In generale l’adozione di co-lonne binate, fino ad allora del tutto inusua-le a Roma in un portale di palazzo, apparein diretto rapporto con l’architettura fran-cese. Nella parte realizzata dell’ala d’Or -léans del castello di Blois37, un’altra celebreopera di Mansart certamente ammirata daDe Rossi durante il suo secondo soggiornoin Francia, coppie di colonne compaiononon solo nell’originale portico a pianta cur-vilinea, dove il motivo è utilizzato in se-quenza, ma pure ai lati del portale, simile aquello di palazzo Muti anche nel profilo
173QUADERNI DELL’ISTITUTO DI STORIA DELL’ARCHITETTURA . 60-62/2013-2014
mata del resto dalla collocazione stessa del-le colonnine di protezione, cui si provvede-va di solito a conclusione di una fabbrica.
Si può ipotizzare dunque che, dopo l’ac-quisto di suolo pubblico all’inizio del 1666,la costruzione del nuovo palazzo Muti Pa-pazzurri in piazza dell’Olmo sia stata so-spesa per circa nove anni, e che i lavori ab-biano realmente preso avvio solo alla finedel 1674, cioè dopo l’acquisizione da partedella famiglia del feudo e del titolo mar-chionale di Filacciano21. Certo è che Mat-tia De Rossi entrò al servizio dei Muti Pa-pazzurri del ramo di Girolamo giusto nel167522. Molto probabilmente Pompeo eGiovanni si rivolsero a lui proprio per inca-ricarlo della costruzione del palazzo, e in-fatti l’11 agosto di quell’anno De Rossi uti-lizzò per una delle sue lezioni domenicalipresso l’Accademia di San Luca un disegnocon il parziale progetto del grande portalecon colonne binate23 poi effettivamenterealizzato (fig. 3).
Il rapporto di De Rossi con l’Accademiaera in quegli anni molto stretto, e coincisecertamente con un’attiva adesione dell’ar-chitetto al partito filofrancese di Bellori eMaratti. Il suo ingresso tra gli accademici,approvato per acclamazione il 21 agosto epoi formalizzato il 2 ottobre 1672, era statoinfatti proposto da Charles Errard 24, inquell’anno principe dell’istituzione. Il 30aprile 1673, durante il principato di CarloRainaldi, De Rossi ricevette l’incarico di te-nere lezioni di architettura25, le prime im-partite in Accademia nel quadro di un’atti-vità didattica regolare: è verosimilmente inquesta occasione che egli preparò quindicitavole con accurati disegni a china illustran-ti la morfologia e le proporzioni degli ordi-ni architettonici26. Una finalità didattica ave-vano senza dubbio anche i cinque disegni diDe Rossi conservati in Accademia e datati7, 14 e 28 luglio 1675 (rispettivamente pian-ta, prospetto principale e sezione di un «Ca-sino di Villa che mostri quattro facciate»), 4agosto 1675 (un altare con edicola di ordi-ne corinzio) e 11 agosto 1675 (il già menzio-nato portale con colonne)27. Infine è impor-tante segnalare che nel 1673 – presumibil-mente per volontà del principe di quell’an-no, ovvero Carlo Rainaldi – si istituì, tra iruoli ufficiali attribuiti agli accademici,quello di «Stimatore d’Architetture»28, eche per i primi tre anni tale nuova carica,professionalmente prestigiosa e certamen-te remunerativa, fu sempre ricoperta daMattia De Rossi: nel 1673 con Carlo Fonta-na, nel 1674 con Giovanni Antonio De Ros-si e nel 1675 insieme a Carlo Rainaldi29.
Il confronto tra la planimetria dell’edifi-cio del 1619-1630 (quella che accompagnail chirografo del 1665) e un rilievo del pa-lazzo tardoseicentesco eseguito in vista deiconsistenti interventi di modifica degli an-ni 1889-189230 (fig. 4), ci dà un’esatta no-
zione dell’intervento attuato da De Rossi. Utilizzando la porzione di suolo pubbli-
co acquisita nel 1666, si sarebbe potuto ele-vare lungo l’intero margine orientale del-l’isolato un corpo di fabbrica orientatonord-sud, che avrebbe rivolto verso la piaz-za un maestoso prospetto di circa 80 palmi.L’ampio giardino della casa già Branchiavrebbe fornito lo spazio necessario peruna corte interna. L’architetto scelse inve-ce una soluzione diversa e originale, e rea-lizzò un edificio aperto, ottenuto svilup-pando il palazzo preesistente in due lunghiavancorpi. Di questi, quello sul lato nord fupensato per accogliere al piano nobile unagalleria aperta su tre lati. Essendo costrui-to interamente ex novo, la sua pianta è per-
fettamente regolare. L’avancorpo meridio-nale, invece, risultò dall’addizione di un vo-lume di pianta trapezoidale al corpo pree-sistente della casa Branchi, che già sporge-va per l’intera sua dimensione dal bloccodel palazzo di primo Seicento. L’ampia cor-te tra i due avancorpi, organizzata su due li-velli 31, fu separata dalla piazza da un sem-plice diaframma murario, che assunse pe-rò all’esterno la forma di un maestoso por-tale a colonne binate.
Si tratta, com’è evidente, di una soluzio-ne del tutto insolita nel contesto romano.Anche la grande dimora dei Barberini alleQuattro Fontane, che si è portati a indivi-duare quale precedente per il simile asset-to a pianta aperta, appare in realtà alquan-
172 Aloisio Antinori . RIFLESSI DI EDIFICI PARIGINI IN RESIDENZE ROMANE DEL TARDO SEICENTO
Fig. 3 - Mattia De Rossi, progetto per un portale con colonne binate,1675, disegno (AASL, Disegni di architettura, 2102).
Fig. 4 - Rilievo del palazzo Muti Papazzurri in piazza della Pilotta prima dell’interventoottocentesco, planimetria con campiture di studio, 1889, disegno (ASC, Titolo 54, prot. 40971).
Fig. 5 - Jean Marot, veduta dell’hôtel di Louis Phélypeaux de La Vrillièrea Parigi, incisione (da L’Architecture françoise, cit.).
nella sua casa romana nel 1650, e nel 1653Girolama si era trasferita a Parigi, andandoa risiedere presso il potente fratello insiemeai figli Maria e Filippo Giuliano alle sogliedell’adolescenza e Ortensia in età infantile.I tre giovani Mancini crebbero dunque aParigi, facendosi notare a corte per la loroirrequietezza. Dopo la morte della madre(1656), le loro vite giunsero a una svolta nel1661. Il 28 febbraio di quell’anno Ortensiasposò Armande-Charles de la Porte, ducade La Meilleraye e pronipote del cardinalede Richelieu, che dopo il matrimonio assun-se il cognome e l’arme dei Mazzarino. Il 9marzo il cardinale Mazzarino morì e un me-se più tardi Maria Mancini, che aveva avu-to una relazione con il giovane re, andò insposa per procura al gran conestabile di Na-poli Lorenzo Onofrio Colonna e partì subi-to per Roma. Quanto a Filippo Giuliano45,egli ereditò alla morte dello zio il ducato diNevers e Donzois, metà del palazzo Mazza-rino di Parigi46 e una rendita ingente.
Il palazzo che il cardinale Mazzarinopossedeva in Roma sul Quirinale – già Bor-ghese, Altemps e Bentivoglio – andò al car-dinale Francesco Maria Mancini, fratellodi Lorenzo Mancini, con la clausola che al-la sua morte sarebbe passato alla secondo-
genitura Mancini, e che da quel momentola famiglia romana avrebbe assunto il co-gnome di Mazzarino-Mancini. Quandonel giugno 1672 il cardinale Mancini morì,Filippo Giuliano divenne anche l’unicoproprietario della dimora paterna in via delCorso, verso la quale possiamo ora volge-re la nostra attenzione.
Poco prima del 1660 il cardinale Mazza-rino aveva acquistato alcune case sul Corsoper accorparle all’antica casa dei Mancini,un edificio cinquecentesco nell’angolo sud -occidentale dell’isolato47 (fig.12). Su propo-sta dell’agente romano di Mazzarino, l’aba-te Elpidio Benedetti, la realizzazione del pa-lazzo era stata affidata a Carlo Rainaldi.Non conosciamo questo primo progetto,ma sono giunte fino a noi la lettera e le notedescrittive che il 27 febbraio 1660 Rainaldiinviò al committente insieme ai disegni og-gi perduti48. Tuttavia la spesa prevista perl’opera era così ingente – Rainaldi parla nel-la lettera di 40.000 scudi – che dalla corri-spondenza tra Benedetti e Mazzarino emer-gono dubbi già nel mese di aprile, e nel gen-naio del 1661 l’idea di un’impresa di quelledimensioni sembra abbandonata. Nel mar-zo dello stesso anno il cardinale Mazzarinocessò di vivere e la questione della residen-
za romana fu per lungo tempo accantona-ta. Quando nel 1672 morì anche il cardina-le Francesco Maria, l’ultimo dei Mancini‘romani’, il vecchio palazzetto sul Corso –ormai di proprietà del solo Filippo Giulia-no, residente a Parigi – divenne oggetto del-le mire del potente confinante Flavio Chigiche, programmando di acquistarlo, incari-cò Felice Della Greca di progettare un pa-lazzo esteso all’intero isolato49. Ma il passag-gio di proprietà, dato per certo in un Avvi-so del marzo 167450, non ebbe mai luogo.
Il progetto di ricostruire la dimora di fa-miglia sul Corso fu ripreso in considerazio-ne da Filippo Mancini a partire dal 1686. Ilduca di Nevers continuava a risiedere nel-la capitale francese, ma potava contare sul-l’aiuto che, nella gestione dell’impresa, glioffriva da Roma il marito di sua sorella Ma-ria, Lorenzo Onofrio Colonna. Nel corsodel 1686, quest’ultimo invitò a presentareproposte per il palazzo due diversi architet-ti: Giovanni Battista Contini, del quale cirestano due disegni firmati e datati 3 di-cembre 1686 (fig. 13), e un secondo profes-sionista identificabile in Carlo Fontana, cheeseguì tre disegni51 (fig.14). I due progettidifferiscono nella configurazione della se-quenza atrio-scalone, nella posizione dellastalla, nel numero e nella dimensione dellebotteghe. Molto simile è invece, nelle dueproposte, il semplice cortile quasi quadra-
175QUADERNI DELL’ISTITUTO DI STORIA DELL’ARCHITETTURA . 60-62/2013-2014
centinato dell’apertura (fig. 8). Negli annisessanta poi, com’è noto, le colonne abbi-nate in sequenza avevano ottenuto un rin-novato successo nell’ambito del dibattitosulla facciata orientale del Louvre38, ed è si-gnificativo che la Colonnadedi Claude Per-rault – presentata dall’autore come alter-nanza di un intercolumnio sistilo e di un ae-rostilo – abbia assunto agli occhi dei con-temporanei, come ha evidenziato Pérousede Montclos, il carattere di un’invenzioneà la française 39. A Roma colonne binate
compaiono nel progetto di BartolomeoSantini vincitore del primo premio del con-corso del 1682, sul tema dell’«Ingresso aduna villa», per gli studenti della terza clas-se di architettura dell’Accademia di SanLuca40. Sia la proposta di Santini, sia quel-la di Pio Antonio Sevalle che ottenne il se-condo premio41, sono palesemente in rap-porto con il portale del palazzo Muti Pa-pazzurri alla Pilotta, e questo non sorpren-de se si considera il rilievo che la presenzadi Mattia De Rossi aveva assunto in Acca-demia fin dal 1672.
Un riferimento all’architettura francesesi riscontra anche nell’altro portale del pa-lazzo Muti Papazzurri, quello sul fronte
nord, verso la casa Ciogni. Dal rilievo otto-centesco che ci è pervenuto, apprendiamoche nell’originario disegno di Mattia DeRossi42 (fig. 9) questo portale presentava untipo di bugnato a fasce orizzontali (à re-fends), nel quale, cioè, i giunti verticali so-no tendenzialmente evitati o dissimulati. Sitratta di un bugnato piuttosto raro a Romanel Seicento, specialmente nei portali, e giàcomparso invece in alcuni importanti edi-fici a Parigi e in Francia, dove ebbe poi am-plissima diffusione nel XVIII secolo. DeRossi, che nel 1694 lo ripropose nella Do-gana di Ripa Grande, doveva averlo osser-vato nel portale dell’hôtel di Michel-Antoi-ne Scarron (fig.10), poi d’Aumont43, ascri-vibile a Louis Le Vau (ca. 1644-1648), inquello dell’hôtel di Claude d’Avaux, diPierre Le Muet (1645-1648), noto ancheperché l’autore ne pubblicò l’immagine(fig.11) nelle Augmentationsalla sua Manie-re de bien bastir...44, e ancora nella facciataverso la città dell’ala settentrionale dellaCour Carréedel Louvre, costruita nel 1660su disegno di Louis Le Vau.
Sebastiano Cipriani, il palazzo Mancinial Corso e l’hôtel de Beauvaisin rue Saint-Antoine
Il palazzo romano di Filippo GiulianoMancini (1641-1707) sorge sul lato orien-tale del Corso, all’interno dello stesso vastoisolato occupato per la maggior parte dallaresidenza verso piazza dei Santi Apostoliche – già Colonna e Ludovisi, poi Odescal-chi – apparteneva in quel tempo al cardina-le Flavio Chigi.
L’evento decisivo nella storia dei Manci-ni, famiglia di antiche origini romane, è ilmatrimonio nel 1634 di Lorenzo Mancinicon Girolama Mazzarino, sorella del cardi-nale Giulio Mazzarino. Dopo aver genera-to una numerosa prole, Lorenzo era morto
174 Aloisio Antinori . RIFLESSI DI EDIFICI PARIGINI IN RESIDENZE ROMANE DEL TARDO SEICENTO
Fig. 7 - Jean Marot, prospetto del portaledell’hôtel de La Vrillière, incisione(da Recueil de plusieurs portes, cit.).
Fig. 9 - Rilievo del prospetto nord del palazzo Muti Papazzurriin piazza della Pilotta prima dell’intervento ottocentesco,1889, dettaglio del portale, disegno (ASC, Titolo 54, prot. 40971).
Fig. 10 - Parigi. Hôtel di Michel-Antoine Scarron,poi d’Aumont, portale (ca. 1644-1648).
Fig. 8 - Blois. Castello, ala di Gastone d’Orléans, prospetto sulla corte, 1635-1638.
Fig. 6 - Robert de Cotte, planimetria di rilievo dell’hôtel de La Vrillière,1714, disegno (Parigi, Bibliothèque nationale de France, Va 441, R. de Cotte 1575).
nimetria del pianterreno (fig.15) e un pro-spetto sul cortile (fig.16).
Nei mesi centrali del 1687, dunque, ilventicinquenne Sebastiano Cipriani54 ot-tenne il primo incarico di grande rilievodella sua vita professionale, e s’impegnònella redazione di un progetto che andavacertamente oltre il limitato programma delcommittente. Naturalmente le propostepresentate dai due architetti più espertinon furono subito abbandonate, tanto chein un’altra lettera al cognato datata 7 lu-glio55, Filippo Mancini scrive: «Rimando ildisegno del cavalier Fontana, il quale essen-domi parso lo stesso nel immutabilità delidea circa la situazione della scala, mi è par-so meglio appigliarmi a quella del Continiper la collocazione di essa, ma per l’unionedel ingresso a gli appartamenti nobili, cre-do che si possa migliorare, non aprovandoin nessun conto la disposizione del Conti-ni per le rimesse et le stalle». Non sappia-mo se nelle settimane successive gli orien-tamenti di Mancini siano mutati. Certo èche di quanto il duca afferma nella letteradal 7 luglio, Sebastiano Cipriani, che senzadubbio conosceva i disegni di Contini e diFontana, non sembra aver tenuto conto: ilvasto «Entrone» con quattro pilastri cheegli disegnò, e che fu poi effettivamente
realizzato, è infatti simile a quello previstoda Contini, mentre lo scalone rettangolarea quattro rampe con ampio pozzo si avvici-na, almeno nel tipo, alla proposta di tonopiù elevato presentata da Carlo Fontana.
Bisogna considerare inoltre che Cipria-ni si avvalse certamente anche dei consiglidi un terzo maestro, l’anziano Carlo Rainal-di, presso il quale doveva essersi formato56,e che l’anno precedente gli aveva affidato ildisegno dell’apparato per le esequie diGiorgio Bolognetti. Ventisette anni prima,come si è detto, Rainaldi aveva già inviatoal cardinale Mazzarino una serie di disegniper il nuovo palazzo Mancini al Corso, maquel progetto è perduto, e ignoriamo per-ciò se di esso si conservi traccia nella pro-posta di Cipriani. In ogni caso il giovane ar-chitetto, chiamato a confrontarsi con leidee di due dei maggiori professionisti ro-mani di quegli anni, elaborò un progetto dinotevole originalità.
La maestosa e convenzionale facciatache egli previde verso il Corso (fig. 17), eche venne poi effettivamente edificata, haben tredici assi di aperture. È pari cioè perestensione a quella che, nello stesso isolato,il palazzo di Flavio Chigi presentava versopiazza dei Santi Apostoli dopo l’interven-to berniniano del 1664-1666 e prima del-
l’ulteriore ampliamento settecentesco. Ilsontuoso portale con ringhiera su quattrocolonne deriva direttamente da quello delpalazzo Pamphili in piazza Navona, e vadunque verosimilmente ascritto a un sug-gerimento di Carlo Rainaldi57. Non venne-ro eseguite, o furono eliminate poco dopola loro realizzazione58, le botteghe che l’ar-chitetto pensava di aprire verso la strada.All’interno dell’edificio il progetto di Ci-priani prevede poi un vasto «Entrone» conquattro pilastri liberi, analogo a quello edi-ficato, e quindi un «Portico» sul cortile. Diqui si raggiunge, a sinistra, lo scaloned’onore, mentre una porta sulla destra im-mette in un appartamento «per l’Estate»,che incorpora alcuni ambienti del palazzet-to preesistente.
Alquanto inattesa è la soluzione propo-sta per il vasto cortile rettangolare. Svilup-pato trasversalmente per una dimensionedi 112,5 palmi (circa 25 metri), questo pre-senta infatti sul lato opposto all’ingressoun’ampia esedra con fontana centrale. Vo-lendo cercare dei precedenti di questo in-solito impianto tra i palazzi romani del XVIe XVII secolo, si potrebbero citare – oltreall’irrealizzato progetto di Raffaello per unasua residenza in via Giulia59 (1519-1520), eal problematico disegno dell’Albertina per
177QUADERNI DELL’ISTITUTO DI STORIA DELL’ARCHITETTURA . 60-62/2013-2014
to, dotato di una fontana al centro del latoorientale e collegato direttamente a una ri-messa per le carrozze.
Mentre Contini e Fontana elaboravanoi loro progetti, Lorenzo Onofrio Colonnasi recò proprio a Parigi in visita al cognato,facendo ritorno a Roma all’inizio del 1687.Da una lettera inviatagli da Mancini il 13maggio di quell’anno52, apprendiamo che,appena rientrato, Colonna aveva «presosopra di sé il dar principio alla fabbrica»,assistendo alla querelle insorta tra i due ce-lebri architetti sull’organizzazione funzio-nale del palazzo e sul modo di saldare lanuova costruzione all’edificio preesistente,e informando di tali «controversie» il co-gnato. Quest’ultimo, però, giudicando al-la fine i due professionisti «troppo punti-gliosi et delicati» per le necessità del caso,aveva inaspettatamente scelto di seguireuna nuova via. Dopo aver ricevuto a Pari-gi la visita di un architetto italiano non an-cora affermato, «un giovane che entende etassai vivace», aveva deciso di affidare a luiil disegno del palazzo romano, che non glisembrava dovesse essere, in definitiva, un«edificio di tanta speculazione». Anchel’entità del progetto fu ridimensionata: «Sesi puol migliorare la scala – scrive Mancininella stessa lettera – V[ostra] E[ccellenza]lo giudicherà, che per il rimanente io nonvoglio far altro che alzar tutta la facciata
senza far né rimesse né stalle, vi si penseràpoi finita la fabrica». Il giovane architetto,che il duca chiama semplicemente «Bastia-no», era senza dubbio Sebastiano Cipria-ni, perché la sua firma compare su due di-
segni di progetto per il palazzo del «ducadi Nivers» conservati presso l’Archivio diStato di Roma53 e – per quel che è possibi-le valutare dopo le successive alterazioni –molto vicini all’edificio realizzato: una pla-
176 Aloisio Antinori . RIFLESSI DI EDIFICI PARIGINI IN RESIDENZE ROMANE DEL TARDO SEICENTO
Fig. 11 - Pierre Le Muet, prospetto sulla strada dell’hôteldi Claude d’Avaux a Parigi, incisione (da Maniere de bien bastir, cit.).
Fig. 13 - Giovanni Battista Contini,progetto per il palazzo romano di Filippo Giuliano Manciniduca di Nevers, pianta del pianterreno, 1686,disegno (Subiaco, Archivio Colonna, III, BB.66.21).
Fig. 14 - Carlo Fontana, progetto per il palazzo romanodi Filippo Giuliano Mancini, pianta del pianterreno,1686, disegno (Subiaco, Archivio Colonna, III, BB.66.21).
Fig. 12 - Rilievo dell’area del palazzo Chigi, poi Odescalchi, a Roma, 1667 ca., disegno (BAV, Chigi, P.VII.10, ff. 61v-62r).Si notino le scritte «Case de SS.i Mancini» e «Mancini» nella porzione sud-occidentale dell’isolato.
seminterrato è situata la cucina, come Ci-priani precisa aggiungendo a matita lascritta «di Sotto Cucina»;
- la sequenza di «Corritore e porta segreta»,che il progetto di Cipriani prevede a sini-stra del portale maggiore, è strettamenteaffine, per funzione e posizione, ai due«passages» ai quali, nel palazzo parigino,si accede dalle porte che si aprono simme-tricamente in facciata tra le «boutiques»;si tratta, sia a Parigi sia a Roma, di percor-si di servizio, o segreti, che consentono diraggiungere una scala secondaria66. Quanto agli alzati, non potrà negarsi
una certa affinità di scansione ritmica tra lafacciata principale del palazzo parigino,della quale si conserva a Stoccolma ancheun foglio di progetto67 (fig.20), e l’idea diCipriani per la facciata sul cortile della re-sidenza romana, che vediamo nel secondodei disegni giunti sino a noi (fig.16) tra quel-li da lui eseguiti negli ultimi mesi del 168768.Il ritmo delle campate è ABA-A-ABA a Pa-rigi, e più semplicemente ABABAnel foglioromano. Qui infatti, trattandosi di un pro-spetto sulla corte, non vi è necessità di unamarcata valorizzazione dell’asse centrale,che Cipriani si limita a segnalare per mez-zo di una ringhiera al piano nobile.
Al termine di queste osservazioni, sipuò tentare di proporre una ricostruzionedella genesi del singolare progetto di Seba-stiano Cipriani. È evidente che per la gran-de facciata sul Corso Filippo Mancini im-pose al suo giovane architetto di attenersialla tradizione romana, e lo invitò anzi ve-rosimilmente ad avvalersi dei consigli au-torevoli di Carlo Rainaldi. In quel prospet-to si concentrava infatti la rappresentativi-tà dell’edificio nel contesto urbano e socia-le di Roma, un aspetto al quale, come acca-deva di norma e come emerge chiaramen-te in questo caso anche dalle carte d’archi-vio69, il committente teneva in modo par-ticolare.
Per quanto riguarda invece l’assetto pla-
179QUADERNI DELL’ISTITUTO DI STORIA DELL’ARCHITETTURA . 60-62/2013-2014
il palazzo Del Bufalo in piazza Colonna60,due elaborazioni che difficilmente Cipria-ni poteva conoscere – il palazzo di AngeloMassimo presso piazza Navona, attribuitoa Giovanni Mangone61 (1533-1537), e il pa-lazzo Muti Bussi all’Aracoeli, costruito daGiacomo Della Porta a partire dal 1578 etrasformato tra il 1636 e il 1642 da France-sco Peparelli e poi da Giovanni Antonio DeRossi62. Si tratta di pochi casi, tutti alquan-to distanti – al di là di ogni valutazione sul-la proponibilità di un accostamento forma-le al disegno in esame – dalla vicenda bio-grafica e professionale di Cipriani.
Sembra dunque legittimo proporre cheil modello del cortile con esedra previsto daCipriani sia da cercare altrove, segnatamen-te in un importante edificio non romano,che egli aveva avuto modo di visitare pro-prio poche settimane prima di applicarsial suo progetto. Quest’edificio è l’hôtel deBeau vais, la dimora parigina che tra il 1655e il 1660 Antoine Le Pautre aveva realizza-to sulla rue Saint-Antoine per incarico diCatherine-Henriette Bellier, première fem-me de chambre di Anna d’Austria e mogliedel ricco commerciante Pierre Beauvais63.
Va rilevato che la rue Saint-Antoine –tracciato ampio e quasi rettilineo attraver-so il Marais – era nel XVII secolo una dellestrade più importanti di Parigi, lungo laquale sfilavano i cortei reali quando il sovra-no entrava in città da est. Il prestigio del -l’hôtel de Beauvais dipendeva dunque innon piccola misura dalla sua privilegiataposizione, paragonabile a quella che il pa-lazzo romano di Filippo Mancini avrebbeoccupato su via del Corso. In virtù di taleposizione, il palazzetto progettato da LePautre era stato al centro di un evento me-morabile, celebrato da Jean Marot in un’in-cisione molto nota64 (fig.18).
Infatti in occasione del trionfale corteoche il 26 agosto 1660 aveva accompagnatol’ingresso a Parigi di Luigi XIV dopo la pa-ce dei Pirenei e il suo matrimonio con l’In-fanta di Spagna, la regina madre Annad’Austria aveva voluto assistere alla cerimo-nia proprio dal balcone dell’hôtel de Beau-vais da poco terminato. Ad Anna d’Austria– protettrice di Madame de Beauvais e ar-tefice delle sue fortune – era dedicata del re-sto l’intera decorazione scultorea della fac-ciata, sulla quale campeggiavano lo stemmadella regina sorretto da Vittorie alate, e per-sino la sua effigie65.
Come nel progetto definitivo per palaz-zo Mancini, anche nell’hôtel de Beauvais ilcortile è caratterizzato da un’ampia esedraopposta all’ingresso (fig.19), sebbene neldisegno di Cipriani questa s’innesti su unospazio a sviluppo trasverso, mentre nel-l’edificio parigino costituisce la terminazio-ne di un invaso a imbuto. Inoltre l’architet-to italiano pensò la concavità dell’esedracome fondale chiuso, tanto da collocarvi,
in asse, una fontana. Le Pautre, invece, leconferì il valore di una quinta permeabile,di un diaframma tra il cortile e gli spazi re-trostanti: eliminò infatti completamente itratti di parete tra gli snelli pilastri della suastruttura, sostituendoli con ampie apertu-re ad arco ribassato.
Se fosse dunque l’unica somiglianza, lapresenza di un prospetto concavo in en-trambi i cortili non basterebbe a sostene -
re l’esistenza di un rapporto tra l’hôtel deBeau vais e il progetto per il palazzo Man-cini. Ma confrontando le piante e gli alza-ti dei due edifici, si rileva che l’assonanzanella configurazione delle corti è solo la piùvistosa di una serie di corrispondenze chedifficilmente potranno ritenersi tutte ca-suali. Osservando le due icnografie si notainfatti che:- in entrambi i palazzi è previsto un secon-
do ingresso dalla via laterale posta a de-stra (ossia la rue de Jouy a Parigi e il vico-lo «de’ SS.ri Mancini», poi del Piombo, aRoma), attraverso il quale ci si immette inun ampio androne fiancheggiato dallescuderie e dalla rimessa per le carrozze;
- identica è anche la posizione dello scalo-ne d’onore rettangolare, situato subito asinistra delle sequenze funzionalmente
equivalenti di «Passage de la porte cochè-re – Porche» a Parigi ed «Entrone – Por-tico» a Roma;
- l’ambiente subito a destra del «Porche» ènell’hôtel de Beauvais la «Cuisine»; nelprogetto per il palazzo Mancini l’ampiastanza subito a destra del «Portico» è laprima dell’«Appartam[en]to Terreno perl’Estate», ma nello stesso punto al piano
178 Aloisio Antinori . RIFLESSI DI EDIFICI PARIGINI IN RESIDENZE ROMANE DEL TARDO SEICENTO
Fig. 18 - Jean Marot, Anna d’Austria assiste al corteodel 26 agosto 1660 dal balcone dell’hôtel de Beauvais,1660, incisione (da L’Entrée triomphante, cit.).
Fig. 19 - Jean Marot, pianta del pianterrenodell’hôtel de Beauvais a Parigi (da J.-F. Blondel, Architecture Françoise, cit.).
Fig. 15 - Sebastiano Cipriani, progetto per il palazzo romano di Filippo Giuliano Mancini,pianta del pianterreno, 1687, disegno (ASR, Disegni e Piante, coll. I, 87, 563, I).
Fig. 16 - Sebastiano Cipriani, progetto per il palazzo romano di Filippo Giuliano Mancini,prospetto sul cortile, 1687, disegno (ASR, Disegni e Piante, coll. I, 87, 563, II).
Fig. 17 - Alessandro Specchi,veduta del palazzo di Filippo Giuliano Mancini al Corso,incisione (da Il Quarto Libro del Nuovo Teatro delli Palazzi, cit.).
17. Archivio di Stato di Roma (d’ora in avantiASR), Notai del Tribunale delle acque e strade, 93(notaio Theodorus Marticarus), cc. 14r-16v. All’at-to notarile è allegato il chirografo papale con la re-lativa planimetria (fig. 2). Il testo del chirografo è ilseguente: «Mons.r Urbano Sacchetti chierico del-la nostra Camera, e Presidente delle Strade, haven-doci fatto istanza Mons.r Gio[vanni] Muti de Pa-pazzurri di concederli una portione di sito nellapiazza vicino al suo Palazzo posto dietro al Con-vento de P[ad]ri de Ss.ti Dodeci Apostoli in que-sta n[ost]ra Città di Roma ad effetto in quello fa-bricarvi et unirlo con il med[esim]o suo Palazzo inconformità della qui sopra designata Pianta, e di-segno. Et volendo Noi in ciò gratificarlo. Di qui èche di n[ost]ro motu proprio, certa Scienza, e pie-nezza della n[ost]ra p[ote]stà Ap[osto]lica ordi-niamo a Voi che in nome n[ost]ro, e della n[ost]raCamera concediate al d[ett]o Monsign.re Muti perse, suoi heredi, et succ[ess]ori in perpetuo, sicomenoi concediamo, la detta portione di sito in quan-tità di Canne trentacinque e ½ vicino al muro delGiardinetto del detto suo Palazzo, ad effetto inquello come sopra fabricarvi in conformità dellad[ett]a Pianta, e disegno per il prezzo giusto, e con-veniente, e che à Voi parerà e piacerà, et ogni voltache vi costarà habbia depositato il d[ett]o prezzonel Sacro Monte della Pietà di Roma à v[ost]ra di-spositione gliene spedirete l[ette]re patenti confor-me al solito, overo ne farete Instr[ument]o di ven-dita, e concessione, e quals[ivoglia] altra Scritturacon tutte le clausole promesse, et oblighi, etopp[ositio]ni, che à voi pareranno, e piaceranno,con che d[ett]o Mons.re sia tenuto, et obligato ter-minare d[ett]a fabrica tra uno anno pross[im]o dalgiorno della data del p[rese]nte n.ro Chirografo, etanto eseguirete essendo questa assoluta, et espres-sa volontà n[ost]ra».
18. ASR, Trenta Notari Capitolini, Uff. 18, 173(notaio Laurentius Bonincontri), cc. 693r-696v e708r-710r, 18 giugno 1626. La maggior parte dellasomma necessaria all’acquisto della casa era statafornita a Girolamo da Marcello Muti del ramo diGiovanni, che in cambio ne aveva ottenuto l’usu-frutto vitalizio per sé e per suo fratello Lelio. Cosìalla morte di Marcello Muti nel 1642 (Lelio erascomparso dieci anni prima), anche la casa già Bran-chi entrò nella piena disponibilità di Girolamo: cfr.G. MARINELLI, Matthia de’ Rossi, cit., pp. 81-84.
19. Ivi, p. 86.20. ASR, Presidenza delle Strade, Lettere paten-
ti, 49, cc. 76v, 86v, 92r-v, 105r. 21. I fratelli Giovanni, Pompeo, Scipione e Cur-
zio Muti Papazzurri acquistarono il feudo e il tito-lo marchionale di Filacciano il 4 settembre 1674 daCaterina Nuñez Sanchez, che l’aveva ereditato dalmarito Ottavio Naldi della Bordissiera: E. CALA-BRI, Le vicende storiche dal Medioevo all’Età Mo-derna, in Filacciano e il suo territorio, a cura di M.C.Mazzi, Bari 1995, pp. 49-52, in particolare p. 51,con riferimenti archivistici e bibliografici.
22. Cfr. il documento in ASR, Trenta Notari Ca-pitolini, Instrumenti, Uff. 18 (notaio Ioseph MariaPacichellus), 588, c. 47r-48v, pubblicato in G. MA-RINELLI, Matthia de’ Rossi, cit., p. 12. Si tratta di unaquietanza datata 7 luglio 1708 nella quale Marcan-tonio De Rossi, in veste di procuratore, dichiara diaver ricevuto da Pompeo Muti Papazzurri e da suofiglio Girolamo la somma di ottanta scudi, spettan-te a lui e agli altri eredi dei suoi zii Mattia e Dome-nico, per l’opera prestata da questi ultimi come ar-chitetti del marchese. Nel documento si ricorda (c.47r) come Mattia De Rossi «sin dall’anno 1675 fi-no all’anno 1695 habia assistito e servito d’Archi-tetto in tutte le occorrenze l’Ill.mi Sig.riMarch[es]e Pompeo, e la b[uona] m[emoria] diMonsig.r Giovanni Muti Aud[ito]re della Sac[r]aRota mentre visse».
23. Roma, AASL, Disegni di architettura, 2102.È evidente il rapporto con il portale del palazzoMuti Papazzurri di questo disegno, che è tracciatotuttavia in modo semplificato e astratto, verosimil-mente perché la sua finalità era didattica.
24. AASL, 44, c. 72v e 43, c. 216v. 25. AASL, 43, c. 222r. 26. Giunte sino a noi forse proprio in virtù del-
la loro utilità a fini didattici, queste tavole si con-servano in AASL, Lezioni di architettura, 10 (Mat-tia De Rossi). Nel 1674 il corso di architettura futenuto da Gregorio Tomassini, ma Mattia De Ros-si si occupò insieme a Carlo Rainaldi di «rivederele lezioni di Architettura»: AASL, 43, c. 230r.
27. I disegni, tutti firmati, sono in AASL, Dise-gni di architettura, 2099-2103 (i primi tre numericorrispondono alla successione delle date, ma il di-segno con l’altare, datato 4 agosto, ha il n. 2103,mentre il disegno con il portale, datato 11 agosto,porta il n. 2102). Un’annotazione tracciata in altosul foglio sembrerebbe indicare che il disegno conil portale sia l’unico superstite di una serie di cin-que. Le date apposte sui fogli corrispondono ad al-trettante domeniche e ciò conferma il loro scopodidattico, giacché le lezioni presso l’Accademia sitenevano appunto nel pomeriggio dei giorni festi-vi. Cfr. anche E. KIEVEN, Il disegno di architettura aRoma, in Giuseppe Piermarini tra Barocco e Neoclas-sico, a cura di M. Fagiolo e M. Tabarrini, catalogodella mostra (Foligno, giugno-ottobre 2010), Peru-gia 2010, pp. 113-138, in particolare pp. 113-114.
28. Va precisato infatti che, per quanto riguar-da le prerogative dell’Accademia nell’importantesettore delle perizie, esistevano fino al 1672 soltan-to i ruoli di «Stimatore di Pitture» e «Stimatore diSculture» (cfr. AASL, 43, c. 208v), in ciascuno deiquali erano nominati ogni anno due accademici.
29. AASL, 43, c. 219v e c. 229r; 45, c. 1v. Nel1676 la stessa carica fu ricoperta da Gregorio To-massini e Alessandro Sbringa. Va rilevato ancheche nel 1675 Mattia De Rossi ottenne un altro pre-stigioso riconoscimento, tale da consolidarne de-finitivamente la posizione professionale: l’incaricodi sovrastante della Fabbrica di San Pietro. Daquell’anno, inoltre, egli risulta stabilmente nel ruo-lo della famiglia Pamphili, di cui era l’unico archi-tetto: cfr. A. MENICHELLA, De’ Rossi, Matthia, inDizionario Biografico degli Italiani, 39, Roma 1991,pp. 227-230.
30. ASC, Titolo 54, prot. 40971, anno 1889. 31. La pianta del palazzo disegnata da Paul-Ma-
rie Letarouilly mostra che circa un terzo della su-perficie della corte, verso il corpo della residenza,si trovava a una quota più alta della restante parte,ed era raggiungibile per mezzo di una scala centra-le di nove gradini. Da questa sorta di terrazza, do-ve era posta una fontana con doppia vasca semicir-colare, si poteva accedere direttamente, attraversodue porte precedute da altri gradini, agli ambientiinterni del piano nobile del palazzo: a destra la gal-leria, a sinistra una sequenza di quattro stanze. Vanotato anche che al livello del piano nobile una bal-conata continua, alquanto inusuale in un palazzoromano, correva come un ballatoio lungo tre latidella corte.
32. Louis Phélypeau sposò nel giugno 1635 lafiglia del Soprintendente alle Finanze Michel Par-ticelli d’Émery, Marie, che gli portò in dote oltre300.000 lire. Nel marzo del 1635 prese avvio la co-struzione del palazzo su un terreno che Phélypeauaveva acquistato un anno prima. Il progetto e la di-rezione dei lavori furono affidati al giovane ma giàesperto François Mansart. La struttura murariadell’edificio fu portata a termine nell’estate del1637, mentre le opere di completamento prosegui-rono fino al 1642. Nel corso del 1640 i documentiregistrano anche la presenza nel cantiere del ven-tottenne Louis Le Vau, il cui apporto alla fabbrica
non è però identificabile. È certo invece che Man-sart continuò a occuparsi del palazzo anche neglianni successivi e almeno fino al gennaio 1650,quando firmò con gli scultori Henry Le Grand ePhilippe de Buyster l’ultimo contratto per le scul-ture interne della galleria sul giardino. L’hôtel deLa Vrillière fu venduto dagli eredi di Louis Phély-peau nel 1705, e dopo alcuni passaggi di proprietàpervenne nel 1712 a Louis-Alexandre de Bourbon,conte di Toulouse, bastardo legittimato di LuigiXIV e della marchesa di Montespan. Nel 1714 ilnuovo proprietario incaricò Robert De Cotte dirinnovare l’organizzazione interna del palazzo e al-cuni disegni per questo progetto si conservanopresso la Biblioteca Nazionale di Parigi. Confisca-to dallo Stato durante la Rivoluzione, l’hôtel de LaVrillière, poi de Toulouse, fu scelto da Napoleonenel 1811 come sede della Banca di Francia. Tale im-propria destinazione d’uso, che il palazzo conser-va tuttora, fu all’origine di una sua ulteriore e piùradicale trasformazione, che ne alterò anchel’aspetto esterno. Il più rilevante contributo sul pa-lazzo è di A. GADY, L’hôtel de La Vrillière. Méta-morphoses d’une demeure, in Place des Victoires.Histoire, architecture, société, a cura di I. Dubois,A. Gady, H. Ziegler, Paris 2004, pp. 214-233.
33. A. BLUNT, Art and Architecture in France1500-1700, London 1952, ed. 1982, p. 206.
34. P. FRÉART DE CHANTELOU, Journal de voya-ge du cavalier Bernin en France, a cura di M. M. Sta-nic, Paris 2001, p. 197; D. DEL PESCO, Bernini inFrancia. Paul de Chantelou e il Journal de voyage duCavalier Bernin en France, Napoli 2007, p. 365:«Poiché ci trovavamo davanti alla casa di M. de laVrillière, siamo entrati. Nella corte, il signor Mat-tia mi ha informato che, secondo lui, era costruitasu disegno di Mansart, del quale aveva sentito direche non era mai stato a Roma e che, se vi fosse an-dato, sarebbe diventato un grande architetto».
35. P. FRÉART DE CHANTELOU, Journal de voya-ge, cit., p. 250. D. DEL PESCO, Bernini in Francia,cit., pp. 436-438. Sui rapporti tra Bernini e Man-sart durante il viaggio del maestro italiano in Fran-cia, cfr. C. MIGNOT, M. Mansart et le cavalier Ber-nin. Chronique d’une rencontre manquée, in Le Ber-nin et l’Europe. Du baroque triomphant à l’âge ro-mantique, a cura di C. Grell e M. Stanic, Paris 2002,pp. 77-91.
36. J. MAROT, Recueil de plusieurs portes desprincipaux hostels et maisons de la ville de Paris...,Paris s.d., tav. 14. Sul successo del portale dell’hô-tel de La Vrillière, che sulla scena dell’architetturaparigina intorno al 1640 apparve molto innovativo,si veda A. GADY, L’hôtel de La Vrillière, cit., p. 219.
37. L’ala detta d’Orléans a Blois era stata realiz-zata tra il 1635 e il 1638 per Gastone d’Orléans, chein occasione delle sue nozze aveva ricevuto in do-no quel castello da suo fratello, il re Luigi XIII.
38. Sequenze di colonne binate compaiono giàin alcuni progetti anteriori a quello di Perrault.Mattia De Rossi, che lasciò Parigi nel maggio1667, doveva conoscere quello di Pierre Cottarddel 1665 (Parigi, Bibliothèque nationale de France,Département des Estampes, Va 217, I, A15013),mapotrebbe aver fatto in tempo a vedere anche laproposta attribuita a Louis Le Vau e conservata alLouvre (Département des Arts Graphiques, RF26077), se non quella di François Le Vau (Stoccol-ma, Nationalmuseum, CC 1), la cui datazione èmolto discussa: C. TADGELL, Claude Perrault,François Le Vau and the Louvre Colonnade, in«The Burlington Magazine», 122, 1980, pp. 326-337; R. GARGIANI, Idea e costruzione del Louvre,Firenze 1998, pp. 99-167; C.L. FROMMEL, Il pro-getto di Houdin per il Louvre, in La réception demodèles cinquecenteschi dans la théorie et les artsfrançais du XVIIe siècle, a cura di S. Frommel e F.Bardati, Ginevra 2010, pp. 199-212.
181QUADERNI DELL’ISTITUTO DI STORIA DELL’ARCHITETTURA . 60-62/2013-2014
NOTE
1. La proposta di venire a lavorare presso la cor-te francese era stata rivolta per la prima volta a Ber-nini già nel 1625, al tempo di Luigi XIII. Nel 1645Richelieu gli aveva rinnovato l’invito per il tramitedi Elpidio Benedetti, e nell’ottobre del 1662 il car-dinale Antonio Barberini gli aveva scritto informan-dolo che Luigi XIV desiderava vivamente vederloa Parigi. Soltanto nell’aprile del 1664, quando la ri-chiesta di presentare progetti per il nuovo Louvreera stata rivolta a lui e ad altri tre architetti romani(Carlo Rainaldi, Pietro da Cortona e un dilettantedi nome Candiani), Bernini aveva accettato l’inca-rico e un anno più tardi si era messo in viaggio: L.MIROT, Le Bernin en France. Les travaux du Louvree les statues de Louis XIV, in «Mémoires de la So-ciété de l’histoire de Paris et de l’Île-de-France», 31,1904, pp. 161-288, in particolare pp. 167-197.
2. T. MONTANARI, Bellori e la politica artistica diLuigi XIV, in L’idéal classique: les échanges artisti-ques entre Rome et Paris au temps de Bellori (1640-1700), a cura di O. Bonfait e A.-L. Desmas, Paris2002, pp. 117-137, in particolare p. 119.
3. Ivi, p. 120.4. CH. PERRAULT, La Peinture (Paris 1668), ed. a
cura di J.-L. Gautier-Gentès, Genève 1992, p. 99.Cfr. anche, ivi, la nota 23 alle pp. 98-100, e inoltre T.MONTANARI, Bellori e la politica artistica, cit., p. 121.
5. Sulla vicenda dell’ordre français commissio-nato da Colbert, si veda soprattutto J.-M. PÉROUSE
DEMONTCLOS, Le Sixième Ordre d’Architecture, oula Pratique des Ordres Suivant les Nations, in «Jour-nal of the Society of Architectural Historians», 36,1977, 4, pp. 223-240, in particolare pp. 226-232.
6. Oltre al direttore e al già ricordato segretarioAndré Felibien, dell’Accademia fecero parte ini-zialmente soltanto sei architetti: François Le Vau(fratello di Louis, morto nel 1670), François d’Or-bay, Libéral Bruant, Daniel Gittard, Antoine LePautre e Pierre Mignard: G.R. SMITH, Architectu-ral Diplomacy. Rome and Paris in the Late Baroque,Cambridge (Mass.) and London 1993, p. 321, no-ta 65, basato su Procès-Verbaux de l’Académie Ro-yale d’Architecture, 1671-1793, I-X, a cura di H.Lemonnier, Paris 1911-1929.
7. Cfr. la lettera a Bernini dell’abate Butti (no-vembre 1666), che lo consiglia di visitare la nuovaistituzione francese a Roma giacché «le roi et M.Colbert considèrent cette Académie avec une af-
fection particulière, comme une partie de leuresprit», e quella dello stesso Colbert (marzo 1667),che lo prega di prendersene cura dichiarandosi«bien persuadé que, quand elle sera dirigée par vosordres, ceux qui y sont eslevez réussiront dans lesbeaux-arts; en sorte que la France ne vous sera nonseulement pas redevable de ce grand et superbedessein, mais mesme que vostre nom luy sera enconsidération dans les siècles advenir par le moyendes habils gens qui se seront formez sous vostremain». Sappiamo dal duca di Chaulnes, ambascia-tore di Francia a Roma, che qualche tempo dopoBernini andò finalmente a visitare l’Accademia,dove non metteva piede da sette mesi, e riscosse inquell’occasione il suo assegno: L. MIROT, Le Ber-nin en France, cit., pp. 271-272.
8. T. MONTANARI, La politica culturale di GiovanPietro Bellori, in L’Idea del Bello. Viaggio per Romanel Seicento con Giovan Pietro Bellori, I-II, catalo-go della mostra (Roma, marzo-giugno 2000), a cu-ra di E. Borea e C. Gasparri, Roma 2000, I, pp. 39-49, in particolare pp. 42-43; L. BEAVEN, Cardinal Ca-millo Massimo as Art Agent of the Altieri, in Art andIdentity in Early Modern Rome, a cura di J. Burke eM. Bury, Aldershot (England) 2008, pp. 171-187.
9. Roma, Archivio Storico dell’Accademia diSan Luca (d’ora in avanti AASL), 45, cc. 27r-30r.Charles Le Brun, protagonista da quasi quindicianni della nuova politica culturale di Luigi XIV ePremier peintre du Roidal 1664, risiedeva natural-mente a Parigi, e i suoi rapporti diretti con Romarisalivano agli anni giovanili, quando vi aveva sog-giornato dal 1642 al 1646.
10. Ivi, 45, cc. 43v-44v.11. Ivi, 45, c. 53r-v.12. L’insula maior, che includeva il cosiddetto
«palazzo grande», cioè la residenza patrizia svilup-patasi dal nucleo originario dell’insediamento, eraquella situata sul lato settentrionale di piazza deiSanti Apostoli. Sulla genealogia dei Muti Papaz-zurri: N.M. LIVERANI, Famiglie e archivi. Dagli Al-toviti ai Savorelli, in A. ANTINORI, M. BEVILACQUA,Villa Savorelli a Sutri. Storia architettura paesaggio,Roma 2010, pp. 128-137, in particolare pp. 130-132. Sul «palazzo grande»: A. ANTINORI, Il palaz-zo Muti Papazzurri ai Santi Apostoli nei secoli XVIe XVII. Notizie sull’attività di Giovanni Antonio DeRossi, Carlo Fontana e Carlo Francesco Bizzaccheri,
in Architettura: processualità e trasformazione, At-ti del convegno internazionale (Roma, novembre1999), a cura di M. Caperna e G. Spagnesi, Roma2002, pp. 439-446.
13. Il «palazzo grande» nell’insula maior, rima-sto per undici anni proprietà indivisa dei due fra-telli, era stato infine anch’esso spartito nel 1547:Marco Antonio ne aveva ottenuto la porzione piùimportante, verso piazza dei Santi Apostoli e via diSan Marcello; a Girolamo era andata la parte pro-spiciente le sue case di piazza dell’Olmo.
14. Roma, Archivio Storico Capitolino (d’ora inavanti ASC), Camera Capitolina, Credenzone IV,tomo 86, c. 121r: «Per la p[rese]nte concediamo li-cenza al Sig. Gironimo Muti che possa fabricare lasua casa che ha rincontro il Convento de S.to Apo-stolo per la strada che va verso il frontespizio di Ne-rone»: pubblicato in H. HIBBARD, Di alcune licen-ze rilasciate dai Mastri di Strade per opere di edifica-zione a Roma (1586-’89, 1602-’34), in «Bollettinod’Arte», 52, 1967, pp. 99-117, in particolare p. 109.
15. La stessa cosa aveva fatto sette anni primaVincenzo Muti del ramo di Prospero con le sue ca-se nell’attuale via di San Marcello: cfr. A. ANTINO-RI, Il palazzo Muti Papazzurri, cit., p. 441.
16. Sull’acquisto del 1626, si veda infranel testoe alla nota 18. Nel luglio 1632 Girolamo, che a quel-la data era ormai certamente insediato con la sua fa-miglia nella nuova dimora nell’insula minor, deci-se di disfarsi anche della porzione di sua proprietànell’insula maior, vendendola a Vincenzo del ramodi Prospero, che divenne così il proprietario quasiesclusivo dell’isolato maggiore. Nei primi decennidel XVII secolo si verificò anche la progressivauscita di scena degli ultimi esponenti della linea chediscendeva da Giovanni Muti, cioè i due fratelli Le-lio e Marcello. Alla fine, nel 1638, quest’ultimo do-nò le parti a lui spettanti nelle due insulae ai suoicugini dei rami di Prospero (Prospero, Marco An-tonio e Giovanni Battista) e di Girolamo (Girola-mo II), mantenendo per sé soltanto una piccolaporzione dell’insula maior posta in angolo tra l’at-tuale via dell’Archetto e il vicolo oggi chiuso dellaMadonna dell’Archetto: cfr. A. ANTINORI, Il palaz-zo Muti Papazzurri, cit., p. 441 e p. 446, nota 9; G.MARINELLI, Matthia de’ Rossi e l’architettura di ca-sa Muti Papazzurri. Echi del Barocco berniniano traFilacciano e Roma, Bologna 2010, pp. 82-84.
180 Aloisio Antinori . RIFLESSI DI EDIFICI PARIGINI IN RESIDENZE ROMANE DEL TARDO SEICENTO
nimetrico-funzionale della dimora e il suoprospetto sulla corte, Cipriani fu libero diriferirsi alla prestigiosa residenza parigina inrue Saint-Antoine, che doveva aver visitatopochi mesi prima proprio insieme a Manci-ni. Va sottolineato che il rapporto di que-st’ultimo con l’hôtel de Beauvais era anticoe diretto. Negli anni della sua adolescenza acorte lo aveva visto costruire e decorare inonore di Anna d’Austria, e da una delle suefinestre aveva anch’egli probabilmente assi-stito, diciannovenne, al sontuoso corteo chenell’agosto del 1660 aveva celebrato il trion-fo della strategia politico-diplomatica delfratello di sua madre. Possiamo ritenere,dunque, che per il duca di Nevers il palazzocostruito da Le Pautre fosse non soltanto unmodello di residenza patrizia personalmen-te conosciuto e apprezzato, ma anche unamemoria architettonica – per così dire – de-gli anni del governo di Giulio Mazzarino, alquale interamente era dovuta la straordina-ria ascesa sociale dei Mancini.
>
>
Fig. 20 - Antoine Le Pautre e collaboratori, progetto per la facciata dell’hôtel de Beauvaisa Parigi, 1655 ca., disegno (Stoccolma, Nationalmuseum, THC 6513).
39. J.-M. PÉROUSE DE MONTCLOS, Le SixièmeOrdre, cit., pp. 231-232 e pp. 237-238. Quattrocoppie di colonne presenta anche l’arco trionfaleprogettato da Claude Perrault per la Barrière duTrône e riprodotto nel 1673 da Sébastien Le Clerc,insieme alla Colonnade del Louvre e a una propo-sta di capitello di ordre français, sul frontespiziodell’edizione del trattato di Vitruvio curata dall’ar-chitetto.
40. Del progetto di Santini ci restano i disegnidi pianta e di prospetto (AASL, Disegni di architet-tura, 59 e 60).
41. AASL, Disegni di architettura, 61.42. ASC, Titolo 54, prot. 40971, anno 1889. Nel
corso dell’intervento di trasformazione del palaz-zo attuato a partire dal 1889, l’architetto ErnestoDe Mauro ridisegnò le facciate, adottando un bu-gnato a conci di tipo tradizionale nella parte infe-riore del prospetto sulla piazza e nel portale versonord, e proponendo invece un bugnato a fasceorizzontali nella restante zona basamentale delprospetto nord. Fatta eccezione per il portale ver-so nord, l’edificio di De Rossi non presentava al-cun tipo di bugnato.
43. Il portale si presenta tuttora come nell’inci-sione di Jean Marot, poi inserita anche in J.-F.BLONDEL, Architecture Françoise..., I-IV, Paris1752-1756, II, 1752, tav. 239.
44. P. LEMUET, Maniere de bien bastir pour tou-tes sortes de personnes..., ed. Paris 1647, parte II,Augmentations de nouveaux bastimens faits en Fran-ce. Par les ordres et desseins du sieur Le Muet, tav. 28.
45. Per una biografia del committente del palaz-zo in esame: S. TABACCHI, Mancini, Filippo Giulia-no, in Dizionario Biografico degli Italiani, 68, Roma2007, pp. 478-481.
46. L’altra metà del palazzo di Parigi e delle col-lezioni d’arte in esso contenute andò al marito diOrtensia Mancini, indicato ormai nei documenticome il duca Mazzarino.
47. Sulle fasi iniziali della lunga vicenda del pa-lazzo Mancini: L. SALERNO, Palazzo Mancini, poi del-l’Accademia di Francia, in Via del Corso, Roma 1961,pp. 244-246; A. SCHIAVO, Palazzo Mancini, Palermo1969, pp. 111-131; M. GUERCI, Le palais Mancini àRome: d’une idée de Jules Mazarin au palais du ducde Nevers, in Mazarin. Les lettres et les arts, a cura diI. de Conihout e P. Michel, Saint-Remy-en-l’Eau2006, pp. 123-133, in particolare pp. 123-126.
48. A. SCHIAVO, Palazzo Mancini, cit., pp. 114-116; M. GUERCI, Le palais Mancini, cit., pp. 124-125.
49. Questo progetto si conserva in BibliotecaApostolica Vaticana, Chigi, P.VII.10, ff. 61v-62r.
50. A. SCHIAVO, Palazzo Mancini, cit., p. 121; M.GUERCI, Le palais Mancini, cit., p. 128.
51. Tutti e cinque i disegni – conservati in Subia-co, Archivio Colonna, III, BB.66.21 – furono pub-blicati per la prima volta da L. MAGGI, GiovanniBattista Contini e il palazzo Mancini al Corso in Ro-ma, in «Palladio», 23, 1999, pp. 51-64. Maggi nonestese tuttavia la sua ricerca ai documenti epistola-ri conservati nello stesso archivio, la cui successivascoperta (cfr. la nota seguente) consentì non sol-tanto una migliore comprensione dei progetti deidue architetti consultati da Lorenzo Colonna inrapporto a quello di Sebastiano Cipriani, ma anchel’attribuzione dei tre fogli non firmati a Carlo Fon-tana, al quale il duca fa esplicito riferimento in unadelle lettere.
52. Subiaco, Archivio Colonna, Carteggio di Lo-renzo Onofrio, 1687, Duca di Nivers, 13 maggio1687. Oltre a questa, due altre successive lettere diMancini a Lorenzo Colonna sono rilevanti per laconoscenza della storia della fabbrica, che fu inparte determinata proprio dall’inconsueta bipola-rità della committenza: quella del 7 luglio 1687, dicui si dirà tra poco, e quella del 2 settembre 1687,nella quale Mancini afferma che «essendo giuntoBastiano in Roma si metterà quanto prima manoall’opera volendo che si comminci per la facciata al
corso». La scoperta e la pubblicazione di questelettere si devono a M. GUERCI: Le palais Mancini,cit., pp. 129-131.
53. ASR, Disegni e Piante, coll. I, cart. 87, 563,I-II.
54. Sebastiano Cipriani era nato probabilmen-te nel 1662, giacché nei registri degli Stati delle Ani-me della parrocchia romana di San Nicola in Ar-cione gli è attribuita nel 1738 un’età di 76 anni: T.MANFREDI, Sebastiano Cipriani, in In urbe architec-tus. Modelli, Disegni, Misure. La professione dell’ar-chitetto. Roma 1680-1750, a cura di B. Contardi eG. Curcio, Roma 1991, pp. 336-340, in particola-re p. 339, nota 2. Per una cronologia delle opere diCipriani: A. ANTINORI, L’architettura di SebastianoCipriani: i progetti e le opere realizzate, in A. ANTI-NORI, M. BEVILACQUA, Villa Savorelli, cit., pp. 94-109, di cui, per quanto concerne il palazzo di Filip-po Mancini, il presente studio costituisce un’inte-grazione.
55. Subiaco, Archivio Colonna, Carteggio di Lo-renzo Onofrio, 1687, Duca di Nivers, 7 luglio 1687.
56. Sul problema della prima formazione di Ci-priani a Roma e sui suoi rapporti con Carlo Rainal-di e con Giovanni Battista Contini, cfr. A. ANTINO-RI, L’architettura di Sebastiano Cipriani, cit., p. 109,nota 46.
57. Un portale simile compare anche nel palaz-zo in piazza San Marco trasformato da Carlo Fon-tana tra il 1678 e il 1683 per Giovanni Antonio Bi-gazzini (che ne era diventato proprietario nel1672), e poi demolito all’inizio del secolo scorso(cfr. G. CURCIO, Carlo Fontana: Palazzo Bigazzini,in G. CURCIO, L. SPEZZAFERRO, Fabbriche e archi-tetti ticinesi nella Roma barocca, Milano 1989, pp.136-139). Va rilevato che nell’incisione di SimoneFelice Delino inserita neiNuovi disegni delle archi-tetture e piante dei palazzi di Roma – pubblicati daGiovanni Giacomo De Rossi verso il 1675, cioè nelperiodo in cui Fontana stava elaborando il suo pro-getto – il portale a quattro piedritti del palazzo Bi-gazzini è rappresentato con due colonne centrali edue paraste, mentre alla fine fu realizzato con quat-tro colonne, come appare nella veduta (tav. 65) diGiuseppe Vasi per il Libro Quarto delle Magnifi-cenze di Roma Antica e Moderna, del 1754.
58. Già nell’immagine della facciata del palazzorealizzata da Alessandro Specchi (Il Quarto Librodel Nuovo Teatro delli Palazzi in prospettiva di Ro-ma Moderna..., tav. 40) e pubblicata nel 1699 con ladata 1695, le botteghe non sono presenti. La que-stione della loro iniziale presenza, che sembrereb-be attestata dalle licenze dei Mastri di strade, e del-la successiva eliminazione, è affrontata in modocomplessivamente convincente in M. GUERCI, A la-te seventeenth-century case study in Rome: the con-struction of the Palazzo Mancini, 1686-1690, in Pro-ceedings of the Third International Congress on Con-struction History (Brandenburg University of Tech -nology, Cottbus, Germany, May 2009), a cura di K.-E. Kurrer, W. Lorenz, V. Wetzk, Berlin 2009, pp.759-766, in particolare pp. 764-765. Guerci ipotiz-za che le botteghe siano state eliminate dal cardina-le Niccolò Acciaiuoli poco dopo il suo arrivo nelpalazzo, del quale fu locatario dal 1695 al 1719.Contemporaneamente Acciaiuoli avrebbe allesti-to come nuova sede dell’Accademia degli Umori-sti, che si riuniva in quell’edificio dal 1600, la stan-za situata al pianterreno in angolo tra il Corso e ilvicolo del Piombo. Ciò spiegherebbe la decorazio-ne particolarmente ricca di quest’ambiente quadra-to, che presenta una volta a pianta ottagonale im-postata su semicolonne e ornata da affreschi.
59. Mi riferisco all’idea documentata dai duedisegni oggi in Firenze, Uffizi, 310A e 311A, suiquali si veda specialmente M. TAFURI, Progetto dicasa in via Giulia, Roma. 1519-1520, in Raffaelloarchitetto, a cura di C.L. Frommel, S. Ray, M. Ta-furi, catalogo della mostra (Roma, febbraio-mag-gio 1984), Milano 1984, pp. 235-240.
60. Vienna, Albertina, Az. Rom 1050a. Si trattadi una pianta di progetto per la quale è stata pro-posta un’attribuizione a Ludovico Cardi detto ilCigoli e una datazione al primo decennio del Sei-cento: M. RASPE, Gli scaloni del Borromini: palaz-zo Pamphili, palazzo di Spagna, palazzo Barberini.Con un disegno del Cigoli per palazzo del Bufalo, inFrancesco Borromini, Atti del convegno internazio-nale (Roma, gennaio 2000), a cura di C.L. From-mel, E. Sladek, Milano 2000, pp. 107-121, in par-ticolare pp. 114-117 e fig. 9.
61. Su questo edificio è ancora fondamentaleC.L. FROMMEL, Der Römische Palastbau der Hoch -renaissance, I-III, Tübingen 1973; in particolare,sul cortile, I, pp. 168-169, e II, pp. 101-103.
62. È probabile infatti che il cortile semiottago-nale realizzato in quest’edificio da De Rossi ripren-da un preesistente cortile di Della Porta di piantasemicircolare: G. POCCIMUTIBUSSI, Contributo al-la vicende architettoniche di Palazzo Muti Bussi aRoma alla luce di nuovi documenti, in «Studi di Sto-ria dell’Arte», 15, 2004, pp. 201-214; C. CONFOR-TI, L’architettura, in Palazzo Muti Bussi all’Aracoe-li, a cura di R. Di Paola, Roma 2006, pp. 85-127, inparticolare p. 113.
63. L’hôtel de Beauvais è al n. 68 dell’odiernarue François-Miron, cioè in quello che era l’ultimotratto della rue Saint-Antoine verso la chiesa diSaint-Gervais e l’Hôtel de Ville. Esternamentel’edificio conserva ancora la sua configurazioneoriginaria, pur avendo subito alterazioni prima nel1705 per mano di Robert De Cotte, quindi tra il1734 e il 1740, e infine nel 1802, quando fu adatta-to a maison de rapport. Un ulteriore pesante inter-vento è stato effettuato intorno al 2000 per ade-guarne gli spazi interni all’attuale destinazioned’uso, quella di sede del Tribunale amministrativod’Appello di Parigi. Sull’hôtel de Beauvais si veda-no soprattutto R.W. BERGER, Antoine Le Pautre. AFrench Architect of the Era of Louis XIV, NewYork, New York University Press, 1969, pp. 37-46,e le aggiornate sintesi di N. COURTIN, Paris GrandSiècle. Places, monuments, églises, maisons et hô-tels particuliers du XVIIe siècle, Paris 2008, pp.158-159, e di A. GADY, Les hôtels particuliers deParis. Du Moyen Âge à la Belle Époque, Paris 2008,pp. 198-199.
64. L’incisione fu pubblicata in J. MAROT, L’En-trée triomphante de Leurs Majestez Louis XIV, royde France et de Navarre et Marie Thérèse d’Austri-che, son éspouse, dans la ville de Paris, capitale deleurs royaumes, au retour de la signature de la paixgeneralle et de leur heureux mariage..., Paris 1662.
65. Secondo R.W. BERGER, Antoine Le Pautre,cit., p. 38, l’apparato scultoreo della facciata fu ese-guito da Nicolas Legendre e Pierre Hutinot a par-tire dal 1657. Nel 1659 il maître menuisierÉtienneCarel realizzò il ritratto della regina madre nel-l’ovato sopra il portale: A. GADY, Les hôtels parti-culiers, cit., p. 198.
66. Il fatto che nel palazzo romano sia previstosoltanto uno di questi percorsi, mentre nell’hôtelde Beauvais ne esistevano due in posizione simme-trica, si spiega semplicemente considerando che ilprogetto di Cipriani ingloba la preesistente casaMancini. Conseguentemente il percorso segreto,corrispondente al quinto asse di aperture a sinistradel portale, non può esistere simmetricamente an-che nella metà destra dell’edificio, dove la proget-tazione del nuovo arriva soltanto al terzo asse a par-tire dal portale.
67. Stoccolma, Nationalmuseum, THC 6513. 68. ASR, Disegni e Piante, coll. I, cart. 87, 563, II.69. Cfr. le lettere di Mancini citate supra nel te-
sto e alla nota 52.
Ringrazio Francesco Guidoboni e MichelaLucci per l’assistenza che, nel corso di questo stu-dio, mi hanno offerto rispettivamente a Parigi e aSubiaco.
RIFLESSI DI EDIFICI PARIGINI
IN RESIDENZE ROMANE DEL
TARDO SEICENTO: I PALAZZI
MUTI PAPAZZURRI ALLA PILOTTA
E MANCINI
Nel contributo si esaminano due palaz-zi patrizi progettati a Roma negli anni Set-tanta e Ottanta del XVII secolo, evidenzian-done le affinità, mai finora rilevate, con im-portanti hôtels particuliers costruiti a Pari-gi qualche decennio addietro. Il primo è ilpalazzo Muti Papazzurri in piazza della Pi-lotta, costruito da Mattia De Rossi tra il1675 e il 1678, dove l’inusuale pianta a cor-te aperta tra avancorpi, il portale con colon-ne binate e alcuni aspetti della decorazionederivano da modelli francesi come l’hôtelde La Vrillière, che De Rossi aveva visto neisuoi soggiorni parigini. Nel secondo casol’autore individua una serie di corrispon-denze tra il palazzo Mancini in via del Cor-so, costruito dal 1687 su progetto di Seba-stiano Cipriani, e l’hôtel de Beauvais in rueSaint-Antoine. La somiglianza tra i due edi-fici, spiegabile alla luce del soggiorno inFrancia di Cipriani, è posta in rapporto conl’importanza che l’hôtel aveva avuto nellavicenda biografica del committente, nipo-te del cardinale Giulio Mazzarino.
MEMORIES OF PARIS IN LATESEVENTEENTH-CENTURY ROMANPALAZZI:MUTI PAPAZZURRI ALLA PILOTTAANDMANCINIThe paper focuses on two patrician buil-
dings in Rome, designed in the 1670s and1680s, and highlights their as yet unidenti-fied affinities with important hôtels particu-liers built in Paris a few decades earlier. Thefirst is Palazzo Muti Papazzurri in Piazza del-la Pilotta, built by Mattia De Rossi between1675 and 1678; the unusual open courtyardbetween flanking wings, the portal withcoupled columns, and several decorative ele-ments are all inspired by French models suchas the Hôtel de La Vrillière which De Rossihad seen while staying in Paris. The authorthen identifies several similarities betweenthe Hôtel de Beauvais in rue Saint-Antoineand the second building, Palazzo Mancini inVia de Corso, built in 1687 based on a designby Sebastiano Cipriani. The similarities be - t ween the two buildings, explained by Ci-priani’s sojourn in France, are seen in re -lation to the important role played by the Hô-tel in the life of the client Filippo Mancini,nephew of Cardinal Giulio Mazzarino.
Aloisio Antinori[[email protected]]
182 Aloisio Antinori . RIFLESSI DI EDIFICI PARIGINI IN RESIDENZE ROMANE DEL TARDO SEICENTO QUADERNI DELL’ISTITUTO DI STORIA DELL’ARCHITETTURA . 60-62/2013-2014

























![[Spilimbergo] Il duomo e gli altri edifici di culto](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6312c47d5cba183dbf06cb45/spilimbergo-il-duomo-e-gli-altri-edifici-di-culto.jpg)