Francesco d'Assisi figura dell'"alter Christus". Lettura del canto XI del "Paradiso"
Transcript of Francesco d'Assisi figura dell'"alter Christus". Lettura del canto XI del "Paradiso"
A C C A D E M IA DEI FILOM ARTANI
Lectura Dantis Interamnensisdire tta da G iancarlo Rati
¡f> , PARADISO
9
Beatrice Piccarda
Giustiniano Francesco d ’Assisi
Benedetto
Scritti di
Marco Ariani, Gabriele Muresu, N ino Borsellino, Mario Cimini,
Elena Landoni
BULZONI EDITORE
Volume stampato con il finanziamento della Cassa di Risparmio di Temi e Narni S.p.a.
TUTTI I DIRITTI RISERVATI E vietata la traduzione, la memorizzazione elettronica, la riproduzione totale o parziale, con qualsiasi mezzo,
compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico. L’illecito sarà penalmente perseguibile a norma dell’art. 171
della Legge n. 633 del 22/04/1941
ISBN 978-88-7870-391-9
© 2009 by Bulzoni Editore 00185 Roma, via dei Liburni, 14
http://www.bulzoni.it e-mail: [email protected]
PARADISOBeatrice Piccarda
G iustin iano Francesco d ’Assisi
B enedetto
a cura di G i a n c a r l o R a t i
BULZONI ED ITO RE
INDICE
Marco Ariani La Sapienza Beatrice
Gabriele Muresu Piccarda e la luna
Nino BorsellinoGiustiniano imperatore: la sovranità tra forza e diritto » 89
Mario CiminiFrancesco d’Assisi, figura dell’a/ier Christus » 101
Elena LandoniBenedetto e la visio: contemplano ed esperienza » 127
pag. 9
41
7
Francesco d’Assisi, figura de\Y alter Christus
Mario Cimini
I. La figura d an tesca di San F rancesco d ’A ssisi vive poeticam ente nello spazio d e ll’X I canto del Paradiso. Al di fuori di questo am bito i riferim enti al santo n e ll’opera de ll’A lighieri sono piu ttosto m arginali e quasi “di routine” , in sistendo essi p revalen tem en te sul suo ruolo di fondatore delFOrdi-ne dei frati m inori: in ta le veste com pare già nel quarto tra tta to del Convivio, in associazione con «Santo B enedetto» , «Santo A ngustino» e «Santo D om enico»1; nel X X II canto del Paradiso è ricordato d a San B enedetto com e ultim o restau ra to re , sotto l’insegna d e ll’um iltà , de l prim itivo spirito com unitario c ris tia no: «P ier com inciò sanz’oro e sanza argento, / e io con orazione e con digiuno, / e F rancesco um ilm ente il suo convento»2. Stesso ruolo è riconosciuto per tram ite di San B ernardo, nel
1 Parlando della necessità che anche i laici si p reparino “stoicam ente” alla morte e rescindano gradualm ente i vincoli con la vita terrena, Dante commenta: «E non si puote alcuno escusare per legam e di m atrim onio, che in lunga etade lo tegna; ché non torna a religione pur quelli che a Santo Benedetto, a Santo Augustino, a Santo Francesco e a Santo Domenico si fa d ’abito e di vita sim ile, m a eziandio a buona e vera religione si può tornare in m atrim onio stando, ché Dio non volse religioso di noi se non lo cuore» (iConv., IV 28); p er le citazioni dalle opere minori di Dante facciam o riferim ento a ll’edizione: Opere minori, t. I-II, M ilano-Napoli, R icciardi, 1979.
2 Par., XXII 88-90. P er le citazioni dal poem a utilizziam o, ovviamente, il testo critico stabilito da G. Petrocchi (Milano, M ondadori, 1966-67).
101
Mario Cimini
XXXII canto, dove, al verso 35, Francesco precede — con chiara sottolineatura estimativa — gli altri due fondatori di ordini, «Benedetto e Augustino». Nella funzione di traghettatore di anime verso il Paradiso, il santo è, invece, citato nel XXVII canto de\V Inferno, quando contende ad un demone — tra l'altro senza successo — l’anim a del “consigliere di frode” Guido da Montefeltro3.
Ad ogni modo è indiscutibile che la figura di Francesco rivesta un ruolo di assoluta centralità nel sistema estetico e di pensiero della Commedia, non solo perché il poeta concentra su di essa una serie di messaggi paradigmatici che rinviano direttam ente alle profondità del suo credo religioso e della sua aspirazione a riscoprire una um anità vivificata dalla forza di un cristianesim o autentico, ma anche perché le modalità stesse della rappresentazione rivelano uno sforzo estremo di distillare nella parola poetica il senso di quel rapporto tra finito e infinito, tra terra e cielo, tra storia ed eternità che è caratteristica tutta esclusiva dell’arte “metafisica” di Dante.
L’architettura ideologico-narrativa in cui viene incastonata l’immagine del santo di Assisi è m editatissim a e prelude, nella sua sollemnitas, al complesso di valori allegorici che fa da sfondo sistematico ai canti XI e XII: nulla è casuale e gratuito in poesia, meno che mai nella poesia di Dante. Il peso della “struttura” (vecchio cruccio della critica idealistica) — vogliamo dire — è metonimico e allusivo rispetto all’importanza delle cose che il poeta vuole racchiudere in essa: uguale funzione avranno Yincipit apparentem ente digressivo del
3 «Francesco venne poi, — racconta Guido da Montefeltro - c.om’io fu’ morto / per me; ma un d’i neri cherubini / li disse: “Non portar; non mi far torto. / Venir se ne dee giù tra’ miei meschini / perché diede ’1 consiglio frodolente, / dal quale in qua stato li sono a’ crini; / ch’assolver non si può chi non si pente, / né pentere e volere insieme puossi / per la contradizion che noi consente”» (In f.X X V II 112-120). Scene come questa - di contesa di un’anima tra il santo e il diavolo — erano piuttosto frequenti nella letteratura del tempo, specie nelle sacre rappresentazioni e nelle laude.
102
Francesco d’Assisi, figura dell’aiter Christus
canto XI e l’ampia perifrasi topografica dei versi 49-54 che valgono a “dilatare” i confini fisico-simbolici del luogo natio di Francesco. Ma procediamo con ordine.
II. La dinam ica narrativa del canto XI è accuratam ente predisposta nel corso del canto X: Dante, insieme a Beatrice, è asceso quasi insensibilm ente nella sfera del sole, il cielo degli Spiriti Sapienti che, come «folgòr vivi e vincenti» fanno «corona» al poeta e alla sua compagna, girando intorno a loro per tre volte al ritmo degli ineffabili accordi celestiali. Fermatosi il movimento e cessate la danza e la musica, una delle anime - quella di Tommaso d’Aquino — accesa dallo spirito di carità che contraddistingue tutti gli esseri paradisiaci e leggendo in Dio stesso i pensieri e i dubbi del pellegrino, illustra la composizione della santa «ghirlanda». Si tratta delle anime di dodici sapienti: Alberto Magno, lo stesso Tommaso, Graziano, Pietro Lombardo, Salomone, Dionigi PAeropagita, Paolo Orosio probabilm ente, Severino Boezio, Isidoro di Siviglia, il Venerabile Beda, Riccardo da San Vittore, Sigieri di Brabante. L’elenco non è puram ente esornativo, ma, a partire dalla simbologia del numero (il dodici, risultando dalla moltiplicazione del quattro, cifra del terrestre, con il tre, cifra del divino, è stato letto come numero dell’adempimento escatologico, ossia della fecondazione della storia umana ad opera dell’incarnazione del Figlio di Dio)4, prelude a quella dialettica tra perfezione (o aspirazione alla perfezione che è implicita in ogni ricerca di sapienza) e imperfezione, tra santità e miseria morale, tra ordine e disordine, che costituisce l’ossatura portante dei canti XI e XII e si risolve, sul piano più propriam ente scrittorio, nell’intreccio di intenti celebrativi ai limiti dell’agiografia e motivi polemici.
4 Cfr. J. Freccerò, Dante. La poetica della conversione. Bologna, Il Mulino, 1989, p. 67.
103
Mario Cimini
Intanto, mentre la «gloriosa rota» riprende il suo movimento circolare al ritmo delle dolci note paradisiache, la meditazione del poeta s’insinua, quasi di necessità, nel flusso narrativo e riporta bruscamente il lettore al fosco quadro di un mondo che «mal vive», incapace di liberarsi delle sue storture e delle sue cieche passioni. Siamo finalmente all’avvio del canto XI che, dopo una terzina di deplorazione sull’«insensa- ta cura de’ mortali» schiavi dei loro «difettivi silogismi», enumera otto categorie di uomini affannati nelle loro basse occupazioni terrene: sono quelli che dissipano la loro vita e mercificano la conoscenza per scopi di guadagno, dedicandosi allo studio del diritto («iura», nella duplice versione dello ius civile e dello ius canonicum) e della medicina («amforismi»), alle carriere ecclesiastiche («sacerdozio»), oppure mirano, con mezzi leciti e illeciti, al potere («regnar per forza o p e r sofismi»), a «rubare» o ad arricchirsi con le cariche pubbliche («civil negozio»); altri ancora che ignorano qualsiasi proposito di elevazione abbrutendosi nel «diletto de la carne» o nell’ozio. Anche qui l’elencazione non è fine a se stessa: fa da contraltare, con chiara vis polemica, a quella delle anime sapienti, e già introduce antifrasticamente alla figura di Francesco, l’uomo che con il suo netto rifiuto di ogni ansia di possesso ha segnato la strada per il consapevole ritorno al dirompente messaggio di Cristo5.
5 A quanto ci consta, nella tradizione esegetica non risulta sufficientemente sottolineato lo stretto legame che unisce, in chiave appunto antifrastica, l’apertura polemica del X canto alla figura di S. Francesco. Eppure lo schema dantesco ricalca molto da vicino quello del V libro (cap. 3) dell’Arèor vitae crucifixae (1305) di Ubertino da Casale (c. 1259-1325), interamente dedicato al santo e al francescanesimo come coronamento e fructi- ficatio della storia avviata da Cristo: «Vivevano - si legge in apertura di questo capitolo - in gran numero, sul finire del quinto stato della Chiesa, giumenti di lascivia, rettili di avarizia, bestie di superbia e, a causa di costoro, la vita della chiesa pellegrina, era tutta deturpata e. perciò corrosa dalla turba ipocrita dell’eretica empietà». Ma Gesù, nonostante lo «sdegno contro la malizia della Sposa, che in gran moltitudine deviava dietro gli adulteri»,
104
Francesco d’Assisi, figura dell’aìter Christus
Compiutosi un altro giro delle anime beate, Tommaso raccoglie «riguardando ne la luce etterna» nuovi pensieri e dubbi del poeta: in particolare, avverte il suo desiderio di vedersi chiarito il senso di un inciso - «u’ ben s’impingua se non si vaneggia» — con cui ha commentato la propria appartenenza alla «santa greggia / che Domenico mena», ossia all’ordine domenicano. 11 motivo è indubbiamente pretestuoso; il significato del verso non è così criptico, e comunque non tale da richiedere una spiegazione che si dipana per i restanti 112 versi del canto. In realtà, quest’ampia digressione imperniata sulla figura del santo di Assisi si giustifica come ripresa e rilancio di un tema che pervade quasi ossessivamente l’opera dantesca: quello della esaltazione dell 'ecclesia spiritualis di contro all’imperante mondanizzazione del clero secolare e regolare. Il meccanismo affabulatorio accuratamente predisposto entra ora in piena azione, ma non smentisce le sue caratteristiche di fondo che continuano a poggiare sulla dialettica tra celebrazione della santità e riprovazione delle troppo umane debolezze.
Tommaso, con la sicurezza oratorio-teologica che compete al suo magistero di Doctor Angelicus, parte dunque da lontano e spiega che Dio stesso, «la provedenza, che governa il mondo», affinché la chiesa — argutamente indicata con una perifrasi densa di rinvìi biblici («la sposa di colui eh’ad alte grida / disposò lei col sangue benedetto»)6, - tornasse verso
nella sua infinita misericordia, si prese cura della Chiesa «suscitando in mezzo ad essa uomini di sublime verità, i quali estirparono ogni avidità, sterminarono la voluttà, ricusarono le dignità, e avevano in orrore la doppiezza, difendevano la verità, erano ardenti di carità, rinnovatori dell’onestà e imitatori in modo tutto speciale di Cristo Gesù» (citiamo dalla traduzione di F. Olgiati, L’albero della vita crocifissa di Gesù, in Fonti francescane, a cura di S. da Campagnola, Padova, Edizioni Messaggero, 1983, pp. 1687-88).
6 «ch’ad alte grida» ricalca il «clamans voce magna», il «forte grido» emesso da Gesù nell’atto della sua morte sulla croce (Matteo; 27, 50; Marco, 15, 37; Luca, 23, 46); «disposò lei col sangue benedetto» è chiaramente esemplato su: «adquisivit sanguine suo» di Atti degli Apostoli, 20, 28.
105
Mario C im ini
Cristo («lo suo diletto») rinnovando il suo tiepido amore di carità ed em endandosi dei suoi errori, consacrò per lei due condottieri che la guidassero al compimento della sua missione; fuor di metafora: S. Francesco e San Domenico. L’oratore non nomina esplicitam ente questi due «principi», ma si serve di riferimenti antonomastici che il lettore del tempo di Dante era in grado di decodificare con facilità: il primo viene indicato come il «tutto serafico in ardore», per l’intensità del suo spirito di carità, il secondo come «uno splendore» di «cherubica luce», specchio «in terra» della sapienza divina.
Siamo di fronte a due espressioni tautologiche, strutturalmente simmetriche, che sottolineano allo stesso tempo la complementarità e la diversità dei due personaggi: San Francesco è “l’ardente nell’ardore” (dacché «serafico», etimologicamente, vale “ardente”), San Domenico è invece “splendente nello splendore” («“cherubin” - si legge nel cinquecentesco commento di Trifon Gabriele - vuol dire “lucente” , che si deve proprio alla scienza»)'. Ad ogni modo, conclude Tommaso in stile perfettam ente sillogistico, le loro opere furono dirette ad un unico «fine» — ricondurre sulla strada segnata da Cristo la Chiesa e con essa l’um anità tutta - e dunque parlare dell’uno è come parlare dell’altro («d’amen- due / si dice l’un pregiando, qual c’om prende»). La logica del contrappunto vuole però che il domenicano Tommaso tessa le lodi di San Francesco e stigmatizzi le degenerazioni dell'ordi- ne domenicano; a sua volta, il francescano Bonaventura da Bagnoregio im bastirà un corrispettivo panegirico di San Domenico e non risparm ierà rampogne ai suoi confratelli.
La secolare esegesi dantesca ha ben messo in evidenza come il poeta condensi in queste terzine, con quel potente senso della sintesi di cui solo lui è capace, gli esiti letterari,
7 Cfr. Annotazioni nel Dante fa tte con M. Trifon Gabriele in Bassano, ediz. critica a cura di L. Pertile, Bologna, Commissione dei testi di lingua, 1993. p. 83.
106
«>
Francesco d’Assisi, figura dell’alter Christus
figurativi e storici di una tradizione già ampiamente consolidata al suo tempo: associare nella celebrazione Francesco e Domenico non era una novità; tra l’altro era consuetudine, nonostante i perduranti attriti, che il 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco, nei conventi francescani ci fossero predicatori domenicani a celebrare il fondatore dell’ordine, così come, il 7 agosto, nei conventi domenicani fossero i predicatori francescani a ricam biare la cortesia con apologie di San Domenico. Ma la complementarità dei due santi era un concetto che Dante raccoglieva e faceva proprio anche e soprattutto dalla letteratura mistico-profetica di matrice gioachimi- ta, che aveva preannunciato il loro avvento, o da scritti come quello di Ubertino da Casale che neWArbor vitae crucifixae - un libro di grande suggestione per il poeta - aveva chiaramente sottolineato l’equivalenza della missione dei due “campioni” della fede8.
Non direi ad ogni modo che Dante sia equidistante dai due personaggi, non tanto perché, collocando S. Francesco nella più alta schiera angelica - quella dei serafini - stabilisce in tutta evidenza una gerarchia di posizione tra l’uno e l’altro9, ma soprattutto perché delinea un’immagine del santo
8 Cfr. U. Cosmo, L’ultima ascesa, Bari, Laterza, 1936, p. 150. Cfr. L’albero della vita crocifissa di Gesù (cit., p. 1268): «A similitudine di Elia e di Enoch, splendettero specialmente Francesco e Domenico. Il primo, purificato con il carbone serafico e infiammato d’ardore celeste, sembrava incendiare tutto il mondo. L’altro invece, come cherubino disteso e proteggente, luminoso per luce di sapienza e fecondo per la parola della predicazione, risplendette luminosissimo sopra le tenebre del mondo». L’idea di una comune missione provvidenziale dei due santi, già presente nella Vita secunda di Tommaso da Celano, si ritrova anche nella Legenda S. Clarae e nella Cronica di Salimbene da Parma (cfr. Fonti francescane, cit., ad vocem).
9 Com’è noto Dante raccoglie e fa sua la classificazione “angelica” dello Pseudo-Dionigi Aeropagita (De coelesti hierarchia) per il quale, nelle gerarchie angeliche, i serafini occupano un grado più alto dei cherubini (cfr. Pseudo-Dionigi Areopagita, Gerarchia celeste, in Id., Tutte le opere, a cura di E. Bellini, trad. di P. Scazzoso, Milano, Rusconi, 1981, pp. 69-135). Il tema
107
Mario Cimini
di Assisi dai tratti marcatamente emblematici della “sua” visione del cristianesim o10, anzi quest’immagine è, per certi versi, una vera e propria “controfigura” di Cristo.
III. Il racconto della vita del santo è volutamente costruito su una logica di evidenti simmetrie con quella del Cristo, ma c’è di più: questa storia è essenzializzata, compressa secondo uno schema ben preciso, ridotta insomma a quegli elementi che nell’ottica dantesca ne condensano il messaggio più significativo e rivoluzionario, ovvero l’identificazione Francesco/Cristo sulla base del comune denominatore della povertà. Dante-Tommaso non concede quasi nulla ai particolari aneddotici che pure costituivano il nerbo dell’imponente letteratura francescana, sceglie pochi fatti - e tutti storicamente certi - della vita dell’Assisiate; ma, con magistrale coerenza, focalizza la narrazione su una prospettiva allegorico- figurale in cui le valenze pauperistiche e cristologiche sono esaltate al massimo grado. Storia e metastoria sembrano fondersi inscindibilm ente, anzi l’una presuppone l’altra ed entram be, nel loro continuum ., ci riportano all’idea medievale per la quale il tempo non è mera negazione dell’eternità, semmai ne è uno dei possibili, infiniti segmenti. Il Francesco di Dante è dunque figura storica, su cui però converge il disegno provvidenziale di Dio nella sua accezione più alta, quella di una paradossale nuova incarnazione o quantomeno di un
della classificazione angelica viene affrontato distesamente dal poeta in Paradiso, XXVIII.
10 Sono in questo perfettamente d’accordo con l’impostazione che Mario Marti ha dato ad una sua recente lettura del canto XI (Storia e ideologia nel San Francesco di Dante, in «Giornale Storico della Letteratura Italiana», fase. 598, 2005, pp. 161-79), soprattutto riguardo al fatto che il San Francesco disegnato da Dante rappresenta l’esito di una serie di «scelte di carattere ideologico» che contraddistinguono la concezione etico-politico-religiosa del poeta.
108
Francesco d’Assisi, figura dell’aiter Christus
rimateriarsi del divino nell’umano. Esprimere il senso di questa verità «per verba», con i mezzi del finito, è cosa non semplice: ma questa di dire e raccontare l’ineffabile è anche la sfida di tutta la cantica del Paradiso.
A tal fine il poeta non lesina energie attingendo agli strumenti più ardui della sua arte, a partire dal prologo sul luogo di nascita del santo: ben dodici versi che costituiscono una sontuosa perifrasi, di gusto geografico squisitam ente dantesco, per designare Assisi. Parafrasando la perifrasi, con Vittorio Sermonti, le quattro terzine si possono così commentare:
Fra il fiume Topino («Tupino») e il corso d’acqua che discende dal monte scelto [per il suo romitaggio] dal beato Ubaldo (l’«acqua» è quella del Chiascio, che nasce dal monte, o «colle», Iugino, dove appunto il beato «Ubaldo» Baldassini visse da romito prima di diventare vescovo di Gubbio, e di morire nel 1160) blandamente digrada la fertile costa di un alto monte (il Subasio), che investe «Perugia» sul versante di «Porta Sole» col freddo [dei suoi venti di neve] e col tepore [delle sue brezze estive]; mentre sul versante opposto [dello stesso Subasio] «Noeera» e «Gualdo» Tadino lamentano [le intemperie dovute a]gli scarrupati gioghi [orientali del massiccio]. Su questo versante (quello che guarda Perugia), dove il pendio è meno ripido («frange / più sua rattezza»: letteralmente: ‘maggiormente rompe la sua ripidezza’, ‘precipita meno’), venne al mondo «un sole», come il sole che presidia questo cielo spunta «talvolta» (cioè, in tempo d’equinozio) dal Gange. Perciò chi parla di questa località, non dica ‘Assisi’, ché direbbe poco e male («corto»), ma se vuole esprimersi con proprietà [...] dica Oriente11.
Il quadro può sembrare a noi moderni - non lo era per i lettori medievali - bizantino, barocco, artificioso; ma se per un attimo proviamo a trasporlo e ad attualizzarlo in un linguaggio a noi più familiare, prendiamo quello cinematografi
11 D. Alighieri, La Divina Commedia. Paradiso, lettura e commento di Vittorio Sermonti, Milano, B. Mondadori, 1996, p. 171.
109
Mario Cimini
co, non avremmo difficoltà a riconoscere che siamo di fronte ad un abile uso delle tecniche di rappresentazione (o ripresa), per cui dal “campo lungo” o “lunghissimo” la scena finisce gradualmente per focalizzarsi su un “primo piano” : l’oriente- Assisi con il suo sole nascente. E stato giustamente notato che «di questo paesaggio concreto e inquadrante, che si approfondisce misticamente nel passato e su cui sta per sorgere il nuovo sole cristiano, non è traccia nei testi che si danno come fonti dell’episodio dantesco, né, in genere, nella letteratura francescana antica, per lo più spoglia di notazioni paesistiche»12. Non è quindi azzardato affermare che l’ampia voluta a sfondo topografico sia il frutto di una creazione originalmente dantesca, concepita sì con l’obiettivo di meravigliare il lettore ma anche di prepararlo a quella conclusione arguta — Francesco è sole propizio che sorge ad oriente - che, per quanto straniante, rientrava sicuram ente nell’orizzonte d’attesa del pubblico medievale. L’immagine del santo come “quasi sol oriens''’ era canonica nell’agiografia francescana, soprattutto in quella di tendenza “spirituale” che insisteva sulla perfetta conformità della sua vita con la vita di Cristo: la si trova sostanzialmente identica in scritti come La conformità della vita del Beato Francesco alla vita del Signore Gesù di Bartolomeo da P isa13, e soprattutto nellVlrfcor vitae crucifixae di Ubertino da Casale e nella Legenda maior di San Bonaventura, ovvero in opere che costituiscono le fonti più dirette e certifi- cabili del testo dantesco.
Vero è anche che quell’immagine veniva per lo più spiegata con riferimento all’Apocalisse giovannea riconoscendo in San Francesco il profetizzato angelo del sesto sigillo, il quale, salendo ab ortu solis (dall’oriente), avrebbe recato il signum
12 G. Nencioni, Note dantesche, in «Studi Danteschi», voi. XL, Firenze, Sansoni. 1963. p. 27.
13 Cfr. Bartolomeo da Pisa, De conformitate vitae Beati Francisci ad vitam Domini Iesu. in Analecta Franciscana, Firenze-Quaracchi, 1906, tomi 1V-V.
110
Francesco d’Assisi, figura dell’aiter Christus
Dei vivi (il sigillo del Dio vivo, le stimmate)14: «secondo la veridica profezia dell’altro amico dello sposo (Gv, 3,29), l’apostolo ed evangelista San Giovanni, — scrive ad esempio San Bonaventura — egli è stato rappresentato, e non senza ragione, sotto la figura dell’Angelo che sale dall’Oriente recando il sigillo di Dio vivo. Nell’Apocalisse, infatti, all’apertura del sesto sigillo, Giovanni dice: “Vidi poi un altro angelo salire dall’oriente il quale recava il sigillo di Dio vivo” (Apoc., 7,2)»15. Ma non è fuor di luogo sottolineare, con Erich Auer- bach (uno dei più fini lettori del canto XI), che «secondo una concezione molto diffusa nel medioevo “so/ oriens” , “oriens ex alto” è Cristo stesso (secondo Luca, 1, 7 8 16 e il simbolismo della luce in alcuni passi di Giovanni); questo simbolo si fonda su miti molto più antichi del cristianesimo, che-avevano solide radici nei paesi del Mediterraneo ed erano soprattutto connessi con le nozze mistiche. [ ...] È indubbio dunque che nel paragone col sole nascente, al quale seguono subito dopo le nozze mistiche come prim a conferma della forza solare del santo, egli volesse evocare ed elaborare il motivo della conformità o imitazione di Cristo»17.
Corre l’obbligo di ricordare, tuttavia, che per qualche commentatore - il Bosco in primo luogo — tale motivo sarebbe marginale e non «determ inante»18, riducendosi esso all’unico
14 Cfr. S. da Campagnola, L'Angelo del sesto sigillo e Valter Christus. Genesi e sviluppo di due temi francescani nei secc. XIII-XIV, Roma, Pontificia Università Antoniana, 1971.
15 San Bonaventura da Bagnoregio, Legenda maior. Vita di San Francesco d ’Assisi, trad. di P. Ettorre, Assisi, Edizioni Porziuncola, 1974, p. 6.
16 L’immagine è nella profezia di Zaccaria, padre di Giovanni Battista: «[...] il Sole / ci visiterà spuntando dall’alto / per illuminare quei che giacciono / nelle tenebre e nell’ombra di morte, / per guidare i nostri passi in una via di pace». La nota è nostra.
17 E. Auerbach, Francesco d ’Assisi nella “Commedia”, in Id., Studi su Dante, Milano, Feltrinelli, 1988, pp. 231-32.
18 Notando l’assenza nel Francesco di Dante di alcuni elementi centrali nell’immagine tradizionale del santo (dall’umiltà alla «macerante preghie-
111
Mario C im ini
tema del comune amore di Cristo e Francesco verso la povertà: possiamo solo osservare che la poesia di Dante, come quella di tutti i grandi poeti, apre sempre il campo ad una molteplicità di interpretazioni e che, anzi, la sua forza sta proprio nella capacità di essere polisemica. Personalm ente sono dell'avviso che la posizione di Auerbach sia quella più convincente e densa di suggestioni non aleatorie che riconducono in maniera cogente al tessuto culturale e storico da cui germina l’opera dantesca.
IV. Torniamo ora al testo e si vedrà come il racconto segua, a partire da quella prem essa a sfondo cristologico, una serrata e consequenziale logica narrativa. Il quadro successivo segna un netto stacco cronologico rispetto alla nascita. Vi si vede un Francesco già adulto, ventiquattrenne o venticinquenne, che inizia a far sentire alla terra (come si conviene ad un sole) «de la sua gran virtude alcun conforto» e che soprattutto compie la scelta decisiva della sua vita: sposare intimamente la causa della povertà, della rinuncia estrem a e definitiva ad ogni forma di possesso, della ricerca di una dimensione esistenziale fatta al contempo di abiezione materiale e di esaltazione spirituale. Il fotogramma - in questo ben lontano dal rassicurante e quasi irenico corrispettivo affresco di Giotto nella basilica superiore di Assisi - è colto da Dante nella sua
ra», dalle «visioni» alla «castità», ecc.) Bosco conclude: «E manca quasi totalmente, infine, il carattere essenziale di Francesco, il suo essere e voler essere un nuovo Cristo, alter Christus. Delle tante conformità tra la vita del Redentore e quella del santo, così attentamente messe in rilievo dai francescani, non resta in Dante che una, quella relativa a ciò che solo stava a cuore al poeta: l’essere stato Cristo il primo mistico sposo della Povertà [...]. Nel racconto di Dante, la figura delYalter Christus rimane nello sfondo, non è centrale e determinante come nella letteratura francescana» (U. Bosco, San Francesco (XI del Paradiso), in Id., Dante vicino. Contributi e letture, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 1966, p. 334).
112
Francesco d’Assisi, figura dell’aiter Christus
dram m atica concitazione non attutita dal velo allegorico: Francesco «in guerra / del padre» (contro il volere del padre) «e dinanzi a la sua spiritai corte» (la curia episcopale di Assisi) si unisce in matrimonio con «tal donna», la Povertà, «a cui, come a la morte / la porta del piacer nessun disserra» (a cui nessuno fa lieta accoglienza, come alla morte; sebbene Auerbach abbia proposto, poco felicemente in verità, di leggere questo verso come metafora dell’atto sessuale19, ad accentuare il senso di unione carnale tra il santo e la sua amata). Il lessico guerresco-cavalleresco rimanda allusivamente alla cultura cortese che faceva da sfondo alla giovinezza di Francesco: si ricordi che egli, prima della conversione, non fu alieno da pratiche mondane come i corteggiamenti e che, per un certo periodo, fu anche cavaliere al soldo di un capitano di ventura20; ma l’“energia” del quadro ora sottolinea la sua rinnovata vocazione di combattente in nome di Cristo, e dunque, come è stato detto, egli è veramente non il «poverello» ma «il grande della povertà»21.
Credo tuttavia che l’immagine straniante del matrimonio del futuro santo con madonna Povertà contenga altri elementi profondi che, a quanto mi risulta, l’esegesi dantesca ha solo marginalmente messo in risalto. In particolare non mi sembra che si sia dato il dovuto risalto al senso di scandalo - al di là delle possibili congetture interpretative in chiave sessuale —
19 «Mi sembra molto opportuno — scrive Auerbach (op. cit, p. 233) - intendere l’apertura della porta del piacere nel senso più proprio, come fatto sessuale, spiegando “porta” come porta del corpo femminile»; ma è una interpretazione generalmente rifiutata da tutti gli esegeti del verso.
20 È un particolare che si ritrova in tutte le biografie, ufficiali e non, del santo, ma che è ampliato quanto a dettagli nella cosiddetta Legenda triurn sociorum, la Leggenda dei tre compagni (cfr. Fonti francescane, cit., pp. 1067-71); cfr., tra le biografie moderne, C. Frugoni, Vita, di un uomo: Francesco d ’Assisi, Torino, Einaudi, 2001, pp. 10-18.
21 Cfr. S. da Campagnola, Francesco di Assisi, in Enciclopedia dantesca, III, p. 18.
113
«>
Mario Cimini
che la scena indubbiam ente comunica: sposare una donna derelitta, macilenta, immaginiamo anche ripugnante, respinta, come la morte, da tutti, eppur con tutti equivocamente disponibile, sfidando le convenzioni sociali e meritando la maledizione paterna, cos’altro vorrà dire se non cercare lo scandalo, contestare ab imìs il modo di essere e di pensare comuni, demistificare un sistem a di valori o disvalori? Ma c’è di più. Dante raccoglie l’idea dell’unione tra il santo e la Povertà fatta persona dalla tradizione m istico-spirituale francescana: si è soliti citare a questo proposito il Sacrum com- mercium Sancii Francisci cum domina Paupertate, opera duecentesca di un anonimo minorità, in cui però l’impianto allegorico è talmente preponderante che l’immagine nuziale sfuma nella generica ricerca di un’alleanza tra i due soggetti (Francesco, insieme ai suoi frati, dopo una lunga ricerca incontra madonna Povertà su un alto monte e da lei ascolta la storia delle sue presenze e assenze nel mondo dagli albori del cristianesim o... il santo e i suoi compagni decidono infine di farsi suoi servi e custodi: «Ma ecco, noi siamo tuoi servi e gregge del tuo pascolo. In eterno e per tutti i secoli noi decidiamo con giuramento di custodire i tuoi precetti di g iustizia,»22). Il poeta dunque accentua, sia pure sulla base di un’altra fonte (ovvero il solito Ubertino da Casale), la m aterialità carnale dell’atto nuziale, la furente attrazione erotica di Francesco per l’amata («poscia di dì in dì l'amò più forte», recita il verso 63); con quale obiettivo? chiediamoci.
Se usciamo dalla logica metaforico-allegorica dell’episodio non avremo difficoltà ad ammettere che la scabrosità della situazione altro non è che un richiamo stringente al paradosso della condizione cristiana, rivendicata con forza e chiarezza da Cristo stesso, quel Cristo che non invita solo a spogliarsi dei beni materiali - «Se vuoi essere perfetto, - dice al gio-
22 Sacrum commercium Sancii Francisci cum domina Paupertate, traci, di C. Paolazzi. in Fonti francescane, cit., p. 1660.
114
••
Francesco d’Assisi, figura dell’aìter Christus
vane ricco - va’, vendi quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo» (Matteo, 19,21) - ma a rinunciare anche al bene ultimo, il possesso di se stessi: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, - si legge in Matteo, 16, 24 - prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la troverà». Ed ancora, in Luca, 14, 26: «Se qualcuno viene a me e non odia il padre, la madre, la moglie e i figli, i fratelli e le sorelle e anche la sua vita stessa non può essere mio discepolo». Non è un caso che questi passi dei Vangeli riempiano quasi l’intero secondo paragrafo della cosiddetta Regula non bullata (la più antica redazione della regola francescana, non sottoposta all’approvazione pontifica)23, a significare il richiamo integrale alla paradossalità della condizione cristiana.
Ecco dunque che il Francesco di Dante è l’interprete più puro e conseguente del rivoluzionario messaggio cristiano: la sua carnale immedesimazione nella povertà è il segno tangibile del suo “Christum sequi”, ed è al contempo, se giudicata con gli insufficienti strumenti della ragione umana, follia: «Et dixit Dominus michi quod volebat quod ego essem unus novellus pazzus in mundo», avrebbe urlato il santo di fronte a frati dotti e sapienti che lo invitavano ad addolcire i rigori della sua R egula2*. In quel «novellus pazzus» - un pazzo
23 Altrettanto significativo è il fatto che tali riferimenti scritturali scompaiano poi nella Regula bullata (quella approvata da Onorio III nel 1223), omissione che lascia chiaramente intendere il processo di normalizzazione della “scandalosa” proposta di vita francescana promosso dalla chiesa (cfr. Fonti francescane, cit., pp. 97-126).
24 L’espressione, attribuita a S. Francesco, figura nella maggior parte dei testi biografici a lui dedicati (dalla Legenda perusina allo Speculum per-
fectionis, dall’/lròor mine crucifixae di Ubertino da Casale al De conformita- te vitae Beati Frarwisci di Bartolomeo da Pisa). Sarebbe stata pronunciata, con forte determinazione, dal santo durante il capitolo cosiddetto “delle stuoie” (svoltosi probabilmente nella Pentecoste del 1222) in risposta alle
115
Mario C im ini
“mai visto prim a” o anche “che ha somiglianze con altra persona” - c’è tutto il senso della condizione paradossale dei veri seguaci di Cristo (per San Paolo, Corinzi 4, 10: «stulti propter Christum», “stolti a causa di Cristo”), disposti ad alienarsi, ad abbandonare qualsiasi criterio di giudizio comune, per ritrovare una comunione profonda con l’alterità di Dio.
L’ideale pauperistico come richiamo alla vera vita evangelica percorre gran parte del medioevo (specialmente a partire dall’XI-XII secolo) e trova espressione anche in movimenti di radicale contestazione della chiesa e della società (valdesi, catari, umiliati, ecc.); ma Francesco assume dal vangelo le posizioni più drastiche: nella scelta di assoluta spoliazione va vista - come ha scritto padre Gratien de Paris, uno dei maggiori storici del primo secolo francescano - «la volontà di imitare specificamente il Cristo abbandonato e crocifisso»25.
Dante condivide ed esalta al massimo grado questa visione del cristianesimo; tuttavia - mi permetto di osservare — non
sollecitazioni di frati dotti e sapienti che lo invitavano ad attenersi, nella definizione delle regole di vita della comunità francescana, a prescrizioni e criteri già istituzionali (come quelli delle regole di S. Agostino, S. Bernardo, S. Benedetto): eccone il contesto: «Fratres mei! Fratres mei! Deus vocavit me per viam semplicitatis et ostendit michi viam simplicitatis. Nolo quod nomi- netis michi regni am aliquam neque saneti Augustini, nec sancti Bernardi, nec sancti Benedicti. Et dixit Dominus michi quod volebat quod ego essem unus novellus pazzus in mundo; et noluit nos ducere Deus per aliam viam quam per istam scientiam; sed per vestram scientiam et sapientiam Deus vos confundet». Cfr. G. Miccoli, Francesco d ’Assisi. Realtà e memoria di un’esperienza cristiana, Torino. Einaudi, 1991, pp. 74-78.
25 F. Gratien. St. François d'Assise. Sa personalité, sa. spiritualité, Paris. 1944 \ p. 60. Quanto alla complessa questione “ideologica” della povertà e al rapporto di S. Francesco con essa, cfr. La povertà del secolo X II e Francesco d ’Assisi, Atti del II convegno intemazionale, Assisi, 17-19 ottobre 1974, Assisi, 1975 (in particolare il saggio di B. Manse'lli, La povertà, nella vita di Francesco d ’Assissi, pp. 255-82, ed anche la tavola rotonda. La povertà nel secolo X II e Francesco d ’Assisi, pp. 283-306). Un utile quadro storico è offerto anche da M. Mollat. I poveri nel Medioevo. Bari, Laterza, 2001.
116
Francesco d’Assisi, figura dell ’alter Christus
è un francescano nello spirito (sebbene fosse terziario dell'ordine), soprattutto perché dell’esem plare vita del santo non recepisce il senso dell’umiltà e dell’obbedienza come corollari inscindibili dal fondamentale precetto della povertà: Francesco, al contrario del poeta, non contempla la prospettiva della “ribellione” e della contestazione istituzionale nei confronti della chiesa mondanizzata perché tali prese di posizione avrebbero comportato «in qualche modo un’affermazione di sé, un ricorso ad atteggiamenti, pretese, progetti e strumenti estranei al senso profondo della “sequela Christi” »26.
Ne abbiamo un’immediata dimostrazione tornando al testo. Inscenato il matrimonio scandaloso tra Francesco e madonna Povertà, Dante opera in estrem a ma significativa sintesi un flash-back sulla storia m illenaria della sposa (versi dal 64 al 72): «Questa, privata del primo marito, [Cristo] / mil- lecent’anni e più dispetta e scura [disprezzata e negletta] / fino a costui [Francesco] si stette sanza invito»; è una vedovanza che ha dell’incredibile, non solo per la durata, ma anche in considerazione dell’assoluta e strenua fedeltà di cui la donna ha dato prova nelle sue unioni, ancor prima dell’avvento di Cristo. Due episodi che la fantasia poetica dello scrittore abilmente intreccia attingendo dal repertorio classico e da quello della letteratura francescana a lui coeva lo testimoniano efficacemente: l’essere stata trovata «sicura» nella capanna del povero pescatore epirota Amiclate da «colui ch’a tutto il mondo fé paura», ovvero Giulio Cesare (ne parla Lucano nella Farsaglia, v. 526 e sgg.) e l’essere stata «costante e feroce» (coerente e coraggiosa) nel salire con Cristo stesso «in su la croce» m entre «Maria rimase giuso». L’immagine così visivamente concreta si trova sia nel Sacrum commercium21
26 Ivi, p. 27.27 Cfr. Sacrum commercium Sancti Francisci cum domina Paupertate,
cit., p. 1640: «E persino sulla croce, il corpo ignudo, le braccia stese, le mani e i piedi conficcati al legno, tu soffrivi con Lui. e nulla appariva in Lui che gli desse maggior gloria di te».
117
Mario Cimini
che in Ubertino da Casale: «mentre la tua stessa madre, che però essa sola allora ti amò fedelmente e con affetto pieno di dolore e fu unita a tutte le tue sofferenze; mentre dunque la tua stessa madre, per l’altezza della croce era impotente a toccarti, madonna Povertà con tutte le sue penurie, come un donzello a te gratissimo, stette a te più che mai strettam ente abbracciata e congiunta intimamente al tuo dolore»28.
Il discorso di Dante-Tommaso non è però genericam ente retorico-letterario, ma contiene, sebbene in forma implicita, un chiaro atto d’accusa verso la responsabile principale della lunga segregazione della Povertà, ossia la Chiesa, la cui storia sembra disegnarsi come “rivoluzione” o meglio “rivelazione” tradita: la Chiesa è stata, come la Povertà, sposa di Cristo e dunque, escludendo una bigamia del figlio di Dio, se ne deduce una fondamentale identità tra le due spose. Tuttavia, se in «millecent’anni e più» nessuno ha avuto il coraggio di coltivare e rinnovare nella storia il senso di quella unione profonda, vuol dire che Cristo stesso è stato tradito. Era un’idea radicalissima che, non per altro, avvicinava Dante a correnti oltranziste come quella degli “spirituali” , nate nell’alveo del francescanesimo, ma evolutesi in accezione marcatamente contestataria nei confronti della “m eretrice magna” , la chiesa mondanizzata. Sempre secondo questa concezione, spezzare il circuito perverso dei tradim enti che avevano allontanato l’umanità da Dio non poteva non significare un ritorno alle origini del messaggio evangelico. San Francesco, con il suo reimmedesimarsi in Cristo, segna il punto di rottura, la frattura netta, il mutamento radicale nel corso di una m illenaria vicenda di aberrazione e preconizza l’avvento di una nuova era.
Credo, ad ogni modo, che vada sottolineato un altro elemento che ci riporta ancora una volta alla specularità Francesco/Cristo e getta luce sulla lettura che ne fa Dante: come l’in-
28 Ubertino da Casale, L'albero della vita crocifissa di Gesù, cit., p. 1700.
118
Francesco d’Assisi, figura dell’aiter Christus
carnazione del figlio di Dio non avrebbe avuto senso se non si fosse realizzata nella storia e nel tempo, così l’esistenza e l’azione di un “alter Christus” non avrebbero avuto ragion d’essere - nella prospettiva provvidenzialistica che sempre anima il pensiero medievale — se avessero trasceso e negato tout court la realtà di questo mondo; ecco perché Francesco non è un sem plice anacoreta, uno spregiatore più o meno cosciente della terra, ma è uno spirito attivo, impegnato a promuovere una profonda metànoia del genere umano.
V. La seconda parte della biografia francescana disegnata da Dante-Tommaso insiste proprio su questo carattere, pur restando fermamente ancorata al tema centrale dell’unione indissolubile tra il Santo e la Povertà; i quadri si succedono ora in rapida dissolvenza, ma la cam pitura è sempre netta. La costituzione della prima comunità francescana è rievocata così come naturale conseguenza di un amore realizzato su questa terra:
«La lor concordia e i lor lieti sembianti, amore e maraviglia e dolce sguardo facieno esser cagion di pensier santi;
tanto che ’1 venerabile Bernardo si scalzò prima, e dietro a tanta pace corse e, correndo, li parve esser tardo.
Oh ignota ricchezza! oh ben ferace!Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro dietro a lo sposo, sì la sposa piace»
{Par., XI 76-84).
Al lessico guerresco con cui il poeta ha contrassegnato l’iniziale scelta di Francesco se ne sostituisce uno fatto di «concordia», «lieti sem bianti», «amore», «dolce sguardo», «pensieri santi»; il correre «in guerra» è diventato un correre verso
119
Mario Cimini
la pace, ed anche la povertà ha cambiato volto lasciando emergere un’«ignota ricchezza», un «ben ferace». L’insistenza sull’azione dello “scalzarsi”, poi, pur giustificandosi come richiamo testuale alla Regula (o meglio aìYIntentio regulae) francescana - è Tommaso da Celano nella sua biografia del santo a narrare di una improvvisa illuminazione del neoconverso Francesco nel momento in cui ascolta, nella chiesa di S. Maria in Porziuncola, la lettura dei versetti di M atteo , 10, 9- 10: «Non prendete né oro, né argento, né moneta nelle vostre cinture; né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né calzari, né bastone»29 - sem bra materialmente sottolineare l’esigenza di aderire senza diaframmi di sorta alla terra: Francesco è nuovamente figura di Cristo nella storia, l'incarnazione della possibilità stessa del cristianesimo come realtà viva e operante.
Il quadro successivo è tutto costruito da Dante sull’ordito di immagini e stilemi raccolti dalla letteratura francescana; ma assume un rilievo del tutto proprio nel tratteggio che il poeta fa della personalità di Francesco e della collocazione
29 Tommaso da Celano (Vita di San Francesco d ’Assisi, trad. di F. Casolini, Assisi, Ediz. Porziuncola, 2003, pp. 26-27) collega esplicitamente l'episodio all'intuizione di Francesco su quale dovesse essere la sua form a vitae in ossequio al Vangelo', fattosi umilmente spiegare da un sacerdote quale fosse il senso dei versetti, il santo avrebbe esclamato: «Questo [...] è ciò che voglio, questo è ciò che chiedo, questo bramo con tutto il cuore di fare». «Si affretta perciò il padre santo, pieno di giubilo, - continua il biografo - ad adempire il salutare ammonimento, né frappone indugio a mettere devotamente, in pratica quanto ha sentito. Si scioglie immediatamente dai piedi i calzari, getta il bastone e, contento di una sola tonaca, prende una funicella in luogo di cintura.» Altre leggende (come quella dell’Anonimo di Perugia) collocano, invece, l’episodio in epoca posteriore alla costituzione del primo nucleo dei seguaci di Francesco. Cfr. G. Miccoli, op. cit., pp. 148- 82. I versi di Dante sono, tuttavia, innegabilmente vicini alla fonte di Tommaso da Celano, come rivelano anche altri particolari, in special modo il “correre” del «venerabile Bernardo» verso «tanta pace» che ricorda il passo: «frate Bernardo, volendo partecipare a tale missione di pace, corse prontamente dietro al Santo di Dio per acquistare il regno de’ cieli».
120
Francesco d ’Assisi, figura dell'aiter Christus
che la sua scelta di vita assume nel mondo. Ora egli è «padre» e «maestro», è legato stabilm ente alla sua «donna», ha responsabilità di «famiglia» e una missione da compiere che è voluta da Dio stesso e tuttavia non può non essere riconosciuta ed avallata dalla società degli uomini, dalle istituzioni che la governano e guidano. Ecco dunque che il santo chiede l’approvazione della Chiesa, e lo fa con esem plare dignità, presentandosi a Roma di fronte alla massima autorità spirituale:
«Né li gravò viltà di cor le ciglia per esser fi’ di Pietro Bernardone, né per parer dispetto a maraviglia;
ma regalmente sua dura intenzione ad Innocenzio aperse, e da lui ebbe primo sigillo a sua religione.
Poi che la gente poverella crebbe dietro a costui, la cui mirabil vita meglio in gloria del ciel si canterebbe,
di seconda corona redim ita fu per Onorio da l’Etterno Spiro la santa voglia d’esto archimandrita»
(Par., XI 88-99).
I fatti sono tutti storicamente certi: San Francesco ricevette una prima approvazione orale («primo sigillo») alla sua “form a vitae” da Innocenzo III nel 1210; la bolla pontificia che, invece, istituì l’ordine dei minori fu emessa da Onorio III nel 1223. Oggettiva, se vogliamo, è anche l’interpretazione di fondo della volontà di ortodossia del santo che, nonostante il suo radicalismo pauperistico, mai mise in dubbio la sottomissione e l’obbedienza alla Chiesa di Roma, ministra verace del sangue di Cristo attraverso l’eucaristia. Ma il segno del poeta è sempre forte: lo si vede, prima di tutto, nel disegno psicologico di una figura eroica che non ha «viltà di cuore», non teme di comparire spregevole «a meraviglia» di fronte al potente
121
•»
Mario Cimini
Innocenzo III, determ inata e regale nel sostenere la sua «dura intenzione». E direi che proprio nell’avverbio «regalmente» — ardito rovesciamento dell’humiliter della fonte bonaventuria- na30 — c’è tutto il senso della visione dantesca di San Francesco che, «come Cristo, è il più povero e disprezzato degli uomini e nello stesso tempo è un re»31.
Non va poi dimenticato che l’evidente sottolineatura che il poeta riserva al ruolo dell’istituzione ecclesiastica nel confermare e ratificare la scelta del santo rientra nella sua concezione provvidenzialistica della storia: Dante, insomma, sembra mettere a tacere per un momento i motivi polemici nei confronti della Chiesa che riaffiorano continuam ente nella sua opera (lo abbiamo visto anche nel corso di questo XI canto) per affermare la necessità e la centralità della sua missione, al di là del valore e delle debolezze degli uomini che la guidano e rappresentano. Dunque, come era necessario che la venuta e il sacrificio di Cristo si verificassero nel contesto e per opera di un impero ecumenico che concentrava in sé tutti i poteri sul genere umano, - Dante ne parla diffusamente nel De M onarchia32 e vi ritorna nel VI canto del Paradiso — allo stesso modo l’opera di un novello Cristo non poteva non essere sancita da un’istituzione, come la Chiesa di Roma, che costituiva, nel bene e nel male, la somma autorità spirituale in
30 «Giunto nella curia romana — narra San Bonaventura, (op. cit., p. 44) — e introdotto alla presenza del Sommo Pontefice, egli espose i suoi santi propositi e pregò umilmente ed instantemente, perché gli fosse approvata la suddetta regola di vita».
31 E. Auerbach, op. cit., p. 235.32 «Se dunque Cristo non avesse patito sotto un giudice ordinario, quel
la pena non sarebbe stata una punizione. E il giudice ordinario non poteva essere se non quello che avesse giurisdizione su tutto il genere umano, poiché tutto il genere umano veniva punito nella carne di Cristo, che come diceil Profeta, “portava i nostri dolori” . Ora Tiberio Cesare, di cui era vicario Pilato, non avrebbe avuto giurisdizione su tutto il genere umano, se l’impero romano non fosse stato secondo diritto» (D. Alighieri, Monarchia, a cura di B. Nardi, in Id., Opere minori, cit., p. 433).
122
Francesco d’Assisi, figura dell’aiter Christus
terra. Non è senza significato il fatto che il poeta metta da parte uno dei luoghi più noti della tradizione francescana - quello che riferiva di una diretta ispirazione e approvazione divina del santo33 — e preferisca evidenziare l’incoronazione della sua «santa voglia» ad opera deH’«Etterno Spiro» per tramite del papa («per Onorio»).
VI. Il racconto si avvia ora alla conclusione, ma non per questo viene meno quella dialettica tra cielo e terra, tra spirito e materia, tra tempo ed eternità che l’ha sorretto dall’inizio. Un episodio, apparentem ente divergente rispetto alla logica complessiva della storia, preannuncia l’eroica uscita di scena del santo: un Francesco, assetato «di martirio», predica «Cristo e li altri che ’1 seguirò» «ne la presenza del Soldan superba»; effettivamente l’Assisiate si recò in oriente nel 1219, al tempo della V crociata, incontrò il sultanto Malek al- Kamil e cercò vanamente di convertirlo alla fede cristiana. In filigrana vi si legge un nuovo capitolo dell’aspirazione a seguire le orme di Cristo, non solo per la volontà di reimmedesimarsi in lui subendone lo stesso martirio, ma anche perché il suo viaggio è, dal punto di vista storico e allegorico, un ritorno reale a quell’oriente da cui ha avuto inizio la vicenda di salvazione dell’umanità redenta dal sacrificio del figlio di Dio: «acceso di quella carità perfetta che allontana ogni timore, - scrive San Bonaventura nel capitolo dedicato ai viaggi di Francesco in terra santa - desiderava di immolarsi quale ostia vivente per il Signore, attraverso la fiamma del martirio, per
33 Pur comandando con insistenza l’obbedienza (in primo luogo alle istituzioni ecclesiastiche), nel Testamento San Francesco ribadisce chiaramente la sua diretta “illuminazione dall'Alto” : «il Signore mi ha dato di dire e di scrivere la Regola e queste parole con semplicità e purezza» (Fonti francescane, cit., p. 134). Ma anche in altri luoghi non mancano attestazioni di un rifiuto della “mediazione” (cfr. la nota 24).
123
Mario Cimini
ricam biare così l’amore a Cristo, morto per noi, e incitare gli altri ad amare il Signore»34.
Il mancato martirio per mano degli infedeli non è però che il preludio all’ultimo atto che sancisce la perfetta equiparazione del santo a Cristo, la concessione del privilegio delle stimmate. Tornato in Italia, Francesco
«nel crudo sasso intra Tevero e Arno da Cristo prese l’ultimo sigillo, che le sue membra due anni portarno»
(Par., XI 106-08).
Anche in questo frangente Dante si richiama fedelmente a San Bonaventura, sia per quanto riguarda il collegamento tra il desiderio di martirio del santo e le stimmate («non gli fu negato il merito del martirio tanto desiderato, - si legge sempre nella biografia bonaventuriana - e intanto fu riservato per un altro singolare privilegio [...]. 0 uomo veramente beato, la cui carne, anche se non colpita dal ferro del tiranno, non fu priva della rassomiglianza col divino Agnello imniolatol»)35, sia nella ripresa del termine chiave «sigillo» (le stimmate sono per San Bonaventura «i segni distintivi del Sommo Re, impressi nel suo corpo a modo di sigillo»)36. Il suo dettato è però ancora una volta ridotto all’essenziale, quasi liricam ente condensato: il poeta sorvola sulle discussioni teologiche circa la questione delle stimmate non ancora sopite al suo tempo (San Francesco fu il primo santo della storia ad avere questa particolarità, e lunghe furono le controversie tra sostenitori della loro autenticità, negatori ed anche abili manovratori
34 San Bonaventura, op. cit., p. 128.35 Ivi. p. 135.36 Ivi, pp. 176 e 188.
124
Francesco d’Assisi, figura dell’aìter Christus
interessati ad un loro uso “politico”)37, nulla concede al gusto del miracolistico e del soprannaturale, mentre l’iconografia francescana, non solo quella giottesca (affresco della basilica superiore di Assisi, tavola del Louvre, Cappella Bardi in Santa Croce, ma anche Pietro Lorenzetti nella basilica inferiore, ecc.), abbonda di serafini alati che trafiggono mani, piedi e costato del santo con i loro raggi luminosi. Del resto, egli è ben cosciente di rivolgersi ad un pubblico presso il quale la figura del santo e i particolari della sua vicenda sono ampiamente conosciuti e stabilizzati. Dunque, ridimensionate le finalità didascaliche, l’accento non poteva non cadere sull’interpretazione di quella figura e di quei particolari.
L’ultima sequenza riassum e e ribadisce, con un prevedibile ritorno al “primo piano” , il complesso dei significati attraverso cui si è venuta costituendo nel corso del canto l’immagine del santo; è il momento della morte:
«Quando a colui ch’a tanto ben sortillo piacque di trarlo suso a la mercede ch’el meritò nel suo farsi pusillo,
a’ frati suoi, sì com a giuste rede, raccomandò la donna sua più cara, e comandò che l’amassero a fede;
e del suo grembo l’anima preclara mover si volle, tornando al suo regno, e al suo corpo non volle altra bara»
(Par., XI 109-17).
Francesco, come narra S. Bonaventura, muore «nudo sulla nuda terra», segno della sua volontà estrem a di «confor-
37 Particolari per i quali non si può non rimandare aH'interessante libro di Chiara Frugoni, Francesco e l ’invenzione delle stimmate. Una storia per parole e immagini fino a Bonaventura e Giotto, Torino, Einaudi, 1993.
125
4
Mario Cimini
inaisi in tutto a Cristo crocifisso, il quale pendè dalla croce, povero dolente e nudo»38; ma la scena recupera ed esalta anche l’impianto allegorico di tutta la storia: plasticamente, il santo esala l’anima adagiato in grembo alla sua «donna», la Povertà. E una morte “scandalosa”, disumana per certi versi. E tuttavia è la morte di un uomo che rinnega solo le futili apparenze della terra, che continua a credere, con il suo “volere” e “disvolere” , con il “raccomandare” e “comandare” , - certo eroicamente - alla possibilità di rinnovare in questo mondo cristianamente il patto d’amore tra il Creatore e il creato.
Quell’uomo, per buona parte, è Dante stesso.
3 maggio 2006
38 San Bonaventura, op. cit., pp. 195-96.









































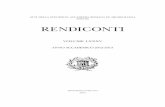




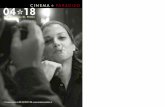



![Lettura di "Inferno XXVIII" [2013]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6320a8fcc5de3ed8a70dd3e8/lettura-di-inferno-xxviii-2013.jpg)

