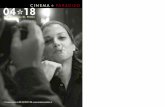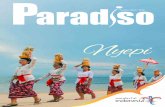Pesticide Residues in Produce Sold in Connecticut in 2012 ...
"Sicut in Paradiso Comedie iam dixi"
Transcript of "Sicut in Paradiso Comedie iam dixi"
STUDI DANTESCHI
SOCIETÀ DANTESCA ITALIANA
Fondati da Michele Barbi
Serie diretta da Enrico Ghidetti
LXXVI
IN FIRENZE, LE LETTERE – 2011
INDICE
Massimo Seriacopi, Inferno XXVII. Guido da Montefeltro eBonifacio VIII: la limitazione dell’intelletto e il sovverti-mento delle regole 1
Diego Quaglioni, «Arte di bene e d’equitade». Ancora sulsenso del diritto in Dante (Monarchia, II v 1) 27
Alfredo Perifano, Dante et l’alchimie dans les commentairesà la Comedia du XIVe au XVIe siècles 47
Marina Marietti, Dantismo machiavelliano 81
Maria Luisa Doglio, Gli studi danteschi di Giovanni Getto 97
NOTE
John A. Scott, Dante ha rivisto il testo dell’Inferno nel 1314? 115
Giuseppe Peressotti, Culto divino e virtù umane nel Purga-torio dantesco 129
Gino Casagrande, «Quando a cantar con organi si stea»(Purgatorio IX 144) 165
Alberto Casadei, «Sicut in Paradiso Comedie iam dixi» 179
Paola Allegretti, Un paratesto antico al De vulgari eloquentia:l’edizione di Trivulziano e Grenoble 199
MANOSCRITTI DANTESCHI
Prue Shaw, Un secondo manoscritto londinese della Monarchia 223
IV INDICE
RECENSIONI
Marco Cerocchi, Funzioni semantiche e metatestuali dellamusica in Dante, Petrarca e Boccaccio (C. Panti) 267
Guglielmo Gorni, Guido Cavalcanti. Dante e il suo«primo amico» (F. Furlan) 272
Valter Leonardo Puccetti, Fuga in Paradiso. Storiaintertestuale di Cunizza da Romano (P. Allegretti) 277
John A. Scott, Perché Dante? (M. Ciccuto) 281
SCHEDE E SEGNALAZIONI 287
Libri e opuscoli ricevuti (concernenti Dante e il suo tempo) 309
Notizie della Società Dantesca Italiana per l’anno 2010 315
Indice dei manoscritti 325
Indice dei nomi 327
«SICUT IN PARADISO COMEDIE IAM DIXI»*
1. Il celebre inciso di Monarchia I 12 6 – «Sicut in Paradiso Comedieiam dixi» – ha per lungo tempo suscitato perplessità, sia per la sua sostan-ziale incongruenza con il registro dell’intero trattato, quasi del tutto scevroda riferimenti autobiografici se non impliciti; sia per la sua scarsa necessitàe funzionalità, considerando anche i numerosi altri contatti con il poemache potevano ben più a ragione essere menzionati dall’autore, a cominciareda Pg. XVI 106 ss. (e ben più funzionali al discorso sono altri rinvii internisicuramente d’autore, come quello al De vulgari in Conv. I v 10); sia perchéesso si colloca piuttosto forzatamente nella sintassi del periodo:
Hoc viso, iterum manifestum esse potest quod hec libertas sive principium hoctotius nostre libertatis est maximum donum humane nature a Deo collatum – sicutin Paradiso Comedie iam dixi – quia per ipsum hic felicitamur ut homines, per ipsumalibi felicitamur ut dii (ed. Shaw, p. 355).
Ciononostante, dopo l’edizione curata da Pier Giorgio Ricci nel 1965,che ha stabilito la presenza dell’inciso già a livello di archetipo nello stem-ma da lui ricostruito, molti critici hanno ritenuto di doverlo valutare come
* Si cita la Commedia secondo l’antica vulgata, a c. di G. Petrocchi (Milano,Mondadori, 1966-1967), confrontata con la Comedia, a c. di F. Sanguineti (Firen-ze, Edizioni del Galluzzo, 2001). Per la Monarchia si fa riferimento alla nuova ed.critica a c. di P. Shaw, edita nel 2006 in versione elettronica e ora disponibile anchein quella cartacea, Firenze, Le Lettere, 2009, da cui si cita: a riscontro si è tenutala precedente ed. critica a c. di P. G. Ricci (Milano, Mondadori, 1965); per i com-menti, si sono consultati principalmente quelli a c. di G. Vinay (Firenze, Sansoni,1950), di B. Nardi (in DANTE, Opere minori, tomo II, Milano-Napoli, Ricciardi,1979), di P. Gaia (in DANTE ALIGHIERI, Opere minori, vol. II, Torino, Utet, 1986).Per le altre opere dantesche si è fatto riferimento al De vulgari eloquentia nell’ed.a c. di M. Tavoni (in DANTE ALIGHIERI, Opere, ed. dir. da M. Santagata, vol. I, Milano,Mondadori, 2011, pp. 1065-1547); alle Epistole nell’ed. commentata a c. di A.Frugoni e G. Brugnoli, in DANTE ALIGHIERI, Opere minori, tomo II cit. Ringrazioper i loro preziosi suggerimenti R. Ferri, C. Giunta, G. Indizio, L. Leoncini, G.Lotito, P. Mastandrea, G.P. Renello, M. Tavoni, P. Trovato.
ALBERTO CASADEI180
una prova evidente della stesura della Monarchia in un momento storicodiverso da quello in cui, sin da Boccaccio (cfr. § 4), essa era stata di solitoipotizzata, e cioè il 1311-13, quando Dante si avvicinò con forte impegnopersonale alla linea politica di Arrigo VII; da più parti si è quindi pensatoche la Monarchia sia stata composta o almeno rielaborata a favore di Can-grande della Scala, senza peraltro che le questioni trattate riguardino nem-meno indirettamente la posizione del Vicario imperiale dopo la morte diArrigo1.
Nella sua recente edizione critica Prue Shaw, pur modificando lo stem-ma proposto da Ricci in diversi e non secondari punti, ha confermato la
1 Per una ricostruzione del contesto storico tra il 1311 e il ’13, cfr. U. CARPI,La nobiltà di Dante, Firenze, Polistampa, 2004, specie pp. 662-671; per il periodosuccessivo all’elezione di Ludovico il Bavaro, cfr. H. THOMAS, Ludwig der Bayer(1282-1347), Kaiser und Ketzer, Regensburg, Pustet, 1993, pp. 13-225; e cfr. infra,§ 2 e n. 10. Per le ipotesi più recenti sulla genesi della Monarchia, si vedano inparticolare G. PADOAN, «Alia utilia reipublice». La composizione della «Monarchia»di Dante (1999), ora in Ultimi studi di filologia dantesca e boccacciana, a c. di A. M.Costantini, Ravenna, Longo, 2002, pp. 41-57, specie 55 ss.; G. SASSO, Dante, l’im-peratore e Aristotele, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma, Nella sedeIst. Pal. Borromini, 2002, specie pp. 183-189; E. FENZI, È la «Monarchia» l’ultimaopera di Dante? (A proposito di una recente edizione), «Studi danteschi», 72, 2007,pp. 215-238, specie 215-219. Quanto alla posizione politica di Cangrande, andràalmeno ricordato che, dopo la morte di Arrigo il 24 agosto 1313, il Vicario impe-riale fu dapprima impegnato nel consolidare il suo potere nello scontro sempre piùaspro contro Padova; dopo l’elezione di Giovanni XXII, e soprattutto dopo lascomunica del 6 aprile 1318, mirò a ottenere il ruolo di maggiore esponente delghibellinismo del Nord d’Italia, sancito dalla nomina a «capitaneus et rector socie-tatis et unionis dominorum et fidelium Imperii in Lombardia» nel dicembre diquell’anno. Ma la sua alleanza con il pretendente imperatore più lontano dall’ere-dità di Arrigo VII, ossia Federico d’Asburgo, nonché le sue progressive difficoltànella gestione dei legami con lo stesso Asburgo (che tra il 1316 e il ’20 era in buonirapporti anche con Roberto d’Angiò e con il pontefice) impediscono di individua-re un quadro storico in cui le problematiche della Monarchia possano trovareun’adeguata collocazione: si noti che Dante non prese mai posizione riguardo allalotta tra Federico e Ludovico il Bavaro, e non scrisse alcunché sulla complessa e avolte ambigua politica di Cangrande dopo la celebre allusione alla scomunica inchiusura del diciottesimo del Paradiso (vv. 124-136). Su questi aspetti, si veda ingenerale il classico H. SPANGENBERG, Cangrande della Scala (1892), trad. it. a c. diM. Brunelli e A. Volpi, Verona, Fiorini, 1992, ma soprattutto G. TABACCO, La po-litica italiana di Filippo il Bello re dei Romani, «Archivio storico italiano», 108, 1950,pp. 3-77, specie 28 ss. Specificamente sui rapporti tra Cangrande e il pontefice èpoi fondamentale ID., La casa di Francia nell’azione politica di Papa Giovanni XXII,Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1953, specie pp. 152-169.
«SICUT IN PARADISO COMEDIE IAM DIXI» 181
presenza in archetipo dell’inciso e ne ha rivendicato senza incertezze l’au-tenticità2. Ritorneremo più avanti su alcuni aspetti della situazione testuale,ma intanto è opportuno ricordare alcune considerazioni di Michele Barbiora piuttosto dimenticate:
La Monarchia si suppone composta [da N. Zingarelli, Dante, Milano, Vallardi,1899-1903] o nel 1317-18 «come vuole il Kraus per causa della bolla In nostra etfratrum, o qualche anno dopo, come sembra più ragionevole» per la famosa cita-zione sicut in Paradiso Comoedie iam dixi [...]. Ma questo inciso, ch’io avvertii esserein tutti i codici rimastici (Bull., N.S., I, 7, n. 2), può essere un’aggiunta fatta nelmargine, sia dell’autografo, sia d’altro antico manoscritto da cui i superstiti sianprovenuti, di mano del poeta, o qualche suo figliuolo, o d’altro conoscitore dell’ope-re dantesche, e passata poi nel testo tal quale o con lieve modificazione (dixit in dixi).E mi pare aggiunta piuttosto d’altri che del poeta, perché la citazione del Paradiso inquel trattato e per un tale particolare e a quel modo mi pare sconveniente. Posterio-re al Convivio la Monarchia a me par di sicuro, e anche all’epistola ai Principi e Si-gnori d’Italia; ma non vedo la necessità di farla scendere sino al 1317: non ha nientedi occasionale, e dové bastare l’opposizione fatta ad Arrigo VII e la mala riuscita dellasua impresa per fare che Dante rivolgesse la sua mente a quell’argomento3.
Pur essendo convinto che l’inciso sia presente «in tutti i codici rima-stici»4, Barbi lo considera interpolato in data molto alta, addirittura a operadi uno dei figli (o comunque, potremmo aggiungere, da parte di qualcunoche aveva interesse a far riconoscere il testo come dantesco). L’ipotesi meritaancora notevole considerazione, perché permette di considerare dalla giu-sta angolatura numerose incongruenze, a partire da quelle relative alla da-tazione del trattato. Per poterla meglio giustificare, però, occorre innanzi-tutto esaminare i riferimenti testuali che possono fornire elementi riguardoalla genesi della Monarchia; sulla base di tutte le evidenze esterne al testo
2 Si veda l’ed. Shaw, cit., pp. 9-14 e 208-212. Ma sul problema in esame avevagià posto importanti questioni, recensendo la versione elettronica dell’ed. Shaw, P.CHIESA, L’edizione critica elettronica della «Monarchia»: la filologia informatica allaprova dei fatti, «Rivista di studi danteschi», 7, 2007, lug.-dic., pp. 325-354, speciepp. 334-341, su cui torneremo più avanti. Altre considerazioni sono svolte dallostesso Chiesa nella recensione all’edizione cartacea del 2009 (ivi, 9, 2009, pp. 398-408). Cfr. anche nota 4.
3 M. BARBI, Problemi di critica dantesca. Prima serie (1893-1918), Firenze, San-soni, 1934, pp. 68 s., n. 1 (la recensione al volume di Zingarelli risale al 1904).
4 Ma bisogna invece considerare che nella princeps, uscita a Basilea «per Ioan-nem Oporinum» nel 1559 (= K), l’inciso non compare, e che il manoscritto dellaCapitolare di Lucca Feliniano 224 (= F) lascia uno spazio bianco e non trascrive iltesto, mentre in quello della Vaticana Pal. lat. 1729 (= P) il copista Francesco Pien-dibieni ha riportato solo la parte conclusiva «comedie iam dixi». Cfr. ed. Shaw,cit., p. 355.
ALBERTO CASADEI182
attualmente disponibili, occorre poi ricostruire il contesto storico in cuil’inciso può essere stato scritto da Dante o da altri; infine, occorre valutarel’ipotesi più economica fra quella che vorrebbe l’inciso presente nell’origi-nale, e quella che invece lo considera un’interpolazione intervenuta a livel-lo di archetipo: ricostruzioni, in teoria, entrambe plausibili.
2. Per la complessa questione della data di stesura della Monarchia, sinoall’uscita dell’edizione Ricci è stato considerato importante se non decisivoun passo del primo capitolo del II libro:
«Quare fremuerunt gentes, et populi meditati sunt inania? Astiterunt regesterre, et principes convenerunt in unum, adversus Dominum et adversus Cristumeius. Dirumpamus vincula eorum, et proiciamus a nobis iugum ipsorum».
Sicut ad faciem cause non pertingentes novum effectum comuniter admira-mur, sic, cum causam cognoscimus, eos qui sunt in admiratione restantes quadamderisione despicimus. Admirabar equidem aliquando romanum populum in orbeterrarum sine ulla resistentia fuisse prefectum, cum, tantum superficialiter intuens,illum nullo iure sed armorum tantummodo violentia obtinuisse arbitrabar. Sedpostquam medullitus oculos mentis infixi et per efficacissima signa divinam provi-dentiam hoc effecisse cognovi, admiratione cedente, derisiva quedam supervenitdespectio, cum gentes noverim contra romani populi preheminentiam fremuisse,cum videam populos vana meditantes, ut ipse solebam, cum insuper doleam regeset principes in hoc unico concordantes: ut adversentur Domino suo et Uncto suo,romano principi. Propter quod derisive, non sine dolore quodam, cum illo clama-re possum pro populo glorioso, pro Cesare, qui pro Principe celi clamabat: «Qua-re fremuerunt gentes, et populi meditati sunt inania? Astiterunt reges terre, etprincipes convenerunt in unum, adversus Dominum et adversus Cristum eius».Verum quia naturalis amor diuturnam esse derisionem non patitur, sed, ut sol esti-vus qui disiectis nebulis matutinis oriens luculenter irradiat, derisione omissa, lu-cem correctionis effundere mavult, ad dirumpendum vincula ignorantie regumatque principum talium, ad ostendendum genus humanum liberum a iugo ipso-rum, cum Propheta sanctissimo me me subsequenter hortabor subsequentia su-bassummens: «Dirumpamus» videlicet «vincula eorum, et proiciamus a nobis iu-gum ipsorum» (Mon. II 1 1-5, ed. Shaw, pp. 365 s.).
Un’interpretazione puntuale del passo era stata fornita nel 1950 daGustavo Vinay, il quale sosteneva che
è vero che Dante non è molto ligio alla ‘consecutio temporum’, ma tra questaconstatazione e l’elevare una saltuaria libertà sintattica a canone ermeneutico, ilpasso è lungo. [...] quando Dante vuol far capire che si riferisce al passato, adope-ra un infinito perfetto («fremuisse») e un verbo indicante conoscenza («noverim»);se subito dopo usa un verbo che significa invece ‘vedere’ («cum videam») e unparticipio presente («meditantes»), si deve ragionevolmente credere che non haaffatto voluto riferirsi al passato, anzi che ha inteso contrapporre il presente alpassato, ravvicinando ai tempi in cui – come narran le storie («noverim») – i popo-
«SICUT IN PARADISO COMEDIE IAM DIXI» 183
li si ribellavano all’impero di Roma, i tempi suoi in cui con i propri occhi («vide-am») gli tocca assistere al triste («doleam») spettacolo di re e principi che invecedi trovare motivo d’accordo nella giustizia, lo trovano nella comune colpevolevolontà di combattere l’imperatore («in hoc unico concordantes»)5.
L’interpretazione di Vinay è condivisibile, ma va ancor meglio esplici-tato che, per una una buona coerenza testuale (data l’indubbia concordan-za al presente, nella consecutio, delle temporali «cum videam...», «cuminsuper doleam...»), si deve considerare il «supervenit» della principale unpresente (come il successivo «possum») anziché un perfetto, come è statofatto sinora in quasi tutte le traduzioni del trattato: e la costruzione dipostquam+perfetto con principale al presente è riscontrabile, per esempio,nel seguente passo del De vulgari eloquentia:
Postquam non omnes versificantes sed tantum excellentissimos illustre utivulgare debere astruximus, consequens est astruere utrum omnia ipso tractandasint aut non; et si non omnia, que ipso digna sunt segregatim ostendere6.
Certo, con la lettura ‘superv�nit’ si perde una clausola interna con tar-dus, ma l’uso del cursus nella Monarchia è notoriamente assai meno siste-matico rispetto alle Epistole e non può risultare nemmeno in questo casodiscriminante7. Comunque, persino interpretando la forma verbale comeun perfetto, l’intero capoverso risulta logicamente plausibile solo se si ipo-tizza una situazione storica precisa e attuale di rivolta contro il «principeromano», nella quale l’autore della Monarchia può effettivamente agire ecombattere, grazie alla sua retta conoscenza, per sconfiggere l’ignoranza cheha condotto molti alla ribellione contro l’imperatore e, in ultima istanza,contro Dio stesso. Che ciò, appunto storicamente, corrisponda al contesto
5 Cfr. ed. Vinay, cit., pp. XXXIV-XXXVI: XXXV. Significativa la scelta della citazio-ne in avvio ricavata dal Salmo II (vv. 1-3), commentato molto frequentemente nellapubblicistica medievale soprattutto in riferimento a gravi contrasti nella cristiani-tà: per un inquadramento di queste citazioni nel novero di quelle bibliche anchedel Convivio, cfr. C. VASOLI, La Bibbia nel «Convivio» e nella «Monarchia» (1986),poi in Otto saggi per Dante, Firenze, Le Lettere, 1995, pp. 65-81, specie 74 s. Cfr.anche E. BRILLI, Reminiscenze scritturali (e non) nelle epistole politiche dantesche,«La Cultura», 45, 2007, 3, pp. 439-455.
6 DVE II 2 1, ed. Tavoni, pp. 1378 s. Per l’interpretazione di ‘supervenit’ comepresente, cfr. R. LA TERRA BELLINA, Mon. II, i: note per la datazione, «Pensiero politicomedievale», 1, 2003, pp. 41-45.
7 Cfr. P. V. MENGALDO, Dante e il «cursus» (1970), in Linguistica e retorica diDante, Pisa, Nistri-Lischi, 1978, pp. 263-280, specie 272 s.; L. LEONCINI, La ‘con-cinnitas’ nella prosa di Dante. Da Cicerone ad Agostino, al di là (e al di qua) dell’‘arsdictaminis’, «Aevum», 81, 2007, 2, pp. 523-557.
ALBERTO CASADEI184
creatosi in Italia tra il 1311 e il 1312 non è dubitabile, mentre nulla di si-mile si può addurre a riscontro per quello compreso fra la duplice elezionedi Ludovico il Bavaro e Federico d’Asburgo del 19-20 ottobre 1314 e lamorte di Dante (cfr. n. 1).
Continuiamo però nell’analisi dei riscontri testuali. Il passo appena citatoviene di solito posto a confronto molto cursoriamente con un altro di pocosuccessivo, nel capitolo decimo (secondo la partizione attuale) sempre delII libro:
Usque adhuc patet propositum per rationes que plurimum rationalibus prin-cipiis innituntur; sed ex nunc ex principiis fidei cristiane iterum patefaciendum est.Maxime enim fremuerunt et inania meditati sunt in romanum Principatum qui ze-latores fidei cristiane se dicunt; nec miseret eos pauperum Cristi, quibus non so-lum defraudatio fit in ecclesiarum proventibus, quinymo patrimonia ipsa cotidierapiuntur, et depauperatur Ecclesia dum, simulando iustitiam, executorem iustitienon admittunt. Nec iam depauperatio talis absque Dei iudicio fit, cum nec paupe-ribus, quorum patrimonia sunt Ecclesie facultates, inde subveniatur, nec ab offe-rente Imperio cum gratitudine teneantur. Redeunt unde venerunt: venerunt bene,redeunt male, quia bene data, et male possessa sunt. Quid ad pastores tales? Quidsi Ecclesie substantia defluit dum proprietates propinquorum suorum exaugean-tur? Sed forsan melius est propositum prosequi, et sub pio silentio Salvatoris no-stri expectare succursum (Mon. II 10 1-3, ed. Shaw, pp. 397 s.; cors. nostro).
Questo incipit è quanto mai significativo, perché riconduce alla stessasituazione descritta nel primo capitolo: lo segnala la ripresa, con leggerevariationes, di alcuni vocaboli presenti nei versetti del Salmo II («fremue-runt et inania meditati sunt»), con la specificazione che, contro il «roma-num Principatum» combattono soprattutto quelli che «zelatores fidei cri-stiane se dicunt»8. E che l’intero passo alluda, ancora una volta in modopiuttosto velato, alla condizione storica in cui vive l’autore, lo suggerisce lachiusa, formulata retoricamente come la fine di una digressione dovuta aun’urgenza di tipo personale (non certo alla volontà di rievocare un lonta-
8 Il contesto è delineato come di consueto in termini allusivi, e si potrà pensa-re a un riferimento ai pontefici, come fa Nardi (op. cit., p. 425), seguito con ulte-riori esempi da Gaia (op. cit., p. 678), che ricorda anche i «pastori predoni» diClemente V; fra gli «zelatores» peraltro potrebbero anche essere compresi rapacisostenitori del papa come i guelfi fiorentini, sebbene il successivo appellativo di«pastores» indebolisca l’ipotesi. Va però notato che il termine in questione (chericorre pure in I 12 9) aveva una valenza anche politica, dato che ricorreva per esem-pio in documenti di sostenitori di Arrigo VII: «et ipsi [i piacentini], sacri imperiizellatores, eius [di Arrigo] adventum laudant et affectant»: in Acta Henrici VII...,a c. di F. Bonaini, parti 2, Firenze, M. Cellini, 1877, I, p. 23 (doc. XVII del 22-26giugno 1310).
«SICUT IN PARADISO COMEDIE IAM DIXI» 185
no passato): «Sed forsan melius est propositum prosequi...». Si noti ancheche la dichiarazione di voler attendere l’aiuto del Salvatore («et sub piosilentio Salvatoris nostri expectare succursum»), ancorché in parte formu-lare, dà senso se tale soccorso è ancora utile, ovvero se l’Imperatore puòrisolvere a proprio favore la lotta contro i suoi avversari.
Ma, al di fuori della Monarchia, esiste un altro riferimento che non èstato confrontato in modo puntuale con i precedenti, ed è il seguente, ri-cavato dall’Epistola ai Fiorentini ‘intrinseci’:
Vos autem divina iura et humana transgredientes, quos dira cupiditatis inglu-vies paratos in omne nefas illexit, nonne terror secunde mortis exagitat, ex quo,primi et soli iugum libertatis horrentes, in romani principis mundi regis et Dei mi-nistri, gloriam fremuistis, atque iure prescriptionis utentes, debite subiectionis of-ficium denegando, in rebellionis vesaniam maluistis insurgere?9
La vicinanza ai passi di Mon. II 1 e 10 è garantita dalla presenza del«fremuistis», dato che il verbo ‘fremere’ in testi latini di Dante ricorre soloin questi luoghi. Ma per di più è il contesto a risultare del tutto congruo,essendo in corso una ribellione pazza e oltraggiosa contro il ‘principe ro-mano’, qui definito, con minime varianti rispetto alla Monarchia, «mundirex et Dei minister». E qui si possono riprendere alcune considerazionispecifiche sul contesto creatosi fra la fine del 1310 e l’inizio del 1311. Comesi ricava facilmente rileggendo l’ampia messe di documenti raccolti da Bo-naini negli Acta Henrici VII, l’accoglienza riservata all’Imperatore è stataentusiastica o quanto meno corretta sino alle prime decisioni concrete, ancheriguardo alle discordie fra guelfi e ghibellini in varie città dell’Italia setten-trionale e a Firenze. Quest’ultima, a partire dal periodo immediatamentesuccessivo all’incoronazione milanese (6 gennaio 1311), cominciò una frondadapprima coperta e poi esplicita, al punto da organizzare, alla fine del mesedi marzo, un parlamento di delegati dei comuni guelfi, evento ormai deltutto ostile ad Arrigo: proprio in quel momento Dante scrive la sua episto-la, datata 31 marzo 1311, nella quale mette in rilievo, con toni da profetabiblico, il ruolo specifico che Firenze sta assumendo come principale op-positrice dell’Imperatore10.
9 Cfr. Epist. VI, § 2 (cors. nostro): op. cit., pp. 552 s., anche per il commento. Peruna ricostruzione del contesto della lettera, cfr. G. INDIZIO, Dante secondo i suoi antichi(e moderni) biografi: saggio per un nuovo canone dantesco, «Studi danteschi», 70, 2005,pp. 237-294, specie 288 ss. Per altri puntuali riscontri tra le epistole e il trattato, cfr.E.G. PARODI, Poesia e storia nella “Divina Commedia”, n. ed. a c. di G. Folena e P.V.Mengaldo, Vicenza, Neri Pozza, 1965, pp. 315-321. Cfr. anche la nota successiva.
10 Cfr. Acta Henrici VII..., cit., specie II, pp. 17-23 (e si noti che, nei documentidal 1° aprile 1311, Arrigo VII viene spesso indicato come «rex Alamaniae», anzi-ché come imperatore o rex Romanorum). Cfr. anche R. DAVIDSOHN, Storia di Firen-ze (1896-1908), trad. it. Firenze, Sansoni, 1960, vol. III, p. 595.
ALBERTO CASADEI186
Ma le obiezioni mosse da Dante alla condotta dei fiorentini toccanoanche esplicitamente questioni di diritto (‘publica iura’) e in particolare lanecessità di evitare ogni forma di cupidigia personale per salvaguardare il benedella ‘cosa pubblica’. Si legge ancora nel secondo capoverso dell’Epistola:
An ignoratis, amentes et discoli, publica iura cum sola temporis terminationefiniri, et nullius prescriptionis calculo fore obnoxia?
Nempe legum sanctiones alme declarant, et humana ratio percontando decer-nit, publica rerum dominia, quantalibet diuturnitate neglecta, nunquam possevanescere vel abstenuata conquiri; nam quod ad omnium cedit utilitatem, sineomnium detrimento interire non potest, vel etiam infirmari; et hoc Deus et naturanon vult, et mortalium penitus abhorreret adsensus.
Quid, fatua tali oppinione summota, tanquam alteri Babilonii, pium deseren-tes imperium nova regna temptatis, ut alia sit Florentina civilitas, alia sit Romana?Cur apostolice monarchie similiter invidere non libet, ut si Delia geminatur in celo,geminetur et Delius?11
Pur in mancanza di riscontri puntuali, è indubbio che la precedenteriflessione concorda con quanto sostenuto nel trattato, e in un certo sensotrova il suo argomento teorico in Mon. II 5 1-5, di cui si veda soprattuttoil passo conclusivo:
Quicunque preterea bonum rei publice intendit, finem iuris intendit. Quodqueita sequatur sic ostenditur: ius est realis et personalis hominis ad hominem propor-tio, que servata hominum servat sotietatem, et corrupta corrumpit – nam illa Di-gestorum descriptio non dicit quod quid est iuris, sed describit illud per notitiamutendi illo –; si ergo definitio ista bene «quid est» et «quare» comprehendit, etcuiuslibet sotietatis finis est comune sotiorum bonum, necesse est finem cuiusqueiuris bonum comune esse; et inpossibile est ius esse, bonum comune non inten-dens. Propter quod bene Tullius in Prima rethorica: semper–inquit ad utilitatemrei publice leges interpretande sunt. Quod si ad utilitatem eorum qui sunt sub legeleges directe non sunt, leges nomine solo sunt, re autem leges esse non possunt:leges enim oportet homines devincire ad invicem propter comunem utilitatem.Propter quod bene Seneca de lege cum in libro De quatuor virtutibus, «legemvinculum» dicat «humane sotietatis». Patet igitur quod quicunque bonum reipublice intendit finem iuris intendit. Si ergo Romani bonum rei publice intende-runt, verum erit dicere finem iuris intendisse. Quod autem romanus populus bo-num prefatum intenderit subiciendo sibi orbem terrarum, gesta sua declarant, inquibus, omni cupiditate summota que rei publice semper adversa est, et universalipace cum libertate dilecta, populus ille sanctus pius et gloriosus propria commoda
11 Ibid. Una piccola nota sulla singolare risonanza fonica, emersa da una me-moria interna interlinguistica, che si evince dal confronto fra «geminatur in celo»e il «geminato cielo» della canzone Io son venuto..., v. 3.
«SICUT IN PARADISO COMEDIE IAM DIXI» 187
neglexisse videtur, ut publica pro salute humani generis procuraret. Unde recte illudscriptum est: «Romanum imperium de Fonte nascitur pietatis»12.
L’epistola, si diceva, è esplicitamente datata 31 marzo 1311. Vista laperfetta sovrapponibilità delle evidenze storiche rintracciabili e delle que-stioni teoriche affrontate nella lettera e nel trattato, è verosimile che la ste-sura dei passi della Monarchia sopra citati non sia di molto lontana da quelladata: essendo le rivolte contro Arrigo aumentate progressivamente nel corsodel 1311, non occorre pensare all’opposizione successiva alla sua incorona-zione il 29 giugno 131213. Comunque, l’allusività della Monarchia si sostan-zia se posta a riscontro con le vicende cui esplicitamente si riferisce l’Epi-stola ai Fiorentini ‘intrinseci’: solo fra il 1311 e il ’12 (o al massimo, mameno probabilmente, i primi mesi del ’13) il contesto storico si configuracome Dante lo delinea nel trattato e nella lettera.
3. Un altro passo che è stato reinterpretato di recente anche per propor-ne una nuova datazione è il seguente, posto quasi in chiusura del trattato:
[...] opus fuit homini duplici directivo secundum duplicem finem: scilicetsummo Pontifice, qui secundum revelata humanum genus perduceret ad vitamecternam, et Imperatore, qui secundum phylosophica documenta genus humanum
12 Per il commento cfr. VINAY, op. cit., pp. 130-135, specie 134. Si veda anche,per una ricostruzione delle fonti, TH. SILVERSTEIN, On the Genesis of «De Monar-chia» II, v, «Speculum», 13, 1938, 3, pp. 326-349. Per alcuni confronti fra il tratta-to, il poema e l’Epistola V ai Re e ai signori d’Italia (op. cit., pp. 540-549), cfr. daultimo G. MURESU, «Monarchia», «Epistole», «Commedia»: una perfetta circolarità,«Letture classensi», 38, 2009, specie pp. 102-106. Cfr. anche V. RUSSO, Impero estato di diritto. Studio su «Monarchia» ed «Epistole» politiche, Napoli, Bibliopolis,1987, specie pp. 30 ss.
13 È già stato assodato dagli interpreti del passo che il termine ‘Uncto’ si puòriferire all’imperatore anche prima di quella data: si veda p.e. il commento di Vi-nay, cit., p. xxxvi, n. 29. Del resto, l’unzione poteva essere già stata concessa sindall’incoronazione di Milano del 6 gennaio 1311, ed era prevista per il successivo15 agosto, come testimonia la missiva di Clemente V del 19 giugno di quell’anno(lettere comuni, n. 7181), nella quale appunto «Praescribitur forma coronationisHenrici regis Romanorum»; ben difficilmente, da questo punto di vista, la fallimen-tare incoronazione romana del 1312 poteva servire a giustificare meglio l’appella-tivo (cfr. anche n. 18). D’altronde, proprio scrivendo ad Arrigo il 17 aprile 1311,Dante non si era trattenuto dal rivolgersi all’Imperatore come nuovo «Agnus Dei»,espressione dalle ancora più forti implicazioni cristologiche (cfr. Epist. VII, § 2, op.cit., p. 564). Cfr. anche F. GAGLIARDI, L’«alto Arrigo» nelle epistole dantesche del1310-11. Modelli biblici e classici, «La Cultura», 45, 2007, 1, pp. 133-142, specie135-138.
ALBERTO CASADEI188
ad temporalem felicitatem dirigeret. Et cum ad hunc portum vel nulli vel pauci, ethii cum difficultate nimia, pervenire possint, nisi sedatis fluctibus blande cupidita-tis genus humanum liberum in pacis tranquillitate quiescat, hoc est illud signumad quod maxime debet intendere curator orbis, qui dicitur romanus Princeps, utscilicet in areola ista mortalium libere cum pace vivatur. Cumque dispositio mundihuius dispositionem inherentem celorum circulationi sequatur, necesse est ad hocut utilia documenta libertatis et pacis commode locis et temporibus applicentur,de curatore isto dispensari ab Illo qui totalem celorum dispositionem presentiali-ter intuetur. Hic autem est solus ille qui hanc preordinavit, ut per ipsam ipse pro-videns suis ordinibus queque connecteret. Quod si ita est, solus eligit Deus, solusipse confirmat, cum superiorem non habeat. Ex quo haberi potest ulterius quodisti qui nunc, nec alii cuiuscunque modi dicti fuerint «electores», sic dicendi sunt:quin potius «denuntiatores divine providentie» sunt habendi. Unde fit quod ali-quando patiantur dissidium quibus denuntiandi dignitas est indulta, vel quia om-nes vel quia quidam eorum, nebula cupiditatis obtenebrati, divine dispensationisfaciem non discernunt. Sic ergo patet quod auctoritas temporalis Monarche sineullo medio in ipsum de Fonte universalis auctoritatis descendit: qui quidem Fons,in arce sue simplicitatis unitus, in multiplices alveos influit ex habundantia boni-tatis (Monarchia, III 16 10-15, ed. Shaw, pp. 435 s.).
Il punto essenziale è quello relativo all’espressione «isti qui nunc»,riferita a coloro che sono chiamati «electores», ovvero i sette grandi elettorigermanici dell’Imperatore. Per primo Maurizio Palma di Cesnola, nel 1998,seguito, con alcuni distinguo, da Carlo Dolcini e altri14, ha riferito l’espres-sione a un evento in corso, ossia l’elezione del successore di Arrigo VII, cheebbe un andamento assai travagliato nell’ottobre del 1314. L’ipotesi è sug-gestiva, ma creerebbe un’immediata difficoltà materiale: se il riferimentofosse contingente, appena terminata l’elezione il testo avrebbe dovuto es-sere corretto; solo ipotizzando, come fa Palma di Cesnola, che la Monar-chia sia una sorta di ‘instant book’, concepito interamente nel 1314, sipotrebbe sostenere che l’espressione avrebbe avuto un riscontro effettivo.Ma, a parte quanto detto sopra a proposito di Mon. II 1 e 10, e a parte ilfatto che di una diffusione immediata della Monarchia nel 1314 non si haalcuna riprova esterna (cfr. § 4), non si comprende davvero a quale scopoDante avrebbe dovuto produrre un trattato così complesso (e non, magari,un’epistola analoga a quella ai Cardinali italiani, che risulterebbe più o menocoeva), proprio mentre la carica di imperatore era vacante, non essendo certo
14 Cfr. M. PALMA DI CESNOLA, «Monarchia». La datazione intrinseca (1998), inQuestioni dantesche. «Fiore», «Monarchia», «Commedia», Ravenna, Longo, 2003,pp. 43-62; C. DOLCINI, Sul tempo della «Monarchia»: ?-1314, «Pensiero politicomedievale», 2, 2004, pp. 33-39 (e anche ID., Per la cronologia del trattato politicodantesco. Risposta a Enrico Fenzi, ivi, 5, 2007, pp. 145-150).
«SICUT IN PARADISO COMEDIE IAM DIXI» 189
questione all’ordine del giorno, in quel torno di tempo, la distinzione deipoteri che è alla base della disquisizione dantesca15.
Inoltre, il contesto in cui l’espressione si inserisce fa intuire, in filigra-na, che qui Dante ha presenti non tanto le dispute in corso, che porterannoalla duplice elezione di Ludovico il Bavaro e Federico d’Asburgo, bensìquelle che da oltre un secolo, precisamente dal 1198 (quando vi fu pureuna scissione fra gli elettori di Filippo di Svevia e di Ottone IV), tormen-tavano spesso (si noti l’«aliquando» di III 16 14) le elezioni degli Impera-tori: solo nel 1273 si ebbe un primo tentativo di applicare il Codice sassone,che individuava i sette grandi elettori nei tre arcivescovi di Magonza, Co-lonia e Treviri, nei conti palatini del Reno, nel duca di Sassonia, nel mar-gravio di Brandeburgo e nel re di Boemia, ma il loro «alto ufficio» fu co-munemente riconosciuto solo dal 1300, e la procedura ebbe applicazionein particolare proprio dall’elezione di Arrigo del 27 novembre 1308, segui-ta dall’incoronazione del 6 gennaio 130916. L’accento quindi batte sulladifferenza fra il sistema elettivo dell’inizio del XIV secolo e quelli dei de-cenni precedenti: il meccanismo ‘nuovo’ dei sette elettori poteva creareancora dubbi o contestazioni – e non a caso, lo stesso Dante nell’epistolaall’Imperatore gli si rivolge come se fosse suo diritto nominare come suc-cessore il figlio per consuetudine ereditaria17.
15 Riguardo all’Epistola ai Cardinali italiani, ascrivibile a un periodo di pocosuccessivo all’inizio (1 maggio 1314) del conclave tenutosi a Carpentras per eleg-gere il successore di Clemente V, e comunque prima dell’allontanamento di queicardinali (14 luglio 1314), si vedano il testo e il commento cit. (pp. 580-593): da essise ne evince una serie esplicita di apostrofi, volte a spronare i cardinali più influen-ti a una specifica azione contro il «Vasconum obproprium» (cfr. §§ 10-11, pp. 588ss.), con un chiaro intento di incidere sulle scelte effettive (viceversa in nessun modoriconoscibile nel capitolo finale del trattato). Si noti comunque che gli evidenti trattiin comune con i canti finali del Purgatorio (basti pensare qui allo «Sponse vehi-culum», § 4.6, p. 582 e al «triunfal veiculo» di Pg. XXXII 119) non sembrano darluogo a evidenti autocitazioni (ma su questi rapporti si tornerà in altra sede). Perfondate obiezioni ai riferimenti individuati da Palma di Cesnola (op. cit., pp. 54-58) alle decretali Romani Principes e Pastoralis cura di Clemente V (14 marzo 1314),si veda ancora DOLCINI, Sul tempo..., cit., pp. 36 ss.
16 Cfr. in particolare A. WOLF, Die Entstehung des Kurfürstenkollegs 1198-1298.Zur 700-jährigen Wiederkehr der ersten Vereinigung der sieben Kurfürsten, Idstein,Schulz-Kirchner, 1998, nonché, per altra bibliografia, la sintetica ma precisa voceElezione imperiale di E. Schubert, nel sito http://www.treccani.it/Portale/elements/categoriesItems.jsp?pathFile=/BancaDati/ Federiciana/VOL01/FEDERICIANA_VOL01_000176.xml.
17 Si veda Epist. VII § 5: op. cit. p. 568 («Iohannes namque, regius primogenitustuus et rex, quem, post dici orientis occasum, mundi successiva posteritas presto-
ALBERTO CASADEI190
È insomma più plausibile considerare l’«isti qui nunc» come un rife-rimento ai ‘nuovi’ elettori, da distinguere rispetto agli elettori che, a variotitolo, avevano operato nel passato più o meno recente per la nomina del-l’Imperatore, compresi nella formula «alii cuiuscunque modi dicti fuerint“electores”». Ma che, per il passo sopra citato, non si debba necessaria-mente pensare al 1314 sembra più che probabile, e anzi lo stesso richiamoalla pacificazione, vero Leitmotiv di molti testi danteschi databili a partiredal 1311, nonché il celebre e controverso appello, immediatamente succes-sivo e conclusivo del trattato, alla concordia e al rispetto fra Imperatore ePapa, si giustificano, al di là delle difficoltà interpretative, solo in un perio-do che vedeva nel pieno delle loro funzioni Arrigo e Clemente, ancora noncontrapposti nei fatti, come avverrà poco dopo l’incoronazione romana delgiugno 1312 che, per i suoi modi, esplicitò la fase di irreversibile allonta-namento tra i due18.
4. I riferimenti più plausibili che si evincono dal testo del trattato in-dicano quindi che almeno il II e il III libro della Monarchia risentono delclima politico italiano creatosi tra il 1311 e il ’12, mentre sono scarsissimi
latur, nobis est alter Ascanius...»), e nota: «Va sottolineato che Dante pensa a unasuccessione ereditaria, per il re dei Romani, destinato all’Impero». In generale, irapporti tra l’epistola ad Arrigo e la Monarchia sono piuttosto numerosi, benchénon consentano di accertare una cronologia, mancando referenti esterni abbastan-za forti. Si vedano comunque le importanti considerazioni stilistiche di GiorgioBrugnoli su Epist. VII § 3 (op. cit., p. 566) e Mon. II 10 6 ss. (cfr. Il latino di Dante,in AA.VV., Dante e Roma, Firenze, Le Monnier, 1965, pp. 51-71). Per altre conside-razioni, e anche per ulteriore bibliografia, cfr. C. DI FONZO, La legittimazione del-l’impero e del popolo romano presso Dante, «Dante», 6, 2009, pp. 39-64.
18 Per il quadro qui delineato e per i problemi relativi all’incoronazione del1312, cfr. D. QUAGLIONI, Papato avignonese e problemi politici, in ID. (a c. di), Lacrisi del Trecento e il papato avignonese (1274-1378), in Storia della Chiesa, già dir.da A. Fliche e V. Martin, n. ed. Cinisello Balsamo, San Paolo, 19952, vol. XI, pp.311-363, specie 313-317 (anche per altra bibliografia). In generale, sul tema dellapace in Dante sono sempre fondamentali le pagine di Cesare Vasoli su La pace nelpensiero di Dante, di Marsilio da Padova e di Guglielmo d’Ockham (1974), ed. rivi-sta in Otto saggi per Dante, cit., pp. 41-63, specie 46-49. Per gli specifici riferimential concetto già agostiniano della pacis tranquillitas, in seguito fondamentale ancheper Marsilio da Padova, cfr. C. DOLCINI, Qualcosa di nuovo su Dante. Sue tesi po-litiche nel 1306, «Pensiero politico medievale», 1, 2003, pp. 19-25, che segnala l’im-piego delle Variae di Cassiodoro già nel Prologo della pace in Lunigiana del 6 otto-bre 1306; e si veda anche E. BERTIN, La pace di Castelnuovo Magra (6 ottobre 1306).Otto argomenti per la paternità dantesca, «Italia medioevale e umanistica», 46, 2005,pp. 1-34, specie 10-19. Solo per alcune altre attestazioni della formula, cfr. ancheG. L. MELLINI, Can Grande e Dante, «Labyrinthos», 43-44, 2006, pp. 41-50.
«SICUT IN PARADISO COMEDIE IAM DIXI» 191
gli appigli per riconoscere eventuali riscritture successive, che peraltro avreb-bero lasciate inalterate proprio le allusioni all’attualità, già profondamentecambiata tra il 1313 e il ’14, e definitivamente mutata dopo l’elezione diGiovanni XXII il 7 agosto 1316. Va sottolineato che nessuno degli editoripiù recenti, da Ricci alla Shaw, ha mai sostenuto che fossero individuabilivarianti d’autore nei testimoni del trattato, benché in numerosi casi le le-zioni varino da un punto di vista semantico-concettuale19. D’altronde, piùancora di quanto abbia fatto l’ultima curatrice, sembra necessario ipotizza-re interventi redazionali nel caso della princeps del 1559, il che giustifiche-rebbe meglio alcune lectiones singulares 20.
Molto rilevante risulta piuttosto un aspetto della storia della tradizionetestimoniato dal celebre Codice Bini, ora alla Staatsbibliothek PreußischerKulturbesitz di Berlino (lat. Folio 437; sigla ed. Shaw: B). Com’è noto, ilcodice pergamenaceo viene ascritto alla metà del XIV secolo, e riporta allecarte 89r-94v la Monarchia anepigrafo, adesposto e senza rubrica iniziale,così come il successivo De vulgari eloquentia (cc. 95r-98v). Si potrebbeipotizzare che il copista abbia trovato i due testi privi di qualunque indi-cazione d’autore, ma l’explicit della Monarchia, «endivinalo sel voy sape-
19 Su questi punti, oltre all’Introduzione alla nuova edizione critica (specie pp.64-102 e 248-272), cfr. P. SHAW, Le correzioni di copista nei manoscritti della «Monar-chia», «Studi danteschi», 63, 1991, pp. 281-312; si veda anche R. IMBACH, «Mi-rabile incrementum». A proposito della nuova edizione della «Monarchia» di PrueShaw, «Studi danteschi», 75, 2010, specie pp. 32-36.
20 Esula dagli scopi di questo intervento una disamina dei criteri dell’ed. Shaw,da molti punti di vista davvero benemerita. In generale, non mancherebbero mo-tivi per ipotizzare una diversa disposizione stemmatica (attualmente, la princeps,pur indubbiamente manipolata, costituisce da sola un ramo dell’albero ipotizzatodall’editrice): cfr. in questo senso la recensione-articolo di G. P. RENELLO, L’edizio-ne critica della «Monarchia», «Italianistica», 40, 2011, 1, pp. 141-180, dove fra l’al-tro si segnalano vari motivi per supporre che il curatore della princeps, GiovanniOporino, non abbia falsificato la paternità dell’opera, ma davvero credesse trattar-si di un discendente quattrocentesco di Dante, dato che non trovava nel suo antigra-fo l’inciso di I 12 6 (cfr. n. 4). Sulle difficoltà ad accettare lezioni sulla base di unaccordo maggioritario che vede la testimonianza di K come discriminante, cfr. G.INGLESE, Appunti sulla bipartiticità stemmatica nella tradizione delle opere di Dante,in Studi sulle società e le culture del Medioevo per Girolamo Arnaldi, a c. di L. Gattoe P. Supino Martini, voll. 2, Roma, All’insegna del giglio, 2002, I, pp. 245-253, specie250; e ora, più in dettaglio, P. TROVATO, La doppia «Monarchia» di P. Shaw (con unapostilla sulla «Commedia»), «Ecdotica», 6, 2010, pp. 25-39. Ma molto importante,alla luce di quanto sin qui emerso, risulta l’ipotesi di Paolo Chiesa (op. cit., pp. 338-341) riguardo a un’«instabilità» del testo dell’inciso, letto con difficoltà e con er-rori diversi (fra cui, forse, la cattiva interpretazione di un’abbreviatura di ‘come-dia’, che potrebbe aver dato origine al singolare «iam»), in particolare nel ramo �.
ALBERTO CASADEI192
re», ha indotto in genere gli interpreti a supporre che il copista avesse saputoo compreso che l’autore era Dante e che evitasse appositamente di nomi-narlo, sfidando il lettore appunto a ‘indovinare’ il suo nome21.
Quest’ultima ipotesi è la più plausibile se si tiene conto del contesto incui la Monarchia è stata sicuramente diffusa. Sulla scorta della ricostruzio-ne proposta da Francis Cheneval nel 1995 (cfr. n. 21), si è al momento sicuriche, prima della morte di Dante, non si riscontrano echi o testimonianzeche possano far sospettare una diffusione del trattato almeno in determi-nati ambienti, in particolare quello veronese; e sarebbe difficile immagina-re che essa sarebbe giovata al poeta dopo il 1318-19, quando ormai era ini-ziato il suo soggiorno nella Ravenna del guelfo moderato Guido Novello daPolenta. Viceversa, dopo il 1321 si hanno tracce forti o sicure della cono-scenza del trattato nell’ambiente bolognese, che di certo ha rappresentatoil luogo della prima diffusione e, a partire dal 1327, delle polemiche cheportarono alla clamorosa condanna di Bertrando del Poggetto, ascrivibileal 132922. Ma esaminiamo più in dettaglio i dati noti.
È opportuno citare innanzitutto il commento integrale al poema pre-parato da Iacopo o Iacomo della Lana tra il 1324 e il ’28, e forse entro il1327. Il Lana cita esplicitamente e compendia con relativa precisione ilcontenuto della Monarchia nell’Introduzione al VII canto del Paradiso:
[5] A la terça cosa si è da savere, sì cum’ prova Aristotelle in la soa /Pollitica/,rasonevelmente lo mundo se dé regere per un principio, lo quale abia custodia eregemento d’i soi suditi,[1] e fo oppinione dell’autore che tal principio circa litemporai regimenti fosse l’imperador |c. 23/r/| de Roma, sì com’ el tratta nella soa/Monarchia/ in la prima et in la secunda parte23.
Nonostante questa prova inconfutabile, e nonostante altri riferimentiimpliciti ma evidenti nell’introduzione al VI canto del Paradiso, è da notarsiche il Lana non accenna minimamente al trattato quando commenta Pr. V19-24, ovvero del luogo del poema cui senza dubbio si fa riferimento nel-l’inciso di Mon. I 12 624. Ora, se il Lana avesse letto quell’inciso, risultereb-
21 Si vedano le edizioni Ricci (p. 70) e Shaw, 219 s.; inoltre, F. CHENEVAL, DieRezeption der Monarchia Dantes bis zur Editio Princeps im Jahre 1559, München,W. Fink, 1995, pp. 21-23.
22 Cfr. CHENEVAL, Die Rezeption..., cit., specie pp. 117-162. In generale, utiliindicazioni si ricavano ancora dal volume miscellaneo Dante e Bologna nei tempi diDante, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1967. E si veda anche infra.
23 Cfr. IACOMO DELLA LANA, Commento alla «Commedia», a c. di M. Volpi, voll.4, Roma, Salerno ed., 2010, ad locum.
24 Cfr. in particolare il commento a V 19 (op. cit.): «/Lo magior don/. Chiaroapare per quel ch’è dicto dello libero arbitrio». Per altri riferimenti alla Monarchia,
«SICUT IN PARADISO COMEDIE IAM DIXI» 193
be singolare che, citando a più riprese la Monarchia nei due canti succes-sivi, non ritenesse importante segnalare un riferimento autoriale a propo-sito del libero arbitrio. Ovviamente, non di prova ma di mero indizio sitratta, che tuttavia potrebbe andarsi a inquadrare adeguatamente nel con-testo che delineeremo tra poco.
In effetti, a partire dal momento in cui Bertrando del Poggetto pone lasua sede di Legato papale a Bologna (febbraio 1327), la controversia sulleidee politiche di Dante non poteva più rimanere circoscritta, e infatti venneben presto proiettata nel contesto delle polemiche tra Impero e Papato, cheormai riguardavano la legittimità stessa di ciascuno dei due poteri. Va dettoche non sappiamo molto dell’uso diretto della Monarchia da parte delloschieramento favorevole a Ludovico il Bavaro: la sua stessa conoscenza daparte di Marsilio da Padova è ancora incerta, sebbene non manchino alcunisegnali in tal senso25. Tuttavia, che il trattato sia stato oggetto di una criticaspecifica e virulenta è indubbio, in primo luogo sulla base del ben noto Dereprobatione Monarchie del domenicano Guido Vernani, scritto fra il 1327e il ’34, più probabilmente prima del 132926.
Si noti che quest’ultimo dedicava, peraltro non evitando alcune severeammonizioni, il suo trattato antidantesco a Graziolo de’ Bambaglioli, guel-fo e collaboratore di Bertrando, ma anche esperto e commentatore di Dante.
in particolare nell’Introduzione a Pr. VI, cfr. ancora CHENEVAL, Die Rezeption..., cit.,pp. 85-97, specie 87-95. Si noti, per inciso, che il riferimento, per quanto evidente,secondo alcuni interpreti non sarebbe opportuno dati i diversi accenti con cui Dantetratta la questione del libero arbitrio nei due passi in questione: cfr. G. HOLMES,Monarchia and Dante’s Attitude to the Popes, in Dante and Governance, a c. di J.R.Woodhouse, Oxford, Clarendon P., 1997, p. 48, dove appunto si notano i contra-sti fra le teorie del Paradiso e quelle del trattato.
25 Cfr. C. DOLCINI, Nuove ipotesi e scoperte su Dante, Marsilio e Michele daCesena. Il nodo degli anni 1324 e 1330, in Etica e politica: le teorie dei frati mendi-canti nel Due e Trecento. Atti del XXVI Convegno, Assisi 1998, Spoleto, FondazioneCentro italiano di studi sull’alto Medioevo,1999, pp. 279-297.
26 Per la data della Reprobatio di Vernani cfr. M. MACCARRONE, Dante e i teo-logi del XIV-XV secolo, «Studi romani», 5, 1957, pp. 20-28, specie 24, dove fra l’altrosi fa notare che il domenicano non taccia Dante di eresia, come invece avrebbeprobabilmente fatto dopo le accuse esplicite di Bertrando all’inizio del 1329 (cfr.anche infra). Sulla questione dell’eresia e dell’inquisizione nel basso Medioevo, an-cora utile M. PICCHIO SIMONELLI, L’inquisizione e Dante: alcune osservazioni (1979),rist. in «Dante Studies», 118, 2000, pp. 303-321, specie 313-315. Per una riconsi-derazione della Reprobatio, cfr. A. K. CASSELL, Logic and Spleen: a post-mortemdialogue between Dante & Guido Vernani (The «Monarchia» and the «ReprobatioMonarchiae», Book III), «L’Alighieri», 24, 2004, pp. 5-24, anche per la bibliografiapregressa.
ALBERTO CASADEI194
La prima redazione del suo commento all’Inferno è ascritta al 1324, ed èprobabile che la glossa a If. II 7-9 dipenda da Mon. II 3 6-827. Ora, significa-tivamente proprio questo e altri passi che trovano riscontri nella Monarchiasono stati manipolati o espunti forse dopo il 1329, e in questo si potrà vedereo meno l’azione diretta dell’autore, ma di certo si dovrà riconoscere un rifles-so della forte ostilità verso il trattato dantesco sul finire degli anni Venti28.
In merito alla controversia sulla Monarchia la testimonianza fondamen-tale resta comunque quella del Boccaccio del Trattatello:
Similemente questo egregio auttore nella venuta d’Arrigo VII imperadore feceuno libro in latina prosa, il cui titolo è Monarcia, il quale, secondo tre quistioni lequali in esso ditermina, in tre libri divise. Nel primo, loicalmente disputando, pruovache a bene essere del mondo sia di necessità essere imperio; la quale è la primaquistione. Nel secondo, per argomenti istoriografi procedendo, mostra Roma diragione ottenere il titolo dello imperio; ch’è la seconda quistione. Nel terzo, perargomenti teologi pruova l’auttorità dello ‘mperio immediatamente procedere daDio, e non mediante alcuno suo vicario, come li cherici pare che vogliano; ch’è laterza quistione.
Questo libro più anni dopo la morte dell’auttore fu dannato da messer Bel-trando cardinale del Poggetto e legato di papa nelle parti di Lombardia, sedenteGiovanni papa XXII. E la cagione fu perciò che Lodovico duca di Baviera, daglielettori della Magna eletto in re de’ Romani, e venendo per la sua coronazione aRoma, contra il piacere del detto Giovanni papa essendo in Roma, fece, contra gliordinamenti ecclesiastici, uno frate minore, chiamato frate Pietro della Corvara,papa, e molti cardinali e vescovi; e quivi a questo papa si fece coronare. E, nata poiin molti casi della sua auttorità quistione, egli e’ suoi seguaci, trovato questo libro,a difensione di quella e di sé molti degli argomenti in esso posti cominciarono adusare; per la qual cosa il libro, il quale infino allora appena era saputo, divennemolto famoso. Ma poi, tornatosi il detto Lodovico nella Magna, e li suoi seguaci,e massimamente i cherici, venuti al dichino e dispersi, il detto cardinale, non es-sendo chi a ciò s’opponesse, avuto il soprascritto libro, quello in publico, sì comecose eretiche contenente, dannò al fuoco. E il simigliante si sforzava di fare dell’os-sa dell’auttore a etterna infamia e confusione della sua memoria, se a ciò non si fosseopposto uno valoroso e nobile cavaliere fiorentino, il cui nome fu Pino della Tosa, ilquale allora a Bologna, dove ciò si trattava, si trovò, e con lui messere Ostagio daPolenta, potente ciascuno assai nel cospetto del cardinale di sopra detto29.
27 Cfr. GRAZIOLO BAMBAGLIOLI, Commento all’«Inferno» di Dante, ed. critica ac. di L. C. Rossi, Pisa, Scuola Normale Superiore, 1998, pp. 32 s. e CXXXII s. Cfr.anche CHENEVAL, Die Rezeption..., cit., pp. 77-84.
28 Cfr. ancora BAMBAGLIOLI, Commento all’«Inferno» di Dante, cit., pp. CXXXIII ss.29 Cfr. GIOVANNI BOCCACCIO, Trattatello in laude di Dante, a c. di P. G. Ricci, in
Tutte le opere, vol. III, Milano, Mondadori, 1974, I red., §§ 195-197, pp. 487 s.; cfr.II red., pp. 529 s.
«SICUT IN PARADISO COMEDIE IAM DIXI» 195
Com’è noto, le testimonianze raccolte da Boccaccio devono trovareriferimenti esterni e possibilmente riscontri non passibili di antiche mani-polazioni per poter essere addotte a prova. In questo caso, però, la fontedoveva in effetti essere piuttosto esatta, perché ben difficilmente da solo ilcertaldese avrebbe potuto ricostruire la presenza a Bologna all’inizio del1329 di Pino della Tosa e Ostasio da Polenta, che oltretutto avrebbero avutopersino motivi biografici per non sentire il dovere di difendere la memoriadi Dante30. D’altra parte, che fosse stata citata o meno dai fautori di Ludo-vico il Bavaro durante le furiose polemiche antipapali del 1327-28, culmi-nate nell’incoronazione romana del 17 gennaio 1328 e nell’elezione dell’an-tipapa Niccolò V il 12 maggio seguente, la Monarchia non poteva più es-sere considerata alla fine degli anni Venti un trattato teorico, ma diveniva,per motivi ben diversi rispetto a quelli della sua concezione, uno strumentopolitico di forte impatto, anche a causa della sempre più ampia notorietàdel suo autore31.
Se dunque le notizie riportate da Boccaccio risultano in questo casosufficientemente attendibili, ancora maggior rilievo assume la sua indica-zione iniziale, e cioè che la Monarchia era stata scritta «nella venuta d’Ar-rigo VII imperadore», perché da un lato sarebbe stato ben più facile ipo-tizzare, essendo note le vicende successive, che la stesura riguardasse il
30 Cfr. C. RICCI, L’ultimo rifugio di Dante, Milano, Hoepli, 19212, pp. 182-189,471; e anche 138 per i contrasti di Dante con il suocero di Ostasio. F. Allegrezza,nella voce su Pino della Tosa del Dizionario biografico degli italiani (37, Roma, Ist.dell’Encicl. Ital., 1989, pp. 697-701, specie 700), accetta in sostanza la ricostruzio-ne di Ricci. Non ci sono motivi per contestare la testimonianza di Boccaccio: e delresto, come sottolineava già lo stesso Ricci (op.. cit.), la notizia dell’accusa di eresiacontro Dante, proprio a causa del trattato, ci è confermata anche da Bartolo daSassoferrato. Solo un’imprecisione risulterebbe allora il fatto che il rogo, secondoBoccaccio, avvenne dopo il ritorno di Ludovico in Germania, ossia tra la fine 1329e l’inizio del 1330? Probabilmente sì, anche se l’attacco diretto che Ludovico vo-leva sferrare contro Bertrando a Bologna, nell’autunno del 1329, poteva lasciarespazio a un ancora più acceso desiderio di vendetta l’anno successivo (cfr. GIOVAN-NI VILLANI, Nuova cronica, ed. G. Porta, Milano, Guanda-Fondazione Bembo, 1990,XI 145-146, pp. 701 ss.). Per ulteriori considerazioni sui motivi della condanna, sivedano le ancora utili notizie fornite da G. BISCARO, Dante a Ravenna. Indaginistoriche, «Bullettino dell’Istituto storico italiano», 41, 1921, pp. 112-117.
31 Per una riconsiderazione delle testimonianze antiche su questa fase, cfr. G.INDIZIO, Dante secondo i suoi antichi (e moderni) biografi, cit. e anche ID., Pietro Ali-ghieri autore del «Comentum» e fonte minore per la vita di Dante, «Studi danteschi»,73, 2008, pp. 224 s., sull’implicita testimonianza di Pietro nella sua canzone Quellesette arti liberali..., specie vv. 3-4: «della nomea del maestro loro [Dante] / ch’è statacondannata in concestoro», da riferirsi comunque al periodo intorno al 1329.
ALBERTO CASADEI196
periodo delle lotte fra Ludovico e Giovanni XXII; d’altro lato, viene impli-citamente fornito l’unico motivo per il quale Dante si sarebbe dovuto im-pegnare nella stesura di un trattato così complesso, che evidentemente ancheai contemporanei sembrava adatto solo a sostenere la dignità dell’Impera-tore quando, per la prima volta, tornava a rivendicarla in Italia.
5. Ricostruiti gli elementi certi o più plausibili riguardo alla genesi ealla prima diffusione della Monarchia, dobbiamo tornare all’inciso e chie-derci quando Dante l’avrebbe inserito e a quale scopo. Se l’inciso fossecontemporaneo alla stesura, dovremmo ipotizzare che, intorno al 1311-12,Dante avesse già scritto il V canto del Paradiso, il che va contro tutte leevidenze esterne sinora riscontrate. D’altra parte, l’ipotesi di un inserimen-to avvenuto nel momento di una rilettura, grosso modo a partire dal 1314-15 (il periodo considerato più plausibile per l’avvio della scrittura della terzacantica), si scontra con l’assoluta mancanza di segnali di una revisione au-toriale, che del tutto inspiegabilmente avrebbe lasciati immutati i riferimentidi II 1 e 10.
Ma soprattutto, se la diffusione integrale del Paradiso non avvenne primadella morte di Dante, come il celebre passo di Egl. II 48-51 e altre evidenzeesterne portano a credere32, quale pubblico avrebbe potuto cogliere questaspecifica allusione, e soprattutto a quale scopo avrebbe dovuto coglierla?L’autocitazione infatti non fornirebbe qui nessun riscontro significativo peril lettore: sarebbe perciò ben diversa da quelle individuabili nel trattatomeglio confrontabile con la Monarchia, ossia il De vulgari eloquentia, dovele citazioni di versi dell’autore sono funzionali a una precisa esemplificazio-ne (spesso, com’è ovvio, pro domo sua), e sono in ogni caso smorzate dal-l’uso del ‘noi’ o delle formule di modestia («amicus eius» e simili), ancheper non incorrere nell’arroganza del parlare di sé senza un giusto motivo,stigmatizzata in Conv. I 2.
È evidente che la pressoché completa impossibilità di collocare in unadata plausibile e di giustificare funzionalmente l’inciso di Mon. I 12 6, sedavvero fosse d’autore, rende molto più economica un’ipotesi che recuperi
32 Si veda, di chi scrive, Sulla prima diffusione della «Commedia», «Italianisti-ca», 29, 2010, pp. 57-66, anche per la bibliografia pregressa. È possibile che singo-li canti (non gruppi) del Paradiso, come già era accaduto per le cantiche preceden-ti, circolassero e avessero una diffusione almeno in alcuni ambienti frequentati daDante, che certo non poteva tacere interamente sulla sua opera nelle corti che loospitavano. Ma difficilmente, prima della diffusione integrale delle cantiche, un let-tore sarebbe stato in grado di individuare un riferimento specifico a un canto dottri-nale e non dotato di episodi autonomi (come nel caso del quinto del Paradiso).
«SICUT IN PARADISO COMEDIE IAM DIXI» 197
e giustifichi la posizione di Barbi sopra menzionata (cfr. § 1). Intorno al1329 molte copie della Monarchia furono bruciate o distrutte, e comunquediventò a lungo problematico diffondere il trattato in forma esplicita, indi-cando titolo e autore, come testimonia il codice Bini (cfr. § 4 e n. 21). Perfar riconoscere l’opera a chi non ne avesse avuta notizia, era quindi neces-sario segnalare in un punto interno al testo e con un riscontro preciso chine fosse l’autore: in questo senso, porre in evidenza con una glossa poiinglobata il primo riferimento sicuro al poema era un modo semplice einoppugnabile (specialmente usando la prima persona) di garantire la pa-ternità dell’opera33. Che l’inciso si sia poi diffuso nella seconda circolazionedel trattato, dopo il 1329-30, e che quindi risulti presente in archetipo (osubarchetipo), non sembra un evento poco plausibile, sulla base della sto-ria della tradizione e delle vicende storiche tout court.
ALBERTO CASADEI
33 Per alcune riflessioni sui falsi medioevali e sulle ricadute riguardo alla bio-grafia di Dante, si veda di chi scrive Considerazioni sull’epistola di Ilaro, «Dante»,8, 2011, in c.s.
* A tal proposito si veda più oltre l’intervento di P. SHAW, Un secondo mano-scritto londinese della «Monarchia» (pp. 223-264).
POSTILLA
Dopo aver corretto le bozze di questo lavoro, leggo, per cortesia del-l’autore, una parte della Nota al testo che Diego Quaglioni sta per pubbli-care nella sua nuova edizione della Monarchia (Milano, Mondadori). Lostudioso ha collazionato un manoscritto, l’Additional 6891 della BritishLibrary, non considerato dalla Shaw nella sua edizione* e invece non solocompleto, ma portatore di una lezione inedita dell’inciso: «sic(ut) in muni(?) adiso i(n)mediate ia(m) dixi» (c. 4r). Ciò apre un nuovo scenario, con-sentendo di ipotizzare che l’inciso nella forma attuale costituisca un’ampiacorruttela o banalizzazione di una frase effettivamente dantesca, che pote-va rimandare a quanto detto poco sopra nel testo (di qui il «iam dixi»),forse in riferimento alle anime del paradiso.
L’ipotesi è degna della massima considerazione, sebbene sia necessariorivedere probabilmente l’intera situazione stemmatica prima di poter espri-mere un parere stringente. In ogni caso, risulterebbe per altre vie confer-mato che l’inciso, nella forma attuale, non è d’autore.