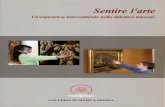Lettura di "Inferno XXVIII" [2013]
-
Upload
wwwuniroma1 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Lettura di "Inferno XXVIII" [2013]
CANTO XXVIII
IL CANTO DELLE « OMBRE TRISTI SMOZZICATE »*
Dopo l’incontro con Guido da Montefeltro del canto xxvii, Dante e Virgi-lio continuano l’attraversamento del cerchio dei fraudolenti sul ponte che so-vrasta le bolge, ed ecco che si apre alla loro vista uno spettacolo raccapriccian-te, forse il piú sconcertante di tutto l’attraversamento infernale. Siamo nella nona bolgia. Qui i dannati, una folla sterminata, si muovono portando in giro i corpi squartati, fatti a pezzi da un diavolo che, tutte le volte che passano da-vanti a lui, con un’enorme spada cosí li « accisma » (v. 37), cioè li concia per le feste. Quindi gli sciagurati riprendono il cammino. Le ferite via via si rimargi-nano, le membra amputate si risaldano. Saranno nuovamente straziate quan-do, concluso il giro, ritorneranno dinanzi al diavolo punitore. Tutto questo per l’eternità. La scena è di una crudeltà in eccesso: c’è il sangue che sprizza, organi interni a vista o che fuoriescono dai corpi squarciati. Il tutto rappresen-tato con un realismo violento.
La colpa di questi peccatori è di aver seminato odio sulla terra, di aver ope-rato per dividere, mettendo gli uni contro gli altri. Il primo dei dannati che parla a Dante, dirà (vv. 34-36):
E tutti li altri che tu vedi qui, seminator di scandalo e di scisma fuor vivi, e però son fessi cosí.
Uno dei piú attenti commentatori antichi di Dante, Guido da Pisa, spiega con precisione cosa debba intendersi per “scandalo” e per “scisma”:
[. . .] est scisma peccatum quo quis aliquem vel aliquos ab unitate Ecclesie separat, vel seiungit. Scandalum vero est offensio qua quis verbo vel facto societatis vel amicitie dividit unitatem.1
Nell’uso medievale, dunque, “scisma” è propriamente il peccato commesso da chi separa i credenti dall’unità della Chiesa (il corpus Ecclesiae);2 “scandalo” è la colpa di chi con le parole o con i fatti semina discordia e odio nella società
* Si pubblica qui, rivisto e ampliato, il testo della Lectura Dantis tenuta presso la Casa di Dante in Roma domenica 13 febbraio 2011.
1. Guido da Pisa, p. 581.2. Paolo, i Cor., 12 14, aveva impiegato la metafora del corpus mysticum della Chiesa.
848
civile, determinando la frantumazione dei vincoli sociali o dell’amicizia o ad-dirittura della parentela. Lo scismatico mina l’unità dei credenti, il fomentato-re di scandali quella delle istituzioni civili. Le colpe sono individuali, ma gli effetti prodotti, essendo scisma e scandali tradimenti contro la collettività, hanno una ricaduta sociale devastante.3 La punizione a cui questi dannati sog-giacciono non è mai altrove cosí pertinente alla natura della colpa: non è del resto un caso che la parola “contrapasso”, la regola penale che applica il criterio della giustizia commutativa, si incontri l’unica volta nella Commedia proprio in relazione a questo canto.4
Ciò che Dante si appresta a raccontare è assolutamente fuori dall’ordinario, addirittura incredibile. La strategia retorica adottata è funzionale a questa ec-cezionalità. Il poeta comincia dichiarando l’impossibilità di descrivere ciò che vede. Non solo in poesia (dove i vincoli del numero delle sillabe, del ritmo e della rima potrebbero limitare la completezza del racconto) ma neppure in prosa, anche ritornandovi piú e piú volte e in maniera sempre piú dettagliata, sarebbe possibile rendere adeguatamente la scena, perché le parole non sono sufficienti a rappresentarla, né la mente umana è in grado di concepirla (vv. 1-6):
Chi poria mai pur con parole sciolte dicer del sangue e de le piaghe appieno ch’i’ ora vidi, per narrar piú volte? Ogne lingua per certo verria meno per lo nostro sermone e per la mente c’hanno a tanto comprender poco seno.
Questi versi configurano ciò che in retorica si definisce una figura di preteri-zione. È tipica dello stile epico: il poeta dichiara la sua inadeguatezza a rende-re la straordinarietà di ciò che sta per raccontare. In Dante la figura di preteri-zione si specializza per lo piú nel senso dell’indicibilità. Il mondo dell’aldilà eccede talora la possibilità di comprensione umana. Dante ricorre al topos
3. Cosí san Tommaso: « Praeterea, bonum multitudinis est maius et divinius quam bonum unius; ut patet per philosophum, in i Ethic. Sed schisma est contra bonum multitudinis, idest contra ecclesiasticam unitatem, infidelitas autem est contra bonum particulare unius, quod est fides unius hominis singularis. Ergo videtur quod schisma sit gravius peccatum quam infidelitas » (Summa Theol., iia-iiae, q. 39 art. 39 2).
4. Contrario all’opinione vulgata di contrapasso come regola di giustizia che ispira tutte le pene infernali è D. Bolognesi, Il contrapasso come chiasma. Appunti su ‘Inferno’ xxviii, in L’A, n.s., n. 36 2010, pp. 5-20. Ma sulla complessa questione del rapporto fra colpa e pena nella speculazione medieva-le e nell’Inferno dantesco cfr. G. Mazzotta, Metaphor and Justice in Id., Dante’s Vision and the Circle of Knowledge (‘Inferno’ xxviii), Princeton, Princeton Univ. Press, 1993, pp. 75-95.
inferno · canto xxviii
849
dell’indicibilità frequentemente nel Paradiso, ed è comprensibile narrandosi delle cose di Dio. È l’eccesso delle cose narrate, la profondità del mistero divi-no a rendere la mente e la lingua umane inadeguate. Qui invece l’indicibile è verso il basso: il negativo morale e insieme il brutto, l’esteticamente ripugnan-te, sono tali da superare ogni possibilità di rappresentazione.
Dicevo della figura di preterizione e dello stile epico. La Sibilla, nel mostra-re a Enea nel libro vi dell’Eneide i puniti dell’ade, dice che neanche se avesse cento lingue e cento bocche e una voce resistente come il ferro potrebbe esau-rire tutte le forme delle colpe ed enumerare tutti i nomi delle pene (vv. 625-27): « Non, mihi si linguae centum sint oraque centum », ecc., formula che ri-torna con piccole variazioni altre volte in Virgilio ed è anche in Ovidio, ed era già in Omero. Dai poeti antichi passa poi nella letteratura medievale, per esempio nella Visio Pauli, nella Babilonia di Giacomino da Verona e altrove.
Ma quando Dante si mette nella scia dei grandi poeti ciò non avviene mai in maniera passiva. Intanto egli fa una distinzione inedita fra narrare in versi e il piú facile narrare in prosa (con « parole sciolte », cioè non regolate); poi è da dire che nei poeti antichi e negli epigoni medievali quella formula si riferiva all’impossibilità di enumerare una quantità sterminata, mentre Dante sposta l’impossibilità del narrare dalla quantità alla qualità, ovvero all’essenza di quel-la condizione: « Chi poria mai pur con parole sciolte / dicer del sangue e de le piaghe appieno ». “Dire appieno”, cioè dar conto in toto della realtà delle cose, non di un numero esorbitante. Ma è evidente che si tratta di un espediente retorico. Proprio in momenti come questi la sfida a dire l’indicibile innalza l’arte di Dante verso le sue punte piú alte. Avverrà molte volte nel Paradiso, fino alla descrizione della Trinità, e accadrà ancora anche nell’Inferno, per esempio nell’attacco del canto xxxii. Nell’Inferno è il riconoscimento ossimorico della possibilità di un sublime verso il basso. Nessun poeta prima di lui aveva osato fare ciò che nella tradizione retorica antica, tardo-antica e medievale era con-siderato un assurdo. L’altezza dello stile si addiceva al genere epico, alle grandi figure della storia o del mito, non a poveri corpi squartati ributtanti.
Ma come va avanti il racconto dopo questa dichiarazione preliminare? Con una comparatio ipotetica che è anche una delle manifestazioni piú alte della fantasia visionaria del poeta. Tutte le volte che Dante raggiunge nell’Inferno un nuovo paesaggio si preoccupa di rendere al lettore con una similitudine ciò che di inusuale si presenta ai suoi occhi. Fa ricorso Dante all’esperienza terrena o alle Scritture o al racconto dei poeti, talvolta anche a meccanismi psicologi-ci.5 Nella bolgia precedente, per descrivere le lingue di fuoco che si muoveva-
5. V. Díaz Corralejo, Los heridos de Apulia, in « Cuadernos de filología italiana », 2000, n. extra-
pasquale stoppelli
850
no nel suo fondo ed entro cui bruciavano i consiglieri di frode, Dante aveva introdotto prima la similitudine del villanello che la sera si riposa su un’altura e vede i campi popolati di lucciole, poi quella del carro di Elia che sale in cielo avvolto in una palla di fuoco. Ma non c’era nulla nella realtà o negli auctores che poteva essere utile a descrivere ciò che ora appare a lui alla vista della nona bolgia. Ed ecco che la fantasia del poeta si accende in uno scatto visionario che rende compresenti fatti storici appartenenti a epoche fra loro lontanissime: se immaginassimo – dice – di vedere riuniti in un solo luogo tutti i feriti di tutte le guerre combattute nel disgraziato meridione d’Italia, da quella dei Troiani6 per la conquista del Lazio alla strage di Canne, che vide i Romani soccombere nella seconda guerra punica all’esercito di Annibale, e poi le sanguinose guer-re di conquista di Roberto il Guiscardo e le piú recenti battaglie tra Svevi e Angioini, da Ceprano a Tagliacozzo, ebbene, la vista tutt’insieme di tutti i fe-riti e tutti i morti di tutte queste guerre (in realtà un’unica lunga guerra con strascichi ancora nel presente) non pareggerebbe in alcun modo lo spettacolo ripugnante della nona bolgia.7 Dunque una “dissimilitudine” piú che una si-militudine, per giunta ipotetica e costruita con una tecnica accumulativa che si riscontra anche nella successione dei quadri dei dannati di questa bolgia. Non si dice che A è come B, ma che, se anche noi immaginassimo l’esistenza di B, A non sarebbe come B ma ancora di piú. Leggiamola (vv. 7-21):
S’el s’aunasse ancor tutta la gente che già in su la fortunata terra di Puglia, fu del suo sangue dolente per li Troiani e per la lunga guerra che de l’anella fé sí alte spoglie, come Livio scrive, che non erra, con quella che sentio di colpi doglie
ordinario, pp. 125-34, alle pp. 125-26, proprio in relazione a questo canto, attribuisce alle similitu-dini dantesche una funzione conoscitiva che va oltre il dato realistico: « [. . .] los símiles constituyen una vía de conocimiento [. . .] sirven de diccionario, a imagen de la realidad exterior, porque pre-sentan ante el intelecto semejanzas tomadas de la realidad aparencial, familiar para el hombre, para que, estableciendo las analogías pertinentes, alcance la verdadera realidad, la sobrehumana, que el intelecto humano no podría nunca alcanzar en principio y por principio ».
6. Ma c’è anche chi intende Troiani come ‘Romani’, supponendo un riferimento alle guerre sannitiche.
7. « Il canto si costruirà, infatti, attraverso una serie di quadri insorgenti in rapida successione, in un vario giuoco di immagini, secondo un processo di perenne ricominciamento e di perenne ripresa, in qualche modo, del programma descrittivo enunciato a principio e dichiaratamente abbandonato per l’impossibilità di un ‘aequare’ che non si concreti per riflessa comparazione » (E. Sanguineti, Interpretazione di Malebolge, Firenze, Olschki, 1961, p. 287 n.).
inferno · canto xxviii
851
per contastare a Ruberto Guiscardo; e l’altra il cui ossame ancor s’accoglie a Ceperan, là dove fu bugiardo ciascun Pugliese, e là da Tagliacozzo, dove sanz’arme vinse il vecchio Alardo; e qual forato suo membro e qual mozzo mostrasse, d’aequar sarebbe nulla il modo de la nona bolgia sozzo.
La scena immaginaria portata a paragone abbraccia ben cinque terzine. I fatti storici ricordati (le guerre, le battaglie) sono materia da stile elevato, tuttavia l’ultima delle cinque terzine e in particolare l’ultimo verso del terzetto, « il modo de la nona bolgia sozzo », sul quale il lungo paragone precipita, con quel sozzo finale, cioè ‘schifoso, immondo’, in rima con Tagliacozzo e mozzo, abbassa vertiginosamente il livello della descrizione precedente. In quindici versi e 97 parole Dante riesce a comunicare al lettore la sensazione di uno spazio stermi-nato brulicante di corpi disfatti. Non c’è nulla nell’arte antica e medievale che si avvicini a questo: per trovare qualcosa di comparabile bisogna aspettare gli ampi paesaggi popolati di figure umane e di mostri immaginati dalla fantasia di Hieronymus Bosch.
Osserviamo da vicino la similitudine: grammaticalmente un periodo ipote-tico della impossibilità con una protasi bimembre asimmetrica. La prima pro-posizione della protasi si distende su 4 terzine: stile alto, proprio della poesia delle armi, che Dante nel De vulgari eloquentia aveva definito salus, a cui era connaturata l’armorum probitas e che costituiva uno dei tre magnalia, insieme ad amor e virtus; in questo genere Dante aveva riconosciuto, immediatamente dopo nel trattato, la palma di miglior poeta in lingua provenzale a Bertran de Born.8 Ma qui non c’è la celebrazione dell’eroismo guerriero, di ciò che si potrebbe definire la bellezza della guerra: la vittoria di Annibale a Canne si ricorda attraverso il bottino vile delle tre moggia di anelli d’oro strappati dalle dita dei cavalieri e senatori romani uccisi, come racconta Tito Livio (xiii 12 1); la vittoria decisiva degli Angioini sugli Svevi a Ceprano (ma in realtà la batta-glia era avvenuta a Benevento) è descritta come conseguenza del tradimento dei baroni meridionali (« [. . .] là dove fu bugiardo / ciascun Pugliese [. . .] »). La figura metrica prevalente in questi versi è l’enjambement. La frequenza degli
pasquale stoppelli
852
8. Vd. risp. D.v.e. 2012, ii 2 7: « Quare hec tria, salus videlicet, venus et virtus, apparent esse illa magnalia que sint maxime pertractanda, hoc est ea que maxime sunt ad ista, ut armorum probitas, amoris accensio et directio voluntatis », e ivi, ii 2 8: « Circa que sola, si bene recolimus, illustres viros invenimus vulgariter poetasse, scilicet Bertramum de Bornio arma, Arnaldum Danielem amorem, Gerardum de Bornello rectitudinem ».
enjambements dà al lungo periodo un’andatura ansante. La dilatazione della sintassi, ottenuta con l’uso insistito di espressioni parentetiche, fa tutt’uno con la dilatazione dello spazio. Ma la rima aspra in -ozzo di Tagliacozzo è il segnale di un repentino cambio di registro, dall’orrore tragico al grottesco ripugnante. La vocale o dominante della rima in -ozzo marca l’intero verso 21, i cui accenti ritmici cadono tutti su parole con o tonica: « il módo de la nóna bólgia sózzo ».
Lo schema a cui Dante si ispira è l’avvio di un planh proprio di Bertran de Born:
Si tuit li dol e-il plor e-il marrimen E las dolors e-il dan e-il chaitivier C’om hanc agues en est segle dolen Fossen ensems, sembleran tuit leugier Contra la mort del jove rei engles.9 [. . .].
‘Se tutti i dispiaceri e i pianti e i tormenti, i dolori, le perdite e le miserie mai patite in questo mondo di sofferenza fossero cumulati insieme, sarebbe poco rispetto alla morte del Re giovane inglese’. Il re pianto da Bertran è Enrico III, figlio di Enrico II Plantageneto d’Inghilterra, morto nel 1183. Proprio per aver messo il figlio contro il padre Bertran è punito in questa bolgia, come sapremo piú avanti nel racconto. Il canto si apre implicitamente nel nome di Bertran de Born: Bertran sarà anche il personaggio con cui il canto si chiuderà. La sua fi-gura è dominante.
Una volta che il lettore è avvertito dell’eccezionalità della scena, Dante co-mincia il suo racconto, convogliando l’attenzione su un primo dannato (vv. 22-27):
Già veggia, per mezzul perdere o lulla, com’io vidi un, cosí non si pertugia, rotto dal mento infin dove si trulla. Tra le gambe pendevan le minugia; la corata pareva e ’l tristo sacco che merda fa di quel che si trangugia.
Lo stile eloquente, da cui aveva preso avvio il canto (Chi poria mai [. . .] e poi S’el s’aunasse ancor tutta la gente), nel giro di poche terzine scende ai livelli piú bassi che la lingua poetica possa concepire. Cambiamenti rapidi di tonalità che nes-
9. G. Gouiran, L’amour et la guerre: l’oeuvre de Bertran de Born, Aix en Provence, Publications Univ. de Provence, 1985, p. 260.
inferno · canto xxviii
853
sun altro poeta è in grado di realizzare in maniera cosí rapida e naturale insie-me. Una botte (vèggia), che ha perso una delle doghe di cui è fatto il suo fondo (le due lulle e il mezzule), non è cosí sfondata come io vidi uno squarciato dal mento fino all’ano. Tra le gambe pendevano le budella, si vedevano le interio-ra e il sacco schifoso (lo stomaco) che trasforma in escrementi tutto quello che si ingurgita. Questa descrizione, dopo i versi eloquenti dell’attacco, produce un contrasto che accentua l’effetto deformante della narrazione. Veggia, mezzu-le e lulla sono termini tecnici, mai prima usati in poesia (un lessico di estrema precisione che contribuisce a dare alla descrizione una qualità, per cosí dire, iperrealistica); pertugiare ha una forte valenza espressiva; trullare (‘scoreggiare’) è voce onomatopeica fortemente plebea, mai attestata prima né in prosa né in verso. Il resto del lessico è adeguato a questo registro: le minugia, la corata, il « tristo sacco » che trasforma in « merda » quello « che si trangugia ». Trangugia-re è verbo che esprime una voracità animalesca piuttosto che umana; le minugia e la corata sono termini di macelleria. Questi dannati sono come animali ma-cellati: sporchi di sangue, immondi. Si noti intanto il virtuosismo tecnico del verso qui di séguito evidenziato dal corsivo:
Già veggia, per mezzul perdere o lulla, com’io vidi un, cosí non si pertugia, rotto dal mento infin dove si trulla.
I due emistichi sono invertiti rispetto al loro ordine logico (“una botte che ha perso un pezzo del suo fondo non è cosí squarciata come io vidi uno, ecc.”): una sintassi sconvolta sottolinea dunque l’innaturalezza del corpo squartato. Mal-grado la precisione tecnica del lessico, in questa descrizione non c’è tuttavia nulla di oggettivo, di realistico, essendo tutto ben oltre la realtà. Il segno lingui-stico viene forzato oltre i suoi limiti semantici, caricandosi di una forza rappre-sentativa e comunicativa straordinaria. Cosí continua (vv. 28-33):
Mentre che tutto in lui veder m’attacco, guardommi, e con le man s’aperse il petto, dicendo: « Or vedi com’io mi dilacco! vedi come storpiato è Mäometto! Dinanzi a me sen va piangendo Alí, fesso nel volto dal mento al ciuffetto.
La rima rara in -acco di tristo sacco richiama due rimanti di forte espressività: m’attacco, che dà concretezza fisica, tangibilità materiale all’atto del guardare (il “vedere” comporta il posarsi dello sguardo, la vista di Dante invece “si attac-ca”); dilacco è conio dantesco, vale ‘mi squarcio, mi trovo diviso in due’ e deriva
pasquale stoppelli
854
da lacca ‘coscia (di animale)’. Ma il Vellutello, commentatore cinquecentesco di Dante, dà una spiegazione di lacca piú precisa: « in lingua romagnola cosí sono domandate [‘dette’] le due parti de l’uomo che sono intorno al fondamento [‘l’ano’], che altramente le domandiamo [‘diciamo’] “chiappe” ».10 Dunque uno squarcio all’altezza dell’attaccatura delle gambe.
Il personaggio è nientemeno che Maometto. Nella tradizione medievale si credeva che Maometto fosse stato originariamente un prelato o addirittura un cardinale che, abbandonata la fede cristiana, aveva dato inizio a una nuova re-ligione. Ecco quello che scrive di Maometto l’Ottimo Commento, che tuttavia non crede alla leggenda di Maometto cristiano e poi fondatore di una nuova fede:11
[. . .] dicono alcuni, ma non è vero, ch’egli fu cardinale, e savio scienziato; e che in servigio della fede cristiana andò a predicare in Affrica; e che fu sí grazioso [‘incontrò un tale successo’], che quasi tutte quelle parti ridusse a cristianitade; e che quando elli andò di là, li fu promesso per li cardinali il papato, se ’l Papa morisse anzi ch’egli ritornasse, la qual cosa non fecero: per lo quale sdegno predicò alla gente convertita il contrario, e diè loro nuove leggi.
Credesse o meno Dante a questa leggenda, qui si considera il fondatore dell’i-slam uno scismatico; con lui si accompagna Alí, suo genero e primo discepolo, che avrebbe dato origine a sua volta alla setta degli sciiti all’interno dello scisma islamico. Alí ha la testa spaccata dal mento all’attaccatura dei capelli (dal mento al ciuffetto).
Come va avanti il racconto? Dopo essersi presentato ai due pellegrini e aver descritto le regole della bolgia, Maometto chiede a Dante chi sia (vv. 43-45):
Ma tu chi sè che ’n su lo scoglio muse, forse per indugiar d’ire a la pena ch’è giudicata in su le tue accuse?
Maometto crede che Dante sia un dannato destinato a una delle zone piú bas-se dell’inferno e si riferisce al suo guardare col verbo musare, che sembra essere piú pertinente a un animale che fissa il muso su qualcosa. Ma Virgilio è pronto a ristabilire la verità (vv. 46-51):
10. Vellutello, p. 641-42.11. Ottimo Commento, p. 482. Per la ricognizione delle fonti a cui si ispirano i commentatori
antichi della Commedia nel dar conto del Maometto dantesco si veda P. Locatin, Maometto negli antichi commenti alla ‘Commedia’, in L’A, n.s., n. 20 2002, pp. 41-75. Piú in generale è ancora utile A. D’Ancona, La leggenda di Maometto in Occidente, in GSLI, a. xiii 1889, pp. 199-281.
inferno · canto xxviii
855
« Né morte ’l giunse ancor, né colpa ’l mena », rispuose ’l mio maestro, « a tormentarlo; ma per dar lui esperienza piena, a me, che morto son, convien menarlo per lo ’nferno qua giú di giro in giro; e quest’è ver cosí com’io ti parlo ».
È talmente inverosimile che un vivo possa aggirarsi per l’inferno che Virgilio per dar fede a quanto detto si vede costretto a chiamare a testimone la verità della sua persona: quello che ti dico è vero come sono vero io che ti parlo. Le parole di Virgilio lasciano sbalorditi i dannati che in quel momento passano sotto il ponte (vv. 52-54):
Piú fuor di cento che, quando l’udiro, s’arrestaron nel fosso a riguardarmi per maraviglia, obliando il martiro.
Si bloccano tutti per la meraviglia: è il fermo di un’immagine in movimento, la prima di una serie di questo tipo che caratterizza l’intera bolgia. A questo punto Maometto manda a dire a fra Dolcino, capo della setta eterodossa degli Apostolici, dunque uno scismatico ed eretico per cosí dire in attività di servi-zio, di premunirsi di scorte di cibo se vorrà resistere alla prossima neve inver-nale e all’assedio che i crociati di Novara e di Vercelli avrebbero portato contro di lui e i suoi adepti rifugiatisi sui monti fra le due città. Si tratta ovviamente di una profezia post eventum, ma è interessante notare come nella prospettiva dell’aldilà dantesco tutto sia destoricizzato e degerarchizzato: il fondatore nientemeno che dell’Islam mostra attenzione a una figura di ribelle di provin-cia, per quanto con una certa notorietà in quegli anni nell’Italia centro-setten-trionale. Dolcino morirà sul rogo nel 1307, e non è difficile prevedere che si apparecchiava anche per lui un posto nella bolgia. Maometto invia il suo mes-saggio profetico a fra Dolcino restando sospeso su un solo piede (vv. 61-63):
Poi che l’un piè per girsene sospese, Maometto mi disse esta parola; indi a partirsi in terra lo distese.
La posizione strana, il gesto burattinesco di Maometto che parla restando so-speso su un piede, in una sorta di ralenti, mette in evidenza un altro aspetto della visionarietà di questo canto, che riguarda anche gli altri dannati: sono tutti fissati, come vedremo, in un gesto innaturale, paradossale, grottesco.12
12. V. Díaz-Corralejo, Otra lectura del canto xxviii del ‘Infierno’, in Tenz, n. 3 2003, pp. 41-55, in-
pasquale stoppelli
856
Dopo Maometto si fa avanti Pier da Medicina. Non si sa bene chi sia stori-camente questo personaggio, che dice di aver conosciuto Dante. La Commedia lo presenta come un istigatore di discordie tra i signori della Romagna. Questa la sua condizione (vv. 64-70):
Un altro, che forata avea la gola e tronco ’l naso infin sotto le ciglia, e non avea mai ch’una orecchia sola, ristato a riguardar per maraviglia con li altri, innanzi a li altri aprí la canna, ch’era di fuor d’ogne parte vermiglia, e disse: [. . .].
Anche qui un gesto a fissare in un’istantanea lo stato del dannato: « aprí la can-na / ch’era di fuor d’ogne parte vermiglia ». Anche Pier da Medicina, come Maometto, invia ai viventi tramite Dante un messaggio. Dice: ‘fai sapere ai due esponenti delle piú nobili famiglie di Fano, Guido (Guido del Cassero) e Angiolello (Angiolello da Carignano) che saranno gettati in mare a tradimen-to nell’Adriatico, nel mare di Cattolica, in un sacco legato a una grossa mazze-ra, di ritorno da un colloquio con Malatestino da Rimini (« quel traditor che vede pur con l’uno », v. 85, che vede cioè con un solo occhio), proprio per or-dine di costui’.13
L’intero Mediterraneo, da Cipro a Maiorca, non ha mai conosciuto un de-litto cosí atroce, non hanno mai commesso un gesto di tale efferatezza nean-che i pirati o i greci che andarono all’assedio di Troia. Un eccesso che era oltre lo stesso mondo violento dell’epica. E questo veniva da gente cristiana: i tiran-ni di Romagna con la loro ferocia bestiale, già stigmatizzati nel canto prece-dente. Quel traditore, cioè Malatestino, aggiunge Pier da Medicina, è signore di una città (Rimini) che un dannato qui vicino a me si pente amaramente di aver mai visto. Queste ultime parole mettono curiosità a Dante. Chiede il poeta pellegrino chi sia il suo vicino: se dirà il suo nome, Dante si impegna a portare notizia di lui nel mondo. Ed ecco un’altra istantanea. Piero da Medici-na tira giú con un gesto violento la mascella del dannato che gli sta accanto mostrando « [. . .] la lingua tagliata ne la strozza » (vv. 94-102):
terpreta in senso simbolico i gesti dei dannati di questa bolgia. In particolare, l’equilibrio precario di Maometto sospeso su un solo piede rimanderebbe, secondo la studiosa, alla condizione di in-stabilità che è propria del malvagio o di chi vive nel male (alle pp. 48-49).
13. Di questo episodio, tuttavia, le cronache non conservano memoria, tanto che è stato suppo-sto che il fatto sia invenzione di Pier da Medicina (vd. qui a p. 000).
inferno · canto xxviii
857
Allor puose la mano a la mascella d’un suo compagno e la bocca li aperse, gridando: « Questi è desso, e non favella. Questi, scacciato, il dubitar sommerse in Cesare, affermando che ’l fornito sempre con danno l’attender sofferse ». Oh quanto mi pareva sbigottito con la lingua tagliata ne la strozza Curio, ch’a dir fu cosí ardito!
È Curione, il tribuno della plebe di cui racconta Lucano nella Farsalia (i 261-91):14 cacciato da Roma nel corso della guerra civile che oppose Cesare a Pom-peo, si rifugiò presso Cesare, allora nella città di Rimini, esortandolo a rompe-re gli indugi e a marciare col suo esercito contro Roma, « affermando che ’l fornito / sempre con danno l’attender sofferse », cioè ‘quando si è pronti ad agire è dannoso restare in una posizione attendista’. Questi versi riformulano un verso di Lucano riferito allo stesso episodio, divenuto poi proverbiale: « tol-le moras: semper nocuit differre paratis » (ivi, i 281). Ma la fantasia dantesca brucia nel fuoco di un’immaginazione potentissima tutti i precedenti, né ha molto interesse interrogarsi sul perché l’invito ad agire dato da Curione a Ce-sare sia stato da Dante giudicato negativamente, dato che va nella direzione del disegno provvidenziale di Dio, che attribuisce proprio a Cesare il compito di fondare l’impero.15 Ma nella sequenza veloce degli accadimenti ecco farsi avanti un altro dannato (vv. 103-6):
E un ch’avea l’una e l’altra man mozza, levando i moncherin per l’aura fosca, sí che ’l sangue facea la faccia sozza gridò: « Ricordera’ti anche del Mosca, che disse, lasso!, “Capo ha cosa fatta”, che fu mal seme per la gente tosca ». E io li aggiunsi: « E morte di tua schiatta »; per ch’elli, accumulando duol con duolo, sen gío come persona trista e matta.
La parola-rima strozza, riferita alla gola squarciata di Curione, avvia una terzina di rime in sonorità aspra (strozza : mozza : sozza) che ferma l’immagine sul gesto
14. L’episodio è ripreso in I fatti di Cesare, a cura di L. Banchi, Bologna, Romagnoli, 1863, p. 74-75.
15. Sulla questione vd. le osservazioni di M. Pastore Stocchi, s.v. Curione, in ED, vol. ii pp. 289-90.
pasquale stoppelli
858
ripugnante del dannato a cui sono amputate le mani e i cui moncherini solle-vati in aria buttano sangue lordandogli la faccia. È Mosca de’ Lamberti. Colui che con la frase « Cosa fatta capo ha » avrebbe dato origine alla lotte tra le fa-miglie dei Buondelmonti e Amidei, causa prima del costituirsi in Firenze del-le fazioni guelfa e ghibellina. Dante, che pagherà di persona le conseguenze di quelle lotte civili, non può trattenersi dal rinfacciare a lui che quelle sue paro-le furono all’origine dell’estinzione di tutta la sua discendenza.
La galleria di fatti cruenti di epoche lontanissime, del recente passato, del presente o ancora da accadere, appiattiti nella prospettiva dell’eternità, diven-tano un campionario di eventi che documentano la discordia come uno dei motori della storia umana. Ma si approssima l’ultima scena, la piú sconvolgen-te. Prima di affrontarla è il caso di fare alcune considerazioni: qui i dannati sembrano non avere alcuna vergogna della loro condizione, non si nascondo-no, non tengono celati i loro nomi, come altri fanno quando scontano la pena di colpe infamanti; anzi li esibiscono, mettono in evidenza i corpi mutilati, vogliono che quel vivo si ricordi di loro. Non sembrano avere consapevolezza delle conseguenze nefaste del loro agire terreno: in questo sono veramente tutti tristi e matti. Anzi si rivolgono a Dante con il verbo all’imperativo e con una loquacità insistente, quasi a obbligarlo a conservare memoria di loro. Ma-ometto: « Or vedi com’io mi dilacco »; Pier da Medicina: « Rimèmbriti da Pier da Medicina »; Mosca dei Lamberti: « Ricordera’ti anche del Mosca ».
Un’altra considerazione riguarda il modo in cui Dante conduce la narrazio-ne. Dopo le similitudini iniziali, la prima ispirata dal compianto di Bertran de Born per la morte del Re giovane e poi quella della botte sfondata, Dante non ne introduce altre, eppure ciò che vede è davvero inusuale. La similitudine è uno degli strumenti fondamentali del realismo dantesco. Per dare un’idea d’insieme della nona bolgia Dante aveva inventato la scena di tutti i morti e tutti i feriti di tutte le guerre, ecc. Ma, per descrivere ciò che nel dettaglio si offre al suo sguardo, non c’è nulla da portare, neppure ipoteticamente, a para-gone. La realtà è talmente insolita che può soltanto parlare da sé. Cosa com-porta questo nella strategia del racconto? che Dante ricorra a una modalità di narrazione che mette il lettore direttamente dinanzi alle scene e ai personaggi narrati, facendo ricorso continuamente a verba videndi. Non è l’unica volta che avverrà nella Commedia, ma è impressionante notare qui la numerosità delle ricorrenze:
3 vidi 53 riguardarmi 112 riguardar23 vidi 56 vedrai 113 vidi26 pareva 67 riguardar 118 vidi e veggia28 veder 71 vidi 123 mirava
inferno · canto xxviii
859
29 guardommi 74 veder 130 vedi30 vedi 78 antiveder 131 veggendo31 vedi 83 vide 132 vedi34 vedi 87 vedere 43 muse 93 veduta
Dietro questa modalità di racconto c’è l’Apocalisse e un modello retorico fun-zionale a una narrazione di fatti eccezionali che mira al massimo dell’oggetti-vità.16 Ad esempio, cosí si legge in Apoc., 5:
1 et vidi in dextera sedentis super thronum librum scriptum, etc.2 et vidi angelum fortem praedicantem voce magna, etc.3 et nemo poterat in caelo neque in terra neque subtus terram aperire librum neque
respicere illum4 et ego flebam multum quoniam nemo dignus inventus est aperire librum nec vi-
dere eum6 et vidi et ecce in medio throni, etc.11 et vidi et audivi vocem angelorum, ecc.
Si approssima dunque l’ultima scena, la piú incredibile, che riguarda appunto Bertran de Born. L’eccellenza nella poesia che Dante riconosce al trovatore nel De vulgari eloquentia e la virtú della liberalità attestatagli dal Convivio (iv 11 14) non gli sono giovate ai fini della salvezza. La scala dei valori umani non corrisponde a quella dei valori divini, come per Farinata, Brunetto, il Mosca e gli altri « ch’a ben far puoser li ’ngegni » (Inf., vi 81) e che ora popolano l’infer-no. Nei canzonieri provenzali che trasmettevano le poesie di Bertran, Dante poteva leggere una vida del poeta, oggi diremmo una scheda biografica:
Bertrans de Born si fo uns castellans de l’evescat de Peiregos, seigner d’un castel que avia nom Autafort. Totz tems ac gerra ab totz los sieus vezins: ab lo comte de Peire-gos et ab lo vescomte de Lemotgas et ab son fraire Constantin et ab En Richart, tant qant fo coms de Peiteus. Bons cavalliers fo e bons gerriers e bons dompneiaire e bons trobaire e savis e ben parlans; e saup tractar mals e bens; et era seigner totas vez, qan se volia, del rei Henric d’Englaterra e del fill de lui. Mas totz temps volia qu’ill agues-son gerra ensems lo paire e-l fills, e-ill fraire l’uns ab l’autre; e totz temps volc que-l reis de Franssa e-l reis d’Englaterra agessen gerra ensems. E s’il avian patz ni treva, ades se penava e·is percassava ab sos sirventes de desfar la patz, e demostrava cum chascuns era desonratz en la patz; e si n’ac de grans bens e de grans mals d’aisso q’el mesclet entre lor; e si en fetz mains bons sirventes dels cals en a aissi plusors escritz.17
16. Lo suggerisce Th. Peterson, Canto xxviii. Scandal and Schism, in Lect. Dant. c.-by-c., Inf., pp. 368-777 [sic?], partic. a p. 376.
17. ‘Bertran de Born fu castellano del vescovato di Perigueux; era signore di un castello detto
pasquale stoppelli
860
Dunque Bertran aveva messo discordia fra padre e figlio, aveva osato infrange-re il vincolo piú stretto che esiste fra gli uomini: la pena non può che essere adeguata all’enormità dell’azione, e infatti ora si aggira per la bolgia portando la testa in mano, sospesa come una lanterna. La cosa è talmente incredibile che Dante è costretto ancora a richiamare il lettore sulla straordinarierà della visio-ne (vv.112-17):
Ma io rimasi a riguardar lo stuolo, e vidi cosa ch’io avrei paura, sanza piú prova, di contarla solo; se non che coscienza m’assicura, la buona compagnia che l’uom francheggia sotto l’asbergo del sentirsi pura.
Aver richiamato in precedenza la testimonianza di Livio (« come Livio scrive, che non erra », v. 12) era stato sufficiente allora a conferire certezza alle cose dette. A certificare la verità di ciò che sta per raccontare non ci sono auctores da allegare né strumenti retorici adeguati. Non c’è figura di preterizione che val-ga. Non resta che far appello alla purezza della propria coscienza e dunque alla verità che sempre accompagna l’uomo giusto. Già nei canti xvi 124 sgg. e xxv 46 sgg. il poeta aveva fatto ricorso a dichiarazioni consimili. Ma ecco la scena (vv. 118-26):
Io vidi certo, e ancor par ch’io ’l veggia, un busto sanza capo andar sí come andavan li altri de la trista greggia; e ’l capo tronco tenea per le chiome, pesol con mano a guisa di lanterna: e quel mirava noi e dicea: « Oh me! ». Di sé facea a sé stesso lucerna, ed eran due in uno e uno in due; com’esser può, quei sa che sí governa.
d’Altaforte. Visse in guerra continua con tutti i suoi vicini: il conte di Perigueux, il visconte di Limoges, suo fratello Costantino e Riccardo, per tutto il tempo che questi fu conte di Poitiers. Fu buon cavaliere e buon guerriero; sapeva ben praticare il servizio d’amore; era buon trovatore, colto e facondo; ed ebbe familiarità col male come col bene. Teneva in soggezione, tutte le volte che voleva, il re Enrico d’Inghilterra e suo figlio. Ma egli voleva che ci fosse sempre guerra fra padre e figlio e tra fratelli, gli uni contro gli altri; e sempre desiderò che il re di Francia e il re d’In-ghilterra si facessero guerra. E se essi concludevano una pace o una tregua, se ne dava pena e procacciava coi suoi sirventesi di farla rompere, sostenendo che la pace ricopriva entrambi di di-sonore. Ebbe grandi vantaggi e grandi perdite per aver messo i due l’uno contro l’altro. Compose su questo argomento molti buoni sirventesi, dei quali i piú sono qui trascritti’.
inferno · canto xxviii
861
Dante sta descrivendo l’impossibile e lo fa con il massimo dell’oggettività. Ma non è ancora tutto. Segue un gesto che fissa anche per questo dannato un fer-mo immagine: quando Bertran arriva ai piedi del ponte leva in alto il braccio con tutta la testa per permettere a Dante di ascoltare piú da vicino le sue paro-le (vv. 127-29):
Quando diritto al piè del ponte fue, levò ’l braccio alto con tutta la testa per appressarne le parole sue [. . .]
Il tono della descrizione è ancora pianamente narrativo, riconducibile a una normalità e a una naturalezza che rendono, per contrasto, ancora piú grotte-sco, se non addirittura sconvolgente, il gesto del dannato che solleva la testa per avvicinare a Dante e Virgilio le sue parole. Ci si chiede come sia possibile raccontare con tale naturalezza un gesto originato da una immaginazione cosí potente; non suoni aspri, né rime rare, endecasillabi tronchi e sdruccioli o altri espedienti tecnici: soltanto una rima franta (« Oh me! »), a sottolineare anche sul piano formale la separazione del capo dal tronco. « Il prodigio orrendo pare ripercuotersi nell’uso acerbissimo della rima spezzata », ha osservato Edoardo Sanguineti.18 Per descrivere un assurdo cosí assurdo la scelta retorica-mente piú efficace è l’approssimazione a una sorta di grado zero del racconta-re.
Ma la scena del decollato che cammina reggendo la testa mozzata non è invenzione dantesca. Nella tradizione agiografica medievale si raccontava di martiri cristiani decapitati che avrebbero raccolto da terra la testa dopo il sup-plizio.19 Sono i cosiddetti santi cefalofori. San Miniato, primo martire nella città di Firenze, apparteneva a questa schiera: dopo la decapitazione si sarebbe incamminato con la testa in mano sul monte dove oggi sorge la basilica a lui intitolata. Ma nel racconto di Dante la testa non è solo un pezzo perduto che si raccatta; quella di Bertran de Born conserva per intero le facoltà di razioci-nio e di parola. Il tronco senza testa e la testa senza tronco mantengono le loro funzioni. Come questo possa essere, dice Dante, lo sa solo Dio (« quei sa che sí governa », v. 126). Dante trasforma in pena infernale un evento miracoloso,
pasquale stoppelli
862
18. Sanguineti, Interpretazione di Malebolge, cit., p. 307.19. Già N. Zingarelli, Bertran de Born e la sua bolgia, in « Rivista d’Italia », a. xi 1908, pp. 698-714,
mise in evidenza il rovesciamento infernale del miracolo cristiano. P. Beltrami, L’epica di Malebol-ge (ancora su ‘Inferno’, xxviii), in SD, vol. lxv 2000, pp. 119-52, partic. a p. 148, fa notare come anche nella Tebaide di Stazio (v 236-40) si legga di una testa spiccata dal busto, e tuttavia etiamnum in murmure, ‘ancora mormorante’.
rovesciandone il segno. La santità guadagnata col martirio, e rivelata tangibil-mente dal corpo privo di testa che si avvia dopo averla raccattata, diventa la pena suprema del dannato fomentatore di odi.
Si diceva in precedenza della loquacità un po’ esibizionistica dei dannati di questa bolgia. Non cosí Bertran. Lui non è un istigatore, come Curione o Mo-sca dei Lamberti; lui è un intellettuale che ha fatto delle guerre e degli odi che le alimentano l’interesse della sua vita, e siccome è stato anche un poeta, anzi un poeta tra i piú grandi, le guerre avevano assunto in lui anche una dimensio-ne estetica. « Visse in guerra con tutti i suoi vicini » recita una delle due vidas del poeta provenzale che accompagnano nei codici le sue poesie; e ancora, come abbiamo letto, « egli voleva che ci fosse sempre guerra tra padre e figlio, tra fratello e fratello, l’uno con l’altro ». E da intellettuale qual è, Bertran non esita a parafrasare Geremia (« O vos omnes qui transitis per viam, adtendite et videte si est dolor ut dolor meus », Lam., 1 12) per sollecitare Dante ad avere pietà della sua condizione (vv. 130-32):
[. . .] Or vedi la pena molesta, tu che, spirando, vai veggendo i morti: vedi s’alcuna è grande come questa.
Il grido del profeta, già riformulato da Dante nei sonetti della Vita nuova: O voi che per la via d’Amor passate (ed. Barbi, vii 3-6; ed. Gorni ii, 14-17) e Deh peregrini che pensosi andate (xl 9-10 / xxix 9-10)20 è utile ancora qui nel contesto inferna-le a conferire un’alta drammaticità alla scena per lo stridore del registro alto di quelle parole con la condizione degradata del dannato, anch’egli una delle « ombre triste smozzicate » (Inf., xxix 6) della bolgia. E poi continua (vv. 133-42):
E perché tu di me novella porti, sappi ch’i’ son Bertran dal Bornio, quelli che diedi al re giovane i ma’ conforti. Io feci il padre e ’l figlio in sé ribelli; Achitofèl non fé piú d’Absalone e di Davíd coi malvagi punzelli. Perch’io parti’ cosí giunte persone, partito porto il mio cerebro, lasso!, dal suo principio ch’è in questo troncone. Cosí s’osserva in me lo contrapasso ».
inferno · canto xxviii
863
20. Le parole di Geremia saranno riprese, seppure in maniera piú coperta, anche in Inf., xxx 58-61.
L’ulteriore richiamo ad Achitofel, che istigò Absalonne contro il re David suo padre, e che in conseguenza di questo si impiccò (ii Reg., 15-17), divenendo negli scrittori cristiani figura di Giuda, conferma la statura eccezionale di Ber-tran rispetto agli altri dannati della bolgia. Il rilievo estetico fa aggio in questo caso sul giudizio etico, ma è moralmente una tragica aggravante, non un rico-noscimento all’altezza dell’arte.
*
Questo canto degli scismatici è uno spettacolo disgustoso, ma di modo che dalle minugia e dalla corata, passando per la figura non ignobile di Mosca Lamberti, il disgusto si purifica e si idealizza fino al sublime dell’orrore: è una materia putrida che si organizza a poco a poco, insino a che ne scintilla una sublime creazione.
Queste parole di Francesco De Sanctis, estratte dalle lezioni del secondo anno del corso torinese (inverno-primavera del 1855), potrebbero fungere da epigra-fe a un excursus sulla fortuna critica del canto in età moderna, contenendo in nuce molti o forse addirittura tutti gli argomenti che i commentatori successivi, con varie gradazioni, avrebbero sviluppato.21 Da un lato il realismo di una rappresentazione disgustosa, dall’altro “il sublime dell’orrore”. Sui dannati della bolgia degli scismatici il critico ritornerà ancora nella Lezione ix sull’In-ferno del periodo zurighese (1856-59), intitolata appunto al Sublime (ivi, pp. 446-47):
Bertram dal Bornio è un personaggio vile, oscuro; ma la colpa da lui commessa isolata da lui ha il sublime dell’orrore. Il che ci spiega il genere di poesia che è nel canto degli scismatici. Costoro sono appena indicati a nome; e l’essenziale della poe-sia è nella descrizione della pena, immagine sensibile della colpa, essendo i colpevoli Seminator di scandalo e di scisma, cosí scissi e laceri nelle membra come sono gli animi di coloro tra i quali essi hanno posto discordia. [. . .] Cosí dal sublime di Farinata e Capaneo, cioè a dire dal sublime del colpevole, siamo discesi al sublime della colpa.
E poi ancora, nella Lezione xii della stessa serie, intitolata al Disgustoso (ivi, pp. 452-53):
Il disgustoso esce dal seno stesso del sublime. Aggiungete al capo senza busto di Ber-tram dal Bornio, i tendini, i nervi, le cervella che schizzano, ecc.; il sublime sparisce sotto il disgustoso. Un campo di battaglia visto nel suo insieme è sublime, destando
21. De Sanctis, Lezioni, pp. 266-67. Le lezioni del periodo torinese furono pubblicate la prima volta in F. De Sanctis, Lezioni inedite della ‘Divina Commedia’. I corsi torinesi del 1854-55, a cura di M.M., Napoli, Morano, 1938.
pasquale stoppelli
864
le idee del nulla, delle morti, delle catastrofi, delle cadute degli imperi, ecc. Sedata questa impressione e veduto nei suoi particolari accidenti, il sublime dà luogo al disgustoso.
Sublime e disgustoso (retoricamente, gli estremi di tragico e comico) si gene-rerebbero dunque in questo canto l’uno dall’altro, intimamente connessi. Vo-lendo per chiarezza dipanare l’intreccio delle due tipologie, potremmo rico-noscere al sublime la dichiarazione iniziale di indicibilità; la grande similitudi-ne dei morti e dei feriti delle guerre del Mezzogiorno d’Italia con la relativa eco bertrandiana; le filigrane epiche profuse a larghe mani nel canto, tra cui di maggiore evidenza quella virgiliana che è dietro le prime sette terzine: « Quis cladem illius noctis, qui funera fando / explicet aut possit lacrimis aequare la-bores » (Aen., ii 361-62), svelata dal v. 20 « [. . .] d’aequar sarebbe nulla »; infine i richiami biblici nell’episodio di Bertran. All’orrido e al disgustoso andrebbero invece ascritti i corpi smembrati, gli organi interni a vista, il sangue, i gesti burattineschi dei dannati.
Passando sopra la mezza pagina dedicata al xxviii dell’Inferno da Benedetto Croce, che sembra poco ben disposto a spendere parole sui dannati di questa bolgia, salvando peraltro del canto solo qualche verso isolato (« Il resto è forse piú etico che profetico »),22 gli interpreti successivi, pur non avendo potuto ancora leggere le lezioni torinesi e zurighesi di De Sanctis, pubblicate rispetti-vamente nel 1938 e nel 1955, esprimono giudizi sostanzialmente simili al suo per quanto riguarda l’alternarsi di alto e basso nello stile del canto, che viene tuttavia messo in relazione col modo di essere e di porsi dei singoli personaggi.
L’impegno maggiore in questa direzione è stato profuso da Vittorio Rossi in un saggio del 1918, ripubblicato nel 1930, e poi nel commento all’Inferno del 1923.23 Il critico nota una variazione sostanziale di toni da figure squallide co-me quella di Maometto al personaggio di Bertran, passando per Pier da Medi-cina e Mosca dei Lamberti, « da una rappresentazione ch’è un’orgia di ribut-tante realismo a una rappresentazione cinta di pietà e attonita di stupor religio-so ».24 Su Maometto si concentrerebbe, secondo Rossi, il massimo degrado dei personaggi di questa bolgia: « [. . .] sanguina nella gran mole d’un omaccione panciuto; e la sua goffa anima volgare si manifesta in gesti e parole che spen-gono la pietà ch’egli vorrebbe destare » (ivi, p. 483). Nel saggio del 1930 Rossi
22. B. Croce, La poesia di Dante, Bari, Laterza, 1921, p. 100.23. V. Rossi, Maometto, Pier da Medicina e compagni nell’Inferno dantesco, in Id., Saggi e discorsi su
Dante, Firenze, Sansoni, 1930, pp. 157-75. Ora leggibile in Rossi(-Frascíno), pp. 482-94.24. Rossi(-Frascíno), p. 487.
inferno · canto xxviii
865
userà nei confronti del personaggio espressioni ancora piú forti: « [. . .] il poeta diguazza in una descrizione di quello scempio, copiosa e precisa di particola-rità nauseabonde, nauseabonda essa stessa di parole basse »;25 quindi continua: « Ah quel corpaccio sbudellato, in piedi su una gamba sola, e partirsi movendo un passo lento e strisciato, come un ballerino! Vien voglia di ridere ».26 Dun-que addirittura un tratto di involontaria comicità nella descrizione di Mao-metto. Originale, poi, il giudizio che Rossi dà della figura di Pier da Medicina e del messaggio solo apparentemente buono (ma in realtà, secondo Rossi, perfidamente mendace) da lui inviato « a’ due miglior da Fano » sul tradimen-to a cui a breve sarebbero andati incontro:27
Forse il messaggio è un triste inganno del dannato, e il tradimento, di cui non serbano memoria le cronache di Romagna, una trovata del poeta intesa a colorire il carattere di Piero, che seguitando laggiú a far la sua arte di mettimale, vorrebbe con quel suo falso presagio gettare nel cuore dei due fanesi germi d’odio contro Malatestino, si-gnore di Rimini.
Attilio Momigliano, che nel suo commento alla Commedia giudica « scialbe e alquanto retoriche » le terzine d’esordio del canto, dedica anch’egli particolare attenzione a Pier da Medicina, giudicandolo addirittura uno dei personaggi danteschi piú complessi. La complessità del carattere risulterebbe dalla predi-zione di un terribile omicidio e nello scherzarci su macabramente. Questo dannato, scrive Momigliano, « che aveva cominciato a parlare con una dignità e una delicatezza affascinante, finisce per apparire il piú barbaro denunziatore dei suoi compagni di pena di tutto l’Inferno ».28
Non diversamente da Rossi e Momigliano, Carlo Grabher dà anch’egli una lettura del canto basata sulla psicologia dei personaggi, arrivando tuttavia a conclusioni opposte.29 Riconosce intanto, contro l’opinione di Momigliano, tutt’altro che malriuscita la similitudine iniziale, utile a creare mirabilmente l’atmosfera che sarà propria dell’intera bolgia. Ma è soprattutto contro l’idea
pasquale stoppelli
866
25. Rossi, Maometto, Pier da Medicina, cit., p. 160.26. Ivi, p. 163. Questa opinione sembra inscrivere il Maometto dantesco in quella che oggi
potrebbe essere definita un’estetica pulp, riassumibile in questi termini: « [. . .] una sorta di realismo fuori misura, cosí enfatizzato da trapassare nel suo contrario e convivere con un’astrazione stiliz-zata ai limiti del manierismo e della parodia, che di continuo ironizza sui linguaggi che mette in scena » (M. Sinibaldi, Pulp. La letteratura nell’era della simultaneità, Roma, Donzelli, 1997, p. 40).
27. Rossi(-Frascíno), p. 484.28. Momigliano, ch. ad ll.29. C. Grabher, Su alcune interpretazioni del canto xxviii dell’‘Inferno’, in Studi letterari. Miscellanea in
onore di Emilio Santini, Palermo, Manfredi, 1956, pp. 129-58.
espressa da Rossi di una comicità involontaria per eccesso di realismo che si appuntano le sue osservazioni. In Maometto, in particolare, non ci sarebbe nulla di buffonesco. Se in lui ci fosse volgarità buffonesca, osserva Grabher, ciò lo sottrarrebbe alla sconfitta e alla pena: in lui è piuttosto la consapevolezza del vinto. In definitiva, tutti i personaggi del canto sarebbero immersi in un clima di tragedia assoluta.
Una svolta interpretativa nel metodo di lettura si avrà con un saggio del 1958 di Mario Fubini, raccolto anni dopo con qualche variante in un volumetto di suoi studi danteschi.30 Il critico sposta l’attenzione dai personaggi alla fisiono-mia del canto. Qui, meglio che negli altri canti di Malebolge, Dante darebbe prova, secondo Fubini, della « sua eccelsa capacità d’artefice ». Dunque, anzi-tutto una prova di alta retorica. Già nell’esordio apparirebbe l’intenzione di assumere una materia orrida, tipicamente medievale, entro schemi e moduli atteggiati classicamente, al fine di provarsi in quella poesia delle armi di cui egli stesso nel De vulgari eloquentia aveva riconosciuto la mancanza nel volgare del sí. Del resto già pochi canti piú indietro, con « Io vidi già cavalier muover cam-po », ecc. (Inf., xxii 1-12), il poeta avrebbe fatto un tentativo nella stessa direzio-ne. Ma la difficoltà a cui Dante sarebbe andato incontro consisteva nell’inte-grare una materia che tradizionalmente faceva riferimento a grandi fatti della storia entro un quadro eticamente definito dalla colpa e rappresentato visiva-mente da mutilazioni vergognose. Tradotto in termini retorici, ciò comporta-va la compresenza nel tessuto del canto di squarci epici, sostenuti da richiami classici o biblici, con modi, costrutti, vocaboli della tradizione piú bassa. Ne conseguiva che, se la poesia delle armi celebrava la bellezza della guerra ed era costruita sull’azione di grandi personaggi, nel canto xxviii non abbiamo per-sonaggi, ma poco piú che nomi.
Anni piú tardi Ettore Paratore, prendendo le mosse dall’episodio di Curio-ne e dal suo raffronto con la fonte lucanea, correggerà in parte l’interpretazio-ne di Fubini, escludendo che in Dante ci fosse un intento di misurarsi nell’e-pica delle azioni guerresche. La guerra sarebbe infatti da lui descritta esclusi-vamente negli effetti distruttori. È vero che il motivo della guerra attraversa l’intero canto, ma la guerra, osserva Paratore, è in Dante sempre rovina, strage, manifestazione funesta degli odi e delle discordie. Arriva quindi egli a questo giudizio conclusivo sulla supposta volontà di Dante di mettersi alla prova nel-la poesia delle armi:31
30. M. Fubini, Di alcune interpretazioni del canto xxviii dell’‘Inferno’, in Id., Il peccato di Ulisse e altri scritti danteschi, Milano-Napoli, Ricciardi, 1966, pp. 77-100.
31. E. Paratore, Il canto xxviii dell’‘Inferno’, in Lett. C.d.D., Inf., pp. 683-704, la cit. è a p. 697.
inferno · canto xxviii
867
Non dunque la poesia, il canto delle armi, come vuole il Fubini, ma la poesia amara e cupa dei lagrimevoli ossari, del compianto sulla furia sterminatrice, quando se ne contemplano gli spaventosi effetti. E ciò anche se il canto termina con la figura di Bertram dal Bornio, il poeta del « gioioso armeggiare ».
Si concentra specificamente sul personaggio di Bertran un saggio di Michelan-gelo Picone, nel quale ci si chiede perché, dopo il giudizio positivo espresso su di lui da Dante nel De vulgari eloquentia e nel Convivio, il poeta provenzale sa-rebbe approdato alla condizione di anima « smozzicata » nel xxviii dell’Infer-no.32 Sicuramente ci sarebbe stata un’evoluzione nel pensiero dantesco nel percorso che dai trattati porta al poema, suggerita forse anche da quello che Dante poteva aver letto in una delle due vidas del poeta provenzale. Ma già l’incipit del canto xxii (« Io vidi gia cavalier muover campo », ecc.), introdotto a commento del gesto scurrile di Malacoda a conclusione del canto precedente, sarebbe stato « una parodia dissacrante di uno dei sirventesi piú puri e idealiz-zanti di Bertran (Be·m plats) ». Bertran, che da poeta modello della salus diventa, come osserva Picone, utile a commentare un gesto scatologico, mostra gli ef-fetti degradati di quella poesia allorché sia disgiunta da finalità provvidenziali. Dunque, tutt’altro che un tentativo di Dante di provarsi nella poesia delle ar-mi: anzi, all’opposto, un prenderne le distanze.
Tra gli studi piú rilevanti del secolo scorso è anche da ricordare un saggio di Anna Maria Chiavacci Leonardi.33 Vi si possono leggere interessanti conside-razioni sulla differenza che correrebbe fra epica classica ed epica dantesca. Nel canto vi dell’Eneide Enea, vivo, incontra dei morti (Anchise, Didone, Deifobo) che sono personaggi raggelati nell’immagine in cui il mito li aveva fissati. An-che Dante è vivo, ma nei morti che incontra si sente ancora pulsare la vita. Ne consegue che nell’aldilà dantesco tutto è contemporaneo: maestro Adamo, piccolo falsario della cronaca duecentesca, è punito fianco a fianco alla biblica moglie di Putifarre e a Sinone, personaggio dell’Eneide; il fondatore dell’islam si occupa del modesto fra Dolcino. I personaggi della storia o del mito, appiat-titi nel presente, diventerebbero le icone di un campionario di eventi che do-cumenta la discordia umana. Anche il lettore finirebbe per essere coinvolto in queste storie, diventando contemporaneo dei personaggi narrati. All’appiatti-mento storico conseguirebbe l’appiattimento dei ruoli e del rilievo dei perso-naggi: nell’aldilà dantesco le differenze di status sono drasticamente pareggiate. A connotarle resta il piano dello stile, che il poeta con maestria adegua alla
pasquale stoppelli
868
32. M. Picone, I trovatori di Dante: Bertran de Born, in « Studi e problemi di critica testuale », n. 19 ottobre 1979, pp. 71-94.
33. A.M. Chiavacci Leonardi, Il canto xxviii dell’‘Inferno’, in L’A, n.s., nn. 1-2 1993, pp. 41-57.
natura e alla statura del personaggio. A questo proposito la stessa studiosa, nell’introduzione al canto xxviii del suo commento all’Inferno, aveva scritto dell’esistenza di un doppio livello stilistico del canto: uno « aspro e petroso », con le immagini crude delle membra lacerate; un altro nel quale « prende voce quella superiore pietà che tutto avvolge, e commisera, insieme alle vitti-me, anche gli sciagurati colpevoli ».34
Le letture critiche dal 2000 in poi non mirano tanto a riassumere il canto in una formula che ne difinisca la caratteristica prevalente, quanto a commentar-lo luogo per luogo e a mettere in risalto gli aspetti tecnici, formali, stilistici o i riferimenti intertestuali e intratestuali che il progresso degli studi in ambito linguistico e filologico ha intanto reso possibile. L’indagine retorica sembra infatti essere qui la piú opportuna per ricondurre a unità elementi testuali ap-parentemente contraddittori. Cosí l’analisi di Pietro Beltrami è volta soprat-tutto a descrivere le caratteristiche, sul piano dello stile, di quella che il critico definisce, in relazione a questo canto, l’epica infernale di Dante, un’epica « della mescolanza, del cozzo e della composizione degli stili », fatta da un lato di perifrasi retoricamente elaborate, di ripresa di immagini e di luoghi dai poemi classici, dall’altro di un lessico basso e di rime tronche e sdrucciole, se-gnali queste ultime di un genere minore.35 Paola Allegretti, in due articoli successivi, scrutinerà con attenzione tutti i luoghi del canto al fine di mettere in evidenza le riprese, alcune delle quali non prima segnalate, dai poemi clas-sici (l’Eneide in primo luogo), dalla Bibbia, oltre che naturalmente da Bertran.36 Matteo Durante aveva intanto percorso il testo, verso dopo verso, esercitando-si in un’analisi linguistica e retorica minutissima.37 Di altri studi recenti riferi-ti ad aspetti particolari si è già data notizia nella prima parte di questa lettura.
Pasquale Stoppelli
inferno · canto xxviii
869
34. Chiavacci Leonardi, i pp. 825-30, a p. 827.35. Beltrami, L’epica di Malebolge, cit., p. 133 e passim.36. P. Allegretti, Canto xxviii, in Lect. Dant. Tur., Inf., pp. 393-406; e Ead., Chi poria mai pur con
parole sciolte (‘Inferno’, xxviii), in Tenz, n. 2 2001, pp. 9-13.37. M. Durante, Sul xxviii dell’‘Inferno’, in Studi di filologia e letteratura italiana in onore di Gianvito
Resta, Roma, Salerno Editrice, 2000, pp. 143-85.
![Page 1: Lettura di "Inferno XXVIII" [2013]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022300/6320a8fcc5de3ed8a70dd3e8/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Lettura di "Inferno XXVIII" [2013]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022300/6320a8fcc5de3ed8a70dd3e8/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Lettura di "Inferno XXVIII" [2013]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022300/6320a8fcc5de3ed8a70dd3e8/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Lettura di "Inferno XXVIII" [2013]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022300/6320a8fcc5de3ed8a70dd3e8/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Lettura di "Inferno XXVIII" [2013]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022300/6320a8fcc5de3ed8a70dd3e8/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Lettura di "Inferno XXVIII" [2013]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022300/6320a8fcc5de3ed8a70dd3e8/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Lettura di "Inferno XXVIII" [2013]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022300/6320a8fcc5de3ed8a70dd3e8/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Lettura di "Inferno XXVIII" [2013]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022300/6320a8fcc5de3ed8a70dd3e8/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Lettura di "Inferno XXVIII" [2013]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022300/6320a8fcc5de3ed8a70dd3e8/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Lettura di "Inferno XXVIII" [2013]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022300/6320a8fcc5de3ed8a70dd3e8/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Lettura di "Inferno XXVIII" [2013]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022300/6320a8fcc5de3ed8a70dd3e8/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Lettura di "Inferno XXVIII" [2013]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022300/6320a8fcc5de3ed8a70dd3e8/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Lettura di "Inferno XXVIII" [2013]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022300/6320a8fcc5de3ed8a70dd3e8/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Lettura di "Inferno XXVIII" [2013]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022300/6320a8fcc5de3ed8a70dd3e8/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Lettura di "Inferno XXVIII" [2013]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022300/6320a8fcc5de3ed8a70dd3e8/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Lettura di "Inferno XXVIII" [2013]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022300/6320a8fcc5de3ed8a70dd3e8/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Lettura di "Inferno XXVIII" [2013]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022300/6320a8fcc5de3ed8a70dd3e8/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Lettura di "Inferno XXVIII" [2013]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022300/6320a8fcc5de3ed8a70dd3e8/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: Lettura di "Inferno XXVIII" [2013]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022300/6320a8fcc5de3ed8a70dd3e8/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: Lettura di "Inferno XXVIII" [2013]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022300/6320a8fcc5de3ed8a70dd3e8/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Lettura di "Inferno XXVIII" [2013]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022300/6320a8fcc5de3ed8a70dd3e8/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: Lettura di "Inferno XXVIII" [2013]](https://reader038.fdokumen.com/reader038/viewer/2023022300/6320a8fcc5de3ed8a70dd3e8/html5/thumbnails/22.jpg)