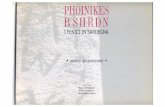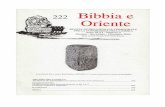Spunti linguistici nella lettura della Bibbia
Transcript of Spunti linguistici nella lettura della Bibbia
1
I
L e p a r o l e e l e c o s e
n e l l ’ A n t i c o T e s t a m e n t o 1. Al principio
Il primo libro dell’Antico Testamento, la Genesi, e uno dei testi teologicamente più densi del Nuovo Testamento, il vangelo di san Giovanni, cominciano esattamente allo stesso modo, Al principio..., inscrivendosi con ciò a pieno titolo nel genere letterario dei cosiddetti ‘racconti di inizio’1. E tutti e due i testi mettono fin dai primi versetti in primissimo piano la nozione di ‘parola’, per di più collegandola strettamente entrambi, sia pure con modalità diverse, a quella di ‘azione’. Sia nell’Antico Testamento sia nel Nuovo i rispettivi termini chiave che designano la nozione di ‘parola’ — dabar in ebraico e logos in greco — sono polisemici, ossia hanno più significati. La loro polisemia però si estende in direzioni diverse, di maniera che le due serie di significati non sono sovrapponibili. Per cercare di cogliere il senso di tale diversità è preferibile procedere con ordine; perciò in questo capitolo ci occuperemo dell’Antico Testamento, e riserveremo il prossimo al quarto vangelo. Il contatto con testi antichi implica sempre lo sforzo di uscire dalle proprie abitudini e conformazioni mentali, per attingere articolazioni concettuali e costellazioni semantiche a cui non si è avvezzi. Tanto più consistente dovrà essere lo sforzo dovendosi accostare alle tematiche dei più antichi libri biblici dell’Antico Testamento, espresse oltre tutto in una lingua dalla struttura assai differente. In questo caso è inevitabile legare l’indagine sul contenuto culturale e teologico dei testi alla forma linguistica nella quale quel contenuto è formulato, e domandarsi che rapporto c’è tra lingua e mentalità. A rischio di aver l’impressione di partire da troppo lontano, è opportuno intanto schizzare discorsivamente una serie di primi elementi linguistici, inizialmente soprattutto d’ordine semantico, al fine di prevenire certi errori metodologici facili a 1 Su tale genere letterario in rapporto al libro della Genesi v. lo studio di P. Gibert, Bibbia, miti e racconti dell’inizio (1986), Queriniana, Brescia 1993.
2
commettersi e di fatto spesso commessi. Partiamo perciò da qualcosa di familiare, utile sia già ora per i temi veterotestamentari sia più avanti per le questioni giovannee. 2. Parole polisemiche2
Che significano le parole riso, cattedra, tirare, vero, potere? E che cosa hanno in comune con dabar o con logos queste parole di uso corrente? Una cosa almeno: quella di avere ‘più significati’ o meglio ‘più accezioni’, di essere polisemiche3. E tuttavia le parole della lista non ‘significano più cose’ tutte allo stesso modo. Si ritiene comunemente che quello di riso non sia un caso di polisemia ma di omonimia: non una parola a due significati ma due parole distinte, che infatti hanno etimologie differenti. In verità, accogliendo il criterio etimologico bisognerebbe dire allora che coppia e copula sono la stessa parola; ma, per non sottilizzare troppo, ammettiamo pure che i riso siano due. E quello di cattedra (“seggio-scrivania” e “insegnamento”) è un caso di omonimia o di polisemia? Né l’uno né l’altro, si dirà: c’è un solo significato fondamentale e una sua estensione metaforica. Bene; e qual è il ‘significato fondamentale’ di tirare (che ha un’etimologia controversa), “trarre a sé” o “allontanare da sé”? I due significati sono evidentemente ben distinti, ma per questo si dirà che si tratta anche di due parole distinte? Distinti sono anche i significati di vero, “reale” e “conforme a verità”, infatti una vera denuncia non è necessariamente anche una denuncia vera: sono anche queste due parole distinte? In realtà i due significati di tirare sono, nonché distinti, alternativi, sicché una frase come tira la corda! più che polisemica la si direbbe ambigua in quanto richiede che il contesto chiarisca se la corda è da avvicinare verso di sé o da lanciare. Per vero le cose paiono andare diversamente; i suoi significati sono piuttosto distinguibili parafrasticamente che distinti o tanto meno alternativi: in che senso è vera la cronaca di Cronaca vera? non c’è qui la presenza, indistinguibile, di “reale, effettiva” e “veritiera”? Possiamo forse dire che tirare significa o “avvicinare” oppure “allontanare”, mentre vero significa sia “reale” e sia “rispondente a verità”. La mancata esplicitazione del significato nel primo caso compromette la comunicazione, nel secondo la rende più complessa senza tuttavia bloccarla; non precisare tira la corda produce un effetto di confusione, non precisare
2 In questo paragrafo riprendo, modificandole, le pp. 137-142 del mio Segni e parole nel quarto vangelo. Alle origini del paradigma agostiniano, “La memoria”, Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo, 5 (1989), pp. 135-167, di cui nel seguito vengono sviluppati altri spunti sparsi lì appena accennati. 3 Ai fini della nostra argomentazione non è necessario distinguere, come pure si dovrebbe, tra polisemia e diversità di accezioni. Per una definizione rigorosa di queste nozioni cfr. T. De Mauro, Minisemantica dei linguaggi non verbali e delle lingue, Laterza, Roma-Bari 1982, 19902, alle pp. 98-102 e 118-126.
3
cronaca vera produce un effetto di sovraccarico di significato4.
2.1. I significati di potere La parola potere, però, si dirà, significa solo “potere”, ossia, come spiega il diziona-rio Garzanti, “avere la forza, la facoltà, la capacità, la possibilità, la libertà di fare qual-cosa”: perché l’abbiamo messa fra le parole polisemiche? Vediamo. Se uno domanda posso entrare? qualche persona spiritosa potrebbe rispondergli sì, ma non devi e in tal modo, giocando sul fatto che la domanda in astratto può vertere sulla “capacità” o sulla “facoltà”, ammettere la prima e negare la seconda. Ma non c’è persona spiritosa che alla domanda posso entrare? possa efficacemente rispondere non lo so anche se ha in mente lo stesso gioco semantico, perché in tal modo l’alternativa resterebbe non esplicitata e la risposta incomprensibile. Si dirà ancora: è come per vero, in quanto non sarebbero due significati ma due sfumature di significato che non si escludono vicendevolmente. Però se i due interlocutori parlano in inglese si ha la situazione inversa; alla domanda can I come in? , “ho la capacità d’entrare?” la seconda risposta è possibile non lo so, sono fatti tuoi che è un invito un po’ cavilloso a correggere la formulazione in un più forbito may I come in? , “ho la facoltà d’entrare?”; invece la prima risposta (sì ma non devi) non è possibile perché, in inglese, l’ambiva-lenza nella domanda non può aver luogo. Il gioco si potrebbe complicare supponendo per esempio che chi sta fuori sia incatenato: se lo spiritoso italiano gli dice puoi entrare, con riferimento implicito ma evidentemente esplicitabile alla facoltà, molto probabilmente lo farà arrabbiare, però forse anche sorridere della battuta; se è uno spiritoso inglese a dirgli you may come in, magari lo farà arrabbiare lo stesso, ma sicuramente non lo fa ridere. Insomma, quelle che in italiano sono due semplici sfumature di significato di un’u-
4 Simile è la conclusione a cui perviene J. Lyons, Semantics, 2 voll., Cambridge University Press, Cambridge 1977, p. 569, alla fine del cap. dedicato ad Omonimia e polisemia: «Nella misura in cui l’omonimia parziale crea ambiguità nelle frasi, crea un’ambiguità che è insieme lessicale e grammaticale; la polisemia invece, come l’omonimia assoluta (a volerne ammettere l’esistenza), produce ambiguità puramente lessicali».
4
nica parola, in inglese sono due parole diverse, anzi tre perché c’è pure il sostantivo power. E a tal proposito ci si può domandare come suonerebbe in inglese un discorso sul potere impostato all’italiana sull’intreccio dei significati “can”, “may” e “power”.5
2.2. Cinque tipi di polisemia Dunque anche potere è una parola polisemica. Ma se una persona non sa l’inglese come fa a rendersene conto? È la parola potere che ha tre significati oppure sono gli anglofoni a tradurre in tre modi differenti quello che in italiano è un significato unico distinguibile solo dalle persone di spirito? Detto altrimenti: è possibile distinguere le diverse sfumature o accezioni al di fuori della traduzione in parole differenti? Le singole occorrenze di potere racchiudono s e m p r e tutte e tre le accezioni o solo una per volta caso per caso come risulta dalla traduzione inglese? Il significato di potere, cioè, è dato dalla somma delle sue accezioni o si esaurisce volta a volta in ciascuna di esse? È evidente che, a seconda dei casi, potere ‘significa’ — cioè si traduce — a volte can, a volte may, a volte power; ma se ci domandiamo che cosa significa potere, quale sarà la risposta? E riuscirà la nostra risposta ad essere simmetrica a quella relativa, per esempio, alla domanda sul significato della parola inglese match? Risponderemo che quest’ultima ‘significa’ i n s i e m e “fiammifero” “confrontare” e “partita” perché è con l’uno o con l’altro che noi lo traduciamo? Abbiamo brevissimamente sperimentato cinque tipi di polisemia6: polisemia o m o n i m i c a : convergenza dell’esito fonologico di parole dall’origine e dal significato differenti: riso: “cereale” (oryza) e “atto del ridere” (risus); miglio: “unità di misura” (milia) e “cereale” (milium); attitudine: “inclinazione per certe attività” (aptitudo) e “atteggiamento del corpo” (actitudo); polisemia m e t a f o r i c a : estensione figurale del significato di parole originariamente designanti oggetti materiali: cattedra: “seggio-scrivania” e “insegnamento”; cucina: “stanza dove si cucina” e “modo di cucinare”; squadra: “arnese triangolare” e “gruppo di persone”; polisemia e s c l u s i v a : parole con significati a distribuzione complementare: tirare: “avvicinare a sé” e “allontanare da sé”; affittare: “dare in affitto” e “prendere in affitto”; ospite: “chi dà ospitalità” e “chi riceve ospitalità”;
5 Si veda per esempio il seguente passaggio di un discorso del generale Dalla Chiesa: «Potere può essere un sostantivo nel nostro vocabolario ma è anche un verbo [...]. Potere; l’ho sentito questo verbo. Ebbene io l’ho colto e lo voglio sottolineare in tutte le sue espressioni o almeno quelle che così estemporaneamente mi vengono in mente: poter convivere, poter essere sereni, poter guardare in faccia l’interlocutore senza abbassare gli occhi, poter ridere, poter parlare, poter sentire, poter guardare in viso i nostri figli e i figli dei nostri figli senza avere la sensazione di doverci rimproverare qualcosa...» (N. Dalla Chiesa, Delitto imperfetto, Mondadori, Milano 1984, p. 53). 6 Si tratta di una tipologia indipendente e in ogni caso diversa da quella relativa alle cinque cause della poli-semia di cui discorre S. Ullmann, La semantica. Introduzione alla scienza del significato (1962), Il Mulino, Bologna 1966, pp. 255-267.
5
polisemia p a r a f r a s t i c a : parole con significati ad intersezione: vero: “conforme alla verità” e “reale, effettivo”; puro: “privo di mescolanze” e “semplice”; sensibile: “che può essere percepito” e “che ha la capacità di percepire”; polisemia i n t e r i d i o m a t i c a : è quella che risulta dalla caratteristica in virtù della quale le lingue storiconaturali segmentano differentemente l’una dall’altra il continuum semantico; la designiamo così perché, come è stato ben scritto, «il profa-no, ma anche a volte il linguista, va messo dinanzi al confronto di realtà linguistiche di-verse e lontane perché acquisti coscienza della fluidità dei sensi»7. Gli esempi sono tal-mente abbondanti da rendere del tutto superfluo dilungarsi: sono i casi come it. potere / ingl. can, may, power; it. uomo / ted. Mann, Mensch; it. sì / fr. oui, si, ecc. 3. I significati di dabar
La parola ebraica per dire “parola” è un caso interessantissimo di polisemia interidiomatica. Che significa infatti dabar? In testi variamente religiosi, e non solo, accade con qualche frequenza di leggere che dabar ‘significa’ (ossia si traduce) da una parte “parola”, “discorso” e dall’altra “cosa”, “avvenimento”. Tali testi di solito aggiungono che questa ambivalenza semantica è di rilevante portata per intendere appieno il sistema culturale dell’ebraismo e dunque la teologia dell’Antico Testamento. A noi lettori comuni in verità riesce difficile capire come i due significati possano andare insieme, sicché, consapevoli della nostra ignoranza, siamo disposti ad accettare, oltre il dato linguistico per noi incontrollabile, anche le sue asserite profonde conseguenze culturali. Senza avventurarci su terreni sconosciuti, cerchiamo quanto meno di farne una prima ricognizione, osservando il quadro lessico-semantico un po’ più nei dettagli. Allargheremo poi il campo d’osservazione ad altri insospettati fenomeni analoghi, per sboccare infine su riflessioni d’ordine generale a proposito del rapporto tra lingua e mentalità, applicate ai testi biblici.
3.1. Interpretazioni tradizionali Il duplice significato di dabar parrebbe conferire alla lingua ebraica qualità uniche e in qualche modo misteriose, stando almeno a come capita di vederle descritte qua e là a dei lettori sprovveduti quali noi siamo. Uno scrittore italiano specializzatosi in libri biblici, per esempio, ne parla come di «una lingua che stringe nel medesimo termine, dabar, sia l’atto che la parola. Forse nessun altro idioma ha legato a tale responsabilità
7 Così De Mauro, Minisemantica, cit., p. 126, a proposito di quei tipi di sensi che sono le accezioni.
6
il nudo dire umano. Esso si trova all’estremità di un braccio di bilancia, all’altro capo c’è l’avvenimento, il fatto»8. A parte simili spunti letterari, in ogni caso efficaci nella loro suggestività, difficil-mente si riesce a capire il senso di talune caratterizzazioni destinate di per sé a render conto di questa peculiarità lessicale dell’ebraico, e che però assumono toni allusivi talvolta vagamente lirici, talaltra prossimi all’incomprensibilità. «La parola — si legge per esempio in un dizionario biblico — non è soltanto espressione pura e semplice del pensiero, ma di esso contiene la forza creatrice e la carica di potenza, così che parola è sinonimo di cosa reale, anche se invisibile»9; gli fa eco un altro: «Dalla doppia struttura di dabar, nel senso di “parola” e “cosa”, deriva che nella parola è sempre mantenuto un aspetto della cosa e che la cosa è solo accessibile nella parola; e d’altra parte, la parola non può essere separata dal suo contenuto, e il contenuto dalla parola»10. Con la probabile intenzione di suscitare un’impressione di sublimità, descrizioni del genere finiscono piuttosto col rasentare il banale quando non l’assurdo. In quale lingua la parola è soltanto espressione pura e semplice del pensiero? in cosa consistono la forza creatrice e la carica di potenza del pensiero? Oppure: in quali lingue esisterebbero le separazioni tra cose, parole e contenuti da cui solo l’ebraico sarebbe esente? e quale aspetto della cosa è (o non è) mantenuto nella parola? Descrizioni di tenore somigliante si leggono anche in buoni dizionari biblici recenti: «Il sostantivo ebraico dabar significa qualche volta “parola, discorso” e qualche volta “cosa, oggetto, evento” [...]. La parola non è soltanto l’espressione di un pensiero o di una volontà, ma la realtà stessa che designa. Più che un suono, essa è una cosa»11. E si leggono altresì, con meraviglia ancora maggiore, in altrettanto recenti studi specialistici di storia della linguistica: «L’ebraico biblico e rabbinico non distingue tra “parola” e “cosa”: dabar viene usato indiscriminatamente»12. Una delle fonti di tali considerazioni è la sezione veterotestamentaria della grande voce sulla “parola” nell’autorevole Grande lessico del Nuovo Testamento, noto come ‘il Kittel’. Qui l’autore dava grande rilievo ad una probabile etimologia di dabar quale “parte posteriore” di qualcosa, e ne ricavava che «in dabar si deve dunque sentire “il retro”, o meglio “il fondo” di una cosa. [...] dabar indica il significato ben definito di una parola, il suo contenuto, il suo fondo concettuale. [...] Si comprende bene come, nel linguaggio comune, il senso e il concetto possano prendere il posto della cosa stessa; la
8 E. De Luca, Una nuvola come tappeto, Feltrinelli, Milano 1991, p. 29. 9 G. Nolli, Lessico biblico, Studium, Roma 1970, s.v. 10 Dizionario dei concetti biblici del NT (1970), Edizioni Dehoniane, Bologna 19802, s.v. 11 Dizionario enciclopedico della Bibbia (1987), Borla-Città Nuova, Roma 1995, s.v. 12 R. Loewe, La linguistica ebraica, in G. C. Lepschy (a cura di), Storia della linguistica, vol. I, Il Mulino, Bologna 1990, pp. 119-166, a p. 120.
7
cosa come evento ha nel suo dabar l’elemento storico. [...] In quanto dabar contiene il significato di una cosa, ne deriva che parola e realtà coincidono»13. Già negli anni Cinquanta però siffatta congettura, in assenza di prove sufficienti, veniva ritenuta «una pura costruzione mentale»14. Più recentemente poi altri due biblisti così argomentano:
dabar non indica solo “parola”, ossia il supporto linguistico di una realtà significativa, ma anche il
contenuto stesso. Qui però bisogna fare un’importante riserva. Se si suppone un duplice senso di
dabar (più o meno “parola” e “cosa”), per spiegare questa duplicità semasiologica non si dovrebbe
ricorrere alla concezione del mondo che avevano gli antichi, i quali non conoscevano alcuna netta
separazione tra lo spirituale e il materiale. La contrapposizione tra “parola” e “cosa” non è quella
tra spirituale e materiale. dabar non sta per oggetto in senso materiale, [...] ma, secondo il suo
carattere, è una pura astrazione. dabar conserva un po’ sempre l’aspetto di attività espresso dal
verbo: indica qualcosa che si può prestare a discussione o a trattazione o ne può diventare oggetto,
come “affare, avvenimento, episodio”15.
L’importante riserva, insomma, si traduce in un criterio generale, peraltro elementare, così sintetizzato ultimamente da un biblista italiano: «Più che all’etimologia, bisogna rifarsi all’uso e al contesto»16. Per far ciò, più e comunque prima dei dizionari teologico-biblici servono i dizionari di lingua.
3.2. I dati lessicali In un recente e maneggevole dizionario ebraico-italiano17, sotto dabar troviamo cinque significati. Il primo e fondamentale significato è naturalmente quello di “parola”, corredato da questa spiegazione (tolti i rinvii ai versetti esemplificativi): «Il senso del termine deve spesso essere reso in italiano a partire dal suo contesto: discorso, ordine, notizia, relazione, consiglio, promessa, lode, detto, comandamenti, parola di Dio». Seguono gli altri significati minori: 2. “affare”, nel senso di “caso”, “questione”; 3. “cosa”, ma — si precisa — in usi negativi e indefiniti (“nulla”, “qualsiasi cosa”); 4. “modo di agire”; 5. “causa”, in nessi esplicativi (“poiché”, “a causa di”). Il quadro non muta e anzi si delinea ancora meglio se consultiamo un altro
13 O. Procksch, La ‘parola di Dio’ nell’AT; è il cap. C della voce levgw del Grande lessico del NT, vol. VI (1942), Paideia, Brescia 1970, coll. 260-284, a col. 261 e 265. 14 A. Robert nella sezione seconda (La parole divine dans l’AT) della voce Logos del Supplément au Dic-tionnaire de la Bible, tomo V, Letouzey et Ané, Parigi 1957, col. 442. 15 E. Jenni, C. Westermann, Dizionario teologico dell’AT (1975), Marietti, Torino 1978, s. v., col. 379. 16 B. Corsani, Parola, in AA. VV., Nuovo dizionario di teologia biblica, Edizioni Paoline, Milano 1988, pp. 1097-1114, a p. 1099. 17 Ph. Reymond, Dizionario di ebraico e aramaico biblici (1991), Società biblica britannica e forestiera, Roma 1995. Vedi la recensione di A. Minissale su “Synaxis”, 1 (1997), pp. 364-368.
8
dizionario, venerando e assai più ampio18, sintetizzando e traducendo dall’inglese la voce che ci interessa. Qui il significato di base (“discorso”, “parola”) viene articolato in quattro grandi rubriche: 1. “discorso”, “detto”, “parola”, come complesso di ciò che si dice; 2. “detto”, “frase”, come parte di un discorso; 3. “una parola”, “parole”; 4. “faccenda”, “affare”. Si tratta sempre di significati aventi a che fare con l’area seman-tica del “parlare”. Dove starebbe allora il significato di “cosa”? Sta tutt’al più al numero 4., e si riferisce per l’appunto, comprensibilmente, alla “cosa di cui qualcuno parla”. Negli stessi termini niente affatto sorprendenti conclude la propria trattazione un altro illustre dizionario19: «dabar è primariamente “parola” nel senso di espressione articolata e intelligibile. Il significato “faccenda, affare, cosa” è derivato da questo come “ciò di cui qualcuno parla”». Già con questa breve ricognizione la singolarità del presunto doppio significato di dabar si attenua notevolmente. Che c’è di strano, di singolare, di profondo nel fatto che, per certe cornici situazionali e in particolari contesti fraseologici, la parola ebraica che significa “parola” possa essere usata in quella lingua in un modo tale che per tradurla accettabilmente noi dobbiamo adoperarne una il cui significato nella nostra lingua ha a che fare con “cosa”? Anche noi in italiano, pur in assenza di attestazioni del vocabo-lario, usiamo correntemente la parola discorso nel senso generico di “cosa”: quando per esempio un insegnante respinge le giustificazioni di uno studente svogliato obiettando che «il discorso del libro pesante non vale»; o un idraulico illustra la convenienza del miscelatore spiegando che «in confronto al rubinetto è un altro discorso»; o un sindacalista perora la sicurezza nel lavoro edile «portando avanti il discorso casco»; e via discorrendo. Diremo per questo che discorso significa “cosa”? È esattamente ciò che avviene a dabar in ebraico, come a molte altre parole non meno ‘nobili’ in tutte le lingue: «dabar si presta inoltre ad essere usato come termine sostitutivo, quando non si ha a disposizione un’espressione particolare, oppure quando questa deve essere evitata, specialmente con una negazione oppure con kol “tutto”. In questo senso attenuato dabar ha assunto anche la funzione di un pronome indefinito; anche altri nomi hanno subito una simile attenuazione ed un simile svuotamento di significato, p. e. mela’ka “lavoro” > “qualcosa”»20 . Insomma, come recita l’avvertenza del più recente fra i dizionari consultati21, non 18 F. Brown, S. R. Driver, C. Briggs, A hebrew and english lexicon of the OT, Clarendon Press, Oxford 1907, 1977. 19 The interpreter’s dictionary of the Bible, Abingdon Press, Nashville, 1962, 1990. 20 E. Jenni, C. Westermann, Dizionario, cit., col. 379-380. Della normalità del fenomeno era perfettamente consapevole Antonio Rosmini: «Quale meraviglia ora che la voce parola, verbum, logos, dabar, sia usata nelle Scritture, e nei greci e nei latini scrittori, per significare qualunque fatto, avvenimento, e fin anche pel generalissimo cosa, come si può vedere nei lessicografi?»; così nel par. 1472 della Psicologia, ed. naz., 4 voll., Bocca, Milano 1941-1951, vol. II, p. 336-337. 21 The Anchor Bible dictionary, a cura di D. N. Freedman, Doubleday, New York 1992, vol. VI, p. 961.
9
solo per dabar «non si può ricavare nessuna conclusione riguardo il suo significato sulla base dell’etimologia, circa la quale non c’è un accordo di fondo»; ma — quel che più importa in questo momento e rinvia a quanto esposto nel praragrafo 2 — «gli sforzi di collegare tra loro i suoi significati basilari di “parola” e “cosa” non tengono sufficientemente conto della polisemia». 4. Due esempi stranianti
Il motivo per cui ci siamo soffermati ad analizzare una singola parola è semplice. Fino a non molto tempo fa (e accade ancora oggi) teologi e biblisti usavano con-trapporre il pensiero ebraico al pensiero greco sulla base di alcuni dati linguistici di particolare evidenza, per lo più appunto lessicali, messi in corrispondenza in modo meccanico e spesso circolare con una non meglio precisata ‘mentalità’. Di contro al pensiero greco tipicamente ‘statico, contemplativo, astratto, intellettualistico, settorializzante’, il pensiero ebraico veniva qualificato come ‘dinamico, attivo, concreto, immaginativo, globalizzante’. Di per sé non c’è nulla di implausibile in ciò; ma il punto è che le caratteristiche, specie per i testi ebraici, venivano ricavate mediante una riflessione sulle parole (nobilitate in veste di ‘concetti’) che trascurava o oltrepassava di troppo l’esame delle situazioni d’uso e dei contesti di occorrenza. Un po’ come se qualcuno sostenesse che gli italiani hanno una forte vocazione idraulica perché dicono «non capisci un tubo», o che i francesi nel profondo sono sedentari perché identificano l’atto minimo del camminare col non-essere (pas “passo” > particella negativa). La questione verrà ripresa più avanti. Intanto abbiamo appena constatato come il presunto duplice significato di dabar abbia dato motivo di sottolineare la maggior concretezza (significato “cosa”) e dinamicità (significato “avvenimento”) della mentalità ebraica. Mostrando quanto poco appiglio fornissero al riguardo i vocabolari, abbiamo voluto contribuire anche noi, nel nostro piccolo, a «ridimensionare certe affermazioni che attribuiscono ad alcune parole ebraiche una eccezionale densità o ric-chezza di significato»22. Per essere più convincenti, proviamo ora ad applicare al siciliano lo stesso metodo antropologico a base (pseudo)filologica.
4.1. Raffinati o grossolani? Immaginiamo due studiosi di antropologia culturale che abbiano svolto un’indagine sull’organizzazione della vita quotidiana dei siciliani. Al momento di redigere il 22 C. Buzzetti, La Bibbia e le sue trasformazioni. Storia delle traduzioni bibliche e riflessioni ermeneutiche, Queriniana, Brescia 1984, p. 15.
10
rapporto finale, le loro valutazioni si dividono nettamente. Il primo, l’antropologo Tizio, è entusiasta delle scoperte fatte e scrive:
La creatività e l’adattabilità mentale del popolo siciliano si rivelano in modo evidente nella conce-
zione della vita domestica. Per quanto l’organizzazione delle attività pratiche esteriormente non
differisca molto dalla nostra, la sua strutturazione interna obbedisce a canoni assai differenti,
dettati da un interscambio intimo e profondo tra le varie funzioni vitali, all’insegna del gusto di
vivere. Momenti per noi diversi, quali la disposizione al riposo notturno, la preparazione accurata
del cibo, la riunione conviviale, vengono sussunti sotto l’unica categoria estetica
dell’“abbellimento”.
L’antropologo Caio, che è un catastrofista, approda a conclusioni di tutt’altro tenore:
L’assenza di norme di comportamento stabili e condivise nella società siciliana trova una
conferma nella vita domestica; non nella sua concreta espressione pratica, esteriormente affine alla
nostra, bensì nella sua interiorizzazione. Nella percezione intima del popolo siciliano manca una
strutturazione in grado di distinguere e regolare le diverse funzioni vitali. Momenti distinti nella
vita civilizzata, quali il sonno, la cucina, la riunione conviviale, sono vissuti nel profondo come
una confusa attività indifferenziata, svolta sotto la spinta primordiale di un utilitario “approntare”.
Una tale disparità di vedute non può che destare grande stupore. Per spiegarla, occorre vedere su quali dati ciascuno dei due studiosi ha basato il proprio giudizio. Tor-niamo perciò al rapporto entusiastico di Tizio, che così continua:
Infatti le trite azioni quotidiane di rifare il letto, condire l’insalata e apparecchiare la tavola si
esprimono in siciliano con un solo verbo, cunzari, il cui significato primario e fondamentale, al
pari del suo etimo latino, è appunto “adornare”, “abbellire”: un dato linguistico che è una riprova
inoppugnabile dell’intima raffinatezza dell’animo siciliano.
Ed ecco il seguito del rapporto catastrofistico di Caio:
Infatti le azioni di civiltà del rifare il letto, condire l’insalata e apparecchiare la tavola si
esprimono in siciliano con un solo verbo, cunzari, il cui significato primario e fondamentale, al
pari del suo etimo latino, è appunto un indistinto “mettere insieme” come risultato del “comprare”:
un dato linguistico che è una riprova inoppugnabile della grossolanità dell’animo siciliano.
Le interpretazioni opposte di Tizio e Caio si fondano dunque sul medesimo dato. Chi fra i due studiosi immaginari avrebbe ragione? Hanno ragione tutti e due per quanto riguarda l’impiego del verbo cunzari e la sua derivazione da una forma latina, sia nel suo significato tardo (Tizio) sia in quello classico (Caio). E tutti e due si sbagliano,
11
ovviamente, per quanto riguarda le conseguenze culturali che credono di poterne trarre. L’ovvietà dell’errore di entrambi appare però meno scontata se si considera che il loro procedimento di fantasia ha forti rassomiglianze col metodo effettivamente seguito nel caso della parola ebraica dabar e delle sue implicanze culturali, arbitrario ed errato quanto quello. Ciò non vuol dire che il sistema concettuale del siciliano e quello dell’ebraico antico non abbiano le loro proprie peculiarità; ma queste non si ricavano né dalla sommatoria dei significati — interidiomaticamente polisemici — di singole parole, né dal loro significato etimologico (e si sa quanto i filosofi siano sensibili all’etimologia).
4.2. Popoli senza futuro Un altro esempio, questa volta reale, di corto circuito tra fatti linguistici e inferenze culturali, relativo non più al repertorio lessico-semantico ma al sistema grammaticale, è dato da una ben nota osservazione d’autore sul sistema verbale del siciliano, dettata anche in questo caso da un criterio simile a quello praticato sui testi biblici:
La paura del domani e l'insicurezza qui da noi sono tali, che si ignora la forma futura dei verbi.
Non si dice mai: «Domani andrò in campagna», ma «dumani, vaju in campagna », domani vado in
campagna. Si parla del futuro solo al presente. Così, quando mi si interroga sull’originario pessi-
mismo dei siciliani, mi vien voglia di rispondere: «Come volete non essere pessimista in un paese
dove il verbo al futuro non esiste?»23.
Si tratta di un luogo comune assai diffuso, che ha trovato posto perfino nella trattazione storica della politica di riforme nella Sicilia del tardo Settecento, il cui insuccesso sarebbe da imputare al «profondo pessimismo» dei contadini, riluttanti a introdurre miglioramenti tecnici: «In un’economia in cui tutto era precario, un comune lavoratore della terra non poteva mai fare programmi per l’avvenire, neanche a breve scadenza. Forse la mancanza del futuro nel dialetto siciliano era espressione di questa difficoltà a pensare al domani»24. È curioso che quest’ultima affermazione provenga da un anglofono, poiché a rigore nemmeno l’inglese ha una forma specifica del futuro, per esprimere il quale adopera
23 L. Sciascia, La Sicilia come metafora, Mondadori, Milano 1979, p. 45. Lo scrittore riprese lo spunto qualche anno più tardi in Occhio di capra, Einaudi, Torino 1984, p. 86-87: «È da osservare che nel dialetto siciliano i verbi, le azioni, non sono mai al futuro: fatto linguistico-esistenziale di grande rilevanza; uno di quei fatti che dice tutto». 24 D. Mack Smith, Storia della Sicilia medievale e moderna, Laterza, Roma-Bari 1973, p. 424. I due studiosi immaginati da noi acquistano maggior verosimiglianza a confronto con due — molto valenti — antropologi veri (G. Harrison e M. Callari Galli, Né leggere né scrivere, Feltrinelli, Milano 1971, p. 96) intenti a spiegare la questione linguistico-culturale del futuro nel siciliano: «Vita senza futuro, è detta da noi istruiti esser la vita dell’analfabeta. E non solo in chiave di metafora — senza futuro, cioè senza prospettive, senza mutamenti, senza progresso — ma anche nella realtà della lingua, delle sue strutture grammaticali e sintattiche, manca al parlare dell’analfabeta della provincia di Brigaria [Palermo] il tempo futuro dei verbi».
12
una forma perifrastica che poi le grammatiche hanno convenzionalmente classificato come futuro. Nessuno però da ciò si sognerebbe di inferire che le persone di lingua inglese hanno «difficoltà a pensare al domani». Inoltre, mentre secondo Mack Smith la mancanza del futuro nella lingua sarebbe conseguenza della mancanza di senso del futuro nella mentalità (manca la forma verbale perché manca il ‘concetto’), la domanda di Sciascia sembra presupporre il contrario: che i siciliani non possono avere il senso del futuro essendo privi del mezzo linguistico in grado di farglielo concepire (manca il ‘concetto’ perché manca la forma verbale). Anche l’ebraico è una lingua ‘priva di futuro’, e in un senso ancora più forte, perché non è che abbia la casella del futuro vuota, ma addirittura non ha caselle di tempo. Infatti il sistema verbale delle lingue semitiche, di cui l’ebraico fa parte, non è imperniato sulla categoria grammaticale del tempo tipica degli esiti moderni delle lingue indoeuropee. Il verbo ebraico privilegia la natura e la modalità dell’azione anziché la sua collocazione temporale, e la forma verbale che alcune grammatiche continuano a chiamare ‘futuro’ non è affatto un futuro. Ora, se fosse vero che «la situazione del futuro del verbo è al centro dell’esistenza», tanto che si può postulare un’interdipendenza tra l’ominizzazione e «la disponibilità del futuro del verbo» e di conseguenza «noi possiamo essere definiti un mammifero che usa il futuro del verbo “essere”», allora siciliani ed ebrei non avrebbero scampo, relegati come sono «nell’inferno, vale a dire in una grammatica senza futuri»25. Ma siamo proprio sicuri che le cose stiano così? Abbiamo messo in corsivo nelle citazioni le parole verbo e grammatica perché toccano esattamente il punto cruciale dell’intera questione. Che il possesso del senso del futuro sia un aspetto costitutivo e anzi una condizione delle facoltà intellettuali superiori dell’essere umano, è un conto, e non solleva contestazioni; altra cosa è far consistere il senso del futuro nella forma futura del verbo: questo è inaccettabile. Il rapporto tra lingua e mentalità (pensiero, cultura, valori) è assai più articolato. 5. Lingua e mentalità
La contrapposizione tra ‘pensiero ebraico’ e ‘pensiero greco’, a cui abbiamo accen-
25 G. Steiner, Dopo Babele. Il linguaggio e la traduzione (1975), Sansoni, Firenze 1984, pp. 134, 153, 155. Anche queste pagine sulla temporalità linguistica, e specificamente sul futuro, rientrano nel giudizio che dell’intero libro ha dato G. C. Lepschy (La linguistica del Novecento, in Storia della linguistica, cit., vol. III, 1994, pp. 401-524, a p. 418-9): «un libro che trasporta, nel fluire di un’esposizione torrenziale, pietre pregiate di osservazioni originali e taglienti, materiali peregrini ricavati da una cultura di ampiezza strabiliante, spezzoni scarsamente utilizzabili [...], e acque limacciose di filosofia irrazionalistica, ma offre comunque al lettore avveduto una ingente quantità di idee interessanti».
13
nato all’inizio del paragrafo 4, trovava invece il proprio fondamento — e al tempo stesso le conferme —, oltre che nel campo lessicale (esplorato nel modo descritto), in alcune caratteristiche grammaticali della lingua ebraica che venivano meccanicamente trasposte sul piano culturale: la dominante aspettuale (orientata sulla natura e la modalità dell’azione) anziché temporale del sistema verbale; la ricorrenza della frase nominale senza il nostro verbo di modo finito; la prevalenza sintattica della coordinazione sulla subordinazione; l’alta frequenza e la tipicità del nesso di determinazione semitico chiamato ‘stato costrutto’26; l’impiego di parole che rinviano a referenti concreti laddove noi adoperiamo termini astratti; l’uso relativamente scarso di aggettivi27. Sono queste le caratteristiche che di solito hanno suggerito l’idea della maggiore ‘storicità-fattualità-dinamicità’ del linguaggio e del pensiero ebraico rispetto a quello greco-occidentale. E tuttavia gli studiosi di storia del pensiero linguistico non solo hanno rilevato in Omero ed Esiodo una «visione concreta, materiale, del parlare — non c’è un astratto, qualità e relazioni sono fisicamente presentate»28; ma hanno altresì individuato nella prosa scientifica dello stesso Aristotele una «preferenza per la descrizione dei processi dinamici piuttosto che per la classificazione astratta»29. Il padre della linguistica del Novecento, Ferdinand de Saussure, adduceva proprio l’esempio dello stato costrutto nell’espressione biblica debar ‘elohim, “parola di Dio”, per mettere in guardia da correlazioni immediate tra ‘tipo mentale’ di un gruppo sociale e fenomeni sintattici della sua lingua: «Diremo che questo tipo sintattico rivela qualche cosa della mentalità semitica? L’affermazione sarebbe ben temeraria, poiché il francese antico ha impiegato regolarmente una costruzione analoga [...]. Così, un fatto sintattico che sembra essere uno dei suoi tratti indelebili non offre alcun indizio certo della mentalità semitica»30. Lo sviluppo delle conoscenze ha fatto retrocedere impostazioni ingenue e affrettate,
26 Viene chiamata così l’alterazione formale (abbreviazione vocalica e perdita di accento) del sostantivo determinante che in una relazione di possesso precede il sostantivo determinato; è in un certo senso il fenomeno inverso rispetto a quello del latino e del greco dove è il determinato a modificarsi al genitivo. 27 Alcune caratteristiche dell’ebraico biblico sono agilmente illustrate da C. Buzzetti, La Bibbia, cit., pp. 11-17. Un’esposizione altrettanto piana e più completa è nell’ancora utile P. Auvray, L’ebraico e l’aramaico, in P. Auvray, P. Poulain, A. Blaise, Le lingue sacre (1958), Edizioni Paoline, Catania 1959, pp. 5-79. 28 D. Gambarara, Alle fonti della filosofia del linguaggio. “Lingua” e “nomi” nella cultura greca arcaica, Bulzoni, Roma 1984, p. 44, corsivo mio. 29 P. Laspia, Omero linguista. Voce e voce articolata nell’enciclopedia omerica, Novecento, Palermo 1996, p. 8, corsivo mio. Sottolinea il fondamento biologico e l’importanza dell’ascolto (che toccheremo più avanti) nel pensiero linguistico di Aristotele F. Lo Piparo nella voce Aristotle del Lexicon grammaticorum. Who’s who in the history of world linguistics, a cura di H. Stammerjohann, Niemeyer, Tubinga 1996. L’impostazione aristotelica ‘autopoietica’, vitale e dinamica, è ottimamente messa in luce dalla stessa Laspia in L’articolazione linguistica. Origini biologiche di una metafora, Nuova Italia Scientifica, Roma 1997. 30 F. de Saussure, Corso di linguistica generale (19222), a cura di T. De Mauro, Laterza, Roma-Bari 19724 e varie edd., p. 277.
14
le quali però hanno ancora un loro peso nel senso comune colto; perciò è opportuna qualche ulteriore precisazione.
5.1. La lezione di Barr Le considerazioni che siamo andati svolgendo sono del tutto normali e addirittura ovvie per chi si occupa di lingue e di linguaggio; lo sono — e soprattutto lo erano — molto di meno fra i cultori di quella che viene chiamata ‘teologia biblica’. Questa scuola «cerca di cogliere le strutture del pensiero ebraico nelle strutture stesse della lingua. Parte cioè dal presupposto di una completa corrispondenza fra ritmo del pensiero e ritmo della lingua»; il suo metodo però «ha portato a uno studio del pensiero ebraico fondato spesso non su ciò che le parole significavano contestualmente lette, ma piuttosto a una sorta di divagazione metafisica, che ha come punto di partenza la radice»31. Provvide a portare lo scompiglio in questo campo di studi, con argomentazioni ser-rate e modi poco diplomatici, un libro del teologo e biblista scozzese James Barr, dal titolo The semantics of biblical language32, che al suo apparire, nel 1961, suonò come «uno squillo di tromba contro le truppe mostruose della linguistica da quattro soldi»33. Il libro infatti mostrò diffusamente e con una certa ironia l’infondatezza linguistica dei procedimenti cari alla scuola della ‘teologia biblica’, e quindi la sostanziale arbitrarietà dei risultati da essa conseguiti. Con la sua irriverenza nei confronti di autori celebrati e metodi invalsi (fra i suoi bersagli principali c’era proprio il peraltro utilissimo Kittel, ossia il già citato Grande lessico del Nuovo Testamento), il lavoro di Barr richiamò ad una maggior sobrietà scientifica e favorì un salutare ripensamento degli studi biblici. Tre punti del contributo di Barr sono di particolare interesse ai nostri fini: il primo è la denuncia dell’abuso del criterio etimologico nell’interpretazione esegetica; il secondo è lo smontaggio degli errori commessi nell’analisi semantica; il terzo è l’inseparabilità di semantica e sintassi.
31 P. Sacchi, Storia del Secondo Tempio. Israele tra VI secolo a. C. e I secolo d. C., SEI, Torino 1994, p. 6 e 8; corsivo mio. Con la dicitura di ‘teologia biblica’, oltre alla “teologia pensata attingendo alla Bibbia”, si intende talvolta anche la “teologia propria degli scrittori della Bibbia”, definita «un insieme più o meno organico di rappresentazioni e giudizi sulla realtà di Dio, dell’uomo e del mondo e su fatti significativi per la storia dei loro rapporti» da C. Buzzetti, La Bibbia e la sua comunicazione, Elle Di Ci, Torino 1987, p. 38. Per un orientamento si veda E. Franco (a cura di), La teologia biblica. Natura e prospettive, AVE, Roma 1989 e P. Beauchamp, Teologia biblica, in B. Lauret e Fr. Refoulé (a cura di), Iniziazione alla pratica della teologia, vol. I: Introduzione (1982), Queriniana, Brescia 1986, pp. 197-251. 32 J. Barr, Semantica del linguaggio biblico (1961), Il Mulino, Bologna 1968, con introduzione dello stesso Sacchi. Vi si ritrovano diffusamente e polemicamente svolti alcuni degli argomenti specifici da noi toccati: il significato di dabar, pp. 186-200; il verbo ebraico e la temporalità, pp. 105-123; lo stato costrutto, pp. 129-139. A questa edizione si riferiscono nel testo i numeri di pagina tra parentesi. 33 M. Silva, Biblical words and their meaning. An introduction to lexical semantics, The Zondervan Cor-poration, Grand Rapids (Michigan), 1983, p. 18. L’introduzione (pp. 17-32) traccia un utile quadro delle discussioni suscitate dal saggio di Barr, delle cui cautele metodologiche il resto del libro costituisce un ampliamento ed una ragionata messa a frutto.
15
Al primo punto abbiamo già accennato a più riprese. Per quanto riguarda il secondo, va segnalato almeno l’errore che Barr chiamava trasposizione illegittima di totalità, consistente nel «voler leggere il ‘significato’ di una parola (inteso come la serie totale di tutte le relazioni di quel vocabolo nella letteratura) in ogni caso particolare» (303)34. Se si rileggono le citazioni riportate qui sopra in 3.1. sulla questione semantica di dabar, si vedrà che rientrano perfettamente in questo tipo di errore. Scrive Barr:
La caratteristica che distingue questo modo di ragionare che stiamo criticando è il tentativo di fare
una sintesi dei due significati che abbia una parola, e questa tendenza raggiunge nel caso di dabar
il suo culmine. Questa parola ha due significati, “parola” e “cosa”; il senso cambia ed è
determinato dal contesto. [L’immagine corrente invece] non è tale da far venire in mente che
dabar possa significare o l’una o l’altra di queste cose, ma piuttosto che le significhi entrambe [...]
o che, in ogni modo, anche quando significa fondamentalmente una delle due cose, tuttavia susciti
sempre anche una certa idea dell’altra. [...] Abbiamo detto che i significati “parola” e “cosa” si
alternano nell’uso: naturalmente questo non significa che noi siamo sempre in grado di
distinguerli chiaramente, ma non è una buona ragione per dedurne che gli antichi in certi casi
indicassero entrambi i concetti (190-191; corsivo mio).
Circa il terzo punto, con altrettanta pertinenza Barr invitava a non isolare nei testi scritturistici le singole parole (i ‘concetti’) — tendenza che seguìta con eccessiva disinvoltura porta ad ipostatizzarne il significato — ma a tenere ben conto del contesto di frase in cui appaiono:
Un pensiero teologico [...] trova la sua caratteristica espressione linguistica non nelle singole
parole, ma nelle combinazioni di parole o frasi. [...] Ma stando così le cose, il tentativo di mettere
in relazione diretta parole singole col pensiero teologico conduce alla deformazione del contributo
semantico portato dalle parole nei loro contesti. Il valore del contesto viene così ad essere visto
come se fosse determinato dal contributo della parola e di conseguenza questo valore viene
ricercato nella parola singola, anche là dove il contesto indica soluzioni diverse. La parola è così
sovraccaricata di indicazioni semantiche (323).
Ammonimenti di tal genere appaiono tanto più opportuni se si pensa che ancora oggi, nella riedizione di un libro del 1964, si continua a sostenere che l’ebraico sarebbe «segnato dalle impronte di Dio», nel senso che la rivelazione divina «influisce intensa-
34 A dire il vero in questo punto l’edizione italiana porta «trasposizione illegittima di identità»; si tratta però di una svista, che salta agli occhi già ad una lettura attenta della traduzione. La «trasposizione illegittima di identità» infatti è l’errore illustrato nella pagina precedente, e consiste in sostanza nell’attribuire a parole diverse lo stesso significato linguistico per il fatto che possono designare lo stesso referente. Qui invece l’autore, come è chiaro, sta illustrando un altro tipo di errore, che nell’edizione originale inglese (p. 218) è chiamato illegitimate totality transfer.
16
mente sulla conformazione della lingua»35: affermazione tanto più sorprendente perché appare in un testo che asserisce di richiamarsi alla ‘scienza del linguaggio’, e del tutto priva di senso, con buona pace dell’autorevolezza di chi un tempo l’ha scritta e oggi confermata. E tuttavia, pur in presenza di simili resistenze, nel complesso forse è esagerato sostenere che l’opera di Barr sul linguaggio biblico sia «finora rimasta lettera morta»36; la sua lezione in realtà è stata accolta dai biblisti più consapevoli, specie se impegnati sul versante delle traduzioni.
5.2. L’idea di lingua negli antichi Ebrei Le cautele metologiche di Barr, insomma, facevano eco a quelle pronunciate da Saussure a commento dell’esempio dello stato costrutto citato poco fa: «Non è mai privo di interesse determinare il tipo grammaticale delle lingue [...] e classificarle secondo i procedimenti che impiegano nell’espressione del pensiero; ma da queste determinazioni e classificazioni non si può inferire con certezza niente fuori del dominio propriamente linguistico»37. Una simile limitazione, tuttavia, non implica che non si possa dir nulla dei modi in cui una determinata comunità umana vive, ed eventualmente rappresenta a se stessa, il proprio rapporto col linguaggio; vuol dire soltanto che una tale ricerca va condotta analiticamente con riferimento all’intero sistema culturale e agli usi di quella comunità, e non ridotta a una serie di inferenze ricavate da singoli elementi grammaticali o semantico-lessicali, prima liberamente interpretati e poi trasposti meccanicamente in termini culturali. Situandosi su questo punto di osservazione più alto e distante, la tradizione biblica relativa alla “parola di Dio”, le cui grandi linee richiameremo nel prossimo capitolo, riceve una luce più nitida dall’idea del linguaggio su cui si innestava, ossia dalla concezione generale che gli antichi Ebrei avevano dei fatti linguistici e del parlare in genere. Non hanno un gran peso in essa, contrariamente a quanto spesso ancora si ritiene, né la questione dell’origine del linguaggio né quella della diversità linguistica. Il linguaggio è costitutivo dell’umanità: questo pare essere il messaggio dei primi undici capitoli della Genesi. Il rilievo assunto dai due miti della lingua originaria e della dispersione babelica appartiene più alla storia delle interpretazioni che alla tradizione biblica in sé considerata; riguardo il secondo, in particolare, l’esegesi recente ha messo
35 L. Alonso Schökel, La parola ispirata. La Bibbia alla luce della scienza del linguaggio, Paideia, Brescia 1987, p. 125. 36 C. Balzaretti, Problemi di linguistica in alcuni studi di filologia biblica, “Rivista biblica”, 41 (1993), pp. 463-490, a p. 464. È pur vero, peraltro, che nella bibliografia di una recente raccolta di ‘studi semantici’ su Genesi 1-11 (E. van Wolde, Words become worlds, Brill, Leida 1994), figurano i nomi di Greimas, della Kristeva, di Lévi-Strauss, ma non quello di Barr: circostanza che non può non sorprendere. 37 F. de Saussure, Corso, cit., p. 277-278.
17
in dubbio l’idea della punizione divina che ha accompagnato la storia dell’Occidente38. L’importanza della comunicazione linguistica nei testi veterotestamentari risalta meglio da altri aspetti. Già il dato quantitativo è tale per cui il verbo che significa “dire” (’mr) ha la frequenza più alta. Da notare è poi il ruolo che nella caratterizzazione dell’essere umano viene assegnato al volto («Egli [Giacobbe] osservava il volto di Labano e si accorse che non era più quello di prima verso di lui»: Genesi 31, 2)39, considerato in quanto sede degli organi attraverso cui la comunicazione si compie: orecchie e bocca. L’essere umano secondo l’Antico Testamento è costituito innanzi tutto dalla sua disponibilità ad ascoltare: l’abilità di ben giudicare che Salomone chiede a Dio è in effetti capacità di ascolto (1 Re 3, 9-11). Da essa dipende la saggezza del parlare, perciò «rispondere prima di ascoltare / è pura follia e vergognosa stupidità» e in definitiva «dalla lingua dipendono la vita e la morte» (Proverbi 18, 13.21). Il giusto rapporto tra ascolto e parola caratterizza così il Servo di Jhwh:
Dio, il Signore mi ha insegnato le parole adatte
per sostenere i deboli.
Ogni mattina mi prepara ad ascoltarlo,
come discepolo diligente.
Dio, il Signore, mi insegna ad ascoltarlo,
e io non gli resisto
né mi tiro indietro (Isaia 50, 4-5)40.
Dal punto di vista dell’antropologia biblica, «si deve quindi ammettere una prevalenza dell’udito e del linguaggio sulle altre capacità comunicative, per un’autentica compren-sione dell’uomo»41. Questa centralità del linguaggio, nei suoi aspetti ricettivo e produttivo, attinge livelli ancora più profondi. Dall’asserita ‘indistinzione’ dei significati di “parola” e
38 Così ad esempio E. Testa, Genesi, vol. I, Marietti, Torino 19772, e Westermann, Genesi, trad. it. Piemme, Casale Monferrato 1989, ad loc. È l’interpretazione tematizzata nel mio Da Utopia a Babele, “Nuove Effemeridi”, 21 (1993), pp. 104-108. Tutte e due le questioni sono riprese da R. Albert, Die Frage des Ursprungs der Sprache im Alten Testament, in J. Gessinger e W. von Rahden (a cura di), Theorien vom Ursprung der Sprache, vol. II, de Gruyter, Berlino-New York 1989, pp. 1-18, il quale in Sofonia 3, 9 («In quel giorno trasformerò i popoli, renderò pure le loro labbra: / così potranno rivolgere le loro preghiere a me, il Signore, / e onorarmi tutti insieme») interpreta labbra pure in senso non cultuale né morale ma col significato di ‘lingua chiara’, vedendovi, in accoppiata all’unificazione, una ripresa dell’utopia prebabelica. 39 Per i motivi che verranno esposti più avanti, le citazioni bibliche sono date secondo la Traduzione interconfessionale in lingua corrente. 40 La Nuovissima traduzione dai testi originali rende in maniera più letterale: «Il Signore Dio mi diede una lingua di discepolo, / perché io sappia sostenere lo stanco con la parola. / Egli risveglia il mio orecchio, / perché io ascolti come fanno i discepoli. / Il Signore Dio mi aprì l’orecchio / ecc.». 41 H. W. Wolff, Antropologia dell’AT (1973, 19905), Queriniana, Brescia 1975, 19933, p. 103. Osservazioni più o meno analitiche sulla concezione biblica del linguaggio sono contenute in quasi tutti i dizionari biblici che siamo venuti citando, a cui perciò si può fare ricorso per un primo accostamento.
18
“cosa” nella parola dabar (assai discutibile, come abbiamo visto), uno degli autori citati in 3.1. ricava delle valutazioni che in sé risultano perfettamente plausibili, una volta sganciate dal fatto lessicale e ricondotte alla visione del mondo e ai relativi comportamenti: «In virtù dell’esistenza della parola è stabilità l’identità di ogni cosa; e viceversa la parola, estensione del parlante che la pronuncia, ha una forza d’effetto irre-versibile, particolarmente in chi è in possesso d’un potere speciale»42. Sono adombrati in questa formulazione due tratti tipici della concezione veterotestamentaria del linguaggio: l’importanza della n o m i n a z i o n e (si pensi agli episodi che raccontano l’attribuzione o il cambiamento di nome, o al tabù linguistico sul nome di Dio) e il carattere p e r f o r m a t i v o del parlare, ossia l’efficacia fattuale dell’enunciazione verbale, soprattutto in determinate circostanze (promesse, benedizioni, anatemi). Come ha scritto recentemente uno studioso francese, «un aspetto fondamentale delle concezioni linguistiche sottostanti il testo biblico è che la nominazione, e più in generale l’enunciazione, stanno in un rapporto di implicazione esistenziale molto stretta, addirittura di immanenza, con il nominato o l’enunciato»; ciò avviene, prosegue lo stesso autore, perché «nell’area culturale semitica il linguaggio non è concepito come uno strumento intellettuale che permette di costruire delle rappresentazioni del mondo; esso è colto anzitutto nella sua dimensione pragmatica, intersoggettiva e sociale»43. E nondimeno, la fissazione della Parola nella scrittura e, per questa via, la sua identificazione con la Legge, avranno col tempo un recupero di autonomia e di potere normativo sull’oralità, fornendo all’ebraismo post-biblico (di cui qui non ci occupiamo), soprattutto nel suo versante mistico, materia per raffinate pratiche e teorizzazioni metalinguistiche44. Alla luce di queste caratteristiche, si comprende meglio la natura eminentemente ‘efficace’ della “parola di Dio”, di cui ci occuperemo nel prossimo capitolo. Sono altresì, al di là dei riscontri grammaticali e lessicali più o meno presunti, le caratteristiche di fondo che inducono ad opporre il ‘concreto’ e ‘dinamico’ parlare-interpellare biblico all’‘astratto’ e ‘statico’ parlare-spiegare greco. Su di esse, ad esempio, si fonda sostanzialmente un famoso saggio di Rudolf Bultmann del 1933, uno dei modelli dell’impostazione qui più volte richiamata, esente peraltro dagli eccessi e dalle approssimazioni dei successori. Secondo Bultmann, nell’uso veterotestamentario, «determinante, ai fini del concetto di parola, è l’esser pronunciata, non il significato»,
42 R. Loewe, La linguistica ebraica, cit., p. 120-121. 43 Dj.-E. Kouloughli, La thématique du langage dans la Bible, in S. Auroux (a cura di), Histoire des idées linguistiques, tomo I: La naissance des métalangages en Orient et en Occident, Mardaga, Liegi 1990, pp. 65-78, a p. 70 e 76. Sul primo punto, fra l’altro, l’autore esprime qualche riserva a proposito di Barr. 44 Fanno testo in proposito gli studi di Scholem sulla qabbalah. Degli sviluppi della concezione ebraica del linguaggio dalla diaspora al Novecento tratta diffusamente il già citato R. Loewe, La linguistica ebraica.
19
perciò «la parola è pronunciata per esser rivolta a..., è interpellazione, non giudizio in senso logico»; nell’uso greco invece «è predominante l’accezione di logos come contenuto di ciò che è detto», per cui della parola si tiene presente «non l’evento del proferirla, bensì il significato da comprendere»45. Sono conclusioni sulle quali si può dissentire o concordare, ma la cui giustificazione è affidata alla fondatezza delle analisi svolte e non all’etimologia o a singole manifestazioni (lessicali o morfo-sintattiche) dei rispettivi sistemi linguistici.
5.3. Bibbia, relativismo e traduzione Il nodo teorico che sta dietro la difficoltà della teologia biblica di dirimere la relazione tra il pensiero ebraico e il pensiero greco è in ultima analisi quello del relativismo linguistico: la convinzione, cioè, secondo cui ogni lingua è già essa stessa una concezione del mondo e fornisce ai suoi parlanti le griglie concettuali attraverso le quali essi pensano, determinandone la configurazione culturale. Questa è, in estrema e rozza sintesi, la convinzione che sta alla base del modo di procedere esemplificato qui sopra negli esempi stranianti del paragrafo 4. Nella linguistica del Novecento essa viene posta sotto il nome di Benjamin Lee Whorf, studioso delle culture e delle lingue amerindiane, le cui posizioni propugnavano un ‘nuovo principio di relatività’: «Il sistema linguistico di sfondo (in altre parole la grammatica) di ciascuna lingua — scriveva — non è soltanto uno strumento di riproduzione per esprimere idee, ma esso stesso dà forma alle idee, è il programma e la guida dell’attività mentale dell’individuo, dell’analisi delle sue impressioni, della sintesi degli oggetti mentali di cui si occupa»; e ancora: «Ogni lingua è un vasto sistema strutturale, diverso dagli altri, in cui sono ordinate culturalmente le forme e le categorie, con cui la persona non solo comunica, ma analizza la natura, nota o trascura tipi di relazioni o di fenomeni, incanala il suo ragionamento e costruisce l’edificio della sua coscienza»46. Spinte alle estreme conseguenze, simili affermazioni, di per sé niente affatto ardite, comportano l’incommensurabilità e al limite l’incomunicabilità fra le lingue, ciascuna delle quali finirebbe con l’essere per chi le parla, individui e popoli, un recinto insormontabile. A questo relativismo radicale si oppone l’idea, altrettanto estrema, che la pluralità linguistica sia un fenomeno di superficie e che il linguaggio umano sia costituito nel profondo da strutture universali identiche per tutte le lingue. Chi ha maggiormente insistito su questa idea negli ultimi decenni è il linguista Noam Chomsky: «I principi
45 R. Bultmann, Il concetto di parola di Dio nel NT, in Credere e comprendere. Raccolta di articoli (1933, 19727), Queriniana, Brescia 1977, 19862, pp. 287-312, a p. 288 e 293; corsivo nel testo. 46 B. L. Whorf, Linguaggio, pensiero e realtà, a cura di J. B. Carroll (1956), Boringhieri, Torino 1970, p. 169 e 211. Può essere utile ricordare qui che i primi interessi linguistici di Whorf, che di professione faceva l’ingegnere chimico, si manifestarono proprio con lo studio dell’ebraico.
20
della grammatica universale non conoscono eccezioni perché costituiscono la facoltà stessa del linguaggio, cioè lo schema costitutivo di ogni particolare lingua umana, la base per l’acquisizione del linguaggio.[...] I principi della grammatica universale sono dotati di parametri, che possono essere fissati sulla base dell’esperienza in un modo o nell’altro. [...] L’acquisizione di una lingua è [...] un processo di fissazione dei parametri»47. Ovvero, in una formulazione recentissima, meno tecnica e più netta e perciò inequivocabile: «le diverse lingue non differiscono affatto, se non per alcune variazioni marginali»48. La serie di interventi sul rapporto tra lingua e cultura o mentalità è innumerevole e non si limita a questi estremi. Sarebbe impossibile, ammesso che sia utile, darne conto in questa sede, dove basterà limitarsi a due ordini di considerazioni. Il primo critica l’errore consistente nel focalizzare la discussione su un rapporto rigido da sistema a sistema, ossia da lingua a cultura, trascurando la gamma di possibilità consentita dalla messa in atto dei sistemi in concreti comportamenti. Riportiamo al riguardo l’opinione di uno studioso sensibile all’argomento, illuminante fra l’altro circa l’inadeguatezza di alcune delle impostazioni qui discusse:
Molte delle ricerche su lingua e cultura hanno saltato l’anello degli usi ed hanno cercato correla-
zioni immediate tra struttura della lingua e struttura della cultura, con risultati complessivamente
ridotti. Le lingue, in quanto sistemi semiotici, sono tutte equivalenti, e nulla vuole che alla cultura
Cx debba necessariamente adattarsi la lingua Lx e non una Ly; ma saranno invece gli usi Ux ad
adattarsi a quella cultura, e questo per definizione perché il rapporto è immediato. La cultura Cx
non potrebbe esprimersi senza la comunicazione per il tramite degli Ux e quindi è impossibile che
di questo rapporto non rimanga traccia. [...] Spesso, nell’estrapolare da lingua a cultura, si fanno
illazioni a partire dall’assenza o presenza di un vocabolo nel lessico esaminato a livello di L, come
se la situazione dovesse essere automaticamente la stessa anche al livello di U. In realtà molto
spesso la differenza può essere perfettamente espressa nell’uso anche linguistico, pur mancando
nel sistema. Inversamente, certi collegamenti, evidenti in un’analisi a livello di L, potrebbero
rivelarsi illusori quando li si cerchi nella pratica linguistica49.
L’altro ordine di considerazioni va ancora più in profondità ed evidenzia come la natura delle lingue sia tale da contenere insieme la specificità idiomatica più spinta e la condivisione di tratti comuni a tutte, e non possa quindi esser colta costringendole stret- 47 N. Chomsky, Linguaggio e problemi della conoscenza (1988), Il Mulino, Bologna 1991, p. 56-57. 48 Dichiarazione contenuta in un’intervista apparsa su “L’Unità” del 4 agosto 1997; corsivo mio. 49 G. R. Cardona, I sei lati del mondo. Linguaggio ed esperienza, Laterza, Roma-Bari 1985, p. 14-15 e 16. Il libro affronta il tema facendo propria l’istanza di fondo dell’ipotesi whorfiana. In un’ottica differente, che tiene conto anche dei più recenti contributi specialistici delle scienze cognitive, si muove F. Cimatti, Esperienza e linguaggio. I fondamenti percettivi dell’attività linguistica, in D. Gambarara (a cura di), Pensiero e linguaggio. Introduzione alle ricerche contemporanee, Nuova Italia Scientifica, Roma 1996, pp. 49-89.
21
tamente entro l’una o l’altra soluzione:
Ipotesi universalistica chomskiana e ipotesi relativistica whorfiana hanno al fondo una stessa idea:
che una lingua sia uno strumento statico, dato una volta per tutte, in rigido rapporto biunivoco con
un mondo culturale e mentale concepito come altrettanto statico, fermo, dato una volta per tutte.
Ma non è così. [...]
Le lingue sono diverse perché si diversificano di continuo ciascuna al suo interno e in rapporto
alla tradizione. E grazie a tale flessibilità indefinita, [...] esse possono essere portate fino a quel
caso limite del diversificarsi indefinito che è l’istituzione di reciproche analogie, di somiglianze e
scambi. Nessun problema, dunque, ad accettare nello stesso tempo l’evidenza della diversità pro-
fonda delle lingue e quella della possibilità di mutua comprensione tra genti di lingua diversa50.
Da questo punto di vista non solo non c’è nessun problema ad accogliere entrambi gli aspetti, di relatività e di universalità, sotto cui è possibile guardare alle lingue, ma, come è stato efficacemente sostenuto da uno storico della questione, «la traduzione nella sua varia e molteplice vita millenaria appare come la manifestazione più tangibile e più certa dei cosiddetti universali linguistici»51. Queste che sono fra le acquisizioni più mature della linguistica attuale, dopo lo scossone di Barr hanno cominciato a circolare anche fra i biblisti e fanno parte oggi, come si è accennato, del patrimonio di quanti fra loro si sono provati a metterle in pratica nel confronto diretto col trasferimento dei testi da una lingua e cultura (e relativi usi) a un’altra. Un serio studio sistematico in Italia dei problemi specifici legati alla traduzione della Bibbia, condotto alla luce dei principi teorici della linguistica moderna, è stato avviato da Carlo Buzzetti a partire dalla tesi discussa all’Istituto Biblico di Roma e pubblicata nel 197352. Ai criteri ivi esposti ha fatto riferimento negli anni seguenti l’iniziativa della Traduzione interconfessionale in lingua corrente (Tilc)53, che noi abbiamo adoperato in queste pagine e nelle prossime. L’intenzione degli autori era quella di «rendere il testo ebraico e greco con parole e forme della lingua italiana di tutti i giorni, quella consueta e familiare, che le persone
50 T. De Mauro, Minisemantica, cit., p. 158-159. E ancora più di recente lo stesso De Mauro scrive: «La variazione non è qualcosa che colpisca le lingue dall’esterno: essa invece si insedia in ogni punto della realtà di una lingua come necessaria conseguenza della sua semantica e pragmatica che, a loro volta, traggono necessariamente i caratteri di estensibilità e flessibilità dalle esigenze funzionali di ciascuna lingua» (Capire le parole, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 80). 51 G. Folena, Volgarizzare e tradurre (1973), Einaudi, Torino 1991, p. 3-4. 52 C. Buzzetti, La parola tradotta. Aspetti linguistici, ermeneutici e teologici della traduzione della sacra scrittura, Morcelliana, Brescia 1973. Dello stesso autore si vedano anche i già citati La Bibbia e le sue trasfor-mazioni (un profilo storico essenziale) e La Bibbia e la sua comunicazione (un’agile trattazione d’insieme), e da ultimo la raccolta di saggi La Bibbia e la sua traduzione, Elle Di Ci, Torino 1993. 53 È apparsa per intero nel 1985 col titolo di Parola del Signore. La Bibbia (Elle Di Ci-Alleanza Biblica Universale, Torino-Roma); il solo Nuovo Testamento era già uscito nel 1976, in una versione poi sottoposta a revisione e qua e là ritoccata.
22
usano per comunicare tra loro» e «fare al lettore estraneo al linguaggio tradizionale un discorso che dica a lui, in modo equivalente, ciò che il testo originale diceva agli antichi lettori». Perciò, seguendo il criterio dell’equivalenza funzionale consistente nel privile-giare il contenuto, hanno prodotto, come dichiarano, una traduzione «decisamente lontana dall’ideale letteralista» e invece «sistematicamente attenta a presentare in maniera comprensibile soprattutto il significato». Non è il caso di occuparsi a questo punto di esempi e confronti54, ma bisogna riconoscere che il risultato corrisponde all’intenzione ed effettivamente si raccomanda nel suo complesso per la leggibilità e comprensibilità conseguite: finalmente un italiano non legge che al principio c’era il Verbo, ma che c’era «colui che è “la Parola”»; e non legge che il Verbo si fece carne, ma che «colui che è “la Parola” è diventato un uomo». Passiamo invece senz’altro a questo che è il secondo dei testi centrati sulla nozione di ‘parola’, il vangelo di Giovanni, e ai problemi differenti che pone rispetto a quelli fin qui visti.
54 Lo faremo nel prossimo capitolo e in maniera più mirata nel capitolo sesto dove ci soffermeremo su un passo degli Atti degli apostoli e sulle differenze di traduzione e interpretazione del termine che vi appare.
23
II
L a P a r o l a e i s e g n i
n e l q u a r t o v a n g e l o 1. Uno strano sermone
In un romanzo che racconta la lacerazione culturale degli indiani d’America, il pastore Tosamah, Sacerdote del Sole nel ghetto indiano di Los Angeles, pronuncia un sermone sull’incipit del quarto vangelo. La sua tesi principale è che l’evangelista Giovanni (che lui peraltro confonde col Battista) afferrò sì l’intuizione istantanea della verità allorché disse «Nel principio era la parola», ma ebbe il torto di voler continuare, mentre in realtà non c’era altro da aggiungere all’enunciazione di quella nuda verità originaria: «Non riusciva a capire di essere giunto al culmine della verità, e continuò. Cercò di renderla più grande e migliore di quel che era, ma non fece che sminuirla e appesantirla». Non poteva che fare così, spiega il predicatore, perché «il vecchio Giovanni era un uomo bianco» e si comportava come tale:
L’uomo bianco ha i suoi modi di fare. Accidenti, ha le sue maniere. Parla della parola. Ne parla in
lungo e in largo. Ci costruisce sopra sillabe, prefissi e suffissi, e trattini e accenti. Aggiunge e
divide e moltiplica la verità. E con tutto questo nasconde la verità. E, fratelli e sorelle, voi siete ve-
nuti qui per vivere nel mondo dell’uomo bianco. Ora, l’uomo bianco commercia con parole, e
commercia facilmente, con grazia e furbizia. E in sua presenza, qui sul suo territorio, voi siete
come dei bambini, semplici bambini nel bosco. Non dovete preoccuparvene, perché in questo voi
avete un certo vantaggio. Un bambino può ascoltare e imparare. La parola è sacra per il bam-
bino55.
Il commento ha un effetto tanto più straniante quanto maggiore è la distanza culturale, oltre che linguistica, dal testo commentato. E tuttavia la pagina giovannea, col suo avvio folgorante, non ha mai cessato di occupare le menti di quanti su di essa si sono arrovellati pur in un ambito storico-culturale meno distante56. Anche noi oggi, 55 N. Scott Momaday, Casa fatta di alba (1966), Guanda, Parma 1979, pp. 102-103. 56 Da questo punto di vista il sermone del Sacerdote del Sole può essere considerato una sorta di rivisitazione pellerossa del passo del Faust di Goethe (parte prima, vv. 1224-1237) in cui il protagonista prova a tradurre dal greco
24
quasi fossimo dei piccoli pellerossa smarriti a contatto con una lingua e una mentalità estranee, seguitiamo a domandarci: cosa c’era al principio? che cos’è il logos? Un’altra domanda, sia pure meno impellente e ardua, va ad aggiungersi a queste se si tiene presente il legame — talmente antico da sembrare ormai ovvio — tra il fenomeno del linguaggio e l’idea di segno: che rapporto c’è nel quarto vangelo tra il logos e i segni? La domanda è tanto più pertinente perché il vangelo di Giovanni è anche il testo nel quale la nozione di ‘segno’ assume un’importanza teologica considerevole, ben maggiore che in tutti gli altri scritti neotestamentari. Proveremo ora, se non a rispondere alle domande, quanto meno a fornire utili elementi di riflessione intorno ad esse57. 2. Il logos giovanneo
Con tutta evidenza, quello della parola greca logos, coi suoi significati principali di “linguaggio” e “ragione”, è un altro caso particolarmente importante di polisemia interi-diomatica. Come in tutti i casi del genere, chi vi si trova dinanzi a partire da un’altra lingua è obbligato a un di più di riflessione, anche se in definitiva trova una soluzione più o meno soddisfacente rifacendosi agli elementi del testo che contornano l’unità problematica e ne chiariscono il senso. Tanto maggiore riflessione esige una parola quale logos quando, come nel prologo del vangelo di Giovanni, è usata in modo non discernibile perché testualmente assoluto, privo cioè di ogni aggancio testuale capace di farne decidere il significato univoco trasferibile in altre lingue dalle articolazioni lessico-semantiche differenti. Non procederemo dunque a un’analisi di tutte le occorrenze di logos nel quarto vangelo, perché l’ampiezza dei suoi usi finirebbe per non dirci niente circa la questione che ha mosso la nostra indagine. Infatti, come è stato osservato, «sia il verbo (legein) che il sostantivo (logos), in tutti gli scritti del Nuovo Testamento, sono usati in tutti i significati e a tutti i livelli, da quello quotidiano a quello più carico di contenuto», al punto che «nella stessa frase si può trovare logos sia nell’uso comune che in quello teologico»58. Dovremo invece necessariamente soffermarci, più che sull’uso non appunto il primo versetto del vangelo di Giovanni, passando, nella versione di F. Fortini, da parola (Wort) a pensiero (Sinn) a energia (Kraft) e finalmente ad azione (Tat). 57 Nelle pagine che seguono riprendo e rielaboro parti di testo e spunti già contenuti in Segni e parole nel quarto vangelo. Alle origini del paradigma agostiniano, “La memoria”, Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Palermo, 5 (1989), pp. 135-167, e poi rifluiti con varie modifiche nei capitoli primo e terzo di Le parole come segni. Introduzione alla linguistica agostiniana, Novecento, Palermo 1994. Rinnovo i ringraziamenti a suo tempo già rivolti al dott. Carlo Pàstena, della Biblioteca centrale della Regione siciliana, e al prof. Antonino Minissale, dell’Istituto teologico S. Paolo di Catania. 58 G. Kittel,‘Parola’ e ‘parlare’ nel NT, parte quarta della voce levgw del Grande lessico del NT, vol. VI (1942), Paideia, Brescia 1970, coll. 285 e 288.
25
marcato del termine, su quello fortemente connotato, guardandoci dall’estendere al primo i tratti caratteristici del secondo; badando, cioè, a non prendere, «come senso normativo e come guida all’uso neotestamentario della parola in genere, il Logos giovanneo», dal momento che «l’uso di ho logos con l’articolo, nel caso particola-rissimo del primo capitolo di Giovanni, è un significato specializzato che non può essere confuso indiscriminatamente con altri casi per il semplice fatto che anche in questi compare la parola logos»59. La caratteristica esclusiva dei testi attribuiti dalla tradizione all’apostolo Giovanni, infatti, è l’uso di logos come appellativo personale, un uso pregnante e speciale che va a costituire quello che viene chiamato ‘logos giovanneo’, destinato a diventare uno dei cardini della religione cristiana. Tale uso è riscontrabile solo in tre luoghi. i) Nella descrizione del cavaliere dell’Apocalisse:
Poi nel cielo aperto vidi un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava è chiamato “Fedele” e
“Verace”, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi brillano come il fuoco: ha molti
diademi sul capo e porta scritto un nome che egli solo conosce. È vestito di un mantello bagnato di
sangue. Il suo nome è: “La Parola [logos] di Dio” (Apocalisse 19, 11-13)60.
Ci limitiamo in questo caso a registrare l’occorrenza senza minimamente commentarla perché il genere letterario dell’opera richiederebbe ben altre analisi; del resto, stando a un parere autorevole, la scena in cui appare «è una traduzione in termini plastici e drammatici della ben nota affermazione del prologo del quarto vangelo: “Il Logos si fece carne e abitò tra noi”» e ha lo stesso intento teologico61. ii) Una seconda occorrenza si trova nel lungo e sintatticamente intricato incipit della prima lettera di Giovanni:
La Parola che dà la vita [ho logos tes zoés] esisteva fin dal principio: noi l’abbiamo udita, l’ab-
biamo vista con i nostri occhi, l’abbiamo contemplata, l’abbiamo toccata con le nostre mani. La
vita si è manifestata e noi l’abbiamo veduta. Siamo i suoi testimoni e perciò ve ne parliamo. Vi
annunziamo la vita eterna che era accanto a Dio Padre e che il Padre ci ha fatto conoscere. Perciò
parliamo anche a voi di ciò che abbiamo visto e udito; così sarete uniti a noi nella comunione62.
59 J. Barr, Semantica del linguaggio biblico (1961), Il Mulino, Bologna 1968, p. 308. 60 Anche in questo capitolo, salvo esplicita indicazione contraria, seguiamo la Traduzione interconfessionale in lingua corrente (Tilc). 61 E. Corsini, Apocalisse prima e dopo, SEI, Torino 1980. V. anche P. Prigent, L’Apocalisse di S. Giovanni, Borla, Roma 1985, p. 586: «Quasi tutti i commentatori concordano nel riconoscere che il ricorso allo stesso titolo cristologico negli scritti giovannei non può essere frutto del semplice caso». 62 La traduzione della Conferenza episcopale italiana resta più aderente alla complessa struttura del testo greco: «Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita (poiché la vita si è fatta visibile, noi l’abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre
26
Su questo passo si può osservare quanto segue: i) il logos tes zoés è qualcosa che si sente, si vede, si tocca, non è un concetto astratto ma una persona fisica; ii) la parola logos non è adoperata assolutamente ma con la specificazione tes zoés, dunque è un appellativo generico, un titolo piuttosto che un nome; iii) il pronome relativo che media il riferimento grammaticale a logos (di genere maschile) in quanto oggetto dei verba sentiendi è nella forma del neutro, non in quella del maschile come ci si attenderebbe, il che vuol dire che la personificazione dell’appellativo non è totale. iii) Finalmente — ed è l’occorrenza più nota e importante — l’appellativo personale di logos apre il prologo del quarto vangelo, dove appare sciolto da determinazioni di sorta, usato assolutamente, e del tutto personificato a mo’ di nome proprio: en arché ên ho logos.
Al principio63,
c’era colui che è “la Parola”.
Egli era con Dio;
Egli era Dio.
Egli era al principio con Dio.
Per mezzo di lui Dio ha creato ogni cosa.
Senza di lui non ha creato nulla.
Egli era vita
e la vita era luce per gli uomini.
Quella luce risplende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno vinta. [...]
Colui che è “la Parola” è diventato un uomo
e ha vissuto in mezzo a noi uomini.
L’unicità di questa qualifica di logos è tanto più rilevante perché «non sembra trat-tarsi di un concetto centrale del Nuovo Testamento»64; si tratta tuttavia di un concetto che a poco a poco si collocherà al centro della dommatica cristiana, trasformando una parola corrente nel linguaggio comune e nel lessico filosofico in tecnicismo teologico per designare il figlio di Dio, fino a farlo diventare «il titolo che assunse la più alta importanza per la discussione teologica»65. Ma non è possibile occuparci qui degli sviluppi post-biblici del concetto e del termine. e si è resa visibile a noi), quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi». 63 La prima edizione aggiungeva l’inciso «prima che Dio creasse il mondo», poi spostato in nota. 64 O. Cullmann, Cristologia del NT (1963), Il Mulino, Bologna 1970, p. 387. Il libro è impostato proprio sull’esame dei titoli assegnati a Gesù; tutto il capitolo Gesù il Logos (pp. 375-401) è un’esposizione sintetica dei temi qui toccati. 65 G. Prestige, Dio nel pensiero dei padri (1952), Il Mulino, Bologna 1972, p. 135.
27
3. Correlati veterotestamentari
Non è nostra intenzione affrontare le numerose questioni riguardanti il logos gio-vanneo e il prologo del quarto vangelo, su ciascuna delle quali (fonti, correlati, genere, struttura, significato) la bibliografia è sterminata66; ai nostri scopi sono sufficienti alcune poche osservazioni, rispondenti del resto alle considerazioni di carattere linguistico esposte nel capitolo precedente. Per individuare l’origine e i correlati di un testo così denso e importante, più che alla speculazione greca occorre volgersi alla tradizione ebraica; il prologo risponderebbe infatti a un tentativo di contemperare entrambe le componenti risolvendo la prima nella seconda proprio mediante l’uso di un termine chiave di lunga consuetudine filosofica, a segnare, dal punto di vista dell’autore, il compimento di riflessioni ed attese secolari. Per dirla in estrema sintesi, nell’appellativo di logos con cui si apre il prologo del quarto vangelo «possono essere confluiti il logos stoico (principio razionale dell’universo), la parola creatrice dell’Antico Testamento, la sapienza personificata del giudaismo post-esilico, le speculazioni di Filone Alessandrino che traduce in termini di logos ciò che il giudaismo del secolo precedente esprimeva in termini di sophía (sapienza)»67. Illustriamo rapidamente le due com-ponenti principali: quella della “parola” e quella della “sapienza”.
3.1. La tradizione della “parola di Dio” L’autore del prologo si rifà alla tradizione biblica già da un punto di vista esterno per il fatto che ripete nell’incipit esattamente le prime parole della Genesi nella traduzione dei Settanta: ejn ajrch~/; segno di una ripresa consapevole di quel ‘racconto di inizio’, a rimarcare la risoluzione definitiva delle questioni che esso poneva68. In più ipostatizza nel sostantivo logos, preceduto dall’articolo, il verbo di dire che, sempre nel
66 Per un primo quadro di insieme si possono consultare le coll. 359-380 del già citato Kittel nel pur vecchio Grande lessico del NT, e meglio ancora le coll. 486-496 della parte quarta (La parole divine dans le NT, a firma di J. Starcky) della voce Logos nel Supplément au Dictionnaire de la Bible, tomo V, Letouzey et Ané, Parigi 1957. Fra gli studi specifici e i commenti segnalo A. Feuillet, Il prologo del quarto vangelo (1968), Cittadella, Assisi 1971; le pp. 127-133 di E. Cothenet, Il quarto vangelo, in A. George e P. Grelot (a cura di), Introduzione al NT, vol. IV: La tradizione giovannea (1977), Borla, Roma 1981, pp. 85-272; l’appendice seconda (pp. 1464-1471) di R. E. Brown, Giovanni (1966-70), 2 voll., Cittadella, Assisi 1979; il cap. XII (pp. 328-355) di C. H. Dodd, L’interpretazione del quarto vangelo (19655), trad. it. Paideia, Brescia 1974; l’excursus primo (pp. 357-373 del I vol.) di R. Schnackenburg, Il vangelo di Giovanni, 3 voll. (1965-1975), trad. it. Paideia, Brescia 1973-1981; le pp. 133-176 del recente R. Fabris, Giovanni, Borla, Roma 1992. 67 B. Corsani, Parola, in AA. VV., Nuovo dizionario di teologia biblica, Edizioni Paoline, Milano 1988, pp. 1097-1114, a p. 1111. 68 Sul rapporto del Prologo col genere dei ‘racconti di inizio’ v. P. Gibert, Bibbia, miti e racconti dell’inizio (1986), Queriniana, Brescia 1993, pp. 224-226.
28
primo capitolo della Genesi, designa la prima azione compiuta da Dio e si trova ripetuto, per ben otto volte, ad ogni enunciazione di atto creativo: «Dio disse... e chiamò...». Più in profondità, Giovanni mediante la sua formulazione (si ricordi che nel testo greco dei Settanta logos, insieme a rhema, traduce l’ebraico dabar) sintetizza e rilancia la tradizione biblica della “parola di Dio” che impregna di sé tutto quanto l’Antico Testamento e rappresenta perciò «un elemento essenziale nella concezione veterotestamentaria della storia»69. La parola di Dio è la forza che ha presieduto alla creazione: «La parola del Signore creò il cielo / e il soffio della sua bocca tutte le stelle. [...] Egli parlò e tutto fu fatto; / diede un ordine e tutto fu compiuto» (Salmo 33, 6.9); continua ad agire nelle trasforma-zioni della natura: «Dio tuona con la sua voce e ci sorprende, / fa cose meravigliose che nemmeno comprendiamo» (Giobbe 37, 5); una volta emessa, è indefettibile e ha validità permanente: «La parola del nostro Dio dura per sempre» (Isaia 40, 8); resta ferma e sicura nella sua immutabilità, come dice Dio stesso: «Quel che prometto, io lo man-tengo; / quel che dico, rimane» (Isaia 45, 23); è presente fra gli uomini e in loro stessi: «La parola del Signore è molto vicina a voi, l’avete imparata e la conoscete bene»70 (Deuteronomio 30, 14); rallegra chi fa di essa il proprio nutrimento: «Ero affamato delle tue parole, / e quando le trovavo / mi sentivo il cuore pieno di gioia / ed ero perfet-tamente felice» (Geremia 15, 16). Soprattutto, conformemente all’idea di lingua illustrata nel capitolo precedente, la parola di Dio è operativa e concretamente efficace: «Dio parlò e vennero tafani / e zanzare in tutto il territorio. / [...] / Parlò e vennero le cavallette, / un numero incalcolabile di locuste» (Salmo 105, 31.34); la sua potenza di azione è tale da produrre effetti anche per interposta persona: «Io pronunziai le parole che il Signore mi aveva ordinato di dire. Il soffio della vita entrò in quei corpi ed essi ripresero vita» (Ezechiele 37, 10). Quest’idea dell’efficacia fattuale e concreta della parola di Dio ha suscitato negli autori biblici immagini che denotano un primo avvio di personificazione del concetto, con tratti che richiamano quelli di un messaggero plenipotenziario:
Manda la sua parola sulla terra
e rapida giunge a compimento.
Fa fioccare la neve come lana,
come cenere sparge la brina.
Raggela le acque in cristalli di ghiaccio: 69 Grande commentario biblico (1968), Queriniana, Brescia 1973, p. 1794. Vedi anche il Dizionario di teologia biblica, a cura di X. Léon-Dufour (1971), Marietti, Casale Monferrato 19765. 70 Letteralmente: «è sulla vostra bocca e nel vostro cuore».
29
chi può resistere a quel freddo?
Manda ancora la parola: ecco il disgelo.
Fa soffiare il suo vento: scorrono le acque (Salmo 147, 15-18).
«La mia parola
è come la pioggia e la neve
che cadono dal cielo e non tornano indietro
senza avere irrigato la terra
e senza averla resa fertile.
Fanno germogliare il grano,
procurano i semi e il cibo.
Così è anche della parola
che esce dalla mia bocca:
non ritorna a me senza produrre effetto,
senza realizzare quel che voglio
e senza raggiungere lo scopo
per il quale l’ho mandata» (Isaia 55, 10-11).
La parola contraddistingue il Dio degli ebrei rispetto agli dei muti dei popoli vicini: «[I profeti di Baal] gridavano: “Baal, ascoltaci”; ma la sola risposta fu il silenzio» (1 Re 18, 26), perché i loro idoli «hanno la bocca, e non parlano» (Salmo 115, 5; idem in 135, 16). La parola di Jhwh invece, attraverso i suoi profeti (l’espressione stessa parola di Dio è termine tecnico della rivelazione profetica), è la protagonista della storia del popolo eletto.
3.2. La tradizione sapienziale Nel popolo ebraico la tradizione sapienziale appare posteriormente a quella della “parola” e si sviluppa dopo l’esilio. Rispetto alla “parola di Dio”, la “sapienza” ha tratti più universalistici e per così dire più umanistici; è meno implicata teologicamente e più orientata alla vita degli uomini. Pur appartenendo alla sfera divina (assiste Dio nella sua opera creatrice), la “sapienza” non ha un ruolo di rivelazione della stessa importanza della “parola” e subisce processi di personificazione ancora più spinti:
All’inizio il Signore mi ha generata,
primizia della sua attività,
origine delle sue opere. [...]
Io ero là, quando Dio fissava i cieli,
30
quando tracciava l’orizzonte sopra l’abisso. [...]
Io ero accanto a lui come un bambino71
ed ero la sua gioia quotidiana (Proverbi 8, 22.27.30).
Per questa via dell’origine e della preesistenza, i due concetti di “parola” e “sapienza” possono compenetrarsi fra loro e talvolta intercambiarsi. Così nel libro deuterocanonico del Siracide (tradotto in greco intorno al 132 a. C.) si legge: «Fonte della sapienza è il logos di Dio nei cieli» (1, 5)72; più oltre la sapienza dice di se stessa di essere stata creata «dal principio» e di essere uscita «dalla bocca dell’Altissimo» (24, 3-9); e d’altra parte è pure asserito che principio di ogni opera è il logos73 (37, 16). Il libro della Sapienza fu scritto direttamente in greco poco più di un secolo prima del quarto vangelo; perciò è particolarmente interessante osservare il livello di astrazione attinto dalla “sapienza” in un israelita che, restando fedele alla religione dei suoi padri, pensa e scrive tuttavia all’interno di un quadro concettuale contenente non piccoli elementi di novità rispetto ai più antichi testi veterotestamentari (così è del corpo come disvalore e dell’idea di immortalità): la sapienza vi è infatti presentata come avente uno spirito caratterizzato da ventuno attributi di natura intellettuale e come «il più agile di tutti i movimenti» ed «emanazione della potenza di Dio» (7,22-8,1). È evidente dunque come l’evangelista Giovanni, mantenendo il rinvio tradizionale all’area della “parola”, abbia potuto trasferire sul termine logos molte delle carat-teristiche della sophía (“sapienza”). La cosa appare con particolare evidenza dalla tabella 174, che raccoglie le corrispondenze tra le espressioni principali del prologo e alcuni passi tratti dalla letteratura sapienziale. 4. La polisemia di logos a confronto col latino
Consideriamo ora più da vicino la polisemia interidiomatica di logos confrontandola con la situazione lessicale del latino. Se prendiamo un buon vocabolario greco75, alla voce lovgo" troviamo una serie di significati che possiamo raggruppare senza grandi sforzi nella maniera seguente:
71 Altre traduzioni possibili: «come un architetto», «come un artigiano». 72 Il versetto è attestato solo da alcuni manoscritti. 73 Sono da notare i differenti modi in cui si trova tradotto il versetto originario (ajrchŸ pantoŸ" e[rgou lovgo", kaiŸ proŸ pavsh" pravxew" boulhv). Traduzione della Conferenza episcopale italiana: «Principio di ogni opera è la ragione, prima di ogni azione è bene riflettere»; Nuovissima traduzione dai testi originali: «L’inizio d’ogni azione è nel discorso, e prima d’ogni opera c’è il consiglio»; Tilc: «Prima di fare qualcosa, parlane con altri e prima di prendere una decisione pensaci su». 74 La riprendo dal commento di Dodd, p. 342-343; una simile c’è anche in quello di Fabris, p. 173-174. 75 Quello di H. Liddell e R. Scott, A greek-english lexicon (1843), Clarendon press, Oxford 1966.
31
1) “calcolo, relazione”; 2) “spiegazione, ragionamento”; 3) “ragione”; 4) “racconto, discorso”; 5) “espressione verbale in genere”; 6) “una particolare espressione”; 7) “argomento di discussione”; 8) “linguaggio”; 9) “manifestazione divina”.
Tralasciamo l’ultimo significato perché la sua apparizione va ricondotta a qualcuno dei precedenti. Se proviamo a riscontrare la lista di significati in un vocabolario latino di pari livello76, siamo costretti a passare per diverse voci, ciascuna delle quali registra altresì dei significati non compresi fra quelli appena elencati. Sotto ratio troviamo i significati da 1) a 3) e il 7). I significati 4), 5) e 8) stanno alle voci sermo e oratio. Sotto verbum sta solo il gruppo 6): “detto, proverbio, sentenza”. Ancora: mentre per logos nei significati 5) e 6) (per quest’ultimo di norma al plurale) l’accezione “una singola pa-rola” è molto rara, proprio questo, di “vocabolo”, è invece il significato principale di verbum. Per trovare tale significato in greco bisogna cercare alla voce lexis, oppure ónoma, o ancora rhéma; e nessuna di queste tre parole è mai riferita a Gesù. Tranne un piccolo punto di contatto con verbum, si ha così in latino una ripartizione dei significati della lista in due aree: da una parte l’area di ratio, dall’altra quella di sermo e oratio. Volendosi dunque attenere alle valenze linguistiche della parola grecalogos, è fuor di dubbio che sul piano strettamente lessicale la traduzione con verbum è in definitiva la meno adatta. Molto più appropriati a rendere il senso della parola greca di partenza sono certamente sermo oppure oratio; il quale ultimo però, per via del genere femminile, si presta meno come equivalente di un sostantivo maschile quale è logos, specie in ambito religioso. Le due parole latine superstiti (sermo e verbum) hanno in comune il riferimento all’area del linguaggio; all’interno di quest’area si differenziano però in un aspetto capitale perché, per dirla in breve, il sermo è composto di più verba. Non per niente Varrone aveva congetturato che sermo deriva da serie, e che di conseguenza non si può applicare a un uomo solo ma laddove si intrattenga una conversazione con altri77. Come rendere allora in latino il logos del prologo di san Giovanni? I primi padri della Chiesa africani (come poi Erasmo da Rotterdam) adoperavano sermo (“discorso”), 76 Ch. T. Lewis e Ch. Short, A latin dictionary (1879), Clarendon press, Oxford 1966. 77 «Sermo, opinor, est a serie [...]: sermo enim non potest in uno homine esse solo, sed ubi oratio cum altero coniuncta» (De lingua latina 6, 64).
32
Mario Vittorino a metà del IV secolo preferiva non tradurla affatto e mantenerla tale e quale nella sua forma greca, Jean Leclerc tra Sei e Settecento adottò ratio (“ragione”), sant’Agostino e soprattutto san Girolamo prescelsero verbum (“parola”), traduzione che si impose ben presto in tutto l’Occidente latino78. Ma mentre un greco interpretava l’incipit di Giovanni mediante una parafrasi del tipo “Al principio c’era qualcosa di cui si può avere un’idea pensandolo come c o m p o s t o d i p i ù p a r o l e ”, un latino invece, di fronte alla traduzione con verbum, non poteva parafrasare in altro modo se non “Al principio c’era qualcosa di cui si può avere un’idea pensandolo come u n a s i n g o l a p a r o l a ”. Non fu dunque, quella di sant’Agostino e di san Girolamo, una scelta priva di conseguenze, anche teologiche. 5. La Parola, le parole, le azioni
Sarà ormai sufficientemente chiaro che quello che viene chiamato logos giovanneo risponde ad un uso speciale e di fatto unico. C’è nondimeno un’area semantica comune della parola, da cui quel concetto eminentemente teologico in fin dei conti trae origine, sia pur finendo poi, col tempo, per modificarla nei suoi usi colti. Perciò, passare brevemente in rassegna l’uso generale di logos nel quarto vangelo può tornare utile per inquadrare meglio lo sfondo su cui si staglia l’uso pregnante e speciale che stiamo considerando. La parola logos nel vangelo di Giovanni è adoperata: i) raramente, e in tal caso solo al plurale, come equivalente di rhémata (il singolare, rhéma, non è attestato in Giovanni) con riferimento a delle parole pro-nunciate da qualcuno; ii) nel senso corrente di “affermazione”, “discorso”, di un pezzo di effettiva produzione linguistica compiuta; iii) nel senso di “messaggio”, come complesso di contenuti trasmesso per via orale ma travalicante il livello linguistico-semantico; e infatti Gesù distingue il suo logos dall’espressione verbale allorché ribatte ai suoi oppositori: «Perché non capite quello che dico [lalía]? Perché siete incapaci di ascoltare la mia parola [logos]» (8, 43); iv) nel senso di “contenuto della rivelazione”, che come tale prescinde dalla vocalità, sicché è possibile accogliere il logos di Dio anche senza vederlo e ascoltarlo: «“Anche Lui ha testimoniato a mio favore, ma voi non avete mai ascoltato la sua voce [phoné] e non avete mai visto il suo volto. La sua parola [logos] non è radicata in voi,
78 La questione delle traduzioni latine di logos nel prologo di Giovanni, e delle loro conseguenze, è trattata nel mio Le parole come segni, cit., pp. 34-50.
33
perché voi non avete fede nel Figlio che egli ha mandato”» (5, 37-38). A parte queste notazioni, valide grosso modo per tutto il Nuovo Testamento, l’uso generale di logos quale emerge da un esame delle concordanze non presenta, dal nostro punto di vista, tratti di particolare rilievo rispetto agli usi del linguaggio ordinario. C’è però da sottolineare un aspetto importante che riguarda il rapporto tra il parlare e l’agire di Gesù. Di fronte alle resistenze dei discepoli a credere nella sua missione, così l’evangelista gli fa rispondere: «Quel che dico non viene da me; il Padre abita in me, ed è lui che agisce» (14, 10)79. Tra il parlare e l’agire di Gesù viene posta in tal modo una correlazione strettissima e quasi una equiparazione, tale da rendere difficile individuare quale dei due debba essere inteso metaforicamente: le parole (di Gesù) sono ‘azioni’ (del Padre), oppure le azioni — opere, fatti — (di Gesù) sono ‘parole’ (del Padre)? In ogni caso, ai nostri fini il dato della correlazione importa più del suo significato. Chi di questa correlazione fece il perno della propria esegesi evangelica fu sant’Agostino, secondo il quale le azioni di Gesù erano delle ‘parole visibili’; e di esse proprio commentando il vangelo di Giovanni Agostino sottolineava la significatività: «Le azioni del Signore non sono soltanto dei fatti, ma anche dei segni. E se sono dei segni, oltre ad essere mirabili, devono pur significare qualcosa»80. Quel che più ci interessa è che Agostino deduceva la significatività di tali azioni dalla qualifica del loro autore come Parola-Verbum: «Essendo Cristo la parola di Dio, ogni azione della parola è per noi una parola» (24, 2); perciò «tutti i prodigi straordinari di nostro Signore Gesù Cristo sono insieme dei fatti e delle parole: fatti perché sono stati compiuti, parole perché sono segni» (44, 1) e insomma «le sue azioni sono parole» (25, 2). Le azioni di Gesù sono dunque dei segni, sono come delle parole; una volta ammessa la prima equazione, per Agostino è del tutto naturale passare all’altra. Ma è esattamente questo il nodo da sciogliere; perciò è tempo di volgerci alla seconda delle due aree semantiche a cui abbiamo accennato nel paragrafo 1, quella di “segno”, per verificare alla fine il rapporto che instaura con il “parlare”. 6. Segni straordinari
Nel Nuovo Testamento la parola seméion appare settantasette volte. L’autore che più la usa è appunto Giovanni: diciassette volte nel vangelo e sette nell’Apocalisse. Noi considereremo qui solo il vangelo. Già il numero di occorrenze è significativo poiché in 79 Nella traduzione della Conferenza episcopale italiana il rapporto tra parole e opere è più trasparente: «Le parole [rhémata] che io vi dico, non le dico da me; ma il Padre che è in me compie le sue opere [erga]». 80 In Iohannis evangelium tractatus, 49, 2. Tra parentesi nel testo i luoghi delle altre tre citazioni.
34
effetti, dei quattro vangeli, quello di Giovanni ha il vocabolario più povero quantitativa-mente (cioè con minor numero di lemmi) e insieme più denso intorno a parole-chiave poco frequenti o addirittura rare nei sinottici, e viceversa mancante del tutto di parole in quelli ricorrenti. Il tentativo di individuare un significato unico del termine nel Nuovo Testamento appare destinato a rimanere infruttuoso, né serve a molto dire che «con semeion si stabilisce o si accenna [...] una possibilità, un intendimento, oppure la necessità di un determinato rapporto umano»81. Del resto l’impresa andrebbe al di là del nostro fine di accertare l’uso giovanneo, il quale, oltre che non univoco esso stesso, è certamente peculiare rispetto agli altri testi neotestamentari. Tuttavia può essere utile uno sguardo sommario allo sfondo dal quale quella peculiarità emerge.
6.1. Il segno nei sinottici e in Paolo Nei vangeli sinottici seméion ha una serie di significati, non tutti presenti nel vangelo di Giovanni: i) “segnale”, “indicazione”: è in questo senso che il bacio di Giuda è un semeion in Matteo 26, 48; e infatti nel passo parallelo di Marco 14, 44 è usato il termine tecnico sússemon, «che vuol dire — spiega Erasmo da Rotterdam — “segno comune” composto, del tipo di quelli che i militari chiamano simboli, alcuni dei quali sono vocali e altri muti»82; ii) “prova”, “verifica”: in Luca 2, 12 l’angelo della natività, dopo aver dato l’annuncio, aggiunge: «Questo per voi il segno: troverete un bambino...», che la Tilc traduce: «Lo riconoscerete così»; iii) “dimostrazione di autorità-legittimità”: i farisei, per mettere alla prova Gesù, gli chiedono un segno (Matteo 12, 38; Marco 8, 11; Luca 11, 29) ed egli si rifiuta, rimproverandoli e rinviando ad un unico segno avvenire, il segno di Giona, allusione alla risurrezione. È questo il semeion classico della tradizione profetica dell’Antico Testamento, un’azione straordinaria che dimostra la legittimità del profeta ad operare in nome di Jhwh. Anche Giovanni riporta questo topos della richiesta di un segno: dopo la cacciata dei mercanti dal tempio i Giudei domandano a Gesù: «Che semeion ci mostri, che fai queste cose?» (2, 18; v. anche, con sfumature differenti, 6, 30). È una formula antica che richiama il significato precedente, di “prova”, tanto che la Tilc rende con «dacci una prova»; tuttavia esemplifica bene anche questo significato di segno dimostrativo di tipo biblico perché nei passi paralleli dei sinottici (Matteo 21, 23;
81 K. H. Rengstorf, voce shmei~on nel Grande lessico del NT, vol. XII (1964), Paideia, Brescia 1979, coll. 17-172, a col. 94. 82 Desiderii Erasmi Roterodami Opera omnia, 11 tomi, Van der Aa, Leida 1703-1711, tomo VI: Novum Testamentum, col. 207 F.
35
Marco 11, 28; Luca 20, 2), con formula analoga a quella giovannea e sempre uguale, è detto: «Con quale exousìa (“diritto, potere, autorità”) fai queste cose?». Ecco perché la Tilc svolge la domanda posta in Giovanni con «dacci una prova che hai l'autorità di fare queste cose»; iv) “presagio”: se il semeion come segno dimostrativo è tipicamente biblico, il segno premonitore di un qualche avvenimento importante e drammatico è, viceversa, l’unico tipo di semeion conosciuto dalla religiosità classica ed ellenistica. Nei sinottici appare in contesto escatologico-apocalittico: per esempio in Matteo 24, 3, Marco 13, 4 e Luca 21, 7 i discepoli vogliono sapere come fare per riconoscere il momento della fine del mondo, quale sarà il semeion, al singolare, ma altrove appare il plurale con rinvio evidente a fenomeni metereologici e atmosferici, straordinari o no. È un significato che Giovanni adotta nell’Apocalisse ma non nel vangelo; ed è altresì il significato prevalente nei sinottici; v) “opere prodigiose”: si tratta di un uso di semeion sempre al plurale e sempre in unione con teras, “prodigio”: seméia kai térata oppure térata kai seméia. L’espressione ricorre nel discorso escatologico di Gesù in Matteo 24, 24 e nel parallelo Marco 13, 22, e, sempre in bocca a Gesù, in Giovanni 4, 48. Manca del tutto nel vangelo di Luca, però è presente nove volte negli Atti, opera dello stesso Luca, e quasi soltanto nei primi otto capitoli. La stranezza ha una spiegazione: pare che sia quella infatti la parte in cui l’autore rielabora materiale orale preesistente, e seméia kai térata era un’espressione ormai codificata ascrivibile, nella traduzione dei Settanta, allo strato deuteronomistico del Pentateuco e relativa al racconto dell'esodo; anche se negli Atti pure gli uomini compiono «segni e prodigi», il riferimento, talvolta esplicito, è alle grandi opere compiute da Jhwh a favore del suo popolo83; vi) c’è infine un uso unico di semeion riferito direttamente ad una persona: nella presentazione di Gesù al tempio (Luca 2, 34) il vecchio Simeone dice a Maria che il bambino è posto quale semeion antilegómenon, cioè probabilmente, piuttosto che come oggetto di rifiuto e con qualche analogia al significato i), come segnale dall’interpretazione controversa oppure come vessillo che invece di unire a raccolta provocherà divisione. La Tilc ancora una volta svolge il nesso: «Sarà un segno di Dio, ma molti lo rifiuteranno». Gli scritti paolini a proposito di semeion presentano una particolarità degna di nota. Delle cinque volte in cui la parola compare, una è in citazione dalla Genesi (Romani 4, 11: «il segno della circoncisione»), un’altra denota semplicemente la firma apposta alla
83 Il saggio di L. O’Reilly, Word and sign in the Acts of the Apostles, Gregoriana, Roma 1987 analizza minutamente il nesso parole-segni negli Atti e ne dà un’interpretazione nuova di maggior consapevolezza da parte dell'autore, anche con riferimento alla formula in esame.
36
lettera (2 Tessalonicesi 3, 17), una terza è nel senso di “miracolo”, al plurale, in associazione con teras e dÿnamis (2 Corinzi 12, 12). I due luoghi restanti, entrambi nella prima lettera ai Corinzi , sono i principali: il primo è la ben nota rivendicazione dello scandalo e della pazzia della croce: «Gli Ebrei vorrebbero miracoli [semeia], e i non Ebrei si fidano solo della ragione [sophía]. Noi invece annunziamo Cristo crocifisso» (1, 22); e qui sembra chiaro il significato di “segno dimostrativo auto-revole”. C’è infine, legata al parlare, l’occorrenza più oscura nel discorso sui carismi, dove Paolo sta cercando di frenare l’entusiasmo dei destinatari per il dono delle lingue e con-clude, con probabile riferimento al significato di “verifica”: «Così, la capacità di parlare in lingue sconosciute è un segno non per i credenti, ma per gli increduli»; ma al versetto seguente l’esempio che fa pare smentire il criterio appena enunciato: «Se la comunità si riunisce, e tutti si mettono a parlare in lingue sconosciute ed entrano degli estranei o dei non credenti, che cosa accadrà? Diranno che siete pazzi!» (1 Corinzi 14, 22-23). Ma allora in che consiste la funzione di segno per i non credenti? O l’oscurità del passo è legata a qualche accezione ancora differente di semeion? Come che sia, va registrata l’assenza in Paolo di una qualche funzione di rilievo assegnabile alla nozione di segno.
6.2. I segni giovannei Per quanto riguarda finalmente il quarto vangelo, semeion è il termine che in italiano è stato tradotto prevalentemente con miracolo, traduzione non del tutto e non sempre adeguata, che oggi infatti viene abbandonata o precisata84. Per visualizzare la situazione, nella tabella 2 sono messe a confronto le rese delle occorrenze giovannee di semeion nelle principali versioni italiane moderne, disposte, dopo la Vulgata detta sisto-clementina (1592), in ordine di apparizione. Accanto alle due rese univoche miracolo di Garofalo e segno della Nuovissima (che spesso ricalca la Cei) oltre che della Vulgata, si osserva la netta preferenza della Cei per segno, quella meno decisa e meno chiara della Concordata per prodigio e la scelta della Tilc di optare per l'espressione segno miracoloso pur di non operare la semplice trasposizione in segno. Possiamo comunque accogliere l’idea che semeion in Giovanni è qualcosa che ha dello straordinario, del miracoloso. D’altronde questo fu il senso prevalente con cui nei primi secoli l’esegesi patristica valutò i segni compiuti da Gesù, dal momento che fra i termini adoperati a commento dell’episodio delle nozze di Cana i tre più ricorrenti, in
84 Su tutta la questione, una buona visione d'insieme, con un taglio diverso, è in G. Segalla, Segno giovanneo e sacramenti, “Studia anselmiana”, 66 (1977), pp. 7-43. Una trattazione apposita nei già citati commenti di Brown (appendice terza, pp. 1472-1481), di Dodd (pp. 182-184) e di Schnackenburg (excursus quarto, pp. 476-493 del primo volume), e inoltre nella voce segno di J. Mateos e J. Barreto, Dizionario teologico del Vangelo di Giovanni (1980), Cittadella, Assisi 1982, pp. 287-291.
37
greco e in latino, sono in ordine di frequenza miraculum, tháuma e mysterium85. Ora, la parola greca specificamente deputata, come un termine tecnico, a designare le azioni straordinarie di Gesù, i suoi miracoli, nei vangeli sinottici è un’altra: è dÿnamis, “atto di potenza”. A questo proposito vanno osservate due cose. La prima è che il termine d´ynamis manca del tutto nel quarto vangelo; ma occorre dire che manca pure, con questo significato, nei Settanta e negli ebrei-ellenisti mentre è presente, proprio nel senso di “miracolo”, nella letteratura popolare ellenistica86. La seconda è che nei sinottici d´ynamis è accompagnato, come si è visto, dall’altro termine, semeion, che però lì non designa mai dei miracoli fatti da Gesù e ha un signifi-cato alquanto diverso. Ciò è particolarmente evidente nelle pericopi, viste poco fa, in cui i farisei chiedono a Gesù un semeion: ebbene, in tutti e tre i casi la richiesta viene avanzata quando Gesù ha appena compiuto una d´ynamis, il che vuol dire che rispetto a quanto ha appena fatto gli astanti si aspettano qualcosa se non di diverso per lo meno di superiore. Anche in Giovanni 6, 30 la gente chiede a Gesù un semeion nonostante egli abbia da poco compiuto qualcosa che l’evangelista chiama appunto semeion (6, 14); qui però, come si evince dal rimprovero di 6, 26, la richiesta nasce dal non aver la folla colto la vera natura della moltiplicazione dei pani, dal non aver capito che si trattava proprio di un semeion. La folla insomma ha scambiato un semeion per una semplice d´ynamis; e poiché compiere delle dynámeis non aveva niente di eccezionale, occorreva un semeion (al singolare) che facesse certi gli ebrei del diritto di Gesù a compierle, come dichiarava, in nome di Dio. Su questa differenza, corroborata dalla singolarità non certo casuale del dato terminologico, è fondata la scelta di limitare l’analisi al semeion giovanneo; una scelta che dal nostro punto di vista resta valida anche ammettendo che dal punto di vista della semiotica narrativa tutti i miracoli, come del resto nei sinottici le parabole, mettono in atto nel racconto evangelico una «istanza di interpretazione»87. È questo un motivo di più per salvaguardare la peculiarità che l’esegesi storico-critica, in modi diversi, ha sempre riconosciuto al quarto vangelo, al punto che Bultmann ha potuto individuare in esso una tradizione anteriore, chiamata appunto ‘fonte dei segni’, teologicamente povera in origine ma sfruttata e trasformata dall’evangelista in un testo redazionale complessivo dal messaggio più elaborato e più alto. Infatti i miracoli di Gesù narrati nel quarto vangelo sono solo sette, e non ci sono 85 Il computo completo è in J. Ramos-Regidor, Signo y poder. A propósito de la exégesis patrística de Jn 2, 1-11, “Salesianum” 27 (1965), pp. 499-562 e 28 (1966), pp. 3-63, a p. 6 86 Lo segnala R. Formesyn, Le semeion johannique et le semeion hellénistique, “Ephemerides theologicæ lovanienses” 38 (1962), pp. 856-895, a p. 882 nota 2. 87 L'espressione è del Gruppo di Entrevernes, Segni e parabole. Semiotica e testo evangelico, LDC, Torino 1982, p. 155-6. «Segni interpretati» sono chiamati quelli giovannei da F. Uricchio, Miracolo, in AA. VV., Nuovo dizionario di teologia biblica, Edizioni Paoline, Milano 1988, pp. 954-978, a p. 972.
38
guarigioni di lebbrosi né, soprattutto, esorcismi, ricorrenti invece nei sinottici88. Evidentemente non è per caso che l’autore ha fatto una cernita tipologica e una scelta numerica. Non è necessario ai nostri fini procedere ad un’analisi puntuale dei passi interessati. Bisogna semmai distinguere tra le diciassette occorrenze del termine semeion e le sette azioni straordinarie di Gesù qualificate come semeia (meglio: così qualificate o qualificabili, nei casi in cui non vengono espressamente denominate con quello che inequivocabilmente è il loro termine); e ciò fatto, aver chiaro che il nostro interesse non è rivolto a queste ultime per se stesse. A noi cioè non interessano i ‘segni’ compiuti da Gesù, ma il fatto che le sue azioni straordinarie siano chiamate segni; perciò, senza attardarci ad esaminare il significato delle azioni, è sufficiente presentare i tratti caratterizzanti della denominazione ricorrendo ancora una volta al dato terminologico fornito dal testo. La tabella 3 mostra i contesti di ciascuna occorrenza del termine in questione89. Da essa si ricavano a colpo d’occhio alcuni elementi di notevole interesse: i) il semeion è qualcosa che si fa: quattordici volte su diciassette dipende dal verbo poiéo, “fare”; ii) è qualcosa che si vede: sei volte (e anche sette se si conta 3, 2) è accompagnato da verbi di vedere: oráo, theoréo; iii) ha a che fare con la fede: dieci volte è in un qualche rapporto grammaticale col verbo pistéuo; iv) chi fa i semeia è sempre Gesù, tranne nei due casi in cui il termine ricorre in bocca a lui stesso in un discorso generale sulla fede imperfetta (4, 48 e 6, 26) e in 10, 41 dove il soggetto è Giovanni il Battista del quale però si dice che, appunto, non fece nes-sun semeion. 7. Segni e parole
In base ai dati appena scorsi, si è pervenuti a una sorta di definizione operativa molto larga: nel vangelo di Giovanni «il semeion è un gesto compiuto da Gesù, la cui visione conduce alla fede»90. Una definizione siffatta per la verità non risolve del tutto
88 Per la verità ce n'è un ottavo, di miracolo, ma è contenuto nell'ultimo capitolo, concordemente ritenuto dagli specialisti un'appendice posteriore. Per la questione della ‘fonte dei segni’ si veda B. Corsani, I miracoli di Gesù nel quarto vangelo. L'ipotesi della fonte dei segni, Paideia, Brescia 1983. 89 La tabella è tratta dalla monografia di L. Erdozáin, La función del signo en la fe según el cuarto evangelio. Estudio crítico exegético de las perícopas Jn IV, 46-54 y XX, 24-29, Pontificio Instituto Bíblico, Roma 1968, pp. 4-5. 90 Così J.-P. Charlier, La notion de signe dans le IVe évangile, “Revue des sciences philosophiques et thé-ologiques” 43 (1959), pp. 434-448, a p. 437.
39
le aporie a cui pare condurre una analisi dei singoli passi: in bocca allo stesso Gesù la ‘fede per segni’ è giudicata negativamente in 4, 48 e, in maniera implicita, favorevolmente in 6, 26. Ma poiché qui non facciamo esegesi né tanto meno teologia biblica, quella definizione per noi è sufficiente, tanto più che si avvicina alle intenzioni esplicite dello stesso evangelista il quale concludendo il proprio racconto dichiara in 20, 30: «Gesù fece ancora molti altri segni miracolosi [semeia] [che] non sono scritti; ma questi fatti sono stati scritti perché crediate»91. Possiamo perciò passare agli elementi che più interessano dal punto di vista qui adottato. i) L’uso di semeion nel quarto vangelo è differente dall’uso dello stesso termine nella letteratura ellenistica, sia religiosa sia profana. Per quanto riguarda la prima, si è già accennato al fatto che l’unico tipo di segno presente in essa è il presagio, e che questo significato è assente nel quarto vangelo dove invece domina quello di segno dimostrativo secondo il modo mosaico e, di più, profetico. A proposito della letteratura ellenistica non religiosa, e in particolare di ciò che è rimasto delle dottrine stoiche (ma la notazione in questo caso vale anche per l’uso aristotelico), «il termine semeion in questa letteratura esprime un aspetto noetico, è di ordine significativo. Il semeion giovanneo invece è di tipo concreto, riguarda degli atti. Nel primo caso si può attribuire ad un fatto la qualità di semeion; nel secondo si fa un semeion»92. ii) Nonostante le riserve di taluni studiosi in proposito, si può aggiungere che il semeion giovanneo ha anche un valore simbolico93. Non nel senso di un rinvio globale e indifferenziato ad una realtà altra, né perché, come pur è stato detto, in Giovanni «gli eventi e le cose di questo mondo derivano la loro realtà dalle Idee eterne che incarnano»94; bensì in quanto rivela e manifesta chi lo compie, in analogia, ancora una volta, al modo profetico più che a quello filoniano. Il semeion, lo si è visto, pertiene al fare, è in stretto rapporto col termine ergon che infatti ricorre in bocca a Gesù per designare ciò che il narratore chiama col primo termine. Ma data «la connessione tra fatto e simbolo, tipica del racconto giovanneo»95, nel quarto vangelo il semeion «possiede un doppio valore, dimostrativo e simbolico»96. iii) L’ultimo elemento riguarda finalmente proprio la questione del rapporto tra segni e parole. Poiché «i segni sono fatti che parlano», presentati dall’evangelista in
91 Il già citato E. Cothenet, p. 150, ritiene più attendibile la lezione il cui valore grammaticale sarebbe “confermarsi nella fede” anziché l’altra possibile per “cominciare a credere”. 92 R. Formesyn, Le semeion johannique, cit., p. 888; corsivo mio. 93 R. E. Brown, Giovanni, cit., p. 1474 arriva ad affermare che «in Giovanni la funzione primaria dei miracoli sembra essere quella del simbolismo». Contrari a tale tesi sono Rengstorf nel Grande lessico, cit., col. 152 e Schnackenburg nel suo commento, p. 485. 94 Così formula la propria contestata convinzione C. H. Dodd, Op. cit., p. 184. 95 R. Schnackenburg, Op. cit., p. 493. 96 È la conclusione a cui perviene R. Formesyn nell’articolo cit., p. 893.
40
associazione ai discorsi, «il carattere proprio e specifico dei segni, ciò per cui si diffe-renziano dalle semplici parole e dalle semplici azioni, è che il segno si colloca in un terreno di confine tra le due: il segno fa sì che la parola dal contenuto spirituale e trascendente si faccia in un certo senso visibile, e che il fatto materiale e visibile acquisisca una dimensione invisibile e trascendente»97. In altre parole, come ha osservato Bultmann, «i concetti di seméia e rhémata (lògoi) si determinano reciprocamente: il semeion — prosegue lo studioso tedesco — non è una semplice dimostrazione, ma un’indicazione parlata, un simbolo, e il rhéma non è insegnamento come comunicazione di un contenuto concettuale, ma una parola accaduta, l’avveni-mento del discorso»98. Sono osservazioni da tenere in conto nello sviluppo dell’esegesi giovannea; ma nella loro formulazione vagamente metaforica e con la finalità er-meneutico-teologica che le caratterizza, vanno al di là del dato semantico ricavabile dai campi di applicazione dei termini, al quale qui ci limitiamo. Dal nostro punto di vista il dato immediato è che nel vangelo di Giovanni (per gli altri scritti neotestamentari la questione nemmeno si pone)99 il termine semeion non è mai applicato a delle parole dette da Gesù. Più precisamente, nel testo del quarto vangelo i campi semantici di “parola” e di “segno” non si toccano. Un accostamento è rilevabile solo nei due brani in cui il verbo semáinein (che solo lì ricorre) è usato per specificare dei verbi di dire: «Diceva questo (in 12, 33; e in 18, 32: il discorso che fece) significando di che morte sarebbe morto»100. Qui però in primo luogo il contesto non è di un normale scambio linguistico ma c’è l’allusione al significato riposto di espressioni altrimenti oscure dette prima; e inoltre, anche a voler dare nella pericope a semáinein il senso forte e propriamente giovanneo di “dare un semeion”, proprio in questo caso il semeion consisterebbe non nelle parole di Gesù ma in ciò a cui rinviano: non le sue parole sarebbero il semeion, ma la sua morte in croce. Benché ci sia chi da questi passi conclude che per l’evangelista «anche le parole possono essere segni»101, è più probabile invece che qui si tratti di un uso non marcato, quale è normale riscontrare anche nella letteratura greca classica: l’attività umana del parlare (légein) può essere un indicare (semáinein) ma evidentemente può anche non esserlo; l’una cosa non implica l’altra, né l’atto risultante dalla prima (logos) si identifica con la realtà (semeion) da cui 97 L. Erdozáin, La función, cit., p. 44. Similmente K. H. Rengstorf nella voce cit., col. 149. 98 R. Bultmann, Das Evangelium des Johannes, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 196217, p. 79. Lo stesso Bultmann in Teologia del Nuovo Testamento (19777), Queriniana, Brescia 1985, p. 392 postula addirittura «l’identità tra parola e opera». 99 Per esempio, nella chiusa della cosiddetta ‘finale di Marco’ i semeia (di Gesù) accompagnano il logos degli apostoli per confermarlo (Marco 16, 20); un rapporto analogo tra logos e semeia kai térata è posto anche in Atti 14, 3. 100 I brani sono tre se si conta anche, nell’appendice, 21, 19. La traduzione Cei rende shmaivnein con indicare e la Tilc con far capire. 101 R. E. Brown, Op. cit., p. 1476; esattamente opposto il parere di Rengstorf, cit., col. 134 e nota 316.
41
si denomina la seconda. La questione è di estrema rilevanza teorica e storica e la sua portata va ben oltre il testo evangelico. Per ora, al termine di questa rapida analisi, ci basta rispondere alla domanda posta in apertura con la semplice constatazione a cui i risultati ci portano: nel quarto vangelo il termine semeion — così importante nell’economia del racconto e nell’annuncio evangelico — non è riferito all’attività linguistica e, reciprocamente, il parlare (di Gesù) non costituisce un semeion. In breve, nel vangelo di Giovanni i segni non sono parole e le parole non sono segni. 8. Fine del sermone
Il Sacerdote del Sole, con piglio tra il profetico e l’istrionico, continua il suo lungo e aggrovigliato discorso e dice che nel mondo dei bianchi il linguaggio ha cambiato natura:
L’uomo bianco dà per scontate cose come le parole e le letterature, ed è così che deve fare, poiché
nel suo mondo non esiste niente di più comune. È circondato da miliardi di parole, una massa infi-
nita di scriti e di carte, di lettere e di libri, di volantini e bollettini, di commenti e conversazioni.
Ha diluito e moltiplicato la parola, e le parole hanno incominciato a soffocarlo. È sazio e insensi-
bile; il suo rispetto per il linguaggio — per la parola stessa — come strumento creativo è dimi-
nuito a tal punto da non poter quasi tornare in vita. Può darsi che perirà a causa della parola.
Non è così nella tradizione indiana, che nutre per le parole un grande rispetto, senza mai mercanteggiarle o buttarle via. È in questo rispetto il fascino della letteratura orale e dei suoi racconti primordiali, continua il pastore, e forse «era questo, penso, che il vecchio san Giovanni aveva in mente quando disse: “Nel principio era la parola”». L’esistenza originaria senza nascita della parola che Giovanni intuì dovette essere per lui qualcosa di terribile; e Tosamah termina il sermone:
E da quel giorno la parola appartiene a noi che l’abbiamo sentita per quella che è, che abbiamo
vissuto temendola e riverendola. Nella parola era il principio; «Nel principio era la parola...»102.
102 N. Scott Momaday, Casa fatta di alba, cit., p. 104 e 106.
42
III
U n e s e m p i o d i l e t t u r a :
A t t i 4 , 1 3 * 1. Cos’è che meravigliava i sinedriti?
L’inizio degli Atti degli Apostoli racconta le prime vicende della comunità cristiana di Gerusalemme. Particolare rilievo hanno due discorsi di Pietro: quello del giorno di Pentecoste (cap. 2), e un altro che segue la guarigione di uno storpio operata dallo stesso Pietro in compagnia di Giovanni (cap. 3). È in seguito a questo secondo discorso che i due vengono arrestati e, l’indomani, interrogati (cap. 4). In risposta alle domande, Pietro di fronte alle autorità religiose torna a proclamare la propria fede. A questo punto (4, 13-14) l’autore sottolinea lo stupore degli astanti. Di cosa si stupivano i membri del sinedrio? Riportiamo il passo secondo la tradu-zione italiana più conosciuta, quella ‘ufficiale’ della Conferenza Episcopale Italiana:
Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e considerando che erano senza istruzione e popo-
lani, rimanevano stupefatti riconoscendoli per coloro che erano stati con Gesù; quando poi videro
in piedi vicino a loro l’uomo che era stato guarito, non sapevano che cosa rispondere.
Sostanzialmente simile è la resa, con franchezza, nella maggior parte delle traduzioni italiane più diffuse, andando indietro fino agli anni Cinquanta103. Franchezza si trova anche nell’antica traduzione di Giovanni Diodati, degli inizi del Seicento,
* Questo capitolo riproduce, con lievi modifiche, un articolo dal titolo La libertà di parola in Grecia e nel Nuovo Testamento gia apparso su “Segno”, 173 (1996), pp. 28-43. 103 Si confrontino, oltre la versione CEI, le seguenti altre: la Bibbia concordata («vedendo la fr. di P. e di G., e avendo appreso che erano uomini illetterati e popolani»), la traduzione di Fabris («Considerando la fr. di P. e di G. e rendendosi conto che si trattava di uomini senza cultura e gente del popolo»), quella di Rossano («Vedendo la fr. di P. e di G., e riflettendo che erano popolani e illetterati»), di Galbiati («Vedendo la fr. di P. e di G., e riflettendo fra loro che erano della gente semplice e illetterati»), di Garofalo («Vedendo però la fr. di P. e di G. e comprendendo che si trattava di persone illetterate e incolte»), di Nardoni («Vedendo la fr. di P. e di G. e saputo che erano uomini illetterati e ordinari»), di Piatti per il Pontificio istituto biblico («vedendo la fr. di P. e di G., e sapendo che erano uomini illetterati e popolani»), di Ricciotti («Osservando allora la fr. di P. e di G., ed avendo appreso ch’erano uomini illetterati e plebei»); lo stesso nella traduzione unica che accompagna i diversi commenti di studiosi tedeschi pubblicati dall’editrice Paideia («vedendo la fr. di P. e G. e comprendendo che si trattava di uomini illetterati e semplici»).
43
rimasta per secoli la traduzione protestante per eccellenza104. Per converso la tradizionale traduzione cattolica autorizzata, fatta da Antonio Martini alla fine del Settecento e ancora in uso fino agli anni Quaranta di questo secolo minimamente ritoccata da Sales, aveva costanza105, scelta motivata però dal fatto che la versione non era stata condotta sui testi originali bensì sulla Vulgata latina di san Girolamo, poi definitivamente fissata dopo il Concilio di Trento, dove infatti si legge constantiam106. La cosiddetta Neovulgata, promossa dopo il Concilio Vaticano secondo, ha sostituito qui constantia con fiducia («Videntes autem Petri fiduciam et Ioannis»), tornando con ciò, peraltro, alle più antiche traduzioni latine e uniformando, come vedremo, la scelta. In ogni caso, quel che è certo è che oggi nelle bibbie italiane domina per questo passo la traduzione con franchezza. Ma, viene da domandarsi, cosa c’entra la franchezza in un contesto del genere? Il dubbio è legittimo, ed evidentemente è sorto anche a quei pochi traduttori recenti, non meno autorevoli degli altri, che rendono la frase senza franchezza: traducono infatti con coraggio Carlo Maria Martini nella Nuovissima versione dai testi originali delle Edizioni Paoline107, Papa in un suo commento per le Edizioni Dehoniane108, e Ghidelli nell’edizione maggiore della Bibbia Marietti109. Nell’edizione italiana Studium di un commento francese — da notare — Massi dà invece sicurezza110. Le cose si complicano se si dà anche solo un’occhiata a qualche traduzione in altre lingue moderne. Per il francese è costante, appunto, assurance, in bibbie dei primi del secolo come pure nella Traduction Œcuménique de la Bible e nell’autorevolissima Bible de Jérusalem111. L’edizione inglese di questa pure ha assurance112, mentre l’antica traduzione detta di re Giacomo aveva boldness113. In una bibbia portoghese si trova desassombro114; in una spagnola, libertad115. Lutero nella sua classica traduzione
104 «Veduta la fr. di P., e di G.; ed avendo inteso ch’erano uomini senza lettere, ed idioti». 105 «Vedendo quelli la costanza di P., e di G.; sapendo per certo che erano uomini senza lettere, e idioti». 106 «Videntes autem Petri constantiam, et Ioannis, comperto quod homines essent sine litteris, et idiotæ». 107 «Vedendo il coraggio di P. e di G. e comprendendo d’altra parte che si trattava di uomini illetterati e sem-plici». 108 «Vedendo il coraggio di P. e G. e considerando che erano uomini illetterati e semplici». 109 «I membri del Consiglio si meravigliarono nel constatare quanto coraggio avessero P. e G.: eppure erano persone molto semplici e senza cultura». 110 «Vedendo la sicurezza di P. e di G., e constatando che erano uomini comuni e senza istruzione». 111 «Considérant l’assurance de Pierre et de Jean et se rendant compte que c’étaient des gens sans instruction ni culture». 112 «They were astonished at the assurance shown by Peter and John, considering they were uneducated lay-men». 113 «Now when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marvelled». 114 «Ao verem o desassombro de Pedro e de Joâo e percebendo que eram homens iletrados e plebeus». 115 «Viendo la libertad de Pedro y Juan, y considerando que eran hombres sin letras y plebeyos».
44
tedesca della Bibbia ancor più sorprendentemente optò per Freudigkeit116. Allora, cos’è che meravigliava gli inquisitori degli Apostoli? Tenendo conto della preferenza italiana per franchezza, si tratta di qualcosa che, al di là delle differenze di lingua, viene denominato in maniere alquanto diverse e il cui significato è da precisare. 2. Un’occhiata ai dizionari
Cominciamo proprio da franchezza. Il Tommaseo dà la solita ovvia pseudodefini-zione («Qualità di persona franca, o di cosa fatta o detta francamente. In senso morale, ch’è uno de’ più comuni oggidì») che rimanda alla voce franco; dove però all’inizio è posta piuttosto la premessa di un discorso che una definizione da vocabolario: «Dal nome d’una nazione [...] è venuto questo aggettivo comune a significare varie disposizioni e mezzi e condizioni ed effetti di libertà»; e infatti da qui prendono l’avvio svariate colonne di osservazioni per noi troppo dispersive. Qualcosa di più definito si ricava dalle definizioni d’apertura delle varie accezioni registrate dal Grande dizionario della lingua italiana della Utet:
1. Ant. e letter. Libertà da uno stato di servitù o di dipendenza; libertà d’azione, assenza di obbli-
ghi, di costrizioni; affrancamento, liberazione. — Anche: spirito di libertà, di indipendenza.
2. Purezza d’animo, onestà, lealtà; atteggiamento o comportamento schietto, spontaneo, privo di
ogni affettazione o ipocrisia; sincerità, aperta confidenza.
3. Coraggio, ardimento; forza d’animo; valore, bravura, fierezza.
4. Sicurezza, decisione, perentorietà; risolutezza, prontezza; facilità d’espressione o d’esecuzione.
5. Naturalezza, scorrevolezza, immediatezza, nitore (di uno stile, di un discorso o un linguaggio).
Tolti il significato originario 1 non più corrente e l’accezione rara “speditezza” di 5, a ben guardare franchezza risulta toccare due diverse aree semantiche: una della “sincerità” (2), l’altra che possiamo chiamare della “sicurezza” (3 e 4); aree semantiche talmente distinte da poter avere, nella seconda accezione, l’espressione mentire con franchezza, che sarebbe un controsenso secondo la prima accezione. La partizione del significato di franchezza in due aree, ben fissata nella sintetica definizione del Devoto-Oli («Evidente sicurezza nell’affrontare persone o situazioni / Sincerità, schiettezza», con l’aggiunta di «disinvoltura (non sempre gradita)» ascrivibile senza forzature all’area della “sicurezza”), è attestata con maggiore o minore evidenza da tutti i
116 «Sie sahen aber an die Freudigkeit Petri und Johannis, und verwunderten sich; denn sie waren gewiß, daß es ungelehrte Leute und Laien waren».
45
vocabolari generali e dai dizionari dei sinonimi117. Ora, se è vero che l’accezione di “sicurezza” nel senso di “coraggio” è storicamente precedente118, è vero pure che molte delle opere lessicografiche citate la registrano come più rara o antica o letteraria o non comune119. Non solo: da un piccolo sondaggio empirico personale è risultato che su trenta persone richieste di dare due sinonimi di franchezza u n a s o l t a n t o ha indicato, e come seconda scelta, una parola rientrante nell’area della “sicurezza”; le altre cinquantanove scelte si sono tutte orientate in senso lato verso l’area della “sincerità”120. Detto altrimenti, l’accezione “sicurezza-coraggio” di franchezza è roba da libri e da vocabolari, ma è praticamente assente dalla coscienza linguistica dei parlanti dove invece domina incontrastata quella relativa alla “sincerità”. A ciò si aggiunga — anche se non è segnalato nei dizionari — che l’area della “sincerità-schiettezza-lealtà” presuppone destinatari coi quali l’agente si trovi in un qualche rapporto di confidenza, mentre al contrario coloro verso cui mostri “sicurezza-coraggio” devono essere in qualche modo una sua controparte. Del secondo tipo è ap-punto la situazione esposta in Atti 4,13, ma questa sua natura conflittuale o rischia di perdersi, attratta dalla valenza moderna e attuale di franchezza come “sincerità (nei confronti di qualcuno con cui si ha confidenza)”, oppure, se ben compresa, contrasta comunque con tale valenza ormai prevalente. Insomma, chi legge il passo in questione nella maggior parte delle traduzioni italiane è indotto a ritenere erroneamente che lo stupore dei notabili israeliti fosse dovuto alla buona disposizione degli Apostoli ad an-dar loro incontro comunicando qualche verità inattesa e scomoda eppure utile. In effetti nella breve risposta alle domande Pietro ha menzionato la crocifissione di Gesù da parte dei suoi interroganti, ma proprio un atto del genere in quelle circostanze semigiudiziarie sarebbe assai meglio qualificabile come “coraggio” che come “sincerità”.
117 Si vedano, tra franchezza e franco, per i primi, Zingarelli, Garzanti, Palazzi-Folena, Dir, Dàrdano, De Felice-Duro, Gabrielli e il nuovo Treccani; per i secondi, il vecchio Prèmoli, Cinti, Pittàno, Gabrielli, Quartu, De Felice, Folena-Leso, il Garzanti e naturalmente l’immancabile Tommaseo, che tratta la voce sotto le rubriche: fr., lealtà; franco, verace, sincero, schietto, ingenuo; franco, manieroso, disinvolto, spiritoso, vivace, brioso; fr., libertà; fr., fidanza, baldanza. 118 Non per caso è la sola adoperata nella Divina Commedia: «perché ardire e franchezza non hai?»; «i’ cominciai come persona franca» (Inf., II,123.132). 119 Si tratta di Zingarelli, Garzanti, Palazzi-Folena, Gabrielli, Treccani e, fra i dizionari dei sinonimi, di Folena-Leso e Garzanti. Anche spulciando tra le schede dei sinonimi di Tommaseo l’accezione “sincerità” appare prevalente: «L’uomo franco è retto e animoso [...]. La sincerità mi vieta parlare altrimenti da quel ch’io penso; la fr. mi fa parlare com’io penso e sento [...]. Schietto, chi dice con semplicità non sciocca quello che sente, chi non simula; franco, chi dice e opera con libertà, né dissimula [...]. La fr. è talvolta dovere [...]. L’uomo franco sovente dispiace [...]. La fr. viene dalla dignità e dalla forza dell’animo; invano la chiedi al tiranno e allo schiavo. [...] Fr. è libertà di parlare e fare senza dissimulazione; la fr. dice e opera come sente [...]. Libertà, nelle parole e ne’ sentimenti; fr., più propriamente, nelle parole e negli altri esterni segni. [...] La fr. è d’uomo libero da timore, da riguardi, o da vani sospetti». 120 I risultati completi sono i seguenti (i numeri tra parentesi indicano quante volte la parola è stata indicata come primo sinonimo e quante come secondo): sincerità (10, 8), schiettezza (8, 3), lealtà (4, 5), chiarezza (4, 3), apertura (2, 0), onestà (1, 4), correttezza (1, 0), trasparenza (0, 2), spontaneità (0, 1), coraggio (0, 1), immediatezza (0, 1), autenticità (0, 1), veracità (0, 1). Come si vede, delle tredici parole solo coraggio è ascrivibile all’area della “sicurezza”.
46
E tuttavia, anche così, il passo è lungi dall’essere appianato. L’accenno immediata-mente successivo alla collocazione sociale di Pietro e di Giovanni è infatti incompati-bile con qualunque delle due accezioni fondamentali di franchezza, perché la frase implicitamente verrebbe a dire che di norma gli individui «senza istruzione e popolani» sono privi di franchezza-“sincerità” ovvero di franchezza-“coraggio”, al punto da suscitare meraviglia quando, com’è qui il caso, se ne mostrassero dotati. Francamente, una spiegazione assurda e in definitiva impossibile. Più plausibile sarebbe la franchezza nel senso di “disinvoltura”, che spiegherebbe la meraviglia di chi la osserva in persone culturalmente sprovvedute, ma abbiamo già rilevato la relativa rarità di questa accezione nell’uso comune. Da questo punto di vista risultano meno equivoci i sostituti stranieri di franchezza nelle altre lingue esaminate, in quanto — tranne il tedesco Freudigkeit adottato da Lutero, che appartiene senz’altro all’area semantica della “gioia” — sono orientati piuttosto sul versante della “sicurezza”: così è del francese assurance “fiducia in se stessi”, degli inglesi assurance (stesso significato) e boldness “risolutezza, coraggio”, per non dire del trasparente spagnolo libertad. Diverso sarebbe il caso del portoghese desassombro “mancanza di ombre, apertura”, ma non è da trascurare a tal proposito la presenza, sia nel portoghese sia nelle altre lingue, dell’esatto equivalente lessicale di franchezza: il portoghese ha franqueza come lo spagnolo, il francese ha franchise, l’inglese ha frankness; parole tutte specificamente deputate all’area della “sincerità-schiettezza”, che i traduttori volendo avrebbero potuto benissimo adottare in questo senso nel passo in questione. Resta però in ogni caso anche per queste traduzioni, nonostante la maggiore univocità di significato, una certa contraddizione con l’osservazione di natura sociale richiamata poco fa; quasi che la gente comune e poco istruita non possa mostrare di possedere assurance, boldness, desassombro, libertad o Freudigkeit. Insomma, cos’è che meravigliava i sinedriti? Se non si riesce ancora a capire bene è perché qualcosa non convince nelle traduzioni finora viste, comprese quelle latine. Bisogna perciò andare direttamente all’originale. 3. Una storia istruttiva
Non pretendevamo certo di venire a capo del brano a forza di considerazioni estravaganti su versioni raccolte più o meno casualmente. Volevamo soltanto preparare il terreno all’esame di una parola dalla storia istruttiva. Veniamo allora finalmente al testo greco di Atti 4, 13-14:
47
[... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...].
Quel che ha mosso la nostra indagine dunque non è altro che la parrhesía. La storia semantica della parola, dalle prime attestazioni fino al monachesimo cristiano, è stata ottimamente ricostruita più di trent’anni fa da Giuseppe Scarpat121; sull’idea di parrhesía poi Michel Foucault tenne delle lezioni negli ultimi mesi di vita limitandosi però alla grecità antica122. Di tale storia riprenderemo qui i tratti essenziali per far luce sul brano neotestamentario al centro della nostra attenzione, dove il vocabolo assume una valenza forse non sufficientemente messa in rilievo dagli specialisti.
3.1. Diritto di parlare Come attesta ogni vocabolario greco, parrhesía vuol dire “libertà di parola”, ed era il nome della prerogativa che costituì l’ideale e il blasone degli ateniesi, «il palladio della loro democrazia»123: la possibilità per i cittadini di intervenire nell’assemblea. Il vocabolo appare tardi nella documentazione scritta proprio per il suo rapporto intrinseco con quella esperienza politico-culturale «fondata sulla pratica del discorso»124. Nei secoli precedenti per i greci l’uomo libero era semplicemente l’opposto dello schiavo, e la caratteristica dell’uomo buono era piuttosto la aidós “modestia, rispetto” che implicava semmai il ritegno nel parlare; perciò, «nella Grecia arcaica la nozione di libertà non comprendeva la libertà di parola»125. Con le guerre persiane la libertà assunse un significato più pienamente politico e passò a designare l’avversione al dispotismo propria dei greci; ne venne così favorita la sua associazione all’idea di democrazia, fino alla connessione stretta tipica della Atene del quinto secolo a. C. È nel pensiero democratico dell’età di Pericle che «la libertà di parola appare come uno degli ingredienti più importanti e necessari della eleuthería »126, e da qui si diffonde parrhesía come sua denominazione e quasi termine tecnico. Il 121 Parrhesía. Storia del termine e delle sue traduzioni in latino, Paideia, Brescia 1964. 122 La trascrizione delle lezioni, tenute a Berkeley (SUA) sul finire del 1983, è appena apparsa in italiano: Discorso e verità nella Grecia antica (1985), Donzelli, Roma 1996. 123 Max Pohlenz, La libertà greca (1955), Paideia, Brescia 1963, p. 39. 124 Luciano Canfora, L’agorà: il discorso suasorio, in G. Cambiano, L. Canfora, D. Lanza (a cura di), Lo spazio letterario della Grecia antica, vol. I: La produzione e la circolazione del testo, tomo I: La polis, Salerno, Roma 1992, pp. 379-395, a p. 379. Il riferimento è all’esperienza ateniese; sulla tradizionale laconicità spartana, o forse dorica, Andrea Cozzo, Note sulla condotta linguistica degli Spartani, in Aa. Vv., Studi di filologia classica in onore di Giusto Monaco, Facoltà di Lettere e filosofia, Palermo 1991, vol. IV, pp. 1371-1378. Sulle varie modalità di trasmissione delle informazioni, Oddone Longo, Tecniche della comunicazione nella Grecia antica, Liguori, Napoli 1981. Per quel che riguarda la centralità dell’oralità e il suo rapporto con la scrittura nella Grecia classica gli studi sono ormai troppo numerosi e conosciuti perché sia necessario farne menzione qui. 125 Arnaldo Momigliano, Libertà di parola e tolleranza religiosa nel mondo antico, in Sally C. Humphreys, Saggi antropologici sulla Grecia antica (1978), Pàtron, Bologna 1979, pp. 351-369, a p. 357. 126 Arnaldo Momigliano, La libertà di parola nel mondo antico (1971), ora in Sesto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, tomo secondo, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1980, pp. 403-436, a p. 426; si tratta di una magistrale ricostruzione sintetica delle forme storiche di attuazione della libertà di parola dalle civiltà mesopotamiche alla Roma imperiale, ulteriormente riassunta nell’articolo citato alla nota precedente. Questo saggio più esteso soprattutto andiamo qui seguendo anche in assenza di citazione esplicita.
48
legame tra le due nozioni appare già in un frammento dubbio di Democrito (il 226) dove si legge che «propria della libertà è la parrhesía, il pericolo sta nel riconoscere il momento giusto»; le prime attestazioni sicure però sono una in Aristofane (Tesmofo-riazuse 540-1: «dato che c’è parrhesía, noi siamo cittadine e possiamo parlare») e nove in Euripide, dove designa precisamente il correlato principale del diritto di cittadinanza:
Che la mia genitrice sia di Atene, affinché da parte di madre io abbia parrhesía. Poiché se uno
straniero arriva in una città incontaminata, anche se a parole [variante: in base alle leggi] è un
cittadino, ha la bocca da schiavo e non ha parrhesía (Ione 671-5).
I miei figli possano vivere liberi e in parrhesía nella gloriosa Atene (Ippolito 421-3].
— Qual è l’inconveniente per gli esuli? — La cosa più grave è non avere parrhesía. — Ma è roba
da schiavi, non poter dire ciò che si pensa! (Fenici 390-2).
Fa eco a questa affermazione un frammento di Demostene: «Per gli uomini liberi non c’è sventura più grande che perdere la parrhesía» (Stobeo 3, 13, 32). Per la via del diritto di cittadinanza, la forma di libertà che è la libertà di parola si incontra con l’idea e la pratica della democrazia. Una pratica talmente sentita da diven-tare costume della vita civile e culturale che trovava il suo luogo proprio nella comme-dia: «La libertà della commedia rientrava nella libertà di parola, nella parrhesía, che concedeva all’individuo di “dire tutto ciò che voleva”; né il popolo era disposto a per-mettere che si scuotesse questo pilastro della sua democrazia»127. Proprio questo radica-mento della parrhesía nel costume diffuso potè portare però allo svuotamento di essa in quanto conquista politica e favorire una deriva della partecipazione verso il deperi-mento delle sue forme rappresentative; è quel che mostra in situazione ancora Demo-stene attestando in due occorrenze vicine la bivalenza tra il politico e il civile:
Ateniesi! Se vi dico delle verità con parrhesía, vi chiedo di non reagire con l’ira. Pensate: in ogni
altro campo voi la parrhesía l’avete estesa a tutti quelli che sono in città, l’avete concessa anche
agli schiavi e agli stranieri. Hanno più diritto (eksousía) di dire ciò che vogliono molti schiavi qui
da noi che dei cittadini in altre città. Ma nelle decisioni politiche l’avete bandita [la parrhesía]. E
così, mentre in assemblea vi lasciate adulare da discorsi lusinghieri, nella realtà state quasi per
soccombere. Se anche adesso il vostro atteggiamento è questo, non ho nulla da dire. Se invece
siete disposti ad ascoltare ciò che vi giova, senza eufemismi, sono pronto a parlare (Terza
Filippica 3; trad. di L. Canfora, modificata).
127 Così Pohlenz, op. cit., p. 62; cfr. pure G. Scarpat, Parrhesia, cit., p. 49: «Nessuna cosa stette più a cuore al popolo ateniese che la parrhesia della commedia». Soprattutto sulla commedia e sui limiti ad essa posti è incentrato Max Radin, Freedom of speech in ancient Athens, «American journal of philology», 48 (1927), pp. 215-230.
49
Per quanto riguarda il partecipare alla cosa pubblica esprimendo liberamente il pro-prio parere i greci avevano già un altro sostantivo, isegoría, che, imparentato con iso-nomía («il nome più bello di tutti»: Erodoto 3, 80, 6), divenne senz’altro una delle de-nominazioni della democrazia in quanto uguaglianza: «Libertà di parola (parrhesía) o uguaglianza di parola (isegoría): le due espressioni costituiscono le più costanti conno-tazioni della democrazia della città; la seconda, per un certo tempo, tiene addirittura luogo della definizione stessa di democrazia. L’intervento verbale è dunque avvertito soggettivamente non soltanto come la garanzia della convivenza democratica, ma come la condizione necessaria strutturale del sistema. Non libertà di parola destinata a garan-tire l’espressione di una libertà di pensiero, cioè di escogitazione intellettuale, riservata a una cerchia ristretta di operatori culturali (per questa libertà nel greco, anche nel greco di Atene, manca significativamente il vocabolo), ma libero accesso di tutti i cittadini al parlare, al parlare in pubblico, alla discussione che precede ogni decisione collet-tiva»128. In questo quadro i due vocaboli rinviavano sì l’uno all’altro, ma con accentuazioni differenti: «uno (parrhesía) sottolineava il diritto di dire qualsiasi cosa, l’altro (isegoría) l’uguaglianza di libertà di parola all’interno di una certa sfera, che poteva includere persino gli schiavi»129. E ancora: «Isegoría implicava l’uguaglianza della libertà di parola, ma non necessariamente il diritto di dire ogni cosa. D’altra parte parrhesía sembra una parola inventata da una mente vigorosa, per la quale la vita democratica implicava libertà da inibizioni tradizionali»130. Invenzione evidentemente motivata dall’appannarsi, nel termine già esistente, dell’originario riferimento linguistico rispetto a quello egualitario; così, «che la polis ateniese pur usando largamente in senso politico il termine isegoría, [...] abbia coniato a un certo momento anche il termine parrhesía, si spiega solo col desiderio di voler portare l’accento sul “dire”, aspetto tanto caro ai Greci, mentre l’isegoría accentuava il concetto di “uguaglianza” come tutti i composti in iso-»131.
3.2. La cosa più bella Il primo campo di applicazione di parrhesía è dunque politico132. Ma come nelle
128 Diego Lanza, Lingua e discorso nell’Atene delle professioni, Liguori, Napoli 1979. 129 A. Momigliano, Libertà di parola e tolleranza religiosa, cit., p. 358. 130 Id., La libertà di parola , cit., p. 429. 131 G. Scarpat, Op. cit., p. 29. 132 Politico ma pur sempre con riferimento a fruitori singoli, giacché un collegamento tra l’idea filosofica di libertà e quella di nazione si avrà solo col cristiano Bardesane (Bar Daisan, siriaco di Edessa) nel suo Dialogo delle leggi e dei paesi scritto intorno al 216 (trad. it. a cura di G. Levi della Vida, Libreria di Cultura, Roma 1921). Su questo dato richiamò l’attenzione Santo Mazzarino nel cap. 11 (Nazioni, “democrazie”, libertà) de La fine del mondo antico (1959), Rizzoli, Milano 1988, pp. 165-166 e nel Pensiero storico classico, Laterza, Bari 1966, vol. I, p. 316 e vol. II t. II, pp. 185 e 396.
50
lingue moderne attributi di originaria attinenza politico-sociologica (del tipo civile, vil-lano, nobile) diventano qualifiche del carattere o del comportamento, «così nel mondo greco l’eléutheros è l’uomo nobile, di sentimenti elevati, alieno da bassezze e servilismi, che si distingue dallo schiavo per la sua franchezza (parrhesía) e mancanza di paura»133. A partire dall’ambito di base sopra descritto, mentre isegoría mantenne sempre il valore esclusivamente politico, parrhesía subì un duplice slittamento di significato dal politico al morale e dal pubblico al privato. Come ha scritto Scarpat, «la democrazia aveva garantito a tutti il diritto di parlare in pubblico nelle assemblee deliberative e la possibilità di dire in privato anche le cose sgradevoli. Ma tale parrhesía, che aveva bisogno dell’assoluta libertà per esercitare i suoi diritti, assurgeva alla dignità di grande virtù morale solo a patto che si mettesse a servizio della verità. Così il termine passa ben presto a significare “dire la verità, dire con franchezza, con coraggio, apertamente, pubblicamente”»134. Delle varie sfumature della parrhesía, precisamente quest’ultima, di “dire la verità”, è quella isolata o quanto meno privilegiata da Foucault nelle sue lezioni, così precisata rispetto alle nozioni con cui si interseca: «La parrhesía è un tipo di attività verbale in cui il parlante ha uno specifico rapporto con la verità attraverso la franchezza, una certa relazione con la propria vita attraverso il pericolo, un certo tipo di relazione con se stesso e con gli altri attraverso la critica [...], e uno specifico rapporto con la legge morale attraverso la libertà e il dovere. [...] Nella parrhesía il parlante fa uso della sua libertà, e sceglie il parlar franco invece della persuasione, la verità invece della falsità o del silenzio, il rischio di morire invece della vita e della sicurezza, la critica invece dell’adulazione, e il dovere morale invece del proprio tornaconto o dell’apatia morale»135. Il risalto dato da Foucault al rapporto con la verità appare eccessivamente marcato se lo si prende come indicatore unico del significato complessivo e dell’intera storia della parrhesía. Tuttavia è fuor di dubbio che la libertà di parlare, ossia la possibilità di dire tutto ciò che si vuole, sul piano individuale diventò “non aver peli sulla lingua”, “esser franchi”; ed è questa l’accezione in cui veniva intesa da Aristotele (più il verbo e l’aggettivo che il sostantivo), ossia l’accezione morale riferita al comportamento individuale. La parrhesía indicò insomma la qualità di chi non adula i superiori e non tace all’amico le cose sgradevoli. Non solo in senso virtuoso. Da “diritto di intervento in assemblea” a “eccesso ver-bale” il passo è breve, e infatti uno dei significati di parrhesía fu anche “abuso della 133 Rudolf Bultmann, Il significato dell’idea di libertà per la civiltà occidentale (1952), in Credere e compren-dere, Queriniana, Brescia 1986, pp. 627-644, a p. 629. 134 G. Scarpat, Op. cit., p. 58. 135 M. Foucault, Op. cit., p. 9-10.
51
libertà di parola”, nella vita associata come nella sfera privata, e quindi anche “linguaggio demagogico”, “sfacciataggine”, “maldicenza”. Insomma, col mutare delle situazioni politiche e la conseguente perdita delle libertà, la parrhesía «diventò una virtù di filosofi» e altresì «una condotta coraggiosa verso i tiranni e gli imperatori»136. Una virtù individuale, dunque, ma che continuava a mantenere forti valenze di pubblicità: «Se la parrhesía per il cittadino ateniese fu sinonimo di libertà, il diritto più gelosamente ambito e difeso, in periodo ellenistico essa divenne la conquista faticosa del filosofo cinico, il suo vanto, il suo patrimonio, la sua assoluta libertà di dire in faccia a chiunque quanto gli pareva»137. A chi gli domandava quale fosse la cosa più bella per gli uomini, Diogene rispondeva: la parrhesía (Diogene Laerzio 6, 69).
3.3. La saggezza del giusto L’evoluzione semantica di parrhesía in senso morale prepara l’estensione del suo uso all’ambito religioso. Nella Bibbia dei Settanta la famiglia lessicale appare piuttosto raramente (dodici volte il sostantivo e sei il verbo), ma «rispetto al greco profano abbiamo un nuovo uso del concetto»138. Nuovo è il riferimento all’atteggiamento di Dio, la cui parrhesía consiste nel “mostrarsi con splendore”. Una novità ben più importante è però l’applicazione che vien fatta del vocabolo all’attitudine mostrata dal credente non soltanto davanti agli altri uomini, ma altresì al cospetto di Dio stesso: elemento, questo, del tutto assente nei testi ellenistici. Così, se in Levitico 26,13 parrhesía traduce una radice ebraica che significa “stare in piedi a testa alta” (e tale significato, secondo qualcuno139, «rimarrà fondamentale in tutti gli impieghi posteriori della parola, tanto nella Bibbia quanto nei Padri»), in Giobbe 22,26 rende un’altra radice avente il valore di “gioia e compiacimento”. La letteratura giudeo-ellenistica, e Filone in particolare, aggiunge questa idea veterotestamentaria alla serie di significati già visti, che sono in lui prevalenti, nell’accezione morale; nei suoi scritti la parrhesía indica la saggezza — solitamente manifestata nel linguaggio — di cui dà prova il giusto in quanto è consapevole della propria buona coscienza, un atteggiamento che «presuppone l’adempimento della legge, la giustizia e la pietà»140.
136 A. Momigliano, La libertà di parola , cit., p. 430. 137 G. Scarpat, Op. cit., p. 102. 138 H. C. Hahn, s. v., in L. Coenen, E. Beyrenther, H. Bietenhard (a cura di), Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento (1970), Edizioni Dehoniane, Bologna 1976, pp. 729-730, a p. 729. 139 H. Jaeger, Parrhesía et fiducia. Etude spirituelle des mots, «Studia patristica» , 1 (1959), pp. 221-239, a p. 223. 140 H. Schlier, Parrhesía, parrhesiázomai, in Grande lessico del Nuovo Testamento, vol. IX (1954-59), Pai-deia, Brescia 1974, coll. 877-932, a col. 901.
52
Se il discorso è pieno di parrhesía, la mente lo è tanto più di libertà [variante: di parrhesía] (Quod
omnis probus liber sit 95).
Gli ignoranti, dunque, è meglio che facciano silenzio: ma per gli uomini che aspirano alla scienza
e sono amanti del loro Signore, la parrhesía è un possesso prezioso e necessario (Quis rerum divi-
narum heres sit 14)141.
Se qualcuno è degno di onore non vanti se stesso innalzandosi e comportandosi insolentemente,
ma rispetti l’uguaglianza condividendo la parrhesía con gli ignoranti (De specialibus legibus 4,
74).
Io mi nutro insaziabilmente di questa mescolanza che mi ha persuaso a non usare la parrhesía
[parrhesiázesthai] senza rispetto e a non essere rispettoso senza parrhesía [aparrhesiástos] (Quis
rerum divinarum heres sit 29).
In questa concezione la parrhesía può addirittura apparire come uno degli attributi di Dio stesso: «Ma tu, per me, o Padrone, sei la patria, la famiglia, la casa paterna; Tu sei il mio onore, la mia parrhesía, la mia grande, gloriosa, inalienabile ricchezza» (ibid. 27).
3.4. Parentesi latina Rispetto ad Atene e agli stati liberali moderni, nel mondo romano la libertà di parola era molto meno sentita in quanto parte costitutiva della libertà. Nella stessa Roma repubblicana, non è dato trovare l’idea di libertà associata esplicitamente a quella di libertà di parola: da una parte, «nel complesso, la libertà di parola apparteneva alla sfera della auctoritas piuttosto che a quella della libertas»142; dall’altra parte «la eleuthería, con l’isonomía e la parrhesía quali sue espressioni principali, appariva ai Romani più vicina alla licentia che alla libertas»143. Del resto non è un caso che nel latino profano non si riscontrino tentativi dichiarati di tradurre parrhesía con un vocabolo equivalente, tranne in ambito retorico, dove la figura così designata prende appunto il nome tecnico di licentia; il che mostra già lo slittamento di questo vocabolo dal significato etimologico originario di “facoltà” a quello poi prevalente di “eccesso”.
141 Quello della parrhesía del giusto davanti a Dio è il tema portante dei primi capitoli dell’opera. Qui seguiamo la traduzione di R. Radice da L’erede delle cose divine, Rusconi, Milano 1981, restituendo parrhesía al posto di libertà di parola. 142 Arnaldo Momigliano, recensione a L. Robinson, Freedom of speech in the roman Republic (1942), ora in Quinto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, tomo secondo, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1975, pp. 949-958, a p. 957. 143 Charles Wirszubski, Libertas as a political idea at Rome during the late Republic and early Principate, Cambridge University Press, Londra 1950, p. 13 (trad. it. Laterza, Bari 1957).
53
Diversa la scelta fatta nel latino cristiano, che sposta la resa lessicale verso un’area semantica totalmente differente. La traduzione di parrhesía di gran lunga prevalente nella Vulgata di san Girolamo è infatti quella con fiducia, che al significato di “sicurezza” e “certezza” giuridica aveva sovraordinato una sfumatura relativa alla “tranquillità” morale. Su questa base, «alcuni traduttori biblici usarono fiducia anche quando parrhesía aveva significati assolutamente intraducibili con tale termine»; così facendo, «traducevano con evidenza (talora eccessiva) le sfumature del termine parrhesía, ma ne sacrificavano il primitivo ed intimo valore»144. 4. La parrhesía dei primi cristiani
Negli scritti del Nuovo Testamento il verbo parrhesiázesthai appare nove volte, e trentuno volte il sostantivo parrhesía. Quest’ultimo «è usato per l’opera di Cristo in Giovanni, per la predicazione del vangelo negli Atti, per l’attività dell’apostolo in Paolo, per la sicurezza della fede nella lettera agli Ebrei, per la confidenza davanti a Dio nella prima lettera di Giovanni»145. Ma vediamo la situazione in dettaglio.
4.1. I vangeli e le lettere Nel vangelo di Giovanni si registrano nove occorrenze del sostantivo, riferite per lo più a Gesù, tutte al dativo con funzione avverbiale e tutte meno una dipendenti da verba dicendi; il senso, chiarissimo, è quello di parlare “manifestamente” e in più “apertamente”, cioè in maniera esplicita anziché in parabole. Del significato originario di “parlare liberamente” resta l’idea di base dell’agire, parlando o no, “in pubblico” e dunque senza timori o ritegni di sorta146.
7, 4: «Quando uno vuole essere conosciuto», letteralmente: «cerca di essere in parrhesía»;
7, 13: «Nessuno parlava di lui apertamente»;
7, 26: «Quest’uomo parla in pubblico senza paura»;
10, 24: «Se tu sei il Messia, dillo apertamente»;
11, 14: «Allora Gesù disse chiaramente»;
11, 54: «evitava di andare e venire pubblicamente»;
16, 25: «vi parlerò con parole chiare»;
16, 29: «Sì, ora parli con chiarezza»;
144 G. Scarpat, Op. cit., p. 134 e 143. 145 W. C. van Unnik, The christian’s freedom of speech in the New Testament, «Bulletin of the John Rylands Library», 44 (1962), pp. 466-488, a p. 487; l’articolo esamina minutamente tutte le occorrenze. 146 Per i motivi detti nel capitolo primo, citiamo i passi neotestamentari seguendo la Traduzione intercon-fessionale in lingua corrente (Tilc). In corsivo le parole che traducono parrhesía.
54
18, 20: «Io ho parlato chiaramente al mondo».
Lo stesso significato in Marco 8, 32: «Parlava di queste cose molto chiaramente»147. Solo col
valore di “pubblicamente”, senza rapporto alcuno col parlare, nella lettera di Paolo ai Colossesi 2,
15: «le ha fatte diventare come prigionieri da mostrare [il testo precisa: «in parrhesía»] nel
corteo».
La prima lettera di Giovanni presenta quattro occorrenze che sono invece rette da ekho e riferite ai fedeli, i quali vengono esortati ad ‘avere parrhesía’ nei confronti di Dio, ossia, come in Filone, un sentimento di tranquillità e confidenza. Resta in ombra — e tuttavia non escluso — l’esprimersi verbalmente; e si può dire che lo stato d’animo a cui Giovanni invita è il residuo della “sicurezza” provata da chi un tempo praticava la “libertà di parola” cosciente di esercitare un proprio diritto.
2, 28: «quando verrà, potremo stare a testa alta»;
3, 21: «ci possiamo rivolgere a Dio con piena libertà»;
4, 17: «ci sentiamo sicuri per il giorno del giudizio»;
5, 14: «ci rivolgiamo a Dio con fiducia».
Nelle quattro occorrenze della lettera agli Ebrei, dove pure manca ogni riferimento esplicito al “parlare”, la valenza del termine è simile, con un risalto maggiore per il ruolo della mediazione del Cristo nel far sì che si possa avere parrhesía.
3, 6: «E quella casa [di Cristo] siamo noi, se conserviamo la libertà e la speranza di cui ci van-
tiamo», letteralmente: «la parrhesía e il vanto (káukhema) della speranza»;
4, 16: «Dunque [dato che il Figlio di Dio ha sofferto come noi] accostiamoci con piena fiducia a
Dio»;
10, 19: «ora [dopo il sacrificio di Gesù] siamo liberi di entrare nel luogo santo del cielo»;
10, 35: «Dunque [per lo stesso motivo] non perdete il vostro coraggio».
Un accostamento della parrhesía al vanto, tema eminentemente paolino, è presente anche nella
seconda lettera ai Corinzi 7, 4: «Sinceramente, sono molto fiero di voi», letteralmente: «ho molta
parrhesía per voi, ho molto orgoglio (káukhesis) di voi».
Del duplice orientamento della parrhesía, verso Dio e verso gli uomini, nelle lettere di Paolo, dove appare otto volte il sostantivo e due volte il verbo, prevale piuttosto il secondo come caratteristica connessa in senso lato alla testimonianza di fede. Benché il legame con un’attività discorsiva in atto non sia sempre espressamente indicato, tuttavia il contesto delle occorrenze è tale da non escluderlo in linea di principio.
147 L’edizione del solo Nuovo Testamento, precedente di un decennio, porta «cominciò a dire chiaramente».
55
Seconda ai Corinzi 3, 12: «E poiché abbiamo questa speranza, possiamo parlare con molta [prima
ed.: grande] franchezza» (letteralmente: «usiamo molta parrhesía»);
7, 4: vedi sopra.
Agli Efesini 3, 12: «Uniti a Cristo, avendo fede in lui, noi possiamo presentarci a Dio con libertà e
piena fiducia», letteralmente: «in lui abbiamo parrhesía e accesso nella confidenza mediante la
fede»;
6, 19-20: «Pregate perché Dio mi faccia trovare parole decise con cui far conoscere la verità del
suo messaggio [letteralmente: «perché quando apro bocca mi sia dato un logos tale da far
conoscere con parrhesía il mistero del vangelo]. [...] Pregate perché io possa parlare
coraggiosamente [parrhesiázesthai], come è mio dovere».
Ai Filippesi 1, 20: «e spero di non vergognarmi, ma di saper parlare con piena franchezza. Anzi
ho piena fiducia che, ora come sempre, Cristo agirà con potenza servendosi di me», letteralmente:
«ma in tutta parrhesía ora come sempre Cristo sia glorificato nel mio corpo».
Ai Colossesi: vedi sopra.
Prima ai Tessalonicesi 2, 2: «Dio mi ha dato la forza», letteralmente: «abbiamo avuto parrhesía
[parrhesiázesthai] nel nostro Dio».
Prima a Timoteo 3, 13: «saranno onorati da tutti e potranno parlare con sicurezza della fede»,
letteralmente: «otterranno un buon grado e molta parrhesía».
A Filemone 8: «Con la forza che mi viene da Cristo», letteralmente: «avendo molta parrhesía in
Cristo».
4.2. Ancora gli Atti Diverso e assai più interessante è a tal proposito il quadro che emerge dagli Atti degli Apostoli, a cui finalmente torniamo, dove la parrhesía non solo è chiaramente ed esclusivamente rivolta verso gli uomini, ma specificatamente ai non credenti e in particolare agli ebrei. Come è stato notato, negli Atti «non è tanto l’opposizione a provocare la “libertà di parola” da parte degli apostoli, ma è la loro parrhesía a provocare opposizione e pericolo»148. In questo senso le occorrenze del verbo, ben sette, sono tutte esplicitamente legate a situazioni di annuncio del messaggio, ossia di predicazione orale in senso stretto.
9, 27-28: «Saulo aveva predicato senza paura [...] e parlava apertamente»;
13, 46: «Ma Paolo e Bàrnaba rispondevano loro con coraggio»;
14, 3: «e con coraggio annunziavano la parola di Dio»;
18, 26: «Con grande coraggio Apollo cominciò a predicare nella sinagoga»;
19, 8: «[Paolo] discuteva con franchezza del regno di Dio»;
148 W. C. van Unnik, The christian’s freedom of speech, cit., p. 480.
56
26, 26: «Il re conosce bene queste cose e a lui posso parlare con franchezza», letteralmente: «parlo
usando parrhesía».
E alla predicazione per così dire istituzionale dell’evangelo sono connesse altresì, sempre negli Atti, le cinque occorrenze del sostantivo, quattro delle quali (esclusa pro-prio quella da cui siamo partiti) in funzione avverbiale con metà parrhesías. Consideriamole una per una. L’espressione metà parrhesías appare per la prima volta in bocca a Pietro nel grande discorso tenuto alla folla il giorno della Pentecoste: «Fratelli, devo parlarvi molto chiaramente riguardo al nostro patriarca Davide» (2, 29). Le tre occorrenze successive sono concentrate nel capitolo quarto, inquadrate tutte negli sviluppi dell’arresto comminato a Pietro e Giovanni, come si ricorderà, a causa della loro predicazione. Dopo l’interrogatorio, dove appare la parrhesía che suscita lo stupore del sinedrio (4, 13), i due vengono rilasciati con l’intimazione di smettere l’attività di proselitismo e si ricongiungono ai compagni a cui riferiscono l’accaduto; quindi tutti insieme formulano una preghiera che termina così: «Ma ora, o Signore, guarda come ci minacciano e concedi a noi, tuoi servi, di poter annunziare la tua parola con grande coraggio» (4, 29). Subito dopo l’autore chiude l’episodio riferendo che «lo Spirito Santo venne su ciascuno di loro, e cominciarono ad annunziare la parola di Dio senza paura» (4, 31). La quinta occorrenza sta significativamente nell’ultima frase del libro e ne rappresenta il senso finale e il sigillo: «Egli [Paolo] annunziava il regno di Dio e insegnava tutto quello che riguarda il Signore Gesù con coraggio e senza essere ostacolato [metà pases parrhesías akoluthos]» (28, 31).
4.3. Ma cos’è che meravigliava i sinedriti? Come sottolineano tutti i commentatori, parrhesía si rivela insomma una parola chiave negli Atti degli apostoli149. Se così è, a far da serratura è proprio il versetto 13 del capitolo 4 da cui siamo partiti, dove si trova — lo ricordiamo — l’unica occorrenza lessicalmente autonoma e non frasale del sostantivo, cioè quella in cui esso mantiene il proprio valore semantico pieno. Ma, fra i vari e diversi finora visti, qual è nel nostro caso questo valore semantico? Per rispondere attendibilmente alla domanda occorre tornare alla lettera del testo. Rifacendoci alla citazione riportata nel paragrafo 1, troviamo che i membri del sinedrio
149 Lo è nel racconto, come si è visto, ma lo è anche in un senso metatestuale con riferimento all’autore e alla sua opera: «amico della verità e della parrhesía» e inoltre «libero e pieno di parrhesía» dev’essere infatti lo storico secondo Luciano nel De arte conscribendæ historiæ, come osserva W. C. van Unnik, Luke’s second book and the rules of hellenistic historiography, in J. Kremer (a cura di), Les Actes des Apôtres. Tradictions, rédaction, théologie, Duculot & Leuven University Press, Lovanio 1979, pp. 37-60, a p. 50-51.
57
rimasero stupefatti per l’accostamento di due motivi: A) per qualcosa che si verificava davanti a loro (vedendo); B) per qualcosa su cui riflettevano collegandola alla prima (considerando). Quel che vedevano era la parrhesía di Pietro e Giovanni; quel che riconsideravano era quanto sapevano di loro, cioè che erano «senza istruzione e popolani». Ora, data la struttura informativa della frase (si stupirono vedendo A e considerando B), dev’esserci qualcosa di stridente tra la prima cosa e la seconda perché è proprio il collegamento dell’una all’altra a destare meraviglia. Ma, come abbiamo già rilevato nel paragrafo 2, cosa mai ci sarebbe di strano nel fatto che uomini «senza istruzione e popolani» mostrino franchezza o coraggio o fiducia o sicurezza o apertura o confidenza o qualunque altra delle qualità indicate nelle traduzioni del passo nelle varie lingue, già passate in rassegna? Dal vicolo cieco si esce a due condizioni: a) che la parrhesía degli apostoli qui non sia una disposizione d’animo bensì un fatto, una azione, una modalità di comportamento; b) che il loro status di non istruiti e popolani contrasti di norma con tale comportamento. La prima condizione esclude l’assurdo di qualità morali generali a cui certe classi sociali non avrebbero accesso, la seconda spiega la meraviglia. Le due condizioni sono necessariamente congiunte, perciò bisogna chiarire cosa significa «senza istruzione e popolani». La seconda parte della frase in greco suona: «kai katalabómenoi hoti ánthropoi agrámmatoi eisin kai idiótai», e la traduzione in questo caso non pone problemi. Carlo Maria Martini annota: «È gente che non ha studiato la legge come i rabbini. Anche per questo non possono essere puniti se prima non vi è stata un’ammonizione formale [v. sopra in 4.2]. Non si vuol dire che gli apostoli non sapessero né leggere né scrivere». Più analiticamente Gerhard Schneider spiega che agrámmatos «vuol dire per lo meno “incolto”, ma non necessariamente (come nel suo senso fondamentale) “analfabeta”», e idiótes «è il “profano” in un determinato settore», aggiungendo che in questo caso l’attributo «si riferisce in particolare all’oratore che non ha avuto un’adeguata formazione scolastica». Abbiamo finalmente la spiegazione. Il dato fondamentale è che Pietro e Giovanni (il solo Pietro, per la verità) hanno appena finito di parlare: questo è il fatto, l’azione, il comportamento che i membri del sinedrio ‘vedono’, a cui assistono; e la particolare modalità di tale atto o comportamento verbale — la parrhesía di un discorso che doveva essere di timorosa e impacciata difesa e invece si è realizzato come articolata e fiera proclamazione ideale in ambiente ostile — contrasta in effetti con la condizione di agrámmatoi e idiótai dei locutori. Come si ricorderà, nessuna delle traduzioni esaminate nel primo paragrafo lasciava trasparire che nel versetto in questione la parrhesía designa precisamente un comporta-
58
mento verbale dalle particolari modalità. Solo la Tilc mette bene in evidenza questo che è il dato fondamentale, sdoppiando il significato del vocabolo greco nelle sue componenti semantiche relative al “parlare” e alla “fierezza-libertà”, sia pur ripiegando per quest’ultima sulla solita franchezza:
I membri del tribunale ebraico erano davvero stupiti dalla franchezza con la quale Pietro e Gio-
vanni parlavano, tanto più che si trattava di persone molto semplici e senza cultura150.
Siamo tornati al punto di partenza, ma adesso abbiamo la risposta alla nostra domanda. Quel che meravigliava i sinedriti era proprio l’antica civilissima preziosa par-rhesía che quegli ignoranti degli apostoli osavano arrogarsi, restituita qui per una volta al suo pieno significato originario di “libertà di parola”. 5. Conclusione duplice
Dalla risposta alla nostra domanda iniziale ci pare di poter trarre due conclusioni. Una, sotto forma di ipotesi e anzi di dubbio, è di ordine linguistico e comporterebbe di rifare tutto il cammino all’indietro, fatti più accorti proprio dalla misconosciuta e carnale “libertà di parola” di Pietro e Giovanni, resa quasi irriconoscibile in veste di nobile disposizione d’animo. Si può formulare così: e se la parrhesía in realtà fosse rimasta sempre “libertà di parola”? Se, cioè, nei testi considerati, quella che per noi oggi è tante cose diverse non avesse mai smesso di essere libertà e capacità di parlare e di dire? Ci è di conforto, nel dubbio, il parere di un esperto autorevole quale Giuseppe Scarpat: «Il termine greco parrhesía acquistò sfumature diverse e si caricò di nuovi valori senza perdere mai il valore etimologico di “libertà di dire, facoltà di dire”»151. L’altra conclusione, connessa alla prima e di carattere culturale generale, constata il deperimento e la sparizione dell’aspetto civile, pubblico della parrhesía — proprio nel senso di “libertà di parola” — nella grecità, e il suo riemergere in primo piano come tratto costitutivo dell’essere cristiani. Nel Nuovo Testamento i cristiani appaiono essere gente che parla liberamente agli uomini e perfino a Dio. Anche questa conclusione ha il sostegno di un grande studioso al di sopra di ogni sospetto, Arnaldo Momigliano: «Abbiamo fatto una lunga strada dalla parrhesía politica di cui gli ateniesi erano orgo-gliosi, ma la nuova parrhesía del martire e santo cristiano porta un contributo alla nozione della libertà di coscienza».152 Sarebbe questo allora un altro dei tratti culturali
150 La prima edizione al posto di senza cultura portava ordinarie. 151 G. Scarpat, Op. cit., p. 143, corsivo mio. 152 A. Momigliano, La libertà di parola, cit., p. 434, mio il corsivo.
59
della modernità attraverso cui si può mostrare «quanto facilmente una certa lettura ontologica dell’uomo come intenzionalità e progetto, ossia come libertà, si adatti alle pagine bibliche e possa (o debba) dunque riconoscere in esse la propria fonte».153
153 Marisa Ercoleo, La libertà dei filosofi e la mela di Adamo. Origine biblica dell’antropologia filosofica contemporanea, Novecento, Palermo 1993, p. 10.