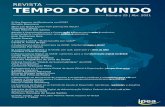CONDELLO La Bibbia al tempo
Transcript of CONDELLO La Bibbia al tempo
Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e ArchivisticaCITTÀ DEL VATICANO 2005
FORME E MODELLI DELLA TRADIZIONEMANOSCRITTA DELLA BIBBIA
a cura di PAOLO CHERUBINI
prefazione di CARLO MARIA CARD. MARTINI
introduzione di ALESSANDRO PRATESI
LITTERA ANTIQUA
13
Tutti i diritti riservati© 2005 by Scuola Vaticana di Paleografia,
Diplomatica e ArchivisticaISBN - 88-85054-15-3
INDICE GENERALE
Prefazione di CARLO M. CARD. MARTINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. VII
Introduzione di ALESSANDRO PRATESI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » XIII
EDOARDO CRISCI, I più antichi manoscritti greci della Bibbia. Fattori materiali,bibliologici, grafici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1
PAOLO RADICIOTTI, Le Sacre Scritture nel mondo tardoantico grecolatino . . . . . » 33
MICHELLE P. BROWN, Predicando con la penna: il contributo insulare alla tra-smissione dei testi sacri dal VI al IX secolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 61
PAOLO CHERUBINI, Le Bibbie spagnole in visigotica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 109
MASSIMILIANO BASSETTI, Le Bibbie imperiali d’età carolingia ed ottoniana . . . . » 175
JEAN VEZIN, I libri dei Salmi e dei Vangeli durante l’alto Medioevo . . . . . . . . » 267
VIRGINIA BROWN, I libri della Bibbia nell’Italia meridionale longobarda . . . . . » 281
FRANCESCO D’AIUTO, Il libro dei Vangeli fra Bisanzio e l’Oriente: riflessioni perl’età mediobizantina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 309
EMMA CONDELLO, La Bibbia al tempo della riforma gregoriana: le Bibbie atlantiche » 347
MATTHIAS M. TISCHLER, Dal Bec a San Vittore: l’aspetto delle Bibbie ‘neomona-stiche’ e ‘vittorine’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 373
SABINA MAGRINI, La Bibbia all’Università (secoli XII-XIV): la ‘Bible de Paris’e la sua influenza sulla produzione scritturale coeva . . . . . . . . . . . . . . . . . » 407
GUY LOBRICHON, Le Bibbie ad immagini, secoli XII-XV . . . . . . . . . . . . . . . . . » 423
ANTONIO MANFREDI, Manoscritti biblici nelle biblioteche umanistiche tra Firenzee Roma. Una prima ricognizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 459
Tavole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 503
Indici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 505
I. Tavole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 507II. Fonti manoscritte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 509III. Nomi di persona e di luogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 543
EMMA CONDELLO
LA BIBBIA AL TEMPO DELLA RIFORMA GREGORIANA:LE BIBBIE ATLANTICHE
a Paola Supino Martini
Dalla metà dell’XI secolo alla metà circa del XII si sono disegnate econsumate le parabole del moto di riforma interna della Chiesa e della suaimperiosa riproposizione come soggetto politico: un tornante storico, du-rante il quale il codice biblico è stato un potente strumento di propagandae diffusione di istanze spirituali e, in subordine, di messaggi ideologici,veicolati attraverso una presentazione del testo e del libro biblico rinnovata,offerta dalle Bibbie atlantiche.
La nuova tipologia testuale e libraria è nata per corrispondere ad esi-genze religiose profondamente sentite da parte del clero e dei fedeli efatte proprie dai pontificati pregregoriani, da Leone IX in poi, e a pro-grammi di ampio respiro presto anche politico. Essa risulta, almeno fino aiprimi del XII secolo, da una pianificazione volitiva come mai prima si eradato nella storia del libro occidentale, e si pone programmaticamente comemodello da riprodurre, in una logica di diffusione capillare di una nuovaidea del libro biblico che infatti fu ripresa e variamente imitata in largaparte d’Europa, sia per la forza di una suggestione proveniente dal centrodella Cristianità sia per il suo valore di simbolo e al tempo stesso strumen-to di una spiritualità riformata.
Una riflessione complessiva sulle Bibbie atlantiche gode di una situazio-ne di privilegio critico, potendo contare su una serie d’imprescindibili con-tributi elaborati da circa un secolo ad oggi, con incremento e risultati fon-dativi soprattutto negli ultimi decenni. Il lavoro complementare di più di-scipline ha chiarito genesi e linee di sviluppo del fenomeno e illustratoanaliticamente molti dei singoli testimoni (un censimento di chi scrive neha finora contati 96), arrivando a configurare una valutazione critica ormaisalda, radicata nelle indagini testuali di Samuel Berger e Henri Quentin 1,
1 S. BERGER, Histoire de la Vulgate pendant les premiers siècles du Moyen Âge, Nancy, Berger-Levrault, 1893 (rist. New York 1958), pp. 140-143; H. QUENTIN, Mémoire sur l’établissement dutexte de la Vulgate, Rome-Paris, Desclée, 1922, pp. 362-384.
348 EMMA CONDELLO
nelle intuizioni di Pietro Toesca 2, nelle esegesi, determinanti per tanti aspet-ti, condotte sull’apparato decorativo da Edward Garrison, Knut Berg, LarryAyres 3, nelle indagini paleografiche e codicologiche di Paola Supino Marti-ni, risolutive per l’inquadramento delle origini e delle motivazioni stori-che 4. Grazie a questi lavori, altre prospettive di studio si aprono intornoalle Bibbie atlantiche, e un riesame dello status quaestionis vale anche a ri-proporre possibilità, a indicare percorsi ulteriori di ricerca: sugli aspettipaleografici, per i quali si evidenzia una situazione meno stabilizzata diquanto ci si aspetti, almeno per l’XI secolo; sui rapporti con una produzio-ne non biblica coeva sempre più spesso oggetto di singole segnalazioni emeritevole di essere affrontata nel suo complesso; sui contesti di produzio-ne, che accennano a cambiare con il mutare degli scopi e della funzione diqueste Bibbie, sicché se l’individuazione dello scriptorium della ‘Tours roma-nica’ 5 ove le prime di esse hanno avuto origine non può procedere forseoltre quanto già è stato fatto, i manufatti del XII secolo meritano inveceprobabilmente un supplemento d’indagine sugli ambiti d’origine.
Il fenomeno delle Bibbie atlantiche compare subito dopo la metà dell’XIsecolo per estendersi sino alla fine del XII, avendo come epicentro di irra-diazione l’Italia e in primo luogo Roma; rapida è la circolazione a Norddelle Alpi ove le Bibbie giganti italiane veicolano modelli di decorazioneaccolti più largamente in area germanica, meno in Francia, ma sostanzial-mente ovunque 6. La migrazione della grandi Bibbie italiane ha indotto una
2 P. TOESCA, Miniature romane dei secoli XI e XII, in «Rivista del Reale Istituto d’archeolo-gia e storia dell’arte», I (1929), pp. 69-96.
3 E.B. GARRISON, Studies in the history of mediaeval italian painting, Firenze, L’Impronta,1953-62; K. BERG, Notes on the dates of some early Giant Bibles, in «Acta ad archaeologiam etartium historiam pertinentia», II (1965), pp. 167-176; IDEM, Studies in Tuscan XIIth centuryillumination, Oslo-Bergen-Tromsö, Grieg, 1968 (Scandinavian University Books), pp. 17-23, pas-sim; L.M. AYRES, Le Bibbie atlantiche. Dalla Riforma alla diffusione in Europa, in Le Bibbie atlanti-che. Il libro delle Scritture tra monumentalità e rappresentazione (Montecassino-Firenze, 11 luglio2000-gennaio 2001). Catalogo a cura di M. MANIACI e G. OROFINO, Roma, Centro Tibaldi,2000, pp. 27-38 (d’ora in poi, Le Bibbie). V. inoltre infra, part. nota 6.
4 P. SUPINO MARTINI, Roma e l’area grafica romanesca, Alessandria, Ed. dell’Orso, 1987 (Bi-blioteca di Scrittura e civiltà, 1), pp. 25-33, 108-117, passim; EAD., La scrittura delle Scritture(sec. XI-XII), in «Scrittura e civiltà», XII (1988), pp. 101-118 (già, ridotto, in Actas del VIIIColoquio del Comité Internacional de Paleografía Latina [Madrid-Toledo, 29 setiembre-1 octubre1987], Madrid, Joyas Bibliográficas, 1990, pp. 225-227).
5 L.M. AYRES, The Italian Giant Bible: aspects of their Touronian ancestry and early history, inThe early medieval Bible. Its production, decoration and use, edit. by R. GAMESON, Cambridge,University Press, 1994, pp. 125-154: 127.
6 Per l’emulazione e la diversa ricezione dei modelli italiani oltralpe tra XI e XII secoloe per la produzione extra-italiana di Bibbie atlantiche, G. SWARZENSKI, Die Salzburger Malerei vonden ersten Anfängen bis zur Blütezeit des romanischen Stils. Studien zur Geschichte der DeutschenMalerei und Handschriftenkunde des Mittelalters, 2a ediz., Stuttgart, Hiersemann, 1969, pp. 64-65,
349LA BIBBIA AL TEMPO DELLA RIFORMA GREGORIANA
significativa produzione imitativa, attestata precocemente per la Francia (laBibbia normanna di Carilef, Durham, Cathedral Library, A II 4, è databilealla fine degli anni ’80 dell’XI secolo) 7 e per l’area mosana (Tournai, Bi-bliothèque du Séminaire, 1, Bibbia di Lobbes, anno 1084) 8 ma anche, nelcorso del XII secolo, per la Spagna (Madrid, Museo Arquéologico Nacio-nal, 485, Bibbia di Huesca; Léon, Archivo Catedralicio, 3; Lérida, BibliotecaCapitular, 1) 9 e più intensamente per l’Inghilterra (Cambridge, CorpusChristi College, 2, Bibbia di Bury St. Edmund, e 3-4, Bibbia di Dover; Lon-don, Lambeth Palace, L. 3 + Maidstone, All Saints Church, P 5; Oxford,Bodleian Library, Auct. E inf. 1-2, e Winchester, Cathedral Library, s. n.,ambedue da Winchester) 10.
La caratteristica di evidenza immediata per le Bibbie atlantiche è il for-mato anomalo: l’altezza infatti oscilla tra i 500 e i 600 mm, con derogherare quanto al valore minimo e meno rare per quello massimo, e la lar-ghezza tra i 300 e i 400 mm 11. Simili dimensioni, che non sembrano avereparalleli nei codici biblici bizantini coevi 12, non sono assoluta novità nella
passim; cfr. L.M. AYRES, A fragment of a Romanesque Bible in Vienna (Österr. Nationalbibl., Cod. ser.nov. 4236) and its Salzburg affiliations, in «Zeitschrift für Kunstgeschichte», XLV (1982), pp. 130-144; ID., The Bible of Henry IV and an Italian Romanesque pandect in Florence, in Studien zurmittelalterlichen Kunst, 800-1250. Festschrift für Florentine Mütherich zum 70. Geburtstag, hrsg. vonK. BIERBRAUER, P.K. KLEIN, W. SAUERLANDER, München, Prestel, 1985, pp. 157-164; ID., An It-alian Romanesque manuscript of Hrabanus Maurus ‘de laudibus S. Crucis’ and the Gregorian Reform,in «Dumbarton Oaks Papers», XLI (1987), pp. 13-27; ID., An Italianate episode in RomanesqueBible illumination at Weingarten Abbey, in «Gesta», XXIV (1985), pp. 121-128; ID., GregorianReform and artistic renewal in manuscrit illumination: the ‘Bibbia atlantica’ as an international artisticdenomination, in La Riforma gregoriana e l’Europa. Congresso internazionale (Salerno, 20-25maggio 1985), II. Comunicazioni, Roma, LAS, 1992, pp. 145-152 [= «Studi gregoriani», XIV(1991)]; SUPINO MARTINI, La scrittura cit., pp. 110-112, 114, con bibliografia; EAD., Origine ediffusione della Bibbia atlantica, in Le Bibbie cit., pp. 39-44: 42.
7 Durham Cathedral Manuscripts to the end of the twelfth century, with an introd. by R.A.B.MYNORS, Oxford, University Press, 1939, n. 30 pp. 16-18.
8 Manuscrits datés conservés en Belgique. Notices établies sous la direction de F. MASAI-M.WITTEK, I, Bruxelles-Gand, Story-Scientia, 1968, n. 2 pp. 17-18; W. CAHN, La Bible romane.Chefs-d’oeuvre de l’enluminure, Fribourg, Office du livre, 1982, n. 48 p. 266.
9 T. AYUSO MARAZUELA, La Vetus Latina Hispana, I. Prolegómenos, introducción general, estu-dio y análisis de las fuentes, Madrid, Aldecoa, 1953, nn. 84, 89, 95 pp. 368, 370; ID., La Bibliade Calahorra. Un importante códice desconocido, in «Estudios bíblicos», I (1942), pp. 241-271.
10 C.M. KAUFFMANN, Romanesque manuscripts 1066-1190, London, Harvey Miller, 1975,n. 56 pp. 88-90, n. 69 pp. 97-98, n. 70 pp. 99-100, n. 82 p. 107, n. 83 p. 108; N.R. KER,English manuscripts in the century after the Norman conquest, Oxford, Clarendon Press, 1960, pp.35, 50-52; O. PÄCHT - J. J.G. ALEXANDER, Illuminated manuscripts in the Bodleian Library Oxford,III, Oxford, Clarendon Press, 1973, n. 128 p. 15.
11 Per una serie di dati codicologici quantitativi, M. MANIACI, La struttura delle Bibbie atlan-tiche, in Le Bibbie cit., pp. 47-60.
12 Il manoscritto biblico bizantino nei secoli XI e XII, pur praticando dimensioni piùsviluppate nel caso del codice veterotestamentario, presenta taglie nettamente inferiori a quelle
350 EMMA CONDELLO
storia del libro latino, ed è possibile individuare una indubbia linea dicontinuità formale tra il prototipo illustre della Bibbia integrale di misureeccezionali, il codex grandior littera clariore conscriptus che Cassiodoro menzio-na per la biblioteca di Vivarium 13, e le grandi Bibbie della seconda metàdell’XI secolo e del XII. Il codex grandior è certamente il riferimento obbli-gato e più volte richiamato per la Bibbia Amiatina e per i suoi perduticodici gemelli 14 e per le meno vaste ma comunque imponenti Bibbie turo-nensi 15, ma è stato anche il modello simbolico ineluttabile, sebbene sottin-teso e talvolta meno incombente (ma non nei casi più antichi), per unaserie di testimoni biblici di formato stragrande le cui tracce emergono dalpanorama librario gravemente lacunoso del tardoantico e poi nell’alto me-dioevo 16. Di tale linea di trasmissione partecipano i frammenti dei MaccabeiDurham, Cathedral Library B IV 6, in onciale italiana del VI secolo; laBibbia in semionciale del VII secolo, forse spagnola, prima scriptio inferiornel codice di León, Archivo Catedralicio 15; i frustuli da una Bibbia italia-na gigante del VII secolo rinvenuti a Roma, Biblioteca Vallicelliana tomoXa; la Bibbia insulare della quale rimangono i Vangeli di Londra, BritishLibrary, Royal 1. E. VI, e la Bibbia di Metz, Bibliothèque Municipale 7,ambedue della fine dell’VIII secolo 17. La continuità è mantenuta poi attra-
delle coeve Bibbie atlantiche latine: è quanto si deduce da M. MANIACI, Costruzione e gestionedella pagina nel manoscritto bizantino, Cassino, Edizioni Università, 2002, pp. 94-123; a confer-ma, F. BISCHOFF - M. MANIACI, Pergamentgrösse, Handschriftenformate, Lagenkonstruktion. Anmerkun-gen zur Methodik und zu den Ergebnissen der jüngeren kodikologischen Forschung, in «Scrittura eciviltà», XIX (1995), pp. 277-319, contemplano un solo caso, ormai del XIV secolo, di forma-to atlantico nel corpus di manoscritti bizantini indagati (Anhang B, p. 316: Città del Vaticano,Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. gr. 1153+1154, Prophetae, cum Cat.).
13 Inst., I. 14, 2.14 E.A. LOWE, English Uncial, Oxford, Clarendon Press, 1960, pp. 8-13; D. WRIGHT, Some
notes on English Uncial, in «Traditio», XVII (1961), pp. 441-456; J.T. BROWN, The Italo-North-umbrian Gospel text and Cassiodorus, in Evangeliorum quattuor Codex Lindisfarnensis, edit. by T.KENDRICK, T.J. BROWN et al., II, Olten-Lausanne, Urs Graf, 1960, pp. 47-58: 51-58; R.L.S.BRUCE-MITFORD, Decoration and miniature, ibid., pp. 109-261: 142-145. V. ora anche il saggio diM.P. Brown in questo stesso volume.
15 B. FISCHER, Die Alkuin-Bibeln, in Die Bibel von Moutier Grandval, British Museum Add. ms10546, Bern, Verein Schweiz. Litographierbesitzer, 1971, pp. 49-98, rist. in IDEM, LateinischeBibelhandschriften im frühen Mittelalter, Freiburg, Herder, 1985, pp. 203-403: 257-259; C. NOR-DENFALK, Beiträge zur Geschichte der turonischen Buchmalerei, in «Acta archaelogica», VII (1936),pp. 281-307; H.L. KESSLER, The illustrated Bibles from Tours, Princeton, University Press, 1977.Sul formato in particolare, e su molti altri aspetti delle Bibbie turonensi, R. MCKITTERICK,Carolingian Bible production: the Tours anomaly, in The early medieval Bible cit., pp. 63-77, e D.GANZ, Mass production: Carolingian Bibles from Tours, ibid., pp. 53-62: 55.
16 P. SUPINO MARTINI, Origine, in Le Bibbie cit., pp. 39-43: 39-40.17 E.A. LOWE, Codices Latini Antiquiores. A Palaeographical Guide to Latin Manuscripts Prior to
the Ninth Century, 11 voll. e suppl., Oxford, Oxford University Press, 1934-1972 (d’ora inavanti: C. L. A.) II, 153; XI, 1636; IV, 435; II, 214; VI, 786.
351LA BIBBIA AL TEMPO DELLA RIFORMA GREGORIANA
verso le Bibbie turonensi e il filone imitativo che ne è derivato, fino alleBibbie di Roma, Biblioteca Nazionale, Sessoriano 9 e a quella di Saint-Vaastoggi Arras, Bibliothèque Municipale, 559, inizi o prima metà dell’XI 18: que-st’ultima si configura non come il più antico ancorché poco inquadrabileesempio di Bibbia atlantica 19 ma, anche per modalità di impaginazione,grafiche e decorative, piuttosto come epigono di quel modello turonianodal quale le stesse Bibbie atlantiche hanno tratto libera ispirazione formale.Esito dell’influenza del medesimo prestigioso modello, e ulteriori anelli diuna catena che corre dal codex grandior alla Bibbia atlantica, vanno conside-rati anche i grandi codici biblici iberici in carolina della prima metà del-l’XI secolo oggi Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat.5729, Bibbia di Ripoll, e Paris, Bibliothèque Nationale de France, Lat. 6,Bibbia di Sant Pere de Rodes 20; mentre al tardo filone imitativo del model-lo atlantico piuttosto che a quello anticipatorio vanno ascritte le Bibbie diReims, Bibliothèque Municipale, 16-18, 20-23, la cui più recente datazionealla prima metà del XII secolo, avanzata sulla base della decorazione, è deltutto congrua paleograficamente 21.
18 Bibliografia dei manoscritti Sessoriani, a cura di V. JEMOLO, L. MEROLLA, M. PALMA, F.TRASSELLI, Roma, Storia e letteratura, 1987, pp. 34-35; BERG, Studies cit., p. 60 e n. 143;Catalogue general des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Départements, IV. Arras, Avran-ches, Boulogne, Paris, Impr. Nationale, 1872, pp. 169-170, n. 435 (cfr. p. I); CAHN, La Bibleromane cit., pp. 107-114.
19 L. LIGHT, Version et révision du texte biblique, in Le Moyen Age et la Bible, sous la direc-tion de P. RICHÉ et G. LOBRICHON, Paris, Beauchesne, 1984, pp. 55-93: 69-70. Ancora D.J.REILLY, French Romanesque Giant Bible and their English relatives: blood relatives or adopted children?,in «Scriptorium», LVI (2002), pp. 294-311: 299, include la Bibbia di Saint-Vaast nella catego-ria delle atlantiche, che tuttavia nell’ottica dell’autrice viene a dilatarsi in quanto definitasecondo i criteri estrinseci del formato e della presenza di decorazione, e non in base aconsiderazione puntuale della storia del fenomeno e di criteri storico-artistici cogenti, graficio testuali.
20 AYUSO MARAZUELA, La Vetus Latina cit., nn. 73, 74 p. 366; v. inoltre E. CONDELLO, Vat.lat. 5729, in I Vangeli dei popoli. La Parola e l’immagine del Cristo nelle culture e nella storia (Cittàdel Vaticano, 21 giugno-10 dicembre 2000), Catalogo della mostra, Città del Vaticano – Palaz-zo della Cancelleria, 21 giugno – 10 dicembre 2000, a cura di F. D’AIUTO, G. MORELLO, A.M.PIAZZONI, Città del Vaticano-Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana-Edizioni Rinnovamento nelloSpirito Santo, 2000, n. 43 pp. 219-222, e Manuscrits enluminés de la Péninsule Iberique, par F.AVRIL, J.-P. ANIEL, M. MENTRÉ, A. SAULNIER, Y. ZAkUSKA, Paris, Bibliothèque Nationale, 1982,n. 36 pp. 31-43; nonché, da ultimo, A.M. MUNDÒ, Les Bíblies de Ripoll. Estudi dels mss. Vaticá,Lat. 5729 i París, BNF, Lat. 6, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2002 (Studi etesti, 408).
21 L’ipotesi anticipatoria è in LIGHT, Version cit., p. 70, e prima in P. BRIEGER, Bible illus-tration and Gregorian reform, in Papers read at the II winter and summer meetings of the EcclesiasticalHistory Society, ed. by G.J. CUMING, London, Nelson, 1965 (Studies in Church History, 2), pp.154-164: 162; cfr. W. CAHN, Romanesque manuscripts. The Twelfth century, II, London, HarveyMiller, 1996, n. 67 pp. 84-85, 23, n. 69 pp. 86-87.
352 EMMA CONDELLO
Altri caratteri estrinseci, al di là del formato, definiscono i connotatidelle Bibbie atlantiche. La fascicolazione è in quaternioni; ricorrono di re-gola le tavole dei Canoni prima del Nuovo Testamento; non è previsto unapparato organico di commento. Quanto all’impaginazione, il testo è orga-nizzato su due colonne, per agevolare la leggibilità di carte troppo largheper la scrittura su linea lunga; raramente, per testi specifici quali i Salmi,può comparire una disposizione su tre colonne 22, secondo un modello mi-noritario attestato da codici della recensio teodulfiana e da testimoni ibericiad essa connessi 23. Viene rispettata sempre una gerarchia di scritture distin-tive e, per il testo, si adotta sempre la minuscola carolina. Parti specifichequali prologhi, prefazioni, capitula sono vergati in scrittura di modulo ridot-to, secondo il prototipo dei testimoni delle recensioni carolinge 24: spessosono in modulo ridotto anche i Salmi, in assoluto la sezione più autonomaper impaginazione, modulo, fascicolazione e recensione (al punto di segui-re eccentricamente, fino alla fine dell’XI secolo, il testo gallicano comenelle Bibbie alcuiniane anziché quello romano più normale nel contesto diorigine delle Bibbie giganti italiane) 25, e i Vangeli. Le Bibbie atlantiche mani-festano una vocazione prevalente, ma non monolitica, al volume unico. Laconsistenza di libri di formato stragrande, con una media di circa 400carte e punte di oltre 500, e l’assemblaggio per blocchi di libri che è datointuire sulla base di singoli fascicoli eccentrici e di carte bianche in posizio-ni non casuali, ripetute in più codici, – quanto è stato anche chiamato«strutturazione ‘modulare’ » 26, indizio dei confini dei molteplici antigrafi e,
22 Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 587, Bibbia di Santa Cecilia, romana e defini-tivamente datata al terzo quarto dell’XI secolo da SUPINO MARTINI, Roma cit., pp. 109-112; cfr.inoltre BERG, Notes cit., pp. 167-171, e AYRES, scheda n. 5 in Le Bibbie citato.
23 Fischer richiama, per questa ed altre caratteristiche fisiche dei primi testimoni teodul-fiani, anche la suggestione delle pandectes minutiore manu di Cassiodoro, Inst. I, 12. 3: v. B.FISCHER, Bibelausgaben des frühen Mittelalters, in La Bibbia nell’alto Medioevo. Spoleto, 26 aprile -2 maggio 1962, Spoleto, CISAM, 1963 (X Settimana di studio del CISAM), pp. 519-600: 594;ID., Bibeltext und Bibelreform unter Karl dem Großen, in Karl der Große. Lebenswerk und Nachleben,hrsg. von W. BRAUNFELS, II. Das geistige Leben, hrsg. von B. BISCHOFF, Düsseldorf, Schwann,1965, pp. 156-216, rist. in Lateinische Bibelhandschriften, pp. 101-202: 138; R. MCKITTERICK,Carolingian, p. 74, sottolinea piuttosto la consonanza con codici scritturali spagnoli su trecolonne, quali la Bibbia di Danila, Cava dei Tirreni, Archivio della Badia della S.ma Trinità,1: per i rapporti di quest’ultima con gli aspetti non solo formali delle Bibbie teodulfiane, P.CHERUBINI, La Bibbia di Danila: un monumento trionfale per Alfonso II di Asturie, in «Scrittura eciviltà», XXIII (1999), pp. 75-131: 79, 118-124, e sui codici biblici d’area iberica a tre colon-ne il saggio dello stesso Cherubini in questo volume.
24 QUENTIN, Mémoire cit., p. 249; FISCHER, Bibelausgaben cit., pp. 558, 593.25 B. FISCHER, Zur Überlieferung altlateinischer Bibeltexte im Mittelalter, in «Nederlands Ar-
chief voor Kerk-geschiedenis», LVI (1975), pp. 19-33, rist. in ID., Lateinische Bibelhandschriften,pp. 404-421: 412-413.
26 MANIACI, La struttura, in Le Bibbie cit., pp. 55-56.
353LA BIBBIA AL TEMPO DELLA RIFORMA GREGORIANA
talora, della ripartizione del lavoro di copia tra diverse mani cooperanti 27 –hanno esposto Bibbie nate come unitarie o come doppio volume allo smem-bramento in più parti (ad esempio, le già ricordate Bibbie di Bury, oggi intre tomi da uno originario, e di Winchester, due tomi originari rilegati poiin tre e infine in quattro; la Bibbia di Venezia, Biblioteca Nazionale Marcia-na, Lat. I, oggi in quattro tomi da due originari) 28, ovvero hanno consiglia-to fin dall’origine una partizione in tre tomi (ad esempio, Biblioteca Apo-stolica Vaticana, Pall. latt. 3-5, anni ’60-70 del secolo XI), in due (Mantova,Biblioteca Comunale, 131, secolo XI seconda metà, Bibbia di Polirone; Bi-blioteca Apostolica Vaticana, Vatt. latt. 4220-4221, secolo XII, primo quarto,Bibbia di San Crisogono; Napoli, Biblioteca Nazionale, ex Vindob. lat. 8,secolo XII in.), in quattro (Pisa, Museo Nazionale San Matteo, depositoprovvisorio, Bibbia di Calci, post 1168) 29.
La decorazione delle Bibbie atlantiche, assolutamente distintiva dal pun-to di vista stilistico, costituisce un dato identificativo della categoria e hapromosso un’attenzione critica alla quale si debbono tanto la terminologiache designa selettivamente le Bibbie di formato stragrande come famigliaspecifica 30, quanto ipotesi precoci di cronologia, origine, affinità tra i testi-
27 V. un esempio nella Bibbia di Perugia, Biblioteca Comunale Augusta, L 59, al fasc. XIII(ff. 93-98), senione anziché quaternione, in chiusura dell’Ottateuco, che costituisce un bloccotestuale spesso individuale nelle Bibbie atlantiche, e in concidenza con il cambio di copista.
28 KAUFMANN, Romanesque cit., nn. 56, 83; J. VALENTINELLI, Bibliotheca manuscripta ad S.Marci Venetiarum, I, Venetiis, ex Typ. Commercii, 1868, pp. 195-196.
29 Catalogo dei manoscritti polironiani, I. Bibl. Comunale di Mantova (mss 1-100), a cura di C.CORRADINI, P. GOLINELLI, G.Z. ZANICHELLI, Bologna, Patron, 1998, pp. 74-79; E. STEVENSON - I.B. DE ROSSI, Codices palatini Bibliothecae Vaticanae, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vati-cana, 1886, p. 1; BERG, Studies cit., n. 4, pp. 224-227; Le Bibbie cit., nn. 4, 34, 16, 51, 55.
30 P. TOESCA, La pittura e la miniatura nella Lombardia, dai più antichi monumenti alla metà delQuattrocento, Milano, Hoepli, 1912, p. 78. È oggi adottata internazionalmente la definizione di‘Italian Giant Bibles’, da Garrison in poi, accanto a quella di Bibbia ‘atlantica’. È invece rima-sta circoscritta ai contributi d’area germanica e ora desueta la traduzione in ‘Riesenbibeln’(SWARZENSKI, Die Salzburger Malerei cit., pp. 64-65; G. LADNER, Die italienische Malerei in 11.Jahrhundert, in «Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlung in Wien», n. F., V (1931), pp. 33-160: 51-61; H. FICHTENAU, Neues zum problem der italienischen Riesenbibeln, in «Mitteilungen desInstituts für Österreichische Geschichtsforschung», LVIII (1950), pp. 50-67, e ID., Riesenbibeln inÖsterreich und Mathilde von Tuszien, in ID., Beiträge zur Mediävistik, I, Stuttgart, Hiersemann,1975, pp. 163-186). Appare suggestiva ma sostanzialmente limitativa, per una tipologia librariagià diffusa e significativa prima del pontificato di Gregorio VII, la denominazione di Bibbia‘gregoriana’ (A. BARTOLI LANGELI, Scritture e libri da Alcuino a Gutenberg, in Storia d’Europa, III. IlMedioevo, a cura di G. ORTALLI, Torino, Einaudi, 1994, p. 954): peraltro, non priva di tradizio-ne, in quanto adottata in inventari di valore storico, quali quello cinquecentesco di Sant’Agosti-no di Canterbury compilato da Thomas di Elmham (M. BUDNY, The Biblia gregoriana, in St.Augustin and the conversion of England, edit. by R. GAMESON, Stroud, Sutton, 1999, pp. 237-284;R. EMMS, St. Augustine’s Abbey, Canterbury, and the ‘First book of the whole English Church’, in TheChurch and the Book, edit. by R.N. SWANSON, Woodbridge-Rochester, Boydell, 2004, pp. 32-45).
354 EMMA CONDELLO
moni. Lo stile delle iniziali definito ‘geometrico’ da Garrison è rappresen-tato solo limitatamente da codici non biblici, tutti coevi o posteriori alnucleo seriore di Bibbie atlantiche con le quali fin da Toesca si è ritenutol’origine dello stile fosse implicata. La cronologia delle Bibbie atlantiche ita-liane, inizialmente definita da Garrison tra gli anni ’80 dell’XI secolo e lostesso decennio del XII, ha visto indietreggiare la sua fase iniziale al terzoquarto dell’XI secolo ad opera di Berg, sulla base di una più puntualedatazione di tre testimoni tra i più antichi (San Daniele del Friuli, Bibliote-ca Comunale Guarnieriana, I/II; München, Bayerische Staatsbibliothek, Lat.13001, Bibbia di Hirsau; Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat. 587, Bib-bia di Santa Cecilia) 31, e di Ayres, che indica la comparsa dello stile neglianni ’60 del secolo 32. Le iniziali geometriche presentano lettere dall’im-pianto monumentale per il quale Carl Nordenfalk ha acutamente ipotizzatouna suggestione della capitale libraria tardoantica 33, e che manifestano pa-rimenti influenza di capitale epigrafica. Ambedue le scritture sono del restopresenti come distintive in questi codici, la cui scrittura d’apparato ‘classi-cheggiante’, con G a ricciolo, R con tratto obliquo ricurvo e prolungato,alternanza di E capitale e onciale, nessi, inclusioni, ha ripercussioni anchenelle realizzazioni epigrafiche della Roma pregregoriana e gregoriana 34. L’or-nato evolve da modelli di ascendenza carolingia 35, privilegiando geometriz-zazione dei motivi decorativi, rigidezza e monumentalità, scarso o nullouso dell’oro in reazione alle lussureggianti iniziali a girari aurei dell’arteottoniana 36. Le iniziali sono definite da filetto giallo e campite internamen-
31 G. MAZZATINTI, Rovigo, S. Daniele del Friuli, etc., Forlì, Bordandini, 1893 (Inventari deimanoscritti delle biblioteche d’Italia, III), p. 109; La Guarnieriana. I tesori di un’antica biblioteca(San Daniele del Friuli, 10 giugno - 30 ottobre 1988), Udine, Arti grafiche friulane, 1988,pp. 88-90; Catalogus codicum latinorum Bibliothecae regiae Monacensis, composuerunt C. HALM, F.KEINZ, G. MEYER, G. THOMAS, II. 2, Monachii, Bibliothecae regiae, 1876, p. 91; S. PIERALISI,Inventarium codicum manuscriptorum Bibliothecae Barberinae, IV, p. 322 (manoscritto, BibliotecaApostolica Vaticana, Sala Barberini 338); Le Bibbie cit., nn. 8, 3, 5.
32 Per la cronologia e la periodizzazione dello stile in ‘early’, ‘transitional’, ‘middle’, ‘late’,e per l’identificazione del gruppo più antico di testimoni, GARRISON, Studies cit., I, pp. 18-31,37-68, 83-114, 159-176; II, pp. 47-68, 97-112, 151-158, 217-227; III, pp. 33-81, 119-169,281-299; IV, pp. 277-307, 367, e BERG, Studies cit., pp. 12-17, 21-57; per la definitiva datazio-ne della Bibbia di Santa Cecilia, SUPINO MARTINI, Roma cit., pp. 109-112; per le molteplicimesse a punto di Ayres si rinvia supra, nota 5.
33 C. NORDENFALK, Italian Romanesque Illumination, in «Burlington Magazine», CXII (1970),pp. 401-403: 401, ove si richiama la capitale del Virgilio Augusteo Vat. lat. 3256 (C. L. A. I, 13).
34 A. PETRUCCI, Divagazioni paleografiche sulla Roma gregoriana, in Studi sulle società e leculture del Medioevo per G. Arnaldi, a cura di L. GATTO e P. SUPINO MARTINI, Firenze, All’Inse-gna del Giglio, 2002, pp. 471-78.
35 GARRISON, Studies cit., I, pp. 43-46; FICHTENAU, Neues cit., p. 58; BERG, Studies cit.,pp. 12, 18.
36 C. NORDENFALK, L’enluminure à l’époque romane, in A. GRABAR - C. NORDENFALK, La peintureromane du XIe au XIIIe siècle, Genève, Skira, 1958, pp. 131-206: 182, ricorda a tale proposito
355LA BIBBIA AL TEMPO DELLA RIFORMA GREGORIANA
te da pannelli di intrecci geometrizzanti e di motivi foliati sempre altamen-te stilizzati, in blu, rosso, rosso scuro, grigio, bruno; in seguito sono riem-pite anche da motivi vegetomorfi di gamma più diversificata, anche florea-li. Accanto ad esse compaiono le iniziali decorate con tralci di bianchigirari, caratteristiche dei testimoni italiani e presenti già nelle Bibbie Palati-na, di San Daniele, di Santa Cecilia unanimemente riconosciute partecipidel gruppo più antico delle atlantiche 37. Con la fine dell’XI secolo e ancorpiù con il XII l’articolazione delle modalità esecutive e dei motivi di cam-pitura delle iniziali diviene più complessa, anche in ragione del propagarsidel modello decorativo in aree diverse da quella d’origine, coinvolte intradizioni ornamentali differenti, e in conseguenza di un’ampia produzionetoscana in stile geometrico articolata in scuole locali (Firenze, Pisa, Arezzo,Pistoia, Lucca, forse Siena) 38. Tale complessità è stata fonte di propostealternative di localizzazione, in Roma e area umbro-romana oppure in To-scana, per un numero non indifferente di testimoni del XII secolo: si cita-no a titolo di esempio le Bibbie di Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana,XXV. 2 e Ashburnham 93, attribuite da Garrison alla Toscana e da Berggenericamente all’Italia 39; il Laur. XV. 19, romano per Garrison e aretinosecondo Berg in definitiva solo per una nota di possesso del monastero diSan Viriano presso Arezzo, sebbene di somiglianza straniante con testimonicoevi romani 40; le oscillazioni di Garrison riguardo ai Laur. XV. 18 (aretinoo toscano meridionale o umbro), Firenze, Biblioteca Nazionale, Fondo Nazio-nale II. I. 510 (umbro-romano o aretino), Roma, Biblioteca Casanatense,720 (italocentrale o toscano o pistoiese), attribuiti da Berg ad Arezzo i
le resistenze teoriche, più che praticamente realizzate, degli ambienti riformati cistercensi ver-so l’ornamentazione policroma e aurea delle iniziali nella seconda metà del XII secolo. Per lascarsità d’uso dell’oro e dell’argento nelle iniziali geometriche v. inoltre AYRES, A fragment cit.,p. 135; ID., The Bible of Henry IV cit., p. 158.
37 A. BOECKLER, Abendländische Miniaturen bis zum Ausgang der Romanischen Zeit, Berlin-Leip-zig, De Gruyter, 1930, pp. 68-69; AYRES, An Italian Romanesque manuscript cit., pp. 14-25, 27;ID., The Italian Giant Bible cit., pp. 149-151.
38 Oltre all’imprescindibile BERG, Studies cit., si rinvia a G. DALLI REGOLI, Miniatura a Pisatra i secoli XII-XIV: elementi di continuità e divergenze, in La miniatura italiana in età romanica egotica. Atti del I Congresso di storia della miniatura (Cortona, 26-28 maggio 1978), a cura diG. VAILATI SCHÖNBURG WALDENBURG, Firenze, Olschki, 1979, pp. 23-50; EAD., La miniatura luc-chese tra la fine dell’XI e gli inizi del XII secolo: forme di decorazione umbro-romana e cultura graficafrancese, in Romanico padano, romanico europeo. Atti del Convegno internazionale di studi (Mo-dena-Parma, 26 ott.-1 nov. 1977), a cura di A.C. QUINTAVALLE, Parma, Silva, 1982, pp. 273-288; M.G. CIARDI DUPRÉ, Le Bibbie atlantiche toscane, in Le Bibbie cit., pp. 73-79.
39 GARRISON, Studies cit., I, 172, 173 e III, 143, 148; BERG, Studies cit., p. 47 nota 80; A.M. BANDINI, Catalogus codicum Latinorum Bibliothecae Mediceae Laurentianae, I, Florentiae, TypisCaesareis, 1774, coll. 745-748; C. PAOLI, I codici Ashburnhamiani della Regia Bibl. Medicea Lau-renziana di Firenze, I, 1, Roma, Libreria dello Stato, 1887, pp. 46-53; Le Bibbie cit., n. 53.
40 GARRISON, Studies cit., III, 290; BERG, Studies cit., n. 19 pp. 235-236; BANDINI, Cataloguscit., coll. 143-147; Le Bibbie cit., n. 49.
356 EMMA CONDELLO
primi due e a Pistoia l’ultimo 41; il Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. lat.588 attribuito a Roma da Garrison, alla Toscana da Berg, ancora a Romada Ayres 42; infine l’ipotesi di Ayres che la «early tuscan school» possa inrealtà essere esito di una produzione romana di scriptorium diverso da quel-lo delle prime Bibbie atlantiche 43. Da tutto ciò si deduce l’incertezza dinuovi criteri distintivi fondati su localizzazioni troppo spesso ancora subiudice e su testimoni spesso distanziati da scarto cronologico significativo:ciò consiglia ad esempio di accogliere con cautela la segnalazione del ricor-rere di iniziali enfatizzate per i singoli libri vetero e neotestamentari nelleBibbie umbro-romane contro un’opposta sobrietà in quelle toscane, che sa-rebbero a loro volta maggiormente propense a valorizzare iniziali di parti-zione minore 44.
Le Bibbie iconiche più antiche presentano decisi influssi di modelli pa-rietali romani e del comprensorio, indicati da Toesca e da Garrison, conparticolare evidenza per gli affreschi oggi perduti di San Paolo fuori leMura, fonte di echi stilistici o di ispirazione diretta per la Bibbia Palatina,per quella di Roma, Biblioteca Angelica, 1272 45 e per notevole parte diquelle oggi ascritte al terzo quarto dell’XI secolo 46. Ma numerosi e strin-genti sono i paralleli di modi stilistici, colorismo, iconografia segnalati tragli affreschi di San Clemente, Castel Sant’Elia, San Silvestro di Tivoli e laBibbia di Santa Cecilia; tra la cripta di Anagni, ancora Castel Sant’Elia eTivoli e le miniature delle Bibbie del Pantheon Vat. lat. 12958 e di Todi Vat.lat. 10405 47; tra Sant’Abbondio presso Rignano Flaminio, San Paolo pressoSpoleto e la Bibbia di San Valentino in Piano presso Amelia, Parma, Biblio-
41 GARRISON, Studies cit., III, 287, 290; I, 102 e IV, 271; I, 172 e III, 35; BERG, Studiescit., nn. 18, 104, 135 pp. 234-235, 287, 303; BANDINI, Catalogus cit., col. 156; G. MAZZATINTI,Firenze, Bibl. Nazionale, Forlì, Bordandini, 1900 (Inventari dei manoscritti delle Biblioteched’Italia, 10), p. 178.
42 GARRISON, Studies cit., III, 284; BERG, Studies cit., n. 147 pp. 312-313; AYRES, ItalianGiant Bibles cit., pp. 128, 133-136. Per il codice Barberiniano, v. anche PIERALISI, Inventariumcit., p. 323.
43 AYRES, Italian Giant Bibles cit., p. 151; ID., Le Bibbie atlantiche cit., p. 34. Quanto allanecessità di circostanziare anche per l’XI secolo e per l’area umbro-romana datazioni e loca-lizzazioni ancora generiche, SUPINO MARTINI, Roma cit., pp. 32-33.
44 MANIACI, Struttura cit., p. 53.45 H. NARDUCCI, Catalogus codicum manuscriptorum praeter Graecos et Orientales in Bibliotheca
Angelica olim Coenobii S. Augustini de Urbe, Roma, L. Cecchini, 1893, p. 537; Le Bibbie cit., n. 33.46 TOESCA, Miniature cit., pp. 74-94; LADNER, Die italienische Malerei cit., pp. 67-68, 72-74,
84-85, passim; GARRISON, Studies cit., II, pp. 171-188; III, pp. 89-104, 195-220; IV, pp. 117-177, 201-210; L.M. AYRES, An early christian legacy in Italian romanesque miniature painting, in«Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte», XLVI-XLVII (1993-1994), pp. 37-44.
47 CAHN, La Bible romane cit., n. 134 pp. 288-289; M. VATTASSO - E. CARUSI, Codices Vatica-ni latini, codd. 10301-10700, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1920, pp. 88-92; Le Bibbie cit., nn. 45, 15.
357LA BIBBIA AL TEMPO DELLA RIFORMA GREGORIANA
teca Palatina, 386 48; tra San Paolo fuori le Mura, San Giovanni in Lateranoe la Bibbia di Genova, Biblioteca Civica Berio, m. r. Cf 3. 7 49; tra Sant’Ur-bano alla Caffarella e la Bibbia di Hirsau; tra San Paolo fuori le Mura, SanGiovanni a Porta Latina, San Pietro in Ferentillo, San Tommaso presso lacripta di Anagni e la ‘impressionante’ (così Garrison) Bibbia di Perugia,Biblioteca Comunale Augusta, L 59, della quale Toesca sottolinea una rice-zione di modelli orientali parallela, e tuttavia autonoma, a quella riscontra-bile nei codici del gruppo Ada, separativa rispetto ai modi predominantidella miniatura iconica carolingia 50.
Infine, qualche osservazione sulle tavole dei Canoni, che le Bibbie atlan-tiche presentano sempre disposte su quattro facciate, secondo il precedenteturonense come ha fatto rilevare Ayres 51. La prassi di impaginazione vienecontraddetta solo in rari casi e tardi: nel XII secolo compare sporadica-mente una disposizione concentrata in due facciate, come nel caso della IIBibbia di Bovino, Vat. lat. 10510, e del codice di Roma, Biblioteca Casana-tense, 723 52. Dai modelli carolingi dipende la decorazione delle arcate confasce riempite di motivi fogliati o di intrecci perlinati, prevalenti per l’XI,e con pannelli alternati a intrecci e volute, più frequenti nel XII; il ricorsoalla cornice architettonica dei Canoni travalica invece tali modelli e si ri-connette alla tradizione illustre dei codici neotestamentari tardoantichi, maispentasi del tutto e attestata tra VII e IX secolo 53: le Bibbie atlantiche laraccolgono tanto dai precedenti turonensi e teodulfiani quanto dalla indub-bia disponibilità a Roma di esempi dal tardoantico in poi, e la reinterpre-tano adottando lo schema semplificato, peraltro non originale, delle arcatesemplici senza archetti sottesi.
Roma dunque è stata identificata, in primo luogo per il convergeredelle indagini sull’apparato decorativo, come il centro di prima elaborazio-ne e diffusione delle Bibbie giganti italiane. Una precedente attribuzioneall’Italia settentrionale e a Milano avanzata da Berger 54 era già stata confu-
48 CAHN, La Bible romane cit., n. 130 pp. 286-287; Le Bibbie cit., n. 9.49 CAHN, La Bible romane cit., n. 123 pp. 285; Le Bibbie cit., n. 7.50 G. MAZZATINTI, Ravenna, Vigevano, Perugia, Forlì, Bordandini, 1895 (Inventari dei mano-
scritti delle Biblioteche d’Italia, 5), p. 199; Le Bibbie cit., n. 14.51 AYRES, Le Bibbie atlantiche, in Le Bibbie cit., p. 32.52 VATTASSO - CARUSI, Codices Vaticani cit., pp. 262-267; M. VATTASSO, Le due Bibbie di Bovi-
no ora codici Vaticani latini 10510-10511, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana,1900, pp. 5-12, 17-44; Le Bibbie cit., nn. 17, 58.
53 C. NORDENFALK, Die spätantiken Kanontafeln. Kunstgeschichtliche Studien über die eusebiani-sche Evangelien-Konkordanz in den vier ersten Jahrhunderten ihrer Geschichte, Goteborg, Isakson,1938, pp. 174-178.
54 BERGER, Histoire cit., pp. 140-141. Ad una origine italosettentrionale del fenomeno,sotto la suggestione del ruolo politico e culturale svolto nell’XI secolo dal monastero di SanBenedetto del Polirone e della sua intensa attività di produzione libraria, ancora pensava
358 EMMA CONDELLO
tata nel corso degli studi sulla tradizione manoscritta della Vulgata da domQuentin, che l’esame delle varianti dell’Ottateuco, l’attenzione ai caratteriformali, l’inconsistenza della pista italo-settentrionale sorretta sostanzialmenteda un unico testimone, tardo, spingevano a concludere: « Il est impossibleque l’atelier d’où sortirent tous ces volumes si semblables entre eux ait étéailleurs qu’à Rome [...] et ce serait un beau sujet d’étude pour un paléo-graphe et un historien de l’art que de rechercher où fut situé dans la Villece scriptorium si fécond» 55. Proposta in seguito raccolta e risolta dalla storiadell’arte in consonanza con i risultati di Quentin, come si è visto, e piùtardi affrontata dalla paleografia. L’aspetto testuale invece, dopo Berger eQuentin, non è stato approfondito attirando piuttosto osservazioni sporadi-che e talvolta drasticamente riduttive, come quando Fisher ha definito « imi-tazione e ‘rianimazione’ delle Bibbie alcuiniane» 56 le Bibbie atlantiche cheBerger aveva giudicato «une véritable édition». In attesa di una rinnovataattenzione filologica – del cui interesse è saggio significativo un recentespecimen di Guy Lobrichon, che individua nelle note di revisione databiliall’ultimo terzo dell’XI secolo il carattere di un’edizione in corso di allesti-mento e rinviene materia sufficiente per ipotizzare tre fasi testuali successi-ve 57 – è comunque difficile oggi dubitare che si mirasse a realizzare un’edi-zione. Appare anche semplificatorio liquidare il testo delle Bibbie atlantichecon il mero riconoscimento di appartenenza alla famiglia alcuiniana: ri-mangono da chiarire comunque l’incidenza di varianti derivate da PierDamiani, il rapporto con i codici teodulfiani, nonché alcune scelte che cer-tamente connotano in senso più individuale la redazione.
È verosimile che la maturazione di una recensio originale sia stata impe-dita tanto da contingenze esterne quanto da fattori strutturali. Tra le pri-me, una accelerazione imposta al processo dal tumultuoso svolgersi del motoriformatore cui tutta l’operazione era funzionale (sì da conferire un valoresimbolico a posteriori al rammarico di Pier Damiani che comunicava ai con-fratelli di aver rivisto «bibliothecam namque omnium Veteris et Novi Testa-menti voluminum, licet cursim, et per hoc non esacte») 58, e anche quello
FICHTENAU, Neues cit., e Riesenbibeln cit.; per una più aggiornata valutazione dello scriptoriumpolironiano nel processo di ricezione e diffusione del modello decorativo offerto dalle Bibbieatlantiche, G. ZANICHELLI, Le Bibbie atlantiche e il monastero di San Benedetto al Polirone, in «Artemedievale», s. II, VII/1 (1993), pp. 43-59.
55 QUENTIN, Mémoires cit., p. 384.56 FISCHER, Zur Überlieferung cit., p. 413.57 G. LOBRICHON, Riforma ecclesiastica e testo della Bibbia, in Le Bibbie cit., pp. 15-26: 20-
21, 23, v. ora anche La Bible de la Réforme ecclesiastique. Aspects textuels (XIe siècle), in ID., LaBible au Moyen Age, Paris, Picard, 2003, pp. 94-108.
58 Patrologiae cursus completus, seu Bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda, oeconomicaomnium ss. Patrum, Doctorum scriptorumque ecclesiasticorum, sive Latinorum, sive Graecorum... SeriesLatina, in qua prodeunt Patres, Doctores scriptoresque Ecclesiae Latinae a Tertulliano ad InnocentiumIII, accurante J.-P. Migne, Paris, J.-P- Migne, 1844-1864, (d’ora in avanti PL), 145, col. 334c.
359LA BIBBIA AL TEMPO DELLA RIFORMA GREGORIANA
che Lobrichon lucidamente individua come il sostanziale fallimento storicodi un tentativo che ha avuto presa negli ambienti monastici ma non inquelli della predicazione e delle scholae; dei limiti interni, invece, sono atte-stazione le incertezze testuali di cui i manoscritti più antichi riportano trac-cia. Rimangono tuttavia ad attestare un concreto sforzo editoriale, sia purenon pervenuto ad esito completo, anche le scelte compiute riguardo alcanone, oltre all’esame delle varianti effettuato per i primi libri da Quen-tin. Le Bibbie atlantiche dell’XI secolo espungono libri apocrifi quali III-IVEsdra, III-IV Maccabei, Epistola ai Laodicesi, pur largamente circolanti nellaproduzione di codici biblici coevi 59; innovano rispetto al testo turonianointroducendo il prologo alle Lettere cattoliche e il libro di Baruc (quest’ulti-mo manca solo, per il nucleo più antico, in Genève, Bibliothèque Publiqueet Universitaire, 1 e in Montecassino, Archivio dell’Abbazia, 515) 60; presen-tano un canone che manifesta mobilità significativa solo per il blocco deilibri sapienziali e Paralipomeni e, più evidente, per i Salmi, mentre rispettala sequenza di tre blocchi ‘forti’: uno iniziale Ottateuco e Re spesso seguitodai Profeti, un altro insieme sostanzialmente stabile da Giobbe a Maccabei,infine la successione neotestamentaria Vangeli, Atti, Lettere cattoliche, Apoca-lisse, Lettere paoline 61.
Nessun antigrafo della prima generazione di Bibbie atlantiche è statofinora identificato, ma l’allestimento di una nuova edizione non poteva es-sere varato senza la disponibilità di esemplari molteplici: in tal senso van-no anche indizi codicologici quali situazioni significative di fascicolazione,già ricordate, in luoghi che, per essere ricorrenti, si segnalano come strate-gici del cambio di fonti. Tra gli antigrafi potenziali rimane verosimile eimmanente la Bibbia di San Paolo fuori le Mura, prestigiosa per origine,valori simbolici, appartenenza alla recensione alcuiniana: le sue rubrichesono in parte accolte nella tradizione delle atlantiche, essa presenta il testogallicano dei Salmi come appunto nelle Bibbie atlantiche anteriori al XII,alcuni dei suoi testi accessori e distintivi quali il prologo versificato delloscriba Ingoberto e i tituli poetici delle miniature del frontespizio sono ri-
59 LOBRICHON, Riforma cit., p. 16.60 J. SENEBIER, Catalogue raisonné des manuscrits conservés dans la Bibliothèque de la ville de
Genève, Genève, Chirol, 1779, pp. 51-60; M. INGUANEZ, Codicum Casinensium manuscriptorumcatalogus, III, Montis Casini-Romae, Typ. Pont. Inst. Pii IX, 1941, pp. 165-169; Le Bibbie cit.,nn. 2, 6.
61 Per la prima sistematizzazione sul canone delle Bibbie atlantiche, QUENTIN, Mémoire cit.,p. 380. Quanto alla mobilità dei libri sapienziali è bene ricordare come la loro collocazione eil loro ordine siano separativi anche tra il testo turoniano e i codici teodulfiani. I Salmi, nellaredazione delle Bibbie atlantiche entro la fine dell’XI secolo, tendenzialmente si collocanodopo Profeti, ma spesso dopo Re (Genève 1, presumibilmente Clm 13001) e persino a chiusuradella redazione, dopo i libri neotestamentari (Pall. latt. 3-5, Vat. lat. 10405), fino a mancaredel tutto (Admont, Stiftsbibliothek, C/D).
360 EMMA CONDELLO
presi tra fine dell’XI e inizi del XII secolo dalle Bibbie Barb. lat. 588 eArchivum S. Petri A 1 62.
Se la Bibbia di San Paolo è realmente un antigrafo credibile per leprime Bibbie atlantiche, come porta a dedurre anche l’insistenza sulla suafunzione di modello anzitutto codicologico e decorativo 63, Roma si confer-ma come l’unico centro in possesso contemporaneamente dei requisiti persostenere una produzione tanto impegnativa, delle motivazioni per intra-prendere un progetto di così vasta scala, destinato in modo programmaticoad essere veicolato tempestivamente mediante l’immediata circolazione an-che oltralpe di testimoni, al punto di compromettere di fatto l’evoluzionedi un lavoro testuale più sorvegliato e forzatamente più lento; infine, del-l’autorevolezza indispensabile per promuovere l’affermazione del nuovo co-dice biblico. Si deve parlare di autorevolezza, e non di autorità, perché nonè dimostrabile in alcun modo, né è necessario ipotizzarlo, che il nuovoparadigma sia stato apertamente imposto da Roma: certo elaborato e attiva-mente diffuso per intervento diretto della Chiesa romana, se alcune delleBibbie più antiche sono immediatamente dislocate (talora appositamente re-alizzate per la specifica destinazione) in centri geograficamente lontani daRoma, sedi episcopali o più spesso nuove fondazioni monastiche impegnatedirettamente, per opera del vescovo locale o dell’abate, nell’applicazione deiprincipi riformistici e nelle loro conseguenze politiche (Admont, Hirsau,Füßen, Ginevra, forse Sion, Millstatt e Sankt Florian) 64. Diffuso tuttavia, ilnuovo modello di codice scritturale, senza provvedimenti formali, in graziadella forza dell’esempio promosso dal centro della Cristianità: « i modelli,una volta imposti nel loro valore intrinseco e ideale e di fatto diffusi, sioffrono spontaneamente all’imitazione: basti ricordare per analogia, l’espor-tazione e successiva imitazione dell’onciale romana» 65. La circolazione deivalori e della spiritualità della Riforma ha in realtà anche tracciato le vie didiffusione di un testo biblico integrale autorevolmente promosso 66 sebbene
62 Bibbia di San Paolo fuori le Mura. Codex membranaceus saec. IX. Commentario storico, pale-ografico, artistico, critico, Roma, Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato, 1992-93; La Bibbia di SanPaolo fuori le Mura, a cura di V. JEMOLO e M. MORELLI, Roma, De Luca, 1981; FISCHER, ZurÜberlieferung cit., pp. 413, 421; LOBRICHON, Riforma ecclesiastica cit.; AYRES, Italian Giant Biblescit., p. 128; ID., Le Bibbie atlantiche, in Le Bibbie cit., pp. 30-31. Per il codice Archivum S. PetriA 1, C. STORNAJOLO, Inventarium codicum manuscriptorum Latinorum Archivii Basilicae S. Petri inVaticano, I, 1923 (dattiloscritto, Biblioteca Apostolica Vaticana, Sala Barberini 411); Le Bibbiecit., n. 41; GARRISON, Studies cit., III, pp. 284-285, 350-352.
63 GARRISON, Studies cit., I, p. 68; II, pp. 134; III, p. 284; IV, pp. 124, 126, 127, 142,252, 265-266; AYRES, An Italian Romanesque manuscript cit., pp. 25-26, e p. 16.
64 Admont, Stiftsbibliothek, C/D; Clm 13001; Pall. latt. 3-5; Genève, Bibliothèque Publiqueet Universitaire, 1; Sion, Bibliothèque du Chapitre, 15; Graz, Universitätsbibliothek, 1703/1;Sankt Florian, Stiftsbibliothek, XI. 1. Vedi anche infra, pp. 368-70.
65 SUPINO MARTINI, Roma cit., p. 31.66 J. LECLERQ, The Bible and the Gregorian Reform, in « Concilium », II/7 (1966), pp. 34-41.
361LA BIBBIA AL TEMPO DELLA RIFORMA GREGORIANA
non ancora maturo, e di un modello librario di non facile adozione. Lasolennità delle nuove Bibbie appare direttamente proporzionale alla rinno-vata importanza conferita alla lettura comunitaria dell’intero testo scrittura-le sia come mezzo della restaurazione morale del clero (scopo primario delmoto riformatore tra Leone IX e Alessandro II) sia come nutrimento dellaspiritualità monastica e strumento di un’istanza di rinnovamento di vitaclaustrale, sul modello di quella comunitaria illustrata negli Atti degli Aposto-li, destinata a fiorire pienamente nel secolo seguente 67. Le Consuetudinescluniacenses compilate attorno al 1080 da Udalrico monaco su richiesta del-l’abate Guglielmo di Hirsau, figura di spicco in ambito germanico dellapromozione di un fervore religioso «quae [religio monastica] paene refrixe-rat in eis qui habitum religionis praetendebant» 68, rispecchiano una prassifortemente sostenuta dagli abati riformatori e puntigliosamente prescrivono«quomodo Testamentum legatur utrumque»: lettura biblica comunitaria percirculum anni, da tenersi «et in ecclesia et in refectorio, ita ut ubi lectionisterminus fuerit lectae, ibi semper initium fiat legendae de sequenti », senzaomissione di libri ma con ordine non canonico, iniziando dall’Ottateuco incorrispondenza della Septuagesima, interponendo ai libri biblici la letturadei commenti di Agostino ai Salmi e al Cantico dei Cantici, le omelie diGregorio Magno su Ezechiele, eventualmente il commento di Giovanni Cri-sostomo alla Lettera agli Ebrei, «et alii sermones sanctorum Patrum et maxi-me sancti Augustini» 69. Anche la ricchezza di prefazioni, di prologhi specieai libri neotestamentari, di tituli e sommari, la frequenza e la maneggevolez-za delle tavole canoniche disposte su sole 4 facciate indicano l’intento diallestire un apparato finalizzato a facilitare e a rendere più efficace l’utilizza-zione del libro per la lectio: a questa ancora sono funzionali interventi coevi,o di poco successivi, riferiti alla sequenza delle letture per annum nel Laur.XV. 10, f. 337, nel Par. lat. 50 e nel Casan. 722 70. Altre note aggiunte, dicarattere chiaramente liturgico, antifone o notazioni neumatiche posteriori si
67 G. TELLENBACH, Die westliche Kirche vom 10. bis zum frühen 12. Jahrhundert, Göttingen,Vandenhoeck-Ruprecht, 1988, pp. 124-132; T. SCHMIDT, Alexander II. (1061-73) und die römischeReformgruppe seiner Zeit, Stuttgart, Hiersemann, 1977, pp. 134-186; G. CONSTABLE, Renewal andReform in religious life: concept and realities, in Renaissance and renewal in the Twelfth century, edit.by R.L. BENSON, G. CONSTABLE, C.D. LANHAM, Oxford, Clarendon Press, 1982, pp. 37-67: 41,54; ID., The Reformation of the Twelfth century, Cambridge, University Press, 2000, p. 4, passim.
68 HAIMO HIRSAUGIENSIS, Vita Willihelmi abbatis Hirsaugiensis, ed. W. WATTENBACH, in Mo-numenta Germaniae Historica. Scriptores, XII, edidit G. H. WAITZ, Hannoverae, Hahn, 1856,pp. 209-225: 218, 21.
69 Antiquiores consuetudines cluniacensis monasterii, in PL 149, coll. 635-778: 643-645b. I Pa-dri la cui lettura è raccomandata sono quelli che indicava Pier Damiani, nel cui elenco figu-rano inoltre Ambrogio, Girolamo, Prospero, Remigio, Amalario: De ordine eremitarum, PL 145,col. 334d.
70 BANDINI, Catalogus cit., coll. 150-152; F. AVRIL - Y. ZAkUSKA, Manuscrits enluminés d’origineitalienne, I, Paris, Bibliothèque Nationale, 1980, n. 72 pp. 43-44; Le Bibbie cit., nn. 35, 11, 57.
362 EMMA CONDELLO
riferiscono invece ad una conversione o un ampliamento di uso in circo-stanze cui le Bibbie giganti non erano inizialmente destinate (cfr. neumi ag-giunti nelle Bibbie di Admont, Stiftsbibliothek, C/D, di Perugia e Palatina) 71.
La spinta verso moralità e sobrietà di vita invocate tanto dal clero ri-formista, quanto da ampi settori laici soggetti al fascino del pauperismo edella purezza della Chiesa delle origini – con i quali i pontificati dell’XIsecolo dovettero misurarsi in una dialettica sofferta tra riconoscimento, con-tenimento e repressione: si vedano il caso dei laici « imitantes Ipsum quinon venit ministrari set ministrare», organizzati in Baviera e nell’ovest del-la Francia in spirito religioso sul modello della vita comunitaria dei primicristiani 72; o quello della Pataria milanese, che il futuro Gregorio VII ap-poggiò persino nel ruolo di legato apostolico 73 – ha con ogni probabilitàcontribuito ad orientare le scelte decorative delle più antiche Bibbie atlanti-che. La linearità d’insieme dell’ornato, nonostante la monumentalità e ilprestigio, il «compact ornamental control» (Ayres), il rigore geometrizzantee i tralci delle iniziali eseguiti in riserva, l’evidente mancanza di sovrabbon-danze decorative nella figurazione iconica, ha evitato per l’XI secolo e spes-so fino al XII inoltrato un’effettiva connotazione di lusso in questi manu-fatti librari. Una simile attitudine vale a spiegare alcune reazioni di studiosiquali Albert Boeckler o Nordenfalk, chiaramente consci del respiro artisticoe storico del fenomeno, ma portati a comparare con i parametri della piùalta decorazione ottoniana e bizantina l’essenzialità anche esecutiva oltreche iconografica delle prime Bibbie atlantiche, l’intento fortemente didatticodelle loro scelte figurative, i modi di una decorazione che certamente èaltro ma che soprattutto, storicamente, ha voluto essere altro 74.
71 Die illuminierten Handschriften in Steiermark, I. Die Stiftsbibliothek zu Admont und Vorau,von P. BUBERL, Leipzig, Hiersemann, 1911, n. 113 pp. 111-113; Le Bibbie cit., nn. 1, 14, 4.
72 BERNOLDUS, Chronicon, in Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, V, edidit G.H. WAITZ,Hannoverae, Hahn, 1844, pp. 385-467: 452-453; J. LECLERQ, La crise du monachisme aux XIe etXIIe siècles, in «Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo», LXX (1958), pp. 19-41: 29; più in generale, E. WERNER, Pauperes Christi. Studien zu sozial-religiösen Bewegungen imZeitalter des Reformpapsttums, Leipzig, Koheler-Amelang, 1956.
73 E. WERNER, Hildebrand-Gregor und die Mailänder Pataria, in La Riforma gregoriana cit.,pp. 21-28; H.E. COWDREY, The Papacy, the Patarenes and the Church of Milan, in «Transactions ofthe Royal Historical Society», s. V, XVIII (1968), pp. 25-48 (rist. in ID., Popes, Monks andCrusader, London, Hambledon, 1984, sez. V); H. KELLER, Pataria und Stadtverfassung, Stadtgemei-ne und Reform: Mailand im ‘Investiturstreit’, in Investiturstreit und Reichesverfassung, hrsg. von J.FLECKENSTEIN, Sigmaringen, Thorbecke, 1973, pp. 321-350.
74 BOECKLER, Abendländische cit., p. 68: «Konturen und Innenzeichnung sind äußerst ver-einfacht, zeigen nichts von dem Reichtum byzanthinischer Gestaltung, die Figuren sind schwerund gedrungen; die Bewegung abrupt, eckig; das Malerische ins Zeichnerische umgesetzt »;NORDENFALK, L’enluminure cit., pp. 136, 166: « figures souvent grossières», «certes pas [...] parmiles exemples les plus raffinés de l’art médiéval du livre», «Bibles [...] parfois quelque peuschématiques et monotones».
363LA BIBBIA AL TEMPO DELLA RIFORMA GREGORIANA
Funzionale al nuovo modello di libro biblico è infine l’abbinamento traforma fisica del libro e scrittura adottata, che è univocamente la carolina.Le ricerche di Paola Supino, indicando definitivamente Roma come humusdel fenomeno e ipotizzando lo scriptorium del Laterano come sede precipuadi una produzione che tutto indica direttamente promanata dagli intentiteologici e ideologici della cattedra di Pietro, hanno dimostrato, anche esoprattutto attraverso la riflessione sul fatto grafico, il legame genetico tra ifermenti riformistici di età pregregoriana e gregoriana e le nuove Bibbie 75.La delega a diffondere una redazione delle Scritture integrale, controllata econsona ai programmi della Chiesa di Roma nel momento storico specifi-co, viene comprovata dall’assenza, censita dalla studiosa, di Bibbie integraliper l’XI secolo che non siano in carolina e di formato atlantico, anche esoprattutto in ambiti di tradizione grafica diversa da quella carolina, qualil’Italia meridionale, le Isole britanniche e in particolare l’Irlanda, la Spa-gna (con la sola eccezione del Madrid, Biblioteca Nacional, 2, prima metàdel secolo) 76, i territori stessi dipendenti da Roma 77. L’assenza altresì diBibbie atlantiche complete in minuscola romanesca conferma la destinazionedi questi libri ad essere utilizzati in qualsivoglia comunità cristiana ovunquein Europa, il loro essere necessariamente svincolati da connotazioni grafi-che locali e perciò stesso provinciali in sede europea.
La carolina delle Bibbie atlantiche è omogenea, generalmente piuttostopesante, omologata, perfettamente rispondente ad esigenze d’ampia diffu-sione, sicura inequivocità, ricezione senza resistenze – almeno dal punto divista tecnico – prevalenza sui particolarismi. In questo senso non occorreinterpretare l’adozione della carolina come finalizzata a porre il nuovo li-bro nella scia della tradizione delle recensioni fiorite durante la rinascenzacarolingia 78, in un ‘ritorno all’antico’, secondo una efficace espressione diAttilio Bartoli Langeli 79, che nel caso delle Bibbie atlantiche si può forseconsiderare non un fine quanto piuttosto una conseguenza delle urgenzecui questa particolare tipologia libraria è chiamata a corrispondere. Unaconseguenza che viene a trovarsi di fatto in piena armonia con la fascina-zione dell’antico ben presente nella cultura romana dei secoli XI e XII 80 e
75 Sullo scriptorium lateranense nei secoli XI e XII, SUPINO MARTINI, Roma cit., pp. 46-56.76 AYUSO MARAZUELA, La Vetus Latina cit., n. 28 pp. 357-358; CAHN, La Bible romane cit.,
n. 147 pp. 292-293.77 SUPINO MARTINI, Roma cit., pp. 30-31, e EAD., La Scrittura cit., pp. 102-113.78 LOBRICHON, Riforma ecclesiastica cit., p. 16.79 BARTOLI LANGELI, Scritture e libri cit., p. 937.80 H. TOUBERT, Le renouveau paléochrétien à Rome au début du XIIe siècle, in «Cahiers ar-
chéologiques», XX (1970), pp. 94-154 (rist. in EAD., Un art dirigé. Réforme grégorienne et icono-graphie, Paris, Éditions du Cerf, 1990, pp. 239-310); E. KITZINGER, The Gregorian Reform and thevisual arts: a problem of method, in «Transactions of the Royal Historical Society», s. V, XXII(1972), pp. 87-102:99-102; ID., The arts as an aspects of a Renaissance: Rome and the Italy, inRenaissance and renewal cit., pp. 637-670.
364 EMMA CONDELLO
in forte coerenza simbolica con la richiesta di unità e di obbedienza al pon-tefice rivolta al popolo cristiano, ma che certamente è di segno tradizionali-sta dal punto di vista grafico sia rispetto alla realtà scrittoria dinamica evitale del territorio d’origine, ove la tipizzazione romanesca è la libraria piùvivace e rappresentata, sia rispetto a quanto in altri domini culturali nordeu-ropei (ma ancora troppo lontano dall’Italia e da Roma) andava nel frattempomaturando. Si tratta comunque di una conseguenza consapevole e inevitabile,a fronte dell’esigenza di diffusione totale e non ambigua del messaggio: percui anche la definizione di minuscola ‘riformata’, nell’accezione di veicolografico della Riforma 81, viene a sottolineare l’ineluttabile, non potendo darsialternativa alla scelta che fu fatta, pena la rinuncia all’afflato universalisticodel messaggio (con il quale l’adozione di una scrittura ovunque compresa epressoché ovunque accettata e praticata rivela una simbolica coerenza) e lacondanna del tentativo a una dimensione irrevocabilmente circoscritta.
Il richiamo alla tradizione, la sordina ad ogni individualismo graficopossono poi essere stati meno monolitici, nelle applicazioni concrete, diquanto le enunciazioni generali lascino intuire. La vocazione alla correttez-za impersonale, alla « testuale pura, immobile» evocata da Bartoli Langeli èdato generale che assurge ad esempi di ancor più alta cristallizzazione inalcune mani delle Bibbie di Genova (ad esempio, ff. 7, 175, 340) e diPerugia (ff. 4r, 88r, passim), ma lo sporadico avvento della romanesca etracce di una consuetudine alla tipizzazione possono presentarsi per uncerto tempo. Se non fanno testo in quanto inserti, benché coevi e determi-nanti per la definizione cronologica del manoscritto, i ff. 304r-308v, 361r,371r in romanesca nella Bibbia di Santa Cecilia, anteriore al 1080, ancoraai primi del XII secolo due mani in romanesca partecipano alla stesuradell’Archivum S. Petri A 1 (f. 45va, rr. 1-16, e f. 51ra, rr. 14-35; ff. 55v-88v) 82 ed echi della tipizzazione percorrono la scrittura di altre mani attivenel codice, che presentano qualche disordine nell’allineamento, d diritta
81 B. BISCHOFF, Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters, Ber-lin, Schmidt, 1979, p. 161 (ediz. ital.: Paleografia latina. Antichità e medioevo, a cura di G.P.MANTOVANI e S. ZAMPONI, Padova, Antenore, 1992 [Medioevo e umanesimo, 81], p. 181). Bar-toli Langeli conferisce alla definizione anche una valenza grafica, in rapporto all’interpretazio-ne delle Bibbie atlantiche come ripetizione fedele della scrittura del modello turonense (Scrit-ture e libri cit., p. 954; ID., Bibbie atlantiche e carolina ‘riformata’. Una nota, in Le Bibbie cit.,pp. 45-46). Già GARRISON, Studies cit., pp. 37-41: 39-40, nel proporre una periodizzazionedella scrittura delle Bibbie atlantiche e dei codici assimilati, aveva utilizzato la terminologia di« reformed minuscule» per la carolina rigida, tonda, calligrafica dei testimoni del pieno XIIsecolo, molto spesso toscani; la definizione ha per lo studioso una valenza strettamente tecni-ca, in contrapposizione alla scrittura «debased» e « improved» del cinquantennio precedente ealla minuscola di transizione ascritta all’ultimo quarto del XII secolo.
82 Per la trattazione degli inserti e per la datazione della Bibbia di Santa Cecilia v. supranota 22; per le due mani in romanesca dell’Archivum S. Petri A 1, SUPINO MARTINI, Roma cit.,p. 28 nota 14, e Le Bibbie atlantiche cit., n. 41.
365LA BIBBIA AL TEMPO DELLA RIFORMA GREGORIANA
con occhiello molto schiacciato peraltro in alternanza con d tonda e schiac-ciata (f. 27r), u angolata in fine rigo.
Una ricerca puntuale che si esercitasse sul medesimo arco di tempodefinito dai manoscritti appena citati, rilevando qualità, incidenza, indizicronologici delle occorrenze di romanesca nel tessuto della carolina delleBibbie atlantiche, potrebbe rinvenire ripetuti influssi e suggestioni della ti-pizzazione che trapelano in fasi di trascrizione meno controllata, o in manimeno impersonali, e offrire elementi di localizzazione ulteriori rendendosicuramente più mossa la chiaroscurale visione della situazione grafica delleBibbie stesse. Tra le più antiche, la Bibbia di Hirsau presenta nelle primedue mani (ff. 1r-16v, ff. 17r-130r: v. in particolare ff. 24v, 92v, 157r, passim)una carolina inclinata verso destra, con allineamento spesso difettoso, oc-chielli di d e q notevolmente schiacciati, m e n molto inclinate terminanticon un trattino orizzontale marcatamente prolungato sul rigo quasi a pre-parare un legamento, secondo una modalità spiccatamente romanesca chesi vedrà ricorrere ancora in Bibbie atlantiche del primo quarto del XII se-colo. Anche nella scrittura più regolare del Pal. lat. 4 emergono un leggeroeffetto di schiacciamento, una inclinazione a destra più marcata in m e nanche qui desinenti in un lungo filetto adagiato sul rigo, r e s leggermentediscendenti sotto il rigo, la r con l’ultimo tratto arcuato e ben prolungatose in posizione finale, e ancora in fine rigo occorrenza del nesso nT con nminuscola (f. 108v, r. 20). Analogamente nella Bibbia di Polirone, Mantova,Biblioteca Comunale 131, si rinvengono d tonda usata talora a inizio rigo,N in fine parola, r e s che scendono sotto il rigo, nesso NT in fine rigo,complessivo effetto squadrato della scrittura, talvolta (f. 13r) anche leggerainclinazione e filetto terminale evidente nell’ultimo tratto di m e n.
Verso la fine del secolo, il codice di Cividale, Museo Archeologico Na-zionale, Biblioteca Capitolare I-II 83 presenta sporadiche d tonde a inizio dirigo, m e n molto inclinate a destra, N in fine parola anche all’interno dirigo, r terminante sotto il rigo; nella II Bibbia della Biblioteca Angelica diRoma, 1273 84, una delle mani esegue d tonda molto schiacciata in alterna-tiva a quella diritta, m e n inclinate desinenti con un filetto obliquo versodestra piuttosto sviluppato, M in fine rigo e N anche all’interno, r e s chescendono leggermente, u angolata in chiusura di rigo (ff. 94r, 95v, passim).Al limitare tra i due secoli, la prima mano del Vallicelliano A 2 (ff. 1r-158v, 175r-208r) 85 utilizza d talvolta quasi tonda, r e s terminanti sotto ilrigo, S e u angolata a fine rigo (tav. 29); nella prima mano della Bibbia I
83 C. SCALON - L. PANI, I codici della Biblioteca capitolare di Cividale del Friuli, Firenze,SISMEL, 1998, pp. 67-76; Le Bibbie cit., n. 10.
84 NARDUCCI, Catalogus cit., p. 538; Le Bibbie cit., n. 43.85 Censimento dei codici dei secoli XI-XII, II, in «Studi medievali», s. III, XI (1970), pp. 1013-
1133: 1014.
366 EMMA CONDELLO
di Bovino Vat. lat. 10511 (ff. 1r-76r) si rinvengono leggera inclinazione, tal-volta d tonda in inizio di parola o di rigo, frequente S sia in fine che ininterno di rigo.
Con l’esordio del XII secolo, la Bibbia di Todi esibisce una carolinadiritta e regolare, ma alcune mani tendono a una scrittura leggermenteschiacciata, con d tonda accanto a quella diritta, N anche all’interno dirigo, R, S, u angolata e nesso NT in fine rigo (ff. 1r-56r, 62r-113v, 251r-294r, passim). La prima e la seconda mano del Vat. lat. 4217A 86 eseguonouna scrittura quasi diritta ma spesso schiacciata, nella quale tanto più spic-cano m e n molto inclinate, e usano d anche tonda specie in posizioneiniziale, r desinente sotto il rigo, M, N, R e nesso NT a fine rigo, molteletterine soprascritte (ff. 1r-18v, 19r-52v, passim). La Bibbia del Pantheon èin carolina molto rotonda, diritta ma nella prima e nella terza mano emer-gono reminiscenze di romanesca ancora con d tonda sporadicamente usatacome maiuscola e d quasi tonda più frequente all’interno del rigo, M, N enesso nT in chiusura di rigo, r diritta spesso scende leggermente e se inposizione finale ha l’ultimo tratto arcuato e pronunciato, come pronunciatoè anche il tratto terminale nella r tonda. Infine, il codice di Roma, Biblio-teca Nazionale, Sessoriano 1 87 nelle prime cento carte presenta una scritturapiuttosto inclinata, con m e n ancor più inclinate e terminanti con unfiletto prolungato adagiato sul rigo, nesso NT, alternanza di s e S in chiu-sura di rigo, u angolata sempre a fine rigo. Dopo il primo quarto del XIIsecolo il livello di omogeneità della scrittura tra un codice e l’altro aumen-ta in modo sensibile e non sembrano più esservi echi della tipizzazione:comprensibilmente, poiché la confezione di Bibbie atlantiche non ha più, aquesta altezza cronologica, il suo nodo primario e centrale in Roma, aven-do conquistato autonomia produttiva, in qualche caso ragguardevole, anchearee che prima erano destinazione delle Bibbie romane (vedi la Toscana); eperaltro, la romanesca ha ormai intrapreso un definitivo declino che nedetermina la scomparsa dopo la metà del secolo.
Le tracce che ne abbiamo rilevato e che ne ribadiscono la vitalità po-trebbero essere ascritte a una educazione grafica alla romanesca stessa, cuil’apprendimento della carolina non tipizzata verrebbe a sovrapporsi perimitazione di modelli anteriori (qualora si interpreti la scrittura delle Bibbiecome imitazione del paradigma grafico turoniano, e il panorama graficoromano come dominio esclusivo della romanesca con recesso completo del-la carolina pura) 88, o piuttosto a una pratica abituale e consolidata dellatipizzazione da parte di scriventi professionisti comunque avvezzi anche alla
86 Le Bibbie cit., n. 40.87 Censimento cit., I, in «Studi medievali », s. III, IX (1968), pp. 1115-1194: 1156; Biblio-
grafia dei manoscritti Sessoriani cit., p. 30.88 BARTOLI LANGELI, Bibbie atlantiche cit., p. 46.
367LA BIBBIA AL TEMPO DELLA RIFORMA GREGORIANA
carolina, che sono in grado di eseguire anche con assoluta correttezza, inuna situazione in cui la scrittura madre e la sua tipizzazione convivano, siapure non paritariamente per l’XI secolo. A favore della seconda interpreta-zione confluiscono dati molteplici: la continuità di tradizione della carolinaa Roma nei secoli IX e X, le attestazioni in sottoscrizioni documentarie,l’avvento a Roma e nella regione umbro-romana della minuscola diplomati-ca a danno della curiale giusto durante la seconda metà dell’XI secolo, lacompresenza di carolina in subordine alla romanesca in codici romani edell’area umbro-romana 89. A ciò si aggiunge la segnalazione di manoscrittiin carolina non tipizzata strettamente connessi, per confezione, decorazio-ne, spesso per singole mani in comune, a Bibbie atlantiche attribuite a Romasenza più controversia. È quanto si verifica per i Moralia in Iob Bamberg,Staatsbibliothek, Bibl. 41, il Rabano Mauro di Vienna, Österreichische Na-tionalbibliothek, 908, le Enarrationes in Psalmos di Lucca, Biblioteca Capito-lare, 24-25, il codice di Siena, Biblioteca Comunale degli Intronati, F I 6contenente Gregorio Magno in Ezechielem e Girolamo, in Isaiam e in Hiere-miam, l’Agostino, De civitate Dei, Par. lat. 2056 90, infine 11 sui 12 codicifinora identificati delle 29 donazioni librarie elargite dal vescovo GuglielmoII al Capitolo della Cattedrale di Troia tra 1108 e 1137.
Questi ultimi libri in particolare, dopo gli studi dedicati da GabriellaBraga, Giulia Orofino e Marco Palma 91, vengono a costituire una summa
89 In ordine alle presenze di carolina non tipizzata a Roma tra IX e XI secolo, tanto inambito librario quanto sul versante documentario, si rinvia a: P. SUPINO MARTINI, Carolinaromana e minuscola romanesca. Appunti per una storia della scrittura latina in Roma tra IX e XIIsecolo, in «Studi medievali », s. III, XV (1974), pp. 769-793; P. SUPINO MARTINI - A. PETRUCCI,Materiali e ipotesi per una storia della cultura scritta nella Roma del IX secolo, in «Scrittura eciviltà», II (1978), pp. 45-101; C. CARBONETTI, Tabellioni e scriniarii a Roma tra il IX e XI secolo,in « Archivio della Società romana di storia patria », CII (1979), pp. 77-156; C. ROMEO, Lesottoscrizioni autografe nel documento privato romano (X-XI secolo), tesi di laurea a. acc. 1977-78(Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. A. Petrucci); ID., Il testonegato: scrivere a Roma fra IX e XI secolo, in A. PETRUCCI - ROMEO, Scriptores in urbibus. Alfabeti-smo e cultura scritta nell’Italia medievale, Bologna, Il Mulino, 1992, pp. 127-42: 129-131 e 136-137; SUPINO, Roma cit., pp. 18, 24-25, 33-34, passim; EAD., Origine cit., p. 42; EAD., Società ecultura scritta, in Storia di Roma dall’antichità a oggi. Roma medievale, a cura di A. VAUCHEZ, Bari-Roma, Laterza, 2001, pp. 241-265: 248-255; EAD., Aspetti della cultura grafica a Roma tra Grego-rio Magno e Gregorio VII, in Roma nell’Alto Medioevo. Spoleto, 27 aprile - 1 maggio 2000,Spoleto, CISAM, 2001 (Settimane di studio del CISAM, XLVIII), pp. 921-968: 950-961, 968.
90 AYRES, Italian Giant Bibles cit., pp. 151-154; ID., An Italian romanesque Manuscripts cit.;ID., Le Bibbie atlantiche, in Le Bibbie cit., pp. 28, 30-31, 34-35. In riferimento alla problematicagenerale oltre a Ayres, SUPINO MARTINI, Origine cit., p. 43, e inoltre Roma cit., pp. 300, 317per codici di formato atlantico di origine probabilmente analoga ai precedenti, ma in roma-nesca; a proposito di una fiorente produzione circonvicina a Bibbie atlantiche toscane del XIIsecolo, v. supra, nota 37.
91 G. BRAGA - G. OROFINO - M. PALMA, I manoscritti di Guglielmo II vescovo di Troia allaBibl. nazionale di Napoli: primi risultati di una ricerca, in Libro, scrittura, documento della civiltà
368 EMMA CONDELLO
esemplificativa della funzione svolta da Roma nella produzione e circolazionedi codici scritturali, patristici e liturgici tra la metà dell’XI e il primo quartodel XII secolo, e del ruolo dei donatori e committenti che contribuirono adassicurarne la diffusione. I codici donati da Guglielmo, a parte la Bibbia atlan-tica Napoli, Biblioteca Nazionale, XV AA 1-292, anteriore al 1113, e un Ceri-moniale, contengono tutti testi patristici e quasi tutti di esegesi biblica (SuperEvangelium b. Matthaei dello pseudo-Remigio di Auxerre, Tractatus in Evange-lium Iohannis di Agostino, Homiliae in Evangelium s. Marci di Beda, Homiliae inEzechielem e Moralia in Iob di Gregorio Magno, Enarrationes in Psalmos di Ago-stino) in evidente osservanza del programma di approfondimento delle SacreScritture perseguito dalla Chiesa riformista. La scoperta poi che alcuni copistiattivi nei codici del vescovo Guglielmo abbiano collaborato anche alle Bibbieromane di San Crisogono, di Bovino II, del Bessarione Venezia, BibliotecaNazionale Marciana, Lat. Z 1-2 (1949-50), di Milano, Archivio di S. Ambro-gio, M 55, e Biblioteca Apostolica Vaticana, S. Maria Maggiore, 493, offre unaconferma concreta ad un’ipotesi di lavoro avanzata tanto dalla storia dell’artequanto dalla ricerca paleografica: che le Bibbie atlantiche siano state il feno-meno di punta di un contesto articolato e più complesso e di una produzio-ne libraria più ampia e coerente di quanto si fosse finora potuto dimostrare.
La fulminea diffusione del nuovo modello di codice biblico deve moltoa figure che hanno anticipato quella di Guglielmo II di Troia, ad oggil’esempio meglio documentato di donatore e probabile committente di Bib-bie atlantiche. Per il tramite di abati o vescovi in rapporti stretti con lacuria pontificia, impegnati attivamente nell’azione di riqualificazione moraledel clero, molte Bibbie romane della prima generazione sono approdate adestinazioni lontane in tempi molto stretti dopo l’allestimento. Entro il 1074Federico vescovo di Ginevra donava al capitolo della propria sede episco-pale la Bibbia omonima, che ne riporta nota a f. 417v e che viene attribu-ita agli anni ’60-’70 del secolo 94: con quell’anno i rapporti con Roma di-
monastica e conventuale del basso Medioevo (secoli XIII-XV). Atti del Convegno dell’AssociazioneItaliana dei Paleografi e Diplomatisti (Fermo, 17-19 sett. 1997), a cura di G. AVARUCCI, R.M.BORRACCINI VERDUCCI, G. BORRI, Spoleto, CISAM, 1999, pp. 437-470; G. BRAGA, I manoscritti delvescovo Guglielmo II: significato di una scoperta, in Le Bibbie cit., pp. 87-90.
92 Le Bibbie cit., n. 22.93 BRAGA - OROFINO - PALMA, I manoscritti cit., pp. 450, 458-459. Per le Bibbie qui citate per
la prima volta, VALENTINELLI, Bibliotheca cit., pp. 194-195; M. FERRARI, Due inventari quattrocenteschidella Bibl. capitolare di S. Ambrogio in Milano, in Filologia umanistica per Gianvito Resta, a cura di V.FERA - G. FERRAÙ, II, Padova, Antenore, 1997, pp. 771-814: 807; SUPINO MARTINI, Roma cit., p. 27nota 13; Le Bibbie cit., nn. 20, 21. Da segnalare che anche BERG, Studies cit., p. 49 indicava comecomune l’origine della Bibbia di San Crisogono, del codice di Milano e del S. Maria Maggiore.
94 P.B. GAMS, Series episcoporum ecclesiae catholicae, Ratisbonae, Manz, 1873-1885, p. 277;M. DE TRIBOLET, La bibliothèque de Frédéric, évêque de Genève, fin du XIe siècle, in «Bulletin de laSocieté d’histoire et d’archéologie de Genève», XIV (1970), pp. 265-275: 265-270.
369LA BIBBIA AL TEMPO DELLA RIFORMA GREGORIANA
vennero tesi e rarefatti per Federico, fino ad allora allineato con i princi-pi della riforma ma in seguito partecipe del malessere di parte dell’epi-scopato, soprattutto tedesco, nei confronti della volitiva e rigida afferma-zione dell’autorità di Gregorio VII 95. Ad un altro vescovo, il beato Gebharddi Salisburgo, un inventario trecentesco attribuisce il dono della Bibbia diAdmont alla neofondazione benedettina: la notizia è attendibile, perchécoerente con la partecipazione intensa di Gebhard alla riforma della vitacomune del clero e con la fama delle sue donazioni di libri e arrediliturgici alle sue fondazioni di Admont e della subdiocesi di Gurk; anchein questo caso il libro deve essere arrivato subito dopo la confezione, trala fondazione del monastero, 1074, e l’esilio con cui nel 1077 Enrico IVcolpì il vescovo, schieratosi a fianco di Gregorio VII 96. Ancora da Gebhardpotrebbe dipendere l’arrivo, non altrimenti documentato, dei frammentidi Bibbia atlantica oggi Graz, Universitätsbibliothek, 1703/1 97 alla neofon-dazione benedettina di Millstat presso Salisburgo (1070). Situazioni consi-mili sono plausibili in vario grado per altre Bibbie della fase più antica,compatibilmente con i dati storici sul singolo prelato. È quanto avvieneper il codice di Sion, Bibliothèque du Chapitre, 15 che può essere statodonato al capitolo dal vescovo Ermenfried, protagonista di una soffertaparabola analoga a quella di Federico di Ginevra 98; e forse per la Bibbiadi Sankt Florian, Stiftsbibliothek XI. 1, di attribuzione controversa maforse italiana e paleograficamente compatibile con una datazione anterio-re alla fine dell’XI secolo 99, che può essere giunta al cenobio agostinianoper intervento del vescovo che lo riformò, Altmann di Passau, fedelissimodi Gregorio VII, morto nel 1091 100. Diverso negli effetti, perché non im-plica circolazione del codice fuori di Roma, ma significativo per il rilievodel committente, è il caso della Bibbia di Santa Cecilia: prodotta da altroscriptorium romano, è giunta alla basilica, come ormai è dimostrato, inanni in cui ne era cardinale titolare Desiderio di Montecassino (dal 1059
95 Poco dopo il 1073 Federico sarebbe stato sostituito nella carica da un Boczardus: v.Dictionnaire d’histoire et géographie ecclesiatiques (d’ora in avanti DHGE), XX, Paris, Letouzey etAné, 1984, sub voce Genève, col. 449. Sulla reazione episcopale a Gregorio VII, W. GOETZ,Riforma ecclesiastica-Riforma gregoriana, in La Riforma gregoriana cit., I, 1989, pp. 167-178;I.S. ROBINSON, ‘Periculosus homo’: pope Gregory VII and episcopal authority, in «Viator», IX (1978),pp. 103-131.
96 GAMS, Series episcoporum cit., p. 307; DHGE, XX, 1984, coll. 224-227.97 A. KERN, Die Handschriften der Universitätsbibliothek Graz, Wien, Prachner, 1967, p. 124.98 J. LEISIBACH - A. JÖRGER, Livres Sédunois du Moyen Age: enluminures et miniatures. Trésor de
la Bibl. du Chapitre de Sion, Sion, Sedunum Nostrum, 1985, pp. 44-48; AYRES, Le Bibbie atlan-tiche cit., p. 31.
99 A. CZERNY, Die Handschriften der Stiftsbibliothek Sankt Florian, Linz, Corb, 1871, pp. 1-2;CAHN, La Bible romane cit., n. 21 p. 257. Sui problemi di localizzazione e datazione delcodice, FICHTENAU, Riesenbibeln cit., pp. 167-169, e AYRES, A fragment cit., pp. 137-140.
100 GAMS, Series episcoporum cit., p. 301; DHGE, II, 1914, coll. 826-827.
370 EMMA CONDELLO
al 1086) 101, che Ayres ipotizza sia stato il committente o comunque il tra-mite della dotazione 102.
Le eccezioni laiche tra i donatori delle Bibbie più antiche sono rare, trein tutto, delle quali incontrovertibile solo quella relativa alla Bibbia di Hir-sau: il magnifico codice miniato, nel quale una nota in capitale librariaripetuta in apertura di molti libri informa che «Heinricus IIII rex hunclibrum dedit sancto Aurelio» (ff. 1r, 17r, 35r, 42v, 76v, 92v, passim) è giuntoall’abbazia benedettina di Sant’Aurelio di Hirsau prima del 1076, allorchéil monastero scelse la linea dell’obbedienza apostolica nella frattura apertasisulle investiture ecclesiastiche 103. È invece ipotetico, sebbene verosimile elucidamente argomentato da Giuseppa Zanichelli, che la Bibbia di Polironesia arrivata al monastero padano negli anni ’70 del secolo per munificenzadi Matilde di Canossa, allorché il chiostro si pose sotto la protezione diGregorio VII 104; né è più esplicito, nonostante una nota di donazione, ilcaso della Bibbia Palatina il cui donatore, un Odalrico « summis principibusnotus» (Pal. lat. 3, f. 167v) offre i tre tomi ad un monastero di San Ma-gno, probabilmente di Füßen, rivendicando alla propria famiglia il possessodel libro nel caso di un tentativo di furto e utilizzando nel complesso untono effettivamente poco consono ad un prelato, che si trattasse dell’abatedi Füßen o di un omonimo abate di San Gallo, nelle cui pertinenze esiste-va una cella intitolata allo stesso santo 105.
Bisogna arrivare al XII secolo inoltrato per rinvenire la traccia di altredonazioni laiche, del tutto differenti dalle elargizioni sovrane o comitaliappena ricordate. I donatori sono infatti fedeli di estrazione non nobiliare,talora dichiaratamente modesta, e contribuiscono con oboli di varia entità,spesso elargiti in memoria dei propri defunti, cooperando alle spese dicodici biblici di grande impegno confezionati da artigiani laici. Questo è ilcontesto d’origine della Bibbia di Calci, che a chiusura del IV tomo (f. 231r)riporta una lunga lista di quanti hanno contribuito, con versamenti checoprono la metà delle oltre trentadue lire cui ammonta la spesa complessi-va, a offrire una Bibbia completa miniata al monastero dei Santi Vito, Mo-desto e Melchiade in Pisa, nell’anno 1168. La nota, edita integralmente daBerg 106, menziona ben cinquantasei offerenti, tra i quali compaiono un Bur-nettus faber (se l’appellativo non sia da intendersi già come parte del nome),un Gerardinus e un Petrus Vekius pescatori. Segue il sunto dei pagamenti
101 R. HÜLS, Kardinäle, Klerus und Kirchen Roms 1049-1130, Tübingen, Niemeyer, 1977,pp. 154-157.
102 AYRES, The Italian Giant Bible cit., pp. 151-152; ID., An early christian legacy cit., p. 43.103 AYRES, The Bible citato.104 ZANICHELLI, Le Bibbie atlantiche cit., pp. 57-59; v. anche AYRES, The Italian Giant Bible
cit., pp. 137-140.105 CAHN, La Bible romane cit., n. 135 p. 289.106 BERG, Studies cit., pp. 226-227; v. inoltre pp. 151-153.
371LA BIBBIA AL TEMPO DELLA RIFORMA GREGORIANA
per la materia scrittoria e per gli artigiani che hanno confezionato la Bibbia:quattro decoratori (un magister Viviano, responsabile secondo Berg della de-corazione figurata, con l’assistente Caloianni; un Adalberto «scriptor de licte-ris maioribus de auro et de colore», un Andrea per le iniziali minori) e duecopisti (un anonimo e un Alberto da Volterra), uno dei quali verga unacarolina ormai vicina alla minuscola di transizione (leggero contrasto, vertica-lizzazione rigida, angolosità incipienti, sporadica d tonda, scrittura distintivacon D, M, O strozzata ‘a otto’, U di maiuscola gotica: v. ff. 7r, 19r, 23r,passim). Forse il testo segnala anche un noleggio di un antigrafo non rilega-to, se può interpretarsi in questo senso uno dei passi meno perspicui, « itemdedimus presbitero Gregorio quando reduxit quaternus sol. XLII et den. III»:da notare che le spese sembrano elencate secondo l’ordine logico di confe-zione dei quattro tomi (dapprima il conto della pergamena, segue il paga-mento al copista anonimo, poi ancora pergamena, la cifra per l’altro copista,la miniatura delle iniziali maggiori, ancora pergamena, la spesa delle inizialiminori, il denaro pagato con la restituzione dell’oscuro quaternus, infine ilpagamento per il maestro Viviano) e che la cifra di quarantadue soldi e tredenari è superiore a quanto pagato per la decorazione dell’intera Bibbia.
Dati analoghi, ma molto più scarni, offre alla stessa altezza cronologicala Bibbia Casanatense 722 107. Nelle carte iniziali dei fascicoli XVI, XVII,XVIII, sempre nel margine inferiore e sempre con danni da rifilatura, lamano del copista, in scrittura meno rigida e composta, a f. 121r ricorda ifratelli Pietro di Albona e Iacculo, con le mogli, come coloro che «hedifica-verunt quaternum istum»; a f. 129r registra «Zicarus Martinus quaternumscripsit in libro», laddove ‘scripsit’ vale probabilmente ‘scribi fecit’, così comel’‘hedificaverunt’ precedente, poiché la nota avrebbe senso come sottoscri-zione di uno scriba solo in una situazione di ripartizione del lavoro dicopia tra più mani, ciò che il codice non conferma; a f. 137r ancora ilcopista verga una lunga nota purtroppo solo in parte salvata, della quale silegge «hunc [...]gell[...] eiusdem viri custodiunt (?) quaternum ex suis rebuscomponere toto animi affectu studui[...] ». Il Casanatense 722 sembra quindiun caso assimilabile a quello della Bibbia di Calci: purtroppo il codice èstato severamente rifilato, per adattarne le misure a quelle del Casanatense723, adibito a secondo tomo di una Bibbia ricomposta a posteriori 108, ed èverosimile che altre note analoghe alle tre superstiti siano state sacrificate.
Ancora un laico, non un offerente ma un copista, lega il proprio nomead una Bibbia toscana completata nel 1140, come dichiara la sottoscrizionedello scriptor pistoiese Corbolino sul verso dell’ultima carta del Laur. Conv.Soppr. 630 109; Corbolino verga una carolina larga, rotonda, molto calligrafi-
107 Censimento cit., I, p. 1136; SUPINO, Roma cit., p. 331; Le Bibbie cit., n. 57.108 BERG, Studies cit., p. 143.109 Ibid., n. 58 pp. 259-260; CAHN, La Bible romane cit., n. 120 p. 285; Le Bibbie cit., n. 47.
372 EMMA CONDELLO
ca in questo codice dall’apparato decorativo imponente, opera di artisti aiquali, o alla bottega dei quali, Berg ha potuto ricondurre altri quattordicimanoscritti toscani compresi tra metà e fine del secolo, e tra essi le Bibbieatlantiche Laur. XV.13 e Mugell. 2 110.
Poche tracce dirette, quindi, ma tutte univoche, che concorrono a indi-care quanto e profondamente fosse mutato il contesto delle Bibbie atlanti-che, prima della metà del XII secolo, sia dal punto di vista delle motiva-zioni che ne avevano sostenuto l’origine sia da quello degli ambiti di pro-duzione. Conclusasi la stagione riformistica, declinata Roma come centro didiffusione di una tipologia di codice biblico che ha esaurito la sua funzioneinnovatrice e appare ormai tornato nell’alveo rassicurante del libro presti-gioso offerto dai fedeli a celebrazione dei santi eponimi della comunità,la manifattura delle Bibbie appare efficacemente risolta anche da mae-stranze laiche, almeno in area toscana che peraltro è la più feconda diBibbie atlantiche da metà secolo in poi 111. Se questo avvenga anche altrove,con quale incidenza, con quali rapporti con l’analoga produzione ecclesia-stica, in quali contesti di commercio librario, sarà oggetto di percorsi diricerca ancora solo abbozzati; ma il radicamento delle Bibbie atlantiche inarea toscana, con modalità che riflettono la mutazione sostanziale e il de-clino del fenomeno originario, produrrà altre conseguenze oltre quelle de-corative tanto ed esaustivamente studiate. La carolina di questi codici, calli-grafica e larga, di grande impatto estetico e funzionale, standardizzata piùdi quanto, si è visto, lo fosse quella delle Bibbie romane dell’XI, sarà infattiun archetipo, uno dei più largamente disponibili e più frequentemente vi-sualizzati, al quale guardare durante il processo di elaborazione di unaproposta grafica e di decorazione libraria radicalmente diverse rispetto allatradizione delle litterae textuales e dell’ornamentazione gotica. Le Bibbie atlan-tiche del XII secolo saranno un tramite di trasmissione di un’eredità graficaraccolta e coltivata nella Firenze di Coluccio Salutati, come simbolicamentesottolinea appunto l’appartenenza a Coluccio di una Bibbia atlantica toscanaparadigmatica dal punto di vista scrittorio quale l’attuale Casanatense 723112.
110 BANDINI, Catalogus cit., coll. 154, 541-544; BERG, Studies cit., pp. 110-133; Le Bibbiecit., nn. 52, 37.
111 Il fenomeno era stato colto in tutta la sua importanza da BERG, Studies cit., pp. 218-220, e La miniatura cit., pp. 50-52 per la Toscana, e se ne ha chiaro richiamo ancora in G.DALLI REGOLI, Per una storia del libro illustrato. Note sulla tipologia di alcune Bibbie miniate in Italiafra l’XI e il XII secolo, in Atti del I Congresso nazionale di storia dell’arte, a cura di C. MALTESE,Roma, CNR, 1978, pp. 515-528: 520, e in AYRES, The Italian Giant Bibles cit., p. 151. Sullaprospettiva di studio di una produzione laica di Bibbie atlantiche ancora sommersa attiraval’attenzione nel 1987 SUPINO MARTINI, Roma cit., p. 31 nota 20, e Origine cit., p. 43.
112 A f. 137v, la nota di possesso «Liber Colucii pyeri»: v. B. ULLMAN, The Humanism ofColuccio Salutati, Padova, Antenore, 1963 (Medioevo e umanesimo, 4), n. 70 p. 179; BERG,Studies cit., n. 137; Le Bibbie cit., n. 58.