La ragione degli altri: Gabrio Lombardi e la questione del divorzio (con una nota di lettura di...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of La ragione degli altri: Gabrio Lombardi e la questione del divorzio (con una nota di lettura di...
LXXIX 2013
PONTIFICIUM INSTITUTUM UTRIUSQUE IURISFACULTAS IURIS C IV IL I S
STUDIA ET DOCUMENTA
HISTORIAE ET IURIS
DIRECTOR
@ HENRICUS DAL COVOLO
REDACTOR
FRANCISCUS AMARELL I
A SECRETIS
SEBAST IANUS PACIOLLA
LATERAN UNIVERS ITY PRESS
STUDIA ET DOCUMENTA HISTORIAE ET IURIS
FUNDAVERUNT AC DIREXERUNT
AEMILIUS ALBERTARIO ARCADIUS LARRAONA SALVATOR RICCOBONOGABRIUS LOMBARDI IOANNES ALOISIUS FALCHI
DIRECTOR
✠ HENRICUS DAL COVOLO
Rector Pont. Univ. Lateranensis
REDACTOR
FRANCISCUS AMARELLI
A SECRETIS
SEBASTIANUS PACIOLLA
CONSILIUM REDACTIONIS
L. DE GIOVANNI F. GALGANO D. PIATTELLI
COMITATUS SCIENTIFICUS
L. ATZERI (Max-Planck-Institut Frankfurt a. M.) – C. BALDUS (Heidelberg) –M. BALESTRI FUMAGALLI (Milano Statale) – G. BASSANELLI (Bologna) – M. G. BIAN-CHINI (Genova) – C. BUZZACCHI (Milano Bicocca) – J. CAIMI (Genova) –G. CAMODECA (Napoli L’Orientale) – M. CAMPOLUNGHI (Perugia) – F. P. CASAVOLA(Presidente em. della Corte Costituzionale e dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana) – J. M. CAR-RIÉ (Paris EHESS) – D. A. CENTOLA (Napoli Federico II) – J. L. CORIAT (Paris II) – G. DESIMONE (Roma Laterano) – A. Fdez DE BUJAN (Madrid UA) – F. Fdez DE BUJAN (MadridUNED) – G. FALCONE (Palermo) – I. FARGNOLI (Milano Statale) – L. FASCIONE (RomaTre) – L. FRANCHINI (Roma Europea) – E. FRANCIOSI (Bologna) – S. A. FUSCO (Macerata)– P. GARBARINO (Piemonte Orientale) – L. GAROFALO (Padova) – E. GERMINO (SecondaUniv. di Napoli) – C. GIACHI (Firenze) – S. GIGLIO (Perugia) – F. GNOLI (Milano Statale) –A. GUZMAN BRITO (Valparaiso Catolica) – E. HÖBENREICH (Graz) – R. LAMBERTINI(Modena) – C. LANZA (Seconda Univ. di Napoli) – O. LICANDRO (Catanzaro) – A. LOVATO(Bari) – G. LUCHETTI (Bologna) – F. LUCREZI (Salerno) – L. MAGANZANI (Piacenza Catto-lica) – G. MANCINI (Teramo) – V. MAROTTA (Pavia) – M. MIGLIETTA (Trento) – M. L. NA-VARRA (Perugia) – G. NEGRI (Milano Cattolica) – G. M. OLIVIERO NIGLIO (Seconda Univ.di Napoli) – A. PALMA (Napoli Federico II) – G. PAPA (Napoli Parthenope) – F. PERGAMI (Mila-no Bocconi) – S. PULIATTI (Parma) – G. PURPURA (Palermo) – R. QUADRATO (Bari) – F. RE-DUZZI (Napoli Federico II) – E. STOLFI (Siena) – A. TORRENT (Madrid URJC) – G. VALDI-TARA (Roma Europea) – C. VENTURINI (Pisa) – U. VINCENTI (Padova) – J. G. WOLF (Frei-burg i.B.) – P. ZANNINI (Torino).
Redactionem ephemeridis Studia et Documenta Historiae et Iuris quaecumque attinent, mittendasunt ad officium ephemeridis Piazza S. Giovanni in Laterano, 4 - 00120 Città del Vaticano
Omnes libri qui accipientur in ephemeride nunciabuntur: quorum vero duplex exemplar par-venerit, exarabitur, quo fieri poterit, peculiaris recensio.
Quando non riconducibili ad autori invitati dalla Rivista a collaborare con un loro contributoalla composizione di uno dei suoi volumi, la pubblicazione degli scritti che vengono proposti è su-bordinata alla valutazione positiva espressa (rispettando l’anonimato di autore e valutatori) da duestudiosi scelti dalla Redazione, in primo luogo, tra i componenti del Comitato Scientifico; oppure,sentiti i loro vertici, tra i colleghi della Società Italiana di Storia del Diritto e quelli dell’Istituto Italiano diScienze Umane.
La decisione sulla meritevolezza della pubblicazione è comunque assunta dalla Redazionedella Rivista, presso cui viene conservata tutta la documentazione relativa alla procedura di revisio-ne svolta.
Ciò in adesione al comune indirizzo adottato, in tema di regole che governano le pubblicazioniscientifiche, dalle riviste romanistiche italiane (oltre SDHI., AG., BIDR., Iura, Index ed altre) in sèguitoalle indicazioni del Gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Boulvert e a conseguentidelibere del Consiglio Universitario Nazionale e del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Gli autori, i cui scritti vengano accettati per la pubblicazione, sono pregati di inviare anche unabstract in lingua inglese e almeno due parole-chiave in inglese e nella lingua del contributo utiliz-zando il seguente indirizzo di posta elettronica: francoamarelli6tin.it
TIPOGRAFIA S. PIO X - MMXIII
La rivista ha periodicità annuale.L’abbonamento decorre dal 1o gennaio di ogni anno. I fascicoli
non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati entro 10 giornidal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spe-discono contro rimessa dell’importo
Gli abbonamenti possono essere pagati:
– in ITALIAtramite bonifico bancario o C/C postale a favore della PontificiaUniversità Lateranense/Editoria:Cin N; Abi 07601; Cab 03200; C/C 000076563030
– all’ESTEROtramite bonifico bancario a favore della Pontificia Università Latera-nense/Editoria:Banco posta – Poste Italiane S.p.a.IT 23 N 07601 03200 000076563030BIC BPPIITRRXXX per valuta in EuroBIC POSOIT22XXX per tutte le altre valute
specificando sempre la causale del versamento.
Le richieste di abbonamento, le comunicazioni per mutamentidi indirizzo e gli eventuali reclami per mancato ricevimento di fasci-colo vanno indirizzati a:
Lateran University Press – Ufficio Marketing e AbbonamentiPiazza S. Giovanni in Laterano, 4 – 00120 CITTÀ DEL VATICANO
TEL. 06/698 95 688 – FAX 06/698 95 501 -E-MAIL : [email protected]
RIVISTA PUBBLICATA NELLA CITTÀ DEL VATICANO
IURA PROPRIETATIS VINDICABUNTURPONTIFICIAE UNIVERSITATI LATERANENSI
✠ HENRICUS DAL COVOLO, Sponsor
I N D E X
ENRICO DAL COVOLO, La Constitutio Antoniniana e lo sviluppodelle relazioni tra l’Impero e la Chiesa nell’età dei Severi (193-235
d. C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIIFRANCESCO AMARELLI, Il contributo dell’Institutum Utriusque
Iuris allo studio del diritto romano. In ricordo di Gian Luigi Falchi XVROBERTO PERTICI, La ragione degli altri: Gabrio Lombardi e la que-
stione del divorzio (con nota di lettura di Massimo Miglietta) XXV
STUDIA
JOSEPH GEORG WOLF, Interpolationen in den Digesten . . . . . 3ANTONIO FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Contribución al estudio de los
arbitrajes de Derecho Público en la experiencia jurídica romana . . 81HANS-MICHAEL EMPELL, Durchgangseigentum bei Celsus Ulp. 32 ad
Sab. D. 24.1.3.12 sachenrechtlich interpretiert . . . . . . . 103MARCO URBANO SPERANDIO, ‘Gai scripta universa’. Note su
Gaio e la ‘legge delle citazioni’ . . . . . . . . . . . . . 153ARMANDO TORRENT, La fractura Justinianea en la producción del de-
recho, la prohibición de comentar el Digesto, y su ideologia positivista 191PEPA CASTILLO PASCUAL, El río y sus paisajes: los genera per al-
luvionem de agrimensores y juristas . . . . . . . . . . . 221PAOLA LUIGIA CARUCCI, Senato e diritto. Alcuni spunti testuali . . 235ELENA GIANNOZZI, La patria potestas dans l’œuvre de Yan Thomas 279RAMÓN P. RODRÍGUEZ MONTERO, Hilvanando «atributos» femeni-
nos en la antigua Roma . . . . . . . . . . . . . . . 305DANIELE VITTORIO PIACENTE, L’idoneità all’insegnamento nell’impe-
ro romano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325PAOLA BIAVASCHI, Vicende del cursus publicus al tempo del foedus
Gothicum (382 d. C.). . . . . . . . . . . . . . . . 341CARMEN PENNACCHIO, La dactylotheca ovvero una collezione
(minore) di beni di lusso? Consumatori e scelte economiche dal I al
III secolo d. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365ALESSIO GUASCO, CTh. 2.4.2. Un provvedimento imperiale sul proces-
so civile tra principato e tardoantico . . . . . . . . . . . 405
VI Index
ROBERTO SCEVOLA, In margine al ‘litem suam facere’ in età post-
classica e giustinianea . . . . . . . . . . . . . . . . 423ANTONINO MILAZZO, La fattispecie materiale della lex Licinia de
sodaliciis e le origini del reato associativo . . . . . . . . . 481MARIA VIRGINIA SANNA, Spes animantis – da una lex regia ad
Adriano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501MARÍA DEL PILAR PÉREZ ÀLVAREZ, El elemento jurídico en las
comedias de Plauto especial referencia a captivi . . . . . . . 519LOREDANA DI PINTO, Il diritto d’asilo tra Stato e Chiesa . . . . 571MANUEL CAMACHO DE LOS RÍOS, Interrelaciones entre el pactum
ut minus solvatur y la aditio mandatum creditorum . . . 595
DOCUMENTA
ALFONSO CASTRO SÁENZ, El Gayo veronés: nuevas perspectivas sobre
un tema de siempre (Acotaciones en torno a una nueva generación de
romanistas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627JOSÉ MARÍA COMA FORT, «Ein entdecktes juristisches Ineditum»: a
propósito del descubrimiento de las Institutiones de Gayo . . . . 653FERNANDO REINOSO BARBERO, Interpretazione delle citazioni del
digesto negli scritti medievali e rinascimentali . . . . . . . . . 687PAOLO MARI, Per l’edizione critica del Codice di Giustiniano. Note a
margine della riproduzione anastatica della Summa Perusina . . 725
ROBERTO PERTICI
LA RAGIONE DEGLI ALTRI: GABRIO LOMBARDI
E LA QUESTIONE DEL DIVORZIO
CON NOTA DI LETTURA DI MASSIMO MIGLIETTA
Le ‘note di lettura’ vengono generalmente riservate a monografie, nel senso classico deltermine, ossia a volumi più o meno ponderosi. L’acuta ‘rilettura’ della figura di GabrioLombardi, ad un secolo dalla nascita e a venti anni dalla scomparsa, pubblicata da RobertoPertici in Ventunesimo secolo 22 (2010), attraverso un contributo di dimensioni contenute,merita tuttavia una (doverosa) eccezione.
Probabilmente a molti, oggi, il nome di Gabrio Lombardi dice poco.Nulla, addirittura, ad un attuale studente, fosse anche di giurisprudenza.A chi scrive richiama, invece, il legame con i propri maestri – Ferdinando Bona e
Giorgio Luraschi – che di Lombardi furono allievi. In virtù di questo legame, e in virtù diuna ‘tradizione orale’ che da questi mi è stata consegnata, mi sento, in qualche modo, unasorta di ‘allievo di seconda generazione’, nonostante non abbia mai avuto la fortuna diconoscere personalmente Lombardi.
‘Maestro di civismo’ è l’appellativo con il quale Ferdinando Bona lo ricordava in aper-tura del primo dei due volumi di Studia ed Documenta (1994-1995) dedicati alla memoria.
Diversamente molti intellettuali, tra gli anni ’60 e ’80 del secolo scorso, lo presentarono– chi onestamente, chi con secondi fini – quale estremo rappresentante di una forma di‘cattolicesimo intransigente’ (i.e. integralista), in virtù, soprattutto, della lotta che eglicondusse, profeticamente, contro l’introduzione dell’istituto del divorzio all’interno del-l’ordinamento giuridico italiano.
Una lotta – portata avanti in prima persona, senza alcuna concessione al compro-messo politico, giuridico o etico, sfociata nell’insuccesso politico – che gli valse, singolar-mente, il rispetto soprattutto del mondo laico.
Le dense, documentate ma, soprattutto, acutissime pagine di Roberto Pertici – scritteda un autentico ‘pensatore laico’ – sono la dimostrazione di una singolare capacità di‘comprensione’ dell’essere Lombardi giurista, democratico, idealista (e, come tale, appunto,‘profeta’), per ciò stesso naturalmente destinato a restare ‘voce che grida nel deserto’ (ildeserto della desolazione umana) dalla sua stessa appartenenza politico-religiosa. Soprat-tutto laddove rivendicava al cristianesimo lo stesso diritto di introdurre nella dialetticademocratica i valori specifici di quel mondo, al pari di chi ne era estraneo, nella consapevo-lezza di accogliere il rischio di rendersi latore di esigenze minoritarie e, come tali, politica-mente (e perfino, va da sé, giuridicamente) ‘perdenti’.
Come ebbe a riferirmi Ferdinando Bona – dichiarando di non aver ben compreso,all’inizio, il senso profondo della battaglia civile condotta sul tema del divorzio – Lombardigli chiarì che l’approvazione di questo istituto avrebbe aperto la porta all’aborto e all’euta-nasia legalizzati, al suicidio assistito, al disfacimento dell’istituto matrimoniale e, in ultimaanalisi, della famiglia quale ‘società naturale’: attenzione, ‘naturale’ e non religiosa oconfessionale. Si era negli anni ’70 del secolo scorso...
Personalmente credo che la figura di Lombardi richiederà ancora molti anni per essereriscoperta – se mai lo sarà – poiché questo fenomeno potrebbe dipendere dalla riscoperta(integrale) del pensiero di Giuseppe Capograssi, maestro, amico, e anima ispiratrice delpensiero lombardiano. A quello si deve ad esempio – come scrive Pertici – la profonda inte-riorizzazione di Lombardi dell’esigenza di lottare contro i «quattro grandi mali sociali»ossia «la malattia, la morte da lavoro e da miseria, la disoccupazione, l’ignoranza».
Come non vedere anche in queste parole il riflesso di un umanesimo (cristiano) attivo epartecipe dell’epoca postbellica, che operò da sottofondo all’ispirazione di Giovanni XXIII– grande profeta del ventesimo secolo – nell’indizione di un Concilio ecumenico? Ma,
XXVI Roberto Pertici
1 Un popolo al bivio. Referendum sul divorzio frontiera di libertà, Comitato nazionale per il refe-
rendum sul divorzio, Roma 1972, 135 s. Per la questione del divorzio e la vicenda referendaria si
rinvia una tantum a PERTICI, Chiesa e Stato in Italia. Dalla Grande Guerra al nuovo Concordato (1914-1984), Bologna 2009, 526 ss., con la bibliografia precedente.
2 Per un primo approccio alla figura di Lombardi, cfr. CURSI, sv. «Lombardi, Gabrio», inDizionario biografico degli italiani 65 (2005) 478 ss., che raccoglie anche la non molta bibliografia
disponibile.
soprattutto, come non scorgere il valore ‘profetico’ di quelle parole, a mezzo secolo didistanza, nell’attuale contesto politico, culturale, economico, sociale, ricco (soltanto) dipovertà? Un mondo nel quale lo storico del diritto e della società romani scorge, inevitabil-mente, e anche con una certa rassegnazione – che non lo priva, però, dell’istinto di doveroperare qualcosa, in prima persona, persino al di là dei possibili risultati – il fenomeno(ciclico) della ‘caduta di un (altro) impero’?
1. – Il 1o dicembre 1970, il giorno stesso in cui la Camera dei deputati
approvava definitivamente la legge che introduceva l’istituto del divorzio
nella legislazione italiana, «venticinque personalità della cultura e della
scienza», in gran parte (ma non solo) cattoliche, pubblicavano un appello
per l’abrogazione di quella legge attraverso l’istituto del referendum
previsto dall’articolo 75 della Costituzione, nella convinzione – si affer-
mava – che «l’introduzione del divorzio non corrisponde alla volontà del-
la grande maggioranza degli italiani»: era perciò necessario chiamarli «ad
esprimere, con voto diretto e personale, la loro volontà in una materia
fondamentale quale quella della indissolubilità matrimoniale»1. Presidente
del comitato promotore era il giurista Gabrio Lombardi, professore di
diritto romano alla Statale di Milano e, fino a pochi mesi prima presi-
dente del Movimento Laureati di Azione Cattolica2. Nelle polemiche
infuocate degli anni successivi, fra i due schieramenti ma anche all’interno
del mondo cattolico, la sua figura divenne l’emblema della manovra refe-
rendaria e fu considerata come un concentrato di intransigenza clericale e
spregiudicatezza politica. Lombardi sopravvisse per due decenni alla
sconfitta del 12 maggio 1974, ma a differenza di altri promotori del-
l’iniziativa referendaria (si pensi a La Pira, Cotta e Del Noce) che seppero
rilanciare in qualche modo la propria immagine e partecipare attiva-
mente alla vita culturale degli anni successivi, Lombardi restò per sempre
fuori del gioco, emarginato anche dal mondo che era stato il suo: simbolo
di una sconfitta storica. L’onore delle armi gli fu tributato da pochi: fra
questi un liberale (e divorzista) come Nicola Matteucci, che fissò da subito
alcuni punti che possono essere utili ancora oggi per una riflessione sulla
sua figura e il suo itinerario:
La storia è iniziata con la raccolta delle firme per il referendum da parte delcomitato contro il divorzio guidato da Gabrio Lombardi, e si conclude in questimesi con la scesa in campo dei «cattolici democratici», i quali non si sono limitati aricordare che il voto è un fatto di coscienza, ma hanno fatto una frenetica campagna
XXVIIGabrio Lombardi e la questione del divorzio
3 MATTEUCCI, I mediatori cattolici, in Il Mondo, 23 maggio 1974. Che il discorso culturale dei
referendari «non fosse riconducibile semplicemente a un’idea “di destra”», che «non fosse espresso
in forme semplicisticamente antindustriali o di nostalgia per il mondo contadino» e che «nascesseanzi in taluno [S. Cotta] da una approfondita riflessione sul significato e sugli esiti ambigui, e
tuttavia da affrontare e dominare, della “sfida tecnologica”», sarebbe stato poi ammesso anche
da uno degli esponenti di punta dei ‘cattolici del no’, SCOPPOLA, La «nuova cristianità» perduta,Roma 19862, 131 s.
4 Come per LANARO, Storia dell’Italia repubblicana. Dalla fine della guerra agli anni novanta,Venezia 1992, 337.
a favore del divorzio. Tanto la prima, quanto la seconda iniziativa aveva come fine,consapevole o inconsapevole, quello di punire la Dc, o perché favoriva troppo lasocietà permissiva, o perché, accettando il referendum, si spostava a destra e si sepa-rava dai partiti che rappresentano le grandi masse popolari. [...] Secondo la tradi-zione geografica politica i due gruppi, che hanno contestato la Dc, si collocano l’unoa destra, l’altro a sinistra. Se, però, vogliamo formulare un giudizio un po’ menosuperficiale, e scendere al contenuto culturale delle opposte linee politiche di questidue gruppi, vedremo che quello che risulta a destra è più «laico» e più «democra-tico» di quello che milita esplicitamente a sinistra. Più laico, dato che le motivazioni,con le quali respingono il divorzio, non sono religiose ma sociologiche o, se si vuole,socio-morali, e nascono dalla considerazione dei pericoli cui va incontro, nell’etàtecnologica, la società permissiva. Gli altri, invece, si sono preoccupati, troppospesso, di dare motivazioni teologiche, ecclesiali o pastorali alla loro aperta propa-ganda per il divorzio, quasi per continuare il processo storico apertosi col ConcilioVaticano II. E questo corrisponde alla loro formazione culturale, che non è catto-lico-liberale, ma chiaramente integralista, anche se di sinistra. Il gruppo, che apparea destra, è anche più democratico, perché solo un sofista – e in Italia ne abbiamotanti – può dimostrare che il consentire al popolo di esprimersi, attraverso un istitutoprevisto dalla Costituzione, sia una scelta reazionaria. La stessa scelta del refe-rendum è stata fatta ora dai radicali3.
Dunque Matteucci, che lo conosceva bene, sottolineava lo sfondo
laico e cattolico-liberale del pensiero di Lombardi, le motivazioni non
primariamente confessionali, ma sociologiche (o socio-morali) del suo
impegno antidivorzista, il suo tratto fortemente «coscienziale». Per il libe-
rale bolognese questo complesso di posizioni non costituiva una «furberia
[...] per incamerare consensi fra gli indissolubilisti conservatori o acatto-
lici»4, ma proveniva da una storia di lunga data, di cui era stato in
qualche modo testimone.
Mi propongo qui di ricostruire proprio questo retroterra e delineare la
posizione culturale e religiosa di Gabrio Lombardi nella cultura italiana di
metà Novecento, per valutare poi la sua risposta ai cambiamenti vorticosi
del decennio successivo fino a quel «fatale» 1o dicembre 1970.
2. – Il 10 gennaio 1942, Pio XII riceveva in udienza la famiglia
Lombardi, guidata dal patriarca, il professor Luigi, allievo a Torino di
Galileo Ferraris, poi professore di fisica tecnica ed elettrotecnica all’uni-
versità di Napoli e infine di Roma, senatore dal 1939. L’accompagnava la
moglie Emma Vallauri, che negli anni Venti era stata presidente nazio-
nale delle Donne di Azione Cattolica, i figli e le figlie, alcuni già con le
XXVIII Roberto Pertici
5 ZIZOLA, Il microfono di Dio. Pio XII, padre Lombardi e i cattolici italiani, Milano 1990, 24, ma
anche 54 s., per l’udienza di Pio XII e più in generale 24 ss., per il retroterra familiare. Il
piemontese Luigi Lombardi si era trasferito a Napoli e aveva partecipato agli importanti dibattiti
del primo Novecento sul futuro del-l’industria elettrica e sul suo ruolo nello sviluppo del Mezzo-
giorno: cfr. la sua risposta del settembre 1902 al questionario in proposito di Nitti, ora in NITTI,
La conquista delle forze, in Scritti di economia e finanza, III.2, Bari 1966, 300 ss. e passim.6 LOMBARDI, Divorzio, referendum, concordato, Bologna 1970, 39, 5.
loro famiglie: in tutti quattordici persone. Al papa, che li aveva fatti
sedere a cerchio intorno alla sua scrivania, furono presentate le pubblica-
zioni scritte da alcuni dei sette figli: fra questi il gesuita Riccardo, che nel
dopoguerra italiano sarebbe diventato uno dei più celebri predicatori e
polemisti cattolici, il «microfono di Dio», come fu chiamato; Pia, futura
deputata democristiana nella prima legislatura e il più giovane, Gabrio
(nato nel 1913), promettente studioso di diritto romano. «Il clan – è stato
osservato – era borghese, cattolico-romano osservante ma con una vernice
di severità e di attivismo di taglio nord-europeo: un raro incrocio tra
regole comuni e individualismo, tolleranza e intransigenza, religione e
laicità, con tavole di valori adatte a selezionare la specie per ruoli di guida
e riservarle qualche citazione non marginale nella storia della società
italiana del Novecento»5.
Certo l’esperienza di ‘questa’ famiglia dovette essere sempre presente
a Lombardi: i suoi genitori provenivano da ambienti molto diversi (i
Vallauri avevano una cultura più laica e liberale dei Lombardi), avevano
età diverse e forse anche diverse ambizioni. Eppure, dopo il matrimonio,
avevano lasciato il Piemonte, si erano trasferiti a Napoli, dove avevano
messo su casa e dove presto erano arrivati uno dopo l’altro i numerosi
figli. La madre aveva affrontato il compito familiare «con il taglio d’una
vocazione totale» (è ancora Zizola ad osservarlo), eppure era riuscita
anche a dedicarsi ai problemi sociali e a quelli femminili, scrivendo e
impegnandosi in associazioni e comitati. Quando, molti anni dopo,
Lombardi scriverà che «l’incontro matrimoniale è la più impegnativa e la
più grande avventura cui creature umane possano collaborare» e –
citando Capograssi – definirà matrimonio e famiglia come «una vera
organizzazione di sacrificio», che tuttavia risponde a un’esigenza perenne
dell’individuo, quella di «sacrificare la propria tendenza di licenza e di
vagabondaggio, la propria ripugnanza a rimanere prigioniero di una rete
di doveri e di responsabilità»6, ripeteva certamente posizioni tradizionali
della dottrina cattolica, che tuttavia corrispondevano – nel suo caso – a
esperienze di vita vissuta.
Gabrio seguì la famiglia a Roma e, dal 1923 al 1930, quindi dai dieci
ai diciassette anni, fu alunno dell’Istituto Massimiliano Massimo alle
Terme, fondato nel 1879 dopo che i padri gesuiti avevano dovuto lasciare
il Collegio Romano, divenuto Liceo classico statale Ennio Quirino Visconti.
XXIXGabrio Lombardi e la questione del divorzio
7 MASSARUTI S.I., Da Te consolato con Te consolatore, a cura di G. Lombardi, Milano 1975.8 LOMBARDI, Federico Ozanam (nel 150o dalla nascita), in Testimoni di libertà, con Introduzione di
VALDITARA, Roma 2005, 77 s. Il saggio è del 1963, la prima edizione del volumetto risale al
1968 (Brescia).9 CASAVOLA, Individuo, politica, libertà, in Studium 62 (1994) 497 (necrologio di Lombardi).
Dell’ambiente dell’istituto e della formazione che almeno i migliori alunni
vi ricevevano, egli ha lasciato una testimonianza veramente notevole,
pubblicando nel 1975 i diari del p. Giuseppe Massaruti, che – per oltre
mezzo secolo – ne era stato uno degli animatori7. Attivismo e centralità
della coscienza: questi sembrano essere stati i poli della sua formazione
gesuitica. Così il giovane prese parte alle varie associazioni che affianca-
vano l’attività didattica (la Lega missionaria, l’Azione cattolica, il Ristretto
dei XII apostoli); soprattutto avrebbe più volte sottolineato l’importanza
della partecipazione attiva alla Conferenza di San Vincenzo del Massimo
e al suo impegno caritativo: «I miei anni universitari, le squallide borgate
alla periferia di Roma – sono stati anni decisivi, nella mia vita: apertura
agli orizzonti sconfinati della sofferenza e della miseria»8. Ma imparò ad
esercitare anche una cura assidua, quasi spasmodica, dell’interiorità,
un’analisi continua della propria coscienza, da cui derivava poi una
fermezza assoluta, una volta che la scelta era stata compiuta, appunto, «in
coscienza»: «Uomo straordinariamente gentile, di una cortesia aristocra-
tica – così lo avrebbe ricordato un collega e un amico – eppure infrangi-
bile e inattingibile nelle sue convinzioni ove non fossero già condivise.
Dialogante per dovere di metodo, ma non disposto ad arrendersi agli
interlocutori. Ripeteva talora i suoi concetti con lo stesso fraseggio, dando
l’impressione, con l’impostare la voce su toni sottili, di aver esaurito per
stanchezza ogni risorsa dialettica. In realtà la sua era intransigenza
morale, non chiusura intellettuale. Quando sentiva troppo distanti le
opinioni altrui, si limitava a riconfermare le proprie per un debito di lealtà
verso se stesso e verso gli altri»9.
3. – Nel 1931 l’ingresso all’università di Roma, facoltà di giurispru-
denza, e l’incontro con Pietro de Francisci: «Maestri insigni salivano le
cattedre della Sapienza. Ma quel giovane professore che parlava del
diritto pubblico di Roma antica segnò la mia vita». De Francisci era non
soltanto uno dei maggiori storici ed esegeti del diritto romano allora
viventi, ma anche un importante uomo pubblico. Iscritto al Pnf dall’a-
prile 1923, eletto deputato nel 1929, fu ministro di grazia e giustizia dal
luglio 1932 al gennaio 1935, quindi proprio negli anni universitari di
Lombardi.
Tornato all’insegnamento, venne nuovamente nominato rettore del-
l’università romana nel 1935 (lo era già stato negli anni Venti) e nel 1937
successe a Gentile alla presidenza dell’Istituto nazionale di cultura
XXX Roberto Pertici
10 LOMBARDI, Ricordo di Pietro de Francisci (1883-1971), in SDHI. 37 (1971) IX, e XIV. Di
grande rilievo il suo successivo profilo Pietro de Francisci, in SDHI. 39 (1973) 1 ss. Con tutta proba-
bilità si deve alla mediazione di de Francisci la collaborazione di Lombardi al Dizionario di politica,pubblicato in quattro volumi dal Partito nazionale fascista agl’inizi del 1940, ma in gestazione
almeno dal 1936 (cfr. A. Pedio, La cultura del totalitarismo imperfetto. Il «Dizionario di politica» del Partitonazionale fascista (1940), Milano, Unicopli, 2000, pp. 33n, 257). Egli fu redattore delle seguenti
voci: Censori, Centumviri, Civitas, Clienti, Comizi, Console, Decemviri, Edili, Fasti capitolini, Interregnum,
Municipium, Plebe, Pretore, Princeps, Puniche guerre, Questore, Roma (Lo sviluppo costituzionale), Scienza.Mentre più marginale fu la collaborazione del Maestro, che contribuì con le seguenti: Cesare,Impero (I. L’impero di Roma), Roma (La civiltà di Roma). Com’è noto, al Dizionario collaborarono
alcuni dei più bei nomi della cultura italiana, fascisti, semifascisti, afascisti, imminenti antifascisti
(Chabod, Cantimori, Jemolo, Morandi, Maturi, Sestan, etc.), ma spesso i loro contributi non
presentano un carattere «militante»: anche se resta significativa (specie per quelli già accademi-
camente affermati) l’adesione all’iniziativa. Sarebbe auspicabile che uno studioso di diritto
romano prendesse in esame i contributi di Lombardi e magari tutte le voci romanistiche del
Dizionario. Ancora per rispondere a un invito di de Francisci fu dovuta la collaborazione nel 1939
a «Civiltà fascista», organo dell’Istituto nazionale di cultura fascista, di cui egli era presidente dal
1937 (ma ad essa continuavano a collaborare anche studiosi giovani e meno giovani – da Giorgio
Candeloro a Cantimori – che allora certamente fascisti non erano o non erano più).11 GENTILE, Le religioni della politica. Fra democrazie e totalitarismi, Roma-Bari 2001, 134 s.
fascista, entrando nel direttorio nazionale del partito. Lombardi apprese
da de Francisci i fondamenti della scienza romanistica e sotto la sua ala
compì i primi passi della attività scientifica, ma fu sempre diviso da lui da
un dissenso politico di fondo. Ne scriveva l’8 novembre 1944 al presidente
della commissione per l’epurazione del personale universitario, che aveva
allontanato dalla cattedra il suo maestro:
Sapeva perfettamente quali fossero le mie idee nel campo politico e qualeprofonda avversione nutrissi per tutto quanto il fascismo aveva posto a fondamentodella vita nazionale. Eppure, lungi dal cercare di modificare il mio atteggiamentospirituale, ha sempre incoraggiato ogni mia ricerca tendente a lumeggiare – sotto ilregime fascista – la perennità degli schemi ideali della res publica romana. [...]Ritengo che un grande maestro dei decenni aurei del liberalismo non avrebbepotuto tenere più nobilmente un corso universitario10.
Come altri studiosi che gli sarebbero stati a fianco nella battaglia anti-
divorzista (si pensi ancora a Cotta, La Pira, Del Noce), Lombardi non era
stato affatto un «clerico-fascista», ma aveva anzi un passato antifascista di
tutto rispetto, in questo distinguendosi anche da altri membri della sua
famiglia (come il padre o il fratello Riccardo) che invece avevano vissuto i
propri «anni del consenso». Se si scorre la sua prima produzione romani-
stica, si intuisce il nocciolo del suo antifascismo: è la polemica contro la
«statolatria» che in quegli anni risuona in importanti documenti pontifici
e nella pubblicistica cattolica più impegnata. Ma mentre nei numerosi
interventi di Pio XI questa esigenza dei «limiti dello Stato» non è ancora
motivata da una «generale avversione al principio antidemocratico»11,
quanto dalla minaccia che i nuovi Stati «onnipotenti» costituiscono per la
XXXIGabrio Lombardi e la questione del divorzio
12 MASSARUTI S.I., Da Te consolato con Te consolatore cit. 186.13 LOMBARDI, Gaetano Scherillo (1905-1970), in SDHI. 36 (1970) 579.14 LOMBARDI, Italia!, Roma 1945, 36: si tratta di uno straordinario libretto autobiografico
sull’estate-autunno 1943.
«libertà della Chiesa», Lombardi ne ricava da subito un modello di Stato
alternativo a quello fascista. Per lui, il costituzionalismo moderno ha una
preistoria nella repubblica romana: così nella sua storia dell’espansione
italica e mediterranea di Roma si può leggere in filigrana la distinzione fra
lo «Stato di diritto» basato sul binomio «osservanza dei limiti-libertà» (lo
Stato repubblicano pre-augusteo) e lo «Stato personale» di Augusto, che
sostanzialmente travalica quei limiti e non ammette zone franche rispetto
alla volontà del principe. Come vedremo, tale distinzione sarà al centro
del suo discorso politico-religioso degli anni post-bellici.
4. – Ufficiale d’artiglieria di stanza a Roma, Lombardi visse in prima
persona la lunga estate del ’43: il 19 luglio, il giorno del primo bombarda-
mento sulla capitale, «prima di mezzogiorno – non ancora suonato il
cessato-allarme – [...] era stato a S. Lorenzo con i suoi soldati, per
iniziare i lavori di soccorso. [...] Dopo quasi trent’anni rivivo l’impressione
dei primi cadaveri estratti, così impastati di polvere che sembravano
mummie: di secoli o di millenni»12. Poi la caduta del fascismo e l’8
settembre: negli anni del dopoguerra, ripeté più volte che per lui e per
quelli della sua generazione, «l’8 settembre 1943 aveva diviso la vita in
due: un prima, e un poi. [...] L’armistizio non si poteva non concludere,
soprattutto dopo che la Germania aveva chiaramente dimostrato di volere
condurre la sua guerra, senza minimamente prendere in considerazione le
ragioni dell’Italia; ma peggio non si poteva concludere. Un peggio in cui
confluirono le manifeste incapacità dei responsabili italiani e la gretta
ottusità dei responsabili anglo-americani»13.
La mattina di sabato 11 settembre, mentre si spengevano gli ultimi
combattimenti nella capitale, fu raggiunto da una telefonata del p. Massa-
ruti: «una motocarrozzetta tedesca è passata: facendo fuoco. Ha ucciso
tre persone, sulla soglia del Massimo. Il padre Rettore è accorso per dare
l’assoluzione; non ha fatto in tempo. Ora stanno lavando il sangue.
“Scusa, sai... ma non fate nulla?”. La domanda, tanto discreta – avrebbe
ricordato poi Lombardi – raggiunge il vivo; quasi una sferzata»14. Allora
l’ufficiale trentenne decise che qualcosa bisognava fare: attraversò le linee
in Abruzzo e raggiunse Brindisi per riprendere servizio: era il 23 ottobre.
Fu assegnato all’Ufficio informazioni del Comando supremo, dove svolse
soprattutto due compiti: quello di collegamento attraverso messaggi
quotidiani col fronte clandestino di Roma guidato dal colonnello
Giuseppe Cordero di Montezemolo fino alla sua cattura il 25 gennaio
XXXII Roberto Pertici
15 LOMBARDI, Montezemolo e il fronte militare clandestino di Roma (ottobre 1943-gennaio 1944), Roma
1947.16 LOMBARDI, L’8 otto settembre fuori d’Italia, Milano 1966, 7 s. Ma v. anche almeno ID.,
L’eccidio di Cefalonia narrato dal cappellano padre Formato, in Coscienza 22 (1968), 300 ss. (novembre).17 «Ma quando vicende più grandi della volontà del singolo individuo portarono alla caduta
della dittatura e all’armistizio con gli angloamericani, la situazione che venne a determinarsi
nella Penisola – nella sua complessità e contradittorietà – costrinse crudamente il singolo a pren-
dere coscienza degli avvenimenti, stimolandolo individualmente a una scelta che poteva,
comunque, risultare mortale. Proprio perché potenzialmente mortale, la scelta, i più scelsero di nonscegliere, predisponendosi abilmente l’alibi da offrire al vincitore, di nulla avere scelto, essi. Ma
molti scelsero, fortunatamente, con un atto personale di volontà. E non conta, in questa sede –
spero il lettore comprenda – quale fosse oggettivamente la scelta giusta e quale la scelta errata. Ciò
che conta è che una scelta fu fatta da larghi strati della popolazione italiana; può dirsi, in certo
senso, da tutti gli italiani, perché anche coloro che scelsero di non scegliere, in definitiva avevano scelto»(LOMBARDI, La croce nella città, Roma 1957, 37).
194415 e l’altro di cercare di seguire, «attraverso la radio e le molteplici
informazioni, la tragedia dei nostri militari che, trovatisi all’atto del-
l’armistizio fuori d’Italia, si erano rifiutati di collaborare con i tedeschi:
sottrattisi all’internamento in Germania, avevano affrontato ogni sacri-
ficio pur di conservare la libertà, possibilmente collaborando alla lotta
contro i tedeschi». La ‘sua’ Resistenza fu dunque quella dell’esercito rego-
lare sbandatosi nelle varie zone d’occupazione, dei militati internati in
Germania, dell’esercito che riuscì a ricostituirsi nel Regno del Sud: ad
essa – per mezzo secolo trascurata dalla storiografia accademica a favore
di quella più politicizzata delle formazioni partigiane – egli invece dedicò
lunghe ricerche «nel desiderio di rendere testimonianza alle migliaia di
fratelli che in quelle circostanze dolorose non avevano indietreggiato
dinanzi alla morte»16 e alcuni lavori di ricostruzione assolutamente pionie-
ristici per i tempi in cui furono pubblicati.
Sulla scelta che molti allora compirono, rifletté poi a lungo proiettan-
dola sul lungo periodo della storia italiana, con accenti che solo molti
decenni dopo sarebbero riecheggiati nella storiografia: il carattere di
«guerra civile» di quello scontro, l’esistenza di un’ampia «zona grigia», la
«moralità» di coloro che tuttavia fecero una scelta e scesero in campo, indi-
pendentemente dal fatto che compissero la scelta giusta o quella errata17.
Ecco – aggiungeva – in quale senso, sopratutto, considero positiva l’esperienzadella Resistenza. Tragica prova, indubbiamente, per un popolo; ma proprio perchéprova, via al tempo stesso di maturazione. Ricordo l’affermazione paradossale di unamico: l’unica guerra veramente «civile» sarebbe la guerra civile, perché è l’unica incui a ciascun singolo è offerto di scegliere la sua parte. Dalla seconda guerra mondialeil popolo italiano è uscito frantumato nella sua unità spirituale: polverizzati, permolti, gli ideali che avevano alimentato, quasi comune denominatore, la vita e isacrifici delle passate generazioni. D’accordo. Ma non erano quelli, in buona partealmeno, ideali di comodo passivo, se con troppa facilità si sono polverizzati al vento dellabufera? Si pensi, per esempio, allo spettacolo offerto da ufficiali superiori e da gene-rali, dopo l’8 settembre! E non siamo sicuri, tutti, che, in circostanze non dissimili da
XXXIIIGabrio Lombardi e la questione del divorzio
18 LOMBARDI, La croce cit. 38.19 LOMBARDI, La spiritualità di Giuseppe Capograssi, in Testimoni di libertà cit. 137, 139. L’opera
maggiore che Lombardi dedicò a Capograssi fu l’edizione dei suoi Pensieri a Giulia, pubblicati in
tre volumi nel 1978-81, presso l’editore Giuffrè e introdotti da un suo amplissimo studio biogra-
fico. Cfr. ora CAPOGRASSI, Pensieri a Giulia 1918-1924, a cura di G. Lombardi, Prefazioni di SAVA-
RESE, Milano 2007: spec. XLV ss., per l’Introduzione di Lombardi, ma notevole anche il
necrologio del 1956, ora in LOMBARDI, Testimoni di libertà, cit. 137 ss. Di scarsa utilità il vol. di
PARRINO, La lezione di Capograssi nella vita e nell’opera di Gabrio Lombardi, C. Vasale Roma 2005.20 JEMOLO, Prefazione a CAPOGRASSI, Introduzione alla vita etica, a cura di C. Vasale Roma
1976, 3. Per un primo approccio alla figura di Capograssi, cfr. Due convegni su Giuseppe Capograssi(Roma-Sulmona 1986), L’individuo, lo stato, la storia. G. Capograssi nella storia religiosa e letteraria del nove-cento, atti a cura di F. Mercadante, Milano 1990. Una serie di brani tratti dalle lettere a loro
inviate da Capograssi furono raccolti da amici e allievi in CAPOGRASSI, Pensieri dalle lettere, Roma
1958: frequenti sono quelle a Lombardi.
quelle della prima guerra mondiale, quei medesimi ufficiali si sarebbero comportatidecorosamente?18
5. – Eppure il mondo morale di Lombardi risultò plasmato ancora
più decisamente da un rapporto umano, che fu al tempo stesso anche filo-
sofico e religioso: quello con Giuseppe Capograssi, uno dei maggiori filo-
sofi del Novecento italiano. Lo aveva conosciuto all’università :
«Primavera 1932, aula affollata della vecchia Sapienza, a Roma. Esercita-
zioni di Filosofia del diritto. Un piccolo uomo apparentemente da nulla
parlava, con accento insolito alle nostre orecchie di matricole cresciute nel
clima della rivoluzione, dell’individuo e dello Stato». Più di trent’anni dopo,
al momento della sua morte, si sarebbe domandato: «Come si spiega che
per centinaia di amici – molti con i capelli bianchi, molti tra i più signifi-
cativi maestri delle Università italiane – la scomparsa del piccolo uomo
apparentemente da nulla ha cambiato la vita?»19.
Non è facile definire il ‘debito’ di Lombardi verso il pensatore abruz-
zese, tanto questi è presente di continuo nei suoi scritti fino agli ultimi
anni. Capograssi è stato definito un «Socrate cattolico»20: i suoi scolari
costituivano una specie di koinonìa, che si riuniva quasi quotidianamente
nel salottino della sua casa romana di via Mazzini e discuteva col maestro
fino all’ora di cena, praticamente di tutto. Nei periodi di lontananza il
rapporto diventava epistolare, risultando altrettanto ricco e decisivo per i
suoi interlocutori.
Per Lombardi, Capograssi fu soprattutto il filosofo dell’individuo, dei
suoi bisogni, della sua avventura: non l’astrazione che si ritrova in molto
pensiero liberale, ma «questo povero trascurabile impercettibile indi-
viduo, che alla fine è e resta il soggetto di tutta la vita, e che [...] è l’autore
inconsapevole di tutte le variazioni della storia». Di fronte a lui lo Stato
deve avere una funzione meramente «strumentale»: esiste cioè solo per
soddisfare alcune delle sue esigenze fondamentali. Quelle, soprattutto,
della giustizia e dell’uguaglianza: si tratta di liberare l’umanità dai «quattro
grandi mali sociali» ancora largamente presenti (la malattia, la morte da
XXXIV Roberto Pertici
21 LOMBARDI, La spiritualità di Giuseppe Capograssi cit. 103 ss.
lavoro o da miseria, la disoccupazione, l’ignoranza); di rimuovere la
sperequazione nei punti di partenza della vita; di superare l’alienazione
del lavoro nella grande fabbrica. Ma lo Stato deve anche predisporre un
ambiente per quanto possibile favorevole e incoraggiante, in cui l’indi-
viduo possa in piena autonomia evadere dalla mera dimensione sociale e
trovare rapporti disinteressati e gratuiti (Capograssi lo chiamava il momentodell’amicizia); per poi superare la dimensione puramente terrena ed entrare
in un rapporto verticale con la divinità (il momento della speranza). Uno Stato
che provveda all’uguaglianza, ma renda l’individuo un essere puramente
sociale, lo privi dello «spazio libero» in cui sviluppare autonomamente la
sua personalità e tentare l’esperienza di Dio, è per Lombardi inaccetta-
bile: questo probabilmente per lui, l’insegnamento fondamentale di Capo-
grassi.
Ma quella di Dio non può essere un’esperienza puramente indivi-
duale: l’umanità partecipa alla vita divina grazie alla Chiesa. Essa «viene
a proporre e a dare risposta al problema inevitabile del destino del-
l’individuo e dell’universo, del valore della vita: il problema del finito, del
dolore, del male, della morte, della speranza e della disperazione, vale a
dire semplicemente il problema di Dio». Pur accettando la struttura
gerarchica della Chiesa cattolica, Capograssi (e con lui Lombardi) sottoli-
neava il ruolo di ciascun credente all’interno dell’istituzione:
Ognuno di noi porta la responsabilità della Chiesa. La Chiesa ha la promessainfallibile, a cui la storia obbedisce fedele; ma si tradisce questa promessa, se uno siabbandona ad essa come ad una gratuita e automatica assicurazione. Questapromessa si attua attraverso la vita nostra: attuare questa promessa costituisce ilnostro dovere. Ognuno ha la responsabilità della Chiesa, cioè del mondo, cioè del-l’umanità. Bisogna certo fare l’apologetica della propria fede, ma, non è il caso diilludersi, essa non consiste nello scrivere saggi o articoli (come il presente!), o peggiolibri. La sola apologetica, che è efficace per questi tempi, siamo noi e solo noi. E nelquadro delle nostre responsabilità di fronte alla Chiesa, di una cosa dobbiamopersuaderci: che la lotta per la Chiesa si combatte in questo solo modo essenziale,vivere e vivere fino in fondo la verità che si dice di credere21.
È evidente il bisogno di assoluta coerenza che nasceva da una tale
impostazione: il cristianesimo era concepito da Lombardi come difesa
integrale dei valori umani, difesa che si realizzava soprattutto in una
coerente testimonianza. Tale coerenza era richiesta a maggior ragione
all’intellettuale cattolico: inserendosi nelle interminabili discussioni degli
anni Cinquanta sul ruolo dell’intellettuale nella società contemporanea,
egli gli indicava il dovere di «resistere in noi e intorno a noi, per noi e per
tutti gli altri, a ogni forma di settarismo, a ogni forma di conformismo»:
«Bisogna essere disposti alla solitudine, alla povertà, pur di non cedere
alle tanto facili lusinghe che compiacentemente oggi offrono i potenti, i
XXXVGabrio Lombardi e la questione del divorzio
22 LOMBARDI, La libertà dell’uomo di cultura contro ogni settarismo, contro ogni conformismo, Roma
1959, 34. Si tratta di una relazione svolta al convegno Cultura e libertà, organizzato da una serie di
riviste cattoliche a S. Margherita Ligure (9-11 ottobre 1959).
quali domani – padroni o padroncini – chiederebbero in dovuta obbe-
dienza il saldo della cambiale»22.
6. – Per Lombardi l’antifascismo non poteva costituire il momento
conclusivo della lotta per la democrazia: essa doveva ora continuare su
altri fronti, particolarmente contro il comunismo sovietico e i partiti occi-
dentali ad esso legati. Da qui un vivace e costante anticomunismo, che lo
avvicina singolarmente ai cold war liberals degli anni Cinquanta e a una
cultura cattolica che potremmo chiamare «antitotalitaria» o «centrista» o
«degasperiana», per distinguerla da quella della «seconda generazione»
che si sarebbe impadronita del «partito cristiano» dopo il tramonto di De
Gasperi. Per Lombardi, come per tutti quegli ambienti, il comunismo
continuava a essere il problema di fondo dell’epoca, sia da un punto di
vista culturale che politico, ed era rispetto ad esso che appariva neces-
sario, in qualche modo, definirsi.
Nel libro, che costituisce il prodotto più organico della sua riflessione
di quegli anni, pone subito il problema: «La situazione dell’Italia 1957
presenta aspetti contradittori che lasciano perplesso l’osservatore. Da un
punto di vista religioso, la massima parte della popolazione italiana si
dichiara cristiana e cattolica. Da un punto di vista strutturale, l’Italia
procede, da dodici anni, nei termini di una democrazia. Eppure vive e
prospera, nella società italiana, il comunismo che è intrinsecamente contra-
dittorio, così con il cristianesimo, come con la democrazia». L’anticomu-
nismo tradizionale non è servito a sradicarlo né a ridimensionarlo:
certamente è importante intervenire per superare la «situazione di insicu-
rezza e di ingiustizia sociale, ancora largamente diffusa in Italia; situa-
zione che è il terreno fecondo sul quale facilmente fa presa il comunismo.
Dall’altro lato la repressione di quanto di illegale e di antigiuridico il
comunismo fa o tenta di fare». Ma l’esperienza dell’ultimo decennio
dimostra che tutto ciò non basta.
Per Lombardi la larga presenza del comunismo nella società italiana
dipende da un’insufficienza di educazione democratica e (per lui è equiva-
lente) cristiana. Il cristianesimo come si è plasmato in Italia nella prima
metà dell’Ottocento, dopo il trauma rivoluzionario, è stato – da un punto
di vista politico – «legittimista» e «quietista», prestando un appoggio
sostanziale agli Stati restaurati e concentrandosi «sulla così detta vita
privata del singolo, ponendosi prevalentemente l’accento su una serie di
divieti di fare: i divieti cioè di peccare. [...] Tutto questo ha finito per presen-
tare alle coscienze un cristianesimo mortificato, perché sacrificato nel suo
XXXVI Roberto Pertici
23 LOMBARDI, La croce cit. 17 ss.24 LOMBARDI, Civismo, Bologna 1960; ID., Alcune riflessioni sull’insegnamento della educazione
civica, ivi.
respiro. Circoscritto prevalentemente ai problemi di morale individuale, il
cristianesimo degli italiani della prima metà dell’Ottocento ha ignorato la
carica di socialità che è nel Vangelo».
Questa estraneità alla dimensione pubblica e statale si è accresciuta in
seguito al «delinearsi e al precisarsi della “questione romana” che può
ritenersi abbia inciso, nella storia dei decenni successivi, assai più di
quanto solitamente si creda; ed è già molto» e poi nel periodo del-
l’opposizione cattolica; per cui solo a fatica il cattolicesimo italiano ha
potuto avvertire la problematica dello Stato ed elaborare una coscienza
democratica, la consapevolezza, cioè, della piena rispondenza fra i prin-
cipî cristiani e quelli della moderna democrazia. Analoga difficoltà ha
incontrato in Italia il liberalismo post-risorgimentale: il suo carattere
inevitabilmente elitario e notabilare restrinse la vita politica ad «una
ristretta cerchia di individui, spesso spiritualmente mediocre, che la morti-
ficò in periferia, degradandola prevalentemente in funzione della clientela
personale: nulla facendo, o quasi, per una penetrazione nel corpo sociale,
di consapevolezza civica e politica»23.
Come si vede si trattava di motivi che da decenni una diffusa pubblici-
stica aveva già messo in luce per spiegare l’«immaturità democratica» del
popolo italiano e anche il rimedio non era originale: era compito degli
uomini di cultura promuovere una tale educazione, anche attraverso gli
strumenti che il nuovo Stato democratico metteva loro a disposizione. Fra
l’altro – dopo l’introduzione dei programmi di educazione civica nella
scuola secondaria da parte di Aldo Moro ministro della pubblica istru-
zione nel 1958 – Lombardi fu uno dei primi a impegnarsi su questo
fronte, elaborando subito uno strumento didattico che ebbe una certa
fortuna per tutti gli anni Sessanta24.
7. – L’originalità della sua posizione è altrove: nel modo in cui lega
indissolubilmente i valori democratici con l’esperienza storica del cristia-
nesimo. Qui riemerge lo storico del diritto romano: la «libertà dei
moderni», per lui, nasce nei secoli delle persecuzioni contro le comunità
cristiane da parte degli imperatori romani. Quello romano-imperiale – lo
abbiamo visto – era uno «Statopersona» che non riconosceva alcuna sfera
di autonomia all’individuo: rivendicando, invece, un «dominio riservato»
alla coscienza, nella fattispecie il diritto di praticare la propria religione
senza prestare alcun ossequio formale alla religione dello Stato, il cristia-
nesimo ha elaborato per primo una distinzione fra potere civile e potere
religioso, che nel linguaggio moderno si chiama «laicità». Che questa
XXXVIIGabrio Lombardi e la questione del divorzio
coscienza si sia spesso appannata nel corso dei secoli successivi, che la
Chiesa abbia tentato di fare dello Stato un instrumentum salvationis(rischiando di diventare a sua volta un instrumentum regni), non può occul-
tare questo dato storico: cioè l’origine cristiana dei moderni concetti di
«laicità» e «libertà». La «libertà», nella elaborazione di Lombardi, corri-
sponde quindi a quella liberale (libertà da): «nel senso cioè che l’individuo
abbia una certa area di autonomia entro la quale poter esercitare una
propria facoltà di scelta» e che tale «area di autonomia sia garantita, nel
senso cioè che non dipenda [...] dalla fantasia o dall’arbitrio del capo».
La libertà positiva (libertà di) che rivendica consiste quindi essenzialmente
in quella di compiere il proprio dovere: è la figura di Tommaso Moro che
incarna ai suoi occhi la dialettica della libertà cristiana o – che è lo stesso
– della libertà moderna.
Proprio per questo i cristiani, nella loro azione politica, non possono
non optare decisamente per lo «Stato di diritto», insomma per la demo-
crazia, e per lo Stato «laico», in cui cioè venga operata una «sostanziale
distinzione tra problematica orizzontale e problematica verticale», fra le
questioni politico-sociali e quelle religiose. Lo «Stato di diritto», tuttavia,
consiste fondamentalmente in una serie di regole del gioco e di procedure:
è «una delicata e sottile costruzione giuridica aperta: non è, sotto un determi-
nato profilo, che uno schema, una intelaiatura, suscettibile di ricevere conte-nuti diversi. Tanti, i contenuti, quante sono le sfaccettature che – nel
rispetto garantito della libertà individuale – possono darsi al così detto
bonum commune, e ai mezzi concreti per la sua attuazione». Tali conte-
nuti gli derivano dalle diverse visioni del mondo e della storia che sono
presenti nella società e dalla loro libera gara: la visione liberale, la socia-
lista riformista, la comunista rivoluzionaria. Anche la cristiana: il cristia-
nesimo, infatti, – oltre a essere una soluzione della problematica verticale
individuo-Dio – può essere considerato una «visione del mondo e della
storia», che determina anche concrete implicazioni sul piano orizzontale
della struttura giuridica della società politica.
Lombardi mostra di credere che tali implicazioni non siano un
complesso articolato e organico: non parla mai quindi di «dottrina sociale
della Chiesa». Tende insomma a lasciare aperta la gamma delle scelte poli-
tiche del cristiano (la sola incompatibilità è quella con le ideologie totali-
tarie e le loro incarnazioni storiche). Tuttavia si dice convinto che per lui
«un minimum di valori da rispettare e proteggere – sul piano orizzontale,
alla luce del piano verticale – sia individuabile e quindi enumerabile»: sono
quelli la cui negazione implica «un sostanziale rinnegamento dell’amore»
(i cosiddetti «peccati mortali»). Se lo Stato impone tale rinnegamento
(prevede, per esempio, la sterilizzazione coattiva), si opera una «frattura
violenta» fra il cristiano e lo Stato e il primo ha il diritto-dovere di disobbe-
dire: come gli antichi cristiani di fronte all’ordine di sacrificare all’impera-
XXXVIII Roberto Pertici
25 LOMBARDI, La croce cit. 16, 136, 168, 178. L’interesse per la figura di Tommaso Moro è
testimoniato in ID., San Tommaso Moro e la libertà, in Testimoni di libertà cit. 55 ss.
tore. Qualora il «peccato mortale» venga solo legittimato (e qui Lombardi
allude esplicitamente all’introduzione del divorzio), tale frattura non si
opera, perché il cristiano, anche se esiste il divorzio, può non ricorrevi.
Ma ciò non implica un atteggiamento di accettazione rassegnata:
nelle moderne democrazie è la libera gara delle opinioni e delle posizioni
che domina la vita sociale. A determinare la loro struttura «liberamente
concorrono tutti i cittadini-elettori, portando più o meno consapevol-
mente [...] il riflesso della loro più o meno chiarita o unitaria visione del
mondo e della storia». Il cristiano può quindi partecipare a tale libera
gara, portandovi le proprie idee e le proprie aspirazioni «terrene»: ma
accettando le regole del gioco, quindi anche la possibilità di restare in
minoranza, ove questo risulti dal computo delle volontà liberamente
espresse. Tutto dipende, in ultima istanza, dal «maggiore o minore cristia-
nesimo presente nel corpo sociale che può tradursi in maggiore o minore
corrispondenza delle strutture giuridiche della società alle implicazioni
orizzontali del cristianesimo». Ecco perché nel 1957, Lombardi si diceva
convinto che «la democrazia fosse strada aperta a un più intenso lievitare
del cristianesimo»: perché in essa i valori cristiani potevano trovare modo
di affermarsi non per l’imposizione di un principe, ma attraverso la
«libera volontà dei cittadini»25.
8. – Come reagì questa prospettiva «antitotalitaria» ai grandi cambia-
menti degli anni Sessanta che comportarono un complessivo dérapage asinistra non solo del quadro politico, ma anche dell’intero contesto cultu-
rale e religioso? Conviene a proposito operare una qualche periodizza-
zione: distinguere cioè la prima metà di quel decennio (l’avvio del
centro-sinistra e, in campo religioso, lo svolgimento del concilio ecume-
nico Vaticano II) dalla seconda (l’inquieta stagione post-conciliare e il
Sessantotto).
Va innanzitutto ricordato che per Lombardi l’unità politica dei catto-
lici non era un dogma, ma una questione di opportunità politica: così in
Italia, «ove il pericolo del prevalere numerico di chi si ispira al materia-
lismo dialettico è talmente imminente [...], che sembra opportuno
agiscano unitariamente su piano politico quanti intendono vivere e difen-
dere a un tempo il cristianesimo e la democrazia». Ma il partito
«cristiano» doveva dare delle garanzie: «difendere, nei termini della
democrazia, i valori essenziali del cristianesimo», «rispondere quanto più
intensamente possibile all’anelito di eguaglianza», avere una classe dirigente
XXXIXGabrio Lombardi e la questione del divorzio
26 LOMBARDI, La croce, cit. 206 ss. In ID., Riflessioni sulla elezione del Presidente, in Coscienza 19
(1965) 1 s. (gennaio), affermava espressamente che «il partito unico dei cattolici risulta, in termini
di principio, un equivoco: nel senso che la visione cristiana del mondo e della storia è talmente
liberatrice della personalità dell’individuo, che esclude la possibilità che tutti i cattolici di un paese
concordino in quelle specificazioni applicative che necessariamente caratterizzano un concreto
partito politico, nelle specifiche condizionature di spazio e di tempo»: l’opzione per il partito
unico era giustificata dalla situazione contingente e milioni di cattolici italiani, nel votarlo, compi-
vano «un sacrificio».27 Sul già ricordato convegno di S. Margherita Ligure (cfr. supra, nt. 22) qualche cenno in
TASSANI, La cultura politica della destra cattolica, Roma 1976, 4950; sul problema della programma-
zione economica, cfr. LOMBARDI, La croce cit. 198 ss.; sul problema della scuola, cfr. ID., La libertàdella scuola nel quadro della Costituzione italiana, Roma 1964; sulla sentenza del tribunale di Liegi che
nel 1962 assolse i coniugi Vandeput dall’accusa di omicidio volontario per avere ucciso nel sonno
la figlia focomelica (la madre in gravidanza aveva assunto il talidomide), cfr. ID., La sentenza diLiegi, in Studium 58 (1962) 811 ss.
28 LOMBARDI, Prefazione a RIVA, La Chiesa incontra gli uomini: la IVa Sessione del Concilio ecumenico,Brescia 1966, 11.
che vivesse quei valori, nella vita pubblica come in quella privata, realiz-
zare al suo interno «la più scrupolosa democraticità». Sono indizi abba-
stanza precisi di una sua non piena identificazione con la Dc e con la sua
politica e di una sua adesione «per motivo di opportunità contingente»26.
Non mi è capitato di trovare una sua presa di posizione sull’apertura a
sinistra: la presenza in certi momenti di coagulo dell’opposizione cattolica
a quell’operazione, lo scetticismo verso la programmazione economica,
l’impegno a favore della scuola cattolica dopo il voto parlamentare del
25 giugno 1964 che provocò la crisi del primo governo Moro e lo sdegno
di fronte ai primi sintomi della nuova sensibilità post-cristiana che si va
diffondendo in Occidente, possono far pensare a un certo distacco, ma
non a una vera e propria opposizione27. Mentre non emerge alcuna
riserva verso il Vaticano II: nel 1966 detta una prefazione pienamente
consenziente al volume del rosminiano don Clemente Riva, che presenta i
risultati della quarta e ultima sessione del concilio. Lombardi individua,
facendoli propri, gli snodi fondamentali della riflessione di Riva: il carat-
tere pastorale del concilio, l’opportunità di non ribadire la condanna del
comunismo, l’importanza delle conferenze episcopali nazionali, l’otti-
mismo verso i «segni dei tempi». Particolarmente sentito (e totalmente in
linea con la sua precedente riflessione) è il suo apprezzamento della Digni-tatis humanae, la dichiarazione conciliare sulla libertà religiosa, che per lui
segna il «momento di arrivo di una vicenda di quasi duemila anni, e come
apertura di ulteriori ripensamenti»28.
In quegli anni, d’altronde, Lombardi, come altri intellettuali cattolici
che poi si uniranno a lui nella campagna antidivorzista (Cotta e Del
Noce), è inserito in alcuni dei più importanti think tank della cultura demo-
cratica italiana, come l’Associazione del Mulino; partecipa – su invito di
XL Roberto Pertici
29 Della presidenza Lombardi praticamente si tace in AA. VV., In ascolto della storia. L’itine-rario dei «Laureati cattolici» 1932-1982, Roma 1984. Vi vengono ricordati i congressi svoltisi sotto la
sua presidenza, «che, anche quanto a temi, oltre a ricalcare l’impronta della sensibilità del nuovo
Presidente, già rispecchiano, insieme, la problematica complessa e inquieta dei primi anni del
post-concilio e dell’incipiente contestazione»: 1965, Il senso dello Stato; 1966, Il dialogo all’interno dellaChiesa; 1967, Libertà e schiavitù dell’uomo d’oggi; 1968, Il senso cristiano della pace (SCAGLIA, I congressi,ivi., 125 ss., spec. 134 ss.
Norberto Bobbio – ai numerosi cicli di conferenze sull’antifascismo e la
Resistenza che vanno proliferando. Il prestigio da lui raggiunto è dimo-
strato dell’elezione nell’estate del 1964 alla presidenza di una delle più
importanti associazioni del laicato cattolico, il Movimento Laureati. I suoi
interventi sul mensile del Movimento, «Coscienza», ci permettono di
seguire le sue posizioni di fronte alla crisi di fine-decennio. Vi ritornano
molti dei temi che si sono fin qui esaminati, per cui mi limiterò a isolare
solo quelli che maggiormente caratterizzano la sua posizione, anche
rispetto a fasce crescenti del mondo cattolico post-conciliare29.
9. – Innanzitutto la sua critica dell’«antifascismo ideologico», che
costituisce il retroterra valoriale della politica italiana dopo il luglio 1960 e
che trova un ulteriore impulso nell’elezione di Saragat alla presidenza del-
la repubblica alla fine del 1964 e – l’anno successivo – nelle celebrazioni
del ventennale della Liberazione. «Carattere unitario della Resistenza»,
«fascismo come pericolo immanente della storia italiana», quindi «peren-
nità dell’antifascismo»: questi – com’è noto – sono alcuni dei suoi temi.
Altra è l’analisi di Lombardi: «Risulta indubbiamente un substrato
comune, nei “resistenti”: resistere per resistere, contro la violenza, il
sopruso, la barbarie. Resistere perché solo così – in quelle circostanze – ci
si sentiva uomini liberi. Ma se cerchiamo di cogliere, nei resistenti, le
prospettive per il dopo – i programmi da attuare quando la tormenta del-
la guerra fosse passata – allora i presunti “valori unitari” della Resistenza
diventano un nome vano che copre una realtà composita, spesso contrad-
dittoria». Quindi la Resistenza è un’esperienza non attualizzabile: «La
Resistenza appare, unitariamente, quale una preziosa esperienza nella
strada verso la libertà. Ma è un’esperienza passata, conclusa: come ogni
esperienza storica, in quei precisi termini irripetibile. Occorre non mitiz-
zarla. [...] Occorre anzi smitizzare una costruzione artificiosa che in
questi venti anni si è consolidata in taluni ambienti, con una totale chiu-
sura al senso del divenire della storia». Come il mito della Resistenza
«tradita»: «Occorre quindi reagire alla tentazione di farsi trascinare nella
spirale del rimpianto retorico per i così detti “valori traditi della Resi-
stenza”. Lasciamo pure che altri versino ricorrentemente, a questa
XLIGabrio Lombardi e la questione del divorzio
30 LOMBARDI, 25 aprile: significato della Resistenza, in Coscienza 19 (1965) 97 ss.31 LOMBARDI, Non-violenza e guerra d’Israele, in Coscienza 21 (1967) 161 ss. (giugno). La rivista
riportava anche l’appello dei docenti milanesi, fra cui – oltre Giacchi – Ezio Franceschini, Franco
Cordero, Giorgio Balladore Pallieri, Mario Apollonio (ivi, 165). Gli atti del convegno sono in Lapace come dimensione dello spirito, Bologna 1967.
insegna, lagrime amare. Sono lagrime di rivoluzionari mancati, spinti dal
buon senso degli italiani ai margini della storia d’Italia»30.
Non sembra che queste analisi abbiano suscitato reazioni particolari
negli ambienti del Movimento, come invece accadde per una successiva
presa di posizione del presidente: quella a favore di Israele al momento
della «guerra dei sei giorni» e al contemporaneo ribadimento della tradi-
zionale dottrina cattolica della «guerra giusta». Il 26-27 maggio 1967 si
era svolto a Roma un convegno del Comitato cattolico docenti universi-
tari sul tema della pace quale «dimensione permanente dello spirito». Nel
suo intervento, il canonista della Cattolica Orio Giacchi aveva sottoli-
neato quanto di utopistico – oltre che di devitalizzante – fosse in una
prospettiva di assoluta «non violenza»: non ricorrere alla forza in alcun
caso, qualunque cosa accada. Egli e altri intervenuti fecero ricorso alla
tradizionale distinzione fra «guerra giusta» e «guerra ingiusta», e ciò
dispiacque ad alcuni dei presenti, che manifestarono la loro «profonda
malinconia» nel constatare che nel maggio 1967, a due anni dalla conclu-
sione del Concilio, «si rispolverassero categorie che si sperava fossero
sepolte per sempre».
Lombardi prese le difese di Giacchi: «Nessuno contesta che il singolo
individuo [...] possa liberamente scegliere di subire l’ingiusta aggressione
per rendere testimonianza al principio della non-violenza. Ma riteniamo
non si possa trasferire sic et simpliciter una simile posizione dalla espe-
rienza individuale alla esperienza collettiva di gruppi e di società politiche.
Chi ha la responsabilità di altri, deboli e indifesi, non può non ricorrere
alla forza contro la violenza dell’ingiusto aggressore, qualora questa sia
l’unica strategia che gli si offre per difendere determinati valori, che sono
più alti della stessa vita. [...] Il dovere dei pacifici di fronte ai violenti non
è solo quello di proclamare e condannare la violenza, ma anche quello di
opporsi, se necessario con la violenza, per impedire il raggiungimento del
fine violento propostosi». Da qui la presa di posizione a favore di Israele:
«Chi può avere dubbi che la guerra affrontata da Israele, all’alba del 5
giugno, fosse “giusta”: non solamente nel senso di “lecita”, ma nel senso
di “doverosa” da parte dei responsabili?» e il rinvio a un documento di
molti docenti dell’Università Cattolica di Milano, che – «di fronte al
disimpegno dei governanti e alle incertezze di molti» – avevano sentito «il
bisogno di esprimere al popolo di Israele la propria incondizionata solida-
rietà»31.
XLII Roberto Pertici
32 Lettere al Direttore. Ancora sulla pace e sulla guerra, sulla non-violenza e la rivoluzione, in Coscienza 21
(1967) 312 s. (novembre). Ma gli echi dell’intervento di Lombardi dovettero protrarsi nel tempo,
se ancora nel discorso d’apertura del congresso del gennaio 1968 egli sentì il dovere di chiarire e
difendere le sue posizioni (LOMBARDI, Riflessioni sul Congresso 1968, in Coscienza 22 [1968] 35 ss.,
spec. 36 s.). Il convegno non a caso era dedicato a Il senso cristiano della pace. Sulla figura di
Peyretti un cenno significativo in MENOZZI, Chiesa, pace e guerra nel Novecento. Verso una delegittima-zione religiosa dei conflitti, Bologna 2008, 318 nt. 93. Questo libro ricostruisce con precisione il
dibattito conciliare e post-conciliare sull’argomento (ivi, 271 ss.).
Lombardi parlava a titolo personale? O a nome del Movimento? Nei
numeri successivi comparvero lettere di consenso con le sue posizioni, ma
anche non poche di dissenso: particolarmente sottile quella di don Enrico
Peyretti, allora animatore di alcune comunità di base torinesi, da sempre
attivo nel movimento per la non violenza e per la pace: «Se si giustifica in
quei termini la moderna guerra di difesa si deve, a ben maggior ragione,
giustificare la rivoluzione violenta contro la violenza costituita nei sistemi
economici e politici inumani (es. America Latina; situazione del
commercio internazionale; imperialismi economici; governi totalitari;
razzismi, ecc.): questa rivoluzione è davvero una guerra di difesa».
Rispondendo Lombardi ribadì che sussisteva una «profonda diversità
nella tranquillità di coscienza, tra chi affronti una guerra di difesa contro
l’ingiusto aggressore, e chi si disponga a promuovere e a partecipare a
una “rivoluzione violenta contro la violenza costituita nei sistemi econo-
mici e politici inumani”. Non vorrei fare acrobazie bizantine sui termini;
ma non è senza rilievo che Lei parli di “rivoluzione violenta”, mentre
quanti sosteniamo la legittimità della guerra di difesa parliamo di ricorso
alla forza contro la violenza già in atto»32.
Strascichi analoghi suscitarono le posizioni del presidente sulle agita-
zioni studentesche. Nel giugno del 1966, dopo i disordini all’università di
Roma in cui trovò la morte lo studente Paolo Rossi, Lombardi aveva
respinto nettamente l’aspirazione degli studenti a partecipare al governo
dell’università, ritenendola «una somma di equivoci che si perpetuano da
venti anni, ed è grave manchevolezza – da parte dei responsabili accade-
mici e politici – non averli indicati esplicitamente per tali fin dall’inizio»:
era un’affermazione ambigua quella che circolava in certo mondo catto-
lico, secondo cui tale partecipazione costituiva un momento importante di
«educazione alla responsabilità», o l’altra che vedeva gli studenti non
come utenti del servizio universitario, ma quali corresponsabili del servizio
stesso. Lombardi (che – non lo si dimentichi – era professore ordinario)
dava poi un giudizio molto critico degli organismi rappresentativi studen-
teschi, eletti in un clima di largo astensionismo (circa il 75 per cento) e
incapaci di darsi una vera funzione. Soprattutto fortemente politicizzati:
«I partiti politici hanno visto negli organismi un terreno prezioso e
fecondo nel quale i giovani avrebbero potuto avviarsi a scelte squisita-
XLIIIGabrio Lombardi e la questione del divorzio
33 LOMBARDI, L’equivoco degli organismi universitari: a proposito delle vicende dell’Università di Roma,in Coscienza 20 (1966) 167 ss. (giugno). Sulla morte di Paolo Rossi e il suo sfondo, una prima infor-
mazione in LONGO, MONTI, Dizionario del ’68. I luoghi, i fatti, i protagonisti e le idee, Roma 1998,
87 s. Un esame approfondito della crisi universitaria era stato compiuto nel maggio 1965 in un
convegno promosso dal Comitato cattolico docenti universitari, a cui aveva partecipato anche
Lombardi: cfr. L’Università, oggi, Bologna 1966.
mente politiche, nel quadro delle varie visioni del mondo e della storia
circolanti nel corpo sociale italiano». Tuttavia anche Lombardi era
convinto che:
l’Università italiana attraversasse una grave crisi [...]. Si tratta di una Università,nata e impostata strutturalmente per una élite, che si è trovata improvvisamente adovere far fronte a ondate sempre più ampie di giovani. Tutto positivo, natural-mente, l’allargamento della “chiamata alla cultura”. Ma inevitabile lo sfasamentotra le richieste di servizio che gli utenti chiedono all’istituto universitario, e le risposteche l’istituto è attualmente in condizione d’offrire. Di qui l’esigenza di una riformache consenta di adeguare le strutture ai servizi richiesti: strutture in attrezzature, maancor più in uomini, soprattutto nei gradi intermedi degli assistenti e dei professoriincaricati. Naturalmente, nello svolgimento della crisi, non sono senza responsabilitài professori titolari di cattedra che spesso approfittano proprio della crisi in atto pertrovare un comodo alibi alla loro scarsa generosità nel dedicarsi all’impegno univer-sitario33.
Fu proprio la proposta di riforma universitaria elaborata del ministro
Luigi Gui che scatenò fra il 1967 e il 1968 l’ondata del movimento studen-
tesco e le sue teorizzazioni (istituzionalizzazione delle occupazioni delle
sedi universitarie, la fine della delega agli organismi studenteschi, il diritto
allo studio, il lavoro di gruppo, la tesi che «l’Università appartiene alla
base universitaria, e [che] questo possesso va affermato contro le strutture
esistenti che lo negano», come affermavano le pisane Tesi di Sapienza del
febbraio 1967, attentamente analizzate da Lombardi). È anche noto che
fu l’Università Cattolica di Milano uno degli epicentri della contestazione,
per cui acquista risalto l’articolo che Lombardi le dedicò, pubblicato il 16
gennaio 1968 su «L’Italia», il quotidiano della curia milanese. Lombardi
ora arrivava quasi a rimpiangere i vecchi organismi rappresentativi:
Le attuali agitazioni sono prive di qualsiasi serietà anche perché, promosse danon meglio identificati “comitati di agitazione”, si svolgono fuori di ogni qualificatarappresentanza studentesca. Sino a un anno fa, attraverso il faticoso travaglio dioltre venti anni di storia, il mondo studentesco universitario aveva costruito unasorta dì propria “rappresentanza” che si esprimeva negli “Organismi rappresenta-tivi” costituiti attraverso libere elezioni cui erano invitati tutti gli iscritti all’Univer-sità. [...] Da un anno a questa parte, viceversa, uno sparuto gruppo di attivisti cercasistematicamente di vanificare la regolare rappresentanza universitaria sostituendovioccasionali “assemblee” cui manca, per assoluta carenza di un meccanismo organiz-zativo, la stessa possibilità di esprimere una qualsiasi volontà unitaria: al punto che,con sconcertante disinvoltura, tali assemblee sono pronte a mutare ogni giorno ilcontenuto delle loro rivendicazioni.
Insistita era la sua polemica contro l’assemblearismo, come falsa
espressione democratica:
XLIV Roberto Pertici
34 Cit. senza indicazione della fonte in BRAMBILLA, Dieci anni di illusioni. Storia del Sessantotto,Milano 1994, 19.
35 LOMBARDI, L’occupazione delle Università: un illecito penale, in Coscienza 22 (1968) 17 s.
(gennaio). La lettera di Manara (Milano, 17 gennaio 1968) è ivi p. 19. Altre reazioni (anche
critiche) sono in Lettere al Direttore. Sui problemi dell’Università, ivi, 95 s. (marzo).
So bene la suggestione che esercita sui giovani la prospettiva della democraziadiretta. So bene che il meccanismo della rappresentanza è quanto di meno entusia-smante si possa immaginare. Ma la rappresentanza è il sistema meno peggiore chesecoli di storia abbiano saputo elaborare per far vivere in termini di libertà vastecomunità di milioni di uomini. [...] Se la rappresentanza non è entusiasmante,l’assemblea per contro è decisamente mistificatrice: dà l’impressione di un’imme-diata partecipazione generale e diretta, ed è invece il luogo tipico in cui una mino-ranza decisa e abile conduce come vuole e dove vuole. L’assemblea è il preludioinesorabile della dittatura di una minoranza o addirittura di uno solo34.
Non meraviglia perciò il carattere «eversivo» di molte delle sue deli-
berazioni, in particolare dell’occupazione come strumento di lotta:
L’occupazione di una sede universitaria è un illecito penale e come tale vaimmediatamente represso da tutti coloro che, per uno o per altro verso, sono coin-volti nella vicenda con precisa responsabilità. Che le Università siano degli studenti,come spesso si è sentito ripetere nelle settimane scorse, è affermazione compassione-vole prima che eversiva. Le Università non sono dei professori, non sono degli inca-ricati né degli assistenti, non sono degli studenti. Sono del popolo italiano nella suaglobalità, ha ricordato il ministro Gui in una tavola rotonda televisiva, la sera dimercoledì 10 gennaio35.
Anche questa volta non mancarono le reazioni: se il matematico
Carlo Felice Manara (un altro dei futuri promotori del referendum sul
divorzio) era sulle stesse posizioni del presidente, non poche lettere di
dissenso furono pubblicate su «Coscienza»: segno che ormai il Movi-
mento si stava dividendo di fronte all’accelerazione degli avvenimenti e
che le posizioni di Lombardi vi andavano incontrando un’opposizione
crescente.
Lo si vide anche in occasione dell’enciclica Humanae vitae, pubblicata
da Paolo VI il 28 luglio di quell’anno: di fronte alle perplessità che dove-
vano circolare anche fra i Laureati di Azione Cattolica (trovarono
un’espressione pacata in una lunga lettera di Giorgio Stefani), Lombardi
difendeva a spada tratta le scelte del papa, «l’unico suo rammarico
[essendo] che l’enciclica abbia troppo tardato a venire»: al di là dei
problemi specifici che affrontava, il suo senso complessivo era una critica
di un aspetto emergente della modernità: «A me sembra che – scriveva –
il significato più alto dell’enciclica sia quello di avere voluto esplicitamente
bloccare la corsa del mondo moderno – e di molti cattolici contemporanei
– a considerare centrale, e quasi assoluto, il problema del sesso e del
soddisfacimento a qualunque costo, dei relativi istinti. [...] La caratteriz-
XLVGabrio Lombardi e la questione del divorzio
36 Lettere al Direttore. Perplessità circa la «Humanae vitae», lettera di STEFANI (18 agosto 1968) e
replica di LOMBARDI (Roma, 8 settembre 1968), in Coscienza 22 (1968) 242 ss. (settembre).
Sull’impatto della Humanae vitae sul Sessantotto cattolico, cfr. BERETTA, Il lungo autunno. Controstoriadel Sessantotto cattolico, Milano 1998, 116 ss.
37 LOMBARDI, Bilancio di un Congresso, in Coscienza 21 (1967) 37 (febbraio).38 LOMBARDI, Il libro come elemento essenziale del bene comune, in Coscienza 20 (1966) 235
(settembre).
zazione del sesso si iscrive mirabilmente nell’ordine segnato da Dio al
creato. L’enciclica ha ricordato agli uomini – con benefica terapia d’urto
– che questo ordine ha in sé finalismi di ricchezza infinita che vanno ben
oltre i problemi del sesso»36.
L’inizio della fine della sua presidenza si ebbe nel convegno di fine
dicembre 1968 dedicato al ruolo dell’intellettuale all’interno della pasto-
rale della Chiesa e nel più vasto insieme dell’Azione Cattolica. Si trattava
evidentemente di una riflessione sul destino del Movimento: aveva ancora
senso un’organizzazione di intellettuali cattolici o invece essa apparteneva
a un tempo in cui si puntava a una cultura separata ed elitaria? Non era
preferibile ormai sciogliere i Laureati nei Comitati parrocchiali e/o dioce-
sani, calandoli fra la gente comune? Lombardi era convinto che fosse
ancora in svolgimento una lotta ideologica, in cui la cultura che si definiva
cattolica dovesse impegnarsi. Non si sentiva estraneo o nemico dei muta-
menti in atto: «Uomini del ventesimo secolo, ringraziamo la Provvidenza
di averci fatto vivere negli anni sessanta, nella esaltante certezza che
ciascuno di noi può e deve essere protagonista – come singolo e come
membro di gruppi – nella grande avventura di liberazione o di asservi-
mento che si sta giocando nel mondo»37. Ma la cultura non poteva essere
puramente ricettiva: essa gli si presentava come «consapevolezza sulla
realtà, su noi stessi, sul mondo che ci circonda, nella luce di una scala di
valori continuamente rivissuta criticamente e recuperata. Questo, del
continuo recupero della gerarchia dei valori, in una realtà così ricca di
fermenti nuovi e così singolarmente accelerata, è un tema che mi è parti-
colarmente caro», scriveva nel 1966. Non era, insomma possibile evitare
giudizi di valore ed essi andavano elaborati alla luce della concezione
cristiana della vita e della storia: «Nulla di bloccato, evidentemente, circa
la storia. La storia porta continuamente in emersione nuovi valori: a volte
valori, a volte disvalori. Si tratta di ricondurli – io direi: recuperarli – alla
gerarchia fondamentale dei valori di fondo»38. Una impostazione siffatta
evidentemente ancora giustificava l’esistenza di un movimento di intellet-
tuali cattolici.
L’attacco fu portato dal relatore del convegno, Luigi Pedrazzi, uno dei
fondatori del «Mulino», ma ormai conquistato dal fascino di Giuseppe
Dossetti, e dal rappresentante del gruppo toscano, il pedagogista Attilio
Monasta, vicino alla rivista «Testimoniananze» del padre Balducci, che
XLVI Roberto Pertici
39 LOMBARDI, Discussione sulla relazione di Pedrazzi, in Coscienza 23 (1969) 9 ss. (gennaio-
febbraio). Il fascicolo era aperto da un commento dello stesso Lombardi, Significato del nostroincontro (ivi, 1 s.). I nuovi statuti accolsero tuttavia l’esigenza da lui sostenuta, che il Movimento
Laureati conservasse le sue fondamentali strutture, pur in quadro profondamente rinnovato
(LOMBARDI, Nuove prospettive sugli statuti dell’Azione Cattolica, in Coscienza 23 (1969) 177 s. [luglio-
agosto]).40 LOMBARDI, Una svolta nella vita del Movimento, in Coscienza 24 (1970) 105 (maggio).41 LOMBARDI, Fraternamente salutiamo gli amici, in Coscienza 24 (1970) 203 (settembre).
presentò un Contributo per una chiarificazione sul tema dell’incontro di Roma: sullo
sfondo la progettata riforma degli statuti dell’Azione Cattolica (la nota
«scelta religiosa»), che sembrava non riconoscere più uno spazio auto-
nomo al Movimento Laureati. Pedrazzi dichiarò subito che intendeva
dare alla sua relazione un’impostazione non polemica o contestatrice, ma
nettamente alternativa. Criticò la categoria di «intellettuale», che si era
prestata nel Novecento alla seduzione totalitaria, e negò che essa potesse
svolgere ancora un ruolo nella pastorale della Chiesa: il cosiddetto intel-
lettuale era un «fedele» come gli altri e non doveva avere alcun ruolo
privilegiato. Lombardi, nel suo discorso introduttivo, affermò invece espli-
citamente di rifiutare un’accezione sociologica della cultura, citandone
come esempio un passo del documento dei toscani, e riaffermò la neces-
sità di una «riflessione di secondo grado che cerchi di capire e di ricupe-
rare la realtà che diviene, nella luce dei valori». La discussione divenne
accesissima e, soprattutto dopo il lungo intervento di Monasta, sembrò
quasi ridursi a un lungo battibecco fra lui e il presidente. Le tesi di
Pedrazzi e dei toscani fecero breccia in molti fra i più autorevoli degli
intervenuti (Franco Bolgiani, Carlo Alfredo Moro): alla fine risultò
evidente che Lombardi – all’interno dell’organizzazione – era diventato
«segno di contraddizione»39.
Mentre si accingeva a lasciare la carica di presidente, volle riflettere
un’ultima volta sulle tendenze che erano esplose all’interno del mondo
cattolico post-conciliare, opponendosi a una lettura del Vaticano II come
rottura della tradizione:
per la Chiesa occorre aggiungere che nulla potrà farsi di valido se non rima-nendo profondamente ancorati alla tradizione che attraverso un ininterrottocammino di venti secoli ha portato a noi la freschezza della parola di Cristo. [...]Certe prospettive avveniristiche che, pur richiamandosi alla purezza delle “origini”,vorrebbero ripartire quasi da un anno zero, sono il risvolto ecclesiale di quell’atteg-giamento emozionale largamente diffuso nella società civile contemporanea ove siincontrano e paradossalmente si fondono il mito regressivo del buon selvaggio el’utopia di un perfettismo disincarnato dalla storia40.
Nell’assemblea del 19-20 settembre 1970, lasciava la carica che aveva
tenuto per sei anni41.
10. – Il 1o ottobre 1965 il deputato socialista Loris Fortuna presentò
XLVIIGabrio Lombardi e la questione del divorzio
alla Camera una proposta di legge Casi di scioglimento del matrimonio, che
prevedeva l’introduzione del divorzio in una serie di casi estremi, ma pure
di fronte a una separazione legale della durata di almeno cinque anni,
anche non consensuale e indipendentemente da ogni problema di ‘colpa’.
Il problema del divorzio era da anni oggetto di vivace dibattito e per
tempo Lombardi aveva chiarito la sua posizione: dal 5 all’8 dicembre
1964 si era tenuto a Roma un convegno nazionale dei giuristi cattolici, in
cui aveva svolto una relazione dedicata appunto a La famiglia nell’ordina-mento italiano. Come affermava esplicitamente, il suo scopo era quello di
«chiarire su quali elementi si fondi la indissolubilità del matrimonio
nell’ambito di tale ordinamento, anche indipendentemente dall’aspetto
sacramentale dell’istituto».
Questo sarebbe stato il nucleo del suo discorso nel decennio succes-
sivo: l’indissolubilità dell’istituto matrimoniale non discendeva dal suo
carattere sacramentale, ma dalla sua stessa natura e quindi riguardava
non solo il matrimonio concordatario (celebrato sacramentalmente e
trascritto nei registri dello stato civile), ma anche quello puramente civile,
regolato appunto dal codice civile: la famiglia è una realtà naturale, che
esiste non in quanto lo Stato in qualche modo la sanziona, ma per il libero
incontro delle volontà dell’uomo e della donna.
Proprio perché la famiglia è una realtà naturale che si inserisce come forzadeterminante nella sopravvivenza del genere umano, le due libere volontà delsingolo uomo e della singola donna possono benissimo non incontrarsi: ma quandosi siano validamente incontrate, sono definitivamente sfuggite alla disponibilità delleparti. E questa indisponibilità è stata implicitamente voluta, dalle parti, nelmomento stesso in cui si sono incontrate per quello scopo. Intendo dire che la fami-glia è una società naturale coessenziale alla continuazione del genere umano. E cheproprio per questo il matrimonio ha in sé, essenziale, il carattere della indissolubilità.
In parole più povere: quando l’uomo e la donna si dichiarano l’inten-
zione reciproca di essere marito e moglie, non sottopongono una tale
intenzione a una scadenza temporale, ma le attribuiscono chiaramente un
carattere perpetuo. Tale «perpetuità» è costitutiva dell’impegno reciproco
e non può dissolversi che con la scomparsa di uno dei due coniugi: solo
allora una promessa analoga può essere ripetuta, prima al massimo si può
consentire che si interrompa la vita in comune (separazione). È chiaro che
nella logica di Lombardi il prius era la responsabilità dei coniugi verso la
collettività (quella che chiamava la «sopravvivenza», la «continuazione»
del genere umano) piuttosto che la loro «felicità» individuale e ripetuto
era il richiamo all’esperienza storica: «Conosco un pochino la storia; e la
storia mi dice che nel fluire dei millenni la maggioranza degli uomini ha
vissuto l’esperienza matrimoniale nei termini di una famiglia unica e defi-
nitiva. E questo è avvenuto nonostante gli ordinamenti giuridici non stabi-
lissero l’unitarietà e l’indissolubilità del matrimonio».
Un’impostazione siffatta non ammetteva soluzioni intermedie, che
XLVIII Roberto Pertici
42 LOMBARDI, Indissolubilità del matrimonio nell’ordinamento civile italiano, in Coscienza 19 (1965)
10 ss.43 LOMBARDI, Divorzio, referendum concordato cit. 131 ss. Questo libro – lo si ricordi – è degli
inizi del 1970.44 DEL NOCE, Introduzione a SOCCI, FONTOLAN, 1974-1987. Tredici anni della nostra storia,
Milano 1988, 6, che tuttavia ribadiva che «ben maggiore riconoscimento di quello che finora gli
allora invece erano molto discusse: «O il matrimonio è assolutamente indis-
solubile o indissolubile non è», era un suo punto fermo. Così a proposito dei
cosiddetti «casi pietosi» da sanare (famiglie sfasciate da anni, unioni irrego-
lari con figli «adulterini», eccetera), o di situazioni estreme (gravi condanne
penali di uno dei coniugi): «Se è dissolubile anche per un solo caso [...] deve
essere dissolubile per mille altri casi: anzi per tutti i possibili casi: sino al
mutuo consenso, naturalmente; anzi, sino alla volontà unilaterale dell’uno
senza plausibile motivo offerto dall’altro» (allora – 1964 – queste sembra-
vano ipotesi estreme). Lombardi ripeté più volte che la questione dei «casi
pietosi» (accusava i divorzisti di gonfiarne il numero, quando parlavano di 5
milioni di persone coinvolte) era in realtà un escamotage per affermare un
principio e poi estenderne l’applicazione42.
Ma una tale posizione inibiva anche un’altra soluzione intermedia che
invece allora circolò anche in influenti ambienti cattolici sicuramente anti-
divorzisti: quella del «doppio regime». Si proponeva che nella situazione
regolata dal Concordato del 1929, restasse indissolubile – anche nei suoi
effetti civili – il matrimonio concordatario e che si potesse prevedere il
divorzio per quello puramente civile. La scelta di avvalersi del matri-
monio religioso avrebbe impegnato i coniugi a una situazione di indissolu-
bilità, mentre il matrimonio civile avrebbe loro consentito lo scioglimento.
Al contrario, per Lombardi l’impegno umano delle due parti era sostan-
zialmente identico nei due tipi di matrimonio e doveva restare tale: per
predisporre uno strumento per quanti non se la sentissero di impegnarsi
per tutta la vita, arrivò a ipotizzare un terzo tipo di unione, che chiamava
unione registrata, una tipologia non lontanissima da quella prevista nel
disegno di legge varato dal governo Prodi nel febbraio 2007 (quello che
introduceva i cosiddetti Dico): per essa e per essa sola, sarebbe stato possi-
bile lo scioglimento43.
Quasi vent’anni dopo, l’argomentazione «laica» di Lombardi fu accu-
sata da Del Noce di avere impedito ogni possibile compromesso, che
poteva essere basato appunto sul «doppio regime», a cui l’ala più mode-
rata dei divorzisti, ivi inclusi gli stessi comunisti, avrebbe probabilmente
aderito. «L’indissolubilità del matrimonio – avrebbe affermato il filosofo –
ha significato all’interno di una metafisica religiosa e non si può trattarne
al modo di un valore civile autonomo come allora fu fatto»: ciò impedì di
salvare il salvabile e accrebbe la possibilità della vittoria laica44. Si tratta di
ILGabrio Lombardi e la questione del divorzio
è stato attribuito, dovrebbe essere reso alla splendida figura di Gabrio Lombardi». Gli rispose lo
stesso Lombardi in Perché il referendum sul divorzio? 1974 e dopo, Milano 1988.45 LOMBARDI, Divorzio e referendum, in Coscienza 21 (1967) 65 ss. (marzo).46 LOMBARDI, Divorzio e referendum, in Coscienza 22 (1968) 210 (luglio-agosto). Per tutti questi
problemi e il loro svolgimento rinvio ancora a PERTICI, Chiesa e Stato in Italia, cit. supra nt. 1.
un’osservazione fondata, ma si deve aggiungere che Lombardi insisté a
lungo sulla indissolubilità del matrimonio civile, perché la considerava
l’unica questione veramente aperta. Riteneva infatti giuridicamente
impossibile (e qui era completamente in linea con la Santa Sede) che il
parlamento introducesse lo scioglimento del matrimonio concordatario
per legge ordinaria: a suo giudizio il combinato disposto dell’art. 7 della
Costituzione e dell’art. 34 del Concordato allora vigente dava valore
costituzionale all’indissolubilità del matrimonio concordatario, e quindi –
poiché non era pensabile che il Vaticano ritenesse possibile trattare su tale
materia – l’unica via percorribile era quella di una legge di revisione costi-
tuzionale.
Così fu con enorme meraviglia che accolse il parere della Commis-
sione Affari costituzionali della Camera che ammetteva la costituzionalità
della proposta di legge Fortuna45: si era a metà del gennaio 1967, ma
anche più tardi si disse sicuro che la Corte costituzionale avrebbe dichia-
rato incostituzionale un’eventuale legge ordinaria in merito46: com’è noto,
invece, la Corte con la sentenza del 5 luglio 1971 sarebbe stata di parere
contrario. Insomma – garantito dalla copertura costituzionale il matri-
monio concordatario – si trattava di discutere essenzialmente di quello
civile.
Fu quando la proposta Fortuna ebbe superato lo scoglio della costitu-
zionalità, quindi nei primi mesi del ’67, che Lombardi cominciò a parlare
di referendum. Anche qui la situazione era intricata: in quella legislatura
non esisteva in parlamento una maggioranza divorzista e quindi la
proposta Fortuna non aveva avvenire. Ma era possibile che la situazione
mutasse nella V legislatura che si sarebbe aperta dopo le elezioni politiche
del 1968. A suo giudizio «si trattava di un problema di tale gravità – riduci-
bile d’altra parte a una questione estremamente semplice – che era dove-
roso interpellare, in proposito, tutti gli italiani». Tale giudizio doveva
essere preventivo e riguardare appunto solo il matrimonio civile: «Se [...]
la maggioranza del popolo italiano avesse dichiarato di non considerare
l’indissolubilità come elemento essenziale del matrimonio, allora – ma
solamente allora – si sarebbe introdotto correttamente il divorzio».
Allora l’art. 75 della Costituzione, che prevede l’istituto del refe-
rendum, non aveva avuto ancora esecuzione: era necessario – scriveva
Lombardi – approvare rapidamente una legge di attuazione, inserendola
L Roberto Pertici
47 LOMBARDI, Divorzio e referendum cit. (cfr. supra, nt. 45).
«tra i primi impegni programmatici» della nuova legislatura. Restava un
problema: nella costituzione il referendum ha natura meramente abroga-
tiva, ma – come abbiamo visto – esso avrebbe dovuto svolgersi prima del-
l’eventuale approvazione di una legge divorzista, per darle il via o
bloccarla anticipatamente. Come fare? Il giurista propose ripetutamente
che esso vertesse sull’art. 149 del codice civile («Il matrimonio non si scio-
glie che con la morte di uno dei coniugi»), che fondava allora l’indissolu-
bilità del matrimonio civile47.
L’ipotesi del referendum fu quindi da lui affacciata come verifica
preventiva della volontà degli italiani: egli era assolutamente sicuro che la
grande maggioranza del paese fosse antidivorzista (ma questa era
opinione diffusa anche fra molti sostenitori del divorzio) e che il parla-
mento, approvando una legge che non era compresa nel programma elet-
torale di nessun partito, perpetrasse una prevaricazione nei confronti degli
elettori. Il referendum preventivo avrebbe evitato anche molti dei
problemi che in seguito si posero ai referendari: come evitare che si
creasse una sorta di assuefazione al divorzio nel periodo fra l’approva-
zione della legge e l’eventuale referendum abrogativo; come regolare,
dopo l’auspicata abrogazione della legge, gli eventuali divorzi pronunziati
nel frattempo.
Le elezioni del 19 maggio 1968 offuscarono questa prospettiva, già di
per sé piuttosto astratta: perché esse espressero una maggioranza divor-
zista, che non era pensabile si sottoponesse a una specie di esame preven-
tivo. Non restava che un referendum abrogativo della legge introduttiva
del divorzio, dopo che questa fosse approvata: sia che riguardasse solo il
matrimonio civile, sia che contemplasse anche quello concordatario (ma
una tale legge – lo abbiamo accennato – continuava ad apparirgli «mani-
festamente incostituzionale»), sia che il parlamento accettasse finalmente
l’ipotesi di una legge costituzionale, ma l’approvasse senza la maggioranza
dei due terzi: «Sembra dunque possa dirsi che il referendum sia lo stru-
mento idoneo per risolvere, in maniera corretta, il problema dell’even-
tuale introduzione del divorzio in Italia». Restava un problema: la vittoria
degli abrogazionisti (che Lombardi nel 1970 dava per sicura) non avrebbe
conculcato il diritto della minoranza dissenziente? non avrebbe ridotto
quella libertà che restava il valore assolutamente fondamentale nella
prospettiva di Lombardi? La sua risposta era negativa: la soluzione refe-
rendaria in materia di divorzio «risulta indiscutibile nel contesto culturale
degli anni ’70, dato che in nessun paese del mondo la coscienza sociale – e i
conseguenti ordinamenti giuridici – hanno creduto di poter configurare
LIGabrio Lombardi e la questione del divorzio
48 LOMBARDI, Divorzio e referendum cit. (supra, nt. 46) 211.49 LOMBARDI, Divorzio, referendum, concordato cit. 29 ss., spec. 37.
un ipotetico “diritto al divorzio” quale “diritto di libertà”, nel senso di un
“fondamentale diritto dell’uomo”»48.
11. – Fino al 1969 – come s’è visto – gli argomenti di Lombardi resta-
rono di natura essenzialmente giuridica: indissolubilità del matrimonio
civile, incostituzionalità di una legge ordinaria qualora si volesse intro-
durre il divorzio anche nel matrimonio concordatario, esigenza di una
consultazione preventiva degli italiani, in ultima istanza referendum abro-
gativo della legge eventualmente approvata. Quando questa riprese il suo
iter nel nuovo parlamento (a metà del 1969) e la sua approvazione
cominciò a sembrare possibile, prese forza un altro argomento di carat-
tere sociologico o, come avrebbe scritto Matteucci, socio-morale: il
rapporto tra costume e diritto. Fra questi due elementi – scriveva Lombardi
– si innesta una reazione a catena: è ovvio che il costume diffuso in una
determinata società incide sul complesso delle norme giuridiche, ma è
anche vero che tali norme non possono considerarsi una semplice regi-
strazione del costume vigente, ma configurano modelli di comportamentodestinati a incidere in esso. Così in materia matrimoniale scriveva all’i-
nizio del 1970:
L’eventuale introduzione del divorzio risulta deleteria, perché porta inevitabil-mente con sé, come conseguenza, che a quanti si preparano al matrimonio vengaofferto un modello di impegno – almeno sotto il profilo giuridico – non più definitivo,ma provvisorio. La coscienza sociale viene progressivamente abituata a ritenere chela comunione materiale e spirituale tra i due potrà anche continuare sino alla morte,ma che – se questo avverrà – avverrà nel fatto, perché in termini di diritto l’istitutomatrimoniale è caratterizzato dalla provvisorietà49.
Insomma, sulle prime sarebbero stati risolti certamente i «casi
pietosi», ma poi progressivamente si sarebbe affermato un nuovo
costume, che sarebbe stato irreversibile: «L’esperienza di tutti i paesi
divorzisti insegna che una retromarcia in questa materia è praticamente
impossibile. Divorzio crea divorzio».Fu questo lo slogan con cui, neanche un anno dopo, avrebbe iniziato
la raccolta delle firme.
Univ. Bergamo [email protected]




































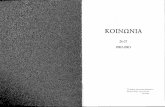








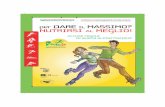




![Introduction: Remembering Aldo Moro [co-authored with Giancarlo Lombardi]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6315661f511772fe451054ce/introduction-remembering-aldo-moro-co-authored-with-giancarlo-lombardi.jpg)



