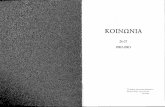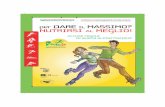Trialogus imperfectus cum muta ac velata figura, II Draft - pubblicato in Inquieto pensare. Scritti...
Transcript of Trialogus imperfectus cum muta ac velata figura, II Draft - pubblicato in Inquieto pensare. Scritti...
fabrizio desideri
Trialogus imperfecTus cum muTa ac velaTa figura
«Non sappiamo forse che tutto questo è soltanto un preludio di quella canzone che dobbiamo imparare?»Resp. vii, 531e
Il Trialogo si svolge sulla riva del mare. Le dramatis personae sono (in or-dine di apparizione): spectator, ignarus e magister. Il primo non interloquisce con gli altri due ed è perfettamente ignorato dal loro colloquio. Al limite della scena, rimugina tra sé, riflette ad alta voce e commenta con ironia, talvolta sarcastica, quanto i due dialoganti si dicono. spectator parla a un pubblico assente, ma sempre presupposto. Parla come una voce terza che rende imper-fetta la forma dialogica. Sullo sfondo della scena si staglia, immobile, una figura velata. Potrebbe essere una statua. Per tutto il tempo rimane ignorata. Solo alla fine spectator si accorge della sua presenza, con oscure parole.
Spectator: ancora un dialogo, ci potete scommettere. Questi che si avvicinano, muovendo da opposte direzioni, sono ancor oggi chiama-ti l’altisonante nome di filosofi. certamente non si limiteranno a fare quello che fanno tutti quando si trovano sulla spiaggia in un tardo po-meriggio di pallido sole invernale. i più si divertono a passeggiare, spensierati o pensosi, curiosi o distratti. alcuni se ne stanno seduti a contemplare in silenzio lo spettacolo delle onde. pochi esercitano la nobile arte della pesca. Questi due, invece, non perderanno occasione di mettere in scena il pensiero, come si suole dire, con fastidioso gergo. stiamo a vedere.
Ignarus (con tono inizialmente adulatorio, ma non troppo da non sem-brare affettuosamente scherzoso): come stai illustrissimo, anche tu ap- profitti di quel poco sole che ancora ci resta.
[Seguono i soliti, trascurabili convenevoli] Di certo non hai letto l’ultimo mio scritto che, come sempre, ti ho mandato con riconoscen-te dedica. lì riflettevo sul significato dei luoghi in alcuni dialoghi di
107_festCacciari_Desideri.indd 1 24/03/15 13:07
2 Fabrizio Desideri
platone. in particolare nel Fedro. la campagna, la passeggiata fuori le mura, le cicale, l’ombra del platano e, soprattutto, l’illisso. il fiume che scorre e le parole che s’intrecciano sulla sua riva. senza questa scena naturale, questa natura che pare soccorrere il pensiero, i passi in-dietro di socrate, il suo ravvedersi, la sua palinodia non avrebbe avuto né forza né senso. e come tu ben sai, il senso è questione di forza.
Magister: sommo artificio, mirabile e indimenticata scena quella che finge il figlio di perictione. come mai altrove, egli lascia che qui la natura irrompa e si intrami nella dialogica tessitura. Non, però, fino al punto di governarla segretamente. attraverso il paesaggio, quando fe-dro e socrate si sono lasciati la pólis alle spalle, è direttamente phýsis che parla. il principio stesso del nascere, del crescere e del trasmutare. ma non parla ancora divinamente. parla phýsis, ma non nella potenza della sua idea: nella potenza che genera il suo stesso generare. e tu di questo, con il tuo pur intelligente articolo non ti sei accorto. anche in questo caso non fai altro che mostrarti ossequioso, sia pur con intelli-genza. stai nella tradizione, ti adagi con disinvolta eleganza sopra di essa. la tua è debolissima ermeneutica. Non fai altro che aggiungere l’ennesima interpretazione. Non sei capace di fare un passo oltre. e, come dovresti sapere, il passo oltre è sempre un passo indietro verso un’origine impensata dai lógoi dei filosofi.
Ignarus: le tue parole mi turbano. se da un altro mi fossero state dette, avrei reagito con una scrollata di spalle. Tutt’al più mi sarei un poco indispettito e avrei tirato innanzi. ma ascoltarle da un maestro quale tu sei, mi costringe a fermarmi e a chiederti che cosa veramente tu voglia dire.
Spectator: poveretto. come un asino, per sua naturale disposizione non può far altro che ragliare o scalciare, così un eterno allievo non può far altro che pendere dalle labbra del maestro, magari per tirargli me-taforici calci quando, altrettanto metaforicamente, gli gira le spalle. stiamo a vedere se i dialoganti sapranno abbandonare questa scolastica pantomima! ma ne dubito.
Magister: Quel che intendo, caro giovane amico, è che nel dialogo phýsis, è comunque ridotta a scenografia, è la quinta di un allestimen-to teatrale. fa parte di quegli arredi di cui anche la più spoglia e so-
107_festCacciari_Desideri.indd 2 24/03/15 13:07
Trialogus imperfectus cum muta ac velata figura 3
bria delle scene abbisogna. e tutti i dialoghi, scritti o detti che siano, sono pur sempre opera drammatica: studiata e recitata teatralità. anche quando l’intreccio, la trama con prologo ed epilogo, pare inconsistente o non esiste affatto. alle leggi che governano questo genus dell’uma-no discorrere non si sottraggono i dialoghi filosofici, tantomeno quelli platonici che di quest’ultimi sono il prototipo. ma lasciamo perdere questa disquisizione. Quanto mi preme dirti è che la voce della natura, che nel Fedro pare parlare con forza autonoma, è pur sempre studiato elemento di una scena allestita con maestria. come tale, essa parla nel-lo spazio di un artificio. in quanto “elemento” di una téchne la natura non può essere mater. piuttosto è natura picta o ficta, figlia sempre im-propria, mero prodotto di una tecnica capace di produrne e riprodurne gli effetti all’occorrenza. Di una téchne poietiké, dovrei precisare.
Ignarus: Non dovresti aggiungere mimetiké? in quanto arte che produ-ce imitando quel che vede: i fenomeni della natura, il canto delle cica-le, lo scorrere delle acque, le voci e le passioni umane. se, giustamente, ti riferisci al dialogo come a una rappresentazione teatrale, non puoi che riconoscervi il sapiente frutto di un’ars imitativa: che ri-produce ciò che già c’è. l’arte, così intesa, non è altro che rappresentazione.
Magister: eh no, caro mio. così dicendo ti confermi quel che sei: un onesto ripetitore. mostri soltanto di aver letto bene i venerati testi, ag-giornandone qua e là l’interpretazione. io volevo dire proprio che la messa in scena qui è frutto di un’autentica poíesis, messa in opera di qualcosa che prima non c’era. Quella di platone, perciò, va considerata un’invenzione assoluta. produzione e post-produzione. mirabile, senza dubbio. fino al punto di far credere che il dialogo sia imitazione, eco e memoria, di una parola viva, di un intreccio di parole che un qualche giorno ebbe luogo, magari sulla riva dell’illisso. Quando platone critica, oltre a pittori e scenografi. anche coloro che scrivono tragedie e finan-che il padre omero, lo fa, al fondo, per opporre al carattere mimetico di un’arte ancora serva, il principio poietico di una rappresentazione as-soluta, priva di presupposti. opera di una téchne che alle sue spalle non ha niente o quasi. soltanto che questa somma philo-sophía non giunge sino a riconoscere la dimensione tecno-poietica del suo stesso princi-pio: quel porsi, mentre si pensa, del noûs. e proprio per quest’origina-ria aporia il suo movimento è costretto a fingersi nell’intreccio delle voci, nel serissimo gioco del porre domande e del dare ragioni.
107_festCacciari_Desideri.indd 3 24/03/15 13:07
4 Fabrizio Desideri
Ignarus: con queste conclusioni, caro maestro, non posso consentire. almeno questo da te l’ho imparato: non convenire mai con quanto non si pensi veramente. Quale che sia la polifonia di significati che possiamo intendere nel termine “veramente”, almeno in questo caso l’avverbio ha il valore e il senso di vincolare il pensiero a un’unica voce. a quanto hai ora sostenuto non si oppone un’altra interpretazione, ma la forza della lettera: la misura di una parola, di un’ultima parola che ha l’effet-to di un comando. se tu, invece, continui a intendere la filosofia come poietica inventio, non fai altro che aggirare questo comando, lo sospen-di in un gioco delle ipotesi che si paralizzano a vicenda, come se questo fosse il possibile che sta più alto non solo di ogni principio di realtà, ma della necessità stessa.
Spectator: il nostro ossequioso allievo pare prendere il volo. vediamo cosa tira fuori. Non vorrei che si rifugiasse in quell’argomentare pre-tesco o da sacrestani che fa finire tutti i salmi in gloria. vediamo se si rende conto che qui non siamo in chiesa o in sinagoga, ma sulla riva del mare dove a valere sono solo nudi argomenti. ad ogni modo stia-mo imparando che niente è come appare e non tutto quel che appare è. l’ignoranza, stavolta, pare solo simulata: l’ignaro nasconde forse un impostore. che sia questa l’origine di ogni dialettica?
Magister: Non capisco bene cosa tu voglia dire. come può la lettera dire più dello spirito che parla tramite e in virtù di essa? come può darsi un’ultima parola nel gioco e pur anche nel conflitto delle inter-pretazioni? Non abbiamo appreso dall’ultimo degli apostoli che “la lettera uccide, mentre e lo spirito vivifica”?
Ignarus: sì, certo. ma non in questo caso. la sentenza paolina non vale per quanto sto per dirti. con “ultima parola” e con potenza della lettera intendo quella mossa con la quale platone in un altro dialogo che ben conosci identifica il Bene, tò Agathón con l’anipotetico. Qui la parola ha il valore di un comando: sospende il pensiero imprimendo un arre-sto al suo erotico movimento. se ipotesi sono a fondamento delle varie scienze, all’origine di ogni epistéme, quanto si sottrae a ogni ipotesi è tanto epékeina tês ousías (di tutto ciò che è, prima ancora che pos-sa esistere) quanto al di là di ogni epistéme. meta-erotico e meta-epi- stemico è l’arresto del porre e del presupporre che il Bene impone al pensare. Nello Stillstand dell’arresto il pensare è misurato, anziché
107_festCacciari_Desideri.indd 4 24/03/15 13:07
Trialogus imperfectus cum muta ac velata figura 5
porsi come misura, criterio di quel giudicare con il quale ogni pensiero si confronta. se del Métron che lo misura avesse una qualche percezio-ne, se potesse al riguardo fingere ancora ipotesi, ravviserebbe nel Bene una qualche natura o almeno un’idea di essa.
Magister: anch’io, come ben sai, mi guardo bene da soluzioni così mi-sere: ricondotto allo spazio della natura, fosse pure di una sua idea, il Bene sarebbe ridotto a ousía e, pertanto, cognitivamente accessibile. la via del naturalismo, così, sarebbe irrimediabilmente aperta. ma il natu-ralismo, anche il più accorto e raffinato, non va oltre una mezza verità.
Ignarus: D’accordo, caro maestro. Non vorrei però che la tua ansia di indagare l’oscura relazione tra il Bene e la Natura giunga a tracciare con speculativa perizia i contorni di una verità e mezzo. anche così il vero sarebbe mancato come bersaglio. Questo non accade soltanto quando s’afferri che il Bene, una volta eliminate tutte le ipotesi da cui si aveva preso lo slancio, sta oltre ogni concetto e proposizione. Dal punto di vista del pensiero esso non può risultare altro che un conceptus termi-nator. anche nel senso che qui il pensare giunge a un termine: si arresta.
Magister: una siffatta dichiarazione d’impotenza mi suona estranea. ad essa si oppone la mia indole inquieta e instancabile nel ricercare.
Ignarus: lo ammetto: preferisco la resa dell’arresto all’estenuarsi in un domandare senza requie. il problematicismo non mi ha mai affasci-nato più di tanto. uno stupore continuo è l’antitesi della commozione all’origine del pensare. a ogni modo, poi, Ursprung ist das Ziel – ri-marca l’epigono che colse nell’inumano i tratti di un “angelo nuovo”. e dinanzi alla mèta, al bersaglio, al télos o come lo vuoi chiamare dob-biamo arrestarci per prendere bene la mira. Naturalmente, ancora, con estremo e consapevole stupore. lo so bene. rispondendo con l’arresto al comando che intima letteralmente il termine arché, il pensiero fi-losofico si riconosce conclusivamente impoetico, passivo prima della distinzione che separa l’attività dalla passività. Tu, invece, attirando l’anipotetica arché nel gioco delle ipotesi, sembra che aspiri a cancel-lare la differenza tra il filosofo e il poeta. Non tanto sul lato di evocativi discorsi capaci di sedurre piuttosto che di convincere, quanto su quello ben più serio e decisivo della verità. piuttosto che rafforzarla nel pa-radigma del corrispondere e del convenire con la cosa stessa, sembri
107_festCacciari_Desideri.indd 5 24/03/15 13:07
6 Fabrizio Desideri
mirare a fiaccarla in una perenne oscillazione. così ogni aspetto della verità si converte nel suo opposto e il Bene stesso può tragicamente trasmutarsi nel suo contrario.
Magister (con malcelato senso di fastidio): mi fai dire quel che non ho mai detto. credi veramente che il confine tra tragedia e filosofia possa essere deciso? Quel senso del limite che evochi con il termine “arre-sto” mi pare frutto di un frettoloso eticismo. Non sembra nemmeno tu abbia letto o capito fino in fondo la distinzione kantiana tra Schranke e Grenze, tra limite/barriera e confine. Non c’è confine che non possa essere attraversato e – intendi bene – non c’è limite che non possa es-sere convertito in confine. Hegel docet. pur ricondotta a un minimo di coerenza concettuale la tua posizione si attesterebbe, comunque, al di qua di Hegel, persistendo nella differenza tra ciò che si crede e ciò che si sa, tra la fede e il sapere.
Spectator: il nostro celebrato maestro vuole dare una lezione all’allievo. Ben gli sta dopotutto. Nemmeno lui, però, ha capito quanto sia vano questo dialogare. come se il pensiero potesse dividersi in voci. Nessuno dei due ha capito che quella del pensare è una drammatica senza phoné.
Ignarus: caro maestro non intendo più seguirti su questo piano del discorso. Troppo insidiose sono le tue parole. a qualche mia timida obiezione opporresti che non ho letto porfirio o giamblico o proclo e, con distinzioni sempre più sottili mi costringeresti a riconoscere la mia ignoranza. avrei facile gioco a risponderti che nemmeno Kant co-nosceva bene gli eclettici Neoplatonici con i loro Grillen. Dopotutto, potrei continuare, non è attraverso le filosofie altrui che si diviene fi-losofi. ma se così osassi rispondere, la mia non sarebbe altro che una hýbris stolta e maldestra, nient’altro che una goffa scimmiottatura della tragica tensione che cattura ogni pensare, autenticamente e conseguen-temente rigoroso.
Spectator: perché mai questi noiosi filosofi quando non hanno altro da dire si mettono a offendere i loro cugini. credono di aver capito in cosa effettivamente consista quell’impulso mimetico che chiamano scim-miottare, nemmeno immaginando quanto complesso e mirabile esso sia. Non sono nemmeno aggiornati al riguardo. Da altre parti, questioni del genere sono oggi prese sul serio, senza per questo dover ritenere
107_festCacciari_Desideri.indd 6 24/03/15 13:07
Trialogus imperfectus cum muta ac velata figura 7
che l’eccezione umana è giunta alla fine. Del resto non puoi compren-dere l’eccezione, se prima non conosci la regola. e questi filosofi spe-culativi presuppongono solo una scimmiottatura della regola (oibò, cosa ho mai detto! anch’io ci sono cascato, alla fine...).
Magister: come al solito i tuoi pensieri mancano di quella phanta- sía che mette ali alle cogitazioni più ardite. Non basta co-agitare nella mente spunti, osservazioni, ricordi di letture per dire che si pensa more philosophico. Bisogna far spiccare il volo ai nostri pensieri, farli uscire dalla prigione della nostra mente e capaci di danzare con fantasia e leggerezza. per questo è necessario, per usare termini scolasticamen-te più consueti, rendere immaginativo, poieticamente immaginativo il pensare. come ho letto poche ore fa nel Trialogus dell’eretico magister oxoniense, la vis aestimativa non è niente senza la vis phantastica. se tu pensassi con la dovuta consequenzialità, queste asserzioni dovreb-bero risultarti familiari. l’Urteilskraft kantiana, che tanto ti sta a cuore, non è anch’essa espressione di un “libero gioco” – “libero gioco”, hai inteso? – tra immaginazione e intelletto?
Ignarus: Immer radikal und niemals consequent, mi verrebbe da rispon-derti con le parole del più enigmatico tra i moderni cabbalisti. fede- le tanto a platone quanto alla forza della pura lettera. ma mi affiderò a un pensiero a lui affine. Nel Bene in quanto anipotetica arché si attesta l’esteriorità radicale a ogni pensiero. e tale esteriorità – questo fuori della contingenza e della gratuità – rende impossibile assimilare il co-mando a una voce interiore. la voce chiama dall’esterno del pensare e della mente. pur intesa quale vox conscientiae, non dovremmo commet-tere la leggerezza di interiorizzarla. la sua esteriorità dice l’insopprimi-bilità dello spazio e la crisi a priori di ogni idealismo, come ben colse Kant con la sua celebre Nota. se la spazialità non può essere ricondotta alla forma del tempo, come qualcuno ebbe erroneamente a pensare e proprio riguardo alle pagine della Prima Critica, c’è – il y a – un esiste-re che antecede ogni concetto e ogni pensare. e questo vale anche per tò Agathón, anzi soprattutto in questo caso. Di qui quel soffio di esternali-smo e forse anche di essoterismo senza di cui il pensiero soffocherebbe.
Magister: lo stesso potremmo esprimere usando le parole del Trialo-gus ossia che «Deum superiorem esse omni genere». Quello che non capisco è la necessità dell’arresto. e perché mai il pensiero dovrebbe
107_festCacciari_Desideri.indd 7 24/03/15 13:07
8 Fabrizio Desideri
fermarsi, una volta tolto, come residuo non lavorato dal concetto, il principio di esteriorità? semmai con questo gesto comincerebbe dav-vero la sua avventura, come del resto viene testimoniato da tutta una tradizione neoplatonica fino all’eriugena e oltre. Non hai proprio idea quante sottigliezze, quanti passi e contro-passi, quanti sentieri che si perdono per essere ripresi da capo contenga la via apofatica. Qui il paradosso è di casa.
Ignarus: il paradosso, lasciamelo dire, e anche una pletora d’immagini. Non tutti sono sobri come l’autore del Tractatus. ma forse il suo mi-stico non è affatto da intendersi apofaticamente. semmai come la pura esteriorità dell’esistere che rende insensata ogni ulteriore domanda.
Magister: Questo poi non lo capisco. Quella del grande viennese è una prospettiva interna, inaccessibile al linguaggio, riguarda quella dimen-sione rispetto a cui non possiamo far altro che tacere.
Ignarus: Qui non sono d’accordo. se il mistico dice il puro “che” del mondo nel suo semplice esistere, l’essere tutt’uno di etica ed estetica dice l’esteriorità della vita e con essa il respiro da cui nasce ogni signi-ficato. Quel respiro che egli identifica come “uso”, forma di vita.
Magister: che cosa vuoi dire? Non sarà che a corto di argomenti cerchi di buttare tutta la questione su un altro piano, che in ogni caso non mi troverebbe impreparato.
Ignarus: se di un Umweg si tratta, di una via indiretta, di un girare attorno al nucleo incandescente del nostro interrogarci quasi battibec-cando, è perché una via diretta non c’è. se con le mie metafore relative al bersaglio e all’eterna dualità tra il pensare e l’oggetto del suo amore avessi dato l’impressione di difendere una tesi intuizionista quanto al Bene e al vero, avrei senz’altro sbagliato. lasciati pure queste imma-gini alle spalle, come la scala su cui sei salito.
Spectator: ma come si fa a scendere poi! un po’ più di concretezza, suvvia!
Magister: eppure all’origine e al limite di ogni pensare vi è la memoria e la promessa di un intuire: del gettare lo sguardo nella cosa stessa, sia
107_festCacciari_Desideri.indd 8 24/03/15 13:07
Trialogus imperfectus cum muta ac velata figura 9
pure per un istante. anzi, per un istante, il vedere dell’intelletto pare trasformarsi in un toccare o almeno in uno sfiorare il proprio principio. se ben intendiamo la lezione aristotelica al riguardo, l’arché e l’éscha-ton del pensare filosofico sono necessariamente estetici.
Ignarus: così dicendo porti vasi a samo, carissimo. e a samo vi sono i labirintici tunnel di eupalino. li avrei percorsi in lungo e in largo se a un certo punto non mi fossi sentito soffocare.
Spectator: poverino, il nostro finto discepolo è anche claustrofobico. e per di più sta esagerando con questi orpelli di reminiscenze classiche.
Magister: Tutte queste metafore mi stanno stufando. Di nuovo stai pra-ticando la poco nobile arte della fuga.
Ignarus: Non è così. Non metafore erano le mie, solo ricordi. Da essi, comunque, s’impara sempre qualcosa. Di ricordi s’intesse la trama del-la nostra esperienza. ma il suo vero nutrimento è fornito da percezioni. grazie ad esse la nostra mente sta in continua relazione di scambio con il mondo, in un commercium dynamicum, vorrei dire, il cui ritmo è dettato dal respiro dell’aísthesis.
Spectator (borbottando): speriamo di non doverci sorbire l’ennesima lezioncina sulla centralità della percezione e sulla mente incarnata.
Magister (quasi avesse sentito il borbottio di Spectator, ma sappiamo che non è così): Non vorrai mica rifilarmi le solite tiritere intorno alla percezione. solitamente vanno a finire in una glorificazione della cor-poreità, del suo carattere rimosso e via discorrendo. più che attardarsi in questi vaniloqui, sarebbe l’ora di intendere seriamente in che senso e misura il corpo è un carcere.
Ignarus: a far questo ci ha già pensato peter gabriel.
Magister: Questa tua mania per gli analitici, proprio non la capisco. finché ci si limita a citare putnam, lo posso capire. ma tutti questi minori per me sono irrilevanti.
Spectator: ah, questi filosofi...
107_festCacciari_Desideri.indd 9 24/03/15 13:07
10 Fabrizio Desideri
Ignarus: forse hai ragione, anche se non hai capito il riferimento scher-zoso. Del resto quella di gabriel è una cover degli Arcade Fire. ma lasciamo perdere le canzonette, anche se un filosofo senz’altro acuto le aveva prese sul serio, intessendone l’elogio. ad ogni modo: anch’io ne ho fin sopra i capelli di queste esaltazioni del corpo e della carne. so-stenere che in ciò consiste la nostra identità suona ridicolo, soprattutto quando si comincia a invecchiare. altro avevo in mente. ossia che l’este-riorità implicata nella dinamica del percepire riguarda anche la dinamica del pensare. riguarda letteralmente la sua potenza e il suo essere in atto. concerne entrambe le figure o momenti del pensiero in guisa di un esteti-co scarto tra di essi: come il sentimento di una differenza. un sentimento senza il quale, insegna Kant, non vi sarebbe possibilità per il pensiero di orientarsi, anche – e forse soprattutto – riguardo alle cose ultime.
Magister: spiegami meglio, forse riesco a capire cosa stai dicendo, seppur con qualche contorsione e oscurità. forse siamo meno in disac-cordo di quanto i nostri primi discorsi lasciassero intravedere.
Spectator: Non mi dite che le posizioni dei nostri filosofi stanno con-vergendo fino a riconoscersi in una comune verità. se così fosse, do-vranno prender congedo dalla forma del dialogo, ammettendo il suo carattere ozioso. o mi sto sbagliando?
Ignarus: cercherò di esprimermi con la massima precisione. Non po-trò, pertanto, evitare un tono un po’ apodittico. Non sarà mai assimila-bile, in ogni caso, a un tono da “gran signore”. Nelle mie proposizioni anche la mente più umile potrà abitare. Bene: al sentimento di una differenza tra destra e sinistra che costituisce l’apriori per così dire empirico di ogni orientarsi nello spazio corrisponde il sentimento di una differenza rispetto al Bene in quanto sottratto a ogni ipotesi e alla sua negazione. Questo sentimento della differenza non precede l’arre-sto del pensare, il suo farsi ascolto, ma lo segue. in giovanissima età mi ero interrogato sulla precomprensione necessaria a questo arresto. come se vi fosse una precondizione dell’ascolto. adesso ho capito che l’ascolto è istituito nel comando. come se fosse una relazione interna comune a entrambi.
Magister: Non dire “come se fosse”, sarebbe un kantismo di troppo. l’ascolto, l’ob-audire è implicato nell’imperatività dell’appello.
107_festCacciari_Desideri.indd 10 24/03/15 13:07
Trialogus imperfectus cum muta ac velata figura 11
Ignarus: concordo in toto. sia che venga ascoltato sia che venga tra-sgredito, il significato del comando è in se stesso adempiuto. sta in un perfetto ordine logico. la relazione interna che lo regola respira nel linguaggio stesso, nel vincolo grammaticale che tiene insieme conven-zione ed espressione. e grammatica – come sostiene il nostro amato filosofo – è teologia, nient’altro che teologia.
Magister: certo. e la grammatica prevede la trasgressione, così come il Bene prevede...
Ignarus: ... la sua ignoranza. scusami se ti prevengo, ignorando a mia volta se questa era l’espressione che esitava sulla punta della tua lin-gua. l’ho invitata a ballare come si faceva con le fanciulle della nostra giovinezza. solo sostenendo l’equazione tra il male e l’ignoranza e, quindi, il loro finale dissolversi come un velo, potremmo capire che il Bene è sottratto a ogni ipotesi. Tutto il resto è drammatica, potremmo dire.
Magister: Drammatica reale, aggiungerei. al di fuori della quale non potremmo nemmeno pensarci per quello che siamo.
Spectator: anche quando paiono far professione di umiltà questi fi-losofi ostentano la sicurezza di sapere chi siamo. Non era questa la domanda delle domande?
Ignarus: Qui sei tu il frettoloso. supponendo, come se niente fosse, che possa esser pensato (o anche semplicemente immaginato) un dramma prima e fuori del discorso che ci distingue. allora rimarrebbe soltanto l’Ego animal di seneca
Magister: Duo tamen non sumus...
Ignarus: appunto, ma come può l’animal dire “ego”? Non ne possie-de la grammatica. l’affermazione, più che l’identità pura e semplice, esprime qui la separazione nell’identità, quella soglia critica tra sé e alter in cui la nostra coscienza consiste e persiste. il dramma è gram-maticale, pertanto, prima ancora che reale. solo così si conferma, per l’equazione anzidetta, che ogni drammatico prologo si svolge in cielo. come dice un grande ockhamista, nostro contemporaneo, “possiamo
107_festCacciari_Desideri.indd 11 24/03/15 13:07
12 Fabrizio Desideri
pur immaginare un linguaggio senza mondo, ma non un mondo senza linguaggio”.
Magister: così dicendo, invece che chiudere, riapri il discorso e co-stringi l’Anipotetico, in quanto vox significativa, a salire sulla giostra delle differenti forme di suppositio. Di cui, nel Trialogus anzi citato, troviamo una tardiva, ma non trascurabile, trattazione. come significa il termine anypótethon in relazione a tò Agathón? Ha il valore di una suppositio significativa (pro re, extra se ipsum) o di una suppositio ma-terialis (“pure pro se ipso”)? oppure si tratta di una suppositio mixta? Qui, caro mio, il pensiero non conosce quell’arresto che prima invocavi.
Ignarus: capisco cosa intendi, caro maestro. e presagisco dove con-duce il tuo accenno.
Spectator: Non è forse questo il destino di ogni dialogo? Dopo un po’ di tempo speso a colloquiare e a studiarsi, l’interlocutore diventa pre-vedibile in ogni sua mossa. la natura, l’indole di ognuno, il carattere, che sin dalla nascita o giù di lì contiene il nodo del nostro destino, sono più forti di ogni invenzione e riflessione. la verità di ogni dialogo, soprattutto di quello consapevole di sé, è che i suoi attori sono mario-nette, marionette senza grazia nel momento stesso che se ne avvedono. ora lo sai, ora non è più lo stesso! a tirare le fila di queste goffe crea-ture è un pensiero impersonale.
Magister: Ti stai dimostrando insopportabilmente presuntuoso. come forse sei sempre stato.
Spectator: che vi dicevo...
Magister (continuando con aria di sfida): su, prova a dire quanto ave-vo in mente! così dimostrerai la tua poca immaginazione.
Ignarus: Non seguirò il tuo invito. l’illusione da cui nasce è che la grammatica sia governata dalla logica. in tal caso il senza-ipotesi viene a significare il suo contrario, vale a dire un presupposto e dunque l’atto del presupporre: del porre in anticipo – di un im Voraus setzen come ben intese il più acuto tra i giovani romantici. si tratta di una grande illusione, ne sono consapevole. e pretendere di distruggerla sarebbe da
107_festCacciari_Desideri.indd 12 24/03/15 13:07
Trialogus imperfectus cum muta ac velata figura 13
mezzi filosofi, come diceva il nostro leopardi. Talvolta consideriamo il linguaggio muovendoci unicamente sulla superficie ghiacciata della logica. vi pattiniamo con eleganza, illudendoci che su questo piano di sottilissime astrazioni non vi sia attrito. Talaltra, però, non possiamo fare a meno di camminare, sentendone la fatica e avvertendo come il terreno ceda sotto i nostri passi. Non è forse quello che sta accadendo adesso, su questo lembo di spiaggia?
Magister: che cosa vuoi dire? Quale intentio obliqua nascondono le tue parole?
Ignarus: stavolta proprio nessuna. voglio dire semplicemente quello che dico. ma se un insegnamento dovessi trarre da quest’affermazione è che con le nostre parole facciamo molte cose tra loro diverse. Quelle del linguaggio sono performances, differenti per logica e regole inter-ne. il gioco che distingue con sagacia le diverse forme di suppositio non è quello dell’ascoltare un comando, al quale si può tanto obbedire quanto il suo contrario. Non per questo cessa di valere come tale, di funzionare secondo le regole ad esso immanenti. la grammatica, in breve, costituisce il vincolo interno a ogni drammatica.
Magister: ma se questa è teologia, allora il pensiero non può che sa-persi e mostrarsi ateo.
Ignarus: Questo lo dici tu, fraintendendo l’enfasi del mio discorso o nel senso di una postulazione etica o in quello di una rivelazione. Dirò di più, intendi l’enfasi e non quello che il discorso sobriamente dice. se schiacciamo il tasto della de-emphasis – è questione puramente tecni-ca: un dispositivo come un altro – forse ascoltiamo una musica diversa. la stessa (con le stesse note, direi), eppure diversa. Quanto mi sono proposto non ha altro valore che quello di una descrittiva chiarifica-zione. Inventio è scoprire qualcosa che stava lì, da sempre, dinanzi ai nostri occhi. prima ancora che poietica, la filosofia è mimetica: un imitation game, direi. ma...
Spectator: che cosa vuole ancora dire, non sa che il suo tempo è sca-duto.
Magister: perché sei così esitante?
107_festCacciari_Desideri.indd 13 24/03/15 13:07
14 Fabrizio Desideri
Ignarus: un ultimo passo, ci resta. in quanto esercita un’ars mimetica il filosofo non è ancora distinguibile dal sofista, rivelandosi incapa-ce di pensare l’oscillazione dell’immagine tra l’essere e il non esse-re. solo un’arte ctetica, quale la pesca, lo può catturare, se gli Dèi lo assistono. Non ti ricordi quella sottigliezza di distinzioni fatte, a tal riguardo, all’inizio dell’omonimo dialogo. sommo tra tutti i dialoghi, anche di noi parlava.
Spectator: Nessuno dei due si è accorto che il vento ha sollevato il velo che copriva la figura sullo sfondo. Non c’è velo dell’essenza, o bellez-za, che un qualche vento non possa portare via con sé. Quel che resta è nient’altro che un masso amorfo, sine figura. Lapis obsidianus, figlio del magma. sorda e indifferente, la pietra assorbe gli ultimi raggi del sole, beata nella sua solitudine.
107_festCacciari_Desideri.indd 14 24/03/15 13:07














![Commentary on M. HEIDEGGER, Costruire abitare pensare [Building Dwelling Thinking], transl. by M. BARISON, in L. TADDIO (ed. by), Costruire abitare pensare [Building Dwelling Thiking],](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6322becd63847156ac06c332/commentary-on-m-heidegger-costruire-abitare-pensare-building-dwelling-thinking.jpg)