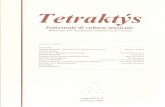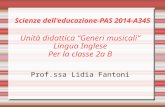Le forme del racconto. I generi narrativi di tradizione orale in Sicilia
Transcript of Le forme del racconto. I generi narrativi di tradizione orale in Sicilia
Presso ogni società la pratica del raccontare è stata formalizzata entrospecifici generi narrativi. Nell’ambito delle culture arcaiche e tradizionali,questi “generi” – mito, leggenda, fiaba, canto, dramma – possono esseresommariamente distinti secondo: a) il tema della narrazione (mitico-religio-so, epico, fiabesco, ecc.); b) le modalità performative (recitazione, canto,danza, pantomima, teatro); c) il contesto esecutivo (cerimonia, rito, intratte-nimento, spettacolo); d) la categoria degli interpreti (esecutori professionali,semiprofessionali, non-professionali).
Esemplificando, possiamo dire che una storia “sacra” può essere narrataattraverso il simultaneo ricorso a varie modalità espressive (recitazione, can-to, danza) entro un contesto rituale da esecutori specializzati e retribuiti (è ilcaso di molte rappresentazioni drammatico-musicali connesse a celebrazionireligiose); così come una narrazione di argomento fantastico si può eseguirein forma recitata entro uno spazio domestico con funzione di intrattenimentoda parte di un esecutore esperto ma non retribuito (è il caso delle fiabe). Que-sto contributo si propone di offrire una campionatura dei generi narrativi ditradizione orale rilevabili in Sicilia, con particolare riferimento alla pluralitàdei codici espressivi (vocali, musicali, coreutici, cinesici) che ne caratteriz-zano la dimensione esecutiva.
La performance della fiaba
Il repertorio favolistico è stato, almeno in tempi recenti, prevalente-mente destinato a intrattenere i bambini. Più diversificato era invece untempo il pubblico che ascoltava le fiabe (cunti), quando chi raccontava –donne o uomini che avevano acquisito una particolare competenza – allie-tava adulti e fanciulli nelle svariate occasioni della vita domestica (soprat-tutto la sera) o nelle pause dal lavoro. Il narrare, non meno di altre prati-che espressive, era una modalità di “messa in forma” dell’identità indivi-duale e di gruppo, e i racconti si caratterizzavano in base al contesto so-cio-economico e culturale di quanti ne perpetuavano la memoria, riaffer-mando così anche le proprie concezioni e aspirazioni di vita (cfr. Giallom-
Le forme del raccontoI generi narrativi di tradizione orale in Siciliadi Sergio Bonanzinga
bardo 1973, 1983b). L’ambito tematico del repertorio siciliano ricalca i “tipinarrativi” circolanti nell’area euro-mediterranea, con prevalenza delle storiedi magia, dei racconti di animali e di tesori nascosti (truvaturi), delle sto-rielle umoristico-satiriche e delle narrazioni agiografiche (cfr. Gonzenbach1870, Pitrè 1875-1888, Lo Nigro 1958, Grisanti 1981, Giallombardo 1983a,Sorgi 1989, Appari 1992, Rubini 1998). Uno spazio specifico occupanoinoltre le narrazioni cavalleresche riferibili al ciclo carolingio, materia spe-cificamente trattata dai contastorie professionali (cfr. infra). Lo sfaldarsi delrepertorio tradizionale ha proceduto di pari passo con la diffusione capil-lare della televisione avvenuta nei primi anni Settanta del secolo scorso Daquel momento i bambini – ultimi destinatari delle fiabe perlopiù narrate dainonni – hanno difatti iniziato a essere fagocitati da una programmazionetelevisiva sempre più invasiva, che è infine giunta a coprire l’intero arcodella giornata, mutando radicalmente le forme ed i contenuti dell’intratte-nimento infantile. Pur non potendo escludere sporadiche persistenze di pra-tica funzionale, oggi appare tuttavia possibile documentare le fiabe soprat-tutto attraverso le testimonianze degli anziani.
La conoscenza del repertorio favolistico tradizionale è in gran partedovuta all’opera di raccolta realizzata, soprattutto nell’Ottocento, da autoridi impostazione romantica e, successivamente, positivistica. Per la Sicilia ilcontributo più consistente è stato offerto da Giuseppe Pitrè: ben cinquevolumi pubblicati tra il 1875 e il 1888. Il celebre demologo non manca diporre in evidenza l’importanza dello stile esecutivo della palermitana Aga-tuzza Messia, che egli considera una “novellatrice-modello”: «[...] la narra-zione della Messia più che nella parola consiste nel muovere irrequietodegli occhi, nell’agitar delle braccia, negli atteggiamenti della persona tutta,che si alza, gira intorno per la stanza, s’inchina, si solleva, facendo la voceora piana, ora concitata, ora paurosa, ora dolce, ora stridula, ritraente lavoce de’ personaggi e l’atto che essi compiono» (1875, I: XIX). La descri-zione, se pure sintetica, contiene informazioni utili alla comprensione dellamolteplicità delle risorse espressive impiegate dalla narratrice. Una molte-plicità che, come puntualmente osserva Alberto Cirese, si traduce in «dif-ficoltà, se non addirittura impossibilità di riprodurre scrittualmente sia certielementi segmentali quali ad esempio le pause che oralmente possono ancheessere sonorizzate, sia l’insieme dei tratti soprasegmentali quali l’intona-zione, l’accentazione intensiva e/o musicale, il ritmo, la durata ecc.» (1991:10). L’antropologo prosegue rilevando pertanto l’inadeguatezza della rap-presentazione scritta: «In materia fiabistica infatti (e non solo in quella), laproduzione orale di un testo verbale associa ai codici fonico-uditivi anchecodici visivo-gestuali (mimica, cinesica e simili): l’informazione global-mente emessa è dunque sfaccettata o multidimensionale, ed è ovvio cheanche la più fedele e adeguata trascrizione della sua componente verbale
14 Sergio Bonanzinga
opera necessariamente una amputazione, dato che non può non escluderedal documento prodotto tutti i codici visivi co-occorrenti» (ibidem).
Come esempio di narrazione basata sull’intersezione di più codiciespressivi si propone la variante siciliana del “tipo” noto come L’osso checanta, diffuso in area europea in forma sia di fiaba sia di ballata (AT 780secondo la classificazione Aarne-Thompson 1961; cfr. anche Thompson1967: 197-199). Il tema del racconto si può così sintetizzare: 1) un giova-ne (o una giovane) uccide il fratello (o sorella) e lo seppellisce (o loannega); 2) dalle ossa dell’ucciso, o da una pianta cresciuta sul luogo dellasepoltura (o dell’annegamento), un passante (pastore, menestrello) ricavauno strumento musicale (flauto, zampogna, arpa); 3) nello strumento s’in-carna l’anima del defunto che attraverso il suono-canto accusa il responsa-bile dell’omicidio (nei termini dell’analisi morfologica di Propp, l’oggettomagico innesca la “funzione di smascheramento” del falso eroe). Nelle ver-sioni siciliane, attestate nella letteratura demologica, sono sempre presentidelle strofe cantate (Gonzenbach 1870: n. 71, ed. it. 1999: 279-297; Pitrè1875, II: 196-200; Grisanti 1909: n. 10, ried. 1981: 253-254; per una pun-tuale analisi del tema narrativo cfr. Cocchiara 1949). La melodia utilizzatanel canto non correda tuttavia nessuna di queste trascrizioni verbali (sulcantato nelle fiabe cfr. Caruso 1996). Essa è stata invece raccolta a Palermoda Alberto Favara (1957, II: n. 509), che commenta: «Così si rinnova inSicilia il mito gentile di Siringa. [...] La Sicilia è ricca, come la Greciaantica, di queste leggende musicali, dove l’essenza e la funzione dellamusica sono rappresentate con una efficacia che invano chiederemmo allenostre astrazioni metafisiche» (1959: 70-71).
Nel 1995 abbiamo potuto ancora documentare la fiaba grazie alla testi-monianza di un anziano pastore di Salemi (TP), abile suonatore di flauto dicanna (friscalettu), che alterna nell’esecuzione tre diverse modalità espres-sive: narrazione, esecuzione strumentale e canto (il documento sonoro èriprodotto in Bonanzinga cd. 2004). I tratti salienti della Liggenna dû fri-scalettu sono i seguenti: 1) un re ha due figli (maschio e femmina) e pro-mette di donare il regno a quello che sarà capace di portagli una penna del-l’uccello prù (probabile corruzione di gru); 2) i due partono alla ricerca delmitico uccello ed è la figlia a trovare la penna; 3) tornando a corte la fan-ciulla si imbatte nel fratello, che l’annega in un fiume per impossessarsidella penna; 4) dopo qualche tempo un pastore si trova a pascolare il greg-ge vicino a un canneto sorto sulla riva del fiume in cui era avvenuto l’an-negamento; 5) il pastore taglia una canna e costruisce un flauto, che appe-na completato si anima di vita propria e inizia a suonare-cantare (la me-lodia precede il canto che acquista la funzione di semantizzare il suonodello strumento): Picurareddu chi mmucca mi teni, / iò sugnu fìgghia dire cavaleri, / iè pi ppigghiari la pinna di prù, / me frati Peppi lu scillira-
LE FORME DEL RACCONTO 15
tu fu! (Pastorello che mi tieni in bocca, / io sono figlia del re cavaliere, /e per prendermi la penna del prù, / è stato quello scellerato di mio fra-tello Peppe!); 6) il pastore stupefatto e incredulo decide di recarsi a corteper consegnare il flauto al re; 7) appena il re porta il flauto alle labbra neesce di nuovo il canto (con parole diverse): Patruzzu miu chi mmanumi teni, / iò fu gghiccata nni l’acqui sireni, / iè pi ppigghiari la pinnadi prù, / me frati Peppi lu scilliratu fu! (Padre mio che mi tieni in mano,/ io sono stata gettata nelle acque serene, / e per prendermi la penna delprù, / è stato quello scellerato di mio fratello Peppe!); 8) il re, attraverso ilmagico suono-canto, viene pertanto a conoscenza della criminosa vicenda.Il narratore miscela con sapienza le proprie competenze performative, con-ferendo al racconto un’intensità drammatica non riscontrabile in altrevarianti recentemente documentate a Isnello (PA), Montedoro (CL) e Mes-sina, dove la fiaba si presenta comunque sempre caratterizzata dall’esecu-zione di parti cantate.
Storie cantate, storie raccontate
I canti narrativi in Sicilia sono tradizionalmente indicati con il terminestoria. Salvatore Salomone Marino ricorda che anche altre denominazionierano adoperate in riferimento a questo genere di componimenti (liggenna,diri, dittu), ma «il nome di Storia è il più diffuso e più universalmenteaccetto; e dopo viene quello di Liggenna» (1926: 2). In riferimento allatipologia della canzone narrativa in area italiana, Roberto Leydi osserva chein termini generali si possono distinguere due filoni principali, quello dellaballata e quello della storia: «La ballata è soprattutto diffusa nelle regionisettentrionali e centrali e conserva i suoi prodotti presumibilmente piùarcaici e organici in Piemonte. [...] La storia è diffusa nelle regioni meri-dionali e soprattutto in Sicilia. Al nord si spinge, parallelamente ad altreforme meridionali di canto lirico, verso l’Emilia» (1973: 228-229). SempreLeydi ricorda che la storia «si collega a una produzione mediterranea eorientale-balcanica» e che con «i canti narrativi dei Balcani ha in comunela lunghezza (anche centinaia di versi), il carattere disteso e ampio del rac-conto, la presenza quasi costante di un eroe o personaggio centrale. Men-tre la ballata punta sul fatto, la storia si dedica al protagonista, che seguein alcune o tutte le sue vicende» (1973: 230). In seguito all’introduzionedella stampa, le storie cominciarono a essere stampate su fogli volanti elibretti che venivano venduti dai cantastorie. I testi narravano episodi sto-rici, catastrofi naturali, avvenimenti della vita politica o di varia attualità(fatti “di sangue” o di cronaca scandalistica), racconti agiografici, eventifantastici e qualsiasi altra vicenda potesse interessare il pubblico di estra-zione popolare (cfr. Salomone Marino 1875, 1880, 1896-1901, 1926). Le
16 Sergio Bonanzinga
storie erano solitamente composte in ottave endecasillabe a rima alterna(cioè nel metro della canzuna o “ottava siciliana”), dove, nella sequenzadelle strofe, l’ultimo verso di una rimava con il primo della successiva(rima ntruccata o ncruccata). Altri metri impiegati erano la “ottava epica”(sei endecasillabi a rima alterna più i due conclusivi a rima baciata), lasestina endecasillaba, la terzina endecasillaba e la canzuna allungata (un’ot-tava siciliana con l’aggiunta di uno o più distici a rima baciata). La quar-tina di ottonari e settenari alternati veniva spesso utilizzata per le storie acarattere comico o satirico che, data l’affinità metrica con arie e canzonette,prendevano il nome di storie ad aria (Salomone Marino 1926: 13). A ogniforma metrica corrispondeva una specifica melodia, sebbene alcune storiepotessero anche avere melodie proprie.
Chi racconta cantando, di norma con l’accompagnamento di uno stru-mento musicale, oggi come in passato, svolge un vero e proprio mestie-re, disciplinato da regole prestabilite. In Sicilia, il termine utilizzato perdesignare il cantore-suonatore ambulante è orbu, considerato che erano inprevalenza ciechi quanti intraprendevano questa singolare professione. Lavicenda degli orbi è ufficialmente documentata a partire dal 1661, anno in
LE FORME DEL RACCONTO 17
Esibizione di un contastorie a Palermo (in Pitrè, 1913)
cui – secondo le fonti più accreditate – si riunirono a Palermo nella con-gregazione dell’Immacolata Concezione, sotto la protezione dei Gesuiti(tale congregazione, seguendo le sorti della Compagnia del Gesù, vennesciolta nel 1767 per essere ricostituita nel 1806). Le testimonianze relativeall’attività degli orbi nell’Ottocento offrono un quadro dettagliato sia delloro repertorio (costituito specialmente da storie sacre e musiche strumen-tali) sia delle occasioni in cui essi si esibivano dietro compenso (celebra-zioni devozionali, feste private, teatro dei pupi). Attraverso le memorie delmarchese di Villabianca, acuto osservatore della Palermo settecentesca, sap-piamo tuttavia che gli orbi avevano contribuito anche alla circolazione dicanzoni di vario argomento stampate su fogli o libretti: vicende cavallere-sche, cronaca nera, satira ecc. (ed. mod. 1991: 113). Questo tipo di reper-torio sarà in seguito recepito da una nuova categoria di cantastorie esclusi-vamente “laici”, che si esibivano nelle piazze davanti a grandi cartellonidipinti in colori sgargianti con le scene delle storie di volta in volta pro-poste. Se la tradizione degli orbi tramonta definitivamente negli anniOttanta del Novecento, sono invece ancora attivi gli altri cantastorie, spe-cializzati in componimenti che riflettono l’attualità politico-sociale ed ope-ranti, con l’ausilio di chitarra e cartelloni, in spazi marginali rispetto a quellipropri dell’industria dello spettacolo (scuole, carceri, piazze, circoli ecc.).
L’organico degli orbi era essenzialmente formato dalla coppia: un suo-natore di violino e uno di citarruni (bassetto o violoncello a tre corde, so-stituito nel Novecento dalla chitarra). A questi potevano aggiungersi altrisuonatori (di mandolino, flauto di canna, triangolo, etc.) e il gruppo man-teneva, nel gergo dei cantastorie, la denominazione di coppia, a ribadi-re la funzione preminente dei due che eseguivano prima e seconda voce(cfr. Guggino 1980: 36-40). Come si è detto, gli orbi furono particolarmen-te attivi nella capillare diffusione della poesia popolare religiosa. Questaera sostanzialmente controllata dalla Chiesa che, attraverso la scrittura, fis-sava temi e motivi destinati alla più ampia ricezione popolare (cfr. Guggi-no 1980, 1988). Gli autori che materialmente posero mano alla stesura deitesti furono sia di estrazione laica come Pietro Fullone (Palermo, XVIIsecolo) o Antonio La Fata (Catania, prima metà del XVIII secolo), sia diprovenienza ecclesiastica come il canonico Antonio Diliberto (Monreale,XVIII secolo) o il sacerdote Giovanni Carollo (Carini, seconda metà delXIX secolo). Quest’ultimo, che diresse a Palermo una “scuola per ciechi”,compose diverse antologie di canti sacri in siciliano specificamente desti-nati agli allievi propensi a intraprendere il mestiere di cantastorie. Tra icomponimenti di più duraturo successo vanno ricordati la storia di San-ta Ginueffa Girmanisa di La Fata, la cui prima stampa risale al 1735, e lanovena di Natale Viaggiu dulurusu di Maria Santissima e lu patriarcaS. Giuseppi in Betlemmi (cfr. Conigliaro-Lipari-Scordato 1987), compo-
LE FORME DEL RACCONTO 19
sta intorno alla metà del Settecento da Diliberto e ancora oggi eseguitanelle più svariate combinazioni strumentali e canore (cfr. Garofalo 1990,d. 1990). Per il suo carattere emblematico in ordine ai processi di crea-zione-trasmissione delle storie a tema religioso, si può segnalare l’ampiaproduzione poetica dialettale che, a partire dalla seconda metà del Seicento,si è andata elaborando intorno alla figura di Santa Rosalia. L’elezione diRosalia a patrona di Palermo risale al 1624, data del presunto rinvenimentodelle sue reliquie mentre la città subiva una grave pestilenza. Nei decennisuccessivi il principale obiettivo dei Gesuiti, che avevano frattanto assuntoun ruolo di primo piano nella direzione del culto, era stato quello di rico-struire la storia della Santa fissandone la nuova tradizione. Al vertice di taleproduzione documentaria si pongono le opere del gesuita palermitano Gior-dano Cascini (in particolare il libro Di S. Rosalia Vergine Palermitana,Palermo 1651), mentre la diffusione popolare del culto ormai normalizzatofu affidata a Pietro Fullone, autore di svariati poemetti in “ottave siciliane”stampati a Palermo tra il 1651 e il 1657 (cfr. Petrarca 1988 e Conigliaro-Lipari-Scordato-Stabile 1991). Furono quindi soprattutto gli orbi che segui-tarono a tramandare fino ad anni recenti la vicenda di Santa Rosaliasecondo i canoni fissati da Cascini e divulgati da Fullone (cfr. Guggino1980, 1981, 1988; Bonanzinga 1991).
Non erano tuttavia soltanto gli orbi a diffondere canti narrativi a carat-tere sacro. Questi difatti erano e sono ampiamente tramandati in ambitopopolare, entrando a far parte del repertorio di esecutori non professionaliche li ripetevano con funzione devozionale nei contesti della vita domestica(ancora oggi soprattutto le donne) oppure del lavoro (in passato prevalen-temente gli uomini). Particolare rilievo assumono inoltre i canti riguardantila passione e morte di Cristo (lamienti, lamintanzi, ladati, parti), tuttoramolto diffusi. Si tratta di canti eseguiti durante i riti della Settimana Santada gruppi maschili “specializzati”, perlopiù collegati a confraternite laicalio a categorie professionali, in forma sia monodica sia polivocale (cfr. Mac-chiarella 1995). Anche in questo caso si tratta di testi composti in formascritta e poi affidati a una trasmissione prevalentemente orale (i cantoridella Settimana Santa, come pure usavano fare gli orbi, copiano i testi inquaderni manoscritti, e di recente anche su fogli dattiloscritti, per sorreg-gere la memoria). Di un lungo componimento intitolato La Passioni diGesù Cristu (cento ottave endecasillabe), tutt’oggi eseguito, per intero o aframmenti, in diversi paesi della Sicilia centrale (tra gli altri Caltanissetta,Montedoro, Butera, Resuttano), si ricorda l’autore Deca Niculaci, di proba-bile origine contadina (cfr. Pitrè 1870-71, II: 377) ma del quale si ignora«la patria ed il tempo del poetare» (Salomone Marino 1896-1901: 265).Ancora contestualmente funzionali si conservano infine i canti legati altema del Natale, di provenienza soprattutto ecclesiastica (come il già ricor-
20 Sergio Bonanzinga
LE FORME DEL RACCONTO 21
Benedetto Miceli (zampogna) e Girolamo Patellaroeseguono la novena di Natale in una osteria della Guadagna (Palermo), 1978
dato Viaggiu dulurusu) ed eseguiti nelle tradizionali “novene” durante ilperiodo che va dall’Immacolata all’Epifania. Nelle case, davanti agli altario ai presepi, nelle strade, presso edicole votive riccamente addobbate, enelle chiese di molti paesi si cantano le storie della Natività, eseguite die-tro compenso da suonatori specializzati o in coro dai fedeli.
A Monreale, importante centro a pochi chilometri da Palermo, diversecoppie di zampognari-cantori ancora si esibiscono dietro compenso dal-l’Immacolata all’Epifania. Particolare è però lo strumento impiegato daquesti suonatori, unici in Sicilia a utilizzare la grande zampogna “a chiave”più comunemente diffusa nell’Italia centro-meridionale. Il medesimo stru-mento era adoperato dagli zampognari palermitani, la cui ultima genera-zione si è estinta all’inizio negli anni Settanta. Questi sono stati però inparte sostituiti dai ciaramiddari di Monreale, che tuttora usano recarsi asuonare presso numerose famiglie e botteghe nei rioni popolari di Palermo(Brancaccio, Cuba-Calatafimi, Mezzomonreale, Guadagna, Uditore, VillaCiambra, Boccadifalco). Dal 29 novembre al 7 dicembre si svolge la nove-na dell’Immacolata (nuvena dâ Madonna), seguita dalla novena di Natale
(nuvena i Natali) che va dal 16 al 24 dicembre. Il ciclo si chiude con l’ot-tava dell’Epifania (detta semplicemente ottava) che si celebra dal 29 dicem-bre al 5 gennaio. Le esibizioni avvengono all’interno delle abitazioni deicommittenti (davanti al presepe o a immagini sacre) oppure all’esterno sevi si trova un’edicola votiva, ancora talvolta decorata secondo consuetudinecon fronde d’agrumi cariche di frutti. I tre brani (tri caddozzi) in cui nor-malmente si articola ogni esibizione variano in funzione delle occasioni edelle richieste dei committenti (parrucciani). Il repertorio comprende cantidi argomento devozionale analoghi a quelli ampiamente attestati in Sicilianei secoli scorsi. Alcuni sono canti narrativi legati ai temi della Natività edella Passione: U caminu i san Giseppi (il viaggio a Betlemme); A la nottidi Natali (la nascita); U picuraru (l’adorazione dei pastori); I tri Re (l’ar-rivo dei Magi); Quannu la santa Matri caminava (la ricerca del CristoMorto da parte della Madonna). Altri raccontano storie di santi (SantaRusulìa, Sant’Antuninu) e la parabola del Figliol prodigo (U fìgghiu prò-ricu). Come normalmente accade nella musica di tradizione orale, un ridottonumero di melodie si adatta a testi diversi. Riguardo alle modalità perfor-mative si rileva in particolare la contrapposizione tra l’andamento libero deipreludi (varianti più o meno estese della medesima struttura melodica) e iltendenziale assestamento metrico delle parti cantate (caratterizzate dallapropensione a ricercare la massima consonanza tra l’emissione vocale e iltimbro dello strumento). La documentazione relativa alle tradizioni musi-cali di orbi-cantastorie e ciaramiddari-cantori conferma la parziale sovrap-posizione tra le due professioni. Entrambe tipicamente urbane, hanno con-diviso un repertorio poetico-musicale in gran parte analogo. Era tuttaviaesteso a comprendere l’intero ciclo annuale il mestiere “devozionale” degliorbi, mentre risulta circoscritto al periodo natalizio quello degli zampo-gnari. Questi zampognari-cantori del circondario palermitano, più sensibilia contesti semiculti e chiesastici rispetto ai suonatori di ambiente pastorale,si sono posti, non diversamente dai cantastorie ciechi, come gli attori e imediatori di un immaginario sacro ancora oggi in parte funzionale (cfr.Bonanzinga 2004).
Nella prima metà del Novecento la tradizione dei cantastorie “laici” siè tramandata e sviluppata soprattutto in alcuni paesi della provincia di Cata-nia. Nel centro costiero di Riposto nasce Orazio Strano (1904-1981).Appena ventenne, a causa di una paralisi agli arti inferiori che non gli per-metteva di compiere mestieri comuni, inizia a girare i paesi della Sicilia edella Calabria esibendosi come cantastorie. Nel 1929 incontra il poeta dia-lettale Turiddu Bella, proveniente da Mascali (alle falde dell’Etna), con cuiintrattiene un lungo e proficuo sodalizio. Bella componeva le storie e Stranole eseguiva in pubblico, vendendo prima i libretti e poi, seguendo il pro-gredire delle tecnologie, i dischi e le audiocassette. Nell’ultimo dopoguerra
22 Sergio Bonanzinga
LE FORME DEL RACCONTO 23
Il cantastorie Ciccio Rinzinu di Paternò (CT) in una esibizione degli anni Sessanta
si forma a Paternò (centro agricolo ai margini della piana del Simeto) unavera “scuola” di cantastorie. Il capostipite è stato Gaetano Grasso, attivodal 1926 al 1955 e specializzato «nella stesura dei cosiddetti “fatti suc-cessi”, cioè di storie che narravano fedelmente dei fatti accaduti» (Sergi1973: 13). Il più noto è stato invece Ciccio Busacca (1925-1989), che gra-zie alle sue straordinarie qualità drammatiche ha anche preso parte a nume-rosi spettacoli teatrali di rilievo nazionale (valga ricordare l’intensa colla-borazione con Dario Fo). Altri protagonisti sono stati Francesco Paparo(detto Ciccio Rinzinu), Paolo Garofalo, Nino Busacca (fratello di Ciccio) eVito Santangelo. Degli ultimi tre, ancora viventi, solo Santangelo continuaa esibirsi in pubblico e a comporre nuove storie (cfr. Geraci 1996). Neglianni Cinquanta, la produzione dei cantastorie si rivolge in modo particolareverso quegli eventi che più duramente stavano segnando la cronaca sici-liana (l’emigrazione, le lotte sindacali, la riforma agraria, il banditismo, lamafia, ecc.). In questo quadro acquista un ruolo di notevole importanza ilpoeta dialettale Ignazio Buttitta di Bagheria (1899-1997), che componediversi testi specificamente destinati ai cantastorie (Lamentu pi la morti di
LE FORME DEL RACCONTO 25
Turiddu Carnivali, 1956; Lu trenu di lu suli, 1963; La vera storia di Sal-vatore Giuliano, 1963). Nello stesso periodo il mestiere si modernizza attra-verso l’uso di apparecchi elettronici di amplificazione sonora. Scomparedefinitivamente la precedente forma di spettacolo, che consisteva nel can-tare davanti a un cartellone appeso al muro, e il tetto delle automobili sitrasforma in palcoscenico per i cantastorie che ora possono spostarsi inmodo molto più rapido da un paese all’altro. Anche questo tipo di spetta-colo itinerante entrerà tuttavia in crisi, fino scomparire quasi del tuttointorno al 1980. Resta invece vitale la figura del cantastorie che, pur conl’aggiornamento delle tematiche e il parziale mutamento dei luoghi di esi-bizione, continua a proporre la propria visione della realtà. Ne sono testi-monianza tra gli altri Nonò Salomone (di Sutera ma emigrato a Torino),Franco Trincale (di Militello Val di Catania ma emigrato a Milano) e For-tunato Sindoni (di Barcellona Pozzo di Gotto). Sotto il profilo esecutivo letecniche di questi cantastorie si uniformano a un modello costante. Lo stru-mento di accompagnamento è sempre la chitarra, suonata con il plettro. Imoduli musicali si fondano su semplici giri armonici, inframmezzati dabrevi interludi strumentali. Le melodie, in numero assai limitato, variano
Il cantastorie Nino Busacca di Paternò, 2002
secondo il metro poetico delle storie. Un tratto fortemente caratterizzante èdato dall’alternanza fra recitato e cantato, e in particolare dall’intonazioneutilizzata per “scivolare” dalla declamazione al canto.
I due più celebri cantastorie siciliani del Novecento, Orazio Strano eCiccio Busacca, come gli orbi del XVIII secolo (cfr. supra), hanno ese-guito, nelle loro esibizioni di piazza risalenti ai primi anni Sessanta, anchediversi canti riferibili al ciclo carolingio: Combattimento di Orlando e Agri-cane, La fuga d’Angelica, Astolfo in paradiso e sulla luna, I paladini diFrancia, su testi di Turiddu Bella e Matteo Musumeci; Storia di Orlandoe Rinaldo, su testo di Giovanni Isaia (cfr. Geraci 1996: 112-113). Le vicen-de cavalleresche, oltre a essere rappresentate nel teatro dei pupi (cfr. infra),erano d’altronde anche argomento esclusivo delle esibizioni dei contastorie(cuntastorii). Questi artisti di strada, eredi degli antichi rapsodi, declama-vano a memoria, a puntate lungo l’intero arco dell’anno, le chansons degeste del ciclo carolingio, filtrate attraverso i poemi e i romanzi italiani delQuattrocento e Cinquecento. Un folto pubblico pagante confluiva nei luo-ghi prefissati – in piazze, ville o mercati – per ascoltare la narrazione delgiorno: u cuntu, cioè “il racconto” per eccellenza. Tra gli ultimi contasto-
26 Sergio Bonanzinga
Il cantastorie Vito Santangelo di Paternò, 2002
rie siciliani si ricordano i palermitani Roberto Genovese, Tommaso Fioren-tino e Peppino Celano (che si esibivano rispettivamente a Villa Bonanno, aVilla Giulia e nel rione del Capo) e il catanese Paolo Puglisi (che raccon-tava a Villa Pacini). Le prime attestazioni dirette di questa importantetradizione narrativa risalgono solo ai primi dell’Ottocento e riguardanoanche Napoli, dove i contastorie erano chiamati rinaldi, dal nome del piùamato fra i Paladini di Carlo Magno (cfr. Rajna 1878, Croce 1936). Vacomunque rilevato che la tecnica performativa dei contastorie non puòessere il risultato di una stilizzazione recente. L’adattamento dei timbrivocali e delle posture del corpo allo sviluppo degli intrecci, l’agitare una“spada” di legno per enfatizzare contrasti e duelli, la percussione del piedeper marcare il ritmo della declamazione e, soprattutto, la particolarissimascansione fonico-ritmica adoperata dai palermitani per rappresentare le bat-taglie rinviano infatti a una koinè del racconto orale diffusa dai Balcani alNord Africa, passando per il Medio Oriente (documenti sonori relativi aGenovese e Celano sono riprodotti in Carpitella-Lomax cd. 2000 e Leydid. 1970). Venuto meno il palcoscenico tradizionale, oggi il cuntu vieneriproposto, anche con aggiornamenti tematici che vanno dalle storie deisanti a quelle delle vittime della lotta alla mafia, dal puparu (marionettis-ta) palermitano Mimmo Cuticchio, che ne ha appreso la tecnica da Celano(cfr. Di Palma 1991).
Le forme drammatiche tra rito e spettacolo
La letteratura epico-cavalleresca è anche l’argomento principale delteatro tradizionale siciliano delle marionette: l’Opra î pupi (Opera dei pupi),che a partire dai primi decenni del XIX secolo fino agli anni Cinquanta delNovecento ha riscosso enorme successo presso i ceti popolari (questo tipodi teatro era diffuso, con lievi varianti, anche in Campania, Puglia e Cala-bria). Il repertorio comprende pure drammi di contenuto sacro (vite di santi,natività e passione di Cristo), storie di briganti, alcune trame shakespeariane(Otello, Macbeth, Giulietta e Romeo) e varie rappresentazioni comiche(farsi) eseguite di norma in appendice agli spettacoli seri. I soggetti sonoin larga parte derivati da fonti scritte, anche se i dialoghi vengono improv-visati durante l’esibizione sulla base di pochi appunti schematici (analoghiai canovacci della Commedia dell’Arte). I gestori dei teatri – detti opranti,pupari o teatrinari – svolgono tutte le attività connesse alla messa in scena:manovrano e danno la voce ai pupi, talvolta li costruiscono e riparano,dipingono le scene ed i cartelloni destinati a pubblicizzare lo spettacolo delgiorno. Non diversamente dal cuntu, anche gli spettacoli dei pupi hannoinfatti carattere ciclico e possono durare fino a un intero anno di recite quo-tidiane. Nella tipologia “palermitana” i pupi misurano ottanta centimetri,
LE FORME DEL RACCONTO 27
pesano circa otto chili, hanno il ginocchio articolato, possono sguainare laspada (mediante un filo), sono dotati di ferri alla testa e al braccio destroper essere manovrati dai lati del palcoscenico. I pupi di tipo “catanese”sono alti un metro e venti, pesano sedici chili circa, hanno il ginocchiorigido, non sono dotati di meccanismo per sfoderare la spada e vengonomanovrati, sempre tramite ferri alla testa e al braccio, da un ponte situatodietro il fondale. Data questa difformità nella dimensione dei pupi, i teatri“catanesi” misurano più del doppio di quelli “palermitani”, sia nell’am-piezza del boccascena sia nella quantità dei posti a sedere (circa duecento).Gli spettacoli si tenevano, oltre che nei rioni popolari delle città, anche neipaesi, dove gli opranti sostavano per periodi più o meno lunghi assecon-dando il favore del pubblico. L’andamento ciclico, la struttura “agonistica”del racconto e la forte caratterizzazione dei personaggi consentivano al pub-blico – esclusivamente maschile – un altissimo grado di immedesimazione.Il coinvolgimento degli spettatori era inoltre rafforzato da svariate strategiesceniche (luci, rumori, musiche) e specialmente dalle straordinarie modalitàattraverso cui si rappresentavano gli scontri armati: vere danze cadenzatedal cozzare di spade, scudi e corazze con intensità crescente, finché la scenanon si copriva di guerrieri morti, decapitati o tagliati in due (come permettela meccanica di certi pupi). Si assisteva all’Opra come a una liturgia (cfr.Buttitta 1996), un giorno dopo l’altro, in costante dedizione, sacrificandoqualche spicciolo per partecipare con entusiasmo alle imprese dei cavalieri,ritenute “vere” e quindi suscettibili di autentiche reazioni: «Le reazioni con-tro il traditore possono ancora oggi esplodere in forma violenta. Avevamosentito raccontare dello spettatore che a Gela acquistò il Gano di Maganzadal puparo, lo appese ad un albero e gli sparò a lupara. L’indomani sera,quando un nuovo pupo comparve sulle scene nella parte del traditore, ilgiustiziere fece il finimondo, sostenendo che non era possibile perché Ganol’aveva levato di mezzo lui. Abbiamo sentito raccontare che a Partinico unospettatore sparò su Gano con la pistola durante lo spettacolo. Pochi anni fa,dopo la morte di Ruggiero, assassinato a tradimento da Gano, abbiamovisto con i nostri occhi uno spettatore alzarsi e venire al proscenio, togliersiuna scarpa e lanciarla più volte con violenza sul traditore» (Pasqualino1977: 44). All’inizio degli anni Sessanta, a causa della crescente pressioneesercitata dall’industria dello spettacolo cinematografico e televisivo, siavvia la crisi dell’Opra, che per sopravvivere deve distanziarsi dal suo ori-ginario contesto di fruizione per divenire uno spettacolo sostanzialmenterivolto a intellettuali, scolaresche e turisti. Oggi sono ancora attive diversefamiglie di opranti – a Palermo, Catania, Siracusa, Alcamo, Licata, Parti-nico, Sortino – che nei loro spettacoli, non più ciclicamente articolati, ten-tano di conciliare tradizione e innovazione, talvolta con risultati artisticipregevoli (cfr. Alberti 1977, Pasqualino 1977, Li Gotti 1978).
28 Sergio Bonanzinga
Le forme teatrali di genere profano si presentano oggi meno vitalirispetto a quelle di tipo sacro. Erano viceversa assai praticate in passato,in continuità con un sapere che va dai mimi della tradizione elleno-latinaalle compagnie della Commedia dell’Arte. Fino alla fine del Settecento congrande successo si mettevano in scena nei casotti (baracche adattate a tea-tri) le vastasati, un tipo di farsa basata su canovacci scritti che recuperavatipi e maschere già diffuse nel secolo precedente (Nòfriu, Virtìcchiu,Pasquinu, Peppi Nappa, Nardu, e poi il Notaio, il Prete, il Frate, il Dot-tore, ecc.; cfr. Cocchiara 1926). Nei primi dell’Ottocento il successo popo-lare delle vastasati declina in favore dell’Opera dei pupi, che non a casocontinua a mantenere le farse in funzione di appendice allo spettacolo“serio” (cfr. supra). Anche in occasione del Carnevale, fino a tempi moltorecenti e sporadicamente tutt’oggi, si sono continuate a inscenare le farse.Di norma si tratta di rappresentazioni in prosa o in versi intese a irriderepersonaggi locali (spesso politici o possidenti), a ironizzare sui vizi umanioppure a esprimere critiche verso comportamenti eccessivi rispetto allenorme etico-morali. Gli uomini interpretano anche i ruoli femminili, camuf-fandosi opportunamente e modificando la voce. Gli autori dei testi sonosolitamente poeti locali, anche se parti consistenti possono essere improv-visate secondo la circostanza. Altre azioni drammatiche carnevalesche sonola pantomima del “Mastro di campo” a Mezzojuso (PA), la recita dei “Mesidell’Anno” a Barrafranca (EN) e il “Corteo dell’Orso e della Corte princi-pesca” a Saponara (ME).
L’ultima domenica di Carnevale nella piazza principale di Mezzojusosi svolge una pantomima incentrata intorno all’azione di una mascheraguerresca: il Mastru di campu (Mastro di campo, appellativo derivante dauna figura effettivamente prevista nell’organico degli antichi eserciti spa-gnoli). Questi ha l’obbiettivo di sconfiggere il Re, arroccato insieme alla“corte” in un “castello” (realizzato su un palco di legno), e conquistare laRegina (cfr. Gattuso 1938, Buttitta-Pasqualino 1986, Bonanzinga 2003). TraCavalieri e Dame abbigliati in costumi medievaleggianti, Barone e Baro-nessa, Ingegneri, Eremiti e Maghi, Giardinere e Fofòrio, spicca la minac-ciosa maschera del protagonista, di colore rosso fuoco, dai tratti marcati dafolte sopracciglia, grossi baffi, zigomi e labbro inferiore sporgenti. Il Fofò-rio è costituito da tredici giovani col volto celato da lunghe barbe scure,abbigliati in nero con mantelli, braghe, stivali, cappellacci e fucili ad arma-collo. Questi infuriano, correndo e gridando (Fòrio, fòrio, fòrio!) agli ordinidel Capufofòrio, fino a catturare qualcuno degli astanti e condurlo in un barper farsi offrire bevande e dolciumi. Il Mastro di campo brandisce la spadamimando un combattimento al ritmo del tamburo, ostacolato dal Picuraru(Pecoraio), personificazione demoniaca che si agita al suono dei numerosicampanacci che porta alla cintola. L’Eroe sconfigge ripetutamente il Picu-
LE FORME DEL RACCONTO 29
raru, scavalcandone il corpo disteso a terra in grottesche convulsioni, e piùvolte si arrampica su una scala appoggiata al palco che rappresenta ilcastello per duellare con il Re. La prima parte della pantomima si concludecon la sconfitta del protagonista, rappresentata dal suo ferimento cui seguela “caduta” ai piedi del castello. Raccolto al volo e portato via dai compo-nenti del Fofòrio (che funge quindi da “aiutante” dell’Eroe), il Mastro dicampo tornerà in scena “magicamente” guarito, riuscendo infine a sconfig-gere il Re ed a conquistare la Regina. Alla connotazione agonistica dell’a-zione coreutica si associa quindi il tema erotico: un eroe “tellurico” – gio-vane, nervoso, impaziente, aggressivo – che per mezzo di una lotta danzatacolma di energie positive lo spazio cerimoniale, sconfigge un Re che èmetafora del tempo consumato, del “vecchio” destinato a essere rimpiaz-zato per consentire l’avvio del nuovo ciclo vitale, e lo fa proprio sottraen-dogli la femmina (per questo a Mezzojuso si dice u Re curnutu), cioènegando a lui e assicurando a sé la prospettiva riproduttiva (la discen-denza): il privilegio di rinnovare il tempo. È chiaro che i motivi erotico eagonistico concorrono a manifestare il medesimo significato, sono anzil’uno rafforzamento dell’altro, come d’altra parte accade presso innumere-voli culture in contesti sia etnologici sia folklorici: «la danza d’armi non èsolo una stilizzazione coreografica del combattimento, ma anche l’unionedelle due forze sulle quali si fonda l’incremento della crescita: la forzanegativa di difesa e la positiva, fallica» (Sachs 1966: 142). Tutti i movi-menti in scena del Mastro di campo vengono ritmati dal tamburo: a) unritmo di marcia ben scandito, detto a generala (la generale), accompagnal’arrivo in piazza del protagonista; b) un rullo (u rullu) sottolinea, assiemead alcuni colpi di “cannone”, il volteggio del protagonista – effettuatoall’interno di un cerchio tracciato a terra dagli Ingegneri – che avvia le osti-lità (si dice che il Mastro di campo fa a taddarita, cioè il pipistrello);c) un ritmo di marcia, detto a guerra, scandisce l’avanzata del Mastro dicampo, i ripetuti scavalcamenti del “Pecoraio” e i duelli con il Re; d) unaltro rullo, uguale al primo, marca il momento della “caduta”; e) la ripresadel ritmo della generala segna la conclusione della pantomima (documen-tazione sonora in Bonanzinga cd. 1996).
Questa rappresentazione carnevalesca si eseguiva anche nei rioni po-polari di Palermo (Kalsa, Borgo, Albergheria) fino alla seconda metà del-l’Ottocento, se pure in una forma ridotta alla sequenza corteo/lotta sullascala/caduta (cfr. Pitrè 1913: 276-278). L’antagonista era in questo caso un“giovane turco” (turchiceddu) o “schiavetto” (schiavuttinu) armato di sci-mitarra, e il combattimento era sempre cadenzato dal tamburo. È interes-sante rilevare come tale azione drammatica sia stata considerata la rievo-cazione parodica di un fatto storico: il tentativo fallito del conte di Modi-ca Bernardo Chiabrera di assaltare lo Steri di Palermo per catturare la
30 Sergio Bonanzinga
regina Bianca di Navarra (vedova di re Martino), sposarla e impadronirsidel Regno di Sicilia (nel 1412). Questa tesi venne dapprima sostenuta dalmarchese di Villabianca (seconda metà del XVIII secolo, ed. mod. 1986:69-73) e poi ripresa da Pitrè (1913: 267-278) per chiarire il significato diuna pantomima, denominata anche “Atto del Castello” o Pappiribella (inbase al nome alternativo del protagonista), che si presentava piuttosto enig-matica. L’azione palermitana si concludeva in ogni caso con la sconfitta delMastro di campo dopo l’assalto al Castello, e tale epilogo già caratterizzavale rappresentazioni settecen-tesche osservate dal marchese di Villabianca. AMezzojuso, la sconfitta dell’assalitore è invece solo temporanea e alla finequesti risulterà vincitore. Nota giustamente Antonio Pasqualino (1986: 47)come lo schema narrativo bifasico riscontrabile a Mezzojuso debba essere«più antico di quello che vide il Villabianca: una forma abbreviata e monca,pur se non ancora ridotta soltanto alla lotta e alla caduta dalla scala, comequelle viste da Pitrè a Palermo». In effetti lo schema narrativo del Mastrudi campu di Mezzojuso rispecchia la tipologia del “dramma di spada”, unaforma drammatica ricorrente nelle feste d’inizio d’anno e primaverili indiverse aree d’Europa (Italia continentale, Inghilterra, Francia, Spagna,ecc.), la cui struttura presenta le seguenti costanti: a) introduzione (circo-scrizione dello spazio scenico e presentazione dei contendenti); b) combat-timento (in forma di danza); c) sconfitta apparente dell’Eroe (ferito oucciso); d) cura dell’Eroe da parte di un Dottore (che medica le ferite) o diun Mago (che lo riporta in vita); e) ritorno in campo dell’Eroe che risol-verà a proprio favore la contesa (non di rado con aggiunta la conquista diuna donna); f) presenza di personaggi comici o grotteschi che svolgonoazioni di questua tra il pubblico (cfr. Weimann 1989: 58). Il fatto di stori-cizzare i personaggi contrapposti nei “drammi di spada”, attenuando incerta misura il valore originario del combattimento rituale o riplasmandoloentro l’ideologia cattolica, ricorre d’altronde in numerose circostanze. Nel-l’Inghilterra dei secoli XVII-XVIII, a esempio, eroi positivi divengono, aseconda dei tempi, San Giorgio, Oliver Cromwell o re Giorgio (cfr. Cham-bers 1933). Non deve quindi stupire, mutatis mutandis, l’assimilazione ope-rata da Villabianca fra il conte Bernardo Chiabrera e il Mastro di camposconfitto delle rappresentazioni carnevalesche palermitane.
Nel corteo carnevalesco che tuttora si svolge il Martedì Grasso a Sapo-nara (ME), sono protagonisti una Corte principesca (il Principe, la Princi-pessa, le Dame ed i Cavalieri) e un Orso (Ussu) tenuto a freno da tre Guar-diani (due con la corda e uno con la catena), sorvegliato da due Cacciatorie scortato da alcuni Battitori che eseguono un particolare ritmo con trombedi conchiglia (brogni) e tamburo (tammurinu). La rappresentazione intenderievocare, secondo la tradizione locale, la caccia e il successivo addome-sticamento di un pericoloso orso per opera del principe di Saponara. La
LE FORME DEL RACCONTO 31
La rappresentazione dei “Mesi” a Barrafranca (EN), 2002
vicenda viene quindi drammatizzata mediante l’armamentario e i compor-tamenti realmente occorrenti in una battuta di caccia. Il corteo attraversatutto il paese, con una serie di soste presso abitazioni private dove l’Ussutrova ospitalità e ristoro (fatto che rimanda a forme di questua in passatomolto più chiaramente esplicitate). L’azione dell’Ussu, abbigliato con pellidi capra e campanacci alla cintola, è caratterizzata da rincorse ed assalti alledonne del luogo, che vengono lascivamente strusciate (si dice che l’Ussufa u zzummi zzummi) e coinvolte in estemporanei balletti accompagnati daun gruppo di suonatori di banda (documentazione sonora in Bonanzinga cd.1996). Dopo ogni ballo l’Orso fa la riverenza alla dama e procede nel suoitinerario. I balli e le mimiche improvvisate per strada sono sempre ripa-gate con l’offerta di beni alimentari. I Guardiani, veri regolatori del flussocaotico, alternano momenti in cui trattengono l’Ussu ad altri in cui lolasciano libero di scorrazzare ed agire senza freni. In questo caso riscon-triamo quindi la presenza di elementi arcaici – ostentazione dell’eros edrammatizzazione della sequenza caccia-cattura-addomesticamento dell’ani-male selvatico associate ad attività di questua – riconfluiti nella più rassi-curante vicenda del Principe cacciatore.
32 Sergio Bonanzinga
Tra le forme drammatiche tipicamente connesse al Carnevale rientra la“tenzone dei Mesi”. Questo tipo di rappresentazione a tema agonistico si ri-trova, secondo diverse tipologie sceniche, in diverse regioni italiane (cfr. To-schi 1976: 612-638). I Mesi possono essere impersonati da uomini ma-scherati (a piedi o a cavallo) oppure raffigurati su carri allegorici. La sfidaprocede con l’enunciazione, declamata o cantata, di particolari testi poetici –spesso articolati in ottave o quartine di endecasillabi a rima baciata – attra-verso cui ogni Mese vanta il proprio apporto alla fecondità della natura. IMesi, armati di spada, lottano tra loro per stabilire chi dovrà essere il nuo-vo Re. Un Re, “padre” dei Mesi, evidente personificazione dell’anno appenatrascorso, destinato a essere rigenerato dall’azione vivificatrice dei suoi“figli”. Questi, come vuole l’epilogo del dramma, saranno unitamente soste-nitori del nuovo ciclo stagionale. Parole, gesti e travestimenti rinviano quin-di a una dimensione simbolica cosmologico-agraria: l’abbondanza futura vie-ne propiziata attraverso la competitiva ostentazione di quella passata. In Sici-lia, la rappresentazione era soprattutto diffusa nell’area centro-orienta-le (Caltanissetta, Montedoro, Ragusa Ibla, Chiaramonte Gulfi, Lentini, Milo).A Rodì Milici e a Tripi, due centri dei Monti Nebrodi in provincia di Messi-na, l’azione si è sporadicamente ripetuta anche di recente, con i personaggiche interpretano i “Mesi” abbigliati in modo da richiamarne le caratteristicheclimatiche e le produzioni alimentari. A Riesi questo tipo di azione dramma-tica si è ripetuta anche in anni recenti, mentre a Barrafranca permane tuttoravitale (cfr. Bonanzinga 2003).
Diverse rappresentazioni drammatiche vengono associate al Natale, allaPasqua e alla celebrazione di alcuni Santi (tra gli altri San Giuseppe, SantaLucia, San Ciro). La loro origine va ricercata nel progressivo affermarsi, trail IV e il IX secolo, di drammi sacri sui temi della Passione e della Natività.Il dramma liturgico, diffuso nell’Isola all’epoca della dominazione bizantina,assunse in seguito una più spiccata autonomia spettacolare. I canovacci desti-nati all’esecuzione pubblica, prodotti in ambiente chiesastico e quindi rigi-damente controllati, si andarono progressivamente adattando all’ambientepopolare (cfr. Buttitta 1985). Gli interpreti tendevano infatti a trasformare gliuffici (o misteri) in rappresentazioni che lasciavano ampio spazio all’im-provvisazione (anche con l’inserimento di danze, mimiche e dialoghi comicio addirittura osceni) e che erano accompagnate dall’abbondante consumo dicibo e bevande (perfino all’interno delle chiese, nonostante le reiterate proi-bizioni stabilite nei Sinodi). In alcuni centri dell’Agrigentino (Raffadali,Casteltermini, Licata, Sant’Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro) nel periodo cheva dal 26 dicembre al 6 gennaio si mette in scena la Pasturali (Pastorale),una significativa permanenza degli antichi officia pastorum. A Licata laPasturali richiede la presenza di sei personaggi: tre pastori chiamati Bardàs-saru, Marsioni e Titu (che nella tradizione locale sono i nomi dei Re Magi),
LE FORME DEL RACCONTO 33
un Curàtulu (soprintendente di masseria) e due suonatori di zampogna e cer-chietto. I pastori indossano i tradizionali costumi in pelle di capra, mentre ilCuràtulu porta un mantello. Nelle parti recitate si alternano dialoghi in ita-liano a battute improvvisate in siciliano, a sfondo comico e talvolta osceno.Alla fine i Pastori, esortati dal Curàtulu, riconoscono la nascita miracolosa eoffrono canti e sonate al Bambino (documentazione sonora in Bonanzingacd. 1996). Una diversa forma di Pastorale si inscena il giorno dell’Epifaniaa Sant’Elisabetta. I nuclei essenziali sono costituiti dalla lunga performan-ce itinerante del Nardu, figura esemplare del servo pigro e indolente, un po’scemo un po’ saggio, e dalla rappresentazione in piazza di alcuni momentidella vita di una masseria (documentazione sonora in Bonanzinga cd. 1996).Si prepara la ricotta che servirà a condire le “lasagne” (poi consumate collet-tivamente), si raccolgono l’erba e la legna, si trasporta l’acqua, si caccia ilconiglio (che viene immediatamente scuoiato, arrostito e mangiato), si cat-tura il “ladro di arance” e infine si uccide il “lupo” che minaccia di attaccareun agnello. A queste sequenze si aggiunge un epilogo del tutto autonomo,costituito dall’arrivo a cavallo dei Tri Re (i Magi) che scortano la Sacra
34 Sergio Bonanzinga
Un momento della Pasturali (Pastorale) di Licata (AG), 2002
LE FORME DEL RACCONTO 35
Famiglia in un breve percorso dalla piazza alla chiesa. Nardu partecipa aquesto corteo palesando grande stupore ed assume quindi il ruolo dello “spa-ventato” del presepe (u meravigghiatu dâ rutta). Mentre nel caso di Licatasi rileva l’adesione al modello delle Pastorali di origine ecclesiastica, aSant’Elisabetta permangono invece evidenti i tratti di un arcaico rituale pro-piziatorio agro-pastorale connesso al solstizio invernale.
Le azioni drammatiche recitate durante la Settimana Santa (martori,scinnenze, casazze), sono spesso ispirate a un testo in italiano della metà delSettecento: Il riscatto di Adamo nella morte di Gesù Cristo di Filippo Orio-les (tra le località in cui la rappresentazione è maggiormente radicata sisegnalano Delia, Grotte, Raffadali e Partanna Mondello). Accanto a questaforma di teatro sacro permangono anche numerose pantomime che rinviano aun più arcaico linguaggio rituale. Si svolgono la Domenica delle Palme e laDomenica di Resurrezione e sono connotate da: a) elementi vegetali (valgasegnalare gli imponenti fasci di palme, decorati con fiori e grappoli di dat-teri, recati in processione a Gangi, e i mazzuna – interamente coperti di fron-de verdi, frutta pregiata e primizie – infissi agli angoli dei simulacri del Cri-
Il Nardu, nella Pastorale di Sant’Elisabetta (AG), 1994
sto e della Madonna il giorno di Pasqua a Misilmeri); b) grandi banchetticollettivi (come nella “Tavola degli Apostoli” che conclude, coinvolgendotutti i devoti, la pantomima del Bammineddu a cavaddu a Realmonte il gior-no delle Palme); c) comportamenti trasgressivi (come il Giuda che si ubriacae balla durante il corteo delle Palme a Butera); d) azioni drammatiche in pre-valenza denominate “Incontri”, dove la Madonna si ricongiunge a GesùRisorto ostacolata da maschere demoniache (i Diavuli e la Morte a Prizzi) ocon l’aiuto dei Santi (in forma di “Giganti”, come accade ad Aragona, SanCataldo, Barrafranca, Aidone, Caltagirone, o trasportati sui tradizionali fer-coli come avviene in moltissime località; cfr. Giallombardo 1990, 2003). Vainoltre ricordata la singolare azione dei Giudei che scorrazzano schiamaz-zando per le strade di San Fratello dal Mercoledì al Venerdì Santo, intrufo-landosi perfino nella processione per rievocare la persecuzione del Cristocrocifisso (documentazione sonora in Bonanzinga cd. 1996).
La rappresentazione della Fuga in Egitto ricorre, attraverso la recita-zione di testi in italiano e in siciliano, nell’ambito delle feste di San Giu-
36 Sergio Bonanzinga
Declamazione delle parti di San Giuseppe a Salemi (TP), 2002
seppe (cfr. Bonanzinga 2001), mentre a Marineo la terza domenica di ago-sto si rievoca la vita di San Ciro inscenando la Dimostranza (azione dram-matica in ventidue “quadri” basata su un testo settecentesco in italiano con-tinuamente rielaborato dalla tadizione orale). A Sàvoca è invece il martiriodi Santa Lucia ad essere messo in scena la seconda domenica di agosto,attraverso una pantomima processionale che ha per protagonista il Diavu-lazzu (Diavolaccio), impersonato da un uomo che indossa un costume rossofornito di sonagli, una cintura di campanacci e una maschera in legno conocchi fiammanti e zanne ricurve (cfr. Bonanzinga 1999). Questi, brandendouna verga (croccu) al ritmo del tamburo, molesta i fedeli e tenta la Lucia(una bambina in abito bianco che viene portata sulle spalle da un devoto).Si segnala infine una singolare rappresentazione drammatica che si svolgea Scicli l’ultima domenica di maggio. In questa occasione viene celebratala Madonna della Pietà, detta “delle Milizie”, attraverso la rappresentazionedi una battaglia nella quale i Cristiani sconfiggono i Musulmani. Diversa-mente da quanto accadeva in passato, quando i dialoghi erano improvvisa-ti in siciliano, da circa un cinquantennio la sceneggiatura è in italiano etutta la recita si svolge su di un palco allestito in piazza. L’azione si con-clude con il trionfale ingresso del simulacro della Madonna (raffigurata acavallo con spada in pugno), sospinto dai devoti davanti al palco tra leacclamazioni del pubblico, l’esplosione dei mortaretti e la musica dellabanda (cfr. Bonanzinga 2002).
Raccontare per fondare il mondo
Gli studiosi di impostazione formalista e semiologico-strutturalista (daPropp a Lévi-Strauss, da Meletinskji a Greimas) concordano sostanzialmen-te nel riconoscere che raccontare significa «costruire un modello del mondo»e che «il processo del raccontare comporta in sé tutto il processo dell’orga-nizzazione culturale del mondo» (Mincu 1986: 13). Non è questa la sede peraccennare un’analisi in questa chiave dei materiali segnalati. L’affermazioneè tuttavia utile a introdurre alcune considerazioni conclusive.
Anzitutto va rilevato che, a prescindere dalla eterogeneità delle fonticui fanno riferimento i “generi narrativi” qui considerati, molto spesso ditipo extra-folklorico e basate su testi originariamente composti in formascritta, la loro funzionalità comunicativa è viceversa sempre esito dellastratificazione di competenze che riflettono una cultura di prevalente “men-talità orale” (cfr. Havelock 1973, 1987). La “messa in forma” del discorsonarrativo risponde infatti, indipendentemente dalla sue strutture di manife-stazione (recitato, declamato, cantato, danzato, drammatizzato), a un com-plesso di stili e di tecniche tradizionalmente determinati. Le accentazio-ni e le inflessioni vocali impiegate dai contastorie, dai marionettisti e dai
LE FORME DEL RACCONTO 37
cantastorie (per le parti declamate) trovano, a esempio, continuità in quelledi chi interpreta le sacre rappresentazioni (eccettuato il caso, oggi fre-quente, di azioni gestite dalle filodrammatiche che naturalmente si ispiranoad altri modelli culturali), così come lo stile figurativo scorre costante daicartelloni dei cantastorie a quelli dell’Opera dei pupi, affermando la suapersistenza anche fuori dai contesti dello spettacolo, come accade nelle pit-ture dei carretti (cfr. Buttitta 1961). Lo stesso si può dire per le “risorsegestuali”, che si uniformano a una langue tramandata per imitazione diret-ta e che chiaramente attraversa i diversi generi di performance. Un esem-pio può essere dato dal repertorio dei movimenti e dei ritmi che ricorro-no nella rappresentazione delle battaglie: dal teatro dei pupi alle esibizio-ni dei contastorie, dalle azioni carnevalesche dei Mesi e del Mastro dicampo alle danze armate come quella del Tataratà che si esegue per lafesta della Santa Croce a Casteltermini (cfr. Bonanzinga 2002). Tra lecostanti spiccano: a) l’opposizione tra la rigidità del busto e il vorticaredelle spade rette in pugno; b) i moduli ritmici che scandiscono le azioniagonistiche, realizzati sia con strumenti (rullare di tamburi, cozzare dispade ecc.) sia mediante tecniche di simulazione vocale (come accade nellacadenza fonico-ritmica impiegata dai contastorie palermitani). Questeprime indicazioni andrebbero tuttavia verificate ed estese attraverso l’ela-borazione di una grammatica delle tecniche performative del racconto tra-dizionale in Sicilia (per una utile proposta di metodo si veda Calame-Griaule 1978, 1985).
Anche sul piano dei contenuti, dove più si avverte la disparità filo-gene-tica dei materiali, è possibile individuare una notevole coesione se si consi-derano i testi nella loro dimensione comunicativa, senza cioè dissociarli dal-le funzioni e dai valori che assumono per gli interpreti e i destinatari neglieffettivi contesti di fruizione. In questo senso il corpus dei prodotti narratividella tradizione orale siciliana, a prescindere dalle differenze di ordineespressivo, riflette infatti una specifica concezione del mondo. Lo schemagenerale delle “prove qualificanti”, della “separazione” (di frequente declina-ta secondo il modulo agonistico) e della “restaurazione dell’ordine” si rige-nera, con la sua straordinaria forza esemplare, in testi di genere diverso: dal-la fiaba ai drammi sacri, dalle storie dei cavalieri a quelle dei santi. L’ideolo-gia profonda che marca la continuità di questo ampio e articolato repertorioinveste l’esigenza di ribaltare la realtà “ordinaria” con le proiezioni “straor-dinarie” della simulazione narrativa. Una simulazione che, riequilibrandoopposizioni assai spesso non risolvibili nella concretezza del vivere quotidia-no (giustizia/iniquità, rettitudine/immoralità, lealtà/slealtà, ricchezza/povertà,salute/malattia, bene/male, vita/morte), si qualifica per la sua capacità diesprimere modelli ideali in grado di rispecchiare le aspettative, le credenze, ivalori e le istanze identitarie degli individui e delle comunità.
38 Sergio Bonanzinga
BIBLIOGRAFIAAarne, A. - Thompson, S.– The Types of the Folk tale. A classification and bibliography , FF Communications n.
184, Academia Scientiarum Fennica, Helsinki 1961.Alberti, Carmelo– Il teatro dei pupi e lo spettacolo popolare siciliano, Mursia, Milano 1977.Appari, Emanuele– Le fiabe siciliane, gli echi culturali e la Germania, Herbita, Palermo 1992.Bonanzinga, Sergio– Forme sonore e devozione popolare per Santa Rosalia, in AA.VV., La rosa dell’Ercta.
Rosalia Sinibaldi: sacralità, linguaggi e rappresentazione, a cura di A. Gerbino, Dorica,Palermo 1991: 297-312.
– Tipologia e analisi dei fatti etnocoreutici, in “Archivio Antropologico Mediterraneo”,I/1-2: 77-105, 1999.
– Le glorie e i dolori del Santo Patriarca, in AA.VV., L’ara e la vampa, suppl. a “Il Pitrè. Qua-derni del Museo Etnografico Siciliano”, II/4: 25-35, 2001.
– Mori e Cristiani in Sicilia: tradizioni drammatiche e musicali, in “Archivio Antropologi-co Mediterraneo”, 3/4: 219-240, 2002.
– Un sistema cerimoniale bipolare, in Tempo di Carnevale. Pratiche e contesti tradizionaliin Sicilia, a cura di S. Bonanzinga e M. Sarica, Intilla, Messina 2003: 50-96.
– La zampogna a chiave in Sicilia, in AA.VV., Le zampogne. Gli aerofoni a sacco in Italia,a cura di M. Gioielli, Iannone, Isernia 2004: 185-218.
Bose, Fritz– Musiche popolari siciliane raccolte da Giacomo Meyerbeer, ed. it. a cura di S. Bonanzin-
ga, Sellerio, Palermo 1993 (tit. or.: Meyerbeer. Sizilianische Volkslieder, Walter DeGruyter & Co., Berlin 1970).
Bronzini, Giovanni Battista – La canzone epico-lirica nell’Italia Centro-Meridionale, 2 voll., prefazione di V. Santoli,
Signorelli, Roma 1956-61.Burgaretta, Sebastiano– ”Cuntu” e contastorie nella Sicilia d’oggi, in “La Ricerca Folklorica”, 19 (La piazza.
Ambulanti vagabondi malv iventi fieranti, a cura di G. Sanga): 121-125, 1989.Buttitta, Antonino– Cantastorie in Sicilia. Premessa e testi, in ‘‘Annali del Museo Pitrè’’, VIII-X: 149-236,
1957-59.– Cultura figurativa popolare in Sicilia, Flaccovio, Palermo 1961.– Le ‘Storie’ di Cicciu Busacca, in “Annali del Museo Pitrè”, XIV-XV: 119-218, 1963-64.
Le ‘Storie’ di Vitu Santangilu, in “Annali della Facoltà di Magistero dell’Università deglistudi di Palermo”, IV-VII: 261-421, 1963-66.
– Strutture morfologiche e strutture ideologiche nelle “storie” dei cantastorie siciliani, in“Uomo e Cultura”, 10: 159-178, 1972.
– Pasqua in Sicilia, con fotografie di M. Minnella, Grafindustria, Palermo 1978. – Il Natale. Arte e tradizioni in Sicilia, Guida, Palermo 1985. – Spettacolo, rito, marionette e pupi, in Id., Dei segni e dei miti. Una introduzione alla
antropologia simbolica, Sellerio, Palermo 1996: 229-44.Buttitta, A. - Pasqualino, A.– Il Mastro di Campo a Mezzojuso, con testi di S. Raccuglia e I. Gattuso, Associazione per
la Conservazione delle tradizioni popolari (Studi e materiali per la storia della culturapopolare, 14), Palermo 1986.
LE FORME DEL RACCONTO 39
Calame-Griaule, Geneviève– Pour une étude des gestes narratifs, Id. (a cura di), Langage e cultures africaines, Maspero,
Paris 1977: 303-59.– La gestuelle des conteurs: état d’une recherche, in AA.VV. Oralità. Cultura, letteratura,
discorso, a cura di B. Gentili e G. Paioni, Atti del Convegno Internazionale (Urbino, 21-25.VII.1980), Edizioni dell’Ateneo, Roma 1985: 301-11.
Caruso, Fulvia– Il cantato nella fiaba di tradizione orale: uno studio preliminare, in “Lares”, LXII/3: 421-
440, 1996.Chambers, Edmund K.– The English Folk-Play , Oxford University Press, Oxford 1933.Cirese, Alberto M.– Introduzione, in AA.VV., Da spazi e tempi lontani. La fiaba nelle tradizioni etniche, a cura
di D.A. Conci, Guida, Napoli 1991: 7-20.Cocchiara, Giuseppe– Pietro Fullone e la poesia popolare sacra in Sicilia, in “Il Folklore Italiano”, I/2-3: 196-
208, 1925.– Le vastasate. Contributo alla storia del teatro popolare, Sandron, Palermo 1926.– L’osso che canta, in Id., Genesi di leggende, Palumbo, Palermo 1949: 107-149.Conigliaro, F. - Lipari, A. - Scordato, C.– Narrazione teologia spiritualità del Natale. Viaggiu dulurusu di Maria Santissima e lu
Patriarca S. Giuseppi in Betlemmi, L.I.S., Palermo 1987.Conigliaro, F. - Lipari, A. - Scordato, C. - Stabile, F.M.– La Rosalia, Poema epico di Petru Fudduni. Storia teologia spiritualità, Poligraf, Palermo.Croce, Benedetto – I “Rinaldi” o i contastorie di Napoli, in “La Critica”, XXXIV: 70-74, 1936. D’Ancona, Alessandro– Canti narrativ i del popolo siciliano, in “Rassegna Settimanale”, VI/131: 449-454, 1880. De Stefani, Lidia – L’ultimo cantastorie, in “Sicilia Mondo”, I, 1 (marzo 1956).Di Giovanni, Vincenzo – Della poesia epica in Sicilia, in “Nuove Effemeridi Siciliane”, III/3: 241-276, 1876.Di Palma, Guido– La fascinazione della parola. Dalla narrazione orale al teatro: i cuntastorie, Bulzoni,
Roma 1991.Eberle, Oskar– Cenalora. Vita, religione, danza, teatro dei popoli primitiv i [1955], trad. it. Il Saggiato-
re, Milano 1996.Favara, Alberto– Canti e leggende della Conca d’Oro, in “Rivista d’Italia”, XXVI: 287-303; ried. in Id.
1959: 58-85 e in “Nuove Effemeridi”, III (1990), 11: 176-188, 1923.– Corpus di musiche popolari siciliane, 2 voll., a cura di O. Tiby, Accademia di Scienze Let-
tere e Arti di Palermo, Palermo 1957.– Scritti sulla musica popolare siciliana - Con un’appendice di scritti di U. Ojetti, C. Bellai-
gue, E. Romagnoli e A. Della Corte, a cura di T. Samonà Favara, De Santis, Roma 1959.Garofalo, Girolamo– U viaggiu dulurusu, in “Nuove Effemeridi”, III/11: 107-119, 1990.Gattuso, Ignazio– Il Mastro di Campo, Tumminelli, Palermo 1938.
40 Sergio Bonanzinga
Geraci, Mauro– Le ragioni dei cantastorie. Poesia e realtà nella cultura popolare del Sud, Il Trovatore,
Roma 1996.Giallombardo, Fatima– La ricerca di un nuovo status sociale nella narrativa popolare siciliana, in “Uomo e cultu-
ra”, VI/1-2: 126-159, 1973.– La raccolta SIC/C (Sicilia occidentale) nell’Archiv io Etnico Linguistico-musicale della
Discoteca di Stato, in “Fonti Orali Studi e Ricerche”, III/2-3: 17-20, 1983a.– Ritratti di narratori. Incontro con la zia Maricchia, in “Fonti Orali Studi e Ricerche”,
III/2-3: 51-53, 1983b.– Festa orgia e società, Flaccovio, Palermo 1990.– La tavola l’altare la strada. Scenari del cibo in Sicilia, Sellerio, Palermo 2003.Gonzenbach, Laura– Sicilianische Märchen, 2 voll., Engelmann, Leipzig 1870 (trad. it. Fiabe siciliane, rilet-
te da V. Consolo, a cura di L. Rubini, Donzelli, Roma 1999).Guggino, Elsa– I canti degli orbi. 1. I cantastorie ciechi a Palermo, Folkstudio (Archivio delle tradizioni
popolari siciliane, 4), Palermo 1980. – I canti degli orbi. 2. I quaderni di Zu Rusulinu, Folkstudio (Archivio delle tradizioni popo-
lari siciliane, 6), Palermo 1981.– I canti degli orbi. 3. I quaderni di Zu Rusulinu, Folkstudio (Archivio delle tradizioni popo-
lari siciliane, 20-21), Palermo 1988.Greimas, Algirdas J.– Semantica strutturale [1966], trad. it. Rizzoli, Milano 1968a.Grisanti, Cristoforo– Folk lore di Isnello, Reber, Palermo 1909; ried. a cura di R. Schenda, Sellerio, Palermo
1981.Havelock, Eric A.– Cultura orale e civ iltà della scrittura. Da Omero a Platone [1963], Introduzione di B. Gen-
tili, trad. it. Laterza, Bari 1973.– La Musa impara a scrivere. Riflessioni sull’oralità e l’alfabetismo dall’antichità al giorno
d’oggi, trad. it. di M. Carpitella, Laterza, Bari 1987, pp. 180 (or. ing. 1986). Lévi-Strauss, Claude– Antropologia strutturale [1958], trad. it. Il Saggiatore, Milano 1966.Leydi, Roberto– Cantastorie, in AA.VV., La Piazza. Spettacoli popolari italiani, Edizioni del Gallo, Mila-
no 1959: 275-389.– I canti popolari italiani. 120 testi e musiche scelti e annotati, collaborazione di S. Man-
tovani e C. Pederiva, Mondadori, Milano 1973.– Monteverdi, il Tasso e il contastorie, in “I quaderni della Civica scuola di musica di Mila-
no”, 4-5 ottobre 1981: 13-18.Li Gotti, Ettore– Il teatro dei pupi, con prefazione di G. Cusumano, Flaccovio, Palermo 1978 (I ed. 1957).Lo Nigro, Sebastiano– Racconti popolari siciliani. Classificazione e bibliografia, Olschki, Firenze 1958.Macchiarella, Ignazio– I canti della Settimana Santa in Sicilia, Folkstudio (Archivio delle tradizioni popolari
siciliane, 33-34), Palermo 1995b.Mazzoleni, Achille – Gli ultimi echi della leggenda cavalleresca in Sicilia, in “Atti e Rendiconti della Accade-
LE FORME DEL RACCONTO 41
mia di Scienze, Lettere ed Arti dei Zelanti e P.P. dello studio di Acireale” 1891, n. s., III:45-69.
Meletinskji, Eleasar M.– La struttura della fiaba [1969], trad. it. Sellerio, Palermo 1977.Mincu, Marin– Mito, fiaba, canto narrativo. Le trasformazioni dei generi letterari, Bulzoni, Roma 1986.Pasqualino, Antonio– L’opera dei pupi, Sellerio, Palermo 1977.– La storia trasfigurata, in Buttitta-Pasqualino 1986: 47-51.– Le v ie del cavaliere, Bompiani, Milano 1992.Perret, Rosalia– “U cuntu”, in “Annali del Museo Pitrè”, V-VII, 1954-56: 107-113.Petrarca, Valerio– Di Santa Rosalia Vergine Palermitana, Sellerio, Palermo 1988. Pitrè, Giuseppe– Canti popolari siciliani raccolti ed illustrati, 2 voll., Pedone Lauriel, Palermo 1870-71 (II
ed. 1891).– Fiabe, novelle e racconti popolari siciliani, 4 voll., Pedone Lauriel, Palermo 1875.– Delle tradizioni popolari cavalleresche in Sicilia, Tip. Montaina, Palermo 1881.– Fiabe e leggende popolari siciliane, Pedone Lauriel, Palermo 1888.– Usi e costumi credenze e pregiudizi del popolo siciliano, 4 voll., Clausen, Palermo 1889.– La famiglia, la casa, la v ita del popolo siciliano, A. Reber, Palermo 1913.Propp, Vladimir Ja.– Morfologia della fiaba [1928], con un intervento di C. Lévi-Strauss e una replica dell’au-
tore, a cura di G.L. Bravo, trad. it. Einaudi, Torino 1966.– Le radici storiche dei racconti di fate [1946], introduzione di A.M. Cirese, trad. it. Borin-
ghieri, Torino 1972 (I ed. it. 1949).– La fiaba russa. Lezioni inedite [1984], a cura di F. Crestani, trad. it. Einaudi, Torino 1990.Rajna, Pio – I “Rinaldi” o i contastorie di Napoli, in “Nuova Antologia”, XII, 1878: 557-579.Rigoli, Aurelio– Scibilia nobili e altre “storie”, Guanda, Parma 1965.– La Baronessa di Carini. Tradizione e poesia, Flaccovio, Palermo 1984 (I ed. 1963, II ed.
1975).Rubini, Luisa– Fiabe e mercanti in Sicilia, Olschki, Firenze 1998.Sachs, Curt– Storia della danza [1933], prefazione di D. Carpitella, trad. it. Il Saggiatore, Milano
1966.Salomone Marino, Salvatore– Storie popolari in poesia siciliana riprodotte sulle stampe de’ secoli XVI, XVII e XVIII,
Tip. Fava e Garagnani, Bologna 1875.– Leggende popolari siciliane in poesia, raccolte ed annotate, Pedone Lauriel, Palermo
1880.– Le storie popolari in poesia siciliana messe a stampa dal secolo XV ai dì nostri, in
“Archivio per lo studio delle tradizioni popolari”, 1896-1901, XV: 105-130, 153-189;XVI: 94-122, 562-584; XVII: 477-512; XVIII: 176-216, 419-442; XIX: 48-64, 327-364;XX: 267-272.
42 Sergio Bonanzinga
– La baronessa di Carini, ed. introdotta e curata da G. Cocchiara, Libreria Tirelli, Catania1926 (I ed. 1870, II ed. 1873, III ed. 1914).
Sergi, Placido– Tradizione e personalità nei cantastorie di Paternò, Tip. Marchese, Paternò 1973.Sorgi, Orietta– Preti, frati e monache nei racconti popolari siciliani, Folkstudio (Archivio delle tradizio-
ni popolari siciliane, 22), Palermo 1989.Thompson, Stith– La fiaba nella tradizione popolare [1946], trad. it. Il Saggiatore, Milano 1967.Toschi, Paolo– Fenomenologia del canto popolare, Edizioni dell’Ateneo, Roma 1947.– Le origini del teatro italiano, Boringhieri, Torino 1976 (I ed. 1955).Villabianca, Emanuele e Gaetani (marchese di)– Descrizione della Sicilia e storie siciliane, ed. mod. a cura di S. Di Matteo, Giada, Palermo
1991.Weimann, Robert– Shakespeare e la tradizione del teatro popolare. Studio sulla dimensione sociale del dramma
[1968, ed. or. ted.], trad. it. condotta sull’ed. aggiornata ing. del 1978, Il Mulino, Bologna1989.
DISCOGRAFIA (d. = disco, cd. = compact disc)
Balloni, S. - Riva, V. – d. Sicilia 2. Lamentu pi la morti di Turiddu Carnivali, Music EPM 30001, con note di
copertina, 1967a.– d. Sicilia 3. La storia di Giuliano, Music EPM 30002, con note di copertina, 1967b.Bonanzinga, Sergio– cd. I suoni delle feste. Musiche e canti, ritmi e richiami, acclamazioni e frastuoni di festa
in Sicilia, Folkstudio, Palermo, 1996.– cd. Sicile. Musiques populaires, Collection Ocora, Radio France, Paris 2004. Busacca, Ciccio– d. Un uomo che v iene dal sud, I Dischi del Sole DS 1006-8, con inserto di copertina,
1992 (ried. in cd nel 1996).Carpitella, D. - Lomax, A.– cd. Italian Treasury: Sicily. Sicilian Traditional Music collected by Alan Lomax and Die-
go Carpitella in July 1954, “Alan Lomax Collection”, Rounder Records, Cambridge(Mass.), texts and notes by S. Bonanzinga, M. Geraci, A. Lomax, G. Plastino and M.Sarica, 2000.
Fugazzotto, G. - Sarica, M.– cd. I doli dû Signuri. Canti della Settimana Santa in Sicilia (Provincie di Catania, Enna e
Messina), Taranta-SudNord-Arché TA10-SN0042, con libretto allegato, 1994.Garofalo, Girolamo– d. Il Natale in Sicilia, 2 dischi, Albatros ALB 23, 1990.– cd. (a cura di), Verso la notte di Natale. Novene e canti sulla Sacra Famiglia dalla tradi-
zione dei cantastorie ciechi, Teatro del Sole TDS 982005 MDS, 1998.Garofalo, G. - Guggino, E.– d. I cantastorie ciechi a Palermo, Albatros VPA 8491, con libretto allegato, 1987.– cd. Sicily. Music for the Holy Week , Auvidis-Unesco D 8210, con libretto allegato,
LE FORME DEL RACCONTO 43
1993. Leydi, Roberto– d. Italia vol. 2 - La canzone narrativa, lo spettacolo popolare, Albatros VPA 8088, con
note di copertina, 1970.Lo Castro, N. - Sarica, M.– cd. ’A cantata di li pasturi. Il Natale nella tradizione musicale della provincia di Messina
(Sicilia), Taranta-SudNord-Arché TA08-SN0038, 1993.
44 I SENTIERI DEI NARRATORI