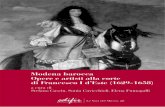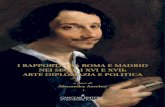«Merita la mia vita d’esser narrata?». L’incipit nel racconto autobiografico degli artisti...
-
Upload
abacatanzaro -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of «Merita la mia vita d’esser narrata?». L’incipit nel racconto autobiografico degli artisti...
MARIA SAVERIA RUGA
«MERItA lA MIA VItA d’ESSER nARRAtA?».l’incipit nEl RAcconto AUtobIoGRAfIco
dEGlI ARtIStI ItAlIAnI dEl SEcondo ottocEnto
estrattoda
lEttERE ItAlIAnEAnno lxVI • numero 3 • 2014
l E o S. o l S c H K I E d I t o R Ef I R E n Z E
2014
LETT
ERE
ITA
LIA
NE
Ann
o L
XV
I n.
3
2014
Leo S. Olschki EditoreFirenze
Anno LXVI • numero 3 • 2014
Carlo Ossola e Carlo Delcornodirettori
LETTERE ITALIANEgià diretta da Vittore Branca e Giovanni Getto
ISSN 0024-1334
LETT
ERE
ITA
LIA
NE
Ann
o L
XV
I n.
3
2014
Leo S. Olschki EditoreFirenze
Anno LXVI • numero 3 • 2014
Carlo Ossola e Carlo Delcornodirettori
LETTERE ITALIANEgià diretta da Vittore Branca e Giovanni Getto
ISSN 0024-1334
Articoli
D. Santero, Abbracciare l’ombra. codice e critica del ritratto galante in Giovan Francesco Loredano . . . . . . . . . . . .
S. Munari, Le cid sur la scène des collèges entre France et italie .
Maria Saveria ruga, «Merita la mia vita d’esser narrata?». L’incipit nel racconto autobiografico degli artisti italiani del secondo Ot-tocento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Note e Rassegne
P. rinolDi, in margine ad una recente edizione del fiore . . . .
g. Jori, nome e mito. «il catullo degli epitalami» nella canzone Al Metauro (vv. 31-40) . . . . . . . . . . . . . . . .
D. aricò, illustrare la guerra con «la penna e il compasso». Algarotti e i ‘commentari’ di cesare del palladio . . . . . . . . . .
g. Petrucci, Su un nuovo commento alle occasioni montaliane . .
Recensioni
antonio urceo coDro, Sermones i-iV, a cura di l. chines con premessa di E. Raimondi (A. Mantovani), p. 453 - a. Manzoni, Gli Sposi promessi. Seconda minuta (1823-1827), a cura di b. colli e G. Raboni (S. contarini), p. 456 - caterina percoto: tra «impegno di vita» e «ingegno d’arte», Atti del convegno di Manzano (Udine), 17-18 novembre 2012, a cura di f. Savorgnan di brazzà (S. Uroda), p. 461
I Libri: «Lettere Italiane» tra le novità suggerisce … (si parla di branca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Libri ricevuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direzione :Gian luigi beccaria, carlo delcorno, cesare de Michelis, Maria luisa doglio,Giorgio ficara, fabio finotti, Marc fumaroli, claudio Griggio, Giulio lepschy,
carlo ossola, Gilberto Pizzamiglio, Jean Starobinski
la Redazione della rivista è affidata al condirettore Gilberto PizzamiglioRedazione :
Giovanni baffetti, Attilio bettinzoli, bianca Maria da Rif,cristiana Garzena, Giacomo Jori, Annick Paternoster
Pubblicato nel mese di dicembre 2014
Pag. 465
» 467
Pag. 333
» 356
» 374
» 393
» 405
» 419
» 440
lEttERE ItAlIAnEAnno lxVI • numero 3 • 2014
«Merita la mia vita d’esser narrata?».1
L’incipit nel racconto autobiograficodegli artisti italiani del
secondo Ottocento
L’attenzione alle domande retoriche che si registrano negli inci- pit di volumi particolarmente significativi per la cultura lettera-ria e politica del Risorgimento italiano – quali I miei ricordi del pitto-re, scrittore e uomo di stato Massimo d’Azeglio (Torino, 1728-1866), da cui è tratta la citazione che compare nel titolo – sembra trovare un riverbero nelle scelte di apertura di un novero di autobiografie di artisti italiani del XIX secolo, rivelando una serie di occorrenze tali da dover essere indagate. Questa lettura, che si sofferma sulle intenzioni preliminari che agiscono sull’autore inducendolo a inse-rire le proprie vicende personali in un discorso storico più ampio, contribuisce a precisare elementi utili nel disegnare l’immagine ed il ruolo dell’artista nella società italiana coeva, quale ulteriore tassello di ricostruzione dell’ambiente artistico tra Napoli e Firenze nei de-cenni pre e postunitari.2
1 M. d’azeglio, I miei ricordi, 1866, pubblicati postumi, Firenze, G. Barbèra Editore, 1867; ed. consultata: a cura di A. Pompeati, Varese, UTET, 2011, p. 67.
2 Il tema è al centro della tesi di dottorato che sto completando presso l’Università di Pisa, dal titolo: La «fucina» di Andrea Cefaly: un crocevia di artisti tra Napoli, Firenze e Parigi (tutor prof. Vincenzo Farinella). Sono grata al prof. Carlo Ossola per avere inco-raggiato la pubblicazione di questo contributo, presentato nel contesto delle giornate re-sidenziali della Scuola dottorale confederale dell’Università della Svizzera Italiana (Kunst-historisches Institut in Florenz, ottobre 2013), e al prof. Gerhard Wolf, tutor di questo approfondimento sulle Memorie d’artista (KHI). Ad Hannah Baader e Giovanna Capitelli va la mia gratitudine per le preziose osservazioni nell’orientare la ricerca. Ringrazio inol-tre per gli utili spunti d’approfondimento: Vincenzo Farinella, Sara Garau, Giacomo Jori, Carla Mazzarelli, Ettore Spalletti.
«Merita la mia vita d’esser narrata?» 375
Accanto al modello proposto da d’Azeglio, altro elemento fon-damentale per la costruzione della dimensione culturale del pensie-ro risorgimentale è costituito dal volume Ricordanze della mia vita di Luigi Settembrini (Napoli, 1813-1876),3 personalità di riferimento per tutta una generazione di artisti patrioti che partecipano alla dissi-denza critica rispetto all’insegnamento accademico napoletano e che tutti hanno lasciato esempi, come si vedrà, di ‘scrittura della propria immagine’: Francesco Saverio Altamura (Foggia, 1822 - Napoli, 1897), Domenico Morelli (Napoli, 1823-1901), Bernardo Celentano (Napoli, 1835 - Roma, 1863), Michele Cammarano (Napoli, 1835-1920). Set-tembrini attraverso l’insegnamento, Francesco De Sanctis – che curò l’edizione postuma delle Ricordanze – con le sue lezioni, Pasquale Villari – che a sua volta editò i ricordi di De Sanc tis – 4 costituiro-no tre interlocutori cardine per i giovani ribelli del Reale Istituto di Napoli, tutti ricordati nelle loro memorie.
Evocando, in questo contesto, le pubblicazioni d’invenzione ad opera di artisti 5 si registra in questi anni un incremento consistente
3 l. SetteMbrini, Ricordanze della mia vita, pubblicazione postuma a cura di F. De Sanctis, Napoli, Antonio Morano Editore, 1879; ed. consultata: Ricordanze della mia vita. Edizione integra con prefazione di Francesco De Sanctis e note ad uso del popolo e delle scuole a cura di Ettore Fabietti, Sesto San Giovanni, 1935; ristampa anastatica Catanzaro, Edizioni la rondine, 2011.
4 P. Villari, La giovinezza di Francesco De Sanctis. Frammento autobiografico, Napoli, Cav. Antonio Morano Editore, 1889. Una testimonianza sulla percezione di questi scritti nei contemporanei è in g. M. zaMPini, Giovanni Duprè e i suoi ricordi autobiografici, con un discorso di a. Conti, Giovanni Duprè come artista e come uomo, Discorso letto al Circolo Filologico di Firenze, Torino, Tipografia Giulio Speirani e figli, 1885, p. 59 sgg.
5 Per una bibliografia essenziale sulle fonti oggetto di ricerca cfr.: F. S. altaMura, Vita e arte, Napoli, Cav. Aurelio Tocco Editore, 1896 (ed. consultata in: Saverio Altamura. Pittore-patriota foggiano nell’autobiografia, nella critica e nei documenti, a cura di M. Si-mone, Foggia, Studio editoriale dauno, 1965); a. CeCioni, Scritti e ricordi, Firenze, Tipo-grafia domenicana, 1905; L. Celentano, Bernardo Celentano. Due settennii nella pittura. Notizie e lettere intime, pubblicate nel ventesimo anniversario della sua morte dal fratello Luigi, Roma, Tip. Bodoniana, 1883; n. CoSta, Quel che vidi e quel che intesi, a cura di G. Guerrazzi Costa, Milano, F.lli Treves Edit. Tip., 1927; l. CalaMatta, Memorie auto-biografiche. Documenti inediti del Fondo George Sand (BHVP), a cura di R Dinoia, Roma, Palombi, 2011; M. CaMMarano, Memorie d’artista, ms. 1898-1916 ca. (cfr. qui nota 47); g. de nittiS, Notes et souveniers du peintre Joseph de Nittis, Paris, Ancienne Maison Quan-tin Librairies-Imprimeries reunies, 1895; g. duPrè, Pensieri sull’arte e ricordi autobiografi-ci, Firenze, Le Monnier, 1879 (ed. consultata: Firenze, Successori Le Monnier, 1907); g. Fattori, Scritti autobiografici editi e inediti, a cura di F. Errico, Roma, De Luca, 1980; F. Hayez, Le mie memorie, Milano, Reale Accademia di belle arti, 1890 (ed. consultata: a cura di F. Mazzocca, Vicenza, Neri Pozza, 1995); d. Morelli, Ricordi della scuola napoletana di pittura dopo il ’40 e Filippo Palizzi, Napoli, A. Tessitore & Figlio, 1901 (ed. consultata: a
Maria Saveria Ruga376
di scritture della memoria redatte da pittori e scultori: genere che presuppone registri molto diversi in cui rientrano ricordi, raccol-te epistolari, diari, autobiografie.6 Ne emerge una geografia artisti-ca degli scritti che percorre l’asse politico tra la Toscana e il Meri-dione d’Italia, con coordinate all’interno delle quali si stabilisce un confronto sia sul piano politico che artistico.7 Firenze accoglie l’eso-do dei pittori rivoluzionari della scuola napoletana dopo il maggio 1848 che qui prendono parte alle adunanze del Caffè Michelan-gelo, ritrovo dei macchiaioli, tra le punte più avanzate del dibatti-to artistico dell’epoca; luogo tradotto in una celebre caricatura di Adriano Cecioni (Artisti al caffè Michelangelo, collezione privata) 8 – artista che si colloca anch’egli sull’asse Napoli-Firenze –, un ac-querello in cui si guadagna un posto anche il già citato napoletano Altamura.
Queste fonti si collocano poi in un arco temporale che segue la conclusione del processo risorgimentale. Tutti questi artisti-scritto-ri – che avevano condiviso aspirazioni unitarie, molti come garibal-dini – mettono mano alle carte quasi al termine della loro carriera, voltandosi indietro e ripercorrendo la loro esistenza in una stagione storicamente determinata dalla nascente questione meridionale e da una forte disillusione sul piano politico, sociale ed esistenziale. Sono anni scanditi dalle mobilità degli artisti per le esposizioni universali e nazionali, dai primi congressi artistici in cui pittori e scultori si con-frontano sul rinnovamento dell’educazione artistica nelle Accademie, sulla funzione dell’artista e la ricerca di una dimensione ‘pubblica’,
cura di V. Caputi, Napoli, ESI, 2012); g. l. Mellini, Francesco Podesti: Memorie biogra-fiche, trascrizione di M. T. Barolo, «Labyrinthos», 1-2, 1982, pp. 203-253; M. t. barolo, Note alle memorie di Francesco Podesti, «Labyrinthos», 3-4, 1983, pp. 128-196; g. toMa, Ricordi di un orfano, Napoli, Tip. Pontieri e Velardi, 1898; t. Signorini, Le 99 discussioni artistiche, Firenze, Tip. Dell’Arte della stampa, 1877.
6 Nella densa bibliografia sul tema si rimanda qui ai testi fondamentali: P. lejeune, L’autobiographie en France, Paris, A. Colin, 1971; id., Le pacte autobiographique, Paris, Éditions du Seuil, 1975 [trad. it. di F. Santini, Il patto autobiografico, Bologna, il Mulino, 1986]; M. guglielMinetti, Memoria e scrittura. L’autobiografia da Dante a Cellini, Torino, Einaudi, 1977; a. battiStini, Lo specchio di Dedalo. Autobiografia e biografia, Bologna, il Mulino, 1990.
7 Cfr. S. Pinto, Arte e Risorgimento a misura di Garibaldi, in Garibaldi: arte e storia, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia e Museo Centrale del Risorgimento, 23 giugno - 31 dicembre 1982), Firenze, Centro Di, pp. 18-27: 24.
8 e. SPalletti, Gli anni del caffè Michelangelo (1848-1861), Roma, De Luca, 1985, la caricatura è riprodotta a p. 68, fig. 48.
«Merita la mia vita d’esser narrata?» 377
si ripensa il ruolo della committenza, ci si rivolge a fruitori diversi e diviene quindi necessaria una strategia mediatica.
Nella storia della critica letteraria, un lapidario giudizio sugli scritti d’artista del secondo Ottocento è quello di Benedetto Croce: «non debbono aspettarsi acquisto di cose di gran pregio artistico […], ma la conoscenza di disposizioni d’animo individuali e socia-li, di sentimenti e di concetti, degni di alcuna memoria».9 Eppure, oltrepassati gli evidenti pregiudizi di merito di Croce – che pure aveva curato nel 1915 l’edizione degli scritti d’arte di Morelli e Dal-bono sulla scuola napoletana di pittura –,10 un approccio a questi documenti che ricerchi le interferenze nei modelli, visivi e cultura-li, attivi nell’autore nel momento in cui decide di avviare la propria opera scritta, chiarisce come questo impulso autobiografico – in un circoscritto arco temporale – veicoli anche un problema di identità strettamente connesso al «rapporto dell’uomo (di ogni uomo) con la propria immagine»,11 alla rappresentazione di sé «comune ad ogni uomo, non solo artista».12
Poiché il corpus di documenti fa riferimento ad autori la cui di-mensione abituale è più figurativa che letteraria, è necessario in-cludere un confronto misurato all’interno del genere del ritratto e dell’autoritratto, in una dinamica tra pulsione autobiografica e rap-presentazione di sé, per valutare se le immagini possano o meno es-sere considerate quali trasposizioni visive di una stessa volontà auto-riale.13 Una riflessione quest’ultima che parte dalla testimonianza di Gustave Courbet del maggio 1854, in cui il pittore afferma la possi-
9 b. CroCe, La letteratura della nuova Italia. Saggi critici, VI, Bari, Laterza, 1974, p. 6, riportato nello studio che qui si segnala: P. Sabbatino, Le città indistricabili. Nel ventre di Napoli da Villari ai De Filippo, cap. III, Pitture di Napoli nelle scritture degli artisti. Du-prè, Celentano, Toma, Morelli, Napoli, ESI, 2007, pp. 113-166: 116.
10 d. Morelli, e. dalbono, La scuola napoletana di pittura nel secolo decimonono ed altri scritti d’arte, a cura di B. Croce, Bari, Gius. Laterza & Figli, 1915.
11 S. Ferrari, Lo specchio dell’io. Autoritratto e psicologia, Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 4. Cfr. d. deMetrio, Scrivere la propria immagine. Riflessioni sull’autobiografia come magnifi-ca finzione, in AutoFocus. L’autoritratto fotografico tra arte e psicologia, a cura di S. Ferrari e C. Tartarini, Bologna, Clueb, 2010, pp. 51-70. Più in generale sul tema della memoria, punto di confronto per la ricerca scientifica e umanistica su connessioni quali l’identità e l’interrelazione tra cultura letteraria e artistica cfr. La cultura della memoria, Atti del con-vegno (Firenze 1989) a cura di L. Bolzoni e P. Corsi, Bologna, il Mulino, 1992.
12 S. Ferrari, Lo specchio cit., p. 5.13 Ivi, p. 26 sgg.
Maria Saveria Ruga378
bilità di leggere nella cospicua serie dei suoi autoritratti quasi un’au-tobiografia: «J’ai fait dans ma vie bien des portraits de moi, au fur et à mesure que je changeais de situation d’esprit; j’ai écrit ma vie en un mot»; 14 citazione celebre, certamente suggestiva e funzionale, ma non casuale data l’ammirazione di cui l’artista godeva tra i con-temporanei, anche tra alcuni di questi pittori-scrittori che si muove-vano tra Napoli e Firenze.15
Alla luce di questa prima ricognizione, appare come I miei ricor-di di Massimo d’Azeglio – perfetta sintesi di memorialistica storica, impresa letteraria e artista – siano il punto di riferimento dichiarato nei proemi di molte ‘Vite d’artista’. D’Azeglio costituisce l’archetipo del successo editoriale: basti pensare alla straordinaria fama riscossa con la sua attività di romanziere – ad esempio con l’Ettore Fieramo-sca (1833) – entrando nel canone della cultura letteraria ma anche in quello iconografico dei pittori impegnati nel processo unitario. È possibile estrapolare dal testo alcuni motivi che ricorrono nelle bio-grafie d’artisti della generazione successiva.
Nel proemio Origine e scopo dell’opera d’Azeglio si rivolge su-bito al lettore: «Merita la mia vita d’esser narrata? Perché sento io il desiderio di narrarla? Mi muove un sentimento lodevole, od è questo un laccio che mi vien teso da un volgare e malaccorto amor proprio?».16 In questo passo si legge uno degli aspetti primari che
14 G. Courbet, lettera a Alfred Bruyas, maggio 1854, in Correspondance de Courbet, a cura di P. Ten-Doesschate Chu, Chicago 1992, Parigi, Flammarion, 1996, p. 114. E cfr. P. bonaFoux, Les peintres et l’autoportrait, Genève, Skira, 1984, pp. 106-114.
15 Una testimonianza è l’articolo di g. CaStagnary, Esposizione delle opere di Gusta-vo Courbet, «Gazzettino delle Arti e del Disegno», I, 1867, n. 23 pp. 182-183; ivi, n. 24, pp. 189-191; ivi, nn. 27-29, pp. 219-221. Per una riflessione sulla dimensione dell’inciden-za di Courbet nella pittura italiana del secondo Ottocento e sulla comprensione del suo realismo cfr. M. bianCale, Cammarano e Courbet, «La Nuova Antologia», 1935, pp. 100-108: 102; V. Farinella, Pittura dei campi. La rappresentazione della vita agreste nel Natu-ralismo europeo, in Pittura dei campi: Egisto Ferroni e il Naturalismo europeo, a cura di A. Baldinotti, V. Farinella, Livorno, Pacini, 2002, p. 9 sgg. con relative note e bibliografia; F. dini, Aspetti della pittura italiana nel paesaggio culturale di Castiglioncello tra Ottocento e Novecento, in Da Fattori a Corcos a Ghiglia: viaggio pittorico a Castiglioncello tra ’800 e ’900, Milano, Skira, 2008, pp. 13-55.
16 M. d’azeglio, I miei ricordi cit., p. 67. Il riferimento a d’Azeglio e ad una sua ci-tazione («Vorrei, col mio libro, servire all’educazione degl’Italiani in erba») compare anche in apertura del secondo volume dell’antologia di Onorato Roux (Illustri italiani contempora-nei. Memorie giovanili autobiografiche di letterati, artisti, scienziati, uomini politici, patrioti e pubblicisti, Firenze, Bemporad e figlio, 1909), in cui, tra gli artisti selezionati, sono presenti Domenico Morelli, Giovanni Duprè, Saverio Altamura e Gioacchino Toma.
«Merita la mia vita d’esser narrata?» 379
intervengono nella ‘scrittura dell’io’ – quello dell’amor proprio –, che traduce il desiderio di ricostruire la memoria collettiva della propria famiglia e rivela i riferimenti della tradizione autobiografi-ca precedente, riecheggiando modelli celebri del Settecento, quali quelli proposti da Vittorio Alfieri.17 Tra le motivazioni espresse si aggiunge poi il personale impegno patriottico che lo induce a scri-vere: l’amor di patria, quell’aver vissuto una lunga carriera che gli aveva consentito di «imbattersi in anime di veri eroi» 18 e il deside-rio di condividere racconti ed esempi in grado di contribuire a for-mare una coscienza nazionale. Altro punto che si può rintracciare è l’affermazione della ricerca e della costruzione di un’identità per-sonale da sintetizzare in «un’immagine di sé ad uso di chi scrive e di un ipotetico (ma indispensabile) lettore».19 D’Azeglio dichiara di non voler raccontare le sue vicende, quanto fare di sé: «uno studio morale e psicologico, cercando di conoscermi e di descrivere a fon-do la natura mia […]. S’io non prendo errore, questa specie d’au-to psia morale riuscirà tutt’altro che inutile».20 Siffatto schema es-senziale – orgoglio personale, amor di patria, finalità pedagogica, costruzione di un’identità – trova diverse corrispondenze se applicato alla memorialistica degli artisti della generazione successiva, segnale di una partecipazione ad una stessa rete: politica, culturale, artisti-ca e sociale.
Ritengo che l’esercizio autobiografico di Massimo d’Azeglio ab-bia giocato un ruolo nell’autorappresentazione di Francesco Hayez (Venezia, 1791 - Milano, 1882), «l’ultimo dei pittori romantici» 21 (tale la definizione di Boito), modello esemplare di pittore di storia per
17 Cfr. M. l. betri, d. Maldini CHiarito, Introduzione, in Scritture di desiderio e di ricordo. Autobiografie, diari, memorie tra Settecento e Novecento, a cura di M. L. Betri e D. Maldini Chiarito, Milano, Franco Angeli, 2002, pp. 7-18: 9. Utili riflessioni sul docu-mentato rapporto tra il genere e la memorialistica settecentesca e di primo Ottocento – da Rousseau ad Alfieri e Chateaubriand, per citare solo alcuni esempi –, applicati al caso specifico di Ippolito Nievo, sono contenute in S. garau, «A cavalcione di questi due seco-li». Cultura riflessa nelle Confessioni d’un Italiano e in altri scritti di Ippolito Nievo, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2010, in particolare la Parte prima: Modelli di genere set-tecenteschi. Lettere e memorie, pp. 3-67, con bibliografia.
18 Cfr. M. d’azeglio, I miei ricordi cit., pp. 68, 71.19 M. l. betri, d. Maldini CHiarito, Introduzione cit., p. 10.20 M. d’azeglio, I miei ricordi cit., p. 68.21 C. boito, L’ultimo dei pittori romantici, «Nuova Antologia», XXVI, s. III, XXXIII,
1891, pp. 60-88, 281-307, citato anche in F. Hayez, Le mie memorie cit., p. 7.
Maria Saveria Ruga380
Giuseppe Mazzini.22 I rapporti tra i due, a partire dalla comune fre-quentazione dell’Accademia di Brera, sono testimoniati dal ritratto che Hayez realizza (1864, olio su tela, Milano, Pinacoteca di Brera) 23 [cfr. Fig. 1] sulla base di una fotografia che orgogliosamente lo stes-so d’Azeglio aveva voluto far scattare dal famoso fotografo parigino André Adolphe Eugène Disderi.24 Con una rilevante serie di autori-tratti che si succede nel tempo, Hayez rappresenta uno degli esempi più significativi, in ambito italiano, di meditazione sulla proiezione della propria immagine di artista di successo; solo per citare alcuni esempi: l’Autoritratto in gruppo di amici (1824-27 ca., Milano, colle-zione privata), con gli artisti Migliara, Palagi, Grossi e Molteni «al centro dell’agguerrito manipolo della Milano romantica»; 25 l’Auto-ritratto a cinquantasette anni (1848, olio su tela, Milano, Pinacoteca di Brera), per l’esposizione di Brera del 1850, la prima dopo i moti del 1848, firmato e datato «Italiano della città di Venezia» e com-mentato nell’Album dell’Esposizione da Luigi Toccagni come un’au-tobiografia in cui tutto si racchiude.26 Hayez era a tal punto legato a questo dipinto da rifiutarsi di donarlo agli Uffizi, dove poi invie-rà nel 1862 un’altra tela, l’Autoritratto a settantuno anni (1862, olio su tela, Firenze, Galleria degli Uffizi) [cfr. Fig. 2], in posa ufficiale con la tavolozza in mano, in cui nella firma scompare la qualifica di «italiano»,27 forse emblema della disillusione dell’ideale risorgimenta-le in un momento in cui la sua Venezia è ancora in mano allo stra-
22 «È il capo della scuola di Pittura Storica, che il pensiero Nazionale reclamava in Italia: l’artista più inoltrato che noi conosciamo nel sentimento dell’Ideale che è chiamato a governare tutti i lavori dell’Epoca» (g. Mazzini, La Peinture Moderne en Italie, «London and Westminster Review», XXXV, 1841: trad. it. La pittura moderna in Italia in id., Scritti editi ed inediti, Imola, Cooperativa Tipografico-Editrice Paolo Galeati, 1915, XXI, pp. 293-313; l’edizione consultata figura trascritta in appendice in Romantici e Macchiaioli. Giuseppe Maz-zini e la grande pittura europea, catalogo della mostra (Genova, Palazzo Ducale, 21 ottobre 2005 - 12 febbraio 2006) a cura di F. Mazzocca, Milano, Skira, 2005, pp. 291-302: 297.
23 l. arrigoni, scheda in Hayez, catalogo della mostra (Milano, Palazzo Reale Sala delle Cariatidi - Accademia Pinacoteca Biblioteca di Brera, novembre 1983 - febbraio 1984) a cura di M. C. Gozzoli e F. Mazzocca, Milano, Electa, 1983, p. 256 nota 126.
24 C. gHibaudi, scheda, in Hayez nella Milano di Manzoni e Verdi, catalogo della mostra (Milano, Pinacoteca di Brera, 13 aprile - 25 settembre 2011) a cura di F. Mazzocca, Milano, Skira, 2011, p. 68, n. III.5; cfr. l. arrigoni, scheda in Hayez cit.
25 F. Hayez, Le mie memorie cit, p. 13; cfr. F. Mazzocca, scheda in Hayez cit., p. 330, n. 177.
26 l. loMbardi, scheda in Hayez nella Milano cit., p. 40, n. I.1, con bibliografia.27 Cfr. l. loMbardi, scheda in Hayez nella Milano cit., p. 42, n. I.2, con bibliografia.
«Merita la mia vita d’esser narrata?» 381
niero (l’annessione al Regno d’Italia avverrà nel 1866). Tra il 1869, a due anni dalla pubblicazione dei Ricordi di d’Azeglio, ed il 1875 Hayez decide di stilare anch’egli le sue memorie che, in una versione ridotta e adattata per la stampa, furono pubblicate dall’Accademia di Brera nel 1890, in occasione dell’inaugurazione del monumento bronzeo dedicato all’artista: una doppia celebrazione postuma che doveva consegnare ai posteri le parole e il volto dell’indiscusso mae-stro. È probabile che il prototipo dell’amico sia stato un forte impul-so per affiancare la scrittura alla costruzione pittorica del suo perso-naggio pubblico. È allo stesso tempo indicativo, tuttavia, osservare come nel testo di Hayez sia abolito il proemio di domande retoriche sul perché si sia cimentato nella scrittura della propria storia, spia di un’alta considerazione di sé e di un compiacimento del resto mai celato per la propria carriera.
Una raccolta di memorie che conobbe uno straordinario suc-cesso editoriale, circolando anche per le scuole, come rilevato già da Croce,28 è l’autobiografia dello scultore Giovanni Duprè (Siena, 1817 - Firenze, 1882) pubblicata nel 1879 a Firenze, nello stesso anno in cui vanno in stampa le Ricordanze di Settembrini. Nel volume di Duprè, che aveva frequentato a Roma d’Azeglio e Minardi,29 torna-no le formule retoriche di apertura e le finalità ‘morali’ di educare e dare il buon esempio ai giovani. Non è un caso, quindi, che già a un contemporaneo quale Giuseppe Maria Zampini fosse chiara la tradizione del genere in cui collocare l’opera dello scultore, costruen-do un percorso dalle Confessioni di Agostino, alla Vita di Benvenuto Cellini a d’Azeglio, fino ad inserire il suo stesso saggio critico nella scia della tradizione affermata da Settembrini.30 In Duprè la carica politica è meno presente, in favore di un intento pedagogico mani-festo, ma anche di una visione della scrittura quale strumento per l’artista per preservare e trasmettere l’autografia delle sue opere; 31 un’affermazione che potrebbe essere letta quale necessaria risposta
28 Cfr. P. Sabbatino, Le città cit., p. 118; E. SPalletti, Il secondo ventennio di attività di Giovanni Duprè (1858-1882), «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», n. 2, 1974, pp. 537-612: 592-593 e nota 136.
29 e. SPalletti, Giovanni Duprè, Milano 2002, p. 34.30 G. M. zaMPini, Giovanni Duprè cit.31 Cfr. P. Sabbatino, Le città cit., pp. 118-119, dove il passaggio (G. duPrè, Pensieri
cit., pp. 424-425) è letto quale traduzione del monito vasariano della scrittura come espe-diente per l’opera d’arte per sopravvivere al tempo e all’oblio.
Maria Saveria Ruga382
all’incidenza crescente del ruolo della critica e al comparire dei pri-mi repertori biografici sugli artisti viventi. Un esempio indicativo in Italia è il caso di Angelo De Gubernatis che aveva già pubblicato i Ricordi biografici d’illustri Italiani (Firenze, 1873), delineando i pro-fili di 42 interlocutori culturali e politici della generazione di artisti di cui stiamo trattando in questa sede: Manzoni, De Sanctis, Settem-brini, Villari, Guerrazzi.32 Da lì a qualche anno, nel 1879, sempre a Firenze, l’erudito avrebbe pubblicato il Dizionario biografico degli scrittori contemporanei in ventuno volumi, un’opera a cui molti artisti avevano di certo guardato con interesse e che, come noto, conteneva anche molte imprecisioni e dati non verificati; impresa editoriale a cui seguì, nel 1889-92, il Dizionario degli artisti italiani viventi, pit-tori, scultori e architetti (in otto volumi).33
È verosimile che – dato il successo editoriale dello scritto di Du-prè – il monito all’impulso memorialistico non sia caduto nel vuoto per la schiera di giovani artisti che operavano sull’asse artistico e po-litico tra Firenze e Napoli, nel decennio pre e postunitario.34
Quest’ultimo è l’anno della prematura scomparsa del pittore Ber-nardo Celentano, evento che generò forte emozione nella comunità artistica tra Roma, Napoli e Firenze.35 La raccolta di lettere dell’ar-tista non sembra propriamente rientrare nel novero delle memorie autobiografiche; tuttavia, l’epistolario fu con questo intento ordina-to, commentato e pubblicato dal fratello Luigi per costruire e veico-
32 Cfr. l. StraPPini, De Gubernatis, Angelo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 36, 1988, pp. 227-235: 233.
33 Ibid.34 Lo scultore senese difatti si colloca su questo tragitto con almeno tre soggiorni a
Napoli: a metà degli anni Cinquanta, nel 1863 (E. SPalletti, Giovanni Duprè cit., p. 180) e nel 1877 in occasione dell’Esposizione Nazionale (cfr. C. CoStantini, L’uomo, in g. roSadi et alii, Giovanni Duprè scultore (1817-1882), Milano, Editori Alfieri & Lacroix, 1917, p. 31; G. duPré, Pensieri cit., p. 459 sgg.). Un’ulteriore attestazione dell’immediata percezione dei Pensieri di Duprè per i giovani artisti, in particolare attivi a Napoli, è nel ricordo postumo – impreciso sulle datazioni ma significativo – dello scultore Francesco Jerace (Polistena, 1853 - Napoli, 1937): «[…] apparvero i ricordi che il Duprè pubblicava con modesta inten-zione di fare cosa gradita alla gioventù studiosa dell’arte. Ma tale pubblicazione fu accolta favorevolmente anche nel mondo letterario ottenendo buona messe di lodi. Quel libro è un documento che maggiormente afferma dell’animo gentile e pio dell’amico di Augusto Conti; ed è in antitesi coi ricordi gloriosi, fantastici e spesse volte malvagi di Benvenuto Cellini. Nel libro del Duprè spira placidezza, rettitudine, amore sereno, attaccamento al lavoro, ed una fede dominante che eleva lo spirito umano» (in F. jeraCe, Ricordando Gio-vanni Duprè, «Brutium», XVI, n. 1, gennaio-febbraio 1937, pp. 4-6: 6).
35 Ricordato dallo stesso Duprè in id., Pensieri cit., p. 390.
«Merita la mia vita d’esser narrata?» 383
lare il profilo del pittore prematuramente scomparso, dando forma all’ambizione di una famiglia che aveva investito tutto nel sostegno alla sua carriera.36
Bernardo Celentano offre un caso di studio sintomatico, in cui l’immagine concorre con la scrittura nella costruzione e affermazione di un’identità, attraverso l’intensa prova dei ‘ritratti d’amicizia’ [cfr. Figg. 3-4] scambiata tra l’artista e Domenico Morelli, figura centrale per il rinnovamento della pittura a Napoli ed emblema dell’impegno patriottico; due immagini speculari che racchiudono un forte messag-gio identitario, affermando lo status raggiunto dai due pittori.
Nella raccolta epistolare si ha una testimonianza dell’episodio:
Fu allora che Morelli e Bernardo si scambiarono i ritratti a mezzo busto. E così rivediamo ancora il zerbinotto dell’autunno 59, a cui Morelli dette per fondo un muro ov’è affisso un cartello che annuncia a spettacolo Benvenu-to Cellini; e così forse anch’egli, nel riguardarsi come dall’amico fu visto a que’ giorni, non troverà mendaci que’ tratti di figure mistiche su tela ancor bianca, su cui Bernardo staccò il suo volto indagatore.37
Il Ritratto di Bernardo Celentano (1859, olio su tela, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea) [cfr. Fig. 4], eseguito da Domenico Morelli, da contestualizzare nel vivo degli anni delle agitazioni anti-accademiche, ostenta un’immagine di artista elegante, caratterizzato da elementi che accentuano e proiettano questi tratti: il sigaro e l’alto cappello a tuba, il panciotto bianco e i guanti ne-ri.38 Il riferimento al Cellini, il cui nome compare sul manifesto affis-so al muro retrostante, è da leggersi verosimilmente quale richiamo all’omonimo melodramma di Hector Berlioz (1836), celando una pro-
36 L. Celentano, Bernardo Celentano. Due settennii cit. Un cospicuo gruppo di artisti attivi a Napoli – tra cui Edoardo Dalbono, Francesco Netti, Francesco Saverio Altamura, Gioacchino Toma, Andrea Cefaly –, indirizzò a Luigi Celentano una lettera di incitamento affinché completasse e pubblicasse al più presto la raccolta epistolare: «Quando la storia di Bernardo sarà completa ed i giovani la studieranno con amore, l’arte italiana progre-dirà più sicura ed ardita, la memoria di vostro fratello ne sarà più gloriosa e benedetta e noi Napolitani lo ricorderemo con più orgoglio» (in Epistolario di Bernardo Celentano, «Roma artistica. Giornale settimanale di Belle Arti applicate all’Industria», VIII, nn. 4-5, aprile-maggio 1882, pp. 53-54).
37 Ivi, p. 373, nota 1.38 Cfr. e. di Majo, scheda in Domenico Morelli e il suo tempo, catalogo della mostra
(Napoli, Castel Sant’Elmo, 29 ottobre 2005 - 29 gennaio 2006) a cura di L. Martorelli, Na-poli, Electa Napoli, 2005, p. 45, con bibliografia.
Maria Saveria Ruga384
babile allusione anche allo stesso dipinto Cellini a Castel Sant’Angelo (Napoli, Museo di Capodimonte) di Celentano; entrambe citazioni che confermano – per il tema che qui ci interessa – l’alta circolazio-ne raggiunta in quegli anni dalla stessa Vita di Benvenuto Cellini,39 quale modello esemplare di autobiografia d’artista.
Nel contemporaneo ritratto che a sua volta Celentano realizza dell’amico Morelli (1859, olio su tela, Milano, collezione Trinca) [cfr. Fig. 3], si osserva lo sguardo vivo e penetrante, quasi di sfida, del pittore verso lo spettatore; questi non ha la tavolozza in mano, bensì sigaro e cappello, forse un’allusione agli studi dal vero.40 Sullo sfon-do è riportato l’abbozzo per la decorazione che l’artista stava com-pletando per la neobizantina cappella Nunziante a Napoli, ulterio-re indizio di quel meccanismo consueto per il pittore, in cui l’esal-tazione delle virtù morali del cristianesimo delle origini acquistava una varietà semantica che seguiva le contingenze storiche e politi-che, alludendo alle fondamenta del nuovo spirito nazionale, tentan-do di eludere la censura del governo.41
Morelli non lasciò una vera autobiografia, ma inserì le sue vicen-de personali in un discorso pubblico,42 in occasione della comme-morazione della scomparsa del pittore Filippo Palizzi, intrecciando i propri ricordi con la ricostruzione dell’identità di tutta una scuo-la, ad uso delle nuove generazioni degli studenti dell’accademia, da cui emerge quel «quadro di forti legami personali e condivisione di ideali» 43 così determinante per la dimensione patriottica.
La pubblicazione della raccolta delle lettere di Celentano diede
39 L’edizione moderna è del 1728 a Colonia, secondo il frontespizio, ma in realtà il luogo è Napoli (in F. borroni SalVadori, Francesco Maria Niccolò Gaburri e gli artisti con-temporanei, «Annali della Scuola normale superiore di Pisa», IV, 4, 1974, pp. 1502-1555: 1518 e note 63-64). La pubblicazione si deve ad Antonio Cocchi, letterato e scienziato, ed è finanziata e curata da Gaetano Berenstadt: vedi l. lindgren, La carriera di Gaetano Berenstadt, contralto evirato (ca. 1690-1735), «Rivista italiana di musicologia», XIX, 1984, pp. 36-112: 59 sgg.; ringrazio qui per la segnalazione Andrea Lazzarini. Cfr. S. garau, «A cavalcione di questi due secoli» cit., p. 31.
40 Cfr. M. bianCale, Bernardo Celentano, Napoli, Palombi, 1936, pp. 69-70; g. Mon-tani, scheda in Domenico Morelli cit., p. 46, con bibliografia.
41 Cfr. M. S. ruga, I pittori e le catacombe di Napoli: dalle vedute al quadro di storia, «Ricerche di storia dell’arte», n. 110-111, 2013, pp. 103-119: 108 sgg.
42 Morelli, Ricordi della scuola napoletana cit.43 Nel nome dell’Italia. Il Risorgimento nelle testimonianze, nei documenti e nelle im-
magini, a cura di A. M. Banti, Bari, Laterza, 2011, p. 79.
«Merita la mia vita d’esser narrata?» 385
un ulteriore impulso alla memorialistica degli artisti patrioti. È elo-quente in tal senso l’incipit dell’autobiografica del pittore Francesco Saverio Altamura, in cui si ritrovano i temi chiave dell’immaginario patriottico e le formule retoriche d’apertura:
È stata, questa vita, così morale e degna da farsi leggere da chi vien dopo? Qual parte ho io preso negli avvenimenti che si sono succeduti ai miei buoni tempi? Io non ebbi virtù di capitano, né rivestii cariche insigni, né come Benvenuto Cellini ho maneggiato con fragorosa bravura la spada e il bulino, o come Massimo d’Azeglio ho scritto, tra un paesaggio e una sce-na di battaglia, libri e romanzi. E anche senza questo, la mia prosa non è troppo umile perché vada degnamente per il mondo? […] Or mi dirà il saggio lettore: – Perché pubblichi questo libro? Io precisamente non so: ma certo dalla lettura di un volume di lettere di Bernardo Celentano, riu-nite da suo fratello Luigi, mi persuasi che l’anima nostra prova un sottile brivido di dolcezza nel rievocare le cose passate […].44
Sono molte le attestazioni delle relazioni tra Altamura, Diego Mar-telli e Telemaco Signorini, figure di spicco nel Caffè Michelangelo, così come i frequenti viaggi a Parigi; 45 qui, nel 1870, si compie il viaggio di formazione di un altro pittore napoletano, Michele Cam-marano.46
Anche Cammarano apre con le ormai consuete formule retoriche: «deciso a por mano a queste mie memorie […] spesso ne respingeva l’idea chiedendo a me stesso se meritavo la mia autobiografia come ad un artista singolare».47 Ritornano i trascorsi patriottici, la forma-
44 F. S. altaMura, Vita e arte cit., p. 3. 45 Sull’artista si veda il più aggiornato contributo La Patria, l’Arte, la Donna. Fran-
cesco Saverio Altamura e la pittura dell’Ottocento in Italia, catalogo della mostra (Foggia, Palazzo Dogana e Museo Civico, 10 novembre 2012 - 12 gennaio 2013) a cura di C. Fare-se Sperken, L. Martorelli, F. Picca, Foggia, Grenzi, 2012. Altamura realizza diversi autori-tratti, dall’età giovanile a quella matura, come il dipinto che, compiuto nel 1870, è donato dalla famiglia del pittore nel 1897, anno della sua morte, all’Istituto Tecnico Industriale di Foggia, città natale dell’artista, intitolato alla sua memoria (cfr. S. d’andola, scheda, ivi, p. 134, n. 5.1).
46 Cfr. M. bianCale, Cammarano e Courbet, «La Nuova Antologia», 1935, pp. 100-108.47 M. CaMMarano, Memorie d’artista cit.; e cfr. id., Memorie mie, a cura di L. Bertoz-
zi, Roma 1998, p. 25. Su Cammarano si rimanda alla stesura definitiva delle sue memorie, di cui sto curando l’edizione critica (M. CaMMarano, Memorie d’artista, a cura di M. S. Ruga, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, in corso di stampa; M. S. ruga, Il manoscritto ritrovato: Michele Cammarano e la «fucina» di Andrea Cefaly, «Ricerche di Storia dell’ar-te», 113, 2014, pp. 87-93). Dei ricordi del pittore napoletano, studiati per la prima volta
Maria Saveria Ruga386
zione artistica, le frequentazioni illustri, l’intento pedagogico per la nuova generazione d’artisti.48 Rivivono nelle pagine la ricostruzione della memoria familiare che coincide con la storia del teatro napole-tano, ma anche la forte amicizia con i fratelli Bernardo e Luigi Ce-lentano, con l’esplicito riferimento alla raccolta epistolare pubblica-ta da quest’ultimo, e l’impatto delle lezioni di Settembrini, i profili delle figure di Palizzi e Morelli.
Due testimonianze che consentono di valutare in modo del tut-to peculiare la commistione dei generi, all’interno della dinamica tra autobiografia testuale e visiva, sono rintracciabili all’interno di una impressionante serie di autoritratti del pittore Antonio Mancini – già allievo di Domenico Morelli a Napoli, appartenente a una generazio-ne più giovane degli esempi proposti – la cui attività è contraddistinta da disturbi psichiatrici che lo costringono, nel 1878, ad allontanarsi da Parigi per rifugiarsi di nuovo nella città partenopea e trasferirsi poi definitivamente a Roma nel 1883, dove muore nel 1930. In un autoritratto giovanile (1880 ca., olio su tavola, collezione privata) [cfr. Fig. 5] egli si ritrae abbozzando frammenti della sua cultura di for-mazione, tra cui sul fondo il profilo di Alessandro Manzoni, il busto ritratto di Mariano Fortuny realizzato da Vincenzo Gemito, il Cristo imbalsamato di Domenico Morelli, mentre nella tela che a sua volta tiene saldamente in mano, esponendola allo spettatore, si riconosce
da Michele Biancale (id., Michele Cammarano, Milano 1936), è nota una stesura parziale edita da Francesca Bertozzi (M. CaMMarano, Memorie mie cit.), di cui questo ritrovamento colma le lacune documentarie nei due intervalli dal 1855 al 1859 e dal 1861 al 1870.
48 A questa motivazione sembra riferirsi anche la dedica di un manoscritto di me-morie inedite del pittore Michele Tedesco (Moliterno, 1834 - Napoli, 1917), partecipe del-lo stesso clima di esperienze artistiche e politiche di Cammarano: «A quegli artisti del-la nuova generazione, cui è serbato realizzare la speranza di quanti preannunziarono la riforma dell’arte italiana» (in A. FrangiPane, L’arte e il suo carattere nelle pagine inedi-te di un Pittore dell’800, «Brutium», XXXII, nn. 11-12, novembre-dicembre 1953, pp. 1-2). L’esistenza di questo volume (datato Napoli, 11 agosto 1901 - giugno 1902), passa-ta fino ad ora inosservata, è riportata da Alfonso Frangipane (ibid.) che ha la possibilità di consultarlo nel 1930, episodio cui potrebbe collegarsi una serie di suoi appunti au-tografi che qui si segnalano (Archivio “A. Frangipane”, Reggio Calabria, fasc. Miche-le Tedesco, ringrazio Vittoria Russo e Alessia De Pasquale, eredi dello studioso, per la loro disponibilità e assistenza alla ricerca). Michele Tedesco annotava nei suoi taccuini, oltre agli schizzi, anche appunti ‘letterari’ tra cui stralci dalle lettere e da I miei ricordi di Massimo d’Azeglio (in i. Valente, Michele Tedesco. Taccuini, Lagonegro, Calice Edi-tori, 2012, pp. 12-13); sul pittore si rimanda alla recente esposizione Michele Tedesco (1834-1917). Un pittore lucano nell’Italia Unita, catalogo della mostra (Potenza, Pinaco-teca Provinciale, 4 febbraio - 15 aprile 2012), a cura di I. Valente, Lagonegro, Calice Edi-tori, 2012.
«Merita la mia vita d’esser narrata?» 387
il ritratto dello stesso Morelli; 49 nel 1929, anno che coincide con la sua nomina ad accademico d’Italia, quando è ormai considerato quale «massimo artista vivente»,50 Mancini fissa invece la sua figura di pit-tore ormai anziano a lato del dipinto (olio su tela, Roma, collezione Pesci-Mancini) [cfr. Fig. 6] e delega questa volta la sua ‘biografia’ ad una scrittura scomposta che fa intervenire direttamente sulla tela dal fondo neutro, annotando le tappe principali della sua vita, i nomi e i luoghi che hanno contraddistinto la sua esistenza.51
Il rapporto tra immagine e testo, declinato nella relazione tra autoritratto e autobiografia, non è esclusivo del XIX secolo, bensì percorre molti secoli della storia dell’arte: si tratta di due tipologie di fonti che per loro natura necessitano di un approccio metodolo-gico differente, ma che concorrono entrambe alla costruzione e af-fermazione di un’identità.52 Un’efficace formulazione del problema è quella proposta da Victor Stoichita, indagando il tema dell’immagine del pittore in età moderna: «L’autoritratto è descrizione di sé, l’auto-biografia è la vita trasposta in racconto […]. L’autoritratto che nulla
49 Cfr. scheda in Antonio Mancini: 1852-1930, catalogo della mostra (Milano, Esposi-zione Permanente e Spoleto, XXIV Festival dei Due Mondi, 16 settembre - 27 ottobre 1991) a cura di B. Mantura e E. di Majo, Roma, Leonardo-De Luca, 1991, pp. 104-105, n. 19.
50 M. CalVeSi, Una testimonianza per Antonio Mancini, «Storia dell’arte», 133, 2012, pp. 181-185: 181.
51 Cfr. M. bianCale, Antonio Mancini. La vita, Roma, Palombi, 1952, pp. 7-8, in cui è trascritta tale ‘biografia’: «Antonio Mancini Roma 1852 / Napoli Morelli Palizzi Mancinelli Lista / Gemito Michetti Esposito / Mesdag Aia Paris Gerome De Nittis / Degas Pastelli veduti al suo atelier / Ballerine / Paolo Bourget già a Napoli veduto / De Amicis a Napoli / Londra Sargent Dublino / Lane direttore / Lady Gregory Ponsonby / Messinger Monaco Berlino / Du Chène Frascati cittadino / Famiglia / Studi Story Sala Venezia Napoli cittadi-no / a Minori Baca Flor Pittore / amico Peruviano / Casciaro Vetri Sartorio amici / Acca-demia d’Italia 1929»; cfr. Antonio Mancini. Nineteenth-Century Italian Master, catalogo della mostra (Philadelphia, Museum of Art, 20 ottobre 2007 - 20 gennaio 2008) a cura di U. W. Hiesinger, Philadelphia, 2007, tav. 45. Sulle profonde implicazioni della «parola scritta» che interviene direttamente sull’immagine, sia da parte dell’artista che dell’osservatore, si veda la suggestiva serie di esempi in M. butor, Les mots dans la peinture, Genève, Skira, 1969 [ed. consultata in trad. it.: Le parole nella pittura, Venezia, Arsenale Editrice, 1987], in particolare sul tema del ritratto, in cui l’autore si sofferma sul caso di Holbein, pp. 44-48.
52 Non si è indagato in questa sede il rapporto con la fotografia che pure occupa un ruolo tutt’altro che marginale nel corso del XIX secolo e che necessita di un ampliamen-to al coevo contesto europeo; scelta dettata allo stato delle ricerche solo per economia di spazi. Cfr. e. grazioli, L’immagine di sé in fotografia, in Autofocus cit., pp. 85-102; M. Miraglia, Il ritratto fotografico e il superamento della mimesi, in Da Canova a Modigliani. Il volto dell’Ottocento, catalogo della mostra (Padova, Palazzo Zabarella, 2 ottobre 2010 - 27 febbraio 2011) a cura di F. Leone, M. V. Marini Clarelli, F. Mazzocca, C. Sisi, Venezia, Marsilio, 2010, pp. 67-73.
Maria Saveria Ruga388
racconta, ma che si limita a descrivere lo stato dell’io dell’autore può, a posteriori, costruirsi come “storia” della sua personalità».53
La variabile che entra in gioco nell’orizzonte temporale in cui si è collocato questo studio è nell’acuirsi di una coscienza già maturata lungo il XIX secolo, anche in prospettiva europea: la conquista di un’identità nazionale e la sua rapida messa in discussione. Vi è poi il pericolo, tutt’altro che marginale, di perdere di vista come ciò che emerga sia un racconto a posteriori e per questo non si tratti di verità assolute. In questo senso è d’aiuto l’affermazione che farà Italo Cal-vino, a proposito del suo «rapporto nevrotico con l’autobiografia» 54 e della difficoltà di isolare una parte dal tutto, dandogli un senso compiuto: «Mi chieda pure quel che vuole sapere, e Glielo dirò. Ma non le dirò mai la verità, di questo può star sicura».55
Tale considerazione non inficia il presupposto della ricerca, bensì diventa una variabile problematica ma significativa, perché anche le modalità di selezione di cosa o meno consegnare ai posteri diventa indice dell’immagine che l’autore vuole proiettare di sé. In questa direzione la riflessione più concisa ed esaustiva è forse quella di Ber-nard Berenson, nel suo Abbozzo per un autoritratto (1949). Il cono-scitore Berenson apre con l’interrogativo se esista:
uomo al mondo che possa ritrarre se stesso con parole, come forse può far-lo col gesso o con i colori? Il pittore, quando guarda nello specchio e vi si vede riflesso ha qualcosa di definito dinanzi a sé […] Ma le parole […]! Non possono far altro che applicare questo o quell’epiteto, questa o quella frase descrittiva, interpretativa, evocativa […]. Un artista della parola, e in ciò molto dotato, potrà anche dare un’idea coerente della persona che egli si trova a ritrarre; difficilmente ne darà una obbiettiva.56
Più avanti, egli si interroga su cosa sia l’io e sul rapporto con la me-moria, ma facendo un uso strumentale di queste sue prime digressio-ni, troviamo qui la chiave di lettura per porre in modo problematico
53 V. i. StoiCHita, L’instauration du tableau: métapeinture à l’aube des Temps modernes, Paris, Méridiens Klincksieck, 1993 [trad. it. L’invenzione del quadro, Milano, Il Saggiatore, 1998]; ed. consultata: Milano, Il Saggiatore, 2013, pp. 226-227, e cfr. p. 323, nota 46.
54 Lettera di Italo Calvino a Claudio Milanini, 27 luglio 1985, in I. CalVino, Lezioni ame-ricane. Sei proposte per il prossimo millennio; ed. consultata: Milano, Mondadori, 2000, p. ix.
55 Lettera di Italo Calvino a Germana Pescio Bottino, 9 giugno 1964, in I. CalVino, Lezioni americane cit., p. ix.
56 b. berenSon, Abbozzo per un autoritratto, Firenze, Electa, 1949, p. 11.
Fig. 1. Francesco Hayez, Ritratto di Massimo d’Azeglio, 1864, olio su tela, cm 119 × 93, Milano, Pinacoteca di Brera.
Fig. 2. Francesco Hayez, Autoritratto a settantuno anni, 1862, olio su tela, cm 125,5 ×101,5, Firenze, Galleria degli Uffizi.
Figg. 3-5. 3. Bernardo celentano, Ritratto di Domenico Morelli, 1859, olio su tela, cm 66 × 52, Milano, collezione Trinca; 4. domenico morelli, Ritratto di Bernardo Celentano, 1859, olio su tela, cm 67 × 52, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Mo-derna; 5. antonio mancini, Autoritratto, 1880 ca.,
olio su tavola cm 35 × 21, collezione privata.
3 4
5
Fig. 7. James ensor, Mon Portrait en 1960, 1888, incisione, mm 64 × 114.
Fig. 6. antonio mancini, Autoritratto, 1929, olio su tela, cm 80 ×70,Roma, collezione Pesci-Mancini.
«Merita la mia vita d’esser narrata?» 389
il rapporto fonti, testuali e visive, partendo dalla consapevolezza che si tratti di una selezione di ‘immagini’ più o meno consapevole, non obiettiva ma coerente, come scrive Berenson, al preciso messaggio culturale e sociale che l’autore vuole veicolare di sé, nelle scelte, più o meno dichiarate, di cosa svelare o tacere allo spettatore o al letto-re. Sulle Ricordanze di Settembrini – già celebri anche nella versione manoscritta, annunciate da Vittorio Imbriani come «il gioiello del-la letteratura italiana del secolo nostro, come la Vita del Cellini è il gioiel lo di quella del Cinquecento» 57 –, un osservatore contempora-neo, recensendone alcuni brani autobiografici sulle pagine de «L’Il-lustrazione Italiana», non mancava di sottolineare come:
Ogni scritto autobiografico ha questo di buono che oltre i ragguagli che l’autore v’ha messi, chi ha la vista acuta ne scorge degli altri che non v’ha messi. Ci scopri l’uomo non soltanto quale vuol parere, ma qual veramen-te è. E anche quando è sincero, anche quando non posa, c’impari almeno come parla, come ordina i suoi pensieri, ne desumi la sua indole ed il suo temperamento.58
Se inseriamo gli esempi qui presentati, così numerosi nel dialogo che si instaura tra il Meridione e la Toscana, si può rilevare come il genere della scrittura della memoria sia molto più praticato da-gli artisti italiani del secondo Ottocento di come si sia fino ad oggi affermato: una chiave di lettura che, circoscritta a un preciso grup-po sociale, ha rivelato la consistenza di un fenomeno che è indice di una compartecipazione a una stessa temperie politica e culturale. Il ricordo dei tempi burrascosi, l’affermazione di una posizione so-ciale – conquistata con duri sforzi e studi – al centro della propria epoca, la sopravvivenza all’oblio del tempo ne costituiscono gli ele-menti cardine.
Si tratta di un genere dei ricordi, funzionali al racconto di espe-rienze civili e politiche, che si colloca in un orizzonte temporale in cui si registra una forte disillusione e la perdita di coordinate certe da parte di questi artisti che sembrano volgersi – quasi ancorandosi – al passato, in una direzione così distante da quella corrente simbolista
57 La testimonianza, tratta secondo la fonte da un articolo di Imbriani su l’«Araldo» di Roma, è in Luigi Settembrini, «L’Illustrazione Italiana», III, n. 56, 19 novembre 1876, p. 387.
58 Cfr. Scrittori viventi. Luigi Settembrini, «L’Illustrazione Italiana», II, nn. 59-60, 3 ottobre 1875, p. 477.
Maria Saveria Ruga390
della generazione successiva, espressa ad esempio in un autoritratto visionario di James Ensor (Ostenda, 1860-1949) che, nel 1888, tra-duce questa irrequietezza proiettando la sua immagine, trasfigurata in uno scheletro, nel 1960 [cfr. Fig. 7]: una potenza immaginifica che va al di là di una sola prefigurazione della morte, come suggerisce l’eloquente sguardo vigile del teschio verso un ipotetico futuro.59
Nella storiografia, il rapporto tra passato e presente è una rifles-sione costante che comporta continue verifiche e revisioni dei princi-pi metodologici applicati. Sulle memorie autobiografiche e sulla loro «giustificazione», un punto saldissimo di riferimento è la prospettiva enunciata da Antonio Gramsci nei Quaderni del carcere:
Spesso le autobiografie sono un atto di orgoglio: si crede che la propria vita sia degna di essere narrata perché «originale», diversa dalle altre […]. Si sa che la propria vita è simile a quella di mille altre vite, ma che per un «caso» essa ha avuto uno sbocco che le altre mille non potevano avere e non ebbero di fatto. Raccontando si crea questa possibilità, si suggerisce il processo, si indica lo sbocco.60
Questa citazione, variamente ripresa dalla critica, merita di essere qui riportata quale risposta ‘ideale’ all’interrogativo che ha avviato que-ste riflessioni, riuscendo con efficacia a cogliere quei punti essenziali che intervengono nella costruzione dell’immagine di un destino in-dividuale, il quale aspira ad essere considerato – nelle sue ambizioni e potenziali ambiguità – parte attiva all’interno di una prospettiva storica complessa.
Maria SaVeria ruga
59 Ringrazio qui il prof. Giacomo Jori per aver richiamato la mia attenzione su que-sto significativo particolare. Cfr. scheda in James Ensor. A Collection of Prints, a cura di E. Gillis, New York, G. C. Boerner, 2002, p. 62 n. 28; P. bonaFoux, Les peintres cit., pp. 132-133. Per una riflessione simbolica e allegorica sulle posizioni ideologiche degli arti-sti tra Otto e Novecento cfr. J. StarobinSki, Portrait de l’artiste en saltimbanque, Genève, Skira, 1970, Paris 1983 [trad. it. a cura di C. Bologna, Ritratto dell’artista da saltimbanco, Torino, 1984]; ed. consultata: Torino, Bollati Boringhieri, 2002, in particolare p. 87 sgg. In un contesto completamente diverso da Ensor, ma affine alla temperie risorgimentale, una parodistica prefigurazione del futuro è in i. nieVo, Storia filosofica dei secoli futuri (e altri scritti umoristici del 1860); ed. consultata: a cura di E. Russo, Roma, Salerno Edi-trice, 2003.
60 a. graMSCi, Quaderni del Carcere, III, ed. crit. dell’Istituto Gramsci a cura di V. Gerratana, Torino, Einaudi, 1975, Quaderno 14 (I), 1932-1935, p. 1718. La citazione è riportata anche in P. Sabbatino, Le città cit., p. 114.
«Merita la mia vita d’esser narrata?» 391
ABSTRACT
During a historical period that registers a remarkable increase in autobio-graphical memoirs by painters and sculptors, the article proposes to trace a path among these sources, from which emerges a convergence towards precise literary models (d’Azeglio, Settembrini, Duprè), which make up the imagery of an entire generation of patriotic artists, in particular between Naples and Florence. This interpretation leads to a comparison, conducted within the genre of the portrait and the self-portrait, which aims at bringing into focus elements that contribute to the identity construction of these artists-writers, in the context of the ongoing Unification process and in terms of a redefinition of their role in society.
RIASSUNTO
In una fase storica in sui si registra un incremento notevole di memorie auto-biografiche da parte di pittori e scultori, lo studio propone un percorso tra que-ste fonti da cui emerge una convergenza verso precisi modelli letterari (d’Azeglio, Settembrini, Duprè) che compongono l’immaginario di tutta una generazione di artisti patrioti, in particolare tra Napoli e Firenze. Questa lettura conduce a un confronto misurato all’interno del genere del ritratto e dell’autoritratto, con lo scopo di mettere a fuoco elementi che agiscono nella costruzione di un’identità da parte degli artisti-scrittori, nel contesto degli esiti del processo unitario e di un ripensamento del proprio ruolo nella società.
Elenco delle immagini:
Fig. 1. FranCeSCo Hayez, Ritratto di Massimo d’Azeglio, 1864, olio su tela, Milano, Pinacoteca di Brera.
Fig. 2. FranCeSCo Hayez, Autoritratto a settantuno anni, 1862, olio su tela, Firenze, Galleria degli Uffizi.
Fig. 3. bernardo Celentano, Ritratto di Domenico Morelli, 1859, olio su tela, Mila-no, collezione Trinca.
Fig. 4. doMeniCo Morelli, Ritratto di Bernardo Celentano, 1859, olio su tela, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna.
Fig. 5. antonio ManCini, Autoritratto, 1880 ca., olio su tavola, collezione privata.Fig. 6. antonio ManCini, Autoritratto, 1929, olio su tela, Roma, collezione Pesci-
Mancini.Fig. 7. jaMeS enSor, Mon Portrait en 1960, 1888, incisione.
Maria Saveria Ruga392
Referenze fotografiche:
Le seguenti immagini vengono riprodotte su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo:
– Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici di Milano, fig. 1.
– Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantro-pologico e per il Polo Museale della città di Firenze, fig. 2.
– Soprintendenza alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, fig. 4.
L’autore è a disposizione degli eventuali detentori di diritti che non sia stato possibile rintracciare.
tutti i diritti sono riservatidirettore responsabile: carlo oSSola
Registrazione del tribunale di firenze n. 1228 del 8 luglio 1965
tipografia «tiferno Grafica» - 06012 città di castello
Pubblicato nel mese di dicembre 2014
Redazioni«lettere Italiane»
dipartimento di Studi linguistici e letterari, Università di PadovaVia beato Pellegrino 1 - 35137 Padova
Via Giulia di barolo 3, int. A - 10024 torinotel. (+39) 011.670.3861 - [email protected]
* * *
Amministrazione casa Editrice leo S. olschki
casella postale 66, 50123 firenze • Viuzzo del Pozzetto 8, 50126 firenze e-mail: [email protected] • conto corrente postale 12.707.501
tel. (+39) 055.65.30.684 • fax (+39) 055.65.30.214
2014: abbonaMento annuale - AnnuAl subscription
iStituzioni - institutions
la quota per le istituzioni è comprensiva dell’accesso on-line alla rivista.Indirizzo IP e richieste di informazioni sulla procedura di attivazione
dovranno essere inoltrati a [email protected] Subscription rates for institutions includes on-line access to the journal.the ip address and requests for information on the activation procedure
should be sent to [email protected]
Italia: € 130,00 • Foreign € 165,00(solo on-line - on-line only € 120,00)
Privati - individuAls
(solo cartaceo - print version only)Italia: € 100,00 • Foreign € 135,00
































![[2019] SGHC 201 Suit No 374 of 2019 (Summons Nos 1803 ...](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6338ea81de784b0be80046a2/2019-sghc-201-suit-no-374-of-2019-summons-nos-1803-.jpg)