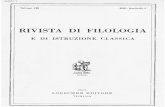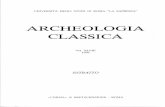Creazione di spazi di vita quotidiana e di un'ausilioteca all ...
L'epicedio di Poliziano per Albiera degli Albizi: tradizione classica e contaminazione di generi
Transcript of L'epicedio di Poliziano per Albiera degli Albizi: tradizione classica e contaminazione di generi
Inhalt
Vorwort .................................................................................................................... ix
Poetik
Rita Degl’Innocenti Pierini L’epicedio di Angelo Poliziano per Albiera degli Albizi: tradizione classica e contaminazione di generi .................................................. 1
Hélène Casanova-Robin Invidia, ira, dolorque La poétique des passions négatives chez Politien : jeu littéraire et construction éthique ................................................................... 29
Virginie Leroux Politien et les songes : désir, imago mortis et vacance de l’âme ....................... 47
Émilie Séris La dérision du corps dans la poésie latine d’Ange Politien ............................ 63
Claudia Wiener Alle Leiden dieser Welt Probleme der Allegorese-Methoden für die Interpretation von Polizianos Sylva in scabiem ........................................................................... 83
M. Elisabeth Schwab Angelo Polizianos Wortmalereien ...................................................................... 99
Thomas Gärtner Lateinische und griechische Epigramme bei Polizian ................................... 119
Philologie
Gianna D’Alessio
Nuove riflessioni sulle Silvae di Stazio in un capitolo della Miscellaneorum Centuria Secunda di Poliziano (Misc. II, 49, Taras) ................ 131
viii Inhalt
Daniela Marrone La poetica nel sistema pedagogico di Poliziano: ripensamenti terminologici ............................................................................... 143
Francesco Caruso Amicus Plato sed magis amica veritas: Poliziano e i confini della filosofia .................................................................... 157
Valerio Sanzotta Per Ficino e Poliziano: alcune riflessioni ......................................................... 177
Rezeption
Catherine Langlois-Pézeret Gilbert Ducher (c. 1490–c. 1548) – émule de Politien ? .................................. 191
Sylvie Laigneau-Fontaine Nicolas Bourbon imitateur, pilleur ou contempteur de Politien ? ............... 203
Laura Refe Poliziano e allievi allo Studio fiorentino: scambi di appunti e di libri tra amici accademici ........................................... 219
Übersetzung
Thomas Baier Poliziano als Übersetzer ..................................................................................... 243
Tobias Dänzer Mechanik und Enzyklopädie in Polizianos Ilias-Übersetzung ..................... 259
Stellenregister zu den Werken Polizianos ....................................................... 275
Namensregister ................................................................................................... 276
Rita Degl’Innocenti Pierini (Florenz)
L’epicedio di Angelo Poliziano per Albiera degli Albizi: tradizione classica e contaminazione di generi*
varietas ipsa, fastidii expultrix et lectionis irritatrix Poliziano, Miscellanea praef. I
Il 24 giugno del 1473 la festa di S. Giovanni, patrono di Firenze, fu celebrata con particolare solennità,1 perché vi partecipò anche Eleonora d’Aragona, fi-glia del re di Napoli, che passava da Firenze per andare a raggiungere Ferrara e sposare Ercole d’Este, duca di Ferrara e di Modena.2 A questi festeggiamenti prese parte anche la giovane Albiera degli Albizi, figlia di Luca degli Albizi e di Caterina di Tommaso Soderini: la famiglia degli Albizi, che possedeva un notevole numero di case nell’odierno Borgo, era molto importante a Firenze dove dal XIII secolo vantava quasi cento priori. Albiera era nata il 15 novem-bre del 1457 ed era stata educata nel monastero fiorentino di S. Vincenzo sotto la guida della fondatrice Annalena Malatesta, vedova di Baldaccio d’Anghiari giustiziato nel 1441 per volontà di Cosimo de’ Medici. Albiera, uscita dal mo-nastero fu fidanzata a Sigismondo Lotteringhi della Stufa,3 egregius iuvenis et qui Laurentio iam inde a puero miro amore, mira pietate esset coniunctus, come lo designa il Poliziano stesso nel Pactianae coniurationis Commentarium. Del resto, come si evince anche dall’Epicedio per Albiera del Poliziano, ai vv. 209 e 249,4 Sigismondo era personalità politica di rilievo, che nel 1473 ricoprì il priorato, summus honos, prima magistratura fiorentina. Inoltre non è da dimenticare, come osserva opportunamente Francesco Bausi5, che il Poliziano fin all’inizio del dicembre 1473 era stato segretario del padre di Sigismondo, Agnolo della Stufa, molto fedele ai Medici, che l’avrà introdotto presso di loro; del resto il
* Ringrazio vivamente Francesco Bausi e Donatella Coppini per alcuni preziosi aggiorna-
menti bibliografici. 1 Sui festeggiamenti di S. Giovanni a Firenze in età medicea, vd. Dempsey 1999, 5–9; Ven-
trone 2007. 2 Falletti 1983, 134. 3 Su questo personaggio, intimo amico del giovane Lorenzo, si vedano le informazioni
fornite da Rochon 1963, 90–93. 4 Rimando all’esaustivo commento ai versi fornito da Bausi 2003. 5 Vd. Bausi 2003, XVI.
2 Rita Degl’Innocenti Pierini
giovane della Stufa risulta figura di un certo spessore culturale, anche a giu-dicare da quello che si deduce dalla sua biblioteca.6
La giovanissima Albiera, che in seguito ai postumi di una polmonite con-tratta durante la festa per Eleonora d’Aragona morì non ancora sedicenne quasi alla vigilia delle nozze, fu seppellita nella chiesa di S. Pier Maggiore, molto probabilmente con un suo busto marmoreo sulla tomba,7 ma niente di questo è rimasto, perchè la chiesa venne demolita nel 1784 dal granduca Pietro Leopoldo, in quanto ritenuta pericolante (si trovava nell’attuale piazza S. Pier Maggiore in fondo quindi a Borgo degli Albizi); quindi il ricordo di lei rimane affidato alle parole di importanti letterati del tempo, primo fra tutti il Poli-ziano, che aveva allora solo 19 anni, ma che si era già fatto ampiamente cono-scere con le sue traduzioni dell’Iliade: a quegli anni del resto risalgono anche le sue prime importanti indagini sui classici, gli studi catulliani e su Marziale.8
Il tragico evento destò grande sconcerto nell’ambiente dei letterati medi-cei:9 ne fa fede in particolare una significativa e ampia antologia dedicata ad Albiera, con testi poetici ed in prosa, trasmessa in un bel codice di dedica do-nato dal fidanzato Sigismondo ad Annalena Malatesta (la fondatrice del mo-nastero fiorentino di S. Vincenzo, dove, come abbiamo già ricordato, Albiera era stata educata) ed ornato da eleganti miniature, conservato oggi nella Bi-blioteca dell’Accademia delle Scienze di Torino (NN.V. 7), che fu studiato da Federico Patetta in un saggio edito negli Atti dell’Accademia stessa (1917–1918). L’epistola dedicatoria di Sigismondo, che leggiamo all’inizio della sil-loge, denota una certa competenza del lessico epistolare e della topica conso-latoria classica e si rivolge alla dedicataria Annalena Malatesta, definita gra-vissima et religiosissima mulier; ne cito solo la parte che più ci interessa:10
Scripserunt ad me amici quidam eulogia nonnulla ut dolorem consolarentur, quem ex obitu Albierae dulcissimae uxoris meae nuper suscepi. Habuerunt multum ponderis, ut, quod nunquam putavi fore ut viverem sine lachrymis, iam resipiscere incipiam et minus adversari voluntati divinae. Ea mitto ad te, si eandem vim habere tecum possint. Scio enim te quoque egere consolatori-bus, que tua in Albieram pietas fuit. Vale.
La raccolta presente nel codice torinese è predisposta secondo un criterio esterno: prima si leggono le composizioni in metro elegiaco, sei, poi tre lettere
6 Bec 1984, 200–203. Vd. anche infra sulla lettera dedicatoria. 7 Se ne occupa ampiamente Luchs 2012. 8 Su Poliziano e Catullo, vd. Gaisser 1982; sul Marziale dei della Stufa e Poliziano, vd.
Bausi 2003, XV. 9 Sull’elegia al Fonzio del 1473 come interessante spaccato della vita letteraria dell’am-
biente frequentato dal giovane Poliziano, basti rimandare all’analisi di Bausi 2003, XVIII ss.
10 Cito da una copia del testo del manoscritto fornitami anni fa dalla Biblioteca dell’Acca-demia delle Scienze di Torino.
L’epicedio per Albiera degli Albizi 3
consolatorie in prosa, seguite da un Hymnus anonimo in metro saffico. A que-sti dieci scritti ‘maggiori’, che sono caratterizzati anche da iniziali miniate, se-guono 28 epigrammi latini, due greci e due epigrafi. Gli autori sono 12, mentre due componimenti risultano anonimi; ci sono nomi molto noti, oltre a Poli-ziano che inaugura la raccolta, Marsilio Ficino, Naldo Naldi, Ugolino Vieri, il Cantalicio, Bartolomeo Fonzio, Francesco da Castiglione, Carlo Marsuppini, Alessandro Braccesi, Bartolomeo Scala: meno noti Amabilio e Andronico Bi-sanzio. La silloge nel suo complesso non è mai stata pubblicata, anche se le altre attestazioni di condoglianza per la giovane Albiera sono ascritte a poeti e letterati importanti, che hanno visto pubblicate le loro opere.11
Oltre al noto epicedio del quale ci occuperemo, è opportuno segnalare che Poliziano compose anche 6 epitafi per la fanciulla (3 tetrastici e 3 distici): que-sti componimenti, che leggiamo nell’edizione Del Lungo,12 sono di fattura molto meno raffinata rispetto all’epicedio, piuttosto banali nelle tematiche e privi di quegli artifici formali, che caratterizzano già la produzione latina po-lizianea, plasmati evidentemente su moduli della tradizione epigrafica ed epi-grammatica.13 Uno di essi, 65 Del Lungo (il secondo nella silloge torinese), sembrerebbe implicare, stando anche allo stesso Del Lungo nella sua edizione, di essere stato apposto sotto il busto nella chiesa di S. Pier Maggiore, ed è elaborato sul motivo topico della superiorità della poesia eternatrice in rap-porto alle arti figurative:14
Vivebam, fato sum rapta Albiera; coniunx Sismundus vitam reddidit en iterum: nam faciem et claram caelato marmore formam, ingenium et mores carmine restituit.
Del resto anche il lungo epicedio per Albiera (286 versi) si chiude con due distici che implicano un epitafio, congeniali senz’altro all’epilogo di un carme composto in metro elegiaco (ma su questi versi torneremo più ampiamente in conclusione). Gli altri epitafi del Poliziano sono rivolti uno, il 66,15 dalla fan-ciulla a Sigismondo, definito ancora coniunx, mentre nel 67, che il Del Lungo intitola Gloria mondana e celeste di Albiera, la fanciulla in prima persona esalta
11 Vd. Perosa 2000, 189–194. 12 Del Lungo 1867. 13 I componimenti meriterebbero comunque una trattazione più ampia, che non è possibile
svolgere in questa sede. 14 Su questo motivo, vd. Mattiacci 2013, 210–213; in particolare da segnalare il confronto
con Mart. 10, 32, 5–6 Ars utinam mores animumque effingere posset / pulchrior in terris nulla tabella foret.
15 Il Del Lungo 1867 ad loc. annota: «Albiera allo sposo. Mi paiono un solo epigramma que-sti 2 distici divisi nelle stampe». Possiamo aggiungere che infatti sono uniti nel codice di Torino: Viva tibi fueram, coniunx, Albiera semper / chara quidem, nunc sum mortua chara ma-gis. / Debebam vivens tibi, sed mage rapta; voluptas / illa fuit , verum haec proxima relligio est.
4 Rita Degl’Innocenti Pierini
la morte come ‘seconda vita’ per la fama immortalatrice conferitale dalla poe-sia in sua memoria.16 Il travestimento classico per cui la morte rende Albiera una dea17 si legge nei due componimenti di un distico rivolti dalla fanciulla a Sigismondo e al padre: 68 Mortalis fueram dum vixi Albiera coniunx / Sismonde, at nunc sum mortua facta dea; 70 Quid quereris, genitor?18 vivit tua filia coelo / Al-biera: anne deam progenuisse doles?
L’epicedio per Albiera divenne giustamente famoso e con esso il giovanis-simo Poliziano si conquistò un posto di rilievo tra i letterati della corte medi-cea: già Giulio Cesare Scaligero nel libro VI della sua Poetica (1561, p. 739) sot-tolineava che Elegia pro epicedio valde bona est, ingeniosa, plena, numerosa, candida, arguta, efficax: plane digna tanto viro et quam equidem scripsisse malim, quam quae dicitur ab Ovidio in morte Drusi missa. Dunque secondo lo Scaligero l’elegia per Albiera sarebbe da preferire alla Consolatio ad Liviam, attribuita ad Ovidio in età umanistica, un testo che viene anche imitato in qualche passo dal Poliziano, e che, come ben sappiamo, ora non viene più considerata opera autentica del Sulmonese.19 Interessante notare, per incidens, che la Consolatio ad Liviam, in quanto ascritta ad Ovidio, fu pubblicata in una delle due prime edi-zioni a stampa (Roma 1471) e poi in quella di Ausonio (Venezia 1472), cioè proprio negli anni immediatamente precedenti all’elaborazione dell’epicedio polizianeo per Albiera. Tutti i manoscritti, come dimostra Reeve,20 sono della fine del XV secolo e quindi coevi alle edizioni a stampa, tanto che c’è stato chi come Moritz Haupt in passato è arrivato a considerarla un falso umanistico: che fosse ben conosciuta nell’ambiente fiorentino, frequentato da Poliziano, lo testimonia la presenza in un codice Laurenziano 36.2 ai ff. 242r–247v, codice L che fu vergato da Bartolomeo Fonzio21 per Francesco Sassetti, presso cui si recò nel 1471. Il Fonzio, più anziano del Poliziano di sette o otto anni, seguì le lezioni di Pietro Cennini, dove si trattava forse anche dell’ad Liviam, come si potrebbe evincere da un codice di appunti, il Riccardianus 152, studiato da Caroti e Zamponi,22 dove a 167v se ne riportano degli excerpta23 (ma una con-nessione diretta con le lezioni del Cennini non è dimostrata).24 Il Poliziano,
16 Morte una geminam sum nacta Albiera vitam / fama etenim terras spiritus astra colit. / Fama
olim, numquam sed spiritus occidet; haec mi / vita quidem semper vivet, at illa diu. 17 Mortalem [...] deam è anche definita Albiera nell’epicedio, v. 150 (vd. Bausi 2003 ad loc.). 18 Il vocativo genitor è omesso nell’edizione Del Lungo, ma è tradito nel manoscritto della
raccolta di Torino ed è necessario per ragioni metriche. 19 Vd. Schoonhoven 1992. 20 Analisi documentata in Reeve 1976, 79–98 (in particolare 80); vd. anche Schoonhoven
1992, 40–52. 21 Vd. bibliografia in Bausi 2003, XIII. 22 Caroti / Zamponi 1974, 41–45. 23 Vv. 9–10, 347, 357–362, 369–374, 427–428 e 443–444. 24 Se Dal Zotto 1904, 57 ss. li attribuisce alle lezioni del Cennini e quindi parla di prima
testimonianza, viceversa Reeve 1976, 94 seguendo Caroti / Zamponi 1974, 41–45 non connette gli excerpta con le lezioni del Cennini.
L’epicedio per Albiera degli Albizi 5
che ne cita quattro versi come Ovidius ad Liviam nel commento ai Fasti p. 23, 46 (Lo Monaco), non sembra che utilizzarla molto sporadicamente per l’Al-biera, come si evince dalle documentate note del commento di Bausi all’epi-cedio;25 forse qualche traccia ulteriore, ma certo piuttosto sfumata, mi pare di poter individuare, come per esempio subito nella protasi al v. 2 in un contesto di lamentatio topico degli epicedi (aut quis iam miseris temperet a lachrymis), dove è vero che temperet a lachrymis ricalca le parole di Enea in Aen. 2, 8, come indica opportunamente Bausi 2003, ad loc., ma non appare forse estraneo an-che alla mediazione di Cons. ad Liv. 8, dove leggiamo et quisquam lacrimas tem-perat ore tuas?. Interessante è anche il caso del distico (vv. 19–20) Maius habes vulnus secreto in pectore, quam quo / te deceat madidas non habuisse genas, dove il Poliziano svolge un motivo consolatorio cortigiano-panegiristico, richia-mando Sigismondo, in quanto membro di una élite, a contenere pubbliche manifestazioni di dolore,26 motivo che si può leggere più ampiamente svolto per la sposa di Augusto a partire dai vv. 345–346 Quid deceat Drusi matrem matremque Neronis / adspice, quo surgas, adspice, mane toro. Una possibile inter-ferenza di un modulo carico di ironia tragica, che rimanda con la movenza sarcastica dell’i nunc ai casi dell’imprevedibile fortuna, presente nei vv. 363–364 dell’ad Liviam (i nunc et rebus tanta impendente ruina / in te solam oculos et tua damna refer) non escluderei che non contribuisca a plasmare i vv. 49–50 dell’epicedio polizianeo (Ah dolor! I nunc, et rebus confide secundis, / quas For-tuna levi fertque refertque manu!), seppure qui si imponga come preminente so-prattutto nei versi successivi la memoria di Properzio 3, 18. Anche nelle pate-tiche parole di Albiera morente che si rivolge al coniunx Sigismondo, vv. 212–213 Parce igitur Manes sollicitare pios; / parce, precor, lachrymis, coniunx [...], mo-venza già presente al v. 193 Parce, precor, lachrymis, si può intravedere un mo-dello anche in Cons. ad Liviam, quando si sottolinea il dominio della cieca For-tuna sulle vicende umana, vv. 375–376 Regna deae inmitis parce inritare querendo / sollicitare animos parce potentis erae. Altri esempi si potranno forse aggiungere, ma mi interessava sottolineare come anche l’ad Liviam interagisca con altri te-sti classici più nobili e possa aver addirittura influito nell’adozione stessa del distico elegiaco da parte di Poliziano per il suo epicedio.
Se come abbiamo detto fu già lo Scaligero ad esaltare l’epicedio di Poli-ziano per Albiera, facendo un lungo salto nel tempo, furono in séguito gli studi di Isidoro Del Lungo e di Giosuè Carducci, che contribuirono a valutare il componimento positivamente, sia per la sua capacità descrittiva ed evoca-tiva sia soprattutto in relazione alla genesi del più importante componimento in volgare del Poliziano, Le Stanze per la giostra, anch’esso elaborato non molto tempo dopo con analogo intento occasionale, celebrativo come è ben noto
25 Il testo dell’epicedio sarà citato secondo l’edizione di Bausi 2003. 26 Ho trattato del motivo in Degl’Innocenti Pierini 1990 b, 221–234.
6 Rita Degl’Innocenti Pierini
della vittoria di Giuliano de’ Medici nel torneo tenutosi in S. Croce il 29 gen-naio 1475. Notava appunto Giosuè Carducci27 che la «macchina mitologica» presente nell’Epicedio costituisce un significativo precedente delle Stanze. No-nostante affermazioni come queste, per anni continuerà a pesare sulla poesia latina del Poliziano un notevole pregiudizio, che in Italia fu poi incrementato dall’idealismo crociano imperante fino almeno alla fine degli anni ‘40 del se-colo scorso; leggiamo per esempio in un articolo di Benedetto Croce del 1932 dedicato alla poesia latina del Rinascimento:28 «ciò che offusca sovente questi carmi latini del Poliziano è la formula letteraria e erudita, della quale egli non sa far di meno e che si mescola alle parole ritraenti le fresche impressioni della realtà [...]. Certo il punto che a noi suona più poetico nella elegia in morte di Albiera degli Albizi è quello in cui si evoca la bella persona della giovinetta; la parte del compianto è alquanto declamata» fino a giungere ad un’afferma-zione piuttosto singolare e quanto mai impressionistica: «Ma anche in quella evocazione si vede alternare nell’esametro la frase nata e nel pentametro la frase fatta».
Ma è soprattutto con un magistrale saggio pubblicato in inglese nella pre-stigiosa rivista dell’Istituto Warburg da Alessandro Perosa nel 1946, che co-mincia l’indagine moderna e filologicamente attrezzata del testo polizianeo del quale ci occupiamo: il Perosa, del quale mi onoro di essere stata allieva a Firenze per la filologia umanistica, aveva studiato con Giorgio Pasquali ed era personalità capace di coniugare lo sguardo d’insieme di grande e acuta com-petenza letteraria all’indagine testuale,29 ma non arrivò purtroppo a pubbli-care un commento all’Epicedio né l’edizione della silloge poetica per Albiera compresa nel codice torinese, come si riprometteva da tempo e pur avendoci lavorato a lungo. L’articolo cui prima mi riferivo è intitolato Febris: A Poetic Myth Created by Poliziano, e il Perosa individua nell’ekphrasis centrale del poe-metto la volontà del giovane poeta latino di emulare i suoi classici ricreando sulle loro orme un mito, che, pur basato su molte letture e riscritture, fosse in grado di vivere di luce propria e di gareggiare con i modelli. Emerge già nel pioneristico saggio del Perosa quello che diventerà il Leitmotiv della critica sul Poliziano e che vediamo applicato allo studio della poesia umanistica a partire da un fondamentale saggio di Mario Martelli del 1973, a 5 secoli dall’elegia per Albiera, La semantica di Poliziano e la «Centuria secunda» dei «Miscellanea»: Poliziano, con la sua dottrina eccezionalmente precoce ed il suo fine gusto letterario, si dimostra in grado di costruire un tessuto poetico in cui interagi-sce un mosaico di voci letterarie, varie per tipologia e età, ma tutte amalga-mate e fatte ruotare intorno a quelle che Martelli definisce «unità semantico-letterarie», nuclei tematici che intersecano notizie erudite e topoi poetici in un
27 Carducci 51863: vd. Bausi 2004–2005, 225 n. 20. 28 Croce 1932, 248. 29 Una recente disamina di Perosa studioso della poesia umanistica offre Coppini 2013,
nell’ambito di una serie di studi dedicati alla memoria dello studioso.
L’epicedio per Albiera degli Albizi 7
nuovo e felicemente armonioso amalgama.30 Ad un allievo di Martelli, Fran-cesco Bausi, anche lui di formazione fiorentina quindi, dobbiamo gli studi più recenti sull’epicedio per Albiera e soprattutto un eccellente commento pun-tuale al carme, edito nel 2003, che viene a colmare quella lacuna, che il Perosa già lamentava ripromettendosi il commento cui abbiamo ora accennato. Ed è appunto da questo importante lavoro che dobbiamo muoverci per la nostra analisi, punto costante di riferimento delle mie considerazioni che partono ovviamente da un’ottica di filologa classica, tralasciando quindi per esempio il rapporto del Poliziano con le fonti di poesia consolatoria umanistica, sulle quali del resto disponiamo di ricerche importanti ancora di Bausi.31
Il mio intento è quello di proporre un percorso di lettura di alcuni snodi della struttura di questo ampio componimento, tentando di individuare nella sua complessa e raffinata tessitura qualche ulteriore suggestione che mi sem-bra pervenire al giovane poeta anche da modelli diversi rispetto a quelli prin-cipali e tradizionalmente evocati, fino a postulare, come vedremo, una forma di poetica implicita, che alessandrinamente intreccia generi diversi in una sorta di Kreuzung der Gattungen, o, come si preferisce ora definirla, un mosaico di generi.32
Mi sembra utile prendere avvio dalla struttura del poemetto, partendo dallo schema proposto nel commento di Bausi, e operando solo qualche limi-tata distinzione rispetto alla sua proposta di suddivisione dei versi: i vv. 1–56 sono caratterizzati da un’ampia protasi che introduce il carme con i caratteri topici della lamentatio dell’epicedio, dove il poeta si descrive, vv. 11–14, come un poeta epico33 che ha abbandonato il suo compito (la traduzione in latino dell’Iliade ovviamente), nil dulce sonans, non quindi per intonare un piacevole canto d’amore, come la scelta del metro elegiaco potrebbe far supporre ai dotti lettori di Poliziano,34 ma carmina moesta, e così assecondare il dolore di Sigi-smondo, intrecciando compianto per il suo lutto e laudatio della giovane per-duta promessa sposa (comunque già definita coniunx al v. 5 e poi ai vv. 24–25).
I vv. 57–58, a mio parere, possono essere considerati un proemio al mezzo, che introduce eziologicamente il racconto dei vv. 59–88, che offrono un’ampia descrizione della festa di S. Giovanni in onore di Eleonora d’Aragona con la partecipazione della giovane Albiera, la cui grazia e bellezza scatenano i torvi
30 Martelli 1995, 267–274. 31 Sui modelli contemporanei, oltre alle note ad locc., vd. la valida sintesi di Bausi 2006, 14
e n. 12. 32 Mi riferisco per esempio alla complessa analisi del carme 64 di Catullo fornita da Fer-
nandelli 2012 a. 33 Bausi 2003, ad loc. confronta Stat. silv. 1, 5, 8–9 Paulum arma nocentia, Thebae, / ponite:
dilecto volo lascivire sodali. 34 Dulcis evoca la poesia leggera, pastorale ed elegiaca: vd. per es. Gell. 19, 9, 4 poetarum
quoque recentium ἐλεγεῖα quaedam erotica dulcia et venusta cecinerunt.
8 Rita Degl’Innocenti Pierini
orbes di Ramnusia, l’invidiosa dea che ordisce contro di lei una trama di morte attraverso l’intervento di Febris; i vv. 89–164 costituiscono un’ekphrasis, cuore centrale del poemetto, ricca di suggestioni espressionistiche di matrice ovi-diana, tesa a contrapporre il tema della morte a quello della bellezza giovanile e dell’amore. Conclusasi l’ekphrasis, si torna in forma di Ringkomposition ai mo-tivi topici dell’epicedio, con ai vv. 165–190 la descrizione della malattia e il dolore dei parenti, seguita dagli ultima verba della fanciulla morente al pro-messo sposo (vv. 191–220), poi dalla descriptio mortis e dello strazio dei parenti e di Sigismondo (vv. 221–250), dalle esequie (vv. 251–280) e chiusa infine da un epitafio di 2 distici (vv. 281–286).
Già dall’analisi schematica del componimento credo che si possa evincere una cura compositiva ed una ricchezza tematica, che travalica la topica dell’epicedio: in particolare la struttura anulare con l’ekphrasis centrale non può non ricordare, a mio avviso, il carme 64 di Catullo, intitolato nei codici umanistici Epithalamium Thetidos et Pelei, un epitalamio mitico,35 modello nel quale Poliziano poteva aver trovato il raffinato antecedente della sua tessitura poetica,36 in cui s’intrecciano Amore e Morte, giacché si conclude con il canto epitalamico delle Parche e l’evocazione di un destino di morte collettiva con la nascita di Achille, apportatore di guerra e di sangue.
I principali modelli classici suggeriti per l’elegia37 vengono a coincidere con famosi epicedi, in distici come Ovidio Amores 2, 6 per la morte del pappa-gallo di Corinna, e 3, 9 in morte di Tibullo (oltre naturalmente alla Consolatio ad Liviam), l’elegia properziana di Cornelia, ma soprattutto si sottolinea, a ra-gione, la profonda influenza esercitata da carmi funebri delle Silvae staziane, la cui editio princeps era uscita un anno prima, nel 1472,38 e che sarà un testo sempre molto caro al Poliziano, che nell’anno 1480/1481 gli dedica il suo primo corso universitario:39 gli epicedi staziani sono numerosi, e, anche se in esametri, per la loro lunghezza, per singoli stilemi e topoi sono presenti conti-nuamente alla memoria poetica del Poliziano (significativi in particolare sono il 2, 1 per il giovane Glaucia; 2, 6 a Flavio Etrusco per la perdita del suo puer delicatus; 5, 1 in morte di Priscilla, la moglie del potente liberto Abascanto).40
Credo comunque che lo schema compositivo, che abbiamo evidenziato per l’Epicedio di Albiera, non trovi soddisfacente riscontro nella struttura degli epi-cedi staziani: lo stesso Poliziano, quando commenta Silvae 2, 1 l’Epicedion in
35 É da segnalare con Fernandelli 2012 a, 2 n. 3, che per esempio già Claudiano, nella Prae-
fatio del suo Epithalamium de nuptiis Honorii Augusti, allude al carme 64, fin dal primo verso, come ad un epitalamio (Surgeret in thalamum ducto cum Pelion arcu).
36 Nelle note introduttive al suo commento a Stat. silv. 1, 2 Poliziano cita Catullo e Clau-diano come autori latini di epitalami pervenuti e Teocrito tra i Greci.
37 Vd. Bausi 2003, XL–XLI. 38 Vd. Bausi 2003, XLV e n. 76. 39 Si veda Cesarini Martinelli 1978. 40 Sugli epicedi di Stazio, vd. Asso 2008, con ulteriore bibliografia.
L’epicedio per Albiera degli Albizi 9
Glauciam (p. 430, 26–431, 24 Cesarini Martinelli) sottolinea, parafrasando Me-nandro retore (2, 9; 413–414 Russel / Wilson), quali sono gli elementi e la strut-tura da seguire in un discorso consolatorio: una prima parte che si configura come una consolatio, in consolatione incipiamus et ipsi conqueri augeamusque af-fectus [...], seguita da laudatio generis, naturae, educationis, eruditionis, studiorum, factorum del defunto, e, se si tratta di un giovane, si fa leva sulla mozione degli affetti (affectus inde eruendi sunt, quod ante diem obierit, quod parentes, quod amicos spe privarit). Nella seconda parte si suggerisce il ritorno alla consolazione, che deve ora trattare della comune condizione umana e anche di come le cose del mondo si deteriorino, della sorte dell’anima e della beatitudine che vive il de-funto. Pur nella sintesi del testo che ho operato, si evince chiaramente che lo schema bipartito appare rispecchiato41 solo nell’incipit dell’Epicedio di Albiera, dove il poeta asseconda ed enfatizza il dolore di Sigismondo, e poi nella parte finale, dove è la stessa Albiera morente a consolare il suo futuro e mancato sposo, e i suoi genitori con le parole topiche degli epicedi e della letteratura consolatoria.
Come si può ben vedere, rimane fuori gran parte dello sviluppo strutturale di un poemetto come l’epicedio per Albiera, che è legato anche all’occasione e alla celebrazione di una festa, quella di S. Giovanni, che prelude alle nozze di Eleonora d’Aragona con Ercole d’Este. Io credo, e tenterò di dimostrarlo nella mia analisi, che Poliziano arrivi a contaminare deliberatamente epicedio ed epitalamio forse per offrire almeno post mortem un dono di nozze poetico, che poteva aver promesso o poteva addirittura essergli stato già commissio-nato da Sigismondo stesso: in questo senso può essere importante un’osser-vazione che leggo in Bausi, nella sua edizione42 dell’epicedio, quando fa no-tare che probabilmente il manoscritto di Marziale corretto da Poliziano, ora alla British Library, sarebbe stato approntato come dono nuziale per le già programmate nozze della Stufa-degli Albizi. In quest’ottica di lettura non sot-tovaluterei il peso programmatico dei versi 13–14, che potrebbero sottinten-dere un rapporto tra dulcia carmina come poesia amorosa per le nozze e i moe-sta carmina dell’epicedio; invece di lasciare l’esperienza epica per cantare poesia d’amore si trova costretto suo malgrado all’esperienza della poesia tri-ste: Heu nil dulce sonans taceo iam bella tubasque / et refero ad nigros carmina moesta rogos. Si può forse supporre un’influenza della poetica catulliana, quando evo-care la morte del fratello implica per il poeta solo una poesia ‘triste’ e non i dulcia carmina d’amore: vd. 65, 1–3; 10–11: Etsi me assiduo confectum cura dolore / sevocat a doctis, Ortale, virginibus, / nec potis est dulcis Musarum expromere fetus / mens animi [...]; at certe semper amabo, / semper maesta tua carmina morte canam.
Esaminiano ora il primo ritratto di Albiera, vv. 25–42:
41 Così Cesarini Martinelli 1978, 140–141. 42 Vd. Bausi 2003, XIV–XV.
10 Rita Degl’Innocenti Pierini
Uxor abest, heu heu!, sed qualem nulla tulerunt Saecula, sed qualem tempora nulla ferent: Uni quicquid habet dederat Natura decoris, Uni etiam dederat Gratia quicquid habet. Candor erat dulci suffusus sanguine, qualem Alba ferunt rubris lilia mixta rosis. Ut nitidum laeti radiabant sidus ocelli: Saepe Amor accensas rettulit inde faces. Solverat effusos quoties sine lege capillos, Infesta est trepidis visa Diana feris; Sive iterum adductos fulvum collegit in aurum, Compta Cytheriaco est pectine visa Venus. Usque illam parvi furtim componere Amores Sunt soliti, et facili Gratia blanda manu, Atque Honor et teneri iam cana Modestia vultus, Et Decor, et Probitas, purpureusque Pudor, Casta Fides, Risusque hilaris, Moresque pudici, Incessusque decens, nudaque Simplicitas.
Lo spazio riservato alla descrizione incantata e insistita della bellezza fisica di Albiera in due lunghi e significativi passi del poemetto non appare consono alla topica dell’epicedio, come teorizzato nei retori e applicato dai poeti latini, dove, specialmente in Stazio, sono esaltate soprattutto le doti morali. Per ve-rificare se la mia interpretazione coglie nel segno, mi soffermerò in particolare sul raffinato ritratto fisico di Albiera, per evidenziarne tracce di una lunga tradizione poetica che richiama l’epitalamio, dove è costante l’esaltazione della bellezza virginale della sposa. Infatti Poliziano nell’evocare la bellezza di Albiera, pur collegata nei vv. 26 ss. ad un motivo topico della lamentatio, sembra voler innanzitutto sottolineare nella fanciulla la bellezza acerba e quasi androgina, simile a quella delle eroine vergini della tradizione epica la-tina, come la Camilla di Virgilio o l’Atalanta di Ovidio, oppure alle ninfe insi-diate e ritrose presenti nelle Metamorfosi. Basterà per esempio a confermarlo la sostanziale distanza, non solo di ruolo e d’età, dal ritratto di una sposa de-funta come la Priscilla dell’epicedio di Stazio silv. 5, 1, che è maggiormente incentrato sulle doti morali arcaizzanti della donna romana, addirittura equi-parata ad un’Apula coniunx del buon tempo andato (vv. 118 tenor idem animo moresque modesti; 121 ipsa dapes modicas et sobria pocula tradit), mentre la sua presenza fisica è evocata con rapidi tocchi, privi di suggestioni erotiche e di fascino, quasi una lode obbligata in negativo (vv. 54 et felix species multumque optanda maritis; 64–66 nec frons triste rigens nimiusque in moribus horror, / sed
simplex hilarisque fides et mixta pudori / gratia). Poliziano sembra volersi ispirare ad una tradizione poetica incentrata sulla
leggiadria virginale, come dimostra, quasi paradossalmente, anche un in-flusso diretto del ritratto fisico staziano di Glaucia, il puer delicatus di Atedio
L’epicedio per Albiera degli Albizi 11
Meliore (silv. 2,1), del quale vengono esaltate le qualità fisiche accanto a quelle morali, costituendo quindi un modello di rilievo per l’Albiera di Poliziano. La descrizione fisica di Glaucia in Stazio mira ad evidenziare pudore e sobrietà, sottolineandone la precoce maturità nell’atteggiamento (vv. 39–40 rapit inde modestia praecox / et pudor et tenero probitas maturior aevo), e anche i particolari dell’acconciatura sono corredati nel testo staziano da un’aggettivazione ‘mo-raleggiante’ (vv. 43–45 et castigatae collecta modestia frontis / ingenuique super crines mollisque decorae / margo comae?). In particolare da questa silva Poliziano sembra far derivare l’immagine del rossore pudico, che tinge l’incarnato can-dido di Albiera, degli occhi che dardeggiano splendenti, nonché la descrizione della chioma, ma, come di consueto, pur non mancando gli elementi comuni, come i vv. 41–42 di Stazio (o ubi purpureo suffusus sanguine candor / sidereique orbes radiataque lumina caelo), basta leggere lo svolgimento dei due motivi in Poliziano per capire come per Albiera i tratti descrittivi varino con grande maestria l’elogio staziano, dimostrando di saper cogliere nella grazia efebica del puer anche il sedimentarsi di una tradizione letteraria, virgiliana, ma so-prattutto ovidiana, che era tesa a far emergere proprio il fascino ambiguo di figure femminili androgine come Camilla o Atalanta,43 confluite poi in Stazio nella grazia efebica di un puer come Glaucia oppure nell’Achille giovane dell’Achilleide,44 quando sta per inserirsi nel chorus delle fanciulle a Sciro, 1, 336–337 fallitque tuentes / ambiguus tenuique latens discrimine sexus.
Anche in questa particolare tecnica di incrocio a mosaico di modelli, segno certo di grande sensibilità interpretativa, il Poliziano mi sembra possa dimo-strarsi in qualche modo precursore della critica moderna,45 che ha appunto insistito nel collegare queste tipologie descrittive, che culminano nel gusto staziano per la grazia efebica, e per questo credo che si possa parlare a buon diritto, come ho già accennato, addirittura di poetica implicita del Poliziano. Del resto immagini simili specialmente in relazione all’acconciatura dei ca-pelli si riscontrano anche per divinità come Diana e Bacco, che sono tradizio-nalmente modelli efebici dagli incerti confini sessuali: di Bacco in un coro dell’Oedipus di Seneca, quando se ne evoca il giovanile travestimento femmi-nile per sfuggire a Giunone, leggiamo, v. 415 spargere effusos sine lege crines, che è molto vicino alla descrizione di Albiera al v. 33 Solverat effusos quoties sine lege capillos, tranne che poi nel Poliziano questa descrizione si lega invece al paragone con Diana cacciatrice, v. 34 infesta est trepidis visa Diana feris, im-magine che si rivela a sua volta plasmata su un famoso passo del III libro dell’Ars amatoria ovidiana dove ai vv. 143–144 leggiamo Altera succinctae reli-getur more Dianae, / ut solet, attonitas cum petit illa feras. Qual è la tessera-spia del mosaico testuale che lega, in questo complesso e suggestivo intarsio, il
43 Vd. infatti per Atalanta Ov. met. 8, 322–323 Talis erat cultu, facies, quam dicere vere / virgi-
neam in puero, puerilem in virgine possis. 44 Vd. Rosati 1992. 45 Vd. per es. La Penna 1996, 161–184; Rosati 1992.
12 Rita Degl’Innocenti Pierini
passo tragico senecano all’Ovidio dell’Ars? Credo senz’altro l’espressione sine lege riferita all’acconciatura, che troviamo poco prima anche nel testo del III libro dell’Ars ovidiana 133–134 non sint sine lege capilli / admotae formam dantque negantque manus, famoso contesto nel quale Ovidio esaltava le munditiae, an-che quelle che simulavano, come anche nel caso di Albiera, una raffinata non-chalance nell’acconciatura (v. 153 et neglecta decet multas coma).46
Del resto proprio l’evocare la fanciulla in diverse forme dell’acconciatura e quindi in varie attitudini dimostra la conoscenza della didascalica erotica ovidiana,47 che implicava una seduzione, che emanava anche da una studiata semplicità (v. 155 ars casum simulet): si nota però nel Poliziano una variatio ri-spetto ai modelli classici, giacché nel testo di Ovidio a Diana cacciatrice ri-mandava un’acconciatura con i capelli legati dietro con un nodo o una treccia che scendeva giù nel collo,48 per la quale non dimentichiamo poi l’ulteriore suggestione derivata da una famosa descrizione di Didone, che nel IV dell’Eneide si avvia alla caccia insieme ad Enea, mentre i suoi crines nodantur in aurum,49 acconciatura, che vediamo ben rappresentata nella pittura e nella scultura fiorentina coeva del Poliziano per giovani donne,50 e che invece viene evocata subito dopo per Albiera in riferimento al seduttivo pettine di Ve-nere.51 Anche la descrizione di Dafne nel I libro delle Metamorfosi52 mi pare offrirci un calzante parallelo di una capigliatura sine lege, e quello che più ci interessa sottolineare è che si collega in modo evidente al tema della verginità ritrosa delle ninfe,53 in allusiva connessione intertestuale con motivi topici
46 Vd. Labate 1984, 167. 47 Il motivo ritorna nelle Stanze: vd. Bausi 2003, ad vv. 33–36. 48 Per il tema della caccia, vd. Didone in Verg. Aen. 4, 138; Atalanta in Ov. met. 8, 319 crinis
erat simplex, nodum collectus in unum. Altri passi discute Gibson 2003, ad loc. 49 Il passo nel suo complesso sembra presente anche in séguito per la presenza del termine
caterva, quando Ramnusia chiede l’intervento di Febris, vv. 133–134: Quae gaudet, fati sor-tisque ignara futurae; / quam digito atque oculis densa caterva notat?; vd. infatti Verg. Aen. 4, 136–139 Tandem progreditur magna stipante caterva / Sidoniam picto chlamydem circumdata limbo; / cui pharetra ex auro, crines nodantur in aurum, / aurea purpuream subnectit fibula ve-stem.
50 Basti citare di Sandro Botticelli il Ritratto di giovane donna come ninfa (forse Simonetta Cattaneo Vespucci) ascritto circa al 1480–1485, ora conservato allo Städel Museum di Frankfurt am Main.
51 Sulla seduzione del pettinarsi, si veda ora l’importante saggio di Rosati 2015. Interes-sante anche il rapporto con Venere ed in particolare (cito testualmente da pp. 239–240) «una presenza di primo piano nell’iconografia della Vanitas, particolarmente diffusa nell’arte medievale e rinascimentale, costituita da una donna nuda, seduta o recombente mentre è dedita alla toilette, cioè mentre si pettina i capelli guardandosi allo specchio, o li adorna con gioielli e fiori».
52 Sulla presenza del mito di Dafne nelle Stanze, vd. Delcorno Branca 2006, 122–123. 53 Da segnalare anche Diana e le sue ninfe nell’episodio di Atteone met. 3, 168–170, dove
Diana al bagno si vede acconciare i capelli dalla ninfa Crocale: nam doctior illis / Ismenis Crocale sparsos per colla capillos / colligit in nodum, quamvis erat ipsa solutis. Del resto non
L’epicedio per Albiera degli Albizi 13
dell’epitalamio, vv. 477–480, dato che mi pare addirittura esibita nel passo ovidiano la dipendenza dal catulliano carme 62:54
Vitta coercebat positos sine lege capillos.55 Multi illam petiere, illa aversata petentes inpatiens expersque viri nemora avia lustrat. Nec, quid Hymen, quid Amor, quid sint conubia curat.
Ancora interessante è lo sviluppo relativo alla descrizione delle chiome di Dafne (tema che prelude alla metamorfosi in pianta, v. 550) sotto lo sguardo innamorato di Apollo, che arriva ad immaginare anche l’effetto di una chioma composta e pettinata, vv. 497–499:
spectat inornatos collo pendere capillos et ‘quid, si comantur?’ ait. Videt igne micantes sideribus similes oculos, […]
La presenza di quest’ultimo passo nella memoria poetica del Poliziano è con-fermata dal paragone (ut nitidum laeti radiabant sidus ocelli) degli occhi ‘ri-denti’56 con stelle, motivo topico della poesia d’amore, nel corteggiamento amoroso,57 ma anche dell’epitalamio a partire da Saffo fr. 34 V., come emerge anche nel successivo ritratto di Albiera durante la festa: qui ci piace ricordare un modello, già riconosciuto dal Bausi nel suo commento, e cioè un’elegia, la 3, 8 del Corpus tibullianum, elegia tibulliana in quanto parte di quel corpus poe-tico, ma in realtà legata al ciclo di Sulpicia, con ogni probabilità post-ovidiano, dove proprio nel raffigurare la giovane Sulpicia appaiono susseguirsi alcuni motivi presenti in questo ritratto, come gli occhi che ispirano amore (vv. 5–6 illius ex oculis, cum vult exurere divos, / accendit geminas lampadas acer Amor), il motivo della duplice, ma comunque seduttiva acconciatura dei capelli (vv. 9–10 seu solvit crines, fusis decet esse capillis; / seu compsit, comptis est veneranda comis), distici cui si inframezza un elemento molto importante ai fini del no-stro componimento, e cioè il tema del Decor personificato, che accompagna la fanciulla in ogni suo gesto esterno (vv. 7–8 Illam, quidquid agit, quoquo vestigia movit, / componit furtim subsequiturque Decor). Infatti anche nel nostro epicedio
dimentichiamo che Albiera è definita nympha nel corso del poemetto (v. 79), come a mag-gior ragione sarà la Simonetta nello scenario boschereccio delle Stanze.
54 Vd. Catull. 62, 42 multi illum pueri, multae optavere puellae; 55–59 multi illam agricolae, multi coluere iuvenci; cum par conubium maturo tempore adepta est, / cara viro magis et minus est invisa parenti. / Hymen o Hymenaee, Hymen ades o Hymenaee!
55 Il verso è espunto da Tarrant nell’edizione oxoniense: a mio parere le nostre considera-zioni corroborano la tesi di Murgia 1985, che difende l’autenticità del verso mettendo in luce anche il rapporto tra il tema della castità e la capigliatura apparentemente non cu-rata.
56 Vd. anche Stanze 1, 55, 1–2: Poi con occhi più lieti e più ridenti, / tal che ‘l ciel tutto asserenò d’intorno (da leggere col commento di Bausi 1997, ad loc.).
57 Sul tema della stella nel corteggiamento, vd. Rosati 2003.
14 Rita Degl’Innocenti Pierini
il distico successivo alla descrizione delle chiome, vv. 37–38, mi pare intro-durre in modo elegante un motivo del tutto anomalo rispetto al ritratto del defunto tradizionale nella laudatio e fortemente corroborare la suggestione di lettura, che proponiamo per il nostro carme, cioè l’intrecciarsi di motivi da epitalamio ad elementi topici dell’epicedio.
Infatti ai vv. 37–38 sono i parvi Amores, gli Amorini,58 che di nascosto ac-conciano la giovane Albiera quasi si trattasse di una sposa (usque illam parvi furtim componere Amores / sunt soliti), e vi collabora la seduttiva Gratia con la sua mano esperta; quindi il tradizionale corteggio di Venere, topico degli epi-talami,59 prelude e apre in modo originale e significativo ai versi seguenti, nei quali vengono enumerate virtù personificate,60 una sorta di comitatus virtutum, un corteggio di virtù, che corrisponde in positivo a quello dei terribili compa-gni di Febris evocati poi ai vv. 97–104 dell’ekphrasis, mescolando qualità di Al-biera, congrue con il tono di solenne rimpianto che si confà al tema funebre, con elementi più consoni alla tradizionale laudatio muliebris della poesia amo-rosa e di corteggiamento sia classica che volgare. Sono elencati Honor, la Mo-destia topica del puer senex, Decor, Probitas, purpureus Pudor, casta Fides, Risus hilaris, Mores pudici, Incessus decens61 e nuda Simplicitas), un passo che, a mio parere, si modella parzialmente, almeno sulle ultime virtù evocate, anche su un’elegia degli Amores, la 1, 3, 11–14, dove però sono riferite al poeta stesso, che così si raffigura, non senza un po’ d’ironia, per conquistare la donna amata:
58 Vd. anche in Poliziano sylv. 2, 216–217 comes alma sorori / it Venus, et Venerem parvi comi-
tantur Amores. Sugli Amorini (parvi Amores in Prop. 3, 1, 11) negli epitalami, oltre a Stazio silv. 1, 2, vd. anche Claud. epith. Honor. 97 ss.; Sid. Apoll. Rur. 53 ss.; Ennod. epith. dict. Maximo 53 ss.; Venant. Fort. poemat. 5, 1, 24. Sull’influsso di Stazio sull’epitalamio tardo, basti citare Pavloskis 1965; Horstmann 2004; Wasdin 2014, passim.
59 Menandro retore suggerisce la presenza degli amorini nel canto nuziale: vd. 2.6 (404, 20 Russell / Wilson); 2, 7 (407, 5–8; 411, 12–13 Russell / Wilson), come testimonia del resto ampiamente Claudiano nei suoi carmi nuziali: epith. Honor. 72–74 mille pharetrati ludunt in margine fratres, / ore pares, aevo similes, gens mollis Amorum; carm. min. 25, 10–20: pinnati passim pueri quo quemque vocavit / umbra iacent; fluitant arcus ramisque propinquis / pendentes placido suspirant igne pharetrae. / Pars vigiles ludunt aut per virgulta vagantur, / scrutantur nidos avium vel roscida laeti / mala legunt, donum Veneri, flexusque secuntur / palmitis et sum-mas pinnis librantur in ulmos, / defendunt alii lucum Dryadasque procaces / spectandi. Per uno sguardo d’insieme sul motivo del corteggio di Venere nella poesia tardo–antica, vd. Gué-rard 2011.
60 Interessante un testo ricco di personificazioni di concetti astratti come Claud. epith. Ho-nor. 77–85 nodo / et flecti faciles Irae vinoque madentes / Excubiae Lacrimaeque rudes et gratus amantum / Pallor et in primis titubans audacia furtis / iucundique Metus et non secura Voluptas; / et lasciva volant levibus Periuria pinnis. / Quos inter petulans alta cervice Iuventas / excludit Senium luco. Per il motivo delle personificazioni in Claudiano, ancora utile Fargues 1933, 258–260.
61 Sul tema dell’incessus, vd. anche Stanze 1, 46, 1–4: Con lei sen va Onestate umile e piana / che d’ogni chiuso cor volge la chiave; / con lei va Gentilezza in vista umana, / e da lei impara il dolce andar soave.
L’epicedio per Albiera degli Albizi 15
At Phoebus comitesque novem vitisque repertor hac faciunt, et me qui tibi donat, Amor, et nulli cessura fides, sine crimine mores nudaque simplicitas purpureusque pudor.
Quanto poi all’Incessus decens, motivo chiaramente molto presente nella poe-sia stilnovistica volgare (basti ricordare Dante e Guinizzelli in primis) mi pare trovare un modello classico ancora una volta sui precetti amorosi dell’Ars amatoria, dove nel III libro, rivolto alle donne, si ricorda che (v. 299) Est et in incessu pars non temnenda decoris.
Ma torniamo ad Amores e Gratia, la cui presenza non ho mai riscontrato in epicedi classici:62 la loro evocazione invece denuncia, a mio parere, un mo-dello staziano e precisamente il famoso epitalamio in Stellam et Violentillam, Silvae 1, 2, molto apprezzato dal Poliziano come siamo in grado di stabilire dal successivo commento a questa selva staziana,63 che già il Carducci consi-derava fonte d’ispirazione per le Stanze per la Giostra.64 I vv. 19–23 dell’epita-lamio di Stazio sono un passo che è opportuno considerare anche in funzione di un particolare della descrizione di Albiera ai vv. 29–30, che avevo prima tralasciato e che mi ero riservata di esaminare in séguito, consapevole delle ulteriori suggestioni di questa più complessa interpretazione, anche in rela-zione alla struttura:
[…] nec blandus Amor nec Gratia cessat amplexum niveos optatae coniugis artus floribus innumeris et olenti spargere nimbo. tu modo fronte rosas, violis modo lilia mixta excipis et dominae niveis a vultibus obstas.
La menzione di Gratia in Stazio per evocare le tre Grazie65 trova un’ampia e dotta spiegazione nel Commento del Poliziano al passo, come osserva la sua editrice, Lucia Cesarini Martinelli,66 dove sarebbe da intendere come sino-
62 Tranne ovviamente dove intercorra un motivo erotico fra il poeta e chi è oggetto di con-
solazione, come nel carme 3 di Catullo per il passer di Lesbia. 63 Basti citarne la parte più significativa, 192, 12–20 Cesarini Martinelli: omnes in hac Sylva
nervos suos poeta intendit. Nam et res ipsa inducta divinarum personarum granditate attollitur et, cum ex admiratione voluptatem incussit, multa narrationis varietate distinguitur, ut aurium fastidio rerum diversitate subveniatur. Ipse praeterea filus orationis ita contexitur, ut multa fi-gurarum varietate exornetur floribusque verborum quodammodo pictaretur. Carmen vero fusum est ac securum quodque ita laetitia luxurietur, ut dignitatem tamen suam retineat.
64 Vd. Carducci 51863, 306–307. 65 Le tre Grazie spargono profumi anche alle nozze di Amore e Psiche: vd. Apuleio met. 6,
24 (sull’importanza del testo apuleiano per Poliziano, vd. infra). Naturalmente in poesia esametrica il singolare Gratia è anche scelta obbligata dal metro, come appare confermato dal motivo epitalamico presente in Ov. met. 8, 428–430: non pronuba Iuno, / non Hymenaeus adest, non illi Gratia lecto: / Eumenides tenuere faces de funere raptas.
66 Vd. l’ampia discussione di Cesarini Martinelli 1978, 134–138.
16 Rita Degl’Innocenti Pierini
nimo di Suadela o Peithò, la Persuasione, e come mi sembra confermato dall’ag-gettivo blandus epiteto di Amor in Stazio,67 come blanda è la Gratia in Poliziano, Albiera v. 38: il Poliziano nel suo corso trae spunto dal passo di Stazio per of-frire una dottissima disquisizione, che fornisce anche rare e preziose varianti del mito, che non ci interessa certo ripercorrere in questa sede. Quello che mi sembra significativo ricordare ai miei fini è che per suffragare la sua tesi il Poliziano sottolinea che Peithò veniva invocata nei rituali di nozze, insieme a dèi più importanti, e cita un passo di Pausania 9, 35, dove si afferma che Er-mesianatte la definiva appunto una delle tre Grazie. A noi basti aggiungere che il tema della persuasione nei confronti della fanciulla ritrosa, che non co-nosce l’amore, appare certo topico nelle complesse e scenografiche alchimie espressive degli epitalami tardi.68
Lo stesso contesto epitalamico staziano prima citato presenta una sugge-stiva immagine di Stella, e della sua sposa, sommersi di fiori che intrecciano colori e fragranze, come è topico dell’epitalamio classico da Saffo in poi:69 i vv. 22–23 tu modo fronte rosas, violis modo lilia mixta / excipis et dominae niveis a vul-tibus obstas erano stati utilizzati dal Poliziano poco prima nel descrivere Al-biera (v. 30), così come il topico contrasto cromatico rossore / pallore ai vv. 29–30 (Candor erat dulci suffusus sanguine, qualem / alba ferunt rubris lilia mixta rosis) è valorizzato dal Poliziano con l’insistenza sul bianco presente nei due incipit successivi (candor / alba) in modo da far ipotizzare, a mio parere, anche un lusus etimologico col nome della fanciulla, suggestione che può essere ul-teriormente motivata dalla presenza delle viole nel passo parallelo dell’epita-lamio di Stazio, fiore evocato per evidente gioco etimologico con il nome della sposa staziana, Violentilla.70 Il numero degli autori suggeriti per il dotto mo-saico di reminiscenze, che caratterizzano il topos del contrasto pallore / ros-sore in Poliziano, è decisamente ampio, e ne fa fede il ricco commento di Bausi: dalla Lavinia di Eneide 12, 67–6971 agli Amores di Ovidio, per non parlare
67 Il Poliziano si sofferma a lungo su blandus commentando Stat. silv. 1, 2: vd. 200, 10–201,
9 Cesarini Martinelli. In particolare da segnalare 201, 3: Blandus Amor, qui ex Venere scili-cet natus est.
68 Vd. per esempio Draconzio (autore peraltro non noto a Poliziano) Rom. 6, 60–65 Ibat in obsequium Risus, Amplexibus haerens; / iusta Libido coit, venit et moderata Voluptas, / candida legitimas acce<n>dens Gratia taedas / occurrit, venit alma Fides, Petulantia simplex, / casta Pu-dicitia procedit mente quieta, / Sobrietas per cuncta vigil devota cucurrit / et quicquid iustos solite comitatur Amores, da leggere col commento di Luceri 2007 ad loc.
69 Vd. Wheeler 1930, 212–214. 70 Si potrà ricordare anche l’allusivo e grecizzante Ianthis di Mart. 6, 21, 1–2: Perpetuam
Stella dum iungit Ianthida vati / laeta Venus, dixit. Inoltre Stella avrebbe definito Asteris la sua donna, giocando sul cognomen Stella: Stat. silv. 1, 2, 195–199 (sempre utili le note di commento di Pederzani 1995).
71 É dedicato a questa immagine virgiliana lo studio di Lyne 1983.
L’epicedio per Albiera degli Albizi 17
di testi tardo-antichi e umanistici; in ogni caso ci interessa segnalare che ap-pare sovente connotato come elemento topico dell’epitalamio e poi della poe-sia stilnovistica.72
Ma veniamo allo snodo strutturale dove, a mio parere, si evince in modo più chiaro che il Poliziano possa aver voluto deliberatamente contaminare il tradizionale lamento dell’epicedio con motivi epitalamici, e cioè a partire da quello che ho prima definito il proemio al mezzo dei vv. 57–58. Consideriamo il distico in cui si ripresenta la persona del poeta che si definisce attonitus lui stesso, compartecipando emotivamente al lutto cantato, e chiede alla Musa di rinnovare la propria ispirazione, vv. 57–58:
Tu mihi nunc tanti fuerit quae causa doloris, Attonito vati, moesta Thalia, refer.
Il Poliziano innesta qui un modulo chiaramente eziologico (quae causa), che non appare motivo topico degli epicedi, ma che invece ben si adatta agli epi-talami, come testimonia in particolare ancora quello staziano per Stella e Vio-lentilla, dove leggiamo, vv. 46–50:
Sed quae causa toros inopinaque gaudia vatis attulit, hic mecum, dum fervent agmine postes atriaque et multa pulsantur limina virga, hic, Erato iucunda, doce.
La dichiarazione staziana implica un aggancio narrativo al motivo eziologico dell’incontro d’amore, che verrà ampiamente sviluppato nei vv. 51–200 dell’epitalamio, dove Venere e Amore costruiscono le premesse celesti e l’an-tefatto ‘mitico’ della vicenda amorosa dei due futuri coniugi. Stazio si ispira chiaramente a Virgilio e alle sue due famose invocazioni alle Muse nell’Eneide (Aen. 1, 8 Musa, mihi causas memora, 7, 37–41 Nunc age [...] Erato [...] primae re-vocabo exordia pugnae) e significativa si rivela soprattutto quella ‘al mezzo’ nel settimo libro, dove Erato riacquista il suo ruolo di Musa congeniale all’amore, così come sottolineato da iucunda, un epiteto adatto ad alludere alle gioie amo-rose. Il Poliziano invoca invece Thalia, la Musa della commedia e della poesia leggera, che Stazio due volte nelle Silvae definisce lasciva (silv. 2, 1, 116; 5, 3, 98), ma qui essa è maesta come si conviene all’epicedio con una sorta di giun-tura dottamente ossimorica, attestata però in poeti umanisti:73 d’altra parte essa indica anche la Musa in generale, come in molti autori latini,74 e come
72 Dal punto di vista formale vorrei aggiungere che forse il più vicino a Poliziano appare
un pentametro anonimo citato in Mar. Victor. G. L. 6,105 K. lactea sanguineis lilia mixta rosis giacché, a parte il diffusissimo emistichio lilia mixta rosis, qui occorre l’aggettivo sanguineus, che evoca il sanguen di Albiera (immagine che sembra derivare anche dall’epicedio staziano di Glaucias v. 41 o ubi purpureo suffusus sanguine candor).
73 Per i passi paralleli rimando al commento di Bausi 2003, ad loc. 74 Musa della poesia in generale (Hor. carm. 4, 6, 25–26 Doctor argutae fidicen Thaliae, /
Phoebe; Ov. fast. 5, 53–54 dicta probarunt / Clioque et curvae scita Thalia lyrae) e dei generi
18 Rita Degl’Innocenti Pierini
indica lo stesso Poliziano, che nelle Stanze 1, 45, 1 afferma di Simonetta: Sembra Talia se in man prende la cetra.
Dunque il proemio al mezzo permette al poeta di stemperare il pathos della lamentatio topica dell’epicedio introducendo una pausa narrativa, un’ampia digressione, che si sofferma a descrivere la festa di S. Giovanni, il pellitus Jo-hannes come lo chiama Poliziano, evocando le corse di cavalli, i festeggiamenti per Eleonora d’Aragona, le danze con la partecipazione della bella Albiera per poi culminare nello scatenarsi in cielo dell’ira invidiosa e vendicativa di Rhamnusia, che nottetempo le avventa contro Febris. Tutto ciò che concerne l’attualità fiorentina subisce un travestimento mitologico, che suggerisce un’atmosfera raffinatamente alessandrina, con ampie e solenni perifrasi spa-zio-temporali ad indicare precise circostanze e luoghi, ma pure soffuse da un’aura irreale e favolistica, segnata già dall’avvio nel verso 59, che implica ancora, a mio parere, un sottile riferimento al più dotto e alessandrino dei carmi catulliani,75 il carme 64, l’Epithalamium Thetidos et Pelei. Non credo che sia senza significato, perché, come abbiamo già affermato, era anche in quel modello che Poliziano poteva aver trovato il raffinato antecedente della sua tessitura poetica, in cui s’intrecciano Amore e Morte, atmosfera rarefatta del mito e realtà del presente: Poliziano, Albiera v. 59 Annua pelliti referentem sa-cra Ioannis appare modellato su Catull. 64, 388 Annua cum festis venissent sacra diebus. Non privo di suggestione a questo proposito si rivela anche il v. 62, dove si ricorda che Eleonora d’Aragona si reca a condividere il talamo di Ercole d’Este (Herculeumque petens regia nata torum), sottolineando così il tema nuziale, sottinteso già nell’evocazione della topica epitalamica e corroborato dalla tessera catulliana virgo regia, che è ancora eco del carme 64, 86–87, dove così è definita Arianna in un contesto di chiara ascendenza epitalamica.
É dunque in questa luce nuova e gioiosa, che si possono inquadrare i fe-steggiamenti per S. Giovanni, patrono di Firenze, che divengono una lieta fe-sta di nozze, dove è coinvolta la città tutta in tutte le sue componenti, come appare dai vv. 65–68:
Pro se quisque igitur pueri iuvenesque senesque Matresque et tenerae, splendida turba, nurus illius adventum celebrant: atque unicus urbis Est vultus, festo murmure cuncta fremunt.
minori, della commedia per Stazio (silv. 2, 1, 116) e dell’elegia per Ovidio trist. 4, 10, 56 notaque non tarde facta Thalia mea est; 5, 9, 31–32.
75 Bausi 2003 ad loc. segnala opportunamente testi ovidiani: interessante per refer soprat-tutto Verg. georg. 1, 338–339 atque annua magnae / Sacra refer Cereri.
L’epicedio per Albiera degli Albizi 19
Si intrecciano qui una serie notevole di modelli in modo da creare un quadro festoso:76 il v. 65 si modella su un contesto panegiristico di Marziale (9, 7, 9 Dilexere prius pueri iuvenesque senesque), mentre il motivo della festa innesta su un passo ovidiano un’inaspettata suggestione77 da una tragedia senecana, l’Agamemnon. Nel passo ovidiano evocato (met. 3, 528–530) si descrive il fe-stante arrivo di Bacco a Tebe, tema caro all’ambiente mediceo; sono presenti termini come turba, matresque nurusque, ma soprattutto spicca fremunt,78 in col-legamento al rituale festis ululatibus, variato da Poliziano in murmure, sulla scorta di un famoso passo del I libro dell’Eneide, dove però si parla del magnus murmur dei venti:
Liber adest, festisque fremunt ululatibus agri: turba ruit, mixtaeque viris matresque nurusque vulgusque proceresque ignota ad sacra feruntur.
La singolare immagine polizianea dell’unicus vultus della città festante è qui incastonata da un famoso coro dell’Agamemnon senecano, quando si evoca la festa dei Troiani, dopo che hanno creduto all’inganno dei Greci e al loro dono fatale, vv. 643–646: Ducunt turmas, haec femineas, / ille viriles. / Festae matres votiva ferunt / munera divis, / festi patres adeunt aras; / unus tota est vultus in urbe. Altri ipotesti ovidiani si impongono alla nostra attenzione per confer-mare la ricercata tessitura di questi versi: mi limito in particolare a rilevare l’elegante intarsio testuale del v. 66 et tenerae, splendida turba, nurus, derivata da her. 8, 12 Graias, barbara turba, nurus con la raffinata presenza dell’apposi-zione parentetica, inserzione dell’apposizione fra aggettivo e sostantivo, se-condo una tecnica già alessandrina, ma ben documentata nelle Egloghe di Vir-gilio (si ricordi almeno 1, 57 raucae, tua cura, palumbes) e che leggiamo anche nell’elegia del Poliziano in morte di Ovidio.79
76 I passi paralleli riportati nel commento da Bausi colgono invece l’elemento del com-
pianto, come Cons. ad Liviam 203–204 Omnis adest aetas, maerent iuvenesque senesque, / Au-soniae matres Ausoniaeque nurus, cui va aggiunto il concetto del cordoglio unanime nei versi precedenti Omnibus idem oculi, par est concordia flendi: / funeris exequiis adsumus omnis eques.
77 Il confronto manca in Serafini 2008, un contributo peraltro molto limitato su Seneca tra-gico in Poliziano.
78 Verg. Aen. 1, 55–56 Illi indignantes magno cum murmure montis / circum claustra fremunt, appare valido confronto soprattutto sul piano della resa formale; vd. anche Ov. trist. 1, 2, 25 Inter utrumque fremunt immani murmure venti. Cuncta fremunt si legge in Lucan. 10, 321–322 cuncta fremunt undis, ac multo murmure montis / spumeus invitis canescit fluctibus amnis.
79 Vd. Degl’Innocenti Pierini 1990, 225. Sull’importanza dell’elegia in morte di Ovidio an-che nell’ambito degli studi ovidiani del Poliziano professore, vd. Bausi 2014, 91–100, che argomenta persuasivamente sull’autunno del 1481 come data di composizione dell’ele-gia, avvicinandone cronologicamente quindi la composizione all’epitafio per Albiera.
20 Rita Degl’Innocenti Pierini
É chiaramente impossibile dare conto di tutte le suggestioni esegetiche, che questa parte relativa alla festa implica: certo è che appare frutto di un’ela-borazione particolarmente raffinata e suggerisce accostamenti di sapore ales-sandrino. Basterà limitarci ad aggiungere qualche considerazione sulla to-pothesia dei vv. 69–70, quando il Poliziano introduce la descrizione del luogo, dove ha sede la festa: si tratta di Borgo Ognissanti, strada famosa per la Chiesa omonima e molto vicina alle rive dell’Arno, dove si trova il Palazzo Lenzi, dalle cui finestre Eleonora d’Aragona avrebbe assistito alle corse dei cavalli, il palio dei barberi, sul prospiciente Prato d’Ognissanti e alle danze di fanciulle alle quali partecipò anche Albiera.80 Poliziano si riferisce a questi luoghi con raffinati toponimi di suo conio, calchi classici come il grecizzante Panthagia per rendere Ognissanti, mentre i Fiorentini sono definiti Syllani,81 Tyrrheni i Toscani, e il Palazzo Lenzi Domus Lentia.
Particolarmente sottile e suggestivo il modello latino sotteso ai vv. 69–70:
Est via (Panthagiam Syllani nomine dicunt): Omnibus hic superis templa dicata82 micant
Infatti Borgo Ognissanti si trasfigura in un locus amoenus classico, anzi direi che si trasforma nel più sublime dei luoghi, in quanto definendolo Panthagia, col travestimento greco del nome, Poliziano sembra voler evocare il cielo degli dèi pagani ed in particolare la Via Lactea, secondo un modulo descrittivo de-rivato, a mio parere, ancora una volta da Ovidio, che in met. 1, 168 Est v ia sublimis caelo manifesta sereno apre così la descrizione romanizzata di una via, che si inerpica nel cielo e presso la quale si trovano le case degli dèi maggiori e minori. Poliziano sembra voler deliberatamente alludere al testo ovidiano,83 operando però un rovesciamento allusivo, giacché Ovidio ‘abbassava’ la sede degli dei assimilandola al romano Palatino (met. 1, 173–174 hac parte potentes / caelicolae clarique suos posuere penates), mentre Poliziano sublima e mitizza la chiesa dedicata a tutti i santi ed anche la domus Lentia, che iperbolicamente ‘squarcia le nubi ed innalza il suo tetto fino al rutilante cielo’ come ben traduce Bausi i vv. 71–72 (Hic domus aethereas perrumpens Lentia nubes, / provehit ad ru-tilos culmina celsa polos).
Il travestimento mitico di una scena reale e attuale, che assolve anche ad un evidente intento panegiristico nei confronti della città di Firenze, dei suoi
80 Sui luoghi rimando al commento ad loc. di Bausi 2003. Sulle danze nelle celebrazioni di
S. Giovanni, vd. Dempsey 1999, 8. 81 Leonardo Bruni nella sua Storia di Firenze inizia il suo racconto storico proprio soste-
nendo che Firenze era stata fondata da Silla: Florentiam urbem Romani condidere a L. Sylla Fesulas deducti, fuerunt hi Syllani milites.
82 Vd. Ov. fast. 1, 706 Hac sunt Ledaeis templa dicata deis. 83 Sull’importanza delle Metamorfosi nell’immaginario ecfrastico del Poliziano volgare, vd.
Delcorno Branca 2006, con la bibliografia ivi citata.
L’epicedio per Albiera degli Albizi 21
Signori, e dell’illustre ospite promessa sposa, serve anche come solenne pre-messa narrativa ad un’ulteriore descrizione di Albiera (vv. 77–84), evocata mentre è intenta a danzare, lei pulcherrima nympha tra le nurus che intrecciano armoniosi passi di danza in onore dell’ospite regale:
Regia nata leves gaudet celebrare choreas, Iamque nurus certa brachia lege movent. Emicat ante alias vultu pulcherrima nymphas Albiera, et tremulum spargit ab ore iubar. Aura quatit fusos in candida terga capillos, Irradiant dulci lumina nigra face; Tamque suas vincit comites, quam Lucifer ore Purpureo rutilans astra minora premit.
Emerge nel primo distico il ricordo anche di un verso, corrotto in parte per noi, ma ugualmente significativo nella clausola, ancora dal catulliano carme 64, v. 287 linquens †doris ce lebranda chore is , dove Catullo descrive, nell’am-bito del paesaggio ameno di Tempe, danze di fanciulle tessale per le nozze di Peleo e Teti: un testo quindi il carme 64 che sembra insinuarsi nella memoria poetica polizianea in punti chiave dell’epicedio di Albiera, a suggellare, io credo, l’idea, che andiamo tentando di suggerire e sviluppare della compre-senza del tema di Amore e Morte, inteso come intersezione retorica tra generi opposti, epicedio ed epitalamio, ma ugualmente d’occasione e celebrativi. Ai vv. 79–84 proprio l’immagine di Albiera, descritta quale la più bella delle fan-ciulle, celebrata come colei che spicca e brilla (emicat) nel gruppo superando le altre, rimanda a motivo topico negli encomi delle spose che si leggono negli epitalami,84 a partire probabilmente da Saffo 34 V., ma soprattutto da Teocrito nell’epitalamio per Elena, dove appunto la celebrata è descritta come la più bella;85 in particolare il paragone con Lucifero, la stella del mattino, ai vv. 83–84 ne è la spia più significativa. La comparazione è molto diffusa e fa parte sia della retorica panegiristica sia della retorica del corteggiamento;86 ne sottoli-nea l’importanza la collocazione incipitaria di emicat al v. 79, nonché l’esplicito paragone con Lucifer, astro che, con la sua luce rossastra, ha il potere di offu-scare tutte le stelle sue compagne. La consapevole raffinatezza della riesuma-zione polizianea traspare anche dal dotto incastro oraziano di ambito enco-miastico da carm. 1, 12, 46–48 micat inter omnis / Iulium sidus, velut inter ignis
84 Vd. Lyghounis 1991, 187; 190. 85 Vd. Theocr. 18, 26–28: «l’Aurora sorgendo manifesta il suo bel volto, o veneranda Notte,
così come la splendente primavera al cessare dell’inverno: così l’aurea Elena splendeva tra noi». Il motivo ritorna anche nell’epitalamio staziano di Stella e Violentilla: vd. silv. 1, 2, 113–116 Celsae procul aspice frontis honores / suggestumque comae. Latias metire quid ultra / emineat matres: quantum Latonia Nymphas / virgo premit quantumque egomet Nereidas exsto.
86 Il motivo è esemplificato con ricco corredo di passi in Rosati 2003.
22 Rita Degl’Innocenti Pierini
/ luna minores. Ma, come di consueto, un modello non soddisfa tutte le molte-plici sfumature del testo di Poliziano, dato che emicat implica sì il bagliore delle stelle, ma anche la giovanile baldanza, che viene esaltata attraverso la collocazione incipitaria nelle figure giovanili, ora per sottolineare l’eroismo di Eurialo e Niso (Aen. 5, 319–320 Nisus / emicat et ventis et fulminis ocior alis; 337 emicat Euryalus et munere victor amici), ora il vigore di Atalanta nella gara di corsa del decimo delle Metamorfosi.87 Se è vero che tremulum iubar occorre già in Lucrezio (5, 697), forse la collocazione di iubar in ultima sede staccato dall’epiteto fa pensare che Poliziano si ispiri anche qui all’Ovidio dei Fasti 1, 78, dove l’immagine è impiegata in un contesto di festa, anche se non riferita al volto femminile (et tremulum summa spargit in aede iubar).88 Del resto lo spet-tacolo della festa si snoda di fronte ad un pubblico estasiato, dove attoniti sono gli spettatori come gli astanti di fronte alla virginea apparizione della Camilla virgiliana nel catalogo del settimo dell’Eneide:89 quindi con scelta sapiente-mente mirata il poeta addensa su Albiera elementi che tutti richiamano figure giovanili dei suoi amati classici, destinate a mors immatura come la sua sfortu-nata eroina.
Se coglie nel segno la nostra interpretazione che vede nel carme un consa-pevole mosaico di generi, in particolare epitalamio ed epicedio, allora anche la macchina mitologica, come la definì Carducci, attraverso la quale Rhamnu-sia, invidiosa di Albiera e del suo destino, volge il suo sguardo torvo dal cielo per colpirla a morte attraverso l’invio di Febris, non troverebbe la sua ispira-zione solo in tre noti episodi delle Metamorfosi, quello di Invidia (met. 2, 752–832), di Tisifone (met. 4, 432–480) e della Fame (met. 8, 788–813), ben indivi-duati già da Perosa nel suo magistrale e pioneristico studio su Febris, ma, con la tecnica dell’oppositio in imitando, anche nell’epitalamio di Stella e Violentilla, come segnalato, a mio parere, già dal ribaltamento tematico del proemio al mezzo nei vv. 57–58. Infatti in Stazio l’aition delle nozze felici (vv. 46–47) ha il suo svolgimento in cielo, dove Venere viene sollecitata da uno dei suoi Amo-rini a spingere Violentilla alle nozze, con lo sguardo divino che dal cielo si rivolge verso la donna, descritta poi anche da Venere come la più bella fra tutte. Venere si reca col carro aggiogato di cigni dalla donna per spingerla a cedere all’amore di Stella (1, 2, 161–193); specularmente opposta invece la Rhamnusia di Poliziano, che si reca da Febris per convincerla a colpire il corpo di Albiera e portarla alla morte (vv. 131–136). Importante mi pare segnalare
87 Vd. met. 10, 652–653 signa tubae dederant, cum carcere pronus uterque / emi ca t et summam
celeri pede libat harenam. 88 Sembrerebbe confermarlo la lunga trattazione del termine iubar nel relativo commento
del Poliziano ai Fasti. 89 Aen. 7, 812–817 illam omnis tectis agrisque effusa iuventus / turbaque miratur matrum et pro-
spectat euntem, / a t ton i t i s inh i a ns an imi s ut regius ostro / velet honos leuis umeros, ut fibula crinem / auro internectat, Lyciam ut gerat ipsa pharetram / et pastoralem praefixa cuspide myrtum.
L’epicedio per Albiera degli Albizi 23
che sia Venere nell’epitalamio di Stazio che Febris in Poliziano si rivolgono alle donne oggetto del loro interesse e che ad entrambe i poeti fanno proferire parole alla loro presenza, mentre invece nelle Metamorfosi di Ovidio Invidia, Tisifone e Fame semplicemente si insinuano silenziosamente nei corpi delle loro vittime: la differenza non era sfuggita ad Alessandro Perosa,90 che ne at-tribuiva la presenza solo alla sensibilità personale del Poliziano, a quello che Perosa definisce «the elegiac pathos which animates, though with a slightly theatrical overtone, the most sincerely felt verses in the Elegy».
Per il percorso di lettura da noi svolto credo che si possa ragionevolmente attribuire questo particolare narrativo all’influsso dell’epitalamio staziano, così apprezzato anche da Poliziano commentatore delle Silvae: così come un modello, meno letteralmente presente, ma alluso in singoli passi e struttural-mente significativo è, come abbiamo osservato, il carme 64 di Catullo, che as-somma in sé temi nuziali e presagi di morte attraverso il canto epitalamico delle Parche. In questo senso è interessante ricordare come molto recente-mente Donatella Coppini abbia persuasivamente indicato un ulteriore mo-dello per l’Albiera di Poliziano nella fabula di Amore e Psiche di Apuleio, pro-sastico, ma dalle sottili implicazioni allegoriche e filosofiche, e soprattutto molto importante per alcuni snodi della struttura dell’epicedio: non si può che consentire con lei, soprattutto sottolineando un ulteriore elemento, significa-tivamente coerente col punto di vista della mia lettura, e cioè che anche nel racconto apuleiano si presenta quel coesistere di amore/matrimonio e morte, che abbiamo evidenziato nel nostro testo e che anche in Apuleio deriva pro-prio, come è stato ampiamente dimostrato, dall’influsso della topica della poe-sia nuziale ed elegiaca.91
Non è possibile certo sondare e, forse, indicare altre intersezioni di topoi letterari e generi nell’epicedio; mi vorrei limitare in conclusione a sottolineare molto sinteticamente alcune presenze di motivi riconducibili ad altre opere di Ovidio, che si conferma autore imprescindibile nell’immaginario poetico del Poliziano.92 Importante mi pare per esempio evidenziare l’interesse per l’an-tiquaria romana, che si presenta, non casualmente, in modo molto particola-reggiato e documentato nella descrizione del culto di Febris ai vv. 123–124, cui l’incipit stesso di sapore arcaizzante, olli, contribuisce a dare una patina d’an-tichità:
Oll i templa olim posuit romana propago, Abstinuit saevas nec tamen inde manus
Inoltre degno di rilievo è il motivo epigrafico, cioè l’inserimento in conclu-sione del carme dei versi di un epitafio da porre sul tumulo della fanciulla,
90 Perosa 1946, 84. 91 Vd. soprattutto Mattiacci 1998, 127–149. 92 Recenti sondaggi sulla presenza di Ovidio in Poliziano si devono a Martelli 2006.
24 Rita Degl’Innocenti Pierini
che potrebbe anche contribuire a spiegare, a mio parere, il motivo per cui Po-liziano sceglie il distico elegiaco per il suo epicedio, pur traendo gran parte della sua ispirazione dall’esametrico Stazio. Ci basti citare i conclusivi vv. 281–286:
Et tandem gelidos operosi marmoris artus Includit tumulus, et breve carmen habet: «Hoc iacet Albierae pulchrum sub marmore corpus; Nulla quidem tantum marmora laudis habent. Exornat tumulum corpus, sed spiritus astra: O quanta accessit gloria lausque polo!»
Poliziano si fa erede di una ben consolidata tradizione elegiaca, risalente a Tibullo e Properzio,93 ma che viene sviluppata soprattutto da Ovidio nelle He-roides, dove talvolta le eroine in conclusione delle loro lettere, quale autoco-sciente presagio del loro tragico destino di morte, si dettano il loro epitafio da apporre sul sepolcro; basterà ricordare la Didone della settima epistola, vv. 193–196:
nec consumpta rogis inscribar Elissa Sychaei, hoc tantum in tumuli marmore carmen erit: «Praebuit Aeneas et causam mortis et ensem. ipsa sua Dido concidit usa manu.»
Si conferma dunque l’interesse già molto giovanile del Poliziano per opere e temi, che saranno anche oggetto di studio dello studioso più maturo, quando dedicò un corso all’epistola ovidiana di Saffo a Faone sul finire dell’anno ac-cademico 1481/1482, e ai Fasti nell’anno 1481/1482. Non irrilevante in questo senso notare che lo stesso espediente dell’epitafio è presente nell’elegia De Ovidii exilio et morte, vv. 31–36, dove sono gli Amorini, che attivano il rogo per il loro poeta d’amore e poi gli dettano l’epigrafe, a testimonianza dell’esigenza di variare e ampliare la topica tradizionale dell’epicedio:
Accurrere leves paphia cum matre volucres, arsuroque faces supposuere rogo: quem simul absumpsit rapidae violentia flammae, relliquias tecto composuere cado; impositum brevi signarunt carmine saxum: «Qui iacet hic teneri doctor amoris erat»
Cosa dire per porre termine ad una troppo lunga trattazione, se non che il Poliziano non finisce mai di stupirci con la sua enorme doctrina, oserei direi mostruosa per un adulescens quale in fondo egli era ancora: concludo così
93 Vd. per es. Prop. 4, 7, 83–86 hic carmen media dignum me scribe columna, / sed breve, quod
currens vector ab urbe legat: / «hic Tiburtina iacet aurea Cynthia terra: / accessit ripae laus, Aniene, tuae» (non in conclusione dell’elegia). Sul tema utili i lavori di Fedeli 1989; Ram-sby 2005.
L’epicedio per Albiera degli Albizi 25
senza una vera conclusione questo vagabondaggio tra i meandri del labirinto di agnizioni in cui ci si inoltra lasciandoci guidare dal fascino raffinato del poetico ludere polizianeo.
Bibliografia
Asso, Paolo: Il genere consolatorio da Stazio alle letterature europee, Vichiana 10, 2008, 176–196.
Bausi, Francesco: L’Epicedion in Albieram di Angelo Poliziano (testo e versione semi-poetica), Yale Italian Poetry 8, 2004–2005, 215–247.
Bausi, Francesco: Due schede su Poliziano professore, in: Lucia Bertolini / Donatella Coppini / Clementina Marsico (curr.): Nel cantiere degli Umanisti per Mariangela Regoliosi, Firenze 2014, 91–111.
Bec, Christian: Les livres des Florentins (1413–1608), Firenze 1984. Caroti, Stefano / Zamponi, Stefano: Lo scrittoio di Bartolomeo Fonzio, Milano 1974. Cesarini Martinelli, Lucia: In margine al commento di Angelo Poliziano alle Selve di
Stazio, Interpres 1, 1978, 96–145. Coppini, Donatella: Amore e Psiche: presenze umanistiche, in: Magali Bélime-Droguet
et alii (curr.): Psyché à la Renaissance, Turnhout 2012, 41–59. Coppini, Donatella: Perosa e la poesia umanistica, Archivum mentis 2, 2013, 9–19. Croce, Benedetto: La poesia latina del Rinascimento, La critica 30, 1932, 241–260. Dal Zotto, Attilio: La consolazione a Livia, Epistola pseudoovidiana. Congetture e cor-
rezioni, Feltre 1904. Degl’Innocenti Pierini, Rita: Il Poliziano e Ovidio esule. Per l’esegesi dell’elegia De Ovi-
dii exilio et morte, Res Publica Litterarum 13, 1990, 215–227 (= Degl’Innocenti Pie-rini 1990 a).
Degl’Innocenti Pierini, Rita: Tra Ovidio e Seneca, Bologna 1990 (= Degl’Innocenti Pie-rini 1990 b).
Delcorno Branca, Daniela: Le Metamorfosi nel Poliziano volgare. I bassorilievi del Pa-lazzo di Venere (Stanze I 95–119), in: Gian Mario Anselmi / Marta Guerra (curr.): Le Metamorfosi di Ovidio nella letteratura tra Medioevo e Rinascimento, Bologna 2006, 109–123.
Dempsey, Charles: Portraits and Masks in the Art of Lorenzo De’ Medici, Botticelli, and Politian’s ‘Stanze per la Giostra’, Renaissance Quarterly 52, 1999, 1–42.
Falletti, Clelia: Le feste per Eleonora d’Aragona da Napoli a Ferrara (1473), in: Spetta-coli conviviali dall’antichità classica alle corti del ‘400, Atti del VII convegno del Centro Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale, Viterbo 1983, 269–289 (poi anche in: Raimondo Guarino (cur.): Teatro e culture della rappresentazione. Lo spettacolo in Italia nel Quattrocento, Bologna 1988, 121–140).
Fargues, Pierre: Claudien. Études sur sa poésie et son temps, Paris 1933. Fedeli, Paolo: Il poeta lapicida, in: Marcel Piérart / Olivier Curty (curr.): Historia Testis.
Mélanges d’épigraphie, d’histoire ancienne et de philologie offerts à Tadeusz Za-wadzki, Fribourg 1989, 76–96.
Fernandelli, Marco: Catullo e la rinascita dell’epos. Dal carme 64 all’Eneide, Hildes-heim / Zürich / New York 2012 (Spudasmata, B. 142) (= Fernandelli 2012 a).
26 Rita Degl’Innocenti Pierini
Fernandelli, Marco: Cultura e significati della praefatio all’Epitalamio per le nozze di Onorio e Maria di Claudiano, Il calamo della memoria 5, 2012, 75–125 (= Fernan-delli 2012 b).
Gaisser, Julia Haig: Catullus and his Renaissance Readers, Oxford 1993. Guérard, Juliette: Le thème du cortège divin dans la littérature latine de l’Antiquité
tardive: lectures profanes et adaptation chrétienne, Camenulae 7, 2011, 1–16. Horstmann, Sabine: Das Epithalamium in der lateinischen Literatur der Spätantike,
München / Leipzig 2004. Labate, Mario: L’arte di farsi amare: modelli culturali e progetto didascalico nell’elegia
ovidiana, Pisa 1984. La Penna, Antonio: Modelli efebici nella poesia di Stazio, in: Fernand Delarue / Sophia
Gergacopoulou / Pierre Laurens / Anne-Marie Taisne (curr.): Epicedion. Hom-mage à P. Papinius Statius, Poitiers 1996, 161–184 (poi anche in: Eros dai cento volti. Modelli etici ed estetici nell’età dei Flavi, Venezia 2000, 135–168).
Luceri, Angelo: Gli epitalami di Blossio Emilio Draconzio (Rom. 6 e 7), Roma 2007 (Bi-blioteca di Cultura Romanobarbarica 10).
Luchs, Alison: Verrocchio and the Bust of Albiera degli Albizzi: Portraits, Poetry and Commemoration, Artibus et Historiae 66, 2012, 75–98.
Lyghounis, Maria Gilda: Elementi tradizionali nella poesia nuziale greca, MD 27, 1991, 159–198.
Lyne, Oliver: Lavinia’s Blush: Vergil, Aeneid 12.64–70, Greece & Rome 30, 1983, 55–66. Martelli, Mario: La semantica di Poliziano e la «Centuria secunda» dei «Miscellanea»,
Rinascimento, s. 2, 13, 1973, 1–84; poi anche in: Angelo Poliziano. Storia e metasto-ria, Lecce 1995, 267–328.
Martelli, Mario: Tra Poliziano ed Ovidio, in: François Livi / Carlo Ossola (curr.): De Florence à Venise. Etudes en l’honneur de Christian Bec, Paris 2006, 213–228.
Mattiacci, Silvia: Neoteric and elegiac echoes in the tale of Cupid and Psyche by Apu-leius, in: Maaike Zimmerman et alii (curr.): Aspects of Apuleius’ Golden Ass, II, Groningen 1998, 127–149.
Mattiacci, Silvia: Quando l’immagine ha bisogno della parola: riflessioni sulla poetica dell’ekphrasis nell’epigramma latino, Prometheus 39, 2013, 207–226.
Menander Rhetor: Edited with translation and commentary by Donald Andrew Russell and Nigel Guy Wilson, Oxford 1981.
Murgia, Charles E.: Imitation and Authenticity in Ovid: Metamorphoses 1.477 and Heroides 15, The American Journal of Philology 106, 1985, 456–474.
Ovidius: Ovid, Ars Amatoria Book 3, edited by Roy K. Gibson, Cambridge 2003 (= Gib-son 2003).
Patetta, Federico: Una raccolta manoscritta di versi e prose in morte di Albiera degli Albizzi, Atti della Regia Accademia della Scienza di Torino 53, 1917–1918, 290–294; 310–328.
Pavlovskis, Zoja: Statius and the Late Latin Epithalamia, Classical Philology 60, 1965, 164–177.
Pederzani, Ombretta: Il talamo, l’albero e lo specchio (saggio di commento a Stat. Silv. I 2, II 3, III 4), Bari 1995.
Perosa, Alessandro: Febris: A Poetic Myth Created by Poliziano, Journal of the War-burg and Courtauld Institutes, 9, 1946, 74–95; poi, in italiano, in: Studi di filologia umanistica 2: Angelo Poliziano, a cura di Paolo Viti, Roma 2000, 53–82.
L’epicedio per Albiera degli Albizi 27
Poliziano, Angelo: Le Stanze, l’Orfeo, le Rime di Messer Angiolo Ambrogini Poliziano, rivedute sui codici e su le antiche stampe e illustrate con annotazioni di varii e nuove da Giosuè Carducci, Firenze 51863 (= Carducci 51863).
Poliziano, Angelo: Prose volgari inedite e poesie latine e greche edite e inedite di An-gelo Ambrogini Poliziano, a cura di Isidoro Del Lungo, Firenze 1867 (rist. Hilde-sheim / New York 1976) (= Del Lungo 1867).
Poliziano, Angelo: Commento inedito alle Selve di Stazio, a cura di Lucia Cesarini Mar-tinelli, Firenze 1978.
Poliziano, Angelo: Commento inedito ai Fasti di Ovidio, a cura di Francesco Lo Mo-naco, Firenze 1991.
Poliziano, Angelo: Silvae, a cura di Francesco Bausi, Firenze 1996 (= Bausi 1996). Poliziano, Angelo: Poesie volgari, Commento a cura di Francesco Bausi, Manziana 1997
(= Bausi 1997). Poliziano, Angelo: Due poemetti latini. Elegia a Bartolomeo Fonzio, Epicedio di Albiera
degli Albizi, a cura di Francesco Bausi, Roma 2003 (= Bausi 2003). Poliziano, Angelo: Poesie, a cura di Francesco Bausi, Classici italiani, Torino 2006 (=
Bausi 2006). Ramsby, Teresa: Striving for Permanence: Ovid’s Funerary Inscriptions, The Classical
Journal 100, 2005, 365–391. Reeve, Michael D.: The tradition of Consolatio ad Liviam, Revue d’histoire des textes
6, 1976, 79–98. Rochon, André: La jeunesse de Laurent de Médicis (1449–78), Paris 1963. Rosati, Gianpiero: L’Achilleide di Stazio, un’epica dell’ambiguità, Maia 44, 1992, 233–
266. Rosati, Gianpiero: Dominus / domina: moduli dell’encomio cortigiano e del corteggia-
mento amoroso, in: Roberto Gazich (curr.): Fecunda licentia: Tradizione e innova-zione in Ovidio elegiaco, Atti delle giornate di studio (Brescia e Milano, 16–17 aprile 2002), Milano 2003, 49–69.
Rosati, Gianpiero: I capelli di Lorelei: riti della seduzione tra antico e moderno, in: Ser-gio Audano / Giovanni Cipriani (curr.): Aspetti della Fortuna dell’antico nella Cul-tura europea, XI Giornata del Centro di Studi sulla Fortuna dell’Antico “Emanuele Narducci” (Sestri Levante, 14 marzo 2014), Foggia 2015, 227-253.
Schoonhoven, Henk: The Pseudo-Ovidian ad Liviam de Morte Drusi, Groningen 1992. Serafini, Mario: Le tragedie di Seneca nell’arte del Poliziano, Firenze 2008. Ventrone, Paola: Simonetta Vespucci e le metamorfosi dell’immagine della donna nella
Firenze dei primi Medici, in: Giovanna Lazzi / Paola Ventrone (curr.): La nascita della Venere fiorentina, Firenze 2007, 7–49.
Ventrone, Paola: La festa di San Giovanni: costruzione di un’identità civica fra rituale e spettacolo (secc. XIV–XVI), Annali di Storia di Firenze, II, 2007, 49–76.
Wasdin, Katherine: Honorius Triumphant: Poetry and Politics in Claudian’s Wedding Poems, Classical Philology 109, 2014, 48–65.
Wheeler, Arthur Leslie: Tradition in the Epithalamium, The American Journal of Phi-lology 51, 1930, 205–223.