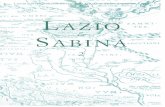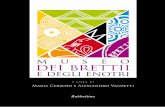Lo scavo in località Macchiagrande a Veio: un contesto di età tardo-arcaica e classica, in Scienze...
Transcript of Lo scavo in località Macchiagrande a Veio: un contesto di età tardo-arcaica e classica, in Scienze...
EDIZIONI QUASAR
SCIENZE DELL’ANTICHITÀ
20 – 2014
Fascicolo 1
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMADIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITÀ
estratto
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITÀ
DirettoreEnzo Lippolis
Comitato di DirezioneMarcello Barbanera, Maria Giovanna Biga, Savino Di Lernia, Giovanna Maria Forni,
Gian Luca Gregori, Laura Maria Michetti, Frances Pinnock, Marco Ramazzotti, Maurizio Sonnino, Eleonora Tagliaferro
Comitato scientificoRosa Maria Albanese (Catania), Graeme Barker (Cambridge),
Corinne Bonnet (Toulouse), Alain Bresson (Chicago), Jean‑Marie Durand (Paris), Alessandro Garcea (Lyon), Andrea Giardina (Firenze), Michel Gras (Roma),
Henner von Hesberg (Roma‑DAI), Tonio Hölscher (Heidelberg), Mario Liverani (Roma), Paolo Matthiae (Roma), Athanasios Rizakis (Atene), Guido Vannini
(Firenze), Alan Walmsley (Copenhagen)
RedazioneLaura Maria Michetti
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
estratto
La ripresa delle indagini in località Macchiagrande‑Vignacce a Veio ha avuto inizio nel 1996 con la creazione del cosiddetto Progetto Veio nato dalla collaborazione tra Sapienza Uni‑versità di Roma e Soprintendenza per l’Etruria Meridionale e finanziato dal capitolo “Gran‑di Scavi” del nostro Ateneo1. Il coordinamento dell’intero progetto, inizialmente affidato a G. Colonna, è attualmente guidato da G. Bartoloni mentre la direzione scientifica delle indagi‑ni nel sito, iniziata con A. Carandini e P. Carafa, è ora assegnata a chi scrive. Le diverse campa‑gne di scavo che si sono succedute in quest’area dal 1996 al 2004 e nuovamente dal 2011 ad oggi hanno permesso di identificare un settore importante dell’abitato che ha rivelato una continua occupazione a partire dal IX sec. a.C. – periodo a cui si datano le prime strutture lignee – fino alla tarda età imperiale, epoca che segna la destrutturazione del paesaggio urbano di Veio2.
In estrema sintesi possiamo confermare che a Macchiagrande ad una prima occupazione capannicola si associano dalla metà del VII sec. a.C. edifici in blocchi di tufo che, con alcune ripetute modifiche, definiscono l’abitato di età arcaica e classica. Ad est di questo settore si estende nello stesso periodo un’area con caratteristiche cultuali che affronteremo più in det‑taglio in questo contributo (Fig. 1)3. In età repubblicana si abbandona il quartiere arcaico che viene in parte sostituito da una grande domus romana con impianto irregolare, incentrata su un ambiente con vasca in lastre di tufo connessa ad un pozzo4. La domus viene modificata e ingrandita a più riprese a partire dalla prima età imperiale, quando a sud‑est di essa si realizza il Foro del Municipium augustum Veiens, individuato in uno stato di notevole spoliazione che ha consentito tuttavia di proporne una ricostruzione dell’impianto5. Sul lato breve occidentale del Foro si affaccia un’area sacra contenente almeno un sacello delimitato da un recinto in asse con la piazza al quale si affianca più tardi un impianto termale di forma irregolare di cui sono stati
1 Sulle prime indagini si rimanda a carafa 1998.2 Per il dettaglio dei rinvenimenti in quest’area
e per la successione dei paesaggi urbani individuati si rimanda a d’aleSSIo 2001, 2010, cds. È un grande piacere ringraziare anche in questa sede tutti i ragaz‑zi che a diverso titolo hanno partecipato alle attività di scavo, documentazione e studio di questa area di Veio.
3 Per un’anticipazione si rimanda a d’aleSSIo cds.4 Vd. il testo e la ricostruzione di M.C. capan-
na, in capanna - fatuccI cds. L’analisi analitica della struttura e dei suoi reperti è attualmente in corso di studio e contiamo di pubblicarne presto i risultati definitivi.
5 Si rimanda in questo caso al testo e alla rico‑struzione di G. fatuccI, in capanna - fatuccI cds.
MarIa tereSa d’aleSSIo – MarIa tereSa dI SarcIna
LO SCAVO IN LOCALITÀ MACCHIAGRANDE A VEIO: UN CONTESTO DI ETÀ TARDO‑ARCAICA E CLASSICA
estratto
106 M.T. D’Alessio – M.T. Di Sarcina Sc. Ant.
Fig
. 1 –
Pla
nim
etri
a ge
nera
le d
ell’a
rea
di s
cavo
in lo
calit
à M
acch
iagr
ande
con
loca
lizza
zion
e de
l sag
gio
α. E
labo
razi
one
graf
ica
di G
. Fat
ucci
.
estratto
20.1, 2014 Lo scavo in località Macchiagrande a Veio 107
scavati alcuni ambienti destinati ai bagni caldi. Alcune vasche forse artigianali addossate ai muri di limite del Foro testimoniano un cambiamento di funzione dell’edificio pubblico che risulta sicuramente abbandonato tra il IV e il V sec. d.C., periodo a cui si datano diverse sepolture a fossa al suo interno.
Oggetto di interesse di questo contributo è un contesto ceramico di età tardo‑arcaica e classica proveniente dall’edificio più orientale tra quelli individuati per questa fase cronologica (Fig. 2, edificio E). Si tratta del materiale rinvenuto nel riempimento di un pozzo dove sono stati individuati circa 7500 reperti databili per la maggior parte tra la seconda metà del VI e gli inizi del IV sec. a.C., periodo per il quale forniscono un campione rappresentativo del materiale in uso.
Lo scavo di questo settore è iniziato nel 2003, in seguito ad una pulizia effettuata per estendere le indagini in un’area precedentemente sottoposta ad analisi geofisiche, in modo da verificarne l’attendibilità dei risultati6. Tali indagini (magnetometria e georadar ad alta riso‑
6 Lo scavo ha avuto luogo nei mesi di settem‑bre e ottobre 2003 con una campagna della durata di
7 settimane che ha visto la partecipazione di circa 50 studenti. Il lavoro, inizialmente condotto con l’ausi‑
Fig. 2 – Planimetria delle strutture in età arcaica (dis. M.T. D’Alessio ‑ M.C. Capanna).
estratto
108 M.T. D’Alessio – M.T. Di Sarcina Sc. Ant.
luzione) sono state condotte in collaborazione con l’Istituto di Tecnologie Applicate ai Beni Culturali del CNR e hanno fornito importanti elementi in relazione all’individuazione del li‑mite settentrionale dell’isolato privato (domus), permettendo inoltre di riconoscere almeno tre nuovi edifici monumentali in opera quadrata di tufo precedentemente non noti (Fig. 1, settore a nord‑est)7.
1) Nel settore immediatamente ad est della domus è emerso un primo edificio circoscritto da un doppio muro su tre lati eccetto quello meridionale aperto verso sud.
2) Più a est è un edificio rettangolare forse con due file di ambienti, di cui si conservano alcuni lacerti di pavimentazione in lastre di tufo.
3) Ancora più ad est è stata invece individuata una calcara circolare probabilmente realiz‑zata in età tarda sfruttando una precedente fornace8.
Il primo di questi tre nuovi edifici è stato indagato nel 2003 solo parzialmente. Davanti ad esso, in una sorta di recinto si notarono già in quell’occasione tre pozzi scavati nel banco geologico. Di uno soltanto, quello più occidentale (US 2859), fu possibile effettuare lo scavo delimitando appositamente un saggio denominato “α” su cui ci soffermiamo in questa sede9. In seguito all’interruzione delle ricerche a Macchiagrande, lo scavo in quest’area è ripreso solo recentemente con due campagne avvenute nell’ottobre del 2012 e del 2013, che hanno permes‑so di definire meglio la planimetria dell’edificio nella sua fase tardo‑arcaica e classica (Fig. 2, E) e completare lo scavo delle fasi di abbandono, riferibili – secondo una prima analisi – alla tarda età repubblicana10. Non è al momento ancora possibile proporre una cronologia definitiva per la costruzione e per le diverse fasi di vita dell’edificio, indagate solo in parte, di cui qui accen‑niamo a livello preliminare.
lo ScaVo del conteSto
Il saggio “α” (m 3,8 x 5,5) è stato collocato in modo da non intercettare alcuna strut‑tura, con il fine principale di svuotare rapidamente il pozzo messo in luce per evitare azioni e/o distruzioni da parte di scavatori abusivi che a volte frequentano il pianoro veiente. Al di sotto dell’arativo, eliminato nelle azioni di pulizia meccanica e manuale, è stata individuata un’unica e cospicua attività di obliterazione dell’area costituita da un esteso strato superiore di sabbia e argilla (US 2713)11 e da altri strati sottostanti, anch’essi a matrice sabbiosa friabile di
lio del mezzo meccanico grazie alla collaborazione di C. Brecciaroli (Ecol B), è poi proseguito con l’inter‑vento manuale degli scavatori fino ad ottenere un’area quasi doppia rispetto a quella precedente.
7 Le indagini geofisiche sono state condotte con la collaborazione del Dott. S. Piro, dell’Istituto ITABC del CNR, che ringrazio.
8 La struttura è stata interamente svuotata per una profondità complessiva di circa 6 m.
9 Lo scavo del saggio “α” è stato condotto nel 2003 da C. Bariviera. Per la ripresa successiva delle
indagini, cfr. infra.10 Lo scavo di questo settore è attualmente se‑
guito da G. Fatucci e M.C. Capanna mentre la clas‑sificazione dei reperti è in corso ad opera di M.T. Di Sarcina. Nella campagna del 2013 sono stati svuotati anche gli altri due pozzi intercettati in precedenza (US 209 con taglio 208 e 3763 con taglio 3718), i cui reperti sono ancora in corso di studio.
11 L’US 2713 contiene 1201 reperti databili tra I sec. a.C. e I sec. d.C. tra cui 2 monete corrose, 680 frr. pertinenti a produzioni datanti: sigillata italica (49
estratto
20.1, 2014 Lo scavo in località Macchiagrande a Veio 109
colore giallo o marrone, spesso contenenti frammenti irregolari di tufo grigio di pic‑cole e medie dimensioni (cm 5‑30 circa)12. Alla quota di m 126,56/61 s.l.m. si conser‑vava parte di un battuto compatto in tufo di colore biancastro, con superficie piana, contenente sporadici frammenti cerami‑ci di età arcaica che può essere identificato con un piano pavimentale (US 3040) dispo‑sto su una consistente preparazione in tufi (US 2977, 3062, 3241)13. In fase con il bat‑tuto era stato allestito un pozzo circolare in tufo (US 2859, con diam. interno di 60 cm ca.) conservato per due filari di blocchi in al‑zato e scavato in profondità nel terreno ver‑gine senza rivestimento (Figg. 3‑4). Il pozzo è stato rinvenuto rasato alla stessa quota di calpestio del pavimento; i conci in tufo gri‑gio che costituivano la ghiera della struttura
frr.), pareti sottili (22 fr.), ceramica comune (340 frr.), africana da cucina (10), vernice rossa interna (3), anfo‑re (234 frr.), lucerne (12 fr.), vetro (10).
12 US 2846, 2858, 2926, 2965, 2984, 2990‑2991, 3088. Appartengono a questa attività anche alcuni strati costituiti da frammenti di lastre irregolari in tufo grigio (US 2935‑2939) e accumuli più consistenti dello stesso materiale (US 3018). Di questi strati, l’US 2991 contiene 83 frr. tra i quali internal slip ware (5), bucche‑ro grigio (10), vernice nera (1); l’US 2935 1 tegola di I fase, l’US 2936 1 parete di ceramica etrusca a fasce e 1
in impasto rosso; l’US 2938 1 fr. di internal slip ware; l’US 2939 1 parete di ceramica etrusca a fasce e 1 in im‑pasto grezzo.
13 La cronologia dell’US 3040 si deve a fram‑menti di impasto grezzo (4), impasto rosso (4), buc‑chero grigio (1) e 1 fr. di tegola di I fase. Degli strati preparatori solo l’US 3062 conteneva materiali cera‑mici: 1 orlo di olletta miniaturistica in ceramica acro‑ma, pareti di impasto grezzo, rosso e bruno e 2 frr. di tegole di I fase.
Fig. 3 – Il pozzo del saggio α (foto M.T. D’Alessio).
Fig. 4 – Pianta e sezione del pozzo US 2859 (dis. G. Fa‑tucci).
estratto
110 M.T. D’Alessio – M.T. Di Sarcina Sc. Ant.
sono di forma e dimensioni irregolari, disposti di taglio, sfalsati tra le due assise. Sia nell’elevato della struttura che nel cavo scavato nel vergine erano realizzati incassi rettangolari con profilo superiore semicircolare con funzione di pedarole (alt. 10 cm ca.; largh. 15 cm ca.; prof. 10 cm ca.). Il riempimento del pozzo è stato rimosso per uno spessore complessivo di m 2,60 fino a raggiungere i m 124,08 s.l.m.14. Al suo interno sono state distinte 13 unità stratigrafiche15, rife‑ribili ad un’unica attività di chiusura del pozzo come dimostrano: l’estrema omogeneità delle classi ceramiche contenute nei diversi strati; la presenza di attacchi tra frammenti rinvenuti in US differenti e a quote tra loro distanti; la presenza limitata ma costante in tutto il deposito dei materiali ceramici più recenti, che datano il formarsi dell’intera attività entro la metà del IV sec. a.C.16. Gli strati presentano una matrice sabbiosa – o con una minima percentuale di argilla – di colore chiaro tendente al giallo e contengono tutti ceramica in grande quantità, inerti di tufo, ossa e alcuni elementi in bronzo17. Per le loro caratteristiche peculiari si distinguono, partendo dall’alto, quattro strati: l’US 2871 è costituita da una matrice di argilla rossa compatta e pre‑senta in superficie frammenti ceramici di grandi dimensioni tra cui 27 frr. di un oggetto cam‑paniforme dal profilo semplice con doppia apertura, parzialmente ricostruibile e interpretabile come la vera fittile del pozzo (diam. mass. 60 cm ca.; diam. min. 45 cm ca.)18; l’US 3155 consiste in una chiazza ovale composta interamente di cenere grigia contenente ceramica, carbone e rari frammenti di ossa; l’US 3190, dal colore nerastro provocato dai molti frustuli di carbone, contiene tegole disposte obliquamente, un grande fr. di dolio, numerosi frr. ceramici e molte ossa; l’US 3231, anch’essa di colore più scuro, presenta carbone, ceramica in grande quantità, laterizi e inerti di tufo.
Notevoli sono le affinità che si possono istituire tra il materiale proveniente da questo contesto e il materiale recuperato nel pozzo svuotato a non troppa distanza sull’altura di Piano di Comunità, all’interno di un edificio individuato sotto una domus tardo‑repubblicana19. Il pozzo di Comunità ha restituito una quantità di reperti superiore di almeno tre volte rispetto a quello di Macchiagrande, ma i due depositi appaiono molto simili per tipologia e composizio‑ne, anche se le attività che hanno portato alla sua obliterazione sembrano datarsi alla fine del IV ‑ inizi del III sec. a.C.
M.T. D’A.
14 A causa delle dimensioni ristrette del pozzo non è stato possibile per motivi di sicurezza rimuo‑vere il riempimento integralmente, ma la natura degli strati e l’andamento delle pareti laterali del taglio sem‑bravano suggerire la vicinanza del fondo.
15 Procedendo dal riempimento più alto a quello più profondo tra quelli scavati sono state individuate le US 2844, 2852, 2871, 2956, 3155, 3170, 3173, 3190, 3225, 3231, 3275, 3276, 3277.
16 Si tratta di frr. ascrivibili alle produzioni di ce‑
ramica a vernice nera, a vernice rossa opaca e anfore, cfr. infra.
17 Quasi tutti gli strati (tranne 2852, 3173 e 3231) contengono ossa (non ancora analizzate). Nelle US 2844, 3173, 3190 e 3225 sono presenti anche frr. di bronzo.
18 Altri 7 frr. dello stesso oggetto erano presenti nell’US 3173.
19 Vd. il contributo curato da B. Belelli Marche‑sini (belellI et al. 2009).
estratto
20.1, 2014 Lo scavo in località Macchiagrande a Veio 111
I MaterIalI del pozzo
Nei 13 strati di riempimento individuati all’interno del pozzo sono stati classificati 7526 reperti, la maggior parte dei quali (5490) pertinenti a ceramica vascolare pari al 72,95% dei rinvenimenti, 1786 a elementi fittili di copertura dei tetti (23,73%) e i restanti 250 a oggetti di instrumentum domesticum (3,32%). I reperti, concentrati soprattutto negli strati più profondi del riempimento, sono perlopiù riferibili a un orizzonte cronologico compreso tra la metà del VI e gli inizi del IV sec. a.C. Tutti i materiali del contesto sono solo parzialmente ricostruibili attraverso il ricongiungimento di frr. distribuiti nei vari strati. Quasi tutti i livelli hanno inoltre restituito ossa animali, particolarmente concentrate nelle US 3275 e 327620.
Una prima classificazione del deposito, rivelatosi un bacino fondamentale d’informazioni sulle ceramiche attestate nell’area urbana di Veio nel tardo arcaismo, ha evidenziato che, a parte una percentuale limitata di frr. databili all’età orientalizzante e alla prima età arcaica21, il resto del materiale costituiva un contesto cronologicamente omogeneo con decisive corrispondenze con i materiali rinvenuti nel deposito di Casale Pian Roseto22, e nel più recente contesto di obliterazione del pozzo di Comunità23.
Dei frr. di ceramica vascolare il 91% è pertinente a produzioni e tipologie databili all’età tardo arcaica e classica, alle quali va ascritta la quasi totalità dei tipi di bucchero, la produzione in assoluto più attestata, mentre i materiali cronologicamente inquadrabili tra V e IV sec. a.C. corrispondono al 3,97%.
Il resto del deposito è costituito per il 23,73% da materiale edilizio, e solo l’1,46% è ricon‑ducibile a classi tipiche dell’età orientalizzante, elemento che consente di parlare di un limitato tasso di residualità nella sua composizione.
Le ceramiche depurate maggiormente attestate sono il bucchero grigio (18,10%), presente soprattutto con forme aperte, come scodelle a vasca emisferica e carenate, piattelli, calici, cop‑pette e la ceramica acroma (11,09%), con brocche, scodelle e piattelli. Tra gli impasti predomi‑nano l’impasto grezzo (17,77%), in gran parte olle ovoidi e la ceramica d’impasto chiaro‑sab‑bioso (13,83%), con brocche, bacini e thymiateria. L’impasto rosso, produzione molto diffusa in età orientalizzante e arcaica, corrisponde solo al 4,66% dei recuperi, poco più dell’internal slip ware, che con 232 frr. corrisponde al 3,08%. Su 35 frr. sono stati individuati graffiti, per la maggior parte pubblicati nel supplemento del CIE dedicato alla città di Veio24.
In questa sede si elencheranno le tipologie più rappresentative dei materiali che si possono considerare utili alla definizione cronologica e all’interpretazione del contesto di provenienza.
20 Solo da qui provengono 2 cassette di ossa; al‑tre concentrazioni più limitate provengono dall’US 2844, l’ultimo riempimento, e dall’US 2956. La futura analisi di tali reperti consentirà di aggiungere ulteriori informazioni sulla natura del deposito.
21 Ceramica italo‑geometrica: 8 frr. (0,11%); im‑
pasto bruno orientalizzante: 102 frr. (1,36%); cerami‑ca etrusco‑corinzia (0,05%).
22 torellI 1998; dI SarcIna 2012.23 belellI et al. 2009.24 CIE, pp. 24‑28.
estratto
112 M.T. D’Alessio – M.T. Di Sarcina Sc. Ant.
Ceramiche fini.Tra le ceramiche d’importazione si registra la presenza esclusiva di ceramica attica, atte‑
stata da 82 frr. pari al 3,38% delle ceramiche fini. Tale quantitativo, benché minimo rispetto al totale dei rinvenimenti, costituisce un dato alquanto significativo per Veio, dove per la fase tardo arcaica e classica è scarsa la presenza di materiale d’importazione, che sembra essere ri‑servato quasi esclusivamente alle esigenze cultuali e al rito funerario, come nella maggior parte dei centri dell’Etruria e del Lazio arcaico25. La maggior parte dei frr. è relativa a forme aperte e tra questi 27 sono riferibili a kyilikes26. Alla produzione a figure nere è ascrivibile un solo frammento, un orlo di kylix con decorazione vegetale stilizzata; circa 15 frr., 11 dei quali dalla US 3275, sono attribuibili a vasellame a figure rosse di eccezionale qualità, databile al pieno V sec. a.C. Sono stati rinvenuti 3 frr. di orli con decorazione a baccelli (Fig. 5.1), pertinenti almeno a due forme chiuse (probabili stamnoi), alle quali sono forse da ricondurre un fr. con figura femminile con testa reclinata indietro (Fig. 5.2)27, e uno con personaggio virile barbato (Fig. 5.3)28. A questi possono aggiungersi altri 2 frr. con braccia piegate (Fig. 5.4‑5), uno dei quali con resti di panneggio. Un altro fr. di forma chiusa (Fig. 5.6) conserva i resti di una figu‑ra, probabilmente femminile, incedente verso sinistra con indosso una lunga veste con ricco panneggio; sulla sinistra rimane il piede di una seconda figura che avanza verso la precedente29. Tra le forme aperte si riconoscono una kylix con cavallo sull’esterno (Fig. 5.7), frr. di kylikes con resti di figure ammantate (Fig. 5.8) e tondi a meandri (Figg. 5.9‑10) e 2 frr. pertinenti a un owl skyphos a figure rosse della metà del V sec. a.C. (Fig. 5.11)30. Tra i frr. non figurati si segna‑lano una kylix con labbro rettilineo (Fig. 6.1), una con vasca arrotondata e ansa a bastoncello (Fig. 6.2) e 2 frr. di piedi a tromba (Figg. 6.3‑4)31. Dall’US 3275 proviene un fondo di coppa con palmetta stampigliata e resti di una seconda (Fig. 5.12)32.
Sono stati inoltre individuati 25 frr. di ceramica a vernice nera, di probabile produzione locale: 3 pertinenti a forme chiuse (tra cui un labbro di oinochoe, Fig. 6.5) e 22 a forme aper‑
25 MartellI 1989; anGelellI 2001. Per le cera‑miche attiche nei santuari: baGlIone 2000; fortunel-lI - MaSSerIa 2012. Sulle attestazioni a Veio caScIno 2012a.
26 Su un piede a tromba di kylix attica è stata in‑dividuata un’iscrizione in lingua etrusca (CIE II I, 5, 6386; US 3275/353: zi×[‑ ‑ ‑]).
27 Per un confronto vd. lo stamnos del c.d. Pittore del Deinos con scena dionisiaca da Nocera dei Pagani, 420‑410 a.C. Napoli, Museo Archeologico Naziona‑le, inv. 81674. beazley 1963, R 1151.2; arIaS ‑ HIrMer 1960, tavv. 206‑211.
28 Cfr. Stamnos da Vulci con scena di parten‑za di un guerriero (440‑430 a.C., Monaco, Museum antiker Kleinkunst 2415, beazley 1967, pp. 1142 ss., n. 2, arIaS - HIrMer 1960, tavv. 193‑5) e la pelike da Gela con il ritorno di Efesto all’Olimpo (430 a.C. ca., Monaco, Museum antiker Kleinkunst 2361, beazley 1967, pp. 1142 ss., n. 36, arIaS - HIrMer 1960, tavv.
196‑199), entrambe del Pittore di Kleophon.29 Per la resa del panneggio e dei piedi cfr. stam-
nos di Hermonax con la morte di Orfeo, Parigi, Louvre G 416, da Nola, beazley 1967, p. 490, I 19, 475‑450 a.C.
30 Per il frammento di kylix con cavallo (3231/1‑3, RP 1163) cf. Moore 1998, CVA P. Getty 8, tav. 431, p. 42, n. 59 (kylix attribuita al pittore di Dokimasia, 480‑470 a.C.). Per l’owl skyphos: torellI - Murray tHreIpland 1970, p. 101, fig. 16 R‑5; Moore 1998, AA XXX, p. 302, tav. 122, n. 1317 (450 a.C.).
31 US 3225/4, labbro: torellI - Murray tHreI-pland 1970, p. 101, fig. 16 R‑3; SparkeS - talcott 1970, stemless cup, fig. 5 n. 471; US 3155/2, labbro, va‑sca e ansa, torellI - Murray tHreIpland 1970, p. 101, fig. 16 R‑1; SparkeS - talcott 1970, fig. 4, n. 420, 432; US 3190/1‑2, piedi a tromba.
32 SparkeS - talcott 1970, stemless cup, 458 (430‑420 a.C.), 463 (425 a.C. ca.).
estratto
20.1, 2014 Lo scavo in località Macchiagrande a Veio 113
Fig. 5 – Frammenti di ceramica attica dal riempimento in esame.
estratto
114 M.T. D’Alessio – M.T. Di Sarcina Sc. Ant.
te33. Tra queste si riconoscono 1 fr. di probabile kantharos (Fig. 6.6), 2 di skyphoi (Fig. 6.7), 2 pertinenti a piatti (Fig. 6.9), 3 a coppe (Figg. 6.8, 6.10‑11) e 2 di kylikes. I frr. presentano una vernice molto compatta, talvolta opaca, l’argilla in sezione è di colore beige. L’analisi autoptica dei corpi ceramici e il confronto con la produzione acroma e a bande fanno propendere per l’appartenenza a una produzione locale, a imitazione dei prodotti attici a vernice nera del V sec. a.C.34.
Solo 24 frr. di forme aperte, parzialmente ricostruibili, sono riconducibili alla vernice ros‑sa opaca, attestata in Etruria meridionale, nel territorio falisco e a Roma in contesti databili a partire dalla fine del VI sec. a.C.35. In area veiente vasellame di questo tipo era noto da Casale Pian Roseto, dove insieme alle produzioni locali a vernice nera era annoverato tra i reperti più recenti. Gli studi su questo tipo di ceramica sono relativi soprattutto alle produzioni di età repubblicana. Recentemente il dibattito sull’inizio della produzione si è riaperto a seguito della scoperta a Falerii Veteres di numerosi vasi a vernice rossa nel riempimento di un pozzo con altro vasellame tardo arcaico (bucchero, argilla depurata, impasto chiaro‑sabbioso) e ter‑recotte architettoniche di V sec. a.C.36. La maggior parte dei frr. diagnostici è caratterizzata da una spessa vernice opaca di colore rosso mattone. Sono stati individuati 2 tipi di piattelli (Figg. 6.14‑15), 2 tipi di coppe (Figg. 6.12, 16, 18) e coppette di piccole dimensioni (Figg. 6.13, 17). Le forme attestate in vernice nera e vernice rossa opaca a Veio condividono il repertorio con le corrispondenti produzioni in bucchero e ceramica acroma, riproponendo modelli della ceramica attica a vernice nera di pieno V‑inizi IV sec. a.C.
La ceramica depurata con decorazione a bande è presente con 84 frr. (3,46% del totale delle classi fini), dei quali 39 pertinenti a forme chiuse e 45 a forme aperte. Tra le prime si rico‑noscono alcune olle con decorazione a fasce e puntini sulla spalla (Fig. 6.19), rari frr. di skyphoi con motivo a linea ondulata sulla spalla (Fig. 6.20‑21), del tipo rinvenuto nel deposito di Casale Pian Roseto, e diversi esemplari di piattelli a labbro distinto decorato da fasce concentriche, attestati per lo più nella versione completamente acroma (Fig. 6.22‑23).
La ceramica depurata acroma è dopo il bucchero la classe fine più attestata. Su 835 frr., corrispondenti all’11,09% dei rinvenimenti e al 34,42% delle produzioni depurate, sono stati individuati 276 elementi diagnostici. Di questi, 127 sono riconducibili a forme chiuse, soprat‑tutto brocche e oinochoai (Fig. 7.2‑5), mentre dei 149 attribuibili a forme aperte ben 125 sono piattelli (Fig. 7.1), 11 scodelle, 1 coppa, 1 miniaturistico, 1 calice, 1 skyphos.
Nelle stratigrafie veienti di età tardo arcaica e classica la presenza di ceramica depurata acroma e con decorazione a bande riveste un’importanza notevole dal punto di vista quantita‑tivo e qualitativo e rivela lo sviluppo di una peculiare tradizione formale che ha origine nelle forme già diffuse nella fase tardo orientalizzante e che si ritrova nelle produzioni più tarde in vernice rossa e vernice nera. La presenza di una produzione locale, indiziata da numerosi scarti
33 I frr. provengono dalle US 3173 (11), 2871 (3), 3170 (2), 3190 (2), 3231 (1), 3275 (3), 3276 (1), 3277 (2). I disegni dei frammenti ceramici sono di M.T. Di Sar‑cina con il contributo di A. Treglia, C. Di Sarcina e P. Colasanti.
34 Vd. L. aMbroSInI, in belellI et al. 2009, p. 106.
35 Per la bibliografia sulle attestazioni di ciotole a vernice rossa in contesti di V sec.: de lucIa brollI 2006, pp. 72 ss., nota 19; Stanco 1994; MantIa 2002; colonna 2002, p. 237.
36 de lucIa brollI 2006.
estratto
20.1, 2014 Lo scavo in località Macchiagrande a Veio 115
Fig. 6 – Ceramiche fini, nn. 1‑4: ceramica attica; nn. 5‑11: ceramica a vernice nera; nn. 12‑18: ceramica a vernice rossa; nn. 19‑23: ceramica depurata a bande.
estratto
116 M.T. D’Alessio – M.T. Di Sarcina Sc. Ant.
di fornace, è stata dimostrata dai recenti scavi di Comunità37, dove J.B. Ward‑Perkins aveva individuato strutture riferibili a una o più fornaci. La distribuzione di tali prodotti nel territo‑rio è pienamente dimostrata dalla massiccia presenza a Casale Pian Roseto, al cui repertorio è ricollegabile la quasi totalità dei reperti di Macchiagrande38.
Il bucchero, percentualmente predominante tra le classi fini, è nel complesso afferente alla produzione di colore grigio scuro con un accurato trattamento delle superfici39. Tra i 1362 frr. recuperati si registra una netta prevalenza e varietà di forme aperte (608 frr., pari al 44,64 %), distinte in vasellame per contenere (scodelle; piatti), per bere (coppe; calici; skyphoi) e per at‑tingere (kyathoi), rispetto alle forme chiuse, attestate da soli 24 frr. corrispondenti soprattutto a vasi per versare (oinochoai; brocche), o più raramente per conservare liquidi (stamnoi; olle). Dall’US 3173 proviene un fr. di askos, del tipo attestato a Casale Pian Roseto e nel pozzo di Comunità40.
Numerosi frr. sono riconducibili a piattelli (93) di piccole e medie dimensioni (diam. com‑presi tra 10 e 20 cm), distinti in 2 gruppi. Nel primo, formato da piatti a vasca troncoconica (tipo Rasmussen pl. 1), il tipo più attestato ha labbro semplice e vasca più o meno profonda, che negli esemplari più conservati presenta la costante del basso piede a tromba (Fig. 7.6). Un secondo tipo (Rasmussen pl. 2) ha labbro ingrossato e rilevato inferiormente (Fig. 7.7). Dal pozzo di Macchiagrande proviene una coppa a labbro rientrante o patera, alla quale posso‑no forse essere accostati anche esemplari di coppe con labbro ingrossato a cordone e vasca molto bassa a profilo arrotondato, dal profilo simile alle scodelle. La forma per contenere più attestata è la scodella, con 216 frr. nelle versioni carenata, a labbro verticale ingrossato e vasca troncoconica (Fig. 7.8), o con breve labbro a tesa e vasca molto profonda dal profilo arroton‑dato (Fig. 7.9). Il gruppo più numeroso è rappresentato dalle scodelle con labbro ingrossato a mandorla, foggia con la quale sono prodotte anche coppe di dimensioni minori e con vasca poco profonda (Fig. 7.10). I coperchi sono attestati da 9 frr., a labbro ingrossato o rovesciato e a tesa con listello41. Sono inoltre attestate le coppe, con vasca carenata, a profilo arrotondato, o con labbro ingrossato a mandorla42: queste ultime, prodotte anche in ceramica acroma e verni‑ce rossa, possono considerarsi tra le produzioni più tarde.
I vasi potori più attestati sono sicuramente i calici, con 55 frr. attribuibili per la maggior parte al tipo carenato su basso piede ad anello (Fig. 7.11), molto attestato a Casale Pian Rose‑to43. Al tipo 4 c Rasmussen ascrive le carinated cups di Casale Pian Roseto44, prevalentemente a labbro svasato rettilineo non decorato e con la costante del piede ad anello; l’unica eccezione
37 Vd. i contributi di R. Cascino sugli indicatori delle produzioni veienti in caScIno et al. 2012. Per lo scavo belellI et al. 2009, pp. 112‑115.
38 torellI - Murray tHreIpland 1970, pp. 74 ss.; fig. 8 ss. Sulle attestazioni di ceramica acroma e con decorazione a bande da Veio: caScIno 2012c e 2012d.
39 È stato rinvenuto un unico fr. di bucche‑ro nero, pertinente a un’ansa a bastoncello di forma aperta dall’US 3231 (inv. 109). Sulla presenza di buc‑chero grigio a Veio caScIno 2012b.
40 US 3173/214: torellI - Murray tHreIpland 1970, p. 90, fig. 7 Q‑2.
41 torellI - Murray tHreIpland 1970, p. 92, fig. 7 P‑4.
42 torellI - Murray tHreIpland 1970, p. 89, fig. 4 C‑2, fig. 4 C‑4; cfr. fig. 4.18 in vernice rossa opaca.
43 Corrispondente a raSMuSSen 1979, chalice 4b, 4c, pp. 100‑101, tav. 29.
44 torellI - Murray tHreIpland 1970, p. 91, fig. 6 gruppo K.
estratto
20.1, 2014 Lo scavo in località Macchiagrande a Veio 117
Fig. 7 – Ceramiche fini e d’impasto, nn. 1‑5: ceramica acroma; nn. 6‑14: bucchero; nn. 15‑23: impasto chiaro‑sabbioso; nn. 24‑25: impasto grezzo; n. 26: internal slip ware.
estratto
118 M.T. D’Alessio – M.T. Di Sarcina Sc. Ant.
è costituita da 1 fr. con labbro ingrossato a piccolo cordone, molto simile per profilo ai calici miniaturistici (miniature cups45).
Dati molto interessanti riguardano le forme miniaturistiche, alle quali corrispondono 66 frr. Sono ampiamente attestati i calici (Fig. 7.12‑14) con labbro semplice rettilineo o ingrossato a piccolo cordone, del tutto assenti dalla tipologia di Rasmussen, oppure con labbro svasato, documentati a Cerveteri e San Giovenale46. Le ridotte dimensioni (diam. 5/8 cm), le caratte‑ristiche dell’orlo e la presenza di numerosi esemplari nei medesimi contesti suggeriscono una funzione cultuale come contenitori di offerte o strumenti di rituali legati al consumo di liquidi. Nel commentare la presenza massiva di tali oggetti nel deposito di Casale Pian Roseto (1/4 cir‑ca degli oggetti in bucchero), M. Torelli li definisce un vero e proprio “fossile‑guida dei conte‑sti sacri dell’arcaismo etrusco‑laziale”, destinato a contenere porzioni minime sia di solidi che di liquidi47. Nel deposito di Macchiagrande è stato riconosciuto 1 solo fr. pertinente a skyphos, forma attestata in discreta quantità a Casale Pian Roseto; il confronto con la ceramica attica figurata e a vernice nera suggerisce una cronologia compresa tra il V e gli inizi del IV sec. a.C.48.
Sui vasi di bucchero è presente il maggior numero di segni grafici individuati (simboli o lettere isolate, in pochi casi resti di iscrizioni), attestati soprattutto negli strati inferiori del riempimento49. Le forme aperte di bucchero risultano essere a Veio un locus privilegiato per la realizzazione di graffiti sul vasellame. Questo dato emerge soprattutto tra i materiali connessi alla sfera sacrale, come quelli rinvenuti nei santuari di Portonaccio, Porta Caere, Campetti, e nei depositi di Casale Pian Roseto e Porta Formello dove in particolare su piattelli e nelle scodelle a vasca bassa sono presenti simboli come la stella a 5 punte e il segno a croce50, oltre a lettere isolate e segni astratti51.
Nel riempimento del pozzo, dal punto di vista quantitativo e della tipologia, tra le forme in bucchero prevale nettamente il vasellame di uso promiscuo, come ciotole e coppe carenate, rispetto ad altre tipologie comprese comunque tra le forme aperte come i piatti su piede e ri‑spetto ai vasi potori e al vasellame per trasportare e per versare52.
Ceramiche d’impasto.La ceramica vascolare d’impasto, corrispondente al 40,73% dei rinvenimenti, è quasi to‑
talmente riconducibile a tipologie di età tardo arcaica. L’impasto chiaro‑sabbioso, presente con 1041 frr. pari al 13,83% dei rinvenimenti e al 33,98% delle ceramiche d’impasto, presenta una discreta varietà di forme e tipi come olle e brocche con decorazione lineare dipinta di colore bruno, bacini con orlo a fascia dipinta, thymiateria su alto fusto dipinto con linee orizzontali.
45 US 3275/606; torellI - Murray tHreIpland 1970, p. 90, fig. 5 gruppo I.
46 raSMuSSen 1979, tav. 42, n. 281, pigmy bowl da San Giovenale‑Porzarago t. 9 e Cerveteri Monte Aba‑tone t. 424, seconda metà VI‑V sec. a.C.
47 torellI 1998, p. 123.48 SparkeS - talcott 1970, p. 250 ss., in particola‑
re fig. 4 nn. 332 e 333 (500 a.C.).49 CIE II I, 5, 6371ter‑6393.
50 Casale Pian Roseto: crIStofanI 1969, pp. 324 ss.; torellI - Murray tHreIpland 1970, in par‑ticolare p. 87, fig. 2 (scodelle gruppo A), p. 90, fig. 5 (piattelli gruppo G e coppette gruppo I), p. 91, fig. 6 (calici gruppo K). Porta Formello: Murray tHreI-pland 1969, p. 2 ss.
51 Sulla ceramica come supporto per iscrizioni nell’ambito etrusco‑padano: SaSSatellI 1993.
52 Così anche a Casale Pian Roseto: torellI 1998.
estratto
20.1, 2014 Lo scavo in località Macchiagrande a Veio 119
Questa produzione di ceramica grezza di colore chiaro, dall’impasto ricco di inclusi, princi‑palmente augitici, è diffusa tra Etruria e Lazio arcaico a partire dalla fine del VII sec. a.C. ed è riconducibile a forme funzionali alla preparazione dei cibi e al trasporto o conservazione di derrate e liquidi53. Gli esemplari individuati nel deposito sono spesso caratterizzati da una decorazione lineare dipinta bruno‑marrone talvolta tendente al rosso, spesso stesa su una scial‑batura chiara.
Tra le forme aperte, alle quali appartengono 89 frr. diagnostici, è presente un unico fr. riconducibile a un piatto con labbro a tesa54; sono inoltre attestate alcune scodelle con vasca troncoconica e labbro ingrossato, del diam. di ca. 20 cm, spesso dipinte a fasce e morfologi‑camente simili ai bacini (Fig. 7.15). 12 frr. sono riferibili a thymiateria, documentati anche in ceramica acroma depurata e a bande55 (Fig. 7.17‑18). I bacini sono attestati da 62 frr.: tra questi, 19 appartengono al tipo con labbro ingrossato e cordone sottostante (Fig. 7.16)56, 19 al tipo con labbro ingrossato a fascia (Fig. 7.19)57 e 14 al tipo con labbro ingrossato e orlo appiattito58 o rilevato (Fig. 7.20)59.
Tra le forme chiuse (129 frr. diagnostici), sono attestate olle globulari con labbro svasato e rilevato (Fig. 7.22)60 e vasi di forma ovoide che, a causa dell’elevata frammentarietà e della conformazione condivisa degli orli, solo raramente è possibile attribuire con certezza a olle o brocche (Fig. 7.21)61. Sono attribuibili a situle 1 fr. di labbro con ansa passante sormontante (Fig. 7.23) e 2 con ansa a occhiello, tipo non attestato a Casale Pian Roseto62. È infine da se‑gnalare 1 fr. di askos, probabilmente con corpo a ciambella, con tracce di pittura arancione, attestato in bucchero a Casale Pian Roseto63.
L’impasto rosso, con 351 attestazioni, costituisce appena il 4,66% dei recuperi e l’11,45% del vasellame d’impasto. Quasi tutti i frr. sono attribuibili a forme chiuse: dei 46 pertinenti a olle, 9 esemplari appartengono al tipo ovoide a labbro svasato distinto, diffuso dalla seconda metà del VI sec. a.C.64. Tra le poche forme aperte si segnalano 1 fr. di piatto con labbro a tesa, l’unico a presentare l’ingubbiatura lucida delle produzioni orientalizzanti, 2 coperchi a labbro ingrossato, 2 scodelle a labbro semplice65, 1 labbro di probabile lopàs o pentola con
53 Sulla produzione cfr. M. Merlo e S. ten kortenaar, in dI MarIo 2005, pp. 21 ss.; dI SarcIna 2012c.
54 US3173/343, non attestato a Casale Pian Ro‑seto; cfr. carafa 1995, pp. 650‑651 (530‑500 a.C.); GorI - pIerInI 2001, p. 144, tav. 32 n. 306.
55 US3277/43, US3173/352: torellI - Murray tHreIpland 1970, p. 106, fig. 21 gruppo H. US3173/4: ibid., p. 106, fig. 21 H‑21. US3190/33: ibid., p. 106, fig. 21 H‑4 (simile).
56 torellI - Murray tHreIpland 1970, p. 102, fig. 17 gruppo C.
57 torellI - Murray tHreIpland 1970, p. 103, fig. 18 gruppo D.
58 torellI - Murray tHreIpland 1970, p. 103, fig. 17 B‑1.
59 torellI - Murray tHreIpland 1970, p. 103, fig.
17 gruppo A.60 torellI - Murray tHreIpland 1970, p. 107,
fig. 22.61 torellI - Murray tHreIpland 1970, p. 105,
fig. 20.62 Per il primo tipo (da US 3275/289) cfr. torel-
lI - Murray tHreIpland 1970, p. 106, fig. 21 G‑2; per il secondo (da US 3173/338) cfr. confronti da Gravi‑sca, GorI - pIerInI 2001, tav. 52,545 (metà V ‑ inizi IV a.C.); Pyrgi 1988‑89, p. 84 ss., fig. 65,90, fig. 66,2 (fine V‑IV a.C.).
63 torellI - Murray tHreIpland 1970, p. 92, fig. 7 Q‑2.
64 torellI - Murray tHreIpland 1970, pp. 117‑119, figg. 32‑34, gruppi B‑E; dI SarcIna 2012a.
65 torellI - Murray tHreIpland 1970, p. 109, fig. 24 A‑4.
estratto
120 M.T. D’Alessio – M.T. Di Sarcina Sc. Ant.
listello66. Dall’US 3275 provengono infine 2 frr. di braciere decorati da fregio a cilindretto con animali divergenti.
L’impasto grezzo, con 1337 frr., costituisce la ceramica vascolare d’impasto più atte‑stata. Si registra una prevalenza di forme chiuse, con 225 frr. diagnostici pertinenti a olle. Di queste 103 frr. sono riferibili a olle ovoidi con labbro svasato distinto (Fig. 7.24‑25)67, al cui gruppo appartengono anche numerosi esemplari in impasto rosso e in internal slip ware (vd. infra). Dall’US 3231 provengono 3 frr. di un’olletta globulare di piccole dimen‑sioni simile a quelle attestate a Casale Pian Roseto68. Le forme aperte annoverano 116 frr. diagnostici attribuibili in maggior parte a scodelle (59 frr.), nelle 4 varietà a labbro semplice (12), appiattito (7), ingrossato (17) o rientrante (4). A queste si aggiungono 43 frr. di co‑perchi, dei quali 32 a labbro ingrossato e 8 semplice69. Infine sono presenti 14 frr. di piccoli bacini a labbro ingrossato.
Nel deposito si registra una cospicua attestazione di ceramica internal slip ware con 232 frr. ai quali sono state aggiunte le uniche 2 pareti con scialbatura esterna (external slip ware)70. Le olle a labbro svasato distinto, con 35 frr., sono l’unica forma chiusa riconosciuta nel pozzo. La maggior parte di esse (33) presenta orlo ingrossato a mandorla, cosa che le accomuna agli esemplari di Casale Pian Roseto71. Un esemplare (Fig. 7.26) presenta labbro ingrossato a fascia rilevata, tipo attestato a Casale Pian Roseto in impasto rosso72. Solo 2 esemplari presentano labbro svasato distinto con orlo ingrossato e rilevato verso il basso, tipologia maggiormente attestata nello scavo dei cunicoli a Porta Nord‑Ovest e da considerarsi probabilmente più an‑tica73. Dall’US 3277 proviene 1 fr. di forma aperta riconducibile a una scodella‑coperchio con labbro rientrante74.
Instrumentum.Tra la ceramica non vascolare sono presenti 5 frr. di pesi da telaio tronco‑piramidali in
impasto chiaro‑sabbioso con simboli impressi. Dall’US 3275 provengono 1 peso intero e 2 frammentari, dei quali 1 (inv. 3) con cuppella e un altro (inv. 4) con segno a croce sulla base minore75. Gli altri 2, integri, provengono dall’US 3276 e presentano entrambi una linea longi‑tudinale incisa sulla base superiore76.
Dagli strati inferiori del riempimento provengono anche 6 frr. di terrecotte architettoni‑che policrome in impasto chiaro‑sabbioso: 1 fr. di lastra con fregio a rilievo nel quale si rico‑
66 Simile a torellI - Murray tHreIpland 1970, p. 95, fig. 10 F‑1, in acroma.
67 torellI - Murray tHreIpland 1970, fig. 27 G‑2. Sulle produzioni veienti di vasellame in impasto grezzo: dI SarcIna 2012b.
68 US3231/164‑165: torellI - Murray tHreI-pland 1970, p. 110, fig. 25 gruppo D.
69 torellI - Murray tHreIpland 1970, p. 110, fig. 25 gruppo C.
70 caScIno - dI SarcIna 2008; dI SarcIna 2012d.71 torellI - Murray tHreIpland 1970, p. 116, fig.
31, gruppo A.72 torellI - Murray tHreIpland 1970, p. 117, fig.
32 B‑2.73 US 3276/14, 21: Murray tHreIpland 1963, p.
55, fig. 14,1‑3, 14,5‑7; torellI - Murray tHreIpland 1970, p. 116, fig. 31 A‑20, A‑21, A‑22.
74 torellI - Murray tHreIpland 1970, p. 110, fig. 25 C‑8 (in impasto grezzo).
75 torellI - Murray tHreIpland 1970, p. 131, fig. 36 B‑1.
76 belellI et al. 2009, p. 109, fig. 34,1.
estratto
20.1, 2014 Lo scavo in località Macchiagrande a Veio 121
nosce una figura maschile, 4 frr. di antefisse del tipo nimbato77 e 1 fr. di antefissa senza nimbo raffigurante Acheloo (Fig. 8), di un tipo non attestato a Veio78.
Dall’US 3275 proviene inoltre 1 fr. di base fittile policroma modanata in impasto chiaro‑sabbioso con foro di fissaggio, da ritenersi probabilmente una base di statua (Fig. 9; diam. mass. 45 cm, alt. 8,7, spess. 3 cm ca.). Si notano una linea bruna sul margine superiore e tracce di pittura rossa in basso79.
Nel deposito sono anche rari oggetti metallici. Tra questi si segnalano 2 frr. relativi ad un colino in bronzo (US 3173/66‑67) del diam. ricostruibile di cm 7: l’attacco di un manico orizzon‑tale e parte della vasca traforata con almeno 2 fori e un fr. di orlo con tracce di 3 fori passanti. Si segnalano inoltre una borchietta con bordo rialzato (diam. 1,5 cm, US 3277/119) e 1 chiodo con testa conica a calotta.
M.T. D. S.
concluSIonI
L’analisi di questo contesto offre interessanti elementi di riflessione sia in merito alla com‑posizione del deposito e alla circolazione di produzioni ceramiche in età tardo‑arcaica e classi‑ca, sia per una possibile identificazione dell’edificio di pertinenza. I reperti individuati e la loro distribuzione nel riempimento indicano che l’obliterazione del pozzo è stata intenzionale ed è avvenuta in un unico momento. Sorprende l’elevata percentuale di vasellame fine da mensa e l’attestazione di ricettività – sia pur limitata – del contesto veiente per le importazioni pregiate ancora durante il V sec. a.C.
77 2 frr. di nimbo combaciano (US 3275/735, RP 1126 e US 3276/8, RP 1074).
78 Il fr. è citato in dI GIuSeppe 2008, p. 74. Per le attestazioni di antefisse con Acheloo a Portonaccio vd. colonna 1987, pp. 437‑441; cIoncolonI feruz-
zI - MarcHIorI 1989‑1990, pp. 714‑715.79 Per la forma: Mura SoMMella 2011, p. 200,
fig. 11, acroterio di Dioniso e Arianna dalla II fase del tempio del Foro Boario.
Fig. 8 – Frammento di antefissa con testa di Acheloo. Fig. 9 – Frammento di base fittile policroma.
estratto
122 M.T. D’Alessio – M.T. Di Sarcina Sc. Ant.
Molto interessante per l’interpretazione e la cronologia è il confronto con il riempimento del pozzo scoperto sulla collina di Comunità80. La composizione del deposito, che annoverava più di 20.000 frammenti tra ceramica vascolare (88%), materiale edilizio (11%) e instrumen-tum (1%), ha suggerito un’interpretazione in chiave sacrale sia del contesto di provenienza dei reperti che dell’attività di obliterazione della struttura. Nel contesto di Macchiagrande i reperti sono riconducibili per la maggior parte a forme aperte in bucchero grigio e ceramica acroma, con una notevole presenza di vasellame in impasto chiaro‑sabbioso, coarseware e internal slip ware per la preparazione, cottura e conservazione dei cibi. La ceramica a bande ha invece una attestazione limitata in entrambi i contesti ma sembra indicare una valenza cultuale.
I reperti rinvenuti, così come quelli di Casale Pian Roseto e Porta Caere sono associati a materiali databili entro la metà del IV sec. a.C. e sono relativi soprattutto a olle con labbro di‑stinto e rilevato all’esterno attestate anche nel cunicolo scoperto a Porta Nord‑Ovest81. In tutti questi contesti, a fronte della presenza di prodotti di lusso, si registra la quasi totale assenza di elementi di decorazione architettonica riconducibili ad edifici monumentali cui riferire queste attività, probabilmente connesse allo svolgersi di pratiche rituali. L’edificio E (Fig. 2), indagato come detto solo in parte, sembra contenere il pozzo analizzato e gli altri due simili all’interno di un’area verosimilmente scoperta: una sorta di corte antistante due ambienti comunicanti tra loro e delimitati da muri a doppio filare di blocchi, gli unici con questa peculiarità costruttiva in tutta l’area. Poco sappiamo ancora sulla natura di questo edificio di cui abbiamo scavato ad oggi solo le attività di abbandono contenenti tra l’altro molti elementi di un tetto tra cui forse 2 frr. di acroteri depositati in una piccola fossa.
L’analisi dei reperti individuati nel pozzo consente di fissarne la chiusura entro la metà del IV sec. a.C., se non – più significativamente per la storia di Veio – agli inizi dello stesso. Manca‑no infatti del tutto indicatori più recenti quali le ceramiche sovradipinte presenti invece nell’a‑nalogo contesto di Comunità82. La datazione del materiale di Macchiagrande assume inoltre un interesse particolare anche in relazione alla consistente presenza di ceramiche databili tra V e IV sec. a.C. come la vernice rossa opaca, la vernice nera ad imitazione della ceramica attica e l’internal slip ware.
M.T. D’A. ‑ M.T. D. S.
Maria Teresa D’AlessioDipartimento di Scienze dell’Antichità
Sapienza Università di [email protected]
Maria Teresa Di SarcinaSoprintendenza Speciale per i beni archeologici di Roma
80 belellI et al. 2009.81 Murray tHreIpland 1963; caScIno et al. 2012.
82 belellI et al. 2009, pp. 106‑107.
estratto
20.1, 2014 Lo scavo in località Macchiagrande a Veio 123
Riferimenti bibliografici
anGelellI 2001: c. anGelellI, Ceramica d’importazione greca, in p. penSabene - S. fal-zone (eds.), Scavi del Palatino I. L’area sud-occidentale del Palatino tra l’età protostorica e il IV secolo a.C. Scavi e materiali della struttura ipogea sotto la cella del tempio della Vittoria (Studi Miscellanei, 32), Roma 2001, pp. 275‑280.
arIaS - HIrMer 1960: p.e. arIaS, Mille anni di ceramica greca, con fotografie di M. Hirmer, Firenze 1960.
baGlIone 2000: M.p. baGlIone, I rinvenimenti di ceramica attica dal santuario dell’area sud, in ScAnt 10, 2000, pp. 338‑382.
beazley 1963: J.d. beazley, Attic Red-Figure Vase-Painters, 2nd edition, Oxford 1963.beazley 1967: J.D. beazley, Attic Red-Figured Vases in American Museums, Cambridge
1918 (ed. anastatica, Roma 1967).belellI et al. 2009: B. belellI MarcHeSInI - l. aMbroSInI - G. colantonI - b. GIulIanI -
M.r. lucIdI - M. Merlo - a. celant, Il contributo degli scavi di Piano di Comunità alla co-noscenza dell’abitato di Veio: materiali dal riempimento di un pozzo sul pianoro sommitale, in G. bartolonI (ed.), L’abitato etrusco di Veio. Ricerche dell’università di Roma ‘La Sapienza’. I. Cisterne, pozzi e fosse, Roma 2009, pp. 65‑123.
capanna - fatuccI cds.: M.C. capanna - G. fatuccI, Veio Macchiagrande. L’area archeo-logica centrale, in C. SMItH - u. fuSco - r. caScIno (eds.), Novità nella ricerca archeologica a Veio. Dagli studi di John Ward-Perkins alle ultime scoperte, Atti del Convegno (Roma 2013), in stampa.
carafa 1995: p. carafa, Officine ceramiche di età regia, Roma 1995.carafa 1998: P. carafa, Veio: la villa di Campetti e la città romana, in L. draGo troccolI
(ed.), Scavi e ricerche archeologiche dell’Università di Roma “La Sapienza”, Roma 1998, pp. 148‑150.
caScIno - dI SarcIna 2008: R. caScIno - M.t. dI SarcIna, L’Internal Slip Ware nella me-dia valle del Tevere, in H. patterSon - f. coarellI (eds.), Mercator Placidissimus. The Tiber Valley in Antiquity. New research in the upper and middle river valley (Roma 2004), Roma 2008, pp. 559‑585.
caScIno 2012a: r. caScIno, La ceramica di importazione attica, in caScIno et al. 2012, pp. 105‑108.
caScIno 2012b: r. caScIno, Il bucchero, in caScIno et al. 2012, pp. 141‑162.caScIno 2012c: r. caScIno, La ceramica etrusca acroma, in caScIno et al. 2012, pp.
135‑141.caScIno 2012d: r. caScIno, La ceramica etrusca a fasce, in caScIno et al. 2012, pp. 131‑135.caScIno et al. 2012: R. caScIno - H. dI GIuSeppe - H. patterSon (eds.), Veii: the historical
topography of the ancient city: a restudy of John Ward-Perkins’s survey, London 2012.CIE: G. colonna - D.F. MaraS (eds.), Corpus Inscriptionum Etruscarum, fasc. II, 1, 5
et additamentum fasc. II, 2, 1, Inscriptiones Veiis et in agro Veientano, Nepesino Sutrinoque repertae, additis illis in agro Capenate et Falisco inventis, quae in fasciculo CIE II, 2, 1 desunt, nec non illis perpaucis in finitimis Sabinis repertis, Pisa‑Roma 2006.
estratto
124 M.T. D’Alessio – M.T. Di Sarcina Sc. Ant.
CionColoni Ferruzzi - MarChiori 1989-1990: R. CionColoni Ferruzzi - S. MarChiori, I culti del santuario di Veio-Portonaccio alla luce delle testimonianze votive, in ScAnt 3-4, 1989-90, pp. 419-446.
Colonna 1987: G. Colonna, Note preliminari sui culti del santuario di Portonaccio a Veio, in ScAnt 1, 1987, pp. 419-446.
Colonna 2002: G. Colonna (ed.), Il santuario di Portonaccio a Veio 1. Gli scavi di Massi-mo Pallottino nella zona dell’altare (1939-1940), MonAntLinc VI, 3, Roma 2002.
CriStoFani 1969: M. CriStoFani, Rivista di epigrafia etrusca, in StEtr XXXVII, 1969, pp. 334, 338-339, 344.
D’aleSSio 2001: M.T. D’aleSSio, I.C. Veio. Macchiagrande - Vignacce, in A.M. Moretti Sgubini (ed.), Veio, Cerveteri, Vulci. Città d’Etruria a confronto, Catalogo della Mostra (Roma 2001), Roma 2001, pp. 17-22.
D’aleSSio 2010: M.T. D’aleSSio, Macchiagrande - Case etrusche e Foro di età romana, in Guida archeologica del Parco di Veio, Roma 2010, pp. 64-65.
D’aleSSio cds: M.T. D’aleSSio, Il contributo dello scavo in località Macchiagrande alla ricostruzione dei paesaggi urbani di Veio tra l’età del Ferro e la tarda età imperiale, in C. SMith - u. FuSCo - r. CaSCino (eds.), Novità nella ricerca archeologica a Veio. Dagli studi di John Ward-Perkins alle ultime scoperte, Atti del Convegno tenutosi a Roma (Roma 2013), in corso di stampa.
De luCia brolli 2006: M.A. De luCia brolli, Dalla tutela alla ricerca: recenti rinveni-menti dall’area urbana di Falerii, in M. PanDolFini angeletti (ed.), Archeologia in Etruria meridionale, Atti delle giornate di studio in ricordo di Mario Moretti (Civita Castellana 2003), Roma 2006, pp. 65-90.
Di giuSePPe 2008: H. Di giuSePPe, Acheloo e le acque deviate, in H. Di giuSePPe - M. Ser-lorenzi (eds.), I riti del costruire nelle acque violate, Atti del convegno internazionale (Roma 2008), Roma 2008, pp. 69-90.
Di Mario 2005: F. Di Mario (ed.), Ardea. Il deposito votivo di Casarinaccio, Roma 2005.Di SarCina 2012: M.t. Di SarCina, L’edificio tardo arcaico di Casale Pian Roseto, in I. van
KaMPen (ed.), Il nuovo Museo dell’Agro Veientano a Palazzo Chigi di Formello, Roma 2012, pp. 131-135.
Di SarCina 2012a: M.T. Di SarCina, La ceramica d’impasto rosso, in CaSCino et al. 2012, pp. 179-201.
Di SarCina 2012b: M.T. Di SarCina, La ceramica d’impasto da mensa e da dispensa di età orientalizzante ed arcaica, in CaSCino et al. 2012, pp. 201-219.
Di SarCina 2012c: M.T. Di SarCina, La ceramica d’impasto chiaro-sabbioso, in CaSCino et al. 2012, pp. 219-229.
Di SarCina 2012d: M.T. Di SarCina, L’Internal Slip Ware, in CaSCino et al. 2012, pp. 229-235. Fortunelli - MaSSeria 2012: S. Fortunelli - C. MaSSeria (eds.), Ceramica attica da san-
tuari della Grecia, della Ionia e dell’Italia, Atti del Convegno internazionale (Perugia 2007), Venosa 2009.
gori - Pierini 2001: b. gori - t. Pierini, Gravisca. Scavi nel santuario 12.1. La ceramica comune. Ceramica comune d’impasto, Bari 2001.
estratto
20.1, 2014 Lo scavo in località Macchiagrande a Veio 125
MantIa 2002: R. MantIa, Ceramica etrusca a vernice nera e a vernice rossa, in G. baGna-Sco GIannI (ed.), Cerveteri. Importazioni e contesti nelle necropoli, Milano 2002, pp. 461‑466.
MartellI 1989: M. MartellI, La ceramica greca in Etruria: problemi e prospettive di ri-cerca, in G. Maetzke (ed.), Atti del Secondo Congresso Internazionale Etrusco (Firenze 1985), Roma 1989, pp. 781‑811.
Moore 1998: M.B. Moore, Corpus Vasorum Antiquorum. The J. Paul Getty Museum- Malibu. Fascicule 8 (U.S.A. fascicule 33), III I Attic Red-figured Vases, California 1998.
Mura SoMMella 2011: A. Mura SoMMella, Roma. Le lastre di rivestimento con sfilate di guerrieri e di divinità nel tempio arcaico del Foro Boario, in Tetti di terracotta. La decorazio-ne architettonica fittile tra Etruria e Lazio in età arcaica, Atti delle giornate di studio (Roma 2010), Roma 2011, pp. 187‑201.
Murray tHreIpland 1963: l. Murray tHreIpland, Excavations beside the North-West Gate at Veii (1957-1958), part II, in BSR 31, 1963, pp. 33‑73.
Murray tHreIpland 1969: L. Murray tHreIpland, Veii. A deposit of votive pottery, in BSR 37, 1969, pp. 1‑13.
Pyrgi 1989: AA.VV., Pyrgi, scavi nel santuario etrusco (1967-71), in NSc 1988‑89, suppl. II. raSMuSSen 1979: t.b. raSMuSSen, Bucchero pottery from Southern Etruria, Cambridge
1979.SaSSatellI 1993: G. SaSSatellI, Il bucchero e le ceramiche affini come supporto per iscrizioni
e graffiti in area padana, in Produzione artigianale ed esportazione nel mondo antico. Il buc-chero etrusco, Atti del colloquio internazionale (Milano 1990), Milano 1993 pp. 195‑205.
SparkeS - talcott 1970: b.a. SparkeS - l. talcott, The Athenian Agora. Vol. XII,1-2. Black and Plain Pottery, Princeton 1970.
Stanco 1994: E.A. Stanco, Ceramica a vernice rossa, in M. balzano - a. caMIllI (eds.), Ceramica romana. Guida allo studio I, Roma 1994, pp. 91‑104.
torellI 1998: M. torellI, “Stata Mater in agro veientano”. La ‘riscoperta’ di un santuario rurale veiente in loc. Casale Pian Roseto, in StEtr 64, 1998, pp. 113‑134.
torellI - Murray tHreIpland 1970: M. torellI - L. Murray tHreIpland, A semi-subterra-nean building in the Casale Pian Roseto (Veii) area, in BSR 38, 1970, pp. 62‑121.
abStract
The investigations in the area of Veii Macchiagrande have revealed the presence of a permanent settle‑ment for the period from the Iron Age (hut inhabited since the mid ca. ninth century BC) and late antiquity (tomb pits, between the fourth and fifth century AD). The topic of this paper is focused on a important ceramic context of Late‑Archaic and Classical period coming from a well, that revealed ele‑ments relating to ritual practices.
estratto
Edizioni Quasar di Severino Tognon s.r.l.via Ajaccio 41/43 – 00198 Roma
www.edizioniquasar.it
per informazioni e [email protected]
ISSN 1123‑5713
ISBN 978‑88‑7140‑582‑7
Finito di stampare nel mese di novembre 2014presso Global Print – Gorgonzola (MI)
estratto
























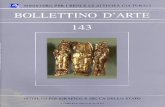



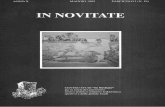
![Reflexiones sobre el concepto de 'publicación' en la Grecia Arcaica: el problema de los tratados en prosa [2005]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6333df82b94d623842026a26/reflexiones-sobre-el-concepto-de-publicacion-en-la-grecia-arcaica-el-problema.jpg)