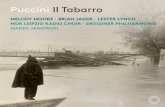Il vescovo e la città. Interessi e conflitti di potere dall'età di dante a Sant'Antonino
U. Fusco, "Il culto di Ercole presso il complesso archeologico di Campetti, area S-O, a Veio...
Transcript of U. Fusco, "Il culto di Ercole presso il complesso archeologico di Campetti, area S-O, a Veio...
nuova serie
Rivista del Dipartimento di Scienze dell’antichità
Sezione di Archeologia classica, etrusco-italica, cristiana e medioevale
Fondatore: giulio q. giglioli
Direzione Scientifica
maria paola baglione, gilda bartoloni, luciana drago, enzo lippolis, laura michetti, gloria olcese,
domenico palombi, maria grazia picozzi, franca taglietti
Direttore responsabile: gilda bartoloni
Redazione:franca taglietti, fabrizio santi
Vol. LXII - n.s. 12011
Estratto
«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER - ROMA
ISBN 978-88-8265-655-3
ISSN 0391-8165
© COPYRIGHT 2011 - SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMAAut. del Trib. di Roma n. 478 del 31 ottobre 2000
Volume stampato con contributo della Sapienza Università di Roma
Archeologia classica : rivista dell’Istituto di archeologia dell’Università di Roma. - Vol. 1 (1949)- . - Roma : Istituto di archeologia, 1949- . - Ill. ; 24 cm. - Annuale. - Il complemento del titolo varia. - Dal 1972: Roma: «L’ERMA» di Bretschneider. ISSN 0391-8165 (1989)
CDD 20. 930.l’05
Comitato Scientifico
pierre gros, sybille haynes, tonio hölscher, mette moltesen, stephan verger
Il Periodico adotta un sistema di Peer-Review
INDICE DEL VOLUME LXII
articoli
p. 127» 41
» 279
» 77» 155
» 7
» 173
» 203
» 357» 413
» 379
arata f.p., felici e., Porticus Aemilia, navalia o horrea? Ancora sui frammenti 23 e 24 b-d della Forma Urbis ................................................
avagliano a., L’Ares tipo Borghese: una rilettura .......................................bocci pacini p., gambaro c., Nummorum imagines circumdatae sunt
armis et tropaeis et aquilis ad ornatum. Antonio Cocchi inventaria le monete degli Uffizi con le incisioni del Piccini alla mano ....................
caruso a., Ipotesi di ragionamento sulla localizzazione del Mouseion di Alessandria ......................................................................................................
despinis G., Frammenti di statue-ritratto equestri loricate da Megara .........mandolesi a., de angelis d., Il tumulo della regina di Tarquinia fra
tradizioni levantine e innovazioni etrusche .................................................marcattili, f. Odore pardi coitum sentit in adultera leo (plin., nat., 8,
42). Etologia ellenistica e cultura urbana in un mosaico iguvino ad Holkham Hall .................................................................................................
pensabene P., Tradizioni punico-ellenistiche a Volubilis. I capitelli corinzi e compositi .....................................................................................................
NOTE E DISCUSSIONI
bellelli v., Ceramiche e bronzi laconici nel mediterraneo arcaico: osser-vazioni su un libro recente da una prospettiva “occidentale” .................
caratelli g., Cori: le sostruzioni di piazza Pozzo Dorico .........................fusco u., Il culto di Ercole presso il complesso archeologico di Campetti,
area S-O, a Veio: testimonianze dall’età etrusca a quella romana .........
indice del volume lxii
p. 537
» 445
» 497
» 309
» 513
» 475
» 467» 489
» 568
» 565
» 590
» 570
» 573
» 557
» 578
» 581
» 593
garofalo p., Rinvenimenti epigrafici negli scavi ottocenteschi del santua-rio di Iuno Sospita a Lanuvium: nuovi dati d’archivio ............................
guiducci F., Il fenomeno dell̓accapo a destra: solo una caratteristica officinale? ........................................................................................................
lilli m., Casale della mandria tra ricerche settecentesche e indagini re-centi. Ancora una villa dal settore meridionale dell’ager lanuvinus .......
Lo schiavo f., milletti m., Una rilettura del ripostiglio di Falda della Guardiola, Populonia (LI) .............................................................................
manderscheid h., carboni f., bruno m., Tabulae lusoriae del mondo romano: il tavoliere dei muratori di Villa Adriana, tabulae dalle Terme di Traiano a Roma e dal complesso severiano di Leptis Magna ...........
pensabene p., gallocchio e., Contributo alla discussione sul complesso augusteo palatino ............................................................................................
romualdi a., Ancora sulla fibula da Populonia con statuetta di argento inserita nell’arco .............................................................................................
tamassia a.m., Un ritratto maschile da Suzzara (Mantova) .......................
RECENSIONI E SEGNALAZIONI
anguissola a., Intimità a Pompei: riservatezza, condivisione e prestigio negli ambienti ad alcova di Pompei (i. bragantini) ............................
boardmann J. with scarisbrick d., Wagner c., zWierlein-diehl e., The Malborough Gems formerly at Blenheim Palace, Oxfordshire (l. pirzio biroli stefanelli) .................................................................................................
cantino Wataghin g., colombara c. (a cura di), Finem dare. Il con-fine tra sacro, profano e immaginario. A margine delle stele bilingue del Museo Leone di Vercelli (r. knobloch) ...........................................
malacrino c.g., Ingegneria dei Greci e dei Romani, trad. dall’inglese Constructing the Ancient World. Architectural techniques of the Greeks and Romans (p. pensabene) .......................................................................
picozzi m.g. (a cura di), Palazzo Colonna. Appartamenti. Sculture antiche e dall’antico (D. manacorda) ..................................................................
scheid J. (ed.), Pour une archéologie du rite. Nouvelles perspectives de l’archéologie funérarie (c. vismara) ........................................................
valenti m. (a cura di), Monumenta. I mausolei romani tra commemora-zione funebre e propaganda celebrativa (p. pensabene) ........................
vistoli f. (a cura di), La riscoperta della Via Flaminia più vicina a Roma: storia, luoghi, personaggi (m. carrara, m. piranomonte) ...............
Pubblicazioni ricevute ............................................................................................
ArchCl LXII, 2011, pp. 379-412
IL cuLto dI ErcoLE prEsso IL compLEsso archEoLo-gIco dI campEttI, arEa s-o, a VEIo: tEstImonIanzE
daLL’Età Etrusca a quELLa romana*
nel presente studio sono analizzati alcuni reperti - frammenti fittili pertinenti ad una statua o ad un gruppo e un’iscrizione votiva – rinvenuti negli scavi effettuati presso il sito di campetti, area s-o, nell’ambito delle attività di ricerca del “progetto Veio” nato dalla con-venzione tra sapienza, università di roma - dipartimento scienze storiche archeologiche e antropologiche dell’antichità – e il ministero per i Beni e le attività culturali – soprin-tendenza per i Beni archeologici per l’Etruria meridionale (Fig. 1, n. 5). L’area archeologica in esame è localizzata all’interno del pianoro dell’antica Veio in posizione periferica, vicino alla porta delle mura etrusche detta «porta di portonaccio», e a meno di 1 Km in linea d’aria dal centro del municipio romano (Fig. 2). occupa attualmente un’area di circa 10.000 m² ed è articolata su due livelli o terrazze (Fig. 3). I nuovi scavi, iniziati a settembre 1996 e terminati nel mese di ottobre 2009, hanno individuato una complessa sequenza stratigrafica riepilogabile in 8 periodi, composti a loro volta da Fasi edilizie1, che coprono l’arco crono-logico dalla fine del IX sec. a.c. fino all’età moderna. L’area archeologica è sostanzialmente inedita e finora sono stati pubblicati alcuni studi sui diversi tipi di strutture e reperti rinve-nuti2. I seminari per l’elaborazione e l’analisi della documentazione di scavo e dei materiali archeologici, finalizzati all’edizione integrale dello scavo, sono tuttora in corso3.
I reperti in esame appartengono a due diversi periodi della storia del sito: i fram-menti fittili al periodo II (seconda metà VII - inizi IV sec. a.c.) e l’iscrizione votiva al
* desidero ringraziare il prof. a. carandini, direttore scientifico dello scavo; il prof. p. carafa per l’in-teresse che ha manifestato nel seguire la ricerca; la prof.ssa m. Bonamici e il prof. g. colonna per i loro pre-ziosi consigli; la prof.ssa g. Bartoloni per avermi offerto l’opportunità di pubblicare lo studio in questa sede; i membri del gruppo di scavo e di studio del sito di campetti: c. attanasio ghezzi, L. camerlengo, o. cera-suolo, m.t. di sarcina, m. gristina, t. Latini, B. Lepri, c.m. marchetti, F. soriano e V. zeppieri. Le foto sono dell’autore tranne la Fig. 2 concessa dal prof. m. guaitoli a seguito delle riprese dall’elicottero effettuate nell’ottobre 2006; la Fig. 11 di o. cerasuolo e le Figg. 3-5, 26, elaborate da F. soriano.
1 per questa metodologia di analisi della sequenza stratigrafica si veda: Carandini 2000, pp. 140-143 e, più recentemente, ManaCorda 2008, pp. 162-183.
2 si veda la bibliografia riportata in FusCo 2008-2009, p. 448, nota 18 e come ultime pubblicazioni: FusCo 2010; FusCo, MarChetti 2010 e FusCo c.d.s.
3 sulle difficoltà e i lunghi tempi connessi all’edizione di un sito archeologico pluristratificato secondo una meto-dologia appropriata si vedano le osservazioni di GianniChedda 2007, pp. 52-53 e ManaCorda 2008, pp. 235-238.
380 note e disCussioni
Fig. 1. pianta con la localizzazione delle aree sacre di Veio (da Colonna 2009, fig. 1).
note e disCussioni 381
Fig. 2. Veio, il sito di campetti al termine della campagna di scavo 2006. In basso a sinistra il Fosso piordo e il mulino (da prof. m guaitoli).
Fig. 3. pianta interperiodo del sito in esame con indicati i due livelli o terrazze.
382 note e disCussioni
periodo IV (fine I sec. a.c. - prima metà II sec. d.c.). mentre i primi reperti sono inediti e quindi saranno oggetto di un’analisi approfondita, l’epigrafe è già stata presentata in un precedente studio4 e in questa occasione sarà descritta sinteticamente al fine di far emergere gli elementi di contatto con i ritrovamenti più antichi. si cercherà inoltre di terminare il lavoro ponendo in risalto gli elementi di continuità e discontinuità tra il san-tuario del periodo II e il complesso archeologico del periodo IV, interpretato come area termale, terapeutica e cultuale.
il CoMplesso arCheoloGiCo nel periodo ii
prima di iniziare l’analisi dei reperti si ritiene opportuno proporre alcune riflessioni sulla funzione del sito in esame. queste preliminari interpretazioni sono ricavate dai dati elaborati in nostri precedenti studi5, da una recente pubblicazione di g. colonna per-tinente a un reperto fittile proveniente dallo scavo6 e dai primi risultati dei seminari di studio in corso7.
Il sito archeologico nel periodo II è interpretabile come un santuario urbano edifi-cato vicino ad una porta della città8, secondo un sistema già attestato non solo a Veio9 (Fig. 1) ma anche in altri casi10. gli scavi hanno mostrato la presenza di ampi edifici e di piccole strutture in entrambi i livelli del sito, rivelando una complessa organizzazione degli spazi precedentemente sconosciuta (Fig. 4). Il livello o terrazza inferiore, nel quale si è maggiormente preservato il patrimonio stratigrafico di tipo orizzontale e verticale, è caratterizzato dalla presenza, a partire dalla fine del VII - inizio VI sec. a.c., di un ampio recinto ipetrale (m 25 × 29 circa; area: m² 725 circa), orientato E-o e di cui si conserva-no solo i filari di fondazione11. risultano scarsamente conservati: il lato o, in quanto fra-nato nella sottostante valle del Fosso della mola in seguito alla progressiva erosione dei limiti del pianoro; i lati n ed E a causa delle asportazioni avvenute durante le successive
4 FusCo 2008-2009, pp. 451-475.5 FusCo, Cerasuolo 2001; FusCo 2006.6 Colonna 2009.7 I seminari sul periodo II sono sviluppati insieme a c. attanasio ghezzi, o. cerasuolo, m.t. di sarcina
e t. Latini.8 sulla struttura: Ward-perkins 1961, pp. 8-11 e fig. 2 e da ultimi Cerasuolo, pulCinelli 2006, p.
104 e fig. 6.9 sulla corona di santuari interni alla città e localizzati in aree marginali e prossime alle porte, si veda:
CIE II, sez. 2, fasc. V, pp. 12-13; Belelli MarChesini 2009, p. 122; Bartoloni, Benedettini 2011, p. 782, con bibl. prec. per recenti sintesi storico-archeologiche sulla città di Veio in età etrusca: CaMporeale 2000, pp. 215-223; Boitani 2008; Van kaMpen 2008; Bartoloni 2010. sul concetto di santuario etrusco, vd. da ultima edlund-Berry 2011, in particolare p. 10.
10 In generale Colonna 1985, pp. 67-68; edlund 1987, p. 41; edlund-Berry 2011, p. 10. sui santua-ri “di margine” della città di cerveteri: CristoFani 2000, pp. 409-420.
11 prime notizie in FusCo, Cerasuolo 2001, p. 10, indicato come edificio B. La struttura è completa-mente obliterata dalle attività di colmatura e sistemazione dell’area nel periodo III (II-I sec. a.c.). su questa tipologia di edificio: Colonna 2006, pp. 143-146.
Fig.
4. p
iant
a sc
hem
atic
a de
l per
iodo
II (F
asi 1
-6) c
on in
dica
ti i p
rinci
pali
edifi
ci (r
iela
bora
zion
e da
Fu
sCo
200
6).
384 note e disCussioni
attività edilizie (Fig. 5). La costruzione presenta un ingresso monumentale sul lato s e una semplice apertura a n12 e nel corso delle fasi edilizie del periodo II è dotato di altre strutture al suo interno e nelle immediate adiacenze (F, g e a, c, d; Fig. 4), le quali sono da considerare in stretta relazione con l’edificio principale13. all’interno del recinto sono da menzionare diverse strutture collegate con l’acqua come: pozzi e una cisterna14 (Fig. 4). tra i reperti già editi e attribuibili al santuario, si ricordano: un frammento di statua fittile policroma, interpretato da g. colonna come elemento di un gruppo statuario raffi-gurante Enea e anchise (Figg. 6a-b, 7) e datato nei primi due o al massimo tre decenni del V sec. a.c.15; un frammento fittile dipinto relativo ad un louterion16; alcune terre-cotte architettoniche riferibili agli edifici costruiti a partire dalla prima metà del VI sec. a.c.17 e un’iscrizione18. Le strutture del livello superiore, di cui al momento è incerto il collegamento con il santuario descritto, sono conservate in maniera limitata a causa delle trasformazioni edilizie attestate a partire dal periodo III e dalle moderne attività agrico-le19. comunque anche in questa terrazza si distinguono diversi edifici (ad esempio I, Fig. 4) e strutture collegate con l’acqua (cisterne, pozzi e canalette; Fig. 4).
Il recinto della terrazza inferiore costituisce il monumento di maggior interesse e si ritiene opportuno proporre alcuni confronti, considerando come elementi discriminanti la planimetria e la localizzazione. È possibile menzionare il santuario di campetti, area n-E, oggetto di scavi parziali nel 1937-38, 1947 e 196920 (Figg. 1, n. 8; 8) e costituito da un recinto ipetrale in blocchi di tufo (dimensioni: m 20 × 17; area: m² 340, Fig. 8, edificio A), conservato per tre lati e con orientamento E-o. nei pressi della struttura sono emersi anche un edificio in blocchi di tufo, forse coperto (Fig. 8, struttura B) e una grotta, che si ritiene sia stata utilizzata come deposito di ex-voto del santuario. una serie di dati costitu-iti dalla presenza del recinto ipetrale, presumibilmente utilizzato per cerimonie all’aperto, dal tipo di materiale votivo rinvenuto, databile tra la fine del VI e il II sec. a.c. (Fig. 8, scarico), dalla grotta, oggetto di ristrutturazioni tra il IV e il III sec. a.c. come mostrano una serie di deposizioni di vasi interpretate come offerte di fondazioni21, ed infine il con-fronto con i santuari siciliani dedicati al culto di Demetra Thesmophoros, hanno portato
12 FusCo, Cerasuolo 2001, p. 10.13 Vd. sul tema da ultima edlund-Berry 2011, pp. 9 e nota 20 con bibl. prec., 12.14 per la presenza nei santuari di apprestamenti idrici finalizzati a pratiche rituali e curative, si vedano in
generale le osservazioni di edlund 1987, p. 41; prayon 1993, pp. 413, 419; pilo 2006, pp. 121-122; FaC-Chinetti 2009, pp. 43-47 e edlund-Berry 2011, p. 11.
15 Colonna 2009 e per la possibile presenza di un ulteriore gruppo statuario dedicato all’eroe, cfr. pp. 66-67 e nota 83.
16 proietti 1977. si vedano anche le osservazioni di Colonna 2009, p. 54 e nota 17 con bibliografia precedente.
17 FusCo 2001a, pp. 14-15, nn. I.B.18-19.18 CIE, 6342; la sigla etrusca rinvenuta su un calice di bucchero è interpretata da g. colonna come teoni-
mo Ha(rθan)/Fa(rθan) equivalente a “progenitore”, Pater Indiges: Colonna 2009, p. 54, nota 19.19 sul toponimo campetti da collegare al suo utilizzo agricolo: Colonna 2009, p. 53, nota 12.20 si veda in generale: pallottino 1938-1939; VaGnetti 1971; CoMella, steFani 1990; BouMa
1996, pp. 104-106; Carosi 2002.21 Carosi 2002, p. 366.
note e disCussioni 385
gli studiosi a considerare quest’area come l’unico thesmophorion d’Etruria, dedicato ini-zialmente al culto di una divinità ctonia, di origine straniera e di stampo plebeo, demetra, a cui si sarebbero sovrapposte l’etrusca Vei e, a partire dal IV sec. a.c., la romana Ceres22.
un ulteriore confronto, anche se cronologicamente più tardo, è con il santuario del pozzarello a Bolsena23. Esso è edificato a ridosso del percorso delle mura e risulta dotato di un ampio recinto rettangolare in blocchi di tufo (m 37,50 × 43,60; area: m² 1.635), orientato nE-so e frequentato, in base ai materiali presenti nei depositi votivi, a partire dalla metà del III sec. a.c. e fino al III sec. d.c.24. La divinità venerata nel santuario è stata inizialmente riconosciuta in Nortia, poi in Selvans e, più recentemente, in una divi-nità ctonia vicina a cerere/demetra25.
22 oltre alla bibliografia precedentemente citata, si veda anche: torelli 1973, pp. 403-404; id. 1986, pp. 189, 197.
23 GaBriCi 1906; aCConCia 2000.24 alla fine del I sec. a.c. è attestata una fase di ristrutturazione dell’area che comporta la costruzione di
un nuovo recinto in opera quasi reticolata e reticolata: aCConCia 2000, pp. 143-149. 25 aCConCia 2005 e Colonna 2006, p. 146.
Fig. 5. pianta schematica del recinto con localizzazione dei depositi votivi (1-5).
386 note e disCussioni
per quanto concerne il santuario in esame, a causa dell’assenza di iscrizioni dedicate a specifiche divinità e/o di consistenti depositi votivi in grado di indirizzare, almeno, l’individuazione della/e divinità titolare/i del culto, come negli altri casi di Veio26, è ipo-
26 Il santuario di campetti, area n-o (Fig. 1, n. 6), è dedicato a minerva (torelli, pohl 1973; Buo-Ma 1996, pp. 106-107); il santuario di campetti, area n-E (Fig. 1, n. 8), come visto a demetra-Vei-cerere;
Figg. 6a-b. Frammento di statua fittile policroma (foto autore).
note e disCussioni 387
tizzabile una generica funzione protettiva, forse in connessione con i riti di passag-gio e con funzioni iniziatiche e di purifi-cazione, in considerazione della localizza-zione urbana e prossima al confine della città27. al momento quindi sarebbe atte-stato solo un culto dedicato ad Enea, se si considera valida la ricostruzione proposta da g. colonna28, ma ulteriori spunti di riflessione possono giungere dall’analisi dei nuovi reperti fittili.
il Contesto di ritroVaMento dei reperti Fittili
I reperti sono stati rinvenuti durante le indagini svolte nel settore a 18 del livello inferiore, nell’us 499929 localizzata all’in-terno del recinto (Fig. 5, n. 5). L’unità stra-tigrafica in esame (Figg. 10-11) è coperta dai livelli di obliterazione e innalzamento del piano di calpestio riferibili al periodo III e occupa un’area di circa 5 m². Lo strato è delimitato sui lati E, s, o dall’usm 1943, una sottile struttura in opera cementizia con funzione di fondazione per il passaggio di una conduttura idrica per l’alimentazione dell’edificio a del periodo IV, e a n dalle fondazioni dello stesso edificio (Fig. 5).
il santuario di macchia grande (Fig. 1, n. 10) ad apollo, minerva, Victoria, Iuppiter Libertas, Dii Dea(que), Pitumnus ed Ercole (torelli 1988, p. 69; BouMa 1996, p. 111 con bibl. prec.; CIE II, sez. 2, fasc. V, p. 13); il deposito di pendici di comunità (Fig. 1, n. 2), riferibile forse a giunone-demetra-cerere (Bartoloni, Bene-dettini 2011, pp. 782-790). per recenti considerazioni sui depositi votivi di obliterazione a Veio: naGy 2011, pp. 113-119. sulla difficoltà di individuare la divinità titolare di un culto in base all’analisi degli ex-voto rinve-nuti nel santuario: pilo 2006, p. 121. L’assenza di un ampio e articolato deposito votivo nel sito di campetti, area s-o, potrebbe essere causata dalla sua obliterazione in seguito all’intensa attività edilizia dei periodi III-V, o dalla sua localizzazione in un’area esterna a quella fino ad ora oggetto di indagine archeologica.
27 Colonna 1985, p. 68; edlund 1987, p. 137.28 per le motivazioni politiche in funzione antiromana dell’adozione del culto di Enea da parte della
comunità veiente nel V sec. a.c.: Colonna 2009, p. 72. per ulteriori attestazioni del culto dell’eroe a Veio: VaGnetti 1971, p. 171; torelli 1973; CoMella, steFani 1990, pp. 175, 188; Colonna 2009, p. 63 e, in particolare, nota 70.
29 Lo scavo è stato condotto da o. cerasuolo e c. attanasio ghezzi.
Fig. 7. ricostruzione del gruppo statuario secon-do g. colonna (da Colonna 2009, fig. 21).
388 note e disCussioni
non è possibile ricostruire l’originaria estensione dell’us: i limiti sono originali sui lati o e, probabilmente, E mentre quelli n e s sono stati oggetto di successive attività di asportazio-ne30. L’us in esame presenta diverse tracce di carbone ed è costituita quasi esclusivamente da materiale edilizio (in particolare lastre architettoniche di II fase), ceramico e da alcuni frammenti fittili policromi (Fig. 12). Il contesto è caratterizzato da materiali con alto tasso di frammentarietà: i reperti più antichi sono alcuni frammenti protostorici31 mentre quelli più tardi sono databili tra la fine del V e gli inizi IV sec. a.c.32. Il margine di definizione dello
30 La costruzione dell’edificio a, posto a n dell’us 4999 (Fig. 5), ha comportato l’asportazione completa della stratigrafia precedente e una situazione simile è riscontrabile anche a s, ove una trincea moderna, rea-lizzata per il posizionamento di una tubatura in cemento per il deflusso delle acque meteoriche di una vicina cisterna, ha sconvolto la stratigrafia esistente.
31 Frammenti di impasto bruno con decorazione a falsa cordicella.32 si tratta principalmente di frammenti di calici, coppette, olle globulari, scodelle in bucchero grigio. ringrazio
Fig. 8. pianta del santuario di campetti, area n-E (da pallottino 1938-1939, p. 402).
note e disCussioni 389
strato in esame con il piano di calpestio sottostante, un battuto in terra (us 5321), è netto. In considerazione della peculiare concentrazione di materiale archeologico, della tipologia dei reperti e del loro tasso di frammentarietà33 si propende per interpretare il contesto non come uno strato di crollo ma come un deposito votivo di tipo secondario, secondo la definizione di a. comella34. potrebbe trattarsi cioè di un accumulo di materiale archeologico vario, la
m.t. di sarcina, responsabile per lo studio dei materiali del periodo II, per avermi anticipato i dati del suo lavoro.33 Indizio di una loro probabile giacitura secondaria, a riguardo vd. GianniChedda 2007.34 CoMella 2005, p. 227. per ulteriori considerazioni sui diversi tipi di depositi votivi si veda: BouMa
1996, pp. 43-51 e BonGhi JoVino 2005 con bibliografia precedente. I pochi elementi stratigrafici a disposizio-ne non consentono di definire con sicurezza la modalità di delimitazione dello spazio (naturale o artificiale) del deposito in esame, per cui si può solo ritenere che esso sia di tipo naturale, probabilmente una depressione del terreno; su questo tema: BaGnasCo Gianni 2005.
Fig. 9. pianta del santuario del pozzarello a Bolsena (da GaBriCi 1906, fig. 3).
390 note e disCussioni
Fig. 10. L’us 4999 durante le attività di scavo (foto autore).
Fig. 11. particolare dei reperti fittili in esame al momento della sco-perta (foto o. cerasuolo).
maggior parte del quale utilizzato originariamente per la decorazione di edifici e per il cul-to, raccolto e deposto in questo punto in coincidenza con l’abbandono o l’obliterazione del santuario in occasione delle attività edilizie e di risistemazione dell’area nel periodo III, per evitarne la violazione o la dispersione35.
35 secondo quest’ultima interpretazione il deposito in esame sarebbe da classificare come “deposito di obliterazione”, in base allo schema presente in BonGhi JoVino 2005, pp. 34 e 40-43, ed inoltre gli elementi
note e disCussioni 391
L’indagine archeologica ha portato alla luce nel livello inferiore altri quattro piccoli depositi votivi in relazione al recinto e alle strutture adiacenti: due (Fig. 5, nn. 1-2) sono da considerarsi di tipo primario, cioè posti in seguito a rituali di celebrazione e fondazio-ne o obliterazione di edifici, e due (Fig. 5, nn. 3-4) di tipo secondario36.
i reperti: desCrizione, interpretazione e CronoloGia
I frammenti fittili rinvenuti sono otto (Fig. 12), di cui alcuni (c-c1 e B-B1) comba-cianti (Figg. 14a-16) e presentano un tipo di argilla 5Yr 5/1 (gray) costituita da nume-
cronologici più recenti del contesto costituiscono il terminus post quem per la sua formazione. 36 I depositi votivi 1, 2, 4 sono in corso di studio da parte di o. cerasuolo.
Fig. 12. I reperti fittili (foto autore).
392 note e disCussioni
rosi inclusi di augite, mica e pietrisco; cottura omogenea; interno cavo, spessore pareti cm 1-2,5; modellazione a mano. si differenzia il reperto d, realizzato con un’argilla 2.5Yr 8/4 (pale yellow) costi-tuita da augite e pietrisco e realizzato a matrice. Il trattamento delle superficie risulta abbastanza accurato, la lisciatura è omogenea e si registrano tracce di ingub-biattura (frammenti a, B-B1, c-c1, E).
reperti:a (Fig. 13): Frammento pertinen-
te ad occhio sinistro (dim: h. cm 5, l. cm 4) di cui si conserva parte del sopracci-glio. La fronte aggrottata, come attestano due rughe, è indizio di un’espressione di paura o sbigottimento nel volto del perso-naggio. Il contorno degli occhi, la pupilla e le sopracciglia sono dipinte di nero con tratto spesso e pastoso. un confronto tipo-
logico e cronologico è proponibile con l’occhio dell’antefissa a testa di dea elmata, di età tardo arcaica, rinvenuta alle pendici di piano di comunità, a Veio37.
B-B1 (Figg. 14a-b): Frammenti pertinenti ad arto inferiore destro. si distinguono la parte posteriore della coscia e parte della gamba. sulla coscia (h. cm 13, largh. cm 10), su cui si conserva l’accenno del gluteo, è visibile una zampa di leone (h. cm 4, largh. cm 3) dipinta con lo stesso colore giallo del reperto d. Il contorno e le unghie sono rese con colore nero. tracce di pittura 2.5Yr 7/3 (pale yellow). La gamba (h. cm 7, l. cm 16) è conservata fino al polpaccio mentre mancano la cavaglia e il piede. Il polpaccio è rappre-sentato gonfio, ad indicare lo sforzo a cui è sottoposto il personaggio in quel momento. La parte anteriore della gamba è piana (largh. cm 7) e nella parte laterale si nota una frattura con ai lati tracce di colore nero, indizio che la gamba si legava originariamente ad un altro oggetto o figura decorata con colore nero. I frammenti presentano tracce di steccatura.
c-c1 (Figg. 15a, 16): Frammento di avambraccio sinistro (l. cm 18) terminante con la mano che stringe energicamente un oggetto di colore nero. questo elemento prosegue sotto la mano terminando in una forma arrotondata e leggermente concava (l. cm 3, lar-gh. cm 4). sono presenti chiari indizi del suo proseguimento al di sopra della mano, con una larghezza maggiore (largh. cm 6, spess. max cm 2,8). L’identificazione dell’oggetto è incerta (Fig. 15b): si potrebbe pensare all’impugnatura di un elemento (spada? meno probabile clava) o a parti anatomiche (corno? orecchio?) di un’altra figura (un animale?). La modellazione della mano e delle dita trova un confronto stringente con quella attesta-ta nel reperto fittile già edito e datato su basi stilistiche all’inizio del V sec. a.c.38
37 CarluCCi 2004, pp. 218-219, fig. 10.38 Colonna 2009, p. 57.
Fig. 13. particolare del frammento a (foto autore).
note e disCussioni 393
d (Figg. 17-19): Frammento di protome leonina (h. cm 5, largh. cm 4,5), lavorata a matrice e applicata in un secondo momento alla statua. sul reperto dopo la cottura è stato steso uno strato omogeneo di pittura di colore giallo (5Yr 8/3, pale yellow) e con una certa schematicità disegnati, con tratti di colore nero, i dettagli anatomici della fiera: la criniera, le orecchie, gli occhi e il naso, a cui è dedicata una maggiore cura.
E (Fig. 12) e F (Fig. 12): si tratta di frammenti di piccole dimensioni (E: h. cm 8, largh. cm 5; F: h. cm 5, largh. cm 3) e non forniscono ulteriori informazioni.
I frammenti B-B1 e d sono gli unici riferibili alla stessa statua, mentre per gli altri l’attribuzione può essere soltanto ipotetica. La protome leonina e la zampa riferibile alla fiera consentono di identificare il personaggio raffigurato con Ercole-hercle39. La for-ma liscia e distesa della protome, la presenza della zampa distesa sulla coscia destra e una serie di confronti iconografici consentono di ricostruire l’immagine dell’eroe come
39 La bibliografia sull’eroe è vastissima e per un inquadramento storico ed archeologico si veda da ultimi: Coarelli 2009 e sChWartz 2009, pp. 244-246, con bibl. prec.
Figg. 14a-b. dettaglio del frammento B-B1 (foto autore).
394 note e disCussioni
a torso nudo, con la leonté avvolta sui fianchi come un perizoma, le zampe posteriori dell’animale pendenti sulle cosce (frammento B1) e la protome leonina (frammento d) utilizzata a copertura del bacino e del sesso. tra i confronti a sostegno di questa ipotesi si ricorda: la statua fittile di Ercole (Fig. 20), raffigurato insieme a minerva, presso il san-tuario di portonaccio a Veio40; alcuni bronzetti come quello di castelbellino41 (Fig. 21), l’esemplare rinvenuto presso il santuario della cannicella ad orvieto42 e quello conser-vato presso l’Ermitage43 ed infine alcuni specchi come l’esemplare rappresentante l’eroe in compagnia di minerva nel giardino delle Esperidi44 (Fig. 22) o quello con l’eroe in lotta con acheloo45, antica divinità fluviale e delle acque correnti (Fig. 23). questa ico-nografia di Ercole risulta ben attestata in Etruria ed Italia centrale a partire dalla tarda età arcaica e fino all’inizio dell’ellenismo46 e secondo g. colonna il tipo di costume indos-
40 Colonna 2001a, pp. 67-68, n. I.F.5, l’autore propone che questo costume sia indossato anche da un altro torso di statua, proveniente dal medesimo santuario, e raffigurante probabilmente l’eroe: pp. 65-66, n. I.F.4, 560-550 a.c.; CarluCCi 2008a, p. 207, n. 19; sChWartz 2009, p. 254, n. 47. Il reperto è datato al 510-500 a.c.
41 Colonna 1970, pp. 26-26, n. 2 tav. III; id. 1987a, p. 21, fig. 51; sChWartz 1990, p. 200, n. 17. La cronologia del reperto è posta ad inizio V sec. a.c.
42 Colonna 1987b, p. 17, fig. 14: la statuettà è datata ad età tardo arcaica.43 Colonna 1987a, p. 21, fig. 48. ulteriori testimonianze di confronto pertinenti a candelabri in bronzo
in sChWartz 1990, p. 166, nn. 40 (450-400 a.c.), 42 (475-450 a.c.).44 Colonna 1987a, p. 21, nota 34 con bibl. prec.; sChWartz 1990, p. 176, n. 264. La cronologia propo-
sta è 400 a.c.45 Colonna 1987a, p. 21, nota 34 con bibl. prec.; peter isler 1981, p. 47, n. 230. La datazione è posta
al 350-300 a.c.46 questo modo di indossare la leonté è stato definito come “tipo etrusco”: krauskopF 1985, p. 136, cfr.
Colonna 2008, p. 57. In generale si veda anche Galli 1941 e la bibliografia raccolta in Colonna 1987a, p. 21, nota 33 e id. 1987b, p. 18, nota 21. una variante di questo schema iconografico è rappresentata da una statuetta in cui Ercole, tipo cipriota, ha come copertura dell’inguine la testa di un cervo: sChWartz 2009, p. 248 add. ii. n. γ.
Figg. 15a-b. particolari dei frammenti c-c1 dopo il restauro (foto autore).
note e disCussioni 395
sato dall’eroe richiamerebbe quello dei Luperci di roma e del dio Faunus47, da cui forse sarebbe derivato48.
nella maggior parte dei confronti proposti l’eroe è rappresentato in posizione fron-tale: la gamba sinistra avanzata leggermente, il braccio destro portato all’indietro con la clava, il braccio sinistro allungato in avanti verso il basso e con in mano stretto l’arco ed eventualmente le frecce. un diverso schema iconografico è utilizzato, invece, nello spec-chio raffigurante l’eroe in lotta con acheloo (Fig. 23): Ercole è proteso nel combattimen-to ed ha gli arti superiori ed inferiori piegati e sotto sforzo nel tentativo di domare il toro, che è afferrato per le corna49.
nel caso in esame gli indizi presenti sui frammenti consentono di proporre il tipo di costume in cui Ercole è raffigurato e di ipotizzare la sua posizione. In base al fram-mento B-B1 l’eroe dovrebbe essere rappresentato con l’arto destro piegato indietro e quello sinistro in avanti, da solo o con un’altra figura50. se il frammento c-c1, rap-presentante l’avambraccio terminante con la mano che stringe un oggetto, appartenes-se alla statua in esame è possibile aggiungere ulteriori considerazioni: l’eroe potrebbe essere raffigurato in posizione di attacco, con l’arto sinistro superiore portato all’indie-tro mentre stringe un’arma51 oppure in uno scontro ravvicinato con un’altra figura, di cui avrebbe afferrato una parte. In questo secondo caso l’eroe potrebbe trovarsi in una posizione simile a quella presente nella Fig. 23, con alcune differenze: il frammento a con la fronte aggrottata potrebbe corrispondere alla tensione emotiva espressa dalla fronte della divinità fluviale come illustrato nella figura Fig. 23 ed in un altro reperto
47 sull’abbigliamento dei Luperci: Wrede 1983. 48 Colonna 1987a, pp. 22-23; id. 1987b, pp. 17-18 e id. 2001a, p. 68.49 su Ercole ed acheloo: peter isler 1981, pp. 25-29 e sChWartz 2009, p. 249.50 Vd. sChWartz 1990, nn. 37, 40, 163, 198, 282, 367a ed ead. 2009, n. 37.51 sChWartz 1990, n. 282, generalmente però l’eroe è raffigurato con l’arma nella mano destra.
Fig. 16. Frammenti c-c1 (veduta superiore) (foto autore).
396 note e disCussioni
proveniente da Veio52; l’arto inferiore destro della statua in esame è maggiormente piegato e la rotazione della mano sinistra è differente rispetto alla figura dello spec-chio; infine l’identificazione dell’oggetto stretto nella mano come corno non è certa. In considerazione delle numerose variabili si è preferito, per il momento, non presentare una ricostruzione. Il gruppo statuario, in particolare la statua di Ercole, è ricostruibile in base alle dimensioni dei frammenti con una grandezza pari a circa un terzo del vero, ossia circa cm 60.
52 si tratta di un pinax a rilievo, datato alla seconda metà del V sec. a.c., proveniente dal santuario di portonaccio, in cui Ercole è raffigurato nudo: Colonna 1987c, p. 437, fig. 26; CionColoni Ferruzzi, Mar-Chiori 1989-1990, p. 714, fig. 5; sChWartz 2009, p. 249.
Figg. 17-19. protome leonina dall’alto, lato posteriore, veduta dal basso (foto autore).
note e disCussioni 397
In base allo stile e ai confronti è possibile proporre una datazione dei frammenti a e c-c1, e anche dei restanti, ad età tardo arcaica, inizio V sec. a.c.
Il gruppo Ercole ed acheloo, come visto, è attestato a Veio nel santuario di porto-naccio53 e la presenza dei due personaggi è interpretata in relazione al contesto topo-
53 ulteriori ritrovamenti riferibili ad acheloo sono: una statuetta votiva con toro accosciato, un oscillum a testa taurina (Colonna 1987c, p. 437; CiuCCarelli 2006, p. 133) e le antefisse (CarluCCi 2008b, p. 204 nn. 12.4-5). per la presenza della divinità fluviale nel santuario di pyrgi (sacello beta): Colonna 2000, p. 268. su acheloo in generale: peter isler 1981; siMon 2009 e di Giuseppe 2009, la quale menziona anche una nuova antefissa di acheloo rinvenuta in un pozzo dello scavo di macchia grande a Veio.
Fig. 20. statua di Ercole dal santuario di portonaccio (da Colonna 2001, p. 67).
Fig. 21. statuetta in bronzo da castelbellino (da Colonna 1970, tav. III).
398 note e disCussioni
grafico, la vicina cascata del fosso della mola, e alle opere di bonifica e canalizzazione idrica del santuario e delle campagne veienti, simboleggianti il dominio dell’uomo sulle acque, come quello di Ercole su acheloo54. nel caso in esame la presenza di Ercole (e di acheloo?), si inserirebbe senza difficoltà nel quadro topografico ed architettonico del santuario di campetti, area s-o, che è localizzato di fronte alla cascata del fosso della mola (Fig. 2) e dotato di numerose strutture collegate con l’acqua (Fig. 4), elemento strettamente legato all’eroe come attestato dalla tradizione e dalle fonti archeologiche55.
54 Colonna 1987c, p. 441, figg. 27-28; CionColoni Ferruzzi, MarChiori 1989-1990, p. 714. CiuC-Carelli 2006, p. 133 oltre a confermare l’ipotesi interpretativa di g. colonna pone in risalto anche l’aspetto ctonio/infero connesso ad acheloo.
55 liV. 22, 1, 10 e serV. Aen. 7, 697; vd. anche: Bayet 1926, pp. 166-167; pFiFFiG 1975, pp. 340-345; krauskopF 1985, p. 136; prayon 1993, pp. 414-415; CristoFani 2000, p. 418; Chellini 2002, pp. 208, 209-210; MCdonouGh 2002; Bellelli 2006, pp. 204-209; Giontella 2006, pp. 172-174; de GruMMond
Fig. 22. specchio in bronzo rappresentante Eracle in compa-gnia di minerva nel giardino delle Esperidi (da de GruMMond 2006, fig. VIII.8).
note e disCussioni 399
il CoMplesso arCheoloGiCo nel periodo iV e il Culto di erCole
nel periodo IV il sito in esame è localizzato nell’immediato suburbio della città roma-na, la cui estensione è notevolmente ridotta rispetto a quella etrusca56 (Fig. 24), e presenta il suo maggior sviluppo edilizio, occupando entrambi i livelli per un’area di almeno m² 10.00057 (Fig. 25). I muri sono costruiti per la maggior parte in cementizio con paramen-to in opera reticolata di tufo. Il sito è dotato di edifici e infrastrutture che suggeriscono in
2006, pp. 182-183 e quanto già raccolto in FusCo 2008-2009, pp. 456-459. sui culti delle acque in Etruria: aeBisCher 1932; Gasperini 1988; torelli 1991; MaGGiani 1999; id. 2003.
56 sulla città di Veio tra la fine del I sec. a.c. e il I sec. d.c.: liVerani 1987, pp. 143-155; GaBBa 1988, pp. 203-204; papi 2000, pp. 103-115.
57 I seminari sui periodi III-VII sono sviluppati insieme a L. camerlengo, m. gristina, t. Latini, B. Lepri, c.m. marchetti, F. soriano e V. zeppieri.
Fig. 23. specchio in bronzo rappresentante Eracle in lotta con acheloo (da de GruMMond 2006, fig. VIII.10).
400 note e disCussioni
maniera inequivocabile una funzione pubblica in cui l’acqua ricopre un ruolo di prima-ria importanza58. si menzionano: le infrastrutture per l’adduzione dell’acqua, costituite da canali ipogei e da acquedotti epigei (Fig. 25, L e r), ricostruibili in base ad allineamenti di pilastri in opera cementizia; alcuni edifici per la conserva dell’acqua (Fig. 25, serbatoi c, g e cisterna h), con una capienza complessiva di oltre m³ 1000; le strutture per l’utiliz-zo dell’acqua, come le vasche per la balneazione a carattere terapeutico e/o rituale59 (Fig. 25, m, n, E), la piscina d, il ninfeo o ed infine il monumentale edificio a nella terraz-
58 Vd. le argomentazioni sviluppate in FusCo 2008-2009 e id. c.d.s.59 sul tema cfr. Guérin-BeauVois, Martin 2007, pp. 1-5.
Fig. 24. Localizzazione del complesso archeologico di campetti, area s-o, e limiti approssimativi della città di Veio in età romana (da FusCo 2001, fig. 1).
note e disCussioni 401
za inferiore, interpretato come una natatio60. In sintesi il complesso risulta razionalmente articolato in spazi funzionali specifici: ambienti per le terme (piscina, vasche ecc.), per le attività fisiche e il soggiorno (portici, estesi spazi aperti, ambienti vari), strutture per la con-servazione dell’acqua (serbatoi, cisterne) e per le varie infrastrutture (acquedotti, fognature ecc.)61. È opportuno ricordare alcuni siti di confronto, localizzati in Etruria ed Italia centro-meridionale e dotati di caratteristiche architettoniche e funzionali simili a quelle descrit-te, come ad esempio il santuario di Valle della mola a cerveteri62, le Aquae Apollinares veteres a stigliano63, le Aquae Tauri a civitavecchia64 e le Aquae Volaterrae o Populoniae a Bagno della Leccia65, il santuario di colle del noce a segni66 e il santuario di apollo al valico di Itri, sulla via appia67. dal punto di vista topografico tutti i complessi citati occupano un’area periferica o nell’immediato suburbio dell’insediamento principale e la sorgente termale di alimentazione può trovarsi all’interno del sito68 o nelle vicinanze69 e l’acqua è portata, ove necessita, attraverso un acquedotto o canalizzazioni ipogee70.
nel sito in esame alcune iscrizioni votive71 (dediche a Igea ed Esculapio?, II sec. d.c.; a Ercole e alle Fonti, prima metà II sec. d.c.; a diana, seconda metà II sec. d.c.), oltre ad un testo di carattere evergetico (I sec. d.c.), contribuiscono a determinare l’a-spetto policultuale dell’area come attestato anche per la maggior parte dei confronti citati72. L’iscrizione di maggior interesse per il tema in esame è la dedica di un fedele, C(aius) Sulpicius Liscus, ad Ercole e alle Fonti in seguito alla guarigione da un tipo di febbre malarica, la tertiana (Fig. 26):
Herculi et Fontibus invictis C(aius) Sulpicius Liscus 5 Seq(uanus?) liberatus (scil. febre) tertiana eo die quo descenderat v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
60 una descrizione puntuale delle strutture idriche del periodo IV e V, comprensiva anche di confronti, è in FusCo c.d.s.
61 si vedano a tale proposito le osservazioni di MandersCheid 1997, pp. 668-669.62 nardi 2005, pp. 185-192; ead. 2006, pp. 585-598.63 Chellini 2002, pp. 95-99, con bibl. prec.; Gasperini 2006, pp. 214-224.64 Chellini 2002, pp. 89-93, con bibl. prec.65 Chellini 2002, pp. 173-177, con bibl. prec.66 reGGiani 2000; alVino, CiFarelli, inniCo 2003; reGGiani 2005.67 QuiliCi 2003.68 Aquae Apollinares novae; Aquae Caeretanae; Bagni della regina; Aquae Apollinares veteres.69 si confronti anche la localizzazione del santuario della acque presso arcella: Gasperini 1988, pp. 11-14.70 Aquae Cutiliae; santuario di Valle della mola; Aquae Tauri; Aquae Volaterrae o Populoniae; santuario
di colle del noce e quello al valico di Itri, sulla via appia.71 per l’analisi dei reperti: FusCo 2001b e id. 2008-2009. 72 da ultimi sul tema: Gasperini 2006 e dall’aGlio 2009, pp. 100-101.
402 note e disCussioni
Fig.
25.
pia
nta
del p
erio
do IV
del
sito
di c
ampe
tti, a
rea
s-o
(da
FusC
o 2
008-
2009
, fig
. 17)
.
note e disCussioni 403
si tratta di una piccola base, un donario, di forma parallelepipeda, integra, in mar-mo bianco a grana fine (h. cm 17.5; largh. cm 22.5; spess. cm 15) rinvenuta in giacitura secondaria in occasione dello scavo dell’ambiente c 11 all’interno dell’us 232773.
a distanza di circa sei secoli nello stesso sito è documentata una nuova testimonianza del culto di Ercole, in questo caso associato ai Fontes nella guarigione di un personag-gio, costituendo un ulteriore elemento a favore dell’aspetto curativo del suo culto e dello stretto legame con le sorgenti termali74. non è noto in quale luogo c. sulpicio Lisco sia stato contagiato dalla malattia, ma sembrerebbe verosimile che il personaggio sia stato infettato da una febbre terzana lungo il litorale dell’Etruria, noto in antichità per la sua insalubrità75. dopo il contagio, probabilmente avvenuto nel periodo primaverile-estivo, c. sulpicio Lisco sarebbe giunto presso il complesso di campetti, area s-o, ove si sarebbe fermato fino alla guarigione76. Il sostantivo plurale Fontes indica l’esistenza di un nume-ro imprecisato di sorgenti che possono essere localizzate all’interno dell’area di scavo o nelle sue immediate vicinanze e in questo caso un acquedotto avrebbe trasportato l’acqua nel sito77. all’interno dell’area di scavo non sono state rinvenute sorgenti come anche nel-le vicinanze e sul pianoro di Veio78. questo dato però non può ritenersi determinante in quanto è possibile considerare l’eventuale esaurimento delle sorgenti nel corso del tem-po o ad attività edilizie che hanno modificato una situazione precedente. si propende al momento per identificare i Fontes citati nel testo epigrafico con il ninfeo o (Fig. 25): la struttura, databile nell’ambito del I secolo d.c., è costituita da un’esedra semicircolare decorata con sette nicchie, una nicchia centrale e tre per ogni lato. Le nicchie laterali, di dimensioni minori, presentano una copertura costituita alternativamente da piattaban-da e arco in laterizio. tutte le nicchie presentano tre fistulae ciascuna, tranne quella ini-ziale e finale dotate di due fistulae, per un totale di 19 condutture79. questa struttura da cui zampillava l’acqua dalle fistule, poteva dare l’impressione di essere costituita da più fonti distinte e potrebbe costituire la monumentalizzazione di una realtà già esistente o essere costruita ex novo ed alimentata da una sorgente esterna. L’utilizzo di acquedotti in complessi termali, terapeutici e cultuali è ampiamente attestato e indica come il trasporto dell’acqua non rappresenti una perdita del suo valore sacro e curativo ed inoltre che il cul-to di una fonte può localizzarsi alla sorgente ma anche allo sbocco dell’acquedotto80. Inol-
73 FusCo 2008-2009, pp. 452 fig. 6.74 FusCo 2008-2009, pp. 459-462 con bibl. prec.75 Cato, orig. 2, 50; plin., epist. 5, 6.76 per un caso di guarigione da febbre terzana benigna dopo circa 40 giorni: GoureVitCh 2001, pp.
80-81.77 per questa soluzione, si vedano le considerazioni espresse da aupert 1991, p. 186. sul valore sacro e
terapeutico della sorgente nel mondo romano: roMizzi 2005. si vedano inoltre saBBatini tuMolesi 2006 e ValVo 2006.
78 a Veio è nota l’esistenza di due sorgenti ai piedi del pianoro: presso i Bagni della regina, sulla riva del torrente Valchetta, antico cremera, nella parte orientale della città di Veio, ove è presente un piccolo complesso termale di età etrusca e romana (Chellini 2002, pp. 81-82) e presso Vignacce, lungo il piordo, non lontano dal santuario di portonaccio (Id. 2002, p. 82 con bibliografia precedente).
79 FusCo 2008-2009, pp. 446-448, 473, 475; FusCo c.d.s. 80 Vd. ad esempio i casi di argo, sanxay, chassenon: aupert 1991, pp. 185-186; id. 1994, pp. 196-
404 note e disCussioni
tre un utile confronto è costituito dal sistema di alimentazione idrica del grande santuario di apollo sulla via appia, al valico di Itri, recentemente ricostruito da L. quilici. L’autore ipotizza la presenza di uno o più acquedotti per il trasporto dell’acqua dal vicino fosso di s. andrea fino alle numerose cisterne presenti nell’area sacra81. questa soluzione potreb-be essere proposta anche per il sito in esame utilizzando un’approvvigionamento idrico da una sorgente esterna, come le acque del torrente piordo82.
ConClusioni
Il primo dato che emerge dall’analisi svolta è la continuità di uso del sito di cam-petti come area sacra dall’età etrusca (peroido II) a quella romana (periodo IV)83. una
198, posizione contraria in FaCChinetti 2010. sul tema cfr. anche settis 1973, p. 708; tölle-kastenBein 1993, pp. 51-128 e da ultimo yeGül 2010, pp. 97-100.
81 QuiliCi 2003, in particolare p. 172. 82 FusCo c.d.s.83 In generale si veda edlund 1987, p. 141. al momento è incerta la funzione del sito nel periodo III ma in
base ad alcuni elementi strutturali, come ad esempio una possibile area di culto, si propende per un’interpretazio-ne a carattere sacra.
Fig. 26. L’iscrizione votiva con dedica ad Ercole e alle Fonti (da FusCo 2008-2009, fig. 7).
note e disCussioni 405
differenza sostanziale è costituita però dal contesto topografico84: mentre in età etrusca l’area è localizzata all’interno della città, in posizione marginale e nei pressi di una porta, in quella romana si trova all’esterno del centro abitato e nel suo immediato suburbio.
Il culto di Ercole risulta attestato nei complessi del periodo II e IV anche se con accen-ti differenti. per quanto concerne il periodo etrusco nel suo recente studio g. colonna ha già espresso la possibilità di identificare nel sito in esame un luogo di culto dedicato ad Ercole connesso con le sorgenti85 e i reperti analizzati potrebbero convergere in questa direzione. non è possibile però stabilire con certezza se l’eroe sia la divinità titolare dell’a-rea, infatti è noto il culto di divinità secondarie accanto a quella principale nell’ambito di uno stesso santuario86, inoltre saranno da approfondire le problematiche cultuali connesse alla contemporanea presenza dell’eroe e di Enea. Le varie strutture collegate con l’acqua suggeriscono, comunque, un ruolo importante di Ercole nel culto. La mancata individua-zione di sorgenti all’interno del sito non è da considerarsi come un dato risolutivo in consi-derazione della testimonianza, anche se di età successiva, menzionante l’esistenza di Fon-tes. La contemporanea presenza dell’acqua e di Ercole potrebbe indicare la pratica di un culto di tipo salutare-curativo all’interno del santuario nel periodo II, ma questa ipotesi non è pienamente convincente. È da ricordare infatti che l’acqua è utilizzata anche a fini ritua-li87, inoltre la connessione dell’eroe con il viaggio e il passaggio88 consente di inserire il suo culto in un’area connessa con i riti di passaggio e con funzioni iniziatiche e di purifica-zione. Infine la localizzazione del sito in ambito urbano, anche se marginale, sconsiglia una funzione curativa. In conclusione il sito apparirebbe a carattere policultuale e polifunziona-le e rientrerebbe nel tipo c della tipologia architettonica proposta da F. prayon: un santuario organizzato con il regolamento dell’acqua mediante un sistema di canali dalla sorgente al luogo di culto, il quale è posto in area più bassa rispetto alla fonte89.
In età etrusca il culto di Ercole a Veio è attestato nel vicino santuario di portonaccio (Fig. 1, n. 4) adorno di diverse statue dell’eroe, il quale però non riveste il ruolo di divi-nità principale90. Inoltre un interessante confronto può essere proposto con il santuario in località s. antonio, localizzato anch’esso in posizione marginale e all’interno della città di cerveteri, considerato il principale luogo di culto dedicato all’eroe. L’area, ancora in corso di scavo, è ricca di strutture collegate con l’acqua (cisterne, canalette, fontana) ed è dotata di due monumentali templi, di cui il più antico a, datato alla fine del VI-inizio V sec. a.c., ingloba una precedente fontana ed è attribuito al culto di Ercole91.
84 per l’importanza di questo aspetto: edlund-Berry 2011, p. 10.85 Colonna 2009, p. 66.86 pilo 2006, p. 121. 87 si veda la bibliografia riportata a nota 13.88 cfr. CristoFani 2000, p. 418 e pilo 2006, p. 123.89 prayon 1993, pp. 418-419. 90 da ultimo sul tema vd. Colonna 2008 con bibl. prec. per quanto concerne i reperti: torso di statua
virile identificato con Ercole, 560-550 a.c. (Colonna 2001a, pp. 65-66, n. I.F.4; CarluCCi 2008, p. 201, n. 1); statua di Ercole, 510-500 a.c. (CarluCCi 2008, pp. 201-202, n. 3 con bibl. prec.); gruppo di Ercole e minerva, 510-500 a.c. (Colonna 2001a, pp. 67-68, n. I.F.5; CarluCCi 2008, p. 207, n. 19).
91 si citano solo i titoli principali su questo monumento: CristoFani 2000, pp. 414-418; Colonna 2001b; Bellelli 2006, pp. 202-208; Cosentino 2008, pp. 73-75; vd. inoltre rizzo 2008a, pp. 83-85, ead.
406 note e disCussioni
nel periodo IV il culto di Ercole presso campetti, area s-o, presenta un caratte-re maggiormente definito. In base all’iscrizione descritta risulta evidente il suo collega-mento con le sorgenti e l’aspetto curativo del culto. anche se è incerta la localizzazione dei Fontes, la loro menzione determina in maniera inequivocabile la funzione termale, terapeutica e cultuale del sito. Le attestazioni del culto di Ercole a Veio sono note presso alcuni santuari della città e databili ad età repubblicana92. per quanto concerne l’Etru-ria si ricorda il sito delle Aquae Caeretane con diverse attestazioni del culto dell’eroe e in cui, secondo alcuni studiosi, sarebbe da localizzare anche il fons Herculis ricordato da Livio (liV. XXII, 1, 10) ove sarebbero avvenuti sinistri presagi (fuoriuscita di acqua mista a sangue) in occasione della seconda guerra punica93.
uGo FusCo
BIBLIograFIa
aCConCia 2000: V. aCConCia, Il Santuario del Pozzarello a Bolsena: (scavi Gabrici 1904) (corpus delle stipi votive in Italia. X, regio VII; 5), roma 2000.
aCConCia 2005: V. aCConCia, «considerazioni sulla stipe del pozzarello a Bolsena (Vt)», in a. CoMella, s. Mele (a cura di), Depositi votivi e culti dell’Italia antica dall’età arcaica a quella tardo-repubblicana, atti del convegno di studi (perugia 2000), Bari 2005, pp. 277-284.
aeBisCher 1932: p. aeBisCher, «notes et suggestions concernant l’étude du culte des eaux en Etrurie», in StEtr VI, 1932, pp. 123-144.
alVino, CiFarelli, inniCo 2003: G. alVino, F.M. CiFarelli, p. inniCo, «Il complesso archeo-logico di colle del noce a segni: le ultime novità», in J.r. Brandt, X. dupré raVentós, G. Ghini (a cura di), Lazio e Sabina 1, atti del convegno (roma 2002), roma 2003, pp. 85-90.
aupert 1991: p. aupert, «Les thermes comme lieux de culte», in Les thermes romains, actes de la table ronde organisée par l’Ecole Française de rome (rome 1988), rome 1991, pp. 185-192.
aupert 1994: p. aupert, «L’eau curative à argos», in r. GinouVès, a-M. GuiMier-sorBets, J. Jouanna, l. Villard (a cura di), L’eau, la santé et la maladie dans le monde grec, actes du colloque (paris 25-27 novembre 1992; BCH suppl. XXVIII), paris 1994, pp. 193-200.
BaGnasCo Gianni 2005: G. BaGnasCo Gianni, «sui “contenitori” arcaici di ex-voto nei san-tuari etruschi», in a. CoMella, s. Mele (a cura di), Depositi votivi e culti dell’Italia antica
2008b e MaGGiani 2008 per l’analisi delle fasi edilizie con bibl. prec. È da ricordare che in età romana, vicino al santuario descritto, ma all’esterno della città, si sviluppa il santuario sulla Valle della mola, ricco di strutture termali e a cui si è precedentemente fatto riferimento vd. nota 61.
92 Frammento di statuetta presso il deposito votivo del santuario di campetti, area n-E, III sec. a.c. (ste-Fani 1990, p. 59, n. E1frI, tav. 13 a); statuetta presso il deposito votivo di piano di comunità, III-II sec. a.c. (Benedettini 2011, p. 422, n. F1III); iscrizione presso il santuario di macchia grande, IV-III sec. a.c. (CIL I², 2633 e CIE II, sez. 2, fasc. V, p. 13).
93 sul sito delle Aquae Caeretane e sul culto dell’eroe in età romana, vd. FusCo 2008-2009, pp. 459-461 con bibl. prec., inoltre per le diverse proposte di localizzazione della fonte di Ercole, p. 456, nota 38.
note e disCussioni 407
dall’età arcaica a quella tardo-repubblicana, atti del convegno di studi (perugia 2000), Bari 2005, pp. 351-358.
Bartoloni 2010: G. Bartoloni, «Veio», in s. Bruni (a cura di), Gli Etruschi delle città: fonti, ricerche e scavi, milano 2010, pp. 194-203.
Bartoloni, Benedettini 2011: G. Bartoloni, G. Benedettini, «note conclusive», in G. Bartoloni, G. Benedettini, Veio il deposito votivo di Comunità (Scavi 1889-2005) con contributo di B. Belelli Marchesini e D. Sarracino (corpus delle stipi votive in Italia. XXI, regio VII; 3), roma 2011, pp. 779-790.
Bayet 1926: J. Bayet, Herclé. Étude critique des principaux monuments relatifs à l’Hercule étrusque, paris 1926.
Belelli MarChesini 2009: B. Belelli MarChesini, «conclusioni», in aa.VV., «Il contributo degli scavi di piano di comunità alla conoscenza dell’abitato di Veio: materiali dal riempi-mento di un pozzo sul pianoro sommitale», in G. Bartoloni (a cura di), L’abitato etrusco di Veio. Ricerche dell’Università di Roma ‘La Sapienza’, roma 2009, pp.122-123.
Bellelli 2006: V. Bellelli, «un bronzetto etrusco, cerveteri e le ‘acque di Ercole’», in Medi-terranea (Quaderni Annuali dell’Istituto di Studi sulle Civiltà Italiche e del Mediterraneo Antico del Consiglio Nazionale delle ricerche, già Quaderni di Archeologia etrusco-italica) III 2006, pp. 173-225.
Benedettini 2011: G. Benedettini, «F1III», in G. Bartoloni, G. Benedettini, Veio il depo-sito votivo di Comunità (Scavi 1889-2005) con contributo di B. Belelli Marchesini e D. Sarra-cino (corpus delle stipi votive in Italia. XXI, regio VII; 3), roma 2011, p. 422.
Boitani 2008: F. Boitani, «Veio. profilo storico-topografico», in M. torelli, a.M. Moretti (a cura di), Etruschi. Le antiche metropoli del Lazio, cat. mostra, milano 2008, pp. 47-51.
BonGhi JoVino 2005: M. BonGhi JoVino, «Mini muluvanice – mini turuce. depositi votivi e sacralità. dall’analisi del rituale alla lettura interpretativa delle forme di religiosità», in a. CoMella, s. Mele (a cura di), Depositi votivi e culti dell’Italia antica dall’età arcaica a quella tardo-repubblicana, atti del convegno di studi (perugia 2000), Bari 2005, pp. 31-46.
BouMa 1996: J.W. BouMa, Religio Votiva: the Archeology of Latial Votive Religion, Corpus of Latial Cult Places. Setting, Nature, Contents and Chronology I-III, groningen 1996.
CaMporeale 2000: G. CaMporeale, Gli Etruschi: storia e società, torino 2000.Carandini 2000: a. Carandini, Storie dalla terra. Manuale di scavo archeologico, torino
2000.CarluCCi 2004: C. CarluCCi, «L’antefissa a testa di dea elmata», in G. Colonna, «I santuari
di Veio: ricerche e scavi su piano di comunità», in h. patterson (ed.), Bridging the Tiber approaches to regional archeology in the middle Tiber valley (archaeological monographs of the British school at roma, 13), London 2004, pp. 218-219.
CarluCCi 2008a: C. CarluCCi, «gruppo di Ercole e minerva 510-500 a.c.», in M. torelli, a.M. Moretti (a cura di), Etruschi. Le antiche metropoli del Lazio, cat. mostra, milano 2008, p. 207, n. 19.
CarluCCi 2008b: C. CarluCCi, «antefissa a testa di acheloo», in M. torelli, a.M. Moretti (a cura di), Etruschi. Le antiche metropoli del Lazio, cat. mostra, milano 2008, p. 204 nn. 12.4, 12.5.
Carosi 2002: s. Carosi, «nuovi dati sul santuario di campetti a Veio», in ArchCl LIII, n.s. 3, 2002, pp. 355-377.
Cerasuolo, pulCinelli 2006: o. Cerasuolo, l. pulCinelli, «contributo allo studio dei din-torni di portonaccio a Veio in epoca etrusca e romana. documenti sulle mura urbiche, la porta
408 note e disCussioni
e la viabilità», in C. pisu, a. GiuFFrida (a cura di), Atti del 1° Convegno Nazionale “Federi-co Halbherr” per i giovani archeologi (roma 2006), roma 2007, pp. 91-108.
Chellini 2002: r. Chellini, Acque Sorgive Salutari e Sacre in Etruria (Italiae Regio VII): Ricerche Archeologiche e di Topografia Antica (Bar International series, 1067), oxford 2002.
CionColoni Ferruzzi, MarChiori 1989-1990: r. CionColoni Ferruzzi, s. MarChiori, «I culti del santuario di Veio-portonaccio alla luce delle testimonianze votive», in ScAnt 3-4, 1989-1990, pp. 705-718.
CiuCCarelli 2006: M.r. CiuCCarelli, «acheloo ctonio dalla magna grecia all’Etruria?», in Mediterranea (Quaderni Annuali dell’Istituto di Studi sulle Civiltà Italiche e del Mediterra-neo Antico del Consiglio Nazionale delle ricerche, già Quaderni di Archeologia etrusco-itali-ca) III, 2006, pp. 121-140.
Coarelli 2009: F. Coarelli, «Ercole in Etruria e a roma», in AnnFaina XVI, 2009, pp. 373-381.
Colonna 1970: G. Colonna, Bronzi votivi umbro-sabellici a figura umana I. Periodo arcaico (studi e materiali di etruscologia e antichità italiche, 8), Firenze 1970.
Colonna 1985: G. Colonna, «I santuari urbani», in G. Colonna (a cura di), Santuari d’Etru-ria, milano 1985, pp. 67-69.
Colonna 1987a: G. Colonna, «Il maestro dell’Ercole e della minerva. nuova luce sull’attività dell’officina veiente», in OpRom XVI, 1987, pp. 7-41.
Colonna 1987b: G. Colonna, «I culti del santuario della cannicella», in AnnFaina III, 1987, pp. 11-26.
Colonna 1987c: G. Colonna, «note preliminari sui culti del santuario di portonaccio a Veio», in ScAnt 1, 1987, pp. 419-446.
Colonna 2000: G. Colonna, «Il santuario di pyrgi dalle origini mitistoriche agli altorilievi fron-tonali dei sette e di Leucotea», in ScAnt 10, 2000, pp. 251-336.
Colonna 2001a: G. Colonna, «gruppo di Ercole e di minerva», in a.M. Moretti sGuBini (a cura di), Veio, Cerveteri, Vulci. Città d’Etruria a confronto, cat. mostra, roma 2001, pp. 67-68.
Colonna 2001b: G. Colonna, «divinazione e culto di rath/apollo a caere (a proposito del santuario in loc. s. antonio)», in ArchCl LII, n.s. 2, 2001, pp. 151-173.
Colonna 2006: G. Colonna, «sacred architecture and the religion of the Etruscans», in n.t. de GruMMond, e. siMon (eds.), The religion of the Etruscans, austin 2006, pp. 132-168.
Colonna 2008: G. Colonna, «L’officina veiente: Vulca e gli altri maestri di statuaria arcaica in terracotta», in M. torelli, a.M. Moretti (a cura di), Etruschi. Le antiche metropoli del Lazio, cat. mostra, milano 2008, pp. 53-63.
Colonna 2009: G. Colonna, «Il mito di Enea tra Veio e roma», in AnnFaina XVI, 2009, pp. 51-92.
CoMella 2005: a. CoMella, s.v. «deposito votivo», in ThesCRA IV, Los angeles 2005, pp. 226-228.
CoMella, steFani 1990: a. CoMella, G. steFani, Materiali votivi del santuario di Campetti a Veio. Scavi 1947 e 1969 (corpus delle stipi votive in Italia. V, 5, regio VII; 2), roma 1990.
Cosentino 2008: r. Cosentino, «cerveteri. profilo storico-topografico», in M. torelli, a.M. Moretti (a cura di), Etruschi. Le antiche metropoli del Lazio, cat. mostra, milano 2008, pp. 71-77.
CristoFani 2000: M. CristoFani, «I culti di Caere», in ScAnt 10, 2000, pp. 395-425.
note e disCussioni 409
dall’aGlio 2009: M. dall’aGlio, I culti delle acque nell’Italia antica, Imola 2009.de GruMMond 2006: n.t. de GruMMond, Etruscan Myth, Sacred History and Legend, phila-
delphia 2006.di Giuseppe 2009: h. di Giuseppe, «acheloo e le acque deviate», in h. di Giuseppe, M. ser-
lorenzi (a cura di), I riti del costurire nelle acque violate, atti del convegno Internazionale (roma 2008), roma 2010, pp. 69-90.
edlund 1987: i.e.M. edlund, The Gods and the Place. Location and Function of Sanctuaries in the Countryside of Etruria and Magna Graecia (700-400 b. C.), stockholm 1987.
edlund-Berry 2011: i. edlund-Berry, «Introduction», in n.t. de GruMMond, i. edlund-Berry (eds.), The Archaeology of Sanctuaries and Ritual in Etruria, portsmouth, rhode Island 2011, pp. 8-15.
FaCChinetti 2010: G. FaCChinetti, «offrire nelle acque e altre strutture artificiali», in h. di Giuseppe, M. serlorenzi (a cura di), I riti del costurire nelle acque violate, atti del conve-gno Internazionale (roma 12-14 giugno 2008), roma 2010, pp. 43-67.
FusCo 2001a: u. FusCo, «Lastra decorata a rilievo, frammento di lastra decorata a rilievo», in a.M. Moretti sGuBini (a cura di), Veio, Cerveteri, Vulci. Città d’Etruria a confronto, cat. mostra, roma 2001, pp. 14-15 nn. 18-19.
FusCo 2001b: u. FusCo, «nuovi reperti dall’area archeologica di campetti a Veio», in ArchCl LII, n.s. 2, 2001, pp. 255-278.
FusCo 2006: u. FusCo, Il complesso archeologico di Campetti a Veio e i luoghi di culto collegati alle acque (santuari alla sorgente, complessi termali/terapeutici/cultuali) dell’Italia centrale in età romana: tipologie monumentali e considerazioni storiche, pisa 2007 (dottorato di ricerca).
FusCo 2008-2009: u. FusCo, «Iscrizioni votive ad Ercole, alle Fonti e a diana dal sito di cam-petti a Veio: ulteriori elementi per l’interpretazione archeologica», in RendPontAc LXXXI, 2008-2009, pp. 443-500.
FusCo 2010: u. FusCo, «due emblemata inediti dal complesso archeologico di campetti a Veio (rm)», in C. anGelelli (a cura di), AISCOM Atti del XVI Colloquio dell’associazione ita-liana per lo studio e la conservazione del mosaico (palermo – piazza armerina 20 marzo 2010), tivoli 2011, pp. 529-538.
FusCo c.d.s.: u. FusCo, «archeologia dell’acqua: il sito di campetti a Veio (rm)», in Monte-grotto. Le aree archeologiche e il termalismo in età antica, atti del convegno (padova 2010), padova c.d.s.
FusCo, Cerasuolo 2001: u. FusCo, o. Cerasuolo, «campetti», in a.M. Moretti sGuBini (a cura di), Veio, Cerveteri, Vulci. Città d’Etruria a confronto, cat. mostra, roma 2001, pp. 9-11.
FusCo, MarChetti 2010: u. FusCo, C.M MarChetti, «I pavimenti di età romana (periodi III-V) del complesso archeologico di campetti a Veio (rm)», in C. anGelelli (a cura di), AISCOM Atti del XVI Colloquio dell’associazione italiana per lo studio e la conservazione del mosaico (palermo – piazza armerina 20 marzo 2010), tivoli 2011, pp. 539-558.
GaBBa 1988: e. GaBBa, «Municipium Augustum Veiens», in Athenaeum 66, 1988, pp. 203-204. GaBriCi 1906: e. GaBriCi, «Bolsena. scavi nel sacellum della dea nortia sul pozzarello», in
MonAntL XVI, 1906, coll. 169-240.Galli 1941: G. Galli, «hereklu», in StEtr XV, 1941, pp. 27-71.Gasperini 1988: L. Gasperini, «gli Etruschi e le sorgenti termali», in Etruria meridionale cono-
scenza, conservazione, fruizione, atti del convegno (Viterbo 1985), roma 1988, pp. 27-35.Gasperini 2006: l. Gasperini, «Le terme-santuario di stigliano e Vicarello nel Foroclodiense»,
in l. Gasperini (a cura di), usus veneratioque fontium, atti del convegno Internazionale
410 note e disCussioni
di studio su «Fruizione e culto delle acque salutari in Italia» (roma-Viterbo 1993), tivoli 2006, pp.189-224.
GeraCi 2006: g. GeraCi, «acque salutari e culti delle acque: conclusioni», in l. Gasperini (a cura di), usus veneratioque fontium, atti del convegno Internazionale di studio su «Fruizio-ne e culto delle acque salutari in Italia» (roma-Viterbo 1993), tivoli 2006, pp. 411-417.
GianniChedda 2007: e. GianniChedda, «Lo scavo, i residui, l’affidabilità stratigrafica», in Facta 1, 2007, pp. 51-64.
Giontella 2006: C. Giontella, I luoghi dell’acqua “divina”. Complessi santuariali e forme devozionali in Etruria e Umbria fra epoca arcaica ed età romana, roma 2006.
GoureVitCh 2001: d. GoureVitCh, I giovani pazienti di Galeno. Per una patocenosi dell’impe-ro romano, roma, Bari 2001.
Guérin-BeauVois, Martin 2007: M. Guérin-BeauVois, J.-M. Martin, «Introduction métho-dologique», in M. Guérin-BeauVois, J.-M. Martin (a cura di), Bains curatifs et bains hygiéniques en Italie de l’Antiquité au Moyen âge, rome 2007, pp. 1-19.
krauskopF 1985: I. krauskopF, s.v. «hercle», in M. CristoFani (a cura di), Dizionario della civiltà etrusca, Firenze 1985, pp. 135-137.
liVerani 1987: p. liVerani, municipium augustum Veiens. Veio in età imperiale attraverso gli scavi Giorgi (1811-13), roma 1987.
MaGGiani 1999: a. MaGGiani, «culti delle acque e culti in grotta in Etruria», in Ocnus VII, 1999, pp. 187-203.
MaGGiani 2003: a. MaGGiani, «acque “sante” in Etruria», in L’acqua degli dei. Immagini di fontane, vasellame, culti salutari e in grotta, cat. mostra, san giustino 2003, pp. 39-43.
MaGGiani 2008: a. MaGGiani, «Il santuario in località s. antonio a cerveteri. Il tempio a: la fase ellenistica», in Mediterranea (Quaderni Annuali dell’Istituto di Studi sulle Civiltà Itali-che e del Mediterraneo Antico del Consiglio Nazionale delle ricerche, già Quaderni di Arche-ologia etrusco-italica) V, 2008, pp. 121-137.
ManaCorda 2008: d. ManaCorda, Lezioni di archeologia, roma, Bari 2008.MandersCheid 1997: h. MandersCheid, s.v. «terme», in EAA suppl. V, 1997, pp. 667-673.MCdonouGh 2002: Ch. MCdonouGh, «hercle and the ciminian Lake Legend: source study for
an Etruscan mirror», in ClJ XcVIII, 2002, pp. 9-19.naGy 2011: h. naGy, «Etruscan votive terracottas and their archaelogical contexts: preliminary
comments on Veii and cerveteri», in n.t. de GruMMond, i. edlund-Berry (eds.), The Archaeology of Sanctuaries and Ritual in Etruria, portsmouth, rhode Island 2011, pp. 113-125.
nardi 2005: G. nardi, «L’area urbana di cerveteri. nuove acquisizioni e dati riassuntivi», in Dinamiche di sviluppo delle città nell’Etruria meridionale. Veio, Caere, Tarquinia, Vulci, atti del XXIII convegno di studi etruschi ed italici (roma, Veio, creveteri, pyrgi, tarquinia, tuscania, Vulci, Viterbo 2001), pisa-roma 2005, pp. 185-192.
nardi 2006: G. nardi, «di una nuova area sacra scoperta a cerveteri», in B. adeMBri (a cura di), AEIMNHSTOS Miscellanea di Studi per Mauro Cristofani II, Firenze 2006, pp. 585-598.
pallottino 1938-1939: M. pallottino, «scavo di un’area sacra a Veio», in Le arti XVII, ott. 1938 - sett. 1939, pp. 402-403.
papi 2000: e. papi, L’Etruria dei Romani. Opere pubbliche e donazioni private in età imperiale, roma 2000.
peter isler 1981: h. peter isler, «acheloos», in LIMC I.1, zürich und münchen 1981, pp. 12-36.
note e disCussioni 411
pFiFFiG 1975: a.J. pFiFFiG, Religio Etrusca, graz 1975.pilo 2006: C. pilo, «dai manufatti archeologici alla ricostruzione del culto», in a. ManCini, C.
pilo, «materiali votivi ed oggetti rituali dal santuario orientale di gabii», in Siris 7, 2006, pp. 121-124.
prayon 1993: F. prayon, «Il culto delle acque in Etruria», in La civiltà di Chiusi e del suo ter-ritorio, atti del XVII convegno di studi Etruschi ed Italici (cianciano terme 1989), Firenze 1993, pp. 413-420.
proietti 1977: G. proietti, «Veio», in StEtr XLV, 1977, pp. 454-455.QuiliCi 2003: l. QuiliCi, «Il tempio di apollo ad clivum fundanum sulla via appia al valico di
Itri», in Santuari e luoghi di culto nell’Italia antica (atlante tematico di topografia antica, XII), roma, pp. 127-175.
reGGiani 2000: a.M. reGGiani, «un antico santuario extraurbano, ritrovato nel territorio di segni», in Orizzonti. Rassegna di archeologia I, 2000, pp. 83-92.
reGGiani 2005: a.M. reGGiani, «Il santuario extraurbano di segni e le prospettive di ricerca nel Lazio» in a. CoMella, s. Mele (a cura di), Depositi votivi e culti dell’Italia antica dall’età arcaica a quella tardo-repubblicana, atti del convegno di studi (perugia 2000), Bari 2005, pp. 139-144.
rizzo 2008a: Ma. rizzo, «cerveteri. Le grandi architetture dei vivi e dei morti», in M. torel-li, a.M. Moretti (a cura di), Etruschi le antiche metropoli del Lazio, cat. mostra, milano 2008, pp. 79-87.
rizzo 2008b: Ma. rizzo, «scavi e ricerche nell’area sacra di s. antonio a cerveteri», in Medi-terranea (Quaderni Annuali dell’Istituto di Studi sulle Civiltà Italiche e del Mediterraneo Antico del Consiglio Nazionale delle ricerche, già Quaderni di Archeologia etrusco-italica) V, 2008, pp. 91-120.
roMizzi 2005: l. roMizzi, s.v. «Fons (mondo romano)», in ThesCRA IV, Los angeles 2005, pp. 242-244.
saBBatini tuMolesi 2006: p. saBBatini tuMolesi, «sulle Aquae Caeretanae recentemen-te ritrovate», in l. Gasperini (a cura di), usus veneratioque fontium, atti del convegno Internazionale di studio su «Fruizione e culto delle acque salutari in Italia» (roma-Viterbo 1993), tivoli 2006, pp. 309-319.
sChWartz 1990: s.J. sChWartz, s.v. «hercle», in LIMC V, zürich und münchen 1990, pp. 196-253.
sChWartz 2009: s.J. sChWartz, s.v. «hercle», in LIMC supplementum 2009, 1, düsseldorf 2009, pp. 244-264.
settis 1973: s. settis, «‘Esedra’ e ‘ninfeo’ nella terminologia architettonica del mondo romano. dall’età repubblicana alla tarda antichità», in ANRW I.4, Berlin, new York 1973, pp. 661-745.
siMon 2009: e. siMon, s.v. «acheloos», in LIMC supplementum 2009 1, düsseldorf 2009, p. 1. tölle-kastenBein: r.tölle-kastenBein, Archeologia dell’acqua. La cultura idraulica nel
mondo classico, milano 1993 (trad. it.).torelli 1973: M. torelli, «recensione a L. Vagnetti», in DialA VII, nn. 2-3, 1973, pp. 396-
407.torelli 1986: M. torelli, «La religione», in Rasenna. Storia e civiltà degli Etruschi, roma
1986, pp. 159-237.torelli 1988: M. torelli, «aspetti ideologici della colonizzazione romana più antica», in Dia-
lA s. III, a. VI, 1988, n. 2, pp. 65-72.
412 note e disCussioni
torelli 1991: M. torelli, «L’acqua degli Etruschi dalle forme ideologiche alle pratiche socia-li», in M. BerGaMini (a cura di), Gli Etruschi maestri di idraulica, perugia 1991, pp. 19-20
VaGnetti 1971: l. VaGnetti, Il deposito votivo di Campetti a Veio (materiali degli scavi 1937-1938), Firenze 1971.
ValVo 2006: a. ValVo, «Fruizione e culto delle acque salutari in età romana nel territorio lom-bardo», in l. Gasperini (a cura di), usus veneratioque fontium, atti del convegno Interna-zionale di studio su «Fruizione e culto delle acque salutari in Italia» (roma-Viterbo 29-31 ottobre 1993), tivoli 2006, pp. 363-383.
Van kaMpen 2008: i. Van kaMpen, «Veio-Vei», in F. CeCi, a. Costantini, Lazio settentrio-nale. Etruria meridionale e Sabina (archeologia delle regioni d’Italia), roma 2008, pp. 139-152.
Ward-perkins 1961: J. Ward-perkins, «Veii. the historical topography of the ancient city», in BSR XXIX, 1961, pp. 1-123.
Wrede 1983: h. Wrede, «statuae lupercorum habitu», in RM 90, 1983, pp. 185-200.yeGül 2010: F. yeGül, Bathing in the Roman World, new York 2010.
summarY
This study is about finds recently discovered at Campetti in Veii during the new series of exca-vations (1996-2009) carried out by the “Sapienza” University of Rome. Among the finds are some terracotta fragments that belonged to a small statue of Hercle. This statue represents the god with a rare iconography, already seen in Veii but also in other sites. In light of the structures (drainage canals, wells, cisterns) and finds, the archaeological site of Campetti can be interpreted as having been an urban sanctuary during Etruscan times, in which water could have played an important role. Hercules continued to be worshiped at the site during the Imperial Age, as suggested by a vo-tive inscription dedicated to Hercules and the Springs by a man after recovering from malaria. The site is considered to have been a spa-sanctuary during the Roman period.