Martinangelo De Martino e la polemica contro il diritto romano
L’insediamento rustico d’età romana e tardo-antica a San Martino di Torano (Borgorose, Rieti):...
Transcript of L’insediamento rustico d’età romana e tardo-antica a San Martino di Torano (Borgorose, Rieti):...
Lazio e Sabina
11Atti del Convegno
Undicesimo Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina
Roma4 - 6 giugno 2014
Lazio e Sabina11
a cura di
e
Atti del Convegno
Undicesimo Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina
Roma4 - 6 giugno 2014
estratto
a cura diElena Calandra, Giuseppina Ghini, Zaccaria Mari
CoordinamentoGiuseppina Ghini
Comitato scientificoElena Calandra, Giuseppina Ghini e Zaccaria Mari
Impaginazione e graficaGiovanni Vastano
© 2016 Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria meridionale
ISBN 978-88-7140-733-3
Edizioni Quasar di S. Tognon srlvia Ajaccio 41-43 00198 Romawww.edizioniquasar.it
estratto
239
1. Introduzione
Nell’estate 2013 si è svolta la sesta campagna d’in-dagini archeologiche a San Martino di Torano di Borgorose (Rieti). Le ricerche sono condotte sotto la forma di campo scuola di archeologia per studenti americani, organizzato dall’Università di Rochester in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio e aperto a studenti provenien-
ti da diversi atenei americani1. L’area oggetto delle in-dagini è ubicata immediatamente a nord della chiesa di San Martino, che s’imposta su un terrazzamento in opera poligonale (fig. 1). Le vestigia attualmente visibili della chiesa si datano al XII secolo, ma si può ipotizzare con sicurezza un’origine ben più antica per l’edificio di culto cristiano. I risultati delle inda-gini finora portate a termine hanno permesso di am-pliare il quadro delle conoscenze del sito e di chiarire
L’insediamento rustico d’età romana e tardo-antica a San Martino di Torano (Borgorose, Rieti): lo stato delle ricerche
Elizabeth Colantoni � Gabriele Colantoni � Maria Rosa Lucidi � Jeffrey A. Stevens � Francesco Tommasi
1 I nostri sentiti ringraziamenti vanno alla Dott.ssa G. Alvino (SBAL) e al sindaco di Borgorose M. Calisse. Una menzione particolare va inoltre riservata al parroco di Torano Don Ma-rio Mandarini per il supporto e l’incoraggiamento offertoci sin
dall’inizio del progetto. I risultati delle precedenti campagne di scavo sono stati presentati in Colantoni et al. 2009; Colantoni et al. 2011.
Fig. 1. Planimetria generale dell�area di scavo.
estratto
240
ELIZABETH COLANTONI ET ALII
alcune delle problematiche inerenti soprattutto le fasi finali dell’occupazione antica, che si datano all’e-tà tardo-imperiale romana e tardo-antica. Lo scavo in corso offre anche un interessante caso di studio per la problematica dei terrazzamenti in opera poligona-le nel Cicolano.
2. Gli scavi a San Martino
Le indagini archeologiche hanno messo parzialmente in luce quelli che possono essere interpretati come i resti della parte produttiva di un grande insediamen-to rurale o villa rustica, che è stato occupato dall’età repubblicana fino al periodo tardo-antico.
L’area produttiva dell’insediamento era collocata a monte, secondo un modello che appare una costan-te delle ville su terrazzamenti. A suffragare l’ipote-si che ci si trovi di fronte ad ambienti legati a una funzione produttiva è la presenza di resti di vasche con rivestimento in cocciopesto e di un grande vaso interrato sotto il livello di calpestio, oltre al rinveni-mento di numerosi frammenti di macine e dolii.
La parte residenziale dell’insediamento potreb-be essere stata collocata sul fronte a guardare a val-le. Non è da escludere neppure che l’insediamento potesse essere articolato su uno o più terrazzamenti superiori. Nell’Area B del sito gli scavi hanno messo in luce un muro, con andamento est-ovest, realiz-zato in grandi blocchi di pietra posizionati a secco, che costituiva a nord il limite della platea sulla quale s’impostavano gli edifici (fig. 2). Parallelo a questo correva un muro di spina che è stato realizzato con spezzoni di tegole allettate di piatto a formare la cor-tina esterna della struttura. Da questo si dipartivano perpendicolarmente altri setti murari.
Nell’Area A gli scavi si sono concentrati sull’in-dagine di un ambiente per la cui fase terminale di frequentazione è assegnabile un terminus post quemdel secondo quarto del VI sec. d.C., come sembra in-dicare il rinvenimento di una piccola moneta del tipo con monogramma (Atalarico?) appena al disotto di uno dei piani pavimentali dell’ambiente. Un saggio stratigrafico condotto nell’ultima campagna sotto lo stesso piano pavimentale ha messo in luce un livel-
lo di crollo, costituito da un ingente quantitativo di tegole ed elementi lignei carbonizzati. Alcuni cam-pioni, presumibilmente resti della travatura di un tetto, sono stati sottoposti ad analisi radiocarbonica (tav. 1). I risultati suggeriscono, in base alla datazione del più recente dei campioni, un terminus post quemdel 390 d.C. circa per lo strato di crollo. Questa cro-nologia sembra essere coerente con quella attribuibi-le ad alcuni frammenti di sigillata africana rinvenuti nel medesimo strato e attualmente in corso di studio.
È infine da ricordare il setto murario che delimita a ovest l’ambiente presenta delle lesioni forse attri-buibili a un evento sismico: un terremoto potrebbe essere stata quindi la causa per la distruzione dell’in-sediamento2. Nella campagna del 2013 è stata inoltre parzialmente indagata una possibile trincea di fonda-zione, ubicata immediatamente a ovest dell’ambien-te dell’Area A. La trincea era riempita con pietrame di piccole e medie dimensioni. Sono stati recuperati anche alcuni materiali ceramici databili tra la fine dell’età repubblicana e la prima età imperiale. Que-sta trincea risulta ad oggi il contesto stratigrafico più antico finora individuato nel corso dello scavo.
A questo proposito va però ricordata anche la presenza di materiali di età medio-repubblicana dai livelli di riempimento, che fa supporre un’occupa-zione ben precedente del terrazzamento rispetto alle strutture finora individuate, in linea quindi con la cronologia del muro in opera poligonale.
2 È noto, d’altro canto, che la vicina Marsica sia stata dall’an-tichità ai nostri giorni soggetta a devastanti terremoti, di cui
proprio in età tardo-antica è ben noto quello che distrusse Alba Fucens: Galadini et al. 2010.
Tav. 1. Risultati radiocarbonici (analisi eseguita da Beta Analytic Inc., Miami).
Lab no. Sample no. Material 13C/12C Ratio
Conventional Radiocarbon Age
Calibrated Age (2σ)
Beta - 357358 Toran134.377 Charred wood -23.9 o/oo 1980 +/- 30 BP 1990-1870 BP (40 BC-AD 80)
Beta - 357359 Toran134.378 Charred wood -23.6 o/oo 1680 +/- 30 BP 1690-1660 BP and 1630-1530 BP (AD 260-300 and AD 320-420)
Fig. 2. Area B in corso di scavo.
estratto
241
L’INSEDIAMENTO RUSTICO D’ETÀ ROMANA E TARDO-ANTICA A SAN MARTINO DI TORANO
di dati di scavo. In alcuni casi, i terrazzamenti in ope-ra poligonale potevano essere funzionali all’esisten-za di aree santuariali, come dimostrato ad esempio dal sito di Sant’Angelo di Civitella (l’unico oggetto d’indagini sistematiche nell’area, ma a cui si possono aggiungere con certezza anche i siti di Sant’Angelo in cacumine montis e di Alzano)5.
In altri casi è invece probabile che questi fossero funzionali alla realizzazione di grandi insediamenti rurali o ville rustiche, come indicano i risultati del-le nostre indagini a San Martino. Una recente ipo-tesi proposta da P. Camerieri e T. Mattioli vede un collegamento tra le strutture in opera poligonale del Cicolano e il percorso delle vie di transumanza che portavano dal reatino al territorio di Alba Fucens6. Secondo questa ricostruzione, la realizzazione delle strutture in opera poligonale del Cicolano sarebbe inoltre direttamente attribuibile all’attività dei coloni di Alba Fucens.
Un altro recente studio, condotto nel quadro del “Pontine Region Project” e pubblicato da T. De Haas, P. Attema e G. Tol, dei terrazzamenti in opera poligonale dei Monti Lepini nel Lazio meridionale, suggerisce alcuni spunti per un altro possibile mo-dello interpretativo dei siti in opera poligonale nella valle del fiume Salto7. De Haas e i suoi colleghi han-no notato che i siti su basamenti in opera poligonale che si trovano nella loro area di studio si collocano in tre contesti topografici e geologici distinti. In due situazioni, ovvero ai piedi e all’interno dell’area mon-tana, i siti s’identificano specificatamente con gran-di insediamenti rustici o ville. Una terza situazione si riscontra in corrispondenza dei pendii calcarei in prossimità delle colonie romane di Norba e Setia e può essere interpretata come relativa a luoghi di cul-to. Gli autori rilevano in particolare che la muratu-ra dei siti con basamenti in opera poligonale mostra in generale una marcata somiglianza con quella dei muri lungo le strade principali delle vicine colonie romane. In base a queste caratteristiche i ricercato-ri olandesi postulano un collegamento esplicito tra le strutture rurali e quelle delle colonie: secondo De Haas e i suoi colleghi, l’élite urbana nelle colonie ro-mane era responsabile della creazione d’infrastruttu-re rurali per scopi commerciali connesse alle aziende agricole produttive costruite sui basamenti in opera poligonale.
Il lavoro di De Haas, Attema e Tol ha diverse im-plicazioni per i siti in opera poligonale nella valle del fiume Salto. In primo luogo, esso offre lo spunto per la creazione di un modello per comprendere questi siti in generale. In particolare appare chiaro che essi
3. San Martino: le ragioni dell�insediamento e il qua-dro degli scambi e dei contatti tra età romana e tardo-antica
Lo scavo di San Martino è un interessante caso di studio sull’insediamento nel Cicolano in età romana e tardo-antica. È ipotizzabile, in base ai dati disponi-bili, che fin dall’età repubblicana il sito abbia avuto una funzione preminentemente produttiva. La fortu-na e la lunga durata dell’occupazione possono essere spiegate con la favorevole posizione geografica sulle pendici di un rilievo collinare che domina il fondoval-le del fiume Salto in corrispondenza di una sorgente d’acqua, a poca distanza da un diverticolo della via Tiburtina Valeria che permetteva di raggiungere Alba Fucens. L’analisi dei reperti ceramici (provenienti sia da unità stratigrafiche chiuse, sia da strati di riempi-mento) ha messo in evidenza per il periodo tardo-re-pubblicano/primo imperiale e fino al periodo tardo-romano un buon afflusso di ceramiche prodotte in altri contesti italici e mediterranei, quali ceramiche a pareti sottili di produzione ispanica, sigillate italiche, e più tardi sigillate africane3. Per quel che riguarda l’età tardo-antica, si nota invece la mancanza di ma-teriali d’importazione nelle fasi terminali di vita del sito. Si può quindi ipotizzare che, proprio nel corso del VI sec. d.C., San Martino sia stata isolata dalle direttive del traffico e di scambio di beni d’impor-tazione, che pure continuarono a giungere in alcune aree della penisola italiana fino alla fine del secolo. Una delle ipotesi di lavoro è che il Cicolano sia stato tagliato fuori dai canali di smistamento dei beni d’im-portazione provenienti dall’Africa e da altre aree del Mediterraneo a seguito della discesa dei longobardi in Italia e della creazione del Ducato Longobardo di Spoleto nella seconda metà del VI sec. d.C.4. Sempre riguardo alla ceramica, bisogna inoltre notare la co-spicua presenza di probabili produzioni locali, che in particolare nel periodo tardo-antico si manifestano in una caratteristica produzione d’imitazioni di for-me di sigillata africana.
4. La problematica dei terrazzamenti in opera poligo-nale nel Cicolano
Una delle motivazioni iniziali al progetto di scavo a San Martino è stata l’interesse a realizzare un’indagi-ne campione su uno dei molti terrazzamenti in opera poligonale di cui è costellato il territorio del Cicola-no. La funzione di tali strutture in quest’area appen-ninica non è sempre facilmente definibile in assenza
3 Colantoni et al. 2012. 4 Colantoni et al. 2015.5 Sant’Angelo di Civitella: Alvino 1995, 477-483; Alvino 2013, 103-104. Sant’Angelo in cacumine montis: Morandi 1984, 318-
328. Alzano: Filippi 1984, 176; Armani Martire 1985.6 Camerieri – Mattioli 2010; Camerieri – Mattioli 2011.7 De Haas et al. 2011-2012.
estratto
242
ELIZABETH COLANTONI ET ALII
devono essere studiati e classificati sulla base della loro posizione in termini geologici e topografici, al fine di ricercare quali siano le tendenze all’interno del campione di siti con opera poligonale.
Inoltre De Haas e i suoi colleghi argomentano in maniera convincente che la realizzazione di siti in opera poligonale coincide con l’arrivo dei Romani nell’area e, più precisamente, con la presenza di co-lonie romane8. Si tratta di una questione complessa, in quanto la tecnica dei muri in opera poligonale è di per sé certamente locale anziché romana: questa è una considerazione di cui va sicuramente tenuto conto anche nell’analisi delle strutture in opera po-ligonale del Cicolano.
È anche da ricordare che nel tentativo di analisi delle strutture in opera poligonale del Cicolano con-dotto da Camerieri e Mattioli viene enfatizzato nella nostra area l’apporto di una vicina colonia romana, ovvero Alba Fucens. In conclusione, anche se allo stato attuale manca per il Cicolano uno studio tipo-logico esaustivo delle strutture in opera poligonale presenti nel territorio, si può senz’altro affermare che queste corrispondessero a una pluralità di funzioni. Nella valle del fiume Salto alcune di queste strutture sono certamente a carattere santuariale, ma altret-tanto certo è il fatto che altre, come a San Martino, fossero invece funzionali a grandi insediamenti rurali o ville rustiche.
University of [email protected]
University of [email protected]
Sapienza Università di [email protected]
University of California, Los [email protected]
Provincia di [email protected]
8 Cfr. Becker 2012.
Bibliografia
“Santuari, culti e paesaggio in un’area italica: il Cicolano”, QuadAEI, 12, 475-486.
G. 2013: “Sabina e Cicolano: archeologia, storia e territo-rio”, Lazio e Sabina, 9, 97-104.
E. 1985: “Resti archeologici in località Monte Fratta di Alzano”, Xenia, 9, 15-40.
J.A. 2012: “Polygonal Masonry and Republican Villas? The Problem of the Basis Villae”, inN. (eds.), Roman Republican Villas. Architecture, Context, and Ideology, Ann Arbor, 111-128.
. 2010: “Le mura poligonali del Cicola-no alla luce di recenti ricerche su transumanza e agro centuriato in Alta Sabina”, in . (eds.), La Valle del Salto nei disegni e nei racconti dei viaggiatori europei dell�Ottocento. Il caso delle mura poligonali, 19-37 (http://valledelsalto.it/images/pdfs/quaderno3.pdf).
T. 2011: “Transumanza e agro centuria-to in alta Sabina, interferenze e soluzioni gromatiche”, Lazio e Sabina, 7, 111-127.
et al. 2009: ., “Indagini archeologiche presso la chiesa di San Marti-
no a Torano (Borgorose)”, Lazio e Sabina, 5, 133-139.et al. 2011:
R., “Testimonianze di età preistorica, romana e medievale
dall’area archeologica di San Martino a Torano (Borgorose): le campagne di scavo 2008-2009”, Lazio e Sabina, 7, 157-163.
et al. 2012: C “Materiali ceramici di età romana e
tardo-antica dall’area archeologica di San Martino a Torano di Borgorose (Rieti)”, Lazio e Sabina, 8, 181-186.
et al. 2015: ., “La ceramica dai contesti
tardo antichi di San Martino a Torano (Borgorose RI)”, in (eds.), Le forme della crisi.
Produzioni ceramiche e commerci nell�Italia centrale tra Romani e Longobardi (III-VIII sec. d.C.) (Atti del Convegno, Spoleto-Cam-pello sul Clitunno, 5-7 ottobre 2012), Bologna, 493-498.
et al. 2011-2012: ., “Polygonal Masonry Platform Sites in the Lepine
Mountains (Pontine Region, Lazio, Italy)”, Palaeohistoria, 53-54, 195-282.
G. 1984: “Recenti acquisizioni su abitati e luoghi di culto nell’ager Aequiculanus”, QuadAEI, 6, 165-177.
et al. 2010: E., “Archaeoseismological evidence of a disruptive Late Antique earthquake at Alba Fucens (central Italy)”, Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata, 51, 143-161.
A. 1984: “Epigrafia latino-italica del Cicolano. Per una definizione etnica degli Aequicoli”, ArchCl, 36, 299-328.
estratto
313
Sommario
RICERCHE SULLE VILLE DEL LATIUM
Le ville del : temi di ricerca .....................................................................................................................13Elena Calandra
La villa romana in Sabina: e spunti di riflessione ...............................................................17Giovanna Alvino � Francesca Lezzi
La villa romana in località Formello a Palombara Sabina (Roma): nuove acquisizioni sull’area archeologica e sulle sculture ................................................................................................................................27Zaccaria Mari � Massimiliano Papini
La fase augustea nelle ville del territorio di Ciampino (Roma) da vecchi e nuovi scavi .................................35Alessandro Betori
Brevi annotazioni per una nuova proposta di lettura del “Ninfeo dorico” di Castel Gandolfo (Roma) .......45Massimiliano Valenti
Disegni e manoscritti del Settecento: nuovi dati sulle ville dell’Beatrice Cacciotti
: il rapporto dialettico tra villa e paesaggio nel contesto del lago di Nemi ..............................63Giuseppina Ghini � Alessia Palladino
“Fabriche antiche in sul colle”. Una villa imperiale in località Poggi d’Oro a Velletri (Roma) .....................75Noemi Tomei � Pamela Cerino � Micaela Angle
Ville rustiche dell’Sandra Gatti
L’arredo scultoreo nelle ville del . “ ” ...............................................97Marina Caso
I rivestimenti pavimentali come indicatori delle dinamiche insediative nel Lazio meridionale ...................107Francesca Sposito
Gianola (Formia, Latina). Una grande villa costiera tra innovazioni architettoniche e arredi scultorei .....117Nicoletta Cassieri
estratto
314
SOMMARIO
SCAVI IN CONCESSIONE
. I risultati della seconda campagna di scavo a Vacone (Rieti) ............131Dylan Bloy � Giulia Masci � Candace Rice � Tyler Franconi � Gary D. Farney � Matthew Notarian
“Proyecto ”: risultati della campagna di scavi 2014..........................................................................139Valeria Beolchini � Pilar Diarte Blasco � Leonor Peña-Chocarro
Indagini archeologiche presso la “Villa degli Antonini” (Genzano di Roma) ..............................................149Deborah Chatr Aryamontri � Michele Di Filippo � Greg Pope � Timothy Renner
Il : risultati della seconda campagna di ricerche ........................................................................157Francesco Maria Cifarelli � Federica Colaiacomo � Stephen Kay � Christopher Smith � Letizia Ceccarelli � Camilla Panzieri � Dimosthenis Kosmopoulos � Alice James
RICERCHE E PROGETTI
Un deposito votivo di obliterazione e/o espiazione nell’area sacra delle SS. Stimmate a Velletri ................169Luciana Drago � Chiara Fanelli � Francesca Farroni Gallo � Cecilia Predan � Donata Sarracino
Il recupero urbano del teatro romano di Ferentino (Frosinone): prime indagini archeologiche .................177Emmanuela Caserta � Sandra Gatti � Giorgio Troja
Un tratto della e un sepolcreto tra e (Ceprano, Frosinone) ....................185Carlo Molle � Sara Marandola
: il recupero di una città antica ...............................................................................................................193Stefania Quilici Gigli � Stefania Ferrante
: città e territorio .......................................................................................................................................203Giovanna Rita Bellini
SEZIONE POSTER
Le ricognizioni di Lukas Holste lungo le vie consolari. Documenti inediti e poco noti ...............................217Lucio Benedetti
Riletture archeologiche dal sito di (Fara in Sabina, Rieti): alcuni dati preliminari .................221Marco Cavalieri
Agro curense (Nerola, Roma). Note topografiche e archeologiche sulla villa romana di Colle S. Pietro ...225Emanuele Brucchietti
Ricognizioni territoriali 2014 nella Conca Velina. Nuovi dati topografici sul periodo protostorico dai siti di Paduli di Monte Cornello (Colli sul Velino, Rieti) e Vicenna Riara (Rieti) .......................................229Alessandro Jaia � Carlo Virili � Clelia Alfonsi � Simone Amici � Luca Coppa � Giulia Ranelli � Eleonora Toti
La villa di Cottanello (Rieti): nuove indagini e ricerche sui materiali ............................................................233Carla Sfameni � Valerio Bruni � Alessandra Caravale � Flavia Campoli � Francesca Colosi �Alessandra Costantini � Eleonora Gasparini
L’insediamento rustico d’età romana e tardo-antica a San Martino di Torano (Borgorose, Rieti): lo stato delle ricerche .........................................................................................................................................239Elizabeth Colantoni � Gabriele Colantoni � Maria Rosa Lucidi � Jeffrey A. Stevens � Francesco Tommasi
estratto
315
SOMMARIO
Il paesaggio urbano di Rieti: presenze antiche ritrovate .................................................................................243Giovanna Alvino � Francesca Lezzi
Una cucina a Rieti intorno alla metà del XIII secolo ......................................................................................247Giovanna Alvino � Francesca Lezzi � Francesca Santini
Il santuario della Madonna del Ronci a Roccagiovine (Roma) ......................................................................251Chiara Carloni � Giulio Carconi � Zaccaria Mari � Sergio Sgalambro
Il territorio di Bellegra (Roma): contributo alla conoscenza di un centro fortificato in opera poligonale ...........................................................................................................................................................255Irene Ullucci
Complesso funerario di età imperiale e cava lungo viale Ungheria a Zagarolo (Roma) ...............................261Zaccaria Mari � Maria Cristina Recco
Un monumento funerario di età romana in via di San Giacinto a Frascati (Roma) ....................................265Fabio Turchetta
Strutture arcaiche e riti di fondazione nelle terre di Ariccia ...........................................................................269Alessia Palladino
La seconda campagna di scavo nel versante occidentale del Santuario di Giunone Sospita, a cura del Museo Civico Lanuvino.....................................................................................................................................273Luca Attenni � Gemma Carafa Jacobini
Il regime delle offerte nell’area sacra delle SS. Stimmate a Velletri: l’Luciana Drago
Rilievi nella parte a mare della villa di Gianola a Formia (Latina) ................................................................281Fabrizio Pesando � Michele Stefanile
Comparing Landscapes: the castle of Ambrifi (Lenola, Latina) and the N-LINK project ..........................285Sabrina Pietrobono � Sam Turner
Nuove ricerche nella villa imperiale di Sperlonga (Latina): tracce di un rivestimento litico parietale nell’edificio a peristilio ......................................................................................................................................289Elena Belgiovine � Daniele Capuzzo
e il suo territorio: indagini archeologiche 2013 ................................................................293Giovanna Rita Bellini � Sophie Hay � Alice James � Alessandro Launaro � Ninetta Leone � Martin Millett
La della Spianata San Marco (Atina-Frosinone) .................................................................................301Valentina Azzalea
Insediamento dell’età del Bronzo in località Piano la Mola (Pofi, Frosinone) .............................................305Italo Biddittu � Alessandra Celant � Valerio Comerci � Marco Germani � Sara Marandola � Elena Soriano
Nuovi dati sull’anfiteatro di (S. Giovanni Incarico, Frosinone): gli scavi dell’Università di Perugia (1996-1997) .............................................................................................................309Simona Consigli
Abbreviazioni .....................................................................................................................................................313
estratto






















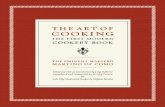


![I nostri rifiuti dalla preistoria all’età moderna, San Martino in Rio 2004, pp. 28-43 [Donato Labate].](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631f1ff73b43b66d3c0f9f37/i-nostri-rifiuti-dalla-preistoria-alleta-moderna-san-martino-in-rio-2004-pp.jpg)





