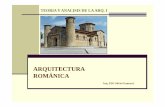L’insediamento rupestre di Santa Restituta (Tarquinia, VT):la fase romanica, in “Scienze...
Transcript of L’insediamento rupestre di Santa Restituta (Tarquinia, VT):la fase romanica, in “Scienze...
EDIZIONI QUASAR
SCIENZE DELL’ANTICHITÀ
19 – 2013
Fascicolo 1
«Ricerche del Dipartimento»
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMADIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITÀ
ESTRATTO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’ANTICHITÀ
DirettoreEnzo Lippolis
Comitato di DirezioneMaria Giovanna Biga, Savino Di Lernia, Eugenia Equini Schneider,
Giovanna Maria Forni, Gian Luca Gregori, Laura Maria Michetti, Frances Pinnock, Loredana Sist, Maurizio Sonnino, Eleonora Tagliaferro
Comitato scientificoRosa Maria Albanese (Catania), Graeme Barker (Cambridge),
Corinne Bonnet (Toulouse), Alain Bresson (Chicago), Jean-Marie Durand (Paris), Alessandro Garcea (Lyon), Andrea Giardina (Firenze), Michel Gras (Roma),
Henner von Hesberg (Roma-DAI), Tonio Hölscher (Heidelberg), Mario Liverani (Roma), Paolo Matthiae (Roma), Athanasios Rizakis (Atene), Guido Vannini
(Firenze), Alan Walmsley (Copenhagen)
RedazioneLaura Maria Michetti
SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ESTRATTO
Presso le pendici occidentali del pianoro della Civita di Tarquinia si impianta nell’alto medioe-vo un insediamento a carattere sacro che vive come luogo di culto fino al tardo medioevo, costituito da alcuni ambienti rupestri che, molto probabilmente, rappresentano il fulcro dell’insediamento stesso, che successivamente viene accresciuto con la realizzazione di ambienti costruiti.
Lungo questa parte del costone roccioso, sul limite del versante nord, fu individuato da Romanelli, durante gli scavi condotti alla metà del secolo scorso, un piccolo santuario addossa-to sul limite della collina1. Di questo rimaneva soltanto la parte basamentale a pianta circolare, definita appunto “basamento semicircolare”, di un piccolo sacello o di un’edicola che doveva rivestire carattere salutare, come interpretato dallo studioso sulla base delle terrecotte votive rinvenute2. Mancano viceversa ad oggi attestazioni dello sfruttamento della parete rocciosa per la realizzazione di tombe a camera, presenti al contrario sul versante nord-est, dove sono state rinvenute più tombe a camera pertinenti alla fase etrusca3, mentre poco più a sud dell’insedia-mento si sono rinvenute tombe del tipo a cappuccina ed a fossa semplice, conferendo all’area una valenza funeraria soltanto nella fase più tarda.
La scelta del sito sarebbe da ricondurre in parte alla sua posizione strategica ed in parte alla presenza dell’acqua. Infatti l’insediamento è posto in un punto dove convergono i tratti stradali che in antico collegavano la costa con la città di Tarquinia e proseguivano verso l’inter-no4. Altro elemento di fondamentale importanza, come abbiamo detto, è l’acqua, attestata da una vena che tuttora sgorga alla base della parete rocciosa, nelle immediate vicinanze dell’inse-diamento e all’interno dell’ipogeo stesso, che costituisce un’utile risorsa per la sopravvivenza della comunità, e che rappresenta un elemento sacro in tutte le società antiche.
B.C. - G.M.
1 Gli scavi condotti dal Romanelli sono stati ef-fettuati a più riprese nel 1934-38 e 1946: roManelli 1950, pp. 214-218. Per una revisione delle mura della città di Tarquinia vd. G. BagnaSco gianni cds.
2 Per l’analisi dei materiali rinvenimenti vd. MaS-Si 1998-99; Quagliuolo 2011-12, pp. 111-114.
3 perego cds. 4 Molto probabilmente la strada, che aveva ori-
gine dalla linea di costa, lambiva la sponda sinistra del
fiume Marta, passava lungo le pendici nord del piano-ro di Corneto, scendeva nella valle del San Savino per risalire sul pianoro della Civita. Questa viabilità nota nel periodo medievale ne ricalca una più antica di fase etrusca che collegava, partendo dalla linea di costa, l’insediamento portuale con la città di Tarquinia. Sul rapporto tra la città e la viabilità in età etrusca vd. Ha-rari 1997. Per un’introduzione alla viabilità medievale vd. Maggiore - Serchia 2011.
Beatrice caSocavallo – giulia Maggiore
L’INSEDIAMENTO RUPESTRE DI SANTA RESTITUTA (TARQUINIA, VT): LA FASE ROMANICA
ESTRATTO
348 B. Casocavallo – G. Maggiore Sc. Ant.
analiSi delle Fonti pertinenti il MonaStero del San Salvatore al Monte aMiata
L’analisi delle fonti documentarie attesta che gran parte del territorio tarquiniese appar-teneva al monastero del San Salvatore al Monte Amiata, già a partire dal IX secolo5. Nell’alto medioevo il monastero benedettino opera un’importante politica espansionistica nella Tuscia, finalizzata al controllo della viabilità e allo sfruttamento del territorio, attuata attraverso la creazione di celle monastiche poste in punti strategici. Una di queste celle è da identificare con quella di Santa Restituta, oggetto dell’indagine archeologica6.
L’area compresa tra Tuscania, Tarquinia e Montalto di Castro risulta essere una delle zone di maggiore concentrazione delle pertinenze amiatine, nonostante sia la più distante dal ceno-bio. La prima menzione della cella di Santa Restituta risale all’8167. Con questo documento a Compiègne l’imperatore Ludovico il Pio conferma all’abate Audoaldo l’immunità per il mo-nastero ed il possesso di alcuni beni, come già riconosciuti da Carlo Magno. I possedimenti vengono in seguito confermati attraverso una serie di diplomi regali e imperiali nel periodo compreso tra il IX e il XII secolo8. Nell’XI e XII secolo sia le proprietà demaniali che quelle acquistate privatamente entrano a far parte della proprietà effettiva del monastero9.
Nel XII secolo, come molti monasteri italiani, San Salvatore vive un periodo di crisi eco-nomica, situazione che tende a migliorare alla fine del secolo, soprattutto con l’abate Rolando.
5 Per un’analisi più approfondita della presenza del San Salvatore al Monte Amiata in area tarquiniese vd. da ultimo Maggiore cds.
6 Nel periodo compreso tra il IX e il XIV secolo, la maggior parte dei documenti provengono dal Fon-do Diplomatico del Monastero del San Salvatore al Monte Amiata, conservato presso l’Archivio di Stato di Siena (ASS) e consistono perlopiù in diplomi regali e imperiali ma anche in privilegi papali, questi ultimi presenti a partire dal XII secolo. Fino al XII secolo questi sono stati editi da W. Kurze (cda I e II).
7 cda, I, pp. 152-154, n 77 del 17 novembre 816. 8 Questi possedimenti e beni vengono successiva-
mente confermati da Lotario nell’837 (cda, I, pp. 244-245, n. 115 del 27 ottobre 837), nell’853 da Ludovico II all’abate Adalberto (cda, I, pp. 279-281, n. 132 del 4 luglio 853), da Arnolfo all’abate Pietro nell’896 (cda, I, pp. 358-360, n. 170 del 27 febbraio 896), dall’imperato-re Berengario nel 915 (cda, I, pp. 398-399, n. 189 dell’ 8 dicembre 915), dai re Ugo e Lotario nel 937 (cda, I, pp. 416-418, n. 198 del 5 ottobre 937), dall’imperatore Ot-tone I nel 962 (cda, II, pp. 3-4, n. 200 del 21 febbraio 962). Nel 964 a Lucca, su richiesta dell’abate Gisilber-to, l’imperatore Ottone I conferma la sua protezione al monastero (cda, II, pp. 8-9, n. 202 del 3 agosto 964). Nel 996 a Roma l’imperatore Ottone III conferma al monastero amiatino, sotto la guida dell’abate Winizo, i suoi possedimenti (cda, II, pp. 34-36, n. 212 del 25
maggio 996). A Regensburg, nel 1007, l’imperatore Enrico II conferma all’abate Winizo i possedimenti, il pagamento delle tasse e garantisce la difesa al mo-nastero (cda, II, pp. 73-75, n. 227 del 10 aprile 1007). Ancora nel 1027 è attestato il diploma dell’imperatore Corrado II, rogato a Roma, con il quale vengono con-fermati all’abate Winizo i possedimenti del monastero del San Salvatore e i diritti sulle tasse (cda, II, pp. 157-160, n. 263 del 5 aprile 1027). Nel 1153 è documentato un privilegio con il quale papa Anastasio IV, presso San Giovanni in Laterano, conferma all’abate Rainerus la propria protezione e alcuni possedimenti al Mona-stero del San Salvatore al Monte Amiata, come già il suo predecessore Celestino II (cda, II, pp. 337-343, n. 345 del 23 ottobre 1153). Nel 1188, a Roma, presso San Giovanni in Laterano, papa Clemente III prende sotto la sua protezione il monastero e conferma tutti i diritti sulle sue dipendenze nel territorio, garantendo i privi-legi concessi dai suoi predecessori Leone IX, Celestino II e Anastasio IV (cda, II, pp. 355-358, n. 353 del 19 febbraio 1188). Nel 1198 è documentato il privilegio rogato a Roma, presso San Pietro in Vaticano, da papa Innocenzo III, il quale, come i suoi predecessori Cele-stino II, Anastasio IV e Clemente III, ripete la confer-ma all’abate Rolando del monastero del San Salvatore il possesso dei beni e delle chiese (cda, II, pp. 388-391, n. 370 del 10 giugno 1198).
9 kurze 1988, p. 12.
ESTRATTO
19.1, 2013 L’insediamento rupestre di Santa Restituta 349
Dalle carte è possibile comprendere che la gestione di queste proprietà avviene almeno fino al XII secolo grazie al nucleo delle celle presenti nel territorio, vale a dire Santa Restituta, San Savino, Santo Stefano e San Pietro; a partire dalla fine dello stesso secolo il controllo sarebbe stato affidato alla chiesa di San Fortunato, dipendenza amiatina posta all’interno del centro cittadino di Corneto, la quale avrebbe assunto anche la cura delle celle più antiche e di con-seguenza anche la gestione degli appezzamenti di terreno da loro amministrati, dimostrando il nuovo assetto territoriale e una nuova politica gestionale da parte del monastero stesso. È possibile in questo momento ricavare notizie anche sulla localizzazione di questi possedimenti, che dovevano concentrarsi nella bassa valle del fiume Marta.
Il XIII secolo è caratterizzato dalla cessione da parte del pontefice, Gregorio IX, dell’ab-bazia all’ordine dei Cistercensi, confermata nel 1231 da Federico II. A quest’ultimo si deve un incremento delle proprietà abbaziali e dei privilegi10.
Durante il XIII e il XIV secolo la presenza del monastero del San Salvatore nel territorio tarquiniese-cornetano è ancora attestata dalla documentazione. Nei documenti della fine del XIII e del XIV secolo le vicende delle ecclesiae tarquiniesi di pertinenza amiatina sempre più si intrecciano con la storia locale di Tarquinia e Corneto, nonché delle loro famiglie più influenti, come ad esempio dimostra la carta del 1277, che attesta la causa intentata dal monastero contro Pandolfo de Tarquinio, che probabilmente si era impossessato illegalmente delle terre spettanti al monastero stesso11. All’inizio del 1300 le ecclesiae di Santa Restituta e San Savino poste nel distretto di Tarquinia, di competenza del monastero amiatino ab ei tempore, cuius memoria non existit, vengono concesse in enfiteusi perpetua, in cambio di un canone annuo, ad un espo-nente di una delle famiglie più importanti di Corneto, quella dei Vitelleschi, in particolare il figlio Pandolfo di Boccavitello dei Vitellesi (Vitelleschi), Pietro12, definito dominus de Corneto. All’interno del documento vengono anche specificati i confini delle proprietà relative a queste ultime, che rimangono sotto la cura di San Fortunato. Nel 1381 frate Pio, abate del monastero, conferisce a frate Benedetto la prepositura della chiesa di San Fortunato di Corneto e la cura delle pertinenze e dei beni delle chiese di San Savino e Santa Restituta de Terquino13. Infine nel 1385 il cardinale Pileo, vescovo di Tuscania, legato apostolico, conferma la prepositura perpetua di San Fortunato di Corneto a frate Benedetto di Gerardo, monaco di San Salvatore, già istituito in questo incarico dall’abate. Quest’ultimo detiene anche la cura e la prepositura delle chiese, definite a questo punto rurali, di San Savino e Santa Restituta nel tenimentum Tarquinii14.
G.M.
10 gorMan 2007, pp. 20-22.11 a.S.S., Fondo Diplomatico del Monastero San
Salvatore al Monte Amiata, c. 227, n. 819 del 2 aprile 1277, Ind. V
12 Pietro di Pandolfo di Boccavitello è nominato in un documento del 27 settembre del 1305, Ind. III, all’interno della Margherita Cornetana (Supino 1969,
pp. 199-203, n. 248); Boccavitello Vitelleschi è iden-tificabile con il podestà e rettore di Corneto nel 1251 (tiBeri 1996, p. 2).
13 a.S.S., Fondo Diplomatico del San Salvatore al Monte Amiata, c. 1078, n. 2207, del 20 aprile 1381.
14 a.S.S., Fondo Diplomatico del San Salvatore al Monte Amiata, c. 1103, n. 2226, del 12 febbraio 1385.
ESTRATTO
350 B. Casocavallo – G. Maggiore Sc. Ant.
l’indagine archeologica. la chieSa
Le ricerche avviate nel 1999 dalla Cattedra di Archeologia Medievale della Sapienza Uni-versità di Roma15, sotto la direzione scientifica prima della prof.ssa Letizia Ermini Pani e poi della prof.ssa Francesca Romana Stasolla, hanno permesso di individuare presso le pendici sud-occidentali della Civita di Tarquinia (Fig. 1), un vero e proprio complesso, che si articola in una serie di ambienti ipogei, quali l’aula di culto collegata a due vani interpretabili il primo come romitorio ed il secondo come ambiente di servizio, e un’area funeraria16.
Questo tipo di insediamento, che vede nella componente rupestre il suo nucleo originario, costituito dall’aula di culto, trova confronti nell’area alto-laziale con diversi complessi rupestri, tra i quali quelli di Santa Maria del Parto17 e Santa Fortunata18 a Sutri, San Giovanni a Pollo a Bassano di Sutri19 e Santa Maria di Monte Casoli a Bomarzo20. Questi esempi mostrano, simil-
15 Si vuole ringraziare la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale nella fi-gura del Soprintendente Dott. Alfonsina Russo, e la Dott. M.G. Scapaticci; il Comune di Tarquinia per aver sostenuto economicamente in tutti questi anni il cantiere di scavo, e tutti gli allievi della I Scuola di Specializzazione e dei corsi di Laurea di Archeologia Medievale e Topografia Medievale della Sapienza
Università di Roma e della facoltà di Beni Culturali dell’Università della Tuscia di Viterbo che in questi anni hanno preso parte alle campagne di scavo.
16 Da ultimo caSocavallo et al. 2011, pp. 193-202.17 raSpi Serra 1976, pp. 83, 91, 71-75. 18 Finocchio 2011, pp. 183-186.19 cippittelli 2011, pp. 187-190. 20 cippittelli - Screpante 2011, pp. 37-45.
Fig. 1 – Tarquinia, insediamento rupestre di Santa Restituta, ubicazione del sito.
ESTRATTO
19.1, 2013 L’insediamento rupestre di Santa Restituta 351
mente al caso analizzato, confronti anche per quanto riguarda l’am-pliamento delle aule di culto con la costruzione di strutture murarie21. Nel caso di Tarquinia lo sviluppo edilizio realizza, attraverso più fasi, un vero e proprio complesso, concentrato intorno all’aula di cul-to (Fig. 2).
Uno dei momenti di maggio-re sviluppo è quello riconducibile al periodo romanico, individuato durante le campagne di scavo degli ultimi anni e ancora in fase di definizione.
In questo momento l’aula di culto originaria, costituita dall’ambiente ipogeo, definito Ambiente 2, viene ampliata attraverso la costruzione di un vano quadrangolare, Ambiente 1; lo spazio sepolcrale che si sviluppa tutto intorno all’edificio viene delimitato con la costruzione di una poderosa struttura muraria. Contestualmente si adegua al nuovo impianto la più antica opera di canalizzazione delle acque, che dal catino absidale dell’Ambiente 2, vengono in questo modo convogliate verso l’esterno22. Le strutture pertinenti all’Ambiente 1 sono caratterizzate da un doppio paramento costituito da conci squadrati di calcare fossilifero legati da malta di calce ed un nucleo interno compo-sto da bozze di calcare e pietra di medie dimensioni legate da malta. I conci sono disposti in filari oriz-zontali regolari, legati da sottili letti di malta. La cortina esterna è caratterizzata da una fine decora-zione architettonica con semico-lonne (Fig. 3), mentre l’interno do-veva, molto probabilmente, recare tracce di affresco come dimostra, la presenza negli strati di crollo in-dividuati all’interno dell’Ambien-te, di blocchi con tracce di colore;
21 Lo sviluppo planimetrico delle aule di culto at-traverso una fase edilizia non trova confronti nell’area falisca, dove il fenomeno rupestre non sembra esserne coinvolto: sono presenti soltanto rari episodi pittorici che definiscono e connotano gli ipogei come luoghi di culto. Sull’area Falisca vd. Fiordiponti 2011, pp. 25-36.
22 Il canale all’interno dell’Ambiente 2 è ricavato
direttamente nel banco calcareo, con un taglio di circa 80 cm molto profondo che in alcuni punti raggiunge il metro di profondità, mentre all’esterno viene realizza-to tagliando i piani di terreno e misura circa 35 cm di larghezza con una profondità costante di circa 30 cm con pareti rivestite da blocchi di calcare e copertura a blocchi sempre di calcare.
Fig. 2 – Tarquinia, insediamento rupestre di Santa Restituta, veduta dell’insediamento da nord-ovest.
Fig. 3 – Tarquinia, insediamento rupestre di Santa Restituta, struttura muraria USM 8, paramento esterno.
ESTRATTO
352 B. Casocavallo – G. Maggiore Sc. Ant.
inoltre sul paramento interno set-tentrionale sono ancora leggibili alcune croci incise (Fig. 4). Ulte-riore elemento decorativo sono le semicolonne in nenfro poste a segnare il punto di congiunzio-ne tra i due ambienti, enfatizza-te dalla presenza di basi. Una di queste è costituita da un blocco di marmo lunense di grandi dimen-sioni che recava iscrizioni su due lati, la più tarda delle quali risale al VI sec. d.C.23.
L’indagine all’interno del vano, tuttora in corso, ha per-messo di individuare una succes-sione stratigrafica rappresentata dall’alternanza di fasi di frequentazione e di abbandono, sigillata dal crollo delle strutture, che determinerà l’obliterazione definitiva nel XVI-XVII secolo. Il piano pavimentale, del quale
rimangono soltanto alcuni lacerti è costituito da fram-menti di lastre di marmo di diversi tipi e dimensioni ed è caratterizzato nella porzione centrale, in corrispondenza dell’accesso al vano ipogeo, da una partitura a mosaico con l’utilizzo quasi esclusivo di tessere bianche (Fig. 5) e sporadiche tessere di colore nero che disegnano una ban-da di delimitazione rintracciata in un lacerto conservato per poco meno di 20 cm. Questa pavimentazione mol-to probabilmente è da mettere in relazione con il piano pertinente alla fase più antica che viene comunque man-tenuto in uso fino al periodo romanico, attraverso una serie di interventi di restauro con continue sovrapposi-zione tra tegole e marmi, individuati soprattutto nella porzione meridionale, presente in lacerti nell’Ambien-te 2. In un momento successivo il pavimento viene inte-ressato da un taglio finalizzato al posizionamento di una sepoltura (Tomba 23) posta nella porzione meridionale dell’Ambiente 1. La tomba, unica attestazione funeraria ad oggi individuata all’interno della chiesa, è costituita da un sarcofago rettangolare in calcare di piccole dimensio-
23 torelli 2006, pp. 249-286.
Fig. 4 – Tarquinia, insediamento rupestre di Santa Restituta, struttura muraria USM 8, paramento interno.
Fig. 5 – Tarquinia, insediamento rupestre di Santa Restituta, Ambiente 1, lacerti di mosaico relativi alla pavimentazione del-la chiesa.
ESTRATTO
19.1, 2013 L’insediamento rupestre di Santa Restituta 353
ni (0,80 x 0,36 m) privo di copertura, all’in-terno del quale sono stati individuati i resti scheletrici in giacitura primaria appartenenti ad un infante. Questo, orientato sud-ovest/nord-est, era posto in decubito dorsale, con gli arti superiori distesi lungo il corpo e quelli inferiori distesi parallelamente (Fig. 6). Lo sta-to di conservazione dello scheletro era stato compromesso in corrispondenza del cranio, da un taglio, riferibile ad uno dei tanti inter-venti di spoliazione che hanno interessato la chiesa nelle fasi successive. L’ultimo livello di frequentazione riferibile alla fase romanica è testimoniato da un piano composto da terra e bozze di calcare di piccole dimensioni, che si estende in modo piuttosto uniforme in tutto l’Ambiente, coprendo la pavimentazione in mosaico e marmo, che in questo modo viene obliterata. Come sopra accennato alla fase ro-manica seguono alcune fasi di frequentazione a carattere rurale, durante le quali vengono messi in atto una serie di interventi di spolia-zione della struttura.
la necropoli
Nella più antica fase di frequentazione dell’insediamento, databile al IX secolo, oltre alla chiesa, è attestata anche la presenza di un’area destinata a necropoli caratterizzata da sepolture ipogee, che si sviluppa lungo la parete roccio-sa, ad oggi testimoniata soltanto nella porzio-ne nord dell’insediamento (Fig. 7).
Nella fase romanica, diversamente, le tombe occupano l’intera area circostante la chiesa, che viene delimitata in questo mo-mento con una struttura muraria, ad oggi in-dividuata nella sua porzione meridionale, con orientamento nord-sud, costituita da un filare unico di blocchi di grandi dimensioni di cal-care e nenfro (Fig. 8). Sono state riconosciute due fasi di utilizzo della necropoli, individua-te sulla base della successione stratigrafica.
Fig. 6 – Tarquinia, insediamento rupestre di Santa Re-stituta, Ambiente 1, Tomba 23.
Fig. 7 – Tarquinia, insediamento rupestre di Santa Re-stituta, prima fase.
ESTRATTO
354 B. Casocavallo – G. Maggiore Sc. Ant.
La prima fase, contemporanea alla costruzione dell’Ambiente 1, è rappre-sentata ad oggi esclusivamente da tombe costituite da una fossa con pareti rivesti-te da lastre e blocchi di calcare e nenfro e copertura litica. Queste sono realizzate tagliando i piani di frequentazione relativi all’area esterna, composti da sottili battuti di terra e piccole bozze di calcare, contem-poranei al primo periodo di frequentazio-ne della chiesa. Sono attribuibili a questa fase almeno quattro sepolture, individuate una ad ovest della chiesa (Tomba 18) che presenta un orientamento nord-ovest/sud-est, una a sud (Tomba 20) con orien-tamento ovest-est, e due poste nell’area nord (Tombe 24 e 26) tutte posizionate ri-spettando l’orientamento ovest-est.
La Tomba 18 (2 x 0,76 m) ospitava lo scheletro in connessione anatomica di un adulto di sesso maschile deposto in decu-bito dorsale con l’arto superiore sinistro flesso e poggiato sull’addome e il destro disteso parallelamente al corpo, mentre gli arti in-feriori erano distesi parallelamente (Fig. 9). La Tomba 20 (2,20 x 1,24 m), posta a ridosso del muro perimetrale sud della chiesa (USM 45) è una sepoltura molto particolare perché uti-lizzata per due deposizioni, l’unica bisoma finora individuata nello scavo; all’interno erano posizionati due adulti di sesso maschile in decubito dorsale, deposti contemporaneamente.
Entrambi presentavano il cranio ruota-to verso sinistra, gli arti superiori flessi e poggiati sul torace e sull’addome, con gli arti inferiori distesi parallelamente (Fig. 10). Le due tombe presenti nell’a-rea nord (Tombe 24 e 26) erano poste a ridosso degli ambienti rupestri nello stretto spazio compreso tra gli ambien-ti, il muro perimetrale nord della chiesa (USM 8) e una struttura muraria a filare unico che corre parallela alla parete roc-ciosa (Fig. 11). La Tomba 24 (1,89 x 0,92 m) ospitava lo scheletro non in connes-sione anatomica di un adulto deposto in decubito dorsale con l’arto superio-
Fig. 8 – Tarquinia, insediamento rupestre di Santa Restituta, seconda fase.
Fig. 9 – Tarquinia, insediamento rupestre di Santa Restituta, veduta dell’area sud-ovest. In primo piano la Tomba 18.
ESTRATTO
19.1, 2013 L’insediamento rupestre di Santa Restituta 355
re destro disteso parallelamente al corpo e l’arto superiore sinistro leggermente flesso e poggiato sull’addome mentre gli arti inferiori erano distesi parallelamente. Molto probabilmente la sepoltu-ra era stata disturbata dal crollo che copriva la co-pertura stessa della tomba costituita da una lastra litica e due blocchi di calcare. La Tomba 26 (1,36 x 0,52 m) ospitava lo scheletro non in connes-sione anatomica di un adulto deposto in decubi-to dorsale con l’arto superiore destro iperflesso con la mano che poggiava sulla clavicola destra e l’arto superiore sinistro flesso a 90°, mentre gli arti inferiori erano distesi parallelamente. Anche questa sepoltura si presentava disturbata da un taglio che aveva probabilmente asportato la co-pertura e parte delle lastre di rivestimento.
Nella seconda fase lo spazio destinato a ne-cropoli si restringe occupando soltanto la por-zione nord-occidentale della zona prossima alla chiesa, mentre a sud l’area è interessata da una frequentazione attestata da piani costituiti da ter-
ra e calcare, caratterizzati in superficie da focolari, testimoniando un cambiamento di destina-zione d’uso. Nell’area funeraria si assiste ad un progressivo innalzamento dei piani di calpestio, attraverso la sovrapposizione di ingenti accumuli costituiti da terra e bozze di calcare, che sa-ranno interessati in seguito da tagli funzionali al posizionamento in questa seconda fase di due sepolture (Tombe 21 e 22). Le tombe, disposte in prossimità del muro perimetrale nord della chiesa (USM 8), sono in fossa semplice, posizionate rispettando l’orientamento ovest-est della fase precedente e depo-ste sovrapposte. Anche se al momento della messa in luce degli scheletri le ossa dei due individui erano separati solo da una lente di terra, l’osservazione delle modalità tafonomiche ha permesso di escludere la deposizione contempora-nea dei due soggetti. Le sepolture erano state intaccate dai tagli funzionali alla realizzazione di successive deposizioni che avevano asportato la maggior parte dei resti scheletrici. In un momento im-mediatamente successivo, vengono rea-lizzate altre tre sepolture (Tombe 9, 19
Fig. 10 – Tarquinia, insediamento rupestre di Santa Restituta, Tomba 20.
Fig. 11 – Tarquinia, insediamento rupestre di Santa Restituta, veduta dell’area nord. In primo piano la Tomba 26 in fase di scavo, in secondo piano la Tomba 24.
ESTRATTO
356 B. Casocavallo – G. Maggiore Sc. Ant.
e 25), posizionate a ridosso delle strutture perimetrali settentrionali della chiesa (UUSSMM 8 e 26), tutte co-stituite da fosse terragne, in questo caso non si rispetta più l’orientamento ovest-est della fase precedente, in-fatti le sepolture mostrano diversi orientamenti, sfrut-tando gli spazi ancora liberi.
La Tomba 9, con orientamento sud-nord (1,67 x 0,62 m), ha restituito i resti scheletrici di un adulto in decubito dorsale, con il cranio ruotato verso sinistra, gli arti superiori flessi e incrociati sul torace, mentre quelli inferiori, di cui si conserva solo la porzione prossimale, erano probabilmente distesi parallelamente. La Tomba 19, orientata in senso nord-sud, presentava la deposi-zione di un individuo sub-adulto in decubito dorsale con il cranio in vista superiore, del quale si conserva-vano solamente gli arti superiori, a causa dell’aspor-tazione dovuta alla realizzazione di una deposizione successiva. L’ultima deposizione relativa a questa fase è rappresentata dalla Tomba 25, orientata in senso ovest-
est (2 x 0,70 m), che ha restituito lo scheletro, in giacitura primaria, di un individuo adulto di sesso femminile deposto in decubito dorsale, con il cranio a vista, gli arti superiori flessi e in-crociati sul torace e gli arti inferiori distesi parallelamente (Fig. 12). La tomba è coperta da un notevole crollo (US 402) che occupa gran parte dell’area nord; costituito da blocchi squadrati di calcare di medie e grandi dimensioni, grumi di malta e lacerti di affresco (Fig. 13), che attesta una fase di destrutturazione dell’area, rappresentando l’elemento di demarcazione tra la fase romanica e quella successiva. Tutte le tombe rinvenute risultano prive di corredo.
La povertà dei materiali rinvenuti nelle stratigrafie costituiti da esigui frammenti di cera-miche prive di rivestimento e rarissimi frammenti di ceramica rivestita, attribuibili in questa
Fig. 12 – Tarquinia, insediamento rupestre di Santa Restituta, Tomba 25.
Fig. 13 – Tarquinia, insedia-mento rupestre di Santa Re-stituta, veduta dell’area nord, in primo piano lo strato di crollo US 402.
ESTRATTO
19.1, 2013 L’insediamento rupestre di Santa Restituta 357
fase preliminare di analisi ad un arco cronologico compreso tra l’XI e il XIII secolo, è un ulte-riore dato che conferma il tipo di frequentazione del sito, sede di una cella monastica.
In questo periodo l’elemento di maggiore interesse rispetto allo sviluppo del complesso di Santa Restituta, è costituito dalla costruzione della chiesa che rappresenta l’ampliamento dell’aula di culto altomedievale, attribuibile al XII-XIII secolo attraverso l’analisi delle caratte-ristiche architettoniche che trovano confronti nel medesimo periodo con le chiese di Corneto, Cencelle e Tuscania. La maggiore visibilità data dalla nuova costruzione, posta in prossimità della viabilità principale, diretta da Corneto a Viterbo, costituisce l’elemento di attrazione della popolazione residente sul territorio e lo specchio di un rinnovato interesse per questa dipen-denza da parte del monastero del San Salvatore al Monte Amiata.
Beatrice [email protected]
Giulia MaggioreSapienza Università di Roma
Riferimenti bibliografici
BagnaSco gianni cds: G. BagnaSco gianni (ed.), Mura tarquiniesi, cds.caSocavallo et al. 2011: B. caSocavallo - d. aleSSandrelli - g. Maggiore - a. Spina,
L’insediamento rupestre di Santa Restituta a Tarquinia (VT), in de MiniciS 2011, pp. 193-202.cda: W. kurze (ed.), Codex diplomaticus Amiatinus, 2 voll., Tubingen 1974.cippitelli 2011: C. cippitelli, L’insediamento rupestre di San Giovanni a Pollo, in de
MiniciS 2011, pp. 187-190.cippitelli - Screpante 2011: C. cippitelli - M. Screpante, L’abitato rupestre di Monte Ca-
soli, in de MiniciS 2011, pp. 37-45.de MiniciS 2011: E. de MiniciS (ed.), Insediamenti rupestri di età medievale nell’Italia
centrale e meridionale. L’organizzazione dello spazio nella mappatura dell’abitato, Atti del II Convegno Nazionale di Studi (Vasanello 2009), Roma 2011.
Finocchio 2011: G. Finocchio, La chiesa di S. Fortunata a Sutri, in de MiniciS 2011, pp. 183-186.
Fiordiponti 2011: T. Fiordiponti, Analisi dei luoghi di culto rupestri nella Tuscia medie-vale. Chiese e insediamenti monastici nel territorio tra la via Cassia e il Tevere, in de MiniciS 2011, pp. 25-36.
gorMan 2007: M. gorMan, Codici manoscritti dalla Badia Amiatina nel secolo XI, in M. Marrocchi - c. prezzolini (eds.), La Tuscia nell’Alto e Pieno Medioevo. In memoria di Willhelm Kurze, Firenze 2007, pp. 15-102.
Harari 1997: M. harari, Tarquinia e il territorio suburbano nel rilevamento ad alta quo-ta: una lettura topografica, in Tarchna I, 1997, pp. 5-17.
ESTRATTO
358 B. Casocavallo – G. Maggiore Sc. Ant.
kurze 1988: W. kurze, Il Monastero di San Salvatore al Monte Amiata e la sua proprietà terriera, in W. kurze - c. prezzolini (eds.), L’Abbazia di San Salvatore al Monte Amiata: do-cumenti storici, architettura, proprietà, Firenze 1988, pp. 1-26.
Maggiore - Serchia 2011: G. Maggiore - i. Serchia, La viabilità medievale nel terri-torio di Corneto (Tarquinia-VT): l’accesso nord-occidentale alla città attraverso la via cava, in Archeologia delle strade. La viabilità in età medievale: metodologie ed esempi di studio a confronto, Atti del Convegno Nazionale di Studi (Viterbo-Roma 2009), Roma 2011, pp. 35-44.
Maggiore cds: G. Maggiore, Presenze monastiche nel territorio di Tarquinia, in ASRSP, in stampa.
MaSSi 1998-99: E. MaSSi, La Civita di Tarquinia: il “basamento semicircolare” e l’annesso deposito votivo, Tesi di Specializzazione in Archeologia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, a.a. 1998-1999.
perego cds: L. perego, La struttura monumentale delle Morre a Pian di Civita. Nota preliminare, in SteingräBer cds.
Quagliuolo 2011-12: A. Quagliuolo, Gli scavi di Pietro Romanelli alla Civita di Tar-quinia: studio e contestualizzazione dei materiali (Ara della Regina), Tesi di Laurea, Università degli Studi di Milano a.a. 2011-2012.
raSpi Serra 1976: J. raSpi Serra, Insediamenti rupestri religiosi nella Tuscia, in MEFRA 88, I, 1976, pp. 27-156.
roManelli 1950: P. roManelli, Tarquinia. Scavi e ricerche nell’area della città, in NSc 1950, pp. 193-270.
SteingräBer cds: S. SteingräBer (ed.), L’Etruria rupestre dalla protostoria al Medioevo – Insediamenti, necropoli, monumenti, confronti, Atti del convegno (Barbarano Romano-Blera 2010), in stampa.
Supino 1969: P. Supino (ed.), La Margarita Cornetana, regesto dei documenti, Roma 1969.Tarchna I: M. Bonghi jovino - c. chiaroMonte treré (eds.), Scavi e ricerche a Tarquinia,
I, Roma 1997.tiBeri 1996: L.G. tiBeri, Notizie sulla famiglia Vitelleschi desunte dai manoscritti dell’Ar-
chivio Falzacappa, in Bollettino della Società Tarquiniense di Arte e Storia 25, 1996, pp. 1-10.torelli 2006: M. torelli, Tarquitius Priscus haruspex di Tiberio e il laudabilis puer Au-
relius. Due nuovi personaggi della storia di Tarquinia, in Archeologia in Etruria Meridionale, Atti delle giornate di studio in ricordo di Mario Moretti (Civita Castellana 2003), Roma 2006, pp. 249-286.
ESTRATTO
19.1, 2013 L’insediamento rupestre di Santa Restituta 359
aBStract
The complex of Santa Restituta is situated on the SW slopes of Ara della Regina platform, near Tar-quinia (VT), the medieval Corneto. This is object of archaeological analysis since 1999 by the ‘Sapienza’ University of Rome. The complex is a S. Salvatore al Monte Amiata Abbey’s cella from the IX to the end of the XIV century. It grew during the romanic age by the construction of the church, which by its architectural features can be dated between the XII and the XIII century, was built in front the former one made by a cave. The outer space, in this phase, is occupied by a necropolis, delimited by a structure which should be interpreted as an enclosure wall. The complex’s development in this period shows a renewed interest for cella of S. Restituta, situated on the way from Corneto to Viterbo, by S. Salvatore al Monte Amiata Abbey.
ESTRATTO
Edizioni Quasar di Severino Tognon s.r.l.via Ajaccio 41/43 – 00198 Roma
www.edizioniquasar.it
per informazioni e [email protected]
ISSN 1123-5713
ISBN 978-88-7140-549-0
Finito di stampare nel mese di febbraio 2014presso Global Print – Gorgonzola (MI)
ESTRATTO