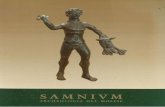L’insediamento del tardo Bronzo di Mokarta (strutture e scavi 1994-97)
Transcript of L’insediamento del tardo Bronzo di Mokarta (strutture e scavi 1994-97)
ISTITUTOITALIANO DI PREISTORIA
E PROTOSTORIA
ATTI DELLA XLIRIUNIONE SCIENTIFICA
DAI CICLOPI AGLI ECISTISOCIETÀ E TERRITORIO
NELLA SICILIA PREISTORICA E PROTOSTORICA
San Cipirello (PA), 16-19 novembre 2006
FIRENZE 2012
ENTI PROMOTORI
Istituto Italiano di Preistoria e ProtostoriaAssessorato Regionale dei Beni Culturali Ambientali e P.I.Comune di San CipirelloUnione de Comuni Monreale JetasCentro Siciliano di Preistoria e Protostoria Archeoclub di Corleone
COMITATO D’ONORE
A. Buttitta, N. Bonacasa, E. De Miro, S. Lagona, V. La Rosa, G. Rizza, E. Tortorici,M. Tosi, V. Tusa, G. Voza
CON IL SOSTEGNO DI
Soprintendenza BB CC AA AgrigentoSoprintendenza BB CC AA CaltanissettaSoprintendenza BB CC AA CataniaSoprintendenza BB CC AA EnnaSoprintendenza BB CC AA MessinaSoprintendenza BB CC AA PalermoSoprintendenza BB CC AA RagusaSoprintendenza BB CC AA SiracusaSoprintendenza BB CC AA TrapaniSoprintendenza al Museo Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini”Museo Archeologico Regionale, AgrigentoMuseo Archeologico Regionale “A. Salinas”, PalermoMuseo Archeologico Regionale “P. Orsi”, SiracusaMuseo “Agostino Pepoli”, TrapaniMuseo Archeologico Regionale della Villa del Casale di Piazza ArmerinaMuseo Archeologico Regionale di CamarinaMuseo Archeologico Regionale di GelaMuseo Archeologico Regionale Eoliano “L. Bernabò Brea”Museo della Ceramica di CaltagironeMuseo di storia naturale e del carretto di Palazzo d’Aumale, TerrasiniParco Archeologico Regionale di Agrigento
COMITATO SCIENTIFICO
Paleolitico e Mesolitico: M.R. Iovino, F. MartiniNeolitico: V. Tinè, S. Tusa Eneolitico: A. Cazzella, D. Cocchi Genik, L. Maniscalco Età del Bronzo: N. Bruno, M. Cavalier, M.C. Martinelli, F. Nicoletti, E. Procelli, S. Tusa Età del Ferro: R.M. Albanese ProcelliInterazioni Sicilia - Mediterraneo: A.M. Bietti Sestieri, M. Marazzi Coordinamento: S. Tusa
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
C. Buccellato, A. Scuderi, A. Vintaloro, E. Viola
REDAZIONE DEGLI ATTI
Enrico Procelli
In copertina: Vaso della cultura di Serrafarlicchio
© Istituo Italiano di Preistoria e Protostoria, 2012Via S. Egidio, 21 - 50122 Firenzetel. 055/2340765 - fax 055/5354821www.iipp.it - e-mail: [email protected]
FABRIZIO NICOLETTI* - SEBASTIANO TUSA*
L’insediamento del tardo Bronzo di Mokarta(strutture e scavi 1994-97)
Mokarta è il nome di un monte di forma ovale, orientato in senso E-W,sito a Mezzogiorno di Salemi (Trapani). La sua massima elevazione (365m s.l.m.), denominata Cresta di Gallo, si trova al centro del lato orientale,mentre sul versante opposto l’altitudine digrada in ampie terrazze rettan-golari fino a quota 288. Su tutti i lati il monte è protetto da inaccessibilibaratri.
L’altura è interessata da diversi insediamenti preistorici, che copronol’arco temporale tra il Bronzo antico e l’età del Ferro. Il principale di essi,cui sono da riferire quasi tutte le necropoli rupestri, occupa il pianoro oc-cidentale, sede del castello che ha dato nome al monte. Noto da recuperioccasionali alla fine degli anni ’60, il sito è stato oggetto di brevi campa-gne di scavo dirette da G. Mannino, concentrate essenzialmente nelle ne-cropoli, che hanno tuttavia individuato, nel 1972, resti di un edificio attri-buito al Bronzo tardo (Mannino e Spatafora 1992; 1995).
L’abitato oggetto di questa nota occupa una terrazza rettangolare, inlieve pendio verso W. Delimitato da pareti scoscese, a quota 288 s.l.m., èquesto l’ultimo dei pianori sommitali digradanti verso Occidente.
Dai rinvenimenti di superficie sembra che l’abitato occupasse tutto ilpianoro, per un’estensione di 100 m in senso N-S e almeno 300 m in sen-so E-W. Resti meno abbondanti di frequentazione coeva si individuanoanche sul pianoro soprastante (317 m s.l.m.), dove poteva esistere unasorta di acropoli.
L’abitato di Mokarta è stato scavato, per la prima volta ed in modoestensivo, nel 1994 e nel 1996-97 (Tusa e Nicoletti 2000), in quella che èverosimilmente la parte centrale dell’insediamento (fig. 1). Durante que-ste campagne sono stati messi in luce quattro edifici circolari e due qua-drangolari, collegati da strutture minori e raccolti intorno a spazi a cieloaperto. Gli edifici sono delimitati da muri lapidei a duplice paramento dipietre a secco, talora tessuti a spina-pesce.
* Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”, Napoli. E-mail: [email protected]; [email protected].
906 F. NICOLETTI - S. TUSA
Tutte le misure suggeriscono che nell’insediamento fosse in uso un mo-dulo metrico fondamentale, un piede di 32 o 33 cm, applicato quasi sem-pre con multipli interi nella realizzazione cantieristica degli edifici.
Fig. 1 - Mokarta (Salemi, Trapani), scavi 1994-1997. Planimetria generale del-l’insediamento.
Con l’eccezione della numero 4 (più piccola delle altre e struttural-mente più elementare, fig. 2.1) le capanne curvilinee di Mokarta appaio-no singolari. La struttura centrale degli edifici si compone, come altrove,di un tamburo murario cilindrico, con un diam. interno di ca. 5,50 m,senza traccia di palificazione interna. La variante locale si caratterizza perun particolare tipo di ingresso (fig. 2.2), formato da due varchi coassialicon un’anticella intermedia. Il primo ingresso si apre nel tamburo mura-rio centrale. All’esterno di questo si trova un’anticella a forcipe, di misure
L’INSEDIAMENTO DEL TARDO BRONZO DI MOKARTA (STRUTTURE E SCAVI 1994-97) 907
anguste, delimitata da due bracci murari curvilinei e concentrici. Questihanno origine dal tamburo centrale, ai due lati dell’ingresso, ed isolanoun secondo varco di accesso, posto all’esterno ma sullo stesso asse delprimo. Nel caso della capanna 1 i muri dell’anticella risultano addossati alcorpo di fabbrica principale; nella capanna 3 essi sono invece ammorsatie quindi previsti in fase di costruzione dell’edificio stesso.
È probabile che questo particolare tema architettonico, qui identifica-to per la prima volta, non sia esclusivo di Mokarta: potrebbero rientrarein tale tema la capanna 2 di Cannatello (Fiorentini 1993-94, tav. 16), lanumero 18 di Sabucina (Mollo Mezzena 1987, fig. 26) e quella del Castel-lazzo di Poggioreale (Falsone et alii 1980-81, fig. 3).
Fig. 2 - Mokarta (Salemi, Trapani), scavi 1994-1997. 1) capanna n. 4; 2) anticellaa forcipe della capanna 2; 3) ambiente interno della capanna n. 1 con ilsistema di canalette solcanti il battuto pavimentale; 4) planimetria dellacapanna polilobata n. 2; 5) planimetria della capanna n. 1; 6) fotopianodella capanna n. 3 e dell’edificio quadrangolare I.
908 F. NICOLETTI - S. TUSA
1 Ad es. capanne 16b, 17, 20b, 22b e 23 di Sabucina (Mollo Mezzena 1987, figg. 13, 26,32, 38), capanne 3 e 5 di Scirinda (Castellana 2000, tav. 3), edificio D di Cannatello – scavoMosso (Mosso 1908, cc. 626-629 e fig. 27). Segnalazioni di capanne simili si hanno anche al Ca-stellazzo di Palma di Montechiaro (De Miro 1971, p. 496).
Le capanne con anticella a forcipe di Mokarta presentano elementi in-terni analoghi: un compatto battuto pavimentale in conglomerato di ar-gilla concotta mescolata a marna, e un focolare centrale a piastra di argillaconcotta (due, adiacenti uno all’altro, nella capanna 1). La capanna 1(Tusa e Nicoletti 2000) presenta anche una singolare rete di canalette,scavate nel battuto e variamente incrociate fra loro, che hanno origine daappositi condotti nel muro perimetrale e proseguono all’esterno dell’edi-ficio dopo averne attraversato l’intero spazio interno (fig. 2.3, 5). La ca-panna 2, caso unico, dispone di un secondo ambiente di planimetria irre-golare con pavimento in acciottolato, accessibile sia dall’esterno che dallostesso ambiente circolare (fig. 2.4). L’edificio rientra nel tipo polilobato,raro ma non ignoto in altri insediamenti coevi1. La capanna 1 contenevacospicui resti della copertura, formata da strati in conglomerato argillosoalternati a strati a base di carbonato di calcio. Lo strato era quasi del tuttoformato da frammenti di concotto, alcuni dei quali con impronte di pun-toni lignei, a sezione circolare, del diam. di 7-12 cm. Altri frammenti por-tano impronte di canne o bacchette, a sezione pure circolare, del diam. di1-2 cm. Queste impronte sono poste in serie parallele e in almeno unframmento è visibile una teoria di bacchette parallela al negativo di unpuntone, lasciando immaginare che le prime tamponassero lo spazio tradue puntoni. In un solo frammento è visibile un incrocio: un puntone, ve-rosimilmente verticale, incrociato alle spalle da una bacchetta, probabil-mente una catena. Il conglomerato è formato da una miscela a based’argilla e paglia sminuzzata (forse di graminacee), i cui steli hanno undiam. di 1-4 mm. Rari frammenti hanno una superficie liscia, in almenoun caso curva, in altro convessa, tuttavia sempre di raggio diverso calcola-to negli assi ortogonali.
La fisionomia dei frammenti e le impronte di infrastrutture lignee,consentono di ipotizzare uno spiccato del tutto rivestito in conglomerato,sorretto da un’intelaiatura lignea ad elementi verticali curvilinei, incatena-ti in orizzontale e tamponati da incannicciata. Dato che non vi sono bu-che di palo, tale struttura doveva scaricare il peso soltanto sul muro peri-metrale. Quest’ultimo non doveva essere più alto dell’attuale (70 cm), inquanto in almeno un punto, sulla cresta del muro, è stato rinvenuto lostesso conglomerato dello spiccato ancora in giacitura primaria: l’ipotesipiù verosimile è quella di una copertura a cupola ogivale, con foro alla
L’INSEDIAMENTO DEL TARDO BRONZO DI MOKARTA (STRUTTURE E SCAVI 1994-97) 909
sommità per il tiraggio del fumo, in quanto al centro del battuto, comedetto, vi è il focolare (fig. 3): una struttura simile, per intenderci, a quelladelle tombe a tholos, presenti, fra l’altro, nel nostro stesso insediamento(Mannino e Spatafora 1995, figg. 5-7, 33). Indizi dello stesso tipo, sebbe-ne in minore quantità, ha restituito anche la capanna 2, la cui coperturadoveva fra l’altro comprendere corni di bovidi infissi sul lato esterno delconglomerato argilloso, tre dei quali sono stati rinvenuti, ancora uniti adun puntone carbonizzato, nel crollo dello spiccato. L’anticella era invece,in tutti i casi, se non scoperta, dotata di copertura deperibile, poiché nes-suna traccia di essa è stata rinvenuta durante gli scavi.
Il parallelo tra il sistema di copertura a cupola ogivale delle capanne ele coeve tholoi funerarie del Bronzo recente siciliano non è nuovo. Il pri-mo a individuare analogie tra tombe e capanne, a partire dai sepolcri diThapsos, è stato forse P. Orsi. Non è del tutto chiaro se lo studioso abbiaposto a confronto le tombe a tholos con strutture capannicole della stessaforma, o come sembra più probabile, l’architettura funeraria con quella
Fig. 3 - Mokarta (Salemi, Trapani), scavi 1994-1997. Restituzione ipotetica dellospiccato della capanna n. 1.
910 F. NICOLETTI - S. TUSA
2 Orsi 1895, c. 137; 1910, pp. 189-193. Nella memoria su Caltagirone le tombe a tholossono fatte risalire ad influenza egeo-micenea (Orsi 1904, p. 95).
3 Per le diverse posizioni cfr. Tomasello 1984, p. 93 e note 4 e 5; 1995-96, pp. 26-30.4 Ad es. Rizzone et Alii 2003, passim e Militello 2003, p. 278, ma anche in tombe non tho-
loidi della Sicilia preistorica (ad es. Luni t. 28, Castellana 1994, p. 19). Nelle tombe a tholosdella Sicilia sud-orientale (articoli citati) sono talvolta segnalate canalette scavate nel piano pa-vimentale; anche questo elemento, qualora confermato, troverebbe confronto nella cap. 1 diMokarta.
domestica in linea puramente generale2. Rimane il fatto che il genericoparallelo tra l’evoluzione della forma domestica e quella della forma fune-raria è stato successivamente ripreso da altri studiosi (Pace 1935-38, pp.346-347; Orlandini 1962, p. 24; Leighton 1999, pp. 169-170).
Mentre alcuni autori non sembrano avere dubbi sull’origine miceneadel tipo, l’ipotesi che le tholoi funerarie della Sicilia siano derivate dall’ar-chitettura domestica locale è stata formulata diverse volte, anche attraver-so studi specifici3. L’idea, oltre che da motivazioni architettoniche, nasceda constatazioni squisitamente paletnologiche (Patroni 1937, p. 365; Mc-Connell 1987; 1991-92; Mannino e Spatafora 1995, p. 151; Tusa e Nico-letti 2000; Albanese Procelli 2003, p. 57). Il primo elemento di raffrontoè costituito dal cd “scodellino”, che sormonta quasi sempre le tholoi fu-nerarie e che può paragonarsi all’opaion per il tiraggio del fumo delle ca-panne, dato che queste (non solo a Mokarta) hanno assai spesso un foco-lare interno e centrale. Lo stesso focolare potrebbe essere saltuariamenterappresentato al centro del pavimento delle tombe a tholos, sotto formadi concavità circolare scavata nella roccia4. Un altro elemento è costituitodalla presenza di banchine perimetrali, comune (e saltuaria in entrambi icasi) sia alle tombe che alle capanne. La stessa articolazione dell’ingressosembra presentare punti di collegamento: talvolta le tombe a tholos sonoprecedute da un’angusta anticella e presentano annessi secondari, gene-ralmente in forma di nicchia. Le anticelle e gli annessi secondari sonoadesso conosciuti anche nell’architettura domestica, nelle capanne 1-3 diMokarta e forse, almeno nel caso dell’anticella, anche altrove.
Sicché i correlati architettonici delle tombe a tholos siciliane e quellidelle coeve capanne circolari sono assai spesso simili, anche più di quelliche legano le tholoi siciliane a quelle del Peloponneso con le quali sono disolito confrontate. Del resto, in un sistema di confronti che coinvolge unasfera notoriamente ideologica e conservativa, quale è quella funeraria, ilparallelo architettonico avulso dal suo significato simbolico assume natu-ra esteriore. Una indagine sull’ideologia funeraria del Bronzo recente sici-liano (Maniscalco 1985) ha indicato nel rito del banchetto funebre a ca-rattere familiare il principale contenuto delle tombe di tipo tradizionale, e
L’INSEDIAMENTO DEL TARDO BRONZO DI MOKARTA (STRUTTURE E SCAVI 1994-97) 911
fra queste le tholoi. Il rito del banchetto funebre è locale, e risale almenoal Bronzo antico se non al tardo Eneolitico. Anche per il contenuto, latholos funeraria può davvero rappresentare la trasposizione funeraria eastrutturale di un archetipo domestico e strutturale.
Entrambi gli edifici rettilinei di Mokarta sono formati dall’accostamen-to di due ambienti quadrangolari, ciascuno comunicante solo conl’esterno. L’edificio I, la cui pianta è simile ad un trapezio con assi di 9x4m ca. (fig. 2.6), scaricava il peso della copertura esclusivamente sui muriperimetrali, dato che al pari degli edifici circolari era privo di buche dipalo. Sulla base degli elementi di scavo, le ipotesi sullo spiccato di questoedificio possono variare solo in funzione del numero di falde del tetto. Ècomunque probabile che queste fossero allineate con i lati lunghi, per evi-tare il displuvio sul muro divisorio. Nell’ipotesi di un tetto a due spioven-ti (fig. 4) è necessario immaginare un coronamento triangolare alla som-mità dei lati corti (malgrado resti incerto come questo potesse raccordarsial tratto di muro curvilineo presente nel vano meridionale), al vertice delquale si appoggia una trave di colmo passante per l’asse maggiore dell’e-dificio. Sui lati obliqui del coronamento possono appoggiarsi anche traviparallele a quella maestra, che contribuiscono ad evitare il collasso dellefalde. Su questo sistema di travature orizzontali può scaricare il peso il te-laio reticolare di puntoni e catene, verosimilmente tamponato con mate-riale vegetale, dato che nessuna traccia di conglomerati appartenenti allacopertura è stata rinvenuta in fase di scavo.
Fig. 4 - Mokarta (Salemi, Trapani), scavi 1994-1997. Planimetria e restituzioneipotetica dello spiccato dell’edificio quadrangolare I.
Questa tema edilizio, una spina di ambienti ad un tempo modulare eparatattica, è noto in altri insediamenti siciliani coevi, sebbene mai in mo-do così completo5.
A Mokarta convivono quindi edifici diversi: singole capanne circolari,edifici rettilinei con distribuzione modulare dei vani ed edifici misti. Tut-tavia né la diversa architettura delle strutture, né la loro disposizione sem-bra casuale: gruppi di edifici di diversa tipologia sono raccordati da settimurari che contribuiscono ad isolare aree esterne, coordinate a ciascungruppo in un unico sistema. Nell’area indagata si distinguono tre di que-sti sistemi (fig. 1). Il primo è formato dall’edificio rettangolare II e dallacapanna polilobata 2, uniti fra loro; i quattro ingressi di queste costruzio-ni si aprono tutti sull’area esterna 1, che sul lato opposto è delimitata daimuri posticci di altri edifici privi, questi ultimi, di accesso al sistema. Ilsecondo sistema comprende la capanna 1 e l’edificio rettangolare I, i cuiingressi accedono all’area esterna 2; un setto murario collega i due edificie al contempo impedisce la comunicazione tra primo e secondo sistema.Il terzo sistema, che ricorda uno schema analogo di Sabucina (Sedita Mi-gliore 1981, tav. 1), comprende le capanne 3 e 4, unite a monte da un mu-ro curvo e aperte sull’area esterna 3, delimitata sul lato opposto da unmuro serpeggiante che segue la fronte dei due edifici.
Sebbene simili a strade, al punto che alcune costruzioni sono margina-te da banchine simili a marciapiedi (fig. 5.1), le aree esterne di Mokartasomigliano maggiormente a cortili, avulsi da ogni criterio di ortogonalità.
La cronologia relativa delle strutture è stata fornita in dettaglio dallestratigrafie. Le capanne 3 e 4 sono state edificate sopra il medesimo stratoe sono collegate da un muro sul lato monte. Il vano A dell’edificio I è sta-to costruito dopo la capanna 3 e dopo il vano B dello stesso edificio. Per-tanto il vano A è stato edificato nello spazio disponibile tra una capannacircolare (la n. 3) e un edificio in origine quadrato (IB). È stato anche ap-purato che i muri sud-orientali dell’edificio rettilineo II sono stati costrui-ti prima dell’edificazione della capanna circolare 2. È quindi assodato chea Mokarta l’architettura geometrico-radiale degli edifici curvilinei e quel-
5 Escludendo gli edifici più complessi, basati sull’accorpamento centripeto di spine di am-bienti (quali i complessi A e B di Thapsos, l’anaktoron di Pantalica e i complessi a e b di Des-sueri – Monte Maio), possiamo ricordare i seguenti: complesso 39-40 di Sabucina (Mollo Mez-zena 1987, figg. 5, 40); Thapsos, edificio di Masseria Calvo, edifici XLVI/35 (c.d. megaron) eXLVII/33 (Bernabò Brea 1970, fig. 2; Voza 1972, fig. 2-c; 1973, pp. 149-154, fig. 10, tav. 1); ca-panna 3 superiore di Cannatello (De Miro 1998, fig. 7); Sant’Angelo Muxaro-Castello (Palermo1979, fig. 2); Serra del Palco, edifici A e B (La Rosa 1997, tav. 42); Rocca Amorella (Tomasello1992, fig. 7).
912 F. NICOLETTI - S. TUSA
L’INSEDIAMENTO DEL TARDO BRONZO DI MOKARTA (STRUTTURE E SCAVI 1994-97) 913
la modulare degli edifici rettilinei sono alternative e non sequenziali. Me-glio che alternativi i due temi architettonici sembrano concorrere alla rea-lizzazione di complessi organici attraverso l’agglutinazione.
È pure assodato che tutti gli edifici cessarono di esistere nello stessomomento ed in modo traumatico. Tracce di incendi, spesso seguiti dacrolli improvvisi, sono stati identificati in tutte le strutture e persino nellearee esterne, al pari dell’abbandono repentino e definitivo dell’insedia-mento. Lo scheletro supino di una giovane è stato rinvenuto dentro la ca-panna 1 (fig. 5.2), e tracce disarticolate di altri resti umani provengono datutti i settori di scavo.
La cronologia assoluta degli edifici di Mokarta, è assicurata dalla cultu-ra materiale in essi rinvenuta, quasi sempre in giacitura originaria. Le ce-ramiche formano un gruppo complessivamente parallelo allo stile di Pan-talica Nord. Peculiarità locali o più genericamente occidentali, sono rav-visabili nella generale assenza di tornitura e stralucido e in alcune tipolo-gie (Nicoletti e Tusa 2006). Taluni dettagli di queste ultime, di ascenden-za tardo-ausonia, suggeriscono una datazione piuttosto avanzata. Per ladistruzione del sito, una collocazione entro la fine dell’XI secolo a.C. onei primi decenni del secolo successivo appare, al momento, la più ragio-nevole.
Fig. 5 - Mokarta (Salemi, Trapani), scavi 1994-1997. 1) banchina nell’area ester-na n. 1; 2) scheletro supino di giovane donna rinvenuto all’interno dellacapanna n. 1.
914 F. NICOLETTI - S. TUSA
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
AA. VV. 1987, Storia e archeologia della media e bassa valle dell’Himera, III gior-nata di studi sull’archeologia licatese, I convegno sull’archeologia nissena, Attidel convegno, Licata - Caltanissetta 1987.
ALBANESE PROCELLI R.M. 2003, Sicani, Siculi, Elimi, Milano.BERNABÒ BREA L. 1970, Thapsos. Primi indizi dell’abitato dell’età del Bronzo,
Adriatica Praehistorica et Antiqua. Miscellanea Gregorio Novak dicata, Za-greb, pp. 139-151.
CASTELLANA G. 1994, Recenti acquisizioni preistoriche nel versante orientale delBasso Belice con riferimento ai nuovi dati delle ricerche nel territorio agrigenti-no, in TUSA S., a cura di, La preistoria del basso Belice e della Sicilia meridiona-le nel quadro della preistoria siciliana e mediterranea, Atti del convegno, Paler-mo, pp. 17-46.
CASTELLANA G. 2000, La cultura del medio Bronzo nell’agrigentino ed i rapporticon il mondo miceneo, Agrigento.
DE MIRO E. 1971, Notiziario, RSP 26, pp. 495-496.DE MIRO E. 1998, Un emporio miceneo sulla costa sud della Sicilia, in LA ROSA V.,
PALERMO D., VAGNETTI L, a cura di, ’Epí Pónton Plazómenoi, Simposio italia-no di studi egei dedicato a Luigi Bernabò Brea e Giovanni Pugliese Carratelli,Roma 18-20 Febbraio, pp. 439-449.
FALSONE G., LEONARD A. JR., FRESINA A., JOHNSON C., FATTA V. 1980-81, Quat-tro campagne di scavo a Castellazzo di Poggioreale, Kokalos 26-27, II-2, pp.931-972.
FIORENTINI G. 1993-94, Attività di indagini archeologiche della SoprintendenzaBeni Culturali e Ambientali di Agrigento, Kokalos 39-40, II-1, pp. 717-720.
LA ROSA V. 1997, Un anaktoron sulla Serra del Palco di Milena? Relazione preli-minare sullo scavo del 1992, in LA ROSA V., a cura di, Dalle capanne alle robbe.La storia lunga di Milocca-Milena, Caltanissetta, pp. 203-212.
LA ROSA V., a cura di, 2004, Le presenze micenee nel territorio siracusano, Atti delI simposio siracusano di preistoria siciliana in memoria di Paolo Orsi, Siracu-sa 15-16 Dicembre, Padova 2004.
LEIGHTON R. 1999, Sicily before history, New York.MANISCALCO L. 1985, Tipologie funerarie nella Sicilia del tardo Bronzo: Pantalica,
Dessueri e Caltagirone, Archivio Storico per la Sicilia Orientale, 81-82, pp.241-266.
MANNINO G., SPATAFORA F. 1992, Materiali preistorici dal territorio di Salemi: LaMokarta, Atti delle giornate internazionali di studi sull’area elima, Gibellina19-22 Settembre 1991, Pisa - Gibellina, pp. 567-575.
MANNINO G., SPATAFORA F. 1995, Mokarta. La necropoli di Cresta di Gallo, Qua-derni del Museo Archeologico Regionale “Antonio Salinas”, suppl. al n. 1,Palermo.
L’INSEDIAMENTO DEL TARDO BRONZO DI MOKARTA (STRUTTURE E SCAVI 1994-97) 915
MCCONNELL B.E. 1987, Architettura domestica e architettura funeraria nel Bron-zo medio, in AA. VV. 1987, pp. 137-182.
MCCONNELL B.E. 1991-92, La capanna circolare in Sicilia, L’età del Bronzo in Ita-lia nei secoli dal XVI al XIV a.C., Atti del congresso, Viareggio 26-30 Ottobre1989, RassA 10, pp. 774-775.
MILITELLO P. 2003, Due nuove tholoi dal medio Irminio, in LA ROSA 2004, pp.269-294.
MOLLO MEZZENA R. 1987, Sabucina, recenti scavi nell’area fuori le mura. Risultatie problematiche, in AA. VV. 1987, pp. 137-182.
MOSSO A. 1908, Villaggi preistorici di Caldare e Cannatello presso Girgenti, MAL18, cc. 573-690.
NICOLETTI F., TUSA S. 2006, L’età del Bronzo nella Sicilia occidentale, AttiIIPPXLI, in questo volume.
ORLANDINI P. 1962, Il villaggio preistorico di Manfria, presso Gela, Palermo.
ORSI P. 1895, Thapsos, MAL 6, cc. 89-150.
ORSI P. 1904, Siculi e Greci a Caltagirone. I. Necropoli sicule della Montagna,NSc, pp. 65-98.
ORSI P. 1910, Due villaggi del primo periodo siculo, BPI 36, pp. 158-193.
PACE B. 1935-38, Arte e civiltà della Sicilia antica, 1-2, Milano - Genova - Roma -Napoli.
PALERMO D. 1979, Sant’Angelo Muxaro. Saggi di scavo sulle pendici meridionalidel Colle Castello, Cronache di Archeologia e Storia dell’Arte, 18, pp. 50-58.
PATRONI G. 1937, La Preistoria, in AA. VV., Storia politica d’Italia, 1, Milano.
RIZZONE V. G., SAMMITO A. M., TERRANOVA G. 2003, Per un corpus delle tholoidell’area iblea, in LA ROSA 2004, pp. 99-170.
SEDITA MIGLIORE M. 1981, Sabucina. Studio sulla zona archeologica di Caltanis-setta, Palermo.
TOMASELLO F. 1984, L’architettura funeraria in Sicilia tra la media e tarda età delBronzo: le tombe a camera del tipo a tholos, in MARAZZI M., TUSA S., VAGNET-TI L., a cura di, Traffici micenei nel Mediterraneo. Problemi storici e documen-tazione archeologica, Atti del convegno, Palermo 11-12 Maggio, 3-6 Dicem-bre, Palermo 1986, pp. 93-100.
TOMASELLO F. 1992, L’anaktoron di Pantalica: una metodologia progettuale, Sicu-lorum Gymnasium, n.s., 45, 1-2, pp. 113-140.
TOMASELLO F. 1995-96, Le tombe a tholos della Sicilia centro meridionale, Paler-mo 1997.
TUSA S., NICOLETTI F. 2000, L’epilogo sicano nella Sicilia occidentale. Il casoMokarta – capanna 1, Gli Elimi e l’area elima, Atti delle terze giornate interna-zionali di studi sull’area elima, Gibellina-Erice-Contessa Entellina, 23-26 Ot-tobre 1997, Pisa - Gibellina, pp. 963-977.
VOZA G. 1972, Thapsos. Primi risultati delle più recenti ricerche, AttiIIPP XIV,pp. 175-205.
916 F. NICOLETTI - S. TUSA
VOZA G. 1973, Thapsos: resoconto sulle campagne di scavo del 1970-71, AttiIIPPXV, pp. 133-157.
RIASSUNTO. - L’INSEDIAMENTO DEL TARDO BRONZO DI MOKARTA (STRUTTURE
E SCAVI 1994-97). - La zona centrale dell’insediamento protostorico di Mokarta ècostituita da raggruppamenti organici di capanne circolari, talora con annessi se-condari, ed edifici quadrangolari di due stanze, raccolti intorno a spazi aperti. Lecapanne sono caratterizzate da una originale anticella “a forcipe”, e da resti dellacopertura tali da consentire l’ipotesi di uno spiccato a cupola ogivale, paragona-bile a quello delle coeve tombe dette a tholos. L’abitato è stato violentemente di-strutto, probabilmente alle soglie del I millennio a.C. Di tale distruzione è tragicatestimonianza lo scheletro di una giovane ragazza rinvenuto riverso sul pavimen-to di una capanna.
SUMMARY. - THE LATE BRONZE AGE VILLAGE AT MOKARTA (STRUCTURES AND
EXCAVATIONS 1994-97). - The central zone of the Mokarta protohistoric settle-ment includes organic clusters of circular huts, sometimes provided with a se-condary annexe, and two-rooms quadrangular buildings, located around con-courses. The huts are characterized by an original antechamber, looking a force-ps, and by roofing remains adequates to suppose an ogival domed structure,comparable to that of the so-called tholos tombs. The settlement has been violen-tly destroyed, probably at beginnings of the first millennium B.C. The young girlskeleton, found lying down the floor inside a hut, is a tragic evidence of that de-struction.