Paesaggi d’acqua e strutture dell’età del bronzo da Monte Vetrano (Salerno),
Cristiano Iaia, Marco Pacciarelli, La cremazione in area mediotirrenica tra Bronzo finale e primo...
Transcript of Cristiano Iaia, Marco Pacciarelli, La cremazione in area mediotirrenica tra Bronzo finale e primo...
CENNI SULLA DIFFUSIONE E L’EVOLUZIONE DEISEPOLCRETI A CREMAZIONE DAL BRONZO MEDIO3 AGLI INIZI DEL BRONZO FINALE
Il rito funerario della cremazione in urna – se si prescindeda episodi precedenti risalenti all’età del rame e talvoltaal neolitico – inizia a svilupparsi diffusamente nell’Italiapeninsulare a partire dalla fase 3 del Bronzo medio edall’età del Bronzo recente, ovvero tra il XIV e la primametà del XII secolo a.C. Comuni ai primi sepolcreti a cremazione sono l’uniformitàdel rito e il carattere poco strutturato delle sepolture. Ilcontenitore delle ossa cremate è costituito da un vaso diforma chiusa non standardizzata, ma tendenzialmente aprofilo arrotondato, spesso coperto da una scodella otazza, mentre alle ossa solo di rado si associano scarsiornamenti perlopiù bruciati sul rogo. Le necropoli meglioconosciute, quelle delle terramare padane, comprendononumerose sepolture fortemente addensate, pertinenti a
individui di classi d’età sia adulte che infantili, e dunquein esse appare tendenzialmente rappresentata l’interacomunità (Cardarelli/Pellacani 2004; Cardarelli/Labate/Pellacani 2006). Come indicato da Renato Peroni e AndreaCardarelli (Peroni 1989, 261 ss.; Peroni 1996; Cardarelli1997), in questi contesti il significato del rito crematorioappare volto a rinsaldare l’unità dell’intera collettività,attraverso l’addensamento delle sepolture e il livellamentodelle differenze sociali e in parte anche delle peculiariidentità degli individui, ideologia cui certo non è estraneoil significato sacrificale del fuoco. Complesse pratiche acarattere probabilmente sacrificale sono infatti documentatenella necropoli terramaricola di Casinalbo, dove le armi,le fibule e gli ornamenti bruciati sul rogo funebre venivanodeposti in aree esterne ai nuclei sepolcrali, mentre lesingole deposizioni non apparivano accompagnate mai(armi) o quasi mai (fibule e ornamenti) da questi elementi(Cardarelli/Labate/Pellacani 2006). Nell’area a sud del Tevere, il Latium Vetus, la più antica
341
M.C. Rovira Hortalà, F.J. López Cachero, F. Mazière (dirs.), Les necròpolis d’incineració entre l’Ebre i el Tíber (segles IX-VI aC): metodologia, pràctiques funeràries i societat,
Monografies 14, MAC, Barcelona 2012, ISBN 978-84-393-8921-7 (pàg. 341-355).
* Università degli studi di Modena e Reggio Emilia.** Università degli studi di Napoli Federico II.
LA CREMAZIONE IN AREA MEDIOTIRRENICA TRABRONZO FINALE E PRIMO FERROProtostoria, Italia mediotirrenica, archeologia sociale, etruschi, latini
Cristiano Iaia* Marco Pacciarelli**
This paper examines how the cremation rite in the central Tyrrhenian area has been several times deeply modifiedfrom the advanced Final Bronze Age to the Early Iron Age (end of 11th century BC – third quarter of 8th), in order torepresent complex symbolic meanings tied to the emergence of new political and social identities.Protohistory, Central Tyrrhenian Italy, Social Archeology, Etruscans, Latins
Este trabajo examina cómo el ritual de la cremación en la zona tirrénica central ha sido sucesiva y profundamentereelaborado entre finales de la Edad del Bronce y principios de la Edad del Hierro (finales del siglo XI – tercer cuartodel siglo VIII), con el objeto de representar complejos significados simbólicos relacionados con la aparición denuevas identidades sociales y políticas.Protohistoria, Italia tirrenica central, arqueología social, etruscos, latinos
Cet article relate la manière dont le rite de la crémation dans la région tyrrhénienne centrale a été successivement etprofondément modifié, entre le Bronze final et le début de l‘âge du Fer (fin du XI – troisième quart du VIIIe s. J.-C.),pour montrer la complexité des significations symboliques liées à l’émergence de nouvelles identités politiques etsociales.Protohistoire, Italie centrale tyrrhénienne, archéologie sociale, Etrusques, Latins
Dels Alps al Tíber5.4:Mono intro1 30/11/12 17:47 Página 341
necropoli a incinerazione èper ora quella di CavalloMorto,databile al Bronzo recente1, mentre in Etruria le primecremazioni di datazione certa risalgono al Bronzo finale.È questa l’età della grande diffusione dei sepolcreti acremazione denominati “protovillanoviani”, termine dietrocui si nasconde una realtà all’inizio ancora in parteomogenea, ma in realtà in via di rapida differenziazioneregionale (tanto che diversi studiosi ormai parlano,soprattutto per il BF3, di sepolcreti protoveneti,protogolasecchiani, protolaziali etc.).Per quanto riguarda l’area medio tirrenica, al momento idati sulle necropoli dell’Etruria settentrionale sono moltoscarsi, mentre in Etruria meridionale e Lazio i sepolcretidelBronzo finale sembrerebbero inveceperlopiùorganizzatiper piccoli gruppi distanziati tra loro, che fanno pensareagruppi di parentela dotati di una loro identità e autonomia.L’Etruriameridionale e il Lazio antico rappresentano l’areamaggiormente innovativa in Italia per quanto riguarda ilrito crematorio, ma soprattutto a partire dalla fase 3 delBronzo finale (Pacciarelli 2001, 202 ss.; Bietti Sestieri/DeSantis 2003). Nelle fasi 1-2, per ora in realtà assai pocodocumentate, il rito presenta ancora caratteristiche comunia diverse necropoli protovillanoviane, soprattutto del Nord.
Si veda ad esempio la frequente presenza dell’urna diforma biconica, spesso ornata a turbante sul corpo, edella tomba perlopiù a semplice pozzetto oppure a cistalitica.Come avviene talvolta anche nel Nord, già dal Bronzofinale 1-2 inizia a manifestarsi la tendenza a superare levalenze egualitarie del rito, inserendo in alcune tombemanufatti di grandepregio nonbruciati sul rogo: si vedanola fibula di grandi dimensioni della tomba maschile diCoste del Marano (Müller-Karpe 1959, tav. 25, nn. 1-2), ela cospicua collana d’ambra della tomba di Ardea, cheinoltre era eccezionalmente fornita di vasi ornati a lamellemetalliche (Delpino 1987). Rimane invece in quest’areaper tutto il Bronzo finale uno dei tabù più diffusi e rigorosidel rito crematorio, quello volto a escludere la deposizionedi armi reali e soprattutto di lance (tabù che fu superatosolo in pochissimi casi in Italia settentrionale includendoarmi sacrificate attraverso un rituale di frammentazione,comportamento che si continua a praticare al nord ancoradurante il primo Ferro).
NUOVE TRADIZIONI CREMATORIE IN ETRURIAMERIDIONALE E NEL LATIUM VETUS NEL BRONZOFINALE EVOLUTOCon la fase 3 del Bronzo finale si vengono formandosistemi rituali complessi e dotati di una loro coerenza, chepossono essere indagati anche da un punto di vistasemantico, come se si trattasse di linguaggi. In questosenso, per la loro storia e il loro significato hanno avutoimportanza non solo fattori interni, ma anche i rapportidialettici e a volte antagonistici tra i diversi sistemi comeespressione di valori di comunità o gruppi sociali.Le innovazioni più precoci, radicali e rigorose sono quelledel Latium Vetus2. In quest’area l’urna assume sovente(anche se non esclusivamente) una forma ovoidale ocomunque a profilo sensibilmente arrotondato, e tendeadessereprivadi decorazioni.Questi caratteri palesementesi allontananodalle formebiconicaoconcollo troncoconicomolto spesso ornate a solcature, che invece prevalgonolargamente in Etruria meridionale. Alquanto diffusa nelLatium Vetus è anche la presenza di corredi composti dagruppi di vasetti miniaturistici, che nell’insieme sembranoriprodurre complessi servizi per banchetti comprendentianche arredi cerimoniali utilizzati dalle élites, che nellarealtà dovevano essere realizzati almeno in parte in laminadi bronzo, comeèstato ipotizzatodagli scriventi in relazioneai c.d. presentatoi (Pacciarelli 2001). Una conferma aquesta tesi è venuta di recente dal ritrovamento a SantaPalomba di modellini di presentatoi realizzati in metallo(De Santis 2005, 2008). In molte tombe del Latium Vetusil vaso-urna viene sostituito dall’urna in forma di capanna,insieme alla quale è talvolta anche presente una statuetta,secondo Anna Maria Sestieri rappresentante il defunto(Bietti Sestieri 1992). Altra innovazione importante che
342
Cristiano Iaia, Marco Pacciarelli
Fig. 1. Etruriameridionale, necropoli di Puntone al Norcino pressoil Sasso di Furbara, tomba 13: complesso corredo con vasiminiaturizzati del Bronzo finale 3 (Brusadin 1964).
1 Angle et al. 2004; recentemente, a seguito di rinvenimenti occasionali, è stata resa nota l’esistenza di una necropoli a cremazione riferibile al BMavanzato/Bronzo recente, ubicata nel territorio di Ciampino (via Bianchi Bandinelli): Angle/Cerino/Fischetti 2010.2 Colonna 1974, 1988; Bietti Sestieri 1992; Bietti Sestieri/De Santis 2000, 2003.
Dels Alps al Tíber5.4:Mono intro1 30/11/12 17:47 Página 342
343
LA CREMAZIONE IN AREA MEDIOTIRRENICA TRA BRONZO FINALE E PRIMO FERRO
Fig. 2. Etruria meridionale, area tolfetano-cerite: selezione esemplificativa di urne cinerarie e dei relativi coperchi o scodelle delBronzo finale 3, che permette di evidenziare la notevole variabilità formale e decorativa.
Dels Alps al Tíber5.4:Mono intro1 30/11/12 17:47 Página 343
riguarda probabilmente le sepolture dei capi è l’introduzionedi armi simboliche miniaturistiche, che spesso riproduconovere e proprie panoplie con spada, lancia, schinieri ecoppie di scudi doppi (Bietti Sestieri/De Santis 2003),senza dubbio anche dal significato rituale come gli Anciliadall’analoga forma ricordati dalle fonti letterarie eiconografiche (Colonna 1991). Un altro rito peculiare delLatium Vetus, che inizia anche se con pochi casi già nel
Bronzo finale e poi si generalizza nel primo Ferro, è l’usodi deporre l’urna e l’intero corredo entro un grande dolio.Nel Bronzo finale 3 l’Etruria meridionale, e in particolarel’area più a sud, segue in parte alcune di queste lineeevolutive, in particolare per quanto riguarda l’introduzionedei corredi miniaturistici e in casi sporadici dell’urna acapanna, ma in modo assai meno costante e organico(Pacciarelli 2001): nella composizione dei corredi
344
Cristiano Iaia, Marco Pacciarelli
Fig. 3. A sinistra: elmi apicati di lamina bronzea del primo Ferro 1, a destra, coperchi fittili simbolici del Bronzo finale 3 e del primoFerro 1 alludenti a un elmo apicato.
Dels Alps al Tíber5.4:Mono intro1 30/11/12 17:47 Página 344
miniaturistici infatti non si notano vere e proprie costantiregionali come nel Lazio, ma ogni gruppo sepolcralesembra seguire proprie regole; le urne a capanna comesi è detto sono rarissime. I corredi miniaturistici piùcomplessi (Fig. 1) appaiono inoltre propri solo di una partedelle sepolture, quelle pertinenti alle identità sociali di piùalto status, mentre nel Latium Vetus sono molto più diffusi.Queste analogie con il Lazio antico sono però solo parziali,poiché in Etruria nel BF3 iniziano a manifestarsi in nucealcune peculiarità che in qualche modo preludono allegrandi innovazioni del primo Ferro. I gruppi insediati adestra del Tevere, come si è detto, prediligono in modopiuttosto netto dapprima l’urna di forma biconica e poiquella con collo troncoconico distinto, spesso fornite didecorazioni incise. Queste ultime nella fase 3 avanzata efinale divengono spesso estremamente complesse edelaborate, e palesemente legate a simbolismi per noidifficili da decodificare, ma certo dotati di precisi corrispettivisemantici. Tali linguaggi decorativi, se talvolta anticipanoschemi e sintassi della prima età del ferro, appaiono peròancora estremamente variabili e disorganici (Fig. 2).Un’altra innovazione che appare importante se consideratanella prospettiva dei successivi mutamenti, è la presenzain molte tombe maschili d’Etruria di coperchi con pomello(Fig. 3) che per vari motivi si può pensare alludano, anche
se alla lontana, a elmi apicati in bronzo, presenti consicurezza nelle sepolture dell’area almeno a partire dalprincipio del Primo Ferro 1 (Iaia 2005, 106 ss.). Questotipo di elmo, ben attestato in Europa continentale danubianatra XI e X secolo a.C. (Schauer 1988) e anche prima, èpresumibile esistesse già da allora in Etruria, anche seovviamente come attributo esclusivo di alcuni capi. Molto diffusa nell’Etruria meridionale è l’usanza di deporrele sepolture di maggiore rilievo entro una custodia di pietracostituita da due valve emisferiche, che tendenzialmentesi contrappone al rito laziale della deposizione entro dolio(un unico caso di custodia litica è al momento attestatonel Lazio a Lavinio, nessuna tomba a dolio è invecepresente nel BF d’Etruria). Queste differenze tra Etruria eLazio antico che emergono nel Bronzo finale 3 sono ancoraabbastanza sfumate, ma come si è detto costituiscono ladiretta premessa della profonda divaricazione dei ritivillanoviano e laziale del primo Ferro. Ciò indica che il ritocrematorio è stato uno degli strumenti di un processo digraduale costruzione di distinte identità politico-territoriali,legate – ma come si dirà solo in parte – da un lato aigruppi a sud del Tevere, probabilmente configuranti unasorta di unità proto-latina, e dall’altro ai gruppi a nord delfiume, che in qualche misura andavano costruendo lepremesse dell’identità etrusca e della svolta protourbana.
345
LA CREMAZIONE IN AREA MEDIOTIRRENICA TRA BRONZO FINALE E PRIMO FERRO
Fig. 4. Etruria meridionale, Tarquinia: topografia del centro protourbano della prima età del ferro (rielaborato da Pacciarelli 2001).Quadrato: necropoli; in grigio: aree interessate da insediamento.
Dels Alps al Tíber5.4:Mono intro1 30/11/12 17:47 Página 345
346
Cristiano Iaia, Marco Pacciarelli
Fig. 5. Etruria meridionale, Tarquinia: selezione esemplificativa di urne cinerarie del primo Ferro 1 dalla necropoli villanoviana de LeRose, che permette di evidenziare la notevole uniformità formale e decorativa (da Buranelli 1983).
Dels Alps al Tíber5.4:Mono intro1 30/11/12 17:47 Página 346
L’EMERGERE DELL’ASSETTO PROTOURBANO E LARIGOROSA CODIFICAZIONE DELLA TRADIZIONECREMATORIA ‘VILLANOVIANA’ IN ETRURIAMERIDIONALE, E I SUOI RIFLESSI NEL NORD ETRURIA
Le comunità che con più precocità assumono un assettoprotourbano sono in base ai dati attuali quelle di Vulci eTarquinia, la cui prima occupazione estensiva è ancoradel Bronzo finale 3 (Pacciarelli 1989-90, 2001), ma a breveseguono tutte le altre. A partire dal momento in cui lecomunità dell’Etruria assumono un assetto insediativo eterritoriale del tutto nuovo, palesemente associato a unanuova configurazione del potere che non può non avereavuto caratteristiche di centralizzazione sociopolitica, ilrito funerario subisce una nuova forte e generalizzatamanipolazione.A partire da questo momento si manifesta un doppioprocesso, che avviene forse in due tempi. In primo luogo,si assiste a una marcata codificazione del rito e deimanufatti ad esso connessi, che assume i caratteri chegli archeologi a partire dall’Ottocento hanno etichettatocome “villanoviani”3.E’ in particolare a Tarquinia (Fig. 4), il centro che èprobabilmente l’epicentro della svolta protourbana, che ilrito funebre crematorio si caratterizza fin dagli inizi per unforte grado di codificazione e organicità nelle forme dicomunicazione simbolica, accompagnandosi inoltre atendenze molto marcate verso l’introduzione di usi innovativi,
successivamente trasmessi al resto dell’Etruria (Iaia 1999a;Trucco 2006; Trucco/De Angelis/Iaia 2001, 2005).L’aspetto formale dei manufatti che più specificamente silegano al rituale della cremazione sembra essere parteintegrante di questo sistema semantico: il centro focale diesso è in primo luogo l’ossuario in forma di vaso con altocollo troncoconico rigonfio (Fig. 5), per lo più monoansatoe caratterizzato da notevoli regolarità dimensionali e formali(De Angelis 2001; Bettelli/Di Pillo 2000). Caratteri standardizzati si osservano: 1. nelle dimensionidegli ossuari, che si aggirano in modo costante tra i 36 ei 42 cm di altezza (ma molto spesso oscillano in un ambitocircoscritto ai 38-40 cm: Barbaro/De Angelis/Trucco 2008);2. nella forma del recipiente, caratterizzato da un corpopiriforme con alta spalla arrotondata e da un collotroncoconico rigonfio scandito nettamente alla base epiuttosto alto (l’altezza in proporzione al corpo è compresatra 2:3 e 1:1); 3. nella costante presenza della decorazionedi stile villanoviano realizzata a pettine e punzonature divario tipo, che mostra una rigorosa partizione sintattica inrapporto alla forma del vaso: alla spalla sono riservati inmodo esclusivo i motivi a metope con croci e svastiche equello a “N ramificate”, mentre al collo sono destinati nellagrandissima maggioranza dei casi i motivi a meandro etalvolta quelli angolari. Questo modello ‘canonico’ di urna è adottato a Tarquinianella prima fase villanoviana in modo estremamentecostante: nelle due necropoli di fase 1 de Le Rose e del
347
LA CREMAZIONE IN AREA MEDIOTIRRENICA TRA BRONZO FINALE E PRIMO FERRO
Fig. 6. Etruria meridionale, Tarquinia: esempi di scodelle del primo Ferro 1.
3 Per il concetto tradizionale di “villanoviano” v. Bartoloni 2002, 2003.
Dels Alps al Tíber5.4:Mono intro1 30/11/12 17:47 Página 347
Selciatello sono ad esso conformi oltre il 90% delle urne. Deve essere osservato come, in realtà, tale estremo rigoreformale si attenui al di fuori di Tarquinia, con l’eccezionedi Veio, limitatamente però al momento iniziale e pienodella fase 1 del Primo Ferro. A Caere – dove tra l’altro vi èuna compresenza fin dall’inizio dell’inumazione – adesempio sono molto diffuse fin dalla prima fase urne dianaloga forma ma prive di decorazione, mentre a Vulci, eanche nell’Etruria settentrionale, alcuni ossuari sono deltutto privi di un collo distinto, e appaiono quindi estraneial modello tarquiniese.Una maggiore variabilità si afferma anche a Tarquinia soloalla fine della fase 1 e soprattutto nella fase 2, quando sidiffondono in modo sensibile ossuari diversamente ornatio privi di decorazione, e iniziano ad affermarsi nuoveforme di urne, come si dirà più avanti.Le urne sono coperte in modo assolutamente prevalenteda scodelle monoansate a orlo rientrante (Fig. 6), anch’essecon caratteri formali piuttosto costanti e sensibili indicatori
di significati simbolici: a Villa Bruschi Falgari (Trucco/DeAngelis/Iaia 2001) si è infatti evidenziata una posizionedifferenziata del vaso sopra l’ossuario, che nelle deposizionidi adulti era tendenzialmente deposto rovesciato, in quelleinfantili in grande maggioranza con la bocca verso l’alto,talvolta impiegato anche come presentatoio di elementidi corredo.Proprio un rinvenimento avvenuto in un’area insediativa diTarquinia villanoviana, quella di Poggio Cretoncini gettaluce sull’uso di questi manufatti: in uno scarico di materialifittili molto omogeneo, costituito con tutta evidenza da unintero “servizio” bruciato in una struttura domestica (indiziatada grandissime quantità di intonaco di capanna), iframmenti di non più di una o due urne biconiche condecorazione in “stile villanoviano” (Iaia/Mandolesi/Pacciarelli2001, 9, fig. 5, n. 1) si associavano a numerosi esemplari,in gran parte ricostruibili, di scodelle del tipo impiegatonelle sepolture come coperchio. L’urna svolgeva dunqueprobabilmente la funzione di grande contenitore da
348
Cristiano Iaia, Marco Pacciarelli
Fig. 7. Etruria meridionale: esempio di normale urna con coperchio fittile simbolico a elmo apicato del primo Ferro 1 (dalla necropolitarquiniese di Villa Bruschi: Trucco et al. 2005), ed eccezionale insieme conservato a Karlsruhe costituito da urna ed elmo apicato dibronzo, proveniente dal mercato antiquario (Iaia 2005).
Dels Alps al Tíber5.4:Mono intro1 30/11/12 17:47 Página 348
cerimonia di liquidi, mentre le scodelle, ripetute in piùesemplari, potevano costituire vasi da razione individuale,nell’ambito di pratiche alimentari del tutto ignote.Ma la sfera di significato dell’urna biconica va oltre: nellanecropoli di Villa Bruschi Falgari a Tarquinia, con significativiriscontri specialmente a Vulci, si hanno le attestazioni piùantiche, risalenti alla fase 1 iniziale, dell’uso diantropomorfizzare il vaso nelle sepolture emergenti,rivestendolo di tessuti (spesso decorati da borchiette) eadornandolo con collane e fibule alla stregua di un corpoumano (Trucco/De Angelis/Iaia 2001). Uso che si diffonderà,molto più tardi, in tutta la koinè villanoviana (come definirlaaltrimenti?), raggiungendo le espressioni più articolatenella Verucchio di fine VIII-prima metà VII secolo a.C. (vonEles 2002), ma che proprio qui, nell’Etruria meridionale diX-IX secolo, è stato introdotto per la prima volta (Iaia1999a).Le caratteristiche salienti del linguaggio rituale cosìorganicamente codificato nel centro tarquiniese sidiffondono nella fase iniziale del primo Ferro – pur conmanifestazioni meno omogenee e codificate procedendosoprattutto verso nord – in tutte le maggiori comunitàdell’Etruria e anche dell’Emilia-Romagna (mentre nello
stesso periodo gli agglomerati protourbani della Campaniane elaborano uno concettualmente analogo maformalmente indipendente, che non può tuttavia essereesaminato in questa sede).Tali innovazioni si inseriscono però in ambienti che avevanoalle spalle tradizioni molto diversificate, che si riflettonoanche nella diversa organizzazione topografica deisepolcreti, meno densa e omogenea nell’Etruriameridionale, e molto più compatta e uniforme in alcunicentri dell’Etruria settentrionale (ad es. a Vetulonia: Bartoloniet al. 1996) e a Bologna (cfr. Belardelli/Giardino/Malizia1990), quasi a richiamare l’eredità di Urnenfelder comequello di Pianello di Genga.In effetti, accanto ai caratteri comuni, ognuno dei grandicentri dell’Etruria manifesta anche scelte rituali proprie edesclusive, che nel tempo si sviluppano portando a sempremaggiori peculiarità locali.La seconda grande innovazione introdotta nei sepolcretivillanoviani e visibile soprattutto a Tarquinia potrebbeapparire contraddittoria rispetto alla codificazione delrituale, mentre invece è probabilmente complementaread essa. Ci si riferisce alla precisa tendenza da parte dialcuni gruppi funerari a infrangere occasionalmente, macon frequenza crescente nel corso della fase 1, la rigidacoerenza formale del rito, inserendo elementi rari o deltutto unici, quasi sempre legati alla sfera della simbologiaguerriera, del rango e del potere. A tal fine si adottanomodelli artigianali allogeni, che nel momento iniziale delprimo ferro sembrano per lo più orientati verso l’Europacentrale.Nella vasta necropoli detta delle Arcatelle, ciò avvienenella forma della deposizione di elmi e vasi in lamina dibronzo, categorie di manufatti che nelle altre necropoli diTarquinia, per non parlare del resto dell’Etruria meridionale,appaiono quasi assenti prima di un orizzonte evoluto dellafase iniziale del Ferro.Si possono citare tre casi di elmi ad apice (Fig. 3), due deiquali di foggia centro-europea risalente allo Ha B1 (Hencken1971; Iaia 2005, 47 ss.). A questi si potrebbe accostareanche una straordinaria associazione conservata aKarlsruhe (Fig. 7), proveniente dal mercato antiquario mariferibile con verosimiglianza a Tarquinia, in cui un vasobiconico in lamina di bronzo ornato a sbalzo nello stilecentro- e nord-europeo della barca solare a protomiornitomorfe, una foggia meglio nota al principio della fase2 del ferro, si accoppia con un elmo apicato anch’esso inbronzo, la cui datazione difficilmente potrebbe scendereoltre la fase iniziale piena del primo ferro (Jurgeit 1999;Iaia 2007, 265, fig. 5).I due pezzi di Karlsruhe, insieme alle tombe con elmodelle Arcatelle, che, va ricordato, si associano ad altrielementi eccezionali come morsi equini, vasi rituali etc.(Iaia 1999a, 41, combinazione 11) configurano l’emergeredi un nuovo gruppo sociale definibile sinteticamente dei‘principi’, ovvero di individui che ricoprono ruoli sociopoliticidi vertice accentrando su di sé una serie di prerogativepolitiche, sociali, e perfino religiose. Non è certo un caso
349
LA CREMAZIONE IN AREA MEDIOTIRRENICA TRA BRONZO FINALE E PRIMO FERRO
Fig. 8. Etruria meridionale, Tarquinia: corredo di capo del primoFerro 1 dalla necropoli delle Arcatelle (Iaia 1999a).
Dels Alps al Tíber5.4:Mono intro1 30/11/12 17:47 Página 349
350
Cristiano Iaia, Marco Pacciarelli
Fig. 9. Etruria meridionale, Bisenzio: esemplificazione di corredi del primo Ferro con ceramiche e bronzi miniaturistici e con urna acapanna o a olla o a brocca (Iaia 1999a).
Dels Alps al Tíber5.4:Mono intro1 30/11/12 17:47 Página 350
che a Tarquinia queste sepolture nella fase 1 si concentrinoin un solo sepolcreto, quello delle Arcatelle, in cui comunquecontinuano ad essere sepolti individui di alto rango anchenella fase 2 (Iaia 1999a, 1999b).Spicca per la sua dirompente novità un’altra deposizionemaschile delle Arcatelle della fase 1b (Fig. 8), in cui untipo di manufatto del tutto inedito fino a quel momento,l’elmo crestato in bronzo, si associa ad una spada lungacon manico fuso ad antenne, ad una tazza d’ispirazionecentro-europea, e a una riproduzione di tavola da banchettoa scala ridotta, anch’essa di bronzo, in cui dei minuscolivasetti sono poggiati come a rappresentare “scenicamente”lo svolgimento in corso di un banchetto o di una libagione(Hencken 1968, 86 ss.; Iaia 2007, 262).Il carattere spiccatamente emergente di una parte delledeposizioni maschili delle Arcatelle si comprende megliose paragonato alla vasta maggioranza di sepolturetarquiniesi riferibili indirettamente ad armati, spesso alquantoaustere, in cui il principale elemento connotante, accantoall’assenza pressoché completa di armi reali, è lariproduzione fittizia, in ceramica, di elmi, che nelle fasi piùantiche sono del tipo a calotta o campana con apice (Fig.7) e più tardi assumono la forma di elmi crestati (Iaia 2005,106 ss.). La volontà di alludere all’esistenza di elmi diparticolare pregio, detenuti da pochi individui di altissimostatus politico, come nei casi sopra visti delle sepolturedella necropoli delle Arcatelle, è testimoniata dalla frequentepresenza sugli esemplari d’impasto tarquiniesi didecorazioni a lamelle metalliche o con applicazioni diborchie in bronzo, mentre per altri centri, come è statoipotizzato per Cerveteri da M. Zuffa (1976, 296), sembraprospettarsi la possibilità dell’esistenza di elmi in cuoio oaltro materiale deperibile. Va osservato in particolare come la conformazione a tettodi capanna dell’apice degli elmi di tipo più antico (Fig. 7),ricorrente anche in gran parte dei centri villanovianidell’Etruria meridionale – dettaglio formale del tutto assentenegli elmi in bronzo di cui sopra si è parlato – indichi comesi intendesse imitare gli elmi reali non in quanto beni diprestigio ma come simboli di una condizione socio-politicache travalicava le differenze di rango. Come indicatosoprattutto dalla necropoli di Villa Bruschi Falgari (Trucco2006; Trucco/De Angelis/Iaia 2001; 2005) dove sepolturecon elmi in ceramica, dotate di ricche associazioni vascolari(ma di regola con pochi oggetti metallici), e caratterizzateda una non trascurabile complessità e curadell’apprestamento funebre (entro strutture a custodia ocassetta), la simbologia dell’elmo-casa sembra da metterein relazione con individui investiti probabilmente del ruolodi capi di raggruppamenti familiari, membri optimo iuredella comunità protourbana corporata, e dunque solo inquanto tali anche guerrieri (Iaia 1999a; Pacciarelli 2001).
Sembra dunque che le innovazioni introdotte nell’ambitoche chiamiamo ‘villanoviano’ possano essere correlatestrettamente all’emergere di grandi centri caratterizzati danuovi e ben precisi nessi tra una massa di membri a pienodiritto della comunità e alcune figure di capi nelle cui manisi concentrano nuove prerogative sociopolitiche e forseanche religiose4.L’esistenza di ben precisi e limitati strappi alla regola delcodice funerario riservati ad alcuni capi si manifesta delresto anche in altri centri villanoviani, come Populonia – sivedano le tombe a camera circolare costruita che hannorestituito elmi di bronzo (Bartoloni 1991; Iaia 2005, 50 ss.)– e a Vetulonia, dove le tombe con spada e lancia (ma inquesto caso non elmo) si concentrano esclusivamentenei cosiddetti circoli di pietre interrotte (Cygielman 1994).
MODELLI RADICALMENTE ALTERNATIVI A QUELLOVILLANOVIANO: I RITUALI CREMATORI DELLA PRIMAETÀ DEL FERRO DEL LATIUM VETUS E DI BISENZIO
La pregnanza semantica dei codici funerari della primaetà del ferro iniziale si evince anche dalla radicaleopposizione esistente tra diversi sistemi simbolico-rituali,opposizione che si manifesta con chiarezza non solo traEtruria e Lazio, ma persino all’interno dell’Etruria.Con il passaggio al primo Ferro nel Latium Vetus le tendenzein atto già nel BF3 si sviluppano e si radicalizzano (Colonna1988; Bietti Sestieri 1992; Bietti Sestieri/De Santis 2000).Ora nelle sepolture a cremazione l’urna è quasi di regolaovoide o globulare, molto di rado decorata e comunquemai in uno stile lontanamente simile a quello villanoviano,le urne a capanna divengono molto frequenti (Bartoloni etal. 1987) e comunque anche le urne vascolari sonoconcepite come casa del morto, avendo spesso uncoperchio a tetto di capanna. Le tombe inoltre non sonoquasi mai a custodia litica come in Etruria mentre moltospesso sono deposte entro un dolio; la presenza dicomplessi corredi miniaturistici riproducenti servizicerimoniali e da banchetto e talvolta armi e strumentidiviene molto diffusa. Il rito crematorio nel Lazio peraltroandrà declinando quantitativamente in modo vistoso nelcorso del Primo Ferro, a fronte della massiccia diffusionedell’inumazione in fossa. Se l’opposizione fosseesclusivamente tra i centri dell’Etruria e quelli del Laziosarebbe lecito pensare tout court a una divaricazione tradifferenti identità etnoculturali, preludente alla formazionedei popoli latino ed etrusco, ma la realtà, come c’è peraltroda attendersi, è ben più complessa.Mentre quella che possiamo chiamare cremazione di“modello tarquiniese” viene adottata anche a Vulci, Veio eCaere, nei sepolcreti di Bisenzio, grande centrodell’entroterra, ci troviamo di fronte ad un rovesciamento
351
LA CREMAZIONE IN AREA MEDIOTIRRENICA TRA BRONZO FINALE E PRIMO FERRO
4 In proposito, è da ricordare che nelle necropoli di Tarquinia di fase 1, e specialmente in quelle che fanno corona al pianoro di Monterozzi, si nota unaparticolare predisposizione alla deposizione di oggetti di valore simbolico in ceramica. Le associazioni di tali elementi vanno da poche unità a interiservizi (come avviene frequentemente a Villa Bruschi Falgari), comprendenti sia elementi simbolici, come carri in miniatura e navicelle d’impasto, chevasi di uso prettamente rituale, come i cosiddetti kernoi (vasi a più recipienti o a più imboccature destinati a miscelare sostanze diverse), i candelabri,e i presentatoi (Iaia 1999a, 2002).
Dels Alps al Tíber5.4:Mono intro1 30/11/12 17:47 Página 351
di molti dei caratteri costitutivi del rituale ‘villanoviano’ (Fig.9), con connotati per molti versi affini a quelli del Latiumvetus (Delpino 1977). Già R. Peroni parecchi anni or sono(Peroni 1996, 434) notava la singolarità dell’assenza diurne biconiche ornate in stile villanoviano fra le sepolturebisentine, attribuendola ad una precisa scelta limitata allasfera rituale, dal momento che frammenti delle stesseforme, in tutto analoghe a quelle di Tarquinia, provenivanoinvece dalle raccolte di superficie nell’abitato (Raddatz1975). Il rifiuto di abbracciare questo tratto canonico eampiamente accolto nel resto d’Etruria si inserisce del tuttonaturalmente in un insieme omogeneo di usi rituali alternativia quello villanoviano (Iaia 1999a, 93 ss.). Se ne riassumonogli aspetti principali: 1. assenza di urne biconiche di stilevillanoviano, connessa con un’accentuata variabilità delleforme di ossuario, fra cui le più frequenti sono ollette ebrocchette inornate, anforette e urne a capanna (questeultime assai più rare a Vulci, Tarquinia, Caere e Veio:Bartoloni et al.1987); 2. forme altrettanto variabili di coperturedegli ossuari, fra cui ricorrono ciotole, piattelli, scodelletroncoconiche, coperchi a tetto di casa, mentre mancanodel tutto le riproduzioni di elmo; 3. servizi vascolari compostida numerosi piccoli recipienti appositamente prodotti peril rituale, alcuni dei quali, reminiscenti di forme del Bronzofinale, con tutta probabilità riproduzioni a scala minore diarredi o vasi di grandi dimensioni; 4. miniaturizzazionedegli indicatori di ruolo maschili, come lance, rasoi, scudi(ma mancano in apparenza le spade).La somiglianza innegabile, già notata da vari autori, chequesto complesso di usi rituali rivela con il rituale crematoriodel Lazio a sud del Tevere nelle fasi I e II, secondo RenatoPeroni (1989, 550) potrebbe essere in realtà un fattoillusorio, dovuto a un distacco intenzionale dal modellorituale tarquiniese-vulcente, conseguente ad un diversorapportarsi al comune retaggio del Bronzo finale.
La realtà è probabilmente complessa, e frutto di dueprocessi concomitanti. Bisenzio riprende e sviluppa latradizione, risalente al Bronzo finale, dei corredi miniaturisticiin ceramica, ma la rifunzionalizza alla luce di una nuovaconcezione del rituale, che in parte accoglie alcuni modellidall’ambito latino, come i coperchi a tetto e soprattutto learmi e i rasoi miniaturistici. Il punto centrale della questioneè che tale nuova concezione esprime ad un livello cognitivoancora prima che formale una vera e propria opposizioneconcettuale rispetto al rito villanoviano. Emblematica è latotale assenza delle classiche urne a collo di tipovillanoviano (se non tardivamente come vaso di corredo)e di coperchi ad elmo, e la scelta di forme di ossuari quasidel tutto ignote all’ambito villanoviano (olle ovoidi, brocchee anfore). Completa questo quadro l’estrema eterogeneitàdegli elementi di copertura delle urne, che di norma noncomprendono scodelle a orlo rientrante, forma canonicadel rito ‘villanoviano’, e invece annoverano forme moltovarie, a volte forse ereditate dal Bronzo finale come leciotole a profilo sinuoso, a volte probabilmente ispiratealla civiltà laziale come i coperchi a tetto di capanna.Rispetto a Vulci e Tarquinia del tutto diverso è inoltre aBisenzio il ruolo delle urne a capanna, non solo molto piùpiccole ma anche più diffuse nella necropoli, e spesso inrelazione a sepolture di status non elevato. Tutti questi complessi fenomeni di codificazione eopposizione coincidono verosimilmente con la faticosaaffermazione dell’autocoscienza di vaste collettività, chesi vanno trasformando in comunità dotate di una propriasovranità territoriale, un processo che è lecito pensare siastato accompagnato da rilevanti tensioni e forse da veri epropri conflitti.Non è casuale che il quadro di radicale contrapposizionetra diversi linguaggi simbolico-rituali che si è illustrato siarelativo soprattutto al primo momento di consolidamentodegli assetti protourbani, ovvero alla fase 1 iniziale e pienadel primo Ferro.
SVILUPPI RITUALI DIFFERENZIATI IN ETRURIANELLA FASE 2 DEL PRIMO FERRO: MAGGIORECONSERVATORISMO AL NORD, NUOVE TRADIZIONICREMATORIE E AFFERMARSI DELL’INUMAZIONEAL SUD
Già dalla fine della fase 1 e poi soprattutto nella fase 2 inEtruria sono riscontrabili una serie di sviluppi differenziatiche segnalano un mutamento degli equilibri interni e degliorientamenti culturali delle singole comunità. Mentrenell’Etruria del Nord e in Emilia si manifesta un forteconservatorismo del tradizionale rituale crematoriovillanoviano – pur in presenza di specifiche peculiaritàcome le tombe a inumazione in fossa e camera di Populonia– l’Etruria meridionale appare come l’area più dinamica eaperta alle innovazioni (Iaia 1999a; Bartoloni 2003;Pacciarelli 2001; Iaia/Mandolesi 2010). In primo luogo aVeio e a Caere inizia già dalla fase 1 e soprattutto nellafase 2 una penetrazione del rito dell’inumazione in fossa
352
Cristiano Iaia, Marco Pacciarelli
Fig. 10. Etruria meridionale, territorio di Veio: sezione di tombadel primo Ferro 2 da Trevignano Romano, con cremazione in ollacoperta da coppa in bronzo (Stefani 1913).
Dels Alps al Tíber5.4:Mono intro1 30/11/12 17:47 Página 352
– nel Latium Vetus come si è detto ormai ampiamentediffuso – dapprima lenta poi massiccia.Ma anche nell’ambito del rito crematorio si assiste allacreazione di nuove forme e nuove tradizioni.La linea di sviluppo più diffusa e innovativa è quella chevide a Veio, Caere e Tarquinia la sostituzione dellatradizionale urna a collo troncoconico con una formalegata alle nuove concezioni del convito a base di vino:l’olla globulare5 (Fig. 10). Questo tipo di vaso, spessorealizzato in ceramica rossa non di rado tornita – chepotrebbe far pensare a una origine fenicia della produzione,forse con la mediazione iniziale del Sud d’Italia6 – comeindicano i corredi miniaturistici era poggiato, fin dalla fase1 finale, su alti holmoi, come poi è in effetti testimoniatoin età orientalizzante. A queste tombe in vari casi siassocia il rito della deposizione entro dolio, che inprecedenza come si è detto era di norma escluso dallenecropoli villanoviane. I maschi cremati deposti entrol’olla in un primo momento recano ancora un coperchiofittile imitante un elmo, ma a partire dalla fase IIB soventesono invece coperti con una coppa di bronzo (Fig. 10),altro elemento che verosimilmente rafforza il legameideologico con l’ambito del banchetto (spegnendo perònel contempo quello con la funzione militare). La quasitotalità delle tombe con cremazione in olla, sia maschiliche femminili, presenta tuttavia corredi di norma nonabbondanti e perlopiù di scarso pregio, e comunque prividegli indicatori tipici dei nascenti ceti aristocratici, comeornamenti in oro e argento, collane d’ambra, morsi equini,elmi o scudi metallici, etc. (Iaia/Mandolesi 2010). Nel complesso tale nuova tradizione rituale – che a volteviene chiamata, ma a nostro giudizio in modo del tuttoimproprio, ‘villanoviano evoluto’ – appare denotare unnuovo ceto, la cui posizione sociale, pur subordinatarispetto alle élites, può essere definita intermedia, siaperché esso non coincide con il livello delle tombe piùpovere, sia perché appare portatore di istanze peculiari,che in quanto tali si pongono in rapporto dialettico conquelle delle élites gentilizie. Con queste ultime naturalmentesussiste un legame di necessaria complementarietà everosimilmente di dipendenza, forse di natura clientelare,che poteva trovare proprio nell’ambito del banchetto, cuiesplicitamente si richiama il rituale, un momento diintegrazione sociale e ideologica.Per sostanziare ulteriormente tale discorso, si può osservareche le tombe di medio rango a cremazione in olla sonomolto diffuse in centri secondari come Trevignano, Narcee Falerii7, in cui per vari motivi si può supporre un forte eindisturbato sviluppo del modello sociale gentilizio-clientelare.Le èlites sociali che si sono sviluppate in seno alla società
dell’Etruria tra la fine della fase 1 e la fase 2 ( 850/830 –730 a.C.) manifestano scelte rituali di segno piuttostovariabile, ma sostanzialmente riconducibili a due scelteprincipali. Una larga parte dei membri di questa nascentearistocrazia in particolare a Veio (ma per il poco che se nesa, anche a Caere) ha adottato il rito dell’inumazione infossa, nei cui corredi viene deposta in modo organico – enon più quindi con modalità selettive come nella tradizionalecremazione – tutta una ampia serie di manufatti connaturatiall’alto status del defunto (Pacciarelli 2001): per le donneornamenti di pregio a volte molto elevato, conocchiemetalliche e rocchetti, per gli uomini spade, pettorali, scudietc., per entrambi morsi equini, spiedi, alari, vasi e sostegnimetallici per banchetto e cerimonie. Una parte più limitatadell’élite, che sostanzialmente coincide con alcunipersonaggi di vertice – forse ricoprenti ruoli pubblici digrande rilievo – appare invece avere sviluppato unaversione esclusiva della tradizione crematoria villanoviana.Tale versione, riservata a figure appunto eccezionali,consiste nella deposizione dei resti cremati entro un’urnaa collo in lamina di bronzo, coperta nel caso delle tombemaschili da un elmo di bronzo, e accompagnata in generedai tipici manufatti d’élite già segnalati, a volte in quantitàrilevanti (De Santis 2005; Iaia 2005, 2007). Questo tipo dirito continuerà in Etruria meridionale fino agli inizi dell’etàorientalizzante, ma solo in centri di importanza secondaria,come Narce (De Lucia Brolli 1997), mentre nei grandicentri protourbani verrà abbandonato con la fine dellafase 2. È questo il momento in cui alcuni personaggi dirango elevatissimo, probabilmente perfino regale, comenel caso della tomba del guerriero di Tarquinia (Hencken1968, 201-220; Kilian 1977), adotteranno il ritodell’inumazione, forse allo scopo di distinguersiulteriormente rispetto all’élite, e nel contempo di aderire aun rito ormai molto diffuso tra le masse.
BIBLIOGRAFIA
ANGLE, M., CERINO, A., FISCHETTI L. 2010, Nuovirinvenimenti “dalle terre di Marino”: sepolture e areefunerarie del Bronzo Finale, L’alba dell’Etruria. Fenomenidi continuità e trasformazione nei secoli XII-VIII a.C.: AttiIX Incontro di Studi “Preistoria e Protostoria in Etruria”(Valentano-Pitigliano settembre 2008), Milano, 339-357. ANGLE, M. et al. 2004, La necropoli ad incinerazione diCavallo Morto (Anzio, Roma), L’età del bronzo recente inItalia: Atti del congresso nazionale (Lido di Camaiore2001), Lucca - Viareggio, 125-138.BAGLIONE, M. P., DE LUCIA BROLLI M.A. 1997, Veio e iFalisci, in G. Bartoloni (a cura di), Le necropoli arcaichedi Veio, Giornata di Studi in memoria di M. Pallottino,
353
LA CREMAZIONE IN AREA MEDIOTIRRENICA TRA BRONZO FINALE E PRIMO FERRO
5 Veio: Bartoloni et al. 1995; Cerveteri: Rizzo 2005, 344 ss. Questo tipo di uso rituale compare anche a Tarquinia, in un momento iniziale della fase 2A,in un ristretto numero di sepolture pertinenti ad individui in posizione sociale subordinata: Iaia 1999a, 22. 6 Un’olla d’impasto rosso tornito è presente in una sepoltura della fase 1 a Torre Galli (t. 28): Pacciarelli 1999, tav. 25, n.2. Si tratta verosimilmente di unodei prototipi di una forma che si diffonderà ampiamente fra la fine della fase 1 e soprattutto la fase 2 a Pontecagnano e in Etruria meridionale. In proposito,ma con differente interpretazione dell’origine della forma, vedi Delpino 1997. 7 Agro Falisco-Capenate: Barnabei/Cozza /Pasqui 1894; Baglione/De Lucia Brolli 1997; Trevignano: Stefani 1913.
Dels Alps al Tíber5.4:Mono intro1 30/11/12 17:47 Página 353
Roma, 145-171. BARBARO, B., DE ANGELIS, D., TRUCCO F. 2008, Latomba 182 della necropoli di Villa Bruschi Falgari a Tarquinia,Aes. Metalli preistorici dalla Tuscia, Catalogo della Mostra(Valentano settembre-ottobre 2008), Valentano, 32-39. BARNABEI, F., COZZA, A., PASQUI, A. 1894, Degli scavidi antichità in territorio falisco, Monumenti Antichi deiLincei IV.BARTOLONI, G. 1991, Populonium Etruscorum quodamhoc tantum in litore - Aspetti e carattere di una comunitàcostiera nella prima età del ferro, Archeologia ClassicaXLIII, 1-37.BARTOLONI, G. 2002, La cultura villanoviana. All’iniziodella storia etrusca, Roma. BARTOLONI, G. 2003, Le società dell’Italia primitiva. Lostudio delle necropoli e la nascita delle aristocrazie, Roma.BARTOLONI, G. et al. 1987, Le urne a capanna rinvenutein Italia, Firenze .BARTOLONI, G. et al. 1995, Veio tra IX e VI secolo a.C.,primi risultati sull’analisi comparata delle necropoli veienti,Archeologia Classica XLVI, 1994 (1995), 1-46. BARTOLONI, G. et al. 1996, Veio e Vetulonia nella primaetà del ferro: affinità e differenze sullo sviluppo di duecomunità dell’Etruria villanoviana, The Iron Age in Europe,Colloquia of the XIII International Congress of the Prehistoricand Protohistoric Sciences 11, Forlì, 67-90BELARDELLI C., GIARDINO C.,MALIZIAA. 1990, L’Europaa sud e a nord delle Alpi alle soglie della svolta protourbana,Treviso.BETTELLI, M., DI PILLO, M. 2000, La decorazione deibiconici villanoviani: contributo ad un’analisi strutturale,Preistoria e Protostoria in Etruria. Atti del quarto incontrodi studi (Manciano-Montalto di Castro-Valentano 1997),Milano, 509-518.BIETTI SESTIERI, A.M., 1992, The Iron Age Community ofOsteria dell’Osa. A Study of Sociopolitical Developmentin Central Tyrrhenian Italy, Cambridge University Press. BIETTI SESTIERI, A.M., DE SANTIS, A. 2000, Protostoriadei Popoli Latini. Museo Nazionale Romano: Terme diDiocleziano, Venezia.BIETTI SESTIERI, A.M., DE SANTIS, A. 2003, Il processoformativo della cultura laziale, Le comunità della preistoriaitaliana. Studi e ricerche sul neolitico e le età dei metalli.In memoria di Luigi Bernabò Brea, Atti della XXXV RiunioneScientifica IIPP (Lipari 2000), Firenze, 745-763.BRUSADIN, D., 1964, Le necropoli protostoriche del Sassodi Furbara. I. La necropoli ai Puntoni, Bullettino diPaletnologia Italiana 73, 148-186.BURANELLI, F., 1983, La necropoli villanoviana “Le Rose”di Tarquinia, Roma.CARDARELLI, A. 1997, Terramare: l’organizzazione socialee politica delle comunità, inM. Bernabò Brea - A. Cardarelli- M. Cremaschi (a cura di), Le Terramare. La più anticaciviltà padana, Catalogo della mostra (Modena, marzo -giugno 1997), Milano, 653-660.CARDARELLI, A., PELLACANI, G. 2004, La necropoli diCasinalbo (Formigine- Modena), L’età del bronzo recente
in Italia: Atti del congresso nazionale (Lido di Camaiore2001), Lucca - Viareggio, 111-120.CARDARELLI, A., LABATE, D., PELLACANI, G. 2006, Oltrela sepoltura. Testimonianze rituali ed evidenze sociali dallasuperficie d’uso della necropoli della Terramara diCasinalbo, Studi in onore di Renato Peroni, Borgo S.Lorenzo 2006, 624-642.COLONNA, G. 1974, Preistoria e Protostoria di Roma edel Lazio, Popoli e Civiltà dell’Italia antica, vol. 2, Roma,273-346.COLONNA, G. 1988, I Latini e gli altri popoli del Lazio,Italia Omnium Terrarum Alumna, Milano, 411-528.COLONNA, G. 1991, Gli scudi bilobati dell’Italia centralee l’ancile dei Salii, Archeologia Classica XLIII, 57-122.CYGIELMAN, M. 1994, Note preliminari per unaperiodizzazione del villanoviano di Vetulonia, La presenzaetrusca in Campania meridionale, Atti del Convegno(Pontecagnano-Salerno 1990), Firenze, 253-292. DE ANGELIS, D. 2001, La ceramica decorata di stile”villanoviano” in Etruria meridionale, Soveria Mannelli. DE LUCIA BROLLI, M.A. 1997, Narce, scavi e ricerche inmuseo: la tomba 4 (XXXIV) della Petrina A, Etrusca etItalica, Scritti in ricordo di M. Pallottino, Pisa-Roma, 205-233. DELPINO, F. 1977, La prima età del ferro a Bisenzio -Aspetti della cultura villanoviana nell’Etruria meridionaleinterna, Memorie dell’Accademia dei LinceiXXI, 453-493.DELPINO, F. 1987, Etruria e Lazio prima dei Tarquini. Lefasi protostoriche, Etruria e Lazio arcaico, Atti dell’Incontrodi studio (Roma 1986), Roma, 9-36.DELPINO, F. 1997, I Greci in Etruria prima dellacolonizzazione euboica: ancora su crateri, vino, vite epennati nell’Italia centrale protostorica, in G. Bartoloni (acura di), Le necropoli arcaiche di Veio, Giornata di Studiin memoria di M. Pallottino, Roma, 185-194.DE SANTIS, A. 2005, Da capi guerrieri a principi: lastrutturazione del potere politico nell’Etruria protourbana,Dinamiche di sviluppo delle città dell’Etruria meridionale.Veio, Caere, Tarquinia, Vulci, Atti del XXIII convegno distudi etruschi e italici (Roma-Veio-Cerveteri/Pyrgi-Tarquinia-Tuscania-Vulci-Viterbo 2001), Pisa-Roma, 615-631.DE SANTIS, A. 2005a, A research project on the earliestphases of the Latial Culture, in P. Attema, A. Nijboer, A.Zifferero (a cura di), Papers in Italian Archaeology VI,British Archaeological Reports 1452.1, 156-163DE SANTIS, A. 2008, I rinvenimenti di epoca protostorica,in R. Cereghino (a cura di), La Cancelliera. Una ricercasul territorio, Roma, 13-24. VON ELES, P. (a cura di) 2002, Guerriero e sacerdote.Autorità e comunità nell’età del ferro a Verucchio. Latomba del trono, Quaderni di Archeologia dell’EmiliaRomagna 6, Firenze. HENCKEN, H. 1968, Tarquinia, Villanovans and EarlyEtruscans, Cambridge. HENCKEN, H. 1971, The Earliest European Helmets,Harvard. IAIA, C. 1999a, Simbolismo funerario e ideologia alle
354
Cristiano Iaia, Marco Pacciarelli
Dels Alps al Tíber5.4:Mono intro1 30/11/12 17:47 Página 354
origini di una civiltà urbana. Forme rituali nelle sepolture“villanoviane” a Tarquinia, Vulci e nel loro entroterra, Firenze.IAIA, C. 1999b, Le Arcatelle di Tarquinia: dati e ipotesisull’organizzazione planimetrica della necropoli protostorica,Bollettino della Società Tarquiniense di Arte e Storia XXVIII,5-21.IAIA, C. 2002, Oggetti di uso rituale nelle necropoli«villanoviane» di Tarquinia, in Negroni Catacchio N. (acura di), Atti V Incontro di Studi Preistoria e Protostoria inEtruria (Pitigliano, Farnese 2000), Milano, 729-738.IAIA, C. 2005, Produzioni toreutiche della prima età delferro in Italia centro-settentrionale. Stili decorativi,circolazione, significato, Biblioteca di Studi Etruschi 40,Pisa-Roma.IAIA, C. 2007, Prima del “simposio”: vasi in bronzo econtesto sociale nell’ Etruria meridionale protostorica,Revista d’Arqueologia de Ponent 16-17, 261-270. IAIA, C., MANDOLESI A. 2010, Comunità e territori nelVillanoviano evoluto dell’Etruria meridionale, L’albadell’Etruria. Fenomeni di continuità e trasformazione neisecoli XII-VIII a.C., Atti IX Incontro di Studi “Preistoria eProtostoria in Etruria” (Valentano-Pitigliano settembre2008), Milano, 61-78. IAIA, C., MANDOLESI, A., PACCIARELLI, M. 2001,Cretoncini: un’indagine nell’area settentrionale dell’abitato,inMORETTI SGUBINI, A.M. (a cura di), Tarquinia etrusca.Una nuova storia, Catalogo della Mostra (Tarquinia 2001),Roma, 7-10. JURGEIT, F. 1999, Badisches Landesmuseum Karlsruhe.Die Etruskischen und Italischen Bronzen sowieGegenstände aus Eisen, Blei, und Leder im BadischenLandesmuseum Karlsruhe, Pisa-Roma.KILIAN, K., 1977, Das Kriegergrab von Tarquinia, JahrbuchDeutschen Archaeologischen Instituts, 92, 24-98.MÜLLER – KARPE, H. 1959, Beiträge zur Chronologie derUrnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen, Berlin.PACCIARELLI, M. 1989-90, Ricerche topografiche a Vulci:dati e problemi relativi all’origine delle città medio-tirreniche,Studi Etruschi LVI, 11-48.PACCIARELLI, M. 1999, Torre Galli. La necropoli dellaprima età del ferro (Scavi P. Orsi 1922-23), Soveria Mannelli.PACCIARELLI, M. 2001, Dal villaggio alla città. La svoltaprotourbana del 1000 a.C. nell’Italia tirrenica, Firenze.PERONI, R. 1989, Protostoria dell’Italia continentale. Lapenisola italiana nelle età del bronzo e del ferro, Popoli eCiviltà dell’Italia antica 9, Roma.PERONI, R. 1996, L’Italia alle soglie della storia, Bari.RADDATZ, K. 1975, Bisenzio I, Beobachtungen auf einemeisenzeitlich-frühetruskischen Siedlungskomplex,Hamburger Beiträge z. Archaeologie V, 1-60.RIZZO, M. A. 2005. Ceramica greca e di tipo greco daCerveteri (dalla necropoli del Laghetto e dall’abitato),Oriente e Occidente: metodi e discipline a confronto.Riflessioni sulla cronologia dell’età del Ferro italiana, AttiIncontro di Studi (Roma 30-31 ottobre 2003),MediterraneaI, Pisa-Roma, 333-378. SCHAUER, P., 1988, Die Kegel- und Glockenförmigen
Helme, Antike Helme. Sammlung Lipperheide und andereBestände des Antikenmuseums Berlin,Mainz, 181-194.STEFANI, E. 1913, Trevignano Romano - Antichi sepolcriscoperti in via della Macchia, Notizie degli Scavi di Antichità,37-43. TRUCCO, F. 2006, Indagini 1998-2004 nella necropolitarquiniese di Villa Bruschi Falgari: un primo bilancio,Archeologia in Etruria meridionale, Atti delle giornate distudio in ricordo di Mario Moretti (Civita Castellana,novembre 2003), Roma, 183-198. TRUCCO, F., DE ANGELIS, D., IAIA, C. 2001, Villa BruschiFalgari: il sepolcreto villanoviano, in MORETTI SGUBINI,A.M. (a cura di), Tarquinia etrusca. Una nuova storia,Catalogo della Mostra (Tarquinia 2001), Roma, 81-93. TRUCCO, F. et al. 2005, Nuovi dati sul rituale funerario diTarquinia nella prima età del ferro, Dinamiche di sviluppodelle città nell’Etruria meridionale, Atti XXIII Convegno diStudi Etruschi e Italici (Roma, Cerveteri, Tarquinia, Montaltodi Castro, Viterbo, ottobre 2001), Pisa-Roma, 359-369. ZUFFA, M. 1976, La civiltà villanoviana, Popoli e Civiltàdell’Italia Antica V, 197-363.
355
LA CREMAZIONE IN AREA MEDIOTIRRENICA TRA BRONZO FINALE E PRIMO FERRO
Dels Alps al Tíber5.4:Mono intro1 30/11/12 17:47 Página 355




















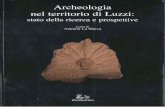













![Finale 2003 - [Untitled3]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63186635cf65c6358f01f7b4/finale-2003-untitled3.jpg)

