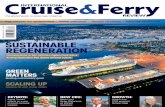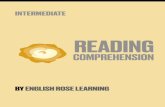Un signaculum in bronzo dal territorio di Rose
Transcript of Un signaculum in bronzo dal territorio di Rose
Il volume è stato stampato grazie anche al contributo della Banca di Credito Cooperativo Mediocrati
© 2002- Rubbettino Editore 88049 Soveria Mannelli (Catanzaro)- Viale Rosario Rubbettino, l O- Te!. (0968) 662034
COMUNE DI LUZZI Assessorato alla Cultura
ASSOCIAZIOìiE CULTURALE "lmleme per Luzzi"
Archeologia nel territorio di Luzzi: stato della ricerca e prospetti ve
Atti della Giornata di Studio (Luzzi , 20 maggio 1998)
a cura di
Antonio La Marca
Rubbettino
Un signaculum in bronzo dal territorio di Rose
di Antonio Zumbo
Il mio breve intervento in questa sede è stato sollecitato dalla cortese segnalazione, da parte del dott. Antonio La Marca, di un inedito documento epigrafico, rinvenuto, casualmente, pochi mesi or sono, nel limitrofo Comune di Rose in loc. Petraro (CS) 1•
Si tratta di una targhetta corniciata a forma di crescente (lung. cm 6 x larg. cm 5,2; spes. cm 0,7-0,8, lett. l. l cm 0,9; l. 2 cm 0,8; peso gr. 92,6) che reca sul retro un anello per la presa a giro interno circolare (diam. cm 1,7). Lo stato di conservazione é ottimo. Le lettere apicate, senza nessi, a rilievo e retrograde, sono distribuite su due linee. Un solo segno di interpunzione triangolare é collocato dopo l 'ultima lettera (figg. 1-2-3). Così il testo:
Cresi centi(s)
Pur non proveniente da un contesto archeologico indagato scientificamente, ma frutto di un rinvenimento fortuito, non avendo perciò a disposizione i dati necessari a rispondere "a tutti gli interrogativi possibili nell'esame e nell 'inte1pretazione dell'oggetto"2, la rarità e eterogeneità della classe di materiali cui appartiene, mi ha spinto a rendere noto questo signaculum di bronzo, verosimilmente, prodotto colando il metallo fuso in una matrice3.
Le difficoltà incontrate nello studio di questi oggetti4, particolarmente ricercati da collezionisti e antiquari , che ne provocano spesso l'allontanamento dai luoghi di rinvenimento, è accentuato dalla mancanza di repertori sistematici e analitici organizzati per aree geografiches.
Il nostro reperto presenta l'indicazione di un solo dato onomastico al genitivo6. Nel Bruzio quest'elemento personale è già attestato come cognomen a Locri?, da dove provengono altri signacula bronzei s.
Dalla paleografia, unico elemento a nostra disposizione, ipotizzerei una datazione al I sec. d. C.
I Romani usavano sigilli realizzati in vari materiali (legno, metallo, pietra, ecc.) e con forme differenti (quadrata, rettangolare, rotonda, lunata, zoo-
morfa, planta pedis, ecc.). L'impressione di un marchio su oggetti costruiti con materiali diversi (argilla, cera, cuoio, pellame, stoffe, prodotti alimentari da forno, ecc.) era volta ad indicarne il proprietario, il produttore, e a volte attraverso espressioni particolari a svolgere una semplice funzione decorati va9.
Se la destinazione d 'uso dei sigilli appare quindi evidente, contrassegnare alcuni oggetti, non é di contro altresì facile determinare sempre con certezza le funzioni e le finalità dei diversi sistemi di bollatura, e nel caso specifico dei sigilli bronzei, l ' individuazione delle categorie di oggetti sottoposti alla marchiatura. Le generiche informazioni offerte in merito dalle fonti letterarie, non aiutano a risolvere la questione. Ricordo in proposito, ad esempio, quanto affermano il naturalista Plinio il Vecchio e il poeta Giovenale.
Il primo nella sua vastissima opera, trattando in generale dei metalli, nel settore riservato agli anelli, fa cenno ai sigilli, ma li considera simboli di prestigio e strumenti d'impiego comune per bollare derrate alimentari: «Dapprima era uso portare anelli a un solo dito, quello vicino al più piccolo; lo vediamo nelle statue di Numa e Servio Tullio. Poi se ne sono messi al dito vicino al pollice, anche nelle immagini delle divinità, e poi ancora si prese piacere a mettere pure al dito mignolo. In Gallia e in Britannia si dice che si utilizzasse il dito medio. Oggi questo è il solo dito escluso, mentre tutti gli altri sono caricati di anelli, così come anche le falangi ne hanno, ognuna per sé, altri più piccoli. C'è chi ne accumula sul solo dito mignolo, mentre altri anche a questo dito portano un solo anello, che serve per sigillare il loro sigillo. Questo è tenuto nascosto, come cosa rara e che non merita l'ingiuria dell'uso, ed è tirato fuori come da un sacrario; così, portare anche un solo anello al mignolo equivale a menar vanto che si possiedono al sicuro oggetti più preziosi. Alcuni poi ostentano il peso dei loro anelli; per altri è unafaticaportarne più di uno; altri ritengono più sicuro, per l'ansietà ad essi procurata dalle gemme, rivestire con laminette d'oro un materiale più leggero, per evitare le cadu-
121
te; altri sotto le gemme racchiudono il veleno, come Demostene, massimo oratore della Grecia, e portano gli anelli per poter morire. Insomma, la maggior parte dei delitti connessi alla ricchezza sono eseguiti con anelli. Oh, quale fu la vita dei nostri antichi avi, e quale la sua innocenza, quando nulla era sigillato! Oggi anche i cibi e le bevande sono protette contro il furto mediante un anello. Questo è il profitto che ci hanno procurato legioni di schiavi, questa moltitudine di stranieri radunata in casa nostra, e il nomenclatore che ormai bisogna impiegare anche per riconoscere i servitori. Altra cosa era presso gli antichi, quando ogni padrone aveva un solo servo, Marciporo o Luciporo, che prendeva il suo nome gentilizio e consumava ogni pasto in comune con lui, e non c'era bisogno di alcuna sorveglianza in casa propria nei confronti della gente di casa. Oggi ci si procurano le vivande che saranno rubate e allo stesso tempo coloro che le ruberanno, e non basta più aver messo sotto sigillo addirittura le chiavi stesse. Si sottraggono gli anelli a chi è appesantito dal sonno o a chi è in punto di morte; la principale ragione di vita ha cominciato a ruotare attorno a questo strumento. Non si sa bene da quando è così; ma sembra che possiamo notare il prestigio di questo oggetto presso i popoli stranieri più o meno al tempo di PoliCI·ate, tiranno di Samo, che gettò in mare l'anello a lui tanto caro e lo riebbe indietro nel ventre di un pesce che era stato pescato; e Policrate fu ucciso attorno al230o anno della nostra città [524 a. C.]. L'uso deve aver cominciato a diffondersi col pre-
122
stito a interesse. Ne è prova la consuetudine della gente del popolo, in mezzo alla quale ancora oggi in occasione di un'obbligazione salta fuori un anello, consuetudine conservatasi dal tempo in cui non c'erano ancora pegni più prontamente disponibili. Possiamo quindi affermare con sicurezza che da noi ha avuto inizio prima l'uso della moneta e più tardi quello degli anelli. Delle monete parleremo tra breve. Gli anelli hanno distinto il secondo ordine dalla plebe, una volta che cominciarono ad essere diffusi, così come la tunica distingueva il senato da coloro che portavano gli anelli ... » 10.
Il secondo, a sua volta, ne parla evidenziandone l'uso nell'ambito domestico per evitare i furti: «[l'avaro l Mortifica il ventre degli schiavi falsificando il moggio, digiunando egli stesso: mai, infatti, si azzarda a consumare i muffiti tozzi di pane bluastro, abituato com'è a riporre nel bel mezzo di settembre gli avanzi del giorno prima e a rimandare all'ora della cena successiva un piatto di fave estive e un resto di pesce (il tutto sotto sigillo) o un mezzo siluro già fetido; e a chiudere in dispensa, dopo averle contate, le fettine di un porro da tritare» 11 •
Le ipotesi formulate circa la destinazione e l'uso specifico di questo tipo di punzoni, hanno dato vita fra gli studiosi ad un dibattito tuttora aperto'2.
Il nostro sigillo potrebbe, quindi verosimilmente, ascriversi sia ad un ambito d'uso domestico, sia ad un particolare gruppo di punzoni, legati alla sfera della produzione e commercializzazione delle merci.
•
NOTE
1 Ringrazio il dott. A. La Marca per le foto , le informazioni liberamente offertemi e l'opportunità concessami di esaminare il reperto, ancora in collezione privata.
2 Per la schedatura dell ' instmmentum cfr. V. MORIZIO, Proposta di 11110 schema-guida per la scheda tura dell'instrumenttl/11 inscriptum, in "Epigrafia della produzione e della distribuzione" Actes de la VIle Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain, Rome, 5-6 juin 1992, Rome 1994, pp. 227-233.
3 Sui signacula cfr. Th. MOMMSEN, CILX, p. 915; H. DRESSEL, CIL XV, I, p. 3; V. CHAPOT, s. v. signun1, in Ch. DAREMBERG, E. SAGLJO, Dictionnaire des antiquités greques et romaines, IV, 2, Paris 1911 , pp. 1328-1331; P. WENGER, s. v. signum, in Pauly Wissawa, II, A2 (1923) , coli. 2361-2448; R. CAGNAT, Cours d'epigraphie latine, Paris 19144, pp. 362-364; M. A. DOLLFUS, Les cachets de bronze romains, in «Bulletin archéologique du comité des travaux historiques et scientifiques» n. s. III (1967) , pp. 117-161; C. GrovAGNETTI, Analisi di Rimini antica: i «signacula», in «Atti e memorie della deputazione di storia patria per le province di Romagna» XXIX-XXX (1978-1979), pp. 71-87; M. BuONOCORE, Signaculo nel Museo Profano della Biblioteca Apostolica Vati cana, in "Epigraphica" XLVI (1984), pp. 158-167; E. M. LoRETI, Signacula bronzei dell'antiquarium comunale di Roma, in "Epigrafia della produzione e della distribuzione" Actes de la VII e Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde roma in , Rome, 5-6 juin 1992, Rome 1994, pp. 645-653 con bibliografia di alcuni repertori .
4 Dopo oltre cento anni dalla sua pubblicazione, l 'unico studio di carattere generale su questa classe di materiali rimane V. PoGGI , Sigilli antichi romani, Parma 1876.
5 F. TAGLJETTI , Un inedito bollo laterizio ostiense ed il commercio dell 'olio betico, in "Epigrafia della produzione e della distribuzione" Actes de la VIJe Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain, Rome, 5-6 juin 1992, Rome 1994, p. 161.
6 Per Crescens come cognomen cfr. I. KAJA NTO, The Lati n cognomina, Helsinki-Helsingfors 1965, pp. 93,234.
7 V d. C! LX, 21; E. DE RUGGI ERO, Sylloge epigraphica orbis romani , vol. Il, pars 1: lnscriptiones ltaliae regionum /.1/.ll/./V.V continens, edidit D. VAGLJERI, Romae 1904, nr. 3352; F. CosTABILE, Municipiwn Locrensium . Istituzioni ed organizzazione sociale di Locri romana (attraverso il corpus delle iscrizioni latine di Locri) , Casoria (Napoli) 1976, n r. 17 (tav. VIII fgg. 15-16); F. NIUTTA, Le fonti letterarie ed epigrafiche, in Locri Epizefiri , I, Firenze 1977, p. 329; M. BuoNoCORE (a cura di) , Locri, in «Supplementa Italica» n. s. III, Roma 1987, p. 17. C/L X, 36; F. BARNABEI, Locri (Comune di Gerace), in «Notizie degli scavi di antichità» (1891), p. 297; F. COSTABILE, Municipiwn Locrensium. Istituzioni ed organizzazione sociale di Locri romana (attraverso il corpus delle iscrizioni latine di Locri) , Casoria (Napoli) 1976, nr. 16 (tav.
VII fg . 14); M. BuoNOCORE(acuradi),Locri, in «Supplementa Italica» n. s. III, Roma 1987, p. 19. Forse da integrare anche in G. FIORELLI , Gerace, in «Notizie degli scavi di antichità» ( 1886), p. 436 nr. a; A. M. DE LOR ENZO, Le scoperte archeologiche di Reggio Calabria nel Il biennio di vita del Museo civico, Reggio Calabria 1886, p. 60 nr. a; EE VIII, 254a; F. COSTABILE,Municipium Locrensium. lstituzioni ed organizzazione sociale di Locri romana (attraverso il corpus delle iscrizioni latine di Locri), Casoria (Napoli) 1976, nr. 19; M. BuONOCORE, Locri , in «Supplementa Italica» n. s. III, Roma 1987, p.20.
8 V d. F. COSTABILE, Municipium Locrensium.lstituzioni ed organizzazione sociale di Locri romana (attraverso il corpus delle iscrizioni latine di Locri) , Casoria (Napoli) 1976, p. 57 nrr. 47-48 (tav. XIX, 37-38), con bibl. precedente. Per completare il quadro dei signacula in bronzo con iscrizione in lingua latina rinvenuti nel Bruzio vd . CILX, 8059, 14 (Vibo Valentia); CILX, 8059,46 (Vibo Valentia); CILX, 8059, 74 (Vibo Valentia); CILX, 8059, 133 (Vibo Valentia); CILX, 8059, 369 (Vibo Valentia); CIL X, 8059, 390 (Vibo Valentia); CIL X, 8059,428 (Vibo Valentia) ; CILX, 8059,441 (Comerconi); CIL X, 8059, 465 (Comerconi); CIL X, 8059, 470 (Vibo Valentia) ; CILX, 8338a (Vibo Valentia); CILX, 8337,3 (Reggio Calabria); F. BARNABEI, Reggio di Calabria. Di un sigillo di bronzo con leggenda latina, in «Notizie degli scavi di antichità» ( 1896), p. 300; A. SOLANO, Bruttium paleocristiano, Vibo Valentia 1976, p. 68 n. 115. Sono altresì da espungere dal patrimonio epigrafico Calabrese i 27 signacula segnalati in V. CAPIALBI, Epistole, Riviste, /{{ustrazioni e Descrizioni, Napoli 1949, pp. 140-142, la maggior parte dei quali erroneamente inseriti nel X volume del Cmpus /nscriptionum Latinarum ai nnr. 8059, 6; 8059, 50; 8059, 163; 8059,170; 8059, 206; 8059, 224;8059,228;8059,241;8059,257;8059,277;8059,295; 8059,311;8059,371;8059,386-387;8059,396; 8059, 403 ; 8059,411;8059,445;8059,463;8059,499;8059,501conle già ribadito da ultimo in M. PAOLETTI , Il giornale degli scavi di Monteleone di Vito Capialbi: w w rilettura , in «Annali della scuola normale di Pisa. Classe di lettere e filosofia» XIX, 2 (1989) , pp. 500-501. Per il rinvenimento di una matrice di bollo nel territorio di Tarsia v d. : P. Gallo, La ricerca archeologica nella media valle del Crati: storia degli studi (sec. XX), injra, fig. 12.
9 Per la determinazione del valore dei bolli ottenuti con signacula bronzei da ultimo cfr. E. M. LORETI, Signacula bronzei dell'antiquarium comunale di Roma, in "Epigrafia della produzione e della distribuzione" Actes de la VII e Rencontre franco-italienne sur l 'épigraphie du m onde romain, Rome, 5-6 juin 1992, Rome 1994, pp. 646-647. Sul fenomeno della bollatura delle merci in età romana cfr. D. MANACORDA, Appunti sulla bollatura in età romana, in w. v. HARRIS (a cura di), The inscribed economy. Production and distribution in the Roma n empire in the ligl1f of instrumentu111 domesticum. The
123
Indice
Presentazione
Saluti delle Autorità
GIUSEPPE MARCHESE Sindaco di Luzzi
ELENA LATI ANZI Soprindentente archeologo per la Calabria
ROBERTINO MONTALTO Assessore ai Beni Culturali del Comune di Luzzi
TARCISIO FINGITORE Ispettore onorario per i Beni Culturali di Luzzi e Rose
ANTONIO LA MARCA Presidente dell'Associazione culturale "Insieme per Luzzi"
Relazioni
Presiede ELENA LATI ANZI
PIER GIOVANNI Guzzo
Ricordi di Luzzi
GIOACCHINO LENA
Evoluzione geom01jologica del territorio di Luzzi
ANTONIO LA MARCA
Nuovi materiali per una carta archeologica del territorio di Luzzi
Presiede SEBASTIANA LAGO NA
MASSIMO FRASCA
Indigeni e Greci nella media valle del Crati
GUGLIELMO GENOVESE
Alcuni aspetti dell 'artigianato coloniale nella Calabria settentrionale. Considerazioni in merito alla rilettura iconografica di una kore miniaturistica di Rose
p. 5
9
11
13
15
17
21
23
27
33
59
61
65
173
PresiedeGIUSEPPEROMA p. 75
MAURIZIO PAOLEITI
La necropoli di San Vito 77
ADELE COSCARELLA
Tracce archeologiche a Muricelle: note su un insediamento rurale 115
ANTONIO ZUMBO
Un signaculum in bronzo dal territorio di Rose 121
SILVANALUPPJNO
La tutela dei beni archeologici nel territorio di Luzzi 125
ANTONELLO SA VAGLIO
Ricerca antiquaria e scoperte archeologiche in Calabria e a Luzzi in Età Moderna 129
PAOLO GALLO
La ricerca archeologica nella media valle del Crati: storia degli studi (sec . XX) 147
ALESSANDRO V ANZEITI- DORIANA RIGHINI
Nota su un reperto protostorico da Muricelle di Luzzi (Cosenza) 157
PAOLO GALLO
Note intorno alla Stati o di Crater fl. 167
174