Da Martino Martini a Zhang Weiwei , 1614-2014. Europa e Cina tra due realtà virtuali
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Da Martino Martini a Zhang Weiwei , 1614-2014. Europa e Cina tra due realtà virtuali
1
Da Martino Martini a Weiwei Zhang, 1614-2014Orlando Lentini
[ Paper presentato alla International Conference‘Martino Martini (1614-1661) man of dialogue’Trento, Centro Martino Martini – October 15-17, 2014]
1. Martino Martini fra due realtà virtuali
La cosiddetta sociologia della conoscenza, un campodi indagine avviato da sociologi tedeschi come MaxWeber con la sua ‘sociologia delle religioni’ e daKarl Mannheim con Ideologia e utopia, per essere poitrattato come disciplina specifica da Robert K.Merton alla Columbia University, era giunta allaconclusione che la realtà è una costruzione sociale.Il libro di Berger e Luckmann, The Social Construction ofReality (1966), riaffermando un principio positivisticodi fatto prendeva atto che la realtà è in primo luogoconoscenza1.
L’avvento dell’informatica aveva ulteriormenterafforzato l’idea che la percezione della realtàreale deve passare per la realtà virtuale. Il cyberfilosofo Pierre Lévy ha anche sostenuto che il nostroaccesso alla realtà è reso possibile dallavirtualizzazione2 dell’esperienza attraverso i varilinguaggi. Con la formazione dei linguaggi, poi dellescritture, i gruppi umani hanno potuto tesaurizzarela loro esperienza cognitiva e organizzativa,avviandosi per vie molteplici alla formazione dei
1 E. Doyle McCarty, Knowledge as Culture. The New Sociology of Knowledge, London and NewYork, Routledge 1996.2 Pierre Lévy, Qu’est-ce que le virtuel? Paris, La Découverte 1995, pp. 69-75.
2
loro sistemi storici. La loro memoria è la realtàvirtuale con cui vivono e costruiscono il presente.
l fatto che si sia giunti a questa visione, che eraulteriormente sostenuta dalle varie svolte culturali,filologiche, dialogiche etc. non significa che primanon vi fosse coscienza della centralità della realtàvirtuale nella vita umana. Ciò era più avvertito aproposito delle religioni, ma anche di prodotticulturali come le varie arti e le letterature(virtualizzazione della virtualizzazione secondoLévy), ivi compresa la scienza, ma era facilegiungere alla conclusione che l’intera vita umana, equindi ‘la cultura’ nel suo complesso, era realtàvirtuale.
Così, gli incontri fra sistemi storici e cultureradicalmente diverse per lingua, scrittura,religione, organizzazione sociale non potevano chedar luogo ad imprese di traduzione delle loro realtàvirtuali. Il problema del contatto fra culturediverse si proponeva ora non più come problemaoccasionale, ma piuttosto come problema siastrutturale che mondiale. Questo è quanto dovetteroaffrontare gli osservatori e investigatori delle dueIndie, quella americana e quella asiatica, implicandoanche la creazione di un’apposita metodologia per lostudio e l’osservazione dell’Altro3. Martino Martinicompare sulla scena a processo già avviato da oltreun secolo, ma il suo contributo in epoca barocca, pereccellenza l’epoca della realtà virtuale e di DonChisciotte, sarà straordinario.
C’è da dire che in quegli stessi anni era in corsonon solo la reciproca traduzione di due realtàvirtuali così diverse come quella europea e quella
3 Nicolas Standaert, Methodology in View of Contact Between Cultures: The China Case in the 17 th
Century, Hong Kong, Center for the Study of Religion and Chinese Society,Occasional Paper N. 11, December 2002.
3
cinese, ma anche l’avvio della prima definizioneteorica della struttura organizzativa della nuovaeconomia mondiale a base europea. Era in corso laformazione di un nuovo modo di pensare il mondo incui misurazione e quantificazione determinavano ilgraduale spostamento dal mondo del pressappoco almondo della precisione. Durante il ‘lungo XVIsecolo’, fra il 1500 e il 1650, si verifica una sortadi ‘accumulazione originaria’ di documentazione,esperienza, informazioni, nuovi saperi, che rendonoobsolete tutte le enciclopedie precedenti4.
Solo grazie a questa sorta di ‘accumulazioneoriginaria’ di nuovi saperi è possibile tentare didare un senso alla dinamica del nuovo sistemamondiale in formazione, con la sua emergente nuovadivisione mondiale del lavoro. L’opera di WilliamPetty, avviando la formazione dell’economia politica,incomincia a definire la logica e la dinamica diquello che sarà più tardi chiamato ‘capitalismo’,mentre negli stessi anni Martini ci descrive in modometodico e con sorprendente cura dei dettagli unmondo almeno all’apparenza statico, che con terminidi Schumpeter possiamo definire di ‘flussocircolare’, senza sviluppo5.
Martini sembra rappresentare il culmine delprocesso di accumulazione originaria di nuovi saperi,dopo il quale si incomincia a modellare il paradigmadi funzionamento del nuovo sistema mondiale informazione. L’originalità dell’impresa intellettualedi Martini assume maggior rilievo quando si prende in
4 Sulla formazione dell’attuale modo occidentale di pensare il mondo, cfr.Orlando Lentini, Saperi sociali, ricerca sociale 1500-2000, Milano, Angeli 2003, pp.9-104.Sulle enciclopedie medievali cfr. Maria Teresa Fumagalli, Premessa a Momenti emodelli nella storia dell’enciclopedia, ‘Rivista di Storia della Filosofia’, 1, 1985.5 Probabilmente si deve a questo supposto ordine naturale cinese, con la suastabilità, se i Fisiocrati ne hanno fatto un modello di buon funzionamentoeconomico. Cfr. Lewis A. Maverick, China. A Model for Europe, San Antonio (Texas),Anderson 1946.
4
considerazione il contesto. Fra il 1500 e il 1650 haavuto luogo in Europa e nelle regioni sotto ildominio europeo una nuova strutturazione dei saperi,in particolare i saperi sociali, e si è andatoformando un nuovo modo di pensare il mondo. Si trattòdi una fase di grande effervescenza ideologica che èstata anche storicizzata come ‘rivoluzionescientifica’, mentre si trattava di nuova fondazionedella realtà virtuale su basi di osservazione,esperienza, esperimento, misurazione6.
Inoltre, a metà del Seicento il declinodell’impero spagnolo e l’ascesa egemonica dell’Olanda(Paesi Bassi) stavano cedendo il passo a un nuovoassetto geoeconomico con un nuovo outsider,l’Inghilterra, che Petty rappresenta in PoliticalArithmetick come il futuro paese in grado di dominareil mercato mondiale. Si trattava di mondi riformatialle prese con importanti trasformazioni dei lororegimi politici. L’Europa era allora politicamentedivisa in monarchie assolute, monarchie parlamentaricome l’Inghilterra, e repubbliche come l’Olanda.
Il mondo di Martini, del Collegio Romano, deigesuiti, è un mondo contro-riformato, con prevalenzadi monarchie assolute, con economie poco brillanti,insomma un mondo quasi statico o comunque diriproduzione semplice o di flusso circolare. Puressendo molto attiva una sorta di comunitàscientifica trasversale, una vera e propria comunitàepistemica, che coinvolgeva paesi di sviluppo e paesidi flusso circolare, il cuore dell’innovazione erasituato nei Paesi Bassi e a Londra. Proprio nella
6 Sul mito storiografico della cosiddetta ‘rivoluzione scientifica’ cfr. H.Floris Cohen, The Scientific Revolution. A Historiographical Inquiry, Chicago and London, TheUniversity of Chicago Press 1994, pp. 494-502.
5
Londra puritana nel 1660 verrà istituita la RoyalSociety of London for Improving of Natural Knowledge7.
D’altra parte questo appare come il programma diricerca di un’intera epoca, il lungo XVI secolo,caratterizzata dallo sviluppo di pratiche ‘induttive’delle intelligentsie asburgiche e ibero-fiamminghe.A consuntivo, dopo un secolo di materialismospontaneo degli spagnoli e di pragmatismo spiritualefiammingo, il Novum Organon (1620) di FrancescoBacone potrà così riassumere il nuovo ‘metodo’:critica della ragione spontanea e ingenua, deitradizionali modi di dimostrazione e delle dottrinefilosofiche ereditate. Bacone registra così la nuovalogica della conoscenza come movimento dello spiritoverso le cose reali, matters of fact, attraverso unprocesso induttivo depurato degli idola, icondizionamenti sociali, individuali, linguistici eintellettuali.
Il mondo ‘unificato’ dapprima da portoghesi espagnoli, poi ristrutturato in termini di vera epropria economie-monde dagli olandesi, attraversato dadivisioni politiche e confessionali insanabili, alleprese con nuove ibridazioni e nuovi meticciati,sembra ora pronto per nuove imprese di documentazionee analisi, atte a strutturare un modo dirappresentazione conseguente. Un tipo ‘critico’ diuomo sembra emergere dai nuovi continenti e nuovioceani europeizzati, ai confini di realtà virtualilegittime, attraversato da abiure, tradimenti, dubbi,e suggestionato da sistemi di norme e valori diversie lontani da quelli europei.
Questo sommario quadro può servire a dare risaltoal valore innovativo del programma di ricerca diMartini, che infatti si troverà anche attraverso
7 Charles Webster, La grande instaurazione. Scienza e riforma sociale nella riforma puritana, tr. It. Milano, Feltrinelli 1980.
6
percorsi avventurosi a concepire e a dare alle stampeuno dei suoi lavori più importanti come parte di unprogetto cartografico e sociografico, il Grand Atlas,proprio attraverso il più importante stampatoredell’epoca, Joan Blaeu, che è anche un esponente diprimo piano della cultura olandese. Il primato dellacartografia olandese era dovuto alla funzioneeconomica che le veniva assegnata, ma soprattutto alrigore delle descrizioni geometriche e degli specchidistanti che la caratterizzavano8.
Il progetto di mondializzazione della realtàvirtuale cattolica, portato avanti in primo luogo daigesuiti, non era in contrasto con i vari progettistatali e privati di controllo del mercato e delladivisione mondiale del lavoro. La colonizzazionedell’immaginario esotico, avviata dagli spagnolinelle Indie occidentali, proseguiva in varie forme, el’entrata dei padri gesuiti nella Cina assumeva unsignificato innegabile: attraverso la Chiesa di Romal’Occidente poteva tentare di penetrarel’impenetrabile.
Il fatto che questa entrata dei gesuiti nella Cinafosse gestita con un paradigma petrinologico non eraun problema, anche se in quegli stessi anni stavaemergendo in Europa una prospettiva costruttivistache concepiva i saperi ‘senza fondamenti’ e come‘strutturazione metodica del caso’9. Anzi, il casocinese si presentava, o poteva essere visto proprio
8 Kees Zandvliet, Mapping for Money. Maps, plans and topographic paintings and their role in Dutchoverseas expansion during the 16th and the 17th centuries, Amsterdam, Batavian LionInternational 2002; C. Koeman, Joan Blaeu and his Grand Atlas, Amsterdam, TheatrumOrbis Terrarum 1970. Cfr. anche Kees Zandvliet, The Dutch Construction of the World in theEarly 17th Century, in Orlando Lentini (a cura di), Pensare il mondo, Angeli, Milano2005. Sulla connessione cruciale fra tecnica, filosofia e scienza nellaRepubblica Olandese, cfr. Wiep van Bunge, From Stevin to Spinoza. An Essay on Philosophy inthe Seventeenth-Century Dutch Republic, Leiden 2001.9 Aldo Gargani, Il sapere senza fondamenti. La condotta intellettuale come strutturazionedell’esperienza comune, Torino, Einaudi 1975. Per la critica del ‘fondazionismo’ cfr.Richard Rorty, La filosofia e lo specchio della Natura, Milano, Bompiani 1986.
7
come un esempio da manuale di questa nuovaprospettiva. L’apparente non strutturazione deisaperi cinesi assumeva un carattere dirompente per icritici dei saperi con fondamenti, non solo inepistemologia ma anche in etica. In ogni casopossiamo dire che nella cultura sociale del CollegioRomano non vi era sentore del mutamento di realtàvirtuale in corso in Europa.
Il processo più generale di mondializzazione cheera incominciato alla fine del Quattrocento, aveva inqualche modo anche provincializzato il Rinascimentoitaliano. Una storia globale mostra oggi come duestorie parallele si avviano a partire dalCinquecento: quella europea e quella dei rapporti fragli europei e il resto del mondo, concepito comeinsieme di ‘nuovi mondi’10. Mentre quelli che possiamochiamare gli europei di dentro mostrano stupore evedono soprattutto il mostruoso dell’Altro, quelli difuori fanno esperienza e interiorizzano nuovi mondi,facendo del meticciato la nuova condizione umana.Meticciato ideologico e meticciato biologicoproducono nuovi tipi umani. Un nuovo pensiero, questavolta meticcio, avvia il suo lavorio11.
In questo processo ormai secolare tuttavia ireligiosi impegnati nella propaganda della federestano fedeli, o tentano di restare fedeli, ai loroimpegni confessionali, limitando il metissage adalcune forme esteriori. Su questa base, il programmadi ricerca di Martini si articola in più fasi,miranti a colmare un vuoto di conoscenza moltosentito. La prima è la definizione dei tempi, quellocinese e quello europeo, evidentemente asincroni inSinicae Historiae. La seconda è la definizione dello
10 Serge Gruzinski, L’Aigle et le Dragon. Démesure européenne et mondialisation au XVIe siècle,Paris, Fayard 2012.11 Serge Gruzinski, La pensée métisse, Paris, Fayard 1999.
8
spazio sub continentale cinese nel Novus Atlas Sinensis,mentre importante gli appare la definizione delpresente cinese, raccontato però alla manieraeuropea, in De Bello Tartarico12. Inutile sottolineare ilvalore economico e politico, oltre che culturale, diquesta nuova documentazione.
Alla metà del Seicento era ancora prevalentenell’immagine del mondo europea la mitologia vetero-testamentaria, che poteva anche sovrapporsi allemitologie laiche, in particolare quelle greco-romane,senza difficoltà. Il lavoro di conciliazioneideologica, che era per lo più anche derivazione, erastato portato avanti per secoli dai cristiani. Nongrandi difficoltà presentava inoltre la conciliazionefra mondo cristiano e mondo musulmano13. Nel casodell’immaginario cinese invece l’impresa eracomplicata da scrittura e lingua, oltre chenaturalmente dalla lunga durata con le sueimplicazioni di misurazione del passato, cherendevano ardua la penetrazione del loro modo divivere e pensare il mondo.
Tuttavia l’impresa non era impossibile. Lungo tuttoil Cinquecento, in particolare nella fase delleinvestigazioni del Consiglio delle Indie, con i suoi
12 Martino Martini S.J., Opera Omnia, voll. I-V, Trento, Università degli Studi diTrento 1998-2013. La pubblicazione con traduzione dell’opera omnia di Martini èin via di conclusione. Ho sfogliato il primo brogliaccio della traduzione delNovus Atlas Sinensis alla fine degli anni ottanta nella casa di Giorgio Melis a Roccadi Papa. A lui si deve la riscoperta del grande intellettuale trentino. Tuttaviaè stato l’impegno del suo amico e collega Giuliano Bertuccioli insieme a donFranco Demarchi a rendere possibile l’opera di portare a termine l’impresafilologicamente assai complessa dell’edizione italiana, poi proseguita daFederico Masini, con la preziosa collaborazione di Luisa M. Paternicò, DavorAntonucci, Beatrice Niccolini e Stefano Rebeggiani, e col sostegno costante delCentro Martini di Trento, guidato da Riccardo Scartezzini. Con la pubblicazionedell’Opera Omnia si può considerare conclusa la fase filologica della riscopertamartiniana, che rende più agevole una sua interpretazione nella storiaideologica dell’Occidente.13 Serge Gruzinski, Quelle Heure est-il Là-bas? Amérique et islam à l’orée des Temps moderns,Paris, Seuil 2008
9
questionari e le regole molto precise per chi eraincaricato di raccogliere dati per quelle che poisarebbero state chiamate ‘relazioni geografiche’, lafigura del ricercatore sociale aveva assunto una suaidentità come raccoglitore di informazioni edocumentazione certe e verificate14.
Nel caso della Cina, non conquistata nébrutalizzata, la figura dell’osservatore partecipanterichiedeva tempi e sforzi, ma anche un atteggiamentoempatico inquadrato nei canoni dell’amicizia. Ilbreve trattato martiniano in cinese sull’amicizialascia intravvedere l’approccio empatico che superail tradizionale fondamentalismo posseviniano dellaBibliotheca Selecta (1593), ma insieme, attraverso ilriuso reiterato delle massime ciceroniane, pone laquestione di quanto importante possa essere stato ilmovimento neo-stoico di matrice lipsiana nelriorientare i gesuiti destinati all’Oriente.
Inoltre, forse non si è lontani dal vero aipotizzare che l’orizzonte politologico di Martinisia quello delineato da Lipsio in Politicorum Libri Sex(1589), che pone la prudenza al centro del suopensiero organizzativo, mentre l’esperienza attuale ela memoria delle esperienze passate sono all’originedi corsi di azione virtuosi, che rendono possibilel’arte civile. L’esperienza, insieme alla storia, che nonè altro che l’anima e la vita della memoria, producela prudenza. La vita civile si fonda sul riconoscimentodella necessità di un “determinato ordine dicommandare & d’ubbidire”, e questo ordine costituiscela struttura principale dei rapporti sociali. “Percioche senza dominio non può stare né Casa, né Città, négenerazione veruna, né l’universo genere degli
14 Sui questionarios e le relaciones ciertas y verdaderas ordinati dal Consejo de Indias,cfr. Duccio Sacchi, Mappe dal Nuovo mondo. Cartografie locali e definizione del territorio in NuovaSpagna (Secoli XVI-XVII), Milano, Angeli 1997.
10
huomini, né la natura delle cose, né finalmente ilmondo stesso”.
D’altra parte lo stesso Lipsio sta elaborando lapolitologia della coesistenza di principato e libertas,dove il “governatore di republica non deve haverealtro oggetto che il bene, & il beato vivere dicittadini”. Si tratta del riuso della tradizione neo-stoica e ciceroniana del principe prudente, virtuosoe clemente che aveva già segnato il passaggio in Romadalla repubblica al principato15, e che ora sembra dinuovo attuale in quella che possiamo chiamarel’ennesima esperienza di rimonarchizzazione16. Granparte dei paesi contro-riformati infatti viveva nelcontesto della rimonarchizzazione.
Dall’adattamento neo-stoico lipsiano si passeràsoprattutto nei paesi riformati all’elaborazione diun nuovo repubblicanesimo e soprattutto alle primematrici di quello che sarà chiamato il paradigma‘liberale’. Ciò implicava una progressivalaicizzazione dei ‘diritti naturali’ e una nuovaconcezione della libertà personale, che sarà unaconquista degli olandesi17. In generale, si assisteràad una laicizzazione complessiva della realtàvirtuale, che continuerà lungo tutto il XVIII secolo(il secolo dei lumi) e il XIX secolo (positivismo escientismo). Le teologie già nei Seicento venivanoviste come forme molto elaborate di realtà virtuale,
15 Giusto Lipsio, Della politica, overo del Governo di Stato libri sei, tr. It. e annotazioni di Hercole Cati, Venetia, Righettini 1618, L. II, cap. I. Cfr. anche Chaim Wirszubski, Libertas. Il concetto politico di libertà a Roma tra Repubblica e Impero, tr. It. Bari, Laterza 1957.16 Ho usato per la prima volta questo termine nel mio Analisi sociale machiavelliana,Milano, Angeli 1992, a proposito di repubbliche costrette a tornare alprincipato.17 Martin van Gelderen, The Political Thought of the Dutch Revolt, 1555-1590, Cambridge, Cambridge University Press 1992, pp. 281-282.
11
autoreferenziali e legate a un immaginario ormaiobsoleto18.
Quindi, da un lato abbiamo, soprattutto nei paesiriformati, la produzione di nuovi principiorganizzativi e di nuova realtà virtuale per pensareil mondo, dall’altro nei paesi contro-riformati laresistenza al cambiamento e strategie di adattamentocome quelle di Lipsio e poi dei gesuiti. Ciò chemancava al ‘pensiero’ deista o potenzialmente laicoemergente in Europa nel Seicento e rappresentato dauomini come Hobbes o Spinoza, era la pratica dellafede nel contesto di una realtà del tutto estranea eostile al proprio immaginario. Su basi confessionalii Gesuiti fanno esperienza attiva dell’altro e deldiverso, e non meramente contemplativa, attraversol’interazione e la convivenza a tutti i livellidell’esistenza umana, andando ben oltre le forme poidivenute canoniche nell’etnologia e nell’antropologiaculturale.
La questione dei ‘riti cinesi’ è un caso da manualedi strategia della convivenza, che si pone sia comeregola di un’intera comunità ecclesiale, che comeregola di interazione fra individui, in cui alcristiano cinese viene riconosciuto il diritto allacomposizione della sua realtà virtuale di base conquella nuova cui ha deciso di aderire. La ‘questionedei riti’ può essere vista come istituzionalizzazionedel coesistere di due realtà virtuali all’apparenzainconciliabili. Va detto a questo proposito chequando la ‘scienza dell’uomo’ incomincerà a darsi
18 Ciò era particolarmente vero per l’Italia, il cui ritardo ideologico ètestimoniato ancora nel primo Settecento dall’atteggiamento piuttosto retrivo diGiovan Battista Vico, nella sua Scienza Nuova, nei confronti delle ricerche diMartini sulla storia cinese. Cfr. Federico Masini, Lingua e scrittura cinese in Vico, inDavid Armando, Federico Masini, Manuela Sanna (a cura di), Vico e l’Oriente: Cina,Giappone, Corea, Roma, Tiellemedia 2008, pp. 226-227. Tutta l’opera di Vico, conla sua disinvolta navigazione nella realtà virtuale passata, costituisce unmonumento di resistenza al mutamento.
12
metodi e tecniche con intenti prettamente laici, nelXVIII secolo, sarà ancora segnata da un intentovalutativo e descrittivo in cui l’osservato ha unruolo sostanzialmente passivo, e l’osservatore unruolo di presunto distacco.
La conoscenza militante intesa anche come azione,coinvolgimento, scambio, sembra precedere laconoscenza distaccata, oggettivante, ed avere effetticostruttivi di realtà virtuale e di immaginario ditipo nuovo, destinati a rendere possibili nuovi‘mondi’ e nuove integrazioni. Naturalmente questaesperienza vissuta di intercultura non era esclusivadei Gesuiti, che semmai sono tra i primi adelaborarla ideologicamente, ma costituiva la realtàvirtuale e l’immaginario nuovo o ‘ibrido’ di migliaiadi più o meno anonimi esseri umani disseminatidall’Europa nei diversi ‘nuovi mondi’.
Innegabile comunque restava il secondo fine dellaevangelizzazione: l’asianizzazione dei gesuiti erapuramente strumentale. Mentre gli iberici avevanoimposto agli Indios con la violenza il loroimmaginario e il loro modo di pensare il mondo, igesuiti dovettero recarsi in Cina col cappello inmano e tentare di sedurre con i loro saperi, le lorobuone maniere, esponenti della classe colta eamministrativa. Tuttavia, a giudicare dalle cronache,un incontro ci fu e su basi di parità. Gli immaginarisi confrontavano, tentavano di convivere e spesso icinesi accettavano il modo di pensare il mondo deicristiani.
Possiamo anche definire quello dei gesuiti unapproccio ‘comprendente’, alla maniera dellasociologia weberiana. Martini aveva preso allalettera ante litteram il compito di intendere invirtù di un procedimento interpretativo la realtà
13
virtuale dei cinesi, ossia il loro agire socialedotato di senso, attraverso la loro millenariastoria. Nello stesso tempo aveva in programma disvolgere, sempre ante litteram, il compitobraudeliano della descrizione della cultura materialecinese, come appare nel Novus Atlas Sinensis. Sial’incontro che l’adattamento richiedevano comunquenuova produzione di senso.
A differenza di William Petty, che avviava illavoro di definizione delle dinamiche del processocostitutivo europeo19, Martini aveva assunto ilcompito di descrittore sistematico e di interprete diun mondo, un vero e proprio impero-mondo, ancoratutto da scoprire, ma sostanzialmente statico, anchechiuso. Sarebbe molto interessante valutare il NovusAtlas come punto d’arrivo della storio-geografia cheprende le sue mosse ai primi del Cinquecento condescrizioni, mappe, atlanti e inchieste, dal PadrónReal di Ferdinando d’Aragona, alle grandi inchiesteiberiche con questionario, alla Descrittione di tutti i PaesiBassi di Ludovico Guicciardini, alle Civitates OrbisTerrarum, al Theatrum Orbis Terrarum di Ortelio.
Il fascino della Sinicae Historiae Decas Prima èmolteplice. Primo perché usando fonti storiche cinesiche considera degne di fede, è in grado di esporreuna sequenza di lunghissima durata, segnata dalledinastie, che con tutta evidenza inizia ben primadella mitologia pseudo-storica del VecchioTestamento. Le parole di Martini, non fosse per latestimonianza adamantina della sua fede in Cristo,possono apparire anche come un capolavoro didissimulazione onesta. Anche se il Collegio romanomostrava una grande apertura alle nuove scienze, non
19 Per una lettura di Petty in questa ottica, cfr. Orlando Lentini, Saperi sociali, ricerca sociale…, cit. pp. 92-104.
14
era davvero facile conciliare i nuovi saperi colcanone petrinologico.
In una situazione di moderato sincretismo, fruttodi accorta selezione e di adesione al più generalemovimento europeo che aveva per centro l’areafiamminga dell’impero asburgico, una cultura socialegesuitica si era proposta come interpretazioneautentica del mondo. Governata dai principi dellaRatio Studiorum, questa cultura aveva il compito digestire la realtà virtuale contro- riformata. IlCollegio Romano appare come il luogo più autorevole,con il suo caratteristico enciclopedismo barocco20,intento a giustapporre la grande massa delle nuoveconoscenze, senza però domandarsi quale fosse lalogica del nuovo sistema storico in formazione.
L’improbabile analogia fra diluvio biblico e diluvicinesi non riesce a mascherare la consapevolezza cheMartini deve aver conseguito del caratteremitologico dei riferimenti biblici. In secondo luogol’esposizione della Decas Prima ricostruisce lematrici dei modi di vita e dello sviluppoorganizzativo del sistema imperiale cinese secondol’ottica indigena, commentata ma non manipolata. Ilriuso martiniano degli annali cinesi sembra piuttostopartecipato. Inoltre dai suoi commenti ai testicinesi, trattandosi di imperatori e di potere, emergemolta della sapienza politologica dei gesuiti, unasorta di fusione della precettistica politicalipsiana e di un sano uso di Machiavelli, che il suoconfratello Giovanni Botero aveva praticato conmaestria21.
20 M. Casciato, M. G. Ianniello, M. Vitale (a cura di), Enciclopedismo in Roma barocca.Athanasius Kircher e il Museo del Collegio Romano tra Wunderkammer e museo scientifico, Venezia,Marsilio 1986, in particolare Cesare Vasoli, Considerazioni sull’’Ars magna sciendi’. Cfr.anche Luce Giard et Louis de Vaucelles (sous la direction de), Les jésuites à l’agebaroque 1540-1640, Grenoble, Jérome Millon 1996. 21 Victoria Kahn, Machiavellian Rhetoric. From the Counter-Reformation to Milton, Princeton,Princeton University Press 1994, pp. 70-84.
15
La qualità intellettuale del lavoro di Martini nonè sminuita dal fatto che in quegli stessi anni duemostri sacri del pensiero occidentale, Hobbes eSpinoza, avessero già avviato un processo didelegittimazione dell’autorità del VecchioTestamento, derubricato in Tractatus Theologico-Politicus atradizione in gran parte costruita e priva difondamento scientifico. La mediazione gesuiticapoteva già servire da ponte fra una realtà virtualepetrinologica e la nuova realtà virtuale laicapostulata dal sistema mondiale nella sua espansioneanche ideologica. L’enfasi sulla laicità delle élitescinesi e del loro principale ispiratore, Confucio,implica il riconoscimento del valore della moraleufficiale di questa così ‘principale natione’, comeegli la definisce22.
In che modo la storiografia occidentale abbiainfluito sul canovaccio martiniano è ancora dastudiare. La storia sinica è soprattutto annalisticaintessuta di cronache, senza alcuna sofisticazionestoriografica, mentre Martini dall’Europa potevadisporre già di numerosi esempi di storie dotate disenso. Si direbbe che il gesuita non avesse alcunproblema ad attestarsi sulle storio-geografie che sierano consolidate nell’arco di centocinquant’anni edi cui egli sarebbe stato l’esponente più illustrenel Seicento. Inoltre, Martini ci presenta un mondosenza impegnarsi in paradigmi, come era del resto ilcaso del Mediterraneo braudeliano all’epoca diFilippo II. I paradigmi infatti erano ancora allostato nascente, e Petty stava per divenirne proprioallora uno dei precursori.
22 Martino Martini S.J., Opera Omnia, ed. diretta da Franco Demarchi, vol. I, acura di Giuliano Bertuccioli, Trento, Università degli Studi di Trento 1998, p.327.
16
2. La nuova Cina come civilizational state ?
Come sappiamo, la storia ideologica dell’Occidentedopo l’avvio della nuova strutturazione dei saperisociali nel Cinquecento, si organizza producendo lanuova realtà virtuale che dovrà servire il sistemastorico in formazione. Si tratta di un processo chefa parte del più complessivo processo costitutivo delnuovo sistema mondiale. In questa ottica, fra Sette eOttocento appare evidente il carattere dinamico dellaproduzione di realtà virtuale in Europa, rispetto alcarattere quasi statico della riproduzione dellarealtà virtuale cinese, non a caso allora più attentaa passioni e sentimenti che a ragione e scienza23.
Diventa quindi legittimo chiedersi in che modoquesta realtà virtuale orientale quasi statica econtenta di se, abbia poi tentato di recuperare ilritardo rispetto a quella ormai decisamenteorganizzativa e costruttiva degli Occidentali24. Dopola presa di coscienza del divario organizzativo, allafine dell’Ottocento intellettuali cinesi incomincianoa tradurre i testi canonici dell’economia e delliberalismo e queste traduzioni implicano unapropensione all’imitazione degli europei o degliamericani. I giapponesi lo avevano già fatto consuccesso. Il canone liberale e repubblicano guida laprima rivoluzione di Sun Yat Sen. D’altra parte,l’imitazione ideologica e organizzativa è semprestata alla base sia dello sviluppo economico che delconfronto scontro fra popoli e culture25.
23 Paolo Santangelo, Sentimental Education in Chinese History. An Interdisciplinary Textual Researchon Ming and Qing Sources, Leiden – Boston, Brill 2003.24 Si veda ad es. Milena Doleželová-Velingerová, Rudolf G. Wagner (eds.), ChineseEncyclopaedias of New Global Knowledge (1870-1930). Changing Ways of Thougt, Berlin, Springer2014.25 Merita di essere citato a questo proposito il vecchio studio di Gabriel Tarde,Les lois de l’imitation, Paris 1890, piuttosto attuale allora, in una fase che veniva
17
Tuttavia nel frattempo in Europa si era affermatoun nuovo canone, il liberal-marxismo, che entrerà afar parte di un nuovo modo di pensare il mondo e poicon la vittoria di Mao si tradurrà in marxismo-stalinismo. Questo nuovo canone, condiviso dallanuova dirigenza e imposto all’intelligentsia, indurràad una nuova lettura della storia cinese e allaproduzione di una nuova realtà virtuale cinese perpensare il mondo, con forzature e imbrigliamenti delpassato del tutto implausibili. La storiografiamarxista in Cina fra mille acrobazie inventatransizioni dal feudalesimo al capitalismo, lotte diclasse piuttosto schematiche, stadi dello sviluppo eogni altra componente di un modo di pensare il mondodi tipo ottocentesco26.
Questa fase di adattamento cinese alla realtàvirtuale europea, che nel frattempo stavamanifestando la sua obsolescenza, entra in crisi nelmomento in cui in tutto il mondo entra in crisi illiberal-marxismo e la sua appendice struttural-funzionale che va sotto il nome di ‘teoria dellamodernizzazione’. Quelle modernizzazioni che ai tempidi Martini venivano assunte a piccolissime dosi, sonostate alla fine poste al centro della costruzione diuna nuova Cina. Continua pertanto a destareperplessità il tentativo di Andre Gunder Frank didimostrare che la Cina non è mai stata periferica eche al contrario ha mantenuto la sua posizionecentrale in quella che egli chiama ‘the Asian Age’27.
definita imperialista.26 Huaiyin Li, From Revolution to Modernization: The Paradigmatic Transition in ChineseHistoriography in the Reform Era. ‘History and Theory’, 49, October 2010. 27 Andre Gunder Frank, ReOrient. Global Economy in the Asian Age, Berkeley and LosAngeles, University of California Press 1998; Weiwei Zhang, Global History from aNoncentric and Holistic Perspective: in Memory of Professor Andre Gunder Frank, Paper presented atthe International Conference: ‘Andre Gunder Frank’s Legacy of Critical SocialScience’, Pittsburg USA, April 1998. Caratteristico, insieme a Frank,l’atteggiamento di molti esponenti della cosiddetta ‘sinistra mondiale’ chehanno tentato di adeguare i loro quadri interpretativi di fronte alla
18
Nel passaggio fra la guida di Mao e quella di Deng,unomondismo, terzomondismo, movimenti culturali divaria natura delegittimano il mito del fardellodell’uomo bianco, demistificano ogni sorta di‘orientalismo’ e pongono la questione di nuovi modiindigeni di definire la situazione e anche di nuovimodi di pensare il mondo. Non più soltanto i paesicentrali, ma anche i cosiddetti paesi non allineatiincominciano a produrre le loro storie. Non esistonopiù paesi ‘senza storia’. Storie globali, storieconnesse, post-colonial studies e mille altre tensioniideologiche pongono il problema di una nuova realtàvirtuale per pensare e vivere il mondo nella fasedella mondializzazione avanzata, una storia che èincominciata più di cinquecento anni fa28. L’ultima risposta della Cina dopo Mao verrà da DengXiaoping, che sceglierà la via delle modernizzazionioccidentali, ancora una volta imitazioneorganizzativa, e nello stesso tempo ribadirà lacapacità dello Stato cinese di prodursi la suaspecifica civiltà29. Inutile ricordare come la Cinarientra nel mercato mondiale attraverso lapenetrazione delle giant corporations e ledelocalizzazioni occidentali. Tuttavia, l’orgoglioritrovato finalmente può dare avvio a nuovi tentatividi prodursi la propria realtà virtuale. Lo spettacolare balzo in avanti della Cina pone alcentro della proiezione politica ed economica delPartito Comunista Cinese, novello imperatorecollettivo, lo spirito acquisitivo e possessivo. Si
sorprendente espansione economica della Cina, fra i quali cfr. Giovanni Arrighi,Adam Smith a Pechino. Genealogie del ventunesimo secolo, Milano, Feltrinelli 2008. 28 Le origini della mondializzazione, nell’ottica con cui molti studiosi francesiaffrontano il tema della globalizzazione, sono al centro degli studi di SergeGruzinski. Cfr. di Gruzinski, La mescolanza dei mondi della Monarchia Cattolica o le originiiberiche della mondializzazione, in Orlando Lentini (a cura di), Pensare il mondo, cit., eId., Les quatre parties du monde. Histoire d’une mondialisation, Paris, La Martinière 2004.29 Weiwei Zhang, The China Wave. Rise of a Civilizational State, Hackensack (NJ), WorldCentury Publishing Corporation, 2012.
19
tratta dell’orientamento ideologico del cosiddetto‘libero popolo inglese’ e del suo universocommerciale, con i suoi operatori economici, cheaveva caratterizzato il decollo europeo comeindividualismo possessivo, e che ora invece in Cina,in carattere con l’economia profetica di FriedrichList, si presenta ancora una volta come ‘sistemanazionale di economia politica’30.
Durante il regime di Mao migliaia di intellettualiin tutto il mondo avevano esaltato il ‘comunismocinese’, la ‘rivoluzione culturale’ e altre presunteacquisizioni del primo e piuttosto volontaristico‘grande balzo’. Ora è il turno dei sostenitori dellaCina come ‘nuovo modello di sviluppo’, anzi comepaese destinato all’egemonia nel sistema mondialedell’economia e nel sistema interstatale, che creeràun nuovo ordine globale31. Insomma con l’ennesima fugain avanti molti intellettuali parlano già di ‘finedell’Occidente’. La cosa forse è plausibile, ma nonnella forma adombrata dal nuovo mito dell’Oriente.
L’argomentazione di Weiwei Zhang riprende lasuggestione di Martin Jacques, della Cina come statoche produce civiltà, e che attraverso unacivilizzazione endogena è in grado di generare i suoipropri standard e valori, avviando un nuovo modellodi sviluppo e un nuovo ‘discorso politico’. L’ondacinese sembra inarrestabile. Naturalmente il‘discorso politico’ ha a che fare con la questione se
30 Si tratta della critica al liberoscambismo astratto e ad Adam Smith, checoncepisce lo sviluppo organizzativo in termini di agire economico eistituzionale di gruppi imprenditoriali uniti da un vincolo ‘politico’;Friedrich List, Il sistema nazionale di economia politica ( 1841),tr. It. Milano, ISEDI1972. La missione ‘statalista’ e antiliberista di List parte dal sostegno allemisure di protezione industriale introdotte da Hamilton negli Stati Uniti, e poialla base del decollo economico di quel paese, con Outlines of Political Economy (1827)e culminerà nel sostegno all’unione doganale tedesca.31 Martin Jacques, When China Rules the World. The End of the Western World and the Birth of a New Global Order, New York, Penguin 2009.
20
la Cina debba seguire i percorsi di democratizzazionegià sperimentati in Occidente. Zhang non lo ritienené necessario né opportuno, anche se molti altricinesi pensano che la ‘democrazia sia una cosabuona’32.
Questo entusiasmo politologico nei confronti di unpresunto ‘modello cinese’ merita qualche riflessione.La Cina si trova al momento al centro del sistemamondiale dell’economia grazie ad una serie di fattoriconvergenti, che vanno dalla penetrazione delle giantcorporations, alle delocalizzazioni occidentali,all’enorme massa di forza lavoro disponibile, alrisveglio di un ceto medio già dotato di cultura ecapacità organizzativa, all’elasticità imposta alPartito Comunista Cinese da Deng Xiaoping, etc.Tuttavia la strategia adottata non si discosta dimolto da quella disegnata da List prima negli StatiUniti e poi in Germania. Forse non sono più tempi di‘egemonia di un solo paese’, ma la storia economicadegli ultimi cinquecento anni sembra seguire unpercorso che neanche la Cina smentisce.
La Cina si considera ormai uno Stato in grado diprodursi la sua civiltà, senza dover chiedere inprestito quelle altrui. Si direbbe dunque che siamocosì tornati al Seicento, alla grande Cina di MartinoMartini, dopo un lungo e tormentato dialogo e nondialogo con la ‘civiltà occidentale’. Ma i problemidi convivenza e compatibilità dovranno ora essereaffrontati secondo le nuove contingenze organizzativedi un mondo ormai diventato unico. Le realtà virtualiin formazione confermeranno l’idea che l’immaginario
32 Yu Keping, Democracy is a Good Thing. Essays on Politics, Society and Culture in ContemporaryChina, Washington, Brookings Institution Press 2009. Dal momento che la domandadi democrazia specie dei ceti medi e del lavoro dipendente è inarrestabile intutto il mondo, saranno i cittadini cinesi a stabilire che tipo di democrazia sidaranno.
21
mondiale non può che essere meticcio. Così pure perquanto riguarda la nuova intelligenza collettiva.
In effetti, i modi di pensare il mondo ai tempi diMartini erano molti e diversi, in conflitto fra loro,apparentemente incomunicabili. Ogni ‘mondo’ aveva lasua geocultura e il suo sistema di norme e valoricondiviso. Eppure già a partire dal Cinquecento lestrategie di convivenza della Scuola di Salamanca edi Francisco de Vitoria nelle sue Relectiones, inparticolare De Indis, i progetti irenisti diavvicinamento non violento alle altre culture,praticati nel circolo orteliano di Anversa, aprivanola via al nuovo diritto internazionale e allacomprensione dell’altro. Molti di questi spuntiverranno poi assunti dai gesuiti, convintidell’esistenza di un nucleo di pietà comune a tutti ipopoli.
Le vie verso l’uniformazione sono state molteplici,con lunghe interruzioni, violenze inaudite siafisiche che ideologiche come nel caso dell’Indiasotto il giogo inglese, o nel caso delle varieAfriche, violenze rubricate come colonialismo,imperialismo, ma anche come civilizzazione,modernizzazione etc. Alla fine si è giunti allaconclusione di un processo che aveva la sua dinamicanella formazione di una divisione mondiale dellavoro. Ormai non sembra esserci dubbio che unadivisione mondiale del lavoro implica una suaspecifica geocultura o realtà virtuale.





















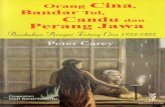






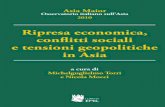






![[rec. a] Alvise Andreose, La strada, la Cina, il cielo. Studi sulla «Relatio» di Odorico da Pordenone e sulla sua fortuna romanza, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2012](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6339de7a2e67deabc605800d/rec-a-alvise-andreose-la-strada-la-cina-il-cielo-studi-sulla-relatio.jpg)






