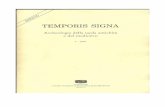L'insediamento rustico di Isola del Piano (PU): tra tarda Antichità e alto Medioevo
Transcript of L'insediamento rustico di Isola del Piano (PU): tra tarda Antichità e alto Medioevo
1
GIULIA BARTOLUCCI – GENNY GRAZIANI
L’INSEDIAMENTO RUSTICO DI ISOLA DEL PIANO:
TRA TARDA ANTICHITÀ E ALTO MEDIOEVO.
L’insediamento di Isola del Piano sorge nel complesso collinare delle Cesane – tra le
vallate dei fiumi Metauro e Foglia – all’interno un territorio geomorfologicamente molto
vario. Le colline disposte lungo le dorsali del fiume Metauro conservano numerose tracce di
insediamenti rurali, legati, oltre che alle ovvie condizioni che rendono le vallate fluviali
favorevoli ad installazioni
stabili, alla presenza della
via consolare Flaminia. Tra
la fine del IV e il VI secolo,
le mutate condizioni socio-
economiche iniziano ad
essere percepite
direttamente dalla
popolazione locale,
sancendo la scomparsa della
maggior parte delle città di
fondovalle dell'Umbria
Adriatica come Pitinum
Pisaurense, Sestinum,
Pitinum Mergens, Tifernum
Metaurense, Suasa,
Sentinum, Ostra 1. Il
paesaggio dominato da
campi coltivati e regolati
dalla centuriazione alternati
ad un incolto marginale, viene sostituito da uno scenario dove aree coltivate ed incolto si
intrecciano mentre il bosco La stessa viabilità subisce profonde trasformazioni con il
1 ALFIERI 1981, p.233
Fig. 1 Pianta genarale del sito di Isola del Piano - Loc. Pian 'de Paoli
2
Fig. 2 Focolare all'angolo NW dell'ambiente A
moltiplicarsi di diverticoli intervallivi alternativi alla via consolare percorsa dagli eserciti
visigoti. All’ arco cronologico compreso tra IV e VI sec. d.C. può essere attribuito
l’impianto rustico di Isola del Piano, oggetto di indagini archeologiche2 nell’estate del 2012.
LE STRUTTURE
L’area in questione, situata in località Pian ‘de Paoli, fu oggetto di indagini preliminari3 che
portarono all’individuazione di due aree distanti tra loro poche decine di metri, l’AREA A,
in seguito scavata in maniere estensiva,
e l’AREA B che, nonostante abbia
restituito anomalie di maggior intensità,
non rientrava nell’interesse della
committenza. Gli scavi archeologici
condotti nell’AREA A hanno
evidenziato la presenza di un
complesso insediativo rustico composto
da dieci ambienti orientati in direzione
N-S lungo tre assi parallele (Fig.1). Le strutture murarie si
presentano generalmente come resti di fondazioni, mentre in
alcuni casi si conserva la sola traccia negativa della trincea di
fondazione. Il corpo centrale vede un edificio a pianta
quadrangolare di circa 20 mt di lato al quale si accede
presumibilmente da S-E (area L) per mezzo di una apertura di
cui si conserva la soglia e dove sono state individuate tracce
di incannucciato che inducono a presupporre la presenza di
una qualche struttura in materiale deperibile, forse a
protezione dell’ingresso principale. Nell’area N-NE sono
2 Alle indagini archeologiche si è proceduto secondo quanto stabilito dal progetto di scavo redatto dalla
Cooperativa Aion, approvato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche sotto la direzione
tecnico-scientifica della Dott.ssa M. G. Cerquetti. 3 Nell’Estate 2008 fu eseguito il survey su tutto il terreno compreso nel Piano di Lottizzazione, seguite da
geoprospezioni realizzate sulle due aree di interesse archeologico individuate guidate dalla dalla Cooperativa
Aion in accordo con la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche sotto la direzione tecnico-
scientifica del Dott. G. Baldelli.
Fig. 3 Olletta proveniente dal
focolare all'ambiente A
3
Fig. 4 Particolare della pavimentazione all'angolo SE dell'ambiente G
state rinvenute vasche per la
raccolta e la torchiatura di
uva o olive – delimitate a N e
ad W da porzioni murarie in
fondazione parzialmente
conservate che delimitavano
un’area presumibilmente
cortilizia recintata. Le
strutture murarie sono
realizzate in scaglia bianca
locale proveniente dai Monti delle Cesane, messa in opera a secco per mezzo della tecnica
“disordinata”4.
Purtroppo il cattivo stato di conservazione degli ambienti non ha generalmente permesso la
loro definizione funzionale; tuttavia le caratteristiche strutturali fanno ipotizzare allestimenti
semplici con pavimentazioni in battuti a volte interessati da strati di malta per
l’alloggiamento di assi in legno che vanno a denotare un modesto livello abitativo dove non
si avverte una distinzione netta tra gli ambienti abitativi e quelli destinati alla produzione.
L’unico ambiente ad uso sicuramente domestico è costituito dal vano A (Fig. 2) dotato di
focolare a terra (conservato in fondazione) delimitato da tegole in frammenti disposti con
andamento semicircolare intorno ad una buca, al cui interno è stata rinvenuta un’olletta in
rozza terracotta (Fig. 3) un coperchio con presa a bottone. Il carattere domestico viene
ulteriormente avvalorato anche dal rinvenimento di una fuseruola da telaio al centro
dell’ambiente. Funzioni legate allo stoccaggio sono invece riconducibili al vano G (Fig. 4),
che presenta una struttura rettangolare in fondazione all’angolo SE costituita da un
perimetro in pietre disposte di taglio che delimita un piano in tegole di grandi dimensioni
perlopiù frammentate, coperto da uno strato omogeneo di argilla concotta e residui di
cocciopesto allo scopo di isolare il pavimento rendendo il deposito adatto alla
conservazione di granaglie. Alcuni confronti a riguardo provengono dal sito di Monte Torto
di Osimo (AN)5 o dalla Villa di Settefinestre (GR)
6. Il rinvenimento all’interno del vano C
4 Vale a dire realizzata con elementi che vanno ad interessare l’intero spessore del muro contraddistinto da
frammenti di pietre con la stessa curvatura. MANNONI et alii 1991, pp. 151-161 e CAGNANA 1994, pp. 41-45. 5 PIGNOCCHI, HÄGGLUND 2001, p. 29, fig. 13.
6 CARANDINI 1985, pp. 197-198, fig. 293.
4
di un elemento circolare in piombo con
Fig. 5 Fondazione parzialmente conservata della Vasca 1
foro centrale a sezione quadrata – probabile ingranaggio in cui andava ad inserirsi il perno
di rotazione della parte superiore della mola (catillus)7 - lascia presumere che parte dei
cereali stoccati venissero macinati in loco
poiché abbiamo indizi a sostegno della
presenza di macine per la molitura delle
granaglie anche se non disponiamo di
evidenze sufficienti per attribuire
all’ambiente C o a quelli adiacenti funzioni
di laboratori per la trasformazione del
grano o
simili. Con
certezza è invece
possibile determinare le funzioni svolte nell’area N, spazio
aperto probabilmente recintato posto lungo il limite N-NE,
dove sono state individuate tre strutture funzionali alla
torchiatura di uva o olive e allo stoccaggio delle derrate. La
prima struttura (Fig. 5), conservata parzialmente in
fondazione, è costituita da due vaschette delimitate da una
canaletta in tegole e malta, rivestite internamente da uno strato
di calce mista a ghiaia molto compatto, utilizzate per la decantazione dei liquidi (Vasca 1).
Della Vasca 2 (Fig.6) si conserva tutto il perimetro e la parte interrata (da 40 cm a 50 cm)
7 ADAM 1988, pp. 347-349.
Fig. 6 Struttura relativa alla produzione di vino o olio
Fig. 7 Particolare della Vasca 2
5
costituita da blocchi lapidei di media grandezza e frammenti di laterizi, intonacata nella
parte inferiore e nel fondo da uno strato compatto di cocciopesto (calcatorium);
quest’ultimo presenta una buca per l’alloggio di un contenitore fittile destinato alla raccolta
del liquido che, data la pendenza, convogliava verso di esso (Fig.7). Infine due gradini in
pietra posti a S-O della vasca facilitavano la discesa nella vasca per ripulirla da eventuali
residui. In genere questo tipo di frantoio sembra essere funzionale alla produzione del vino8
anche se non mancano confronti con vaschetta similari destinate alla raccolta dell’olio a
Monte Torto di Osimo9 o a Cesano di Senigallia
10.
L’Area N ha inoltre restituito un’altra struttura interrata, profonda circa 2 mt con muri in
pietra e pavimentazione in
cocciopesto parzialmente conservata
che risale per circa cm 10 sulle
pareti. (Fig. 8) Tale ambiente è stato
identificato come cella vinaria, luogo
dove avveniva la fermentazione del
mosto. Al suo interno sono stati
rinvenuti numerosi frammenti
ceramici, dolia e anfore, che
proverebbero il suo interro prima
dell’abbandono del sito. Tali indicazioni sono possibili anche sulla base di confronti con i
già citati siti di Monte Torto di Osimo, Cesano di Senigallia, ed ancora con il sito di
Colombara di Acqualagna11
, la Villa di Settefinestre12
, la Villa di Plinio il Giovane a San
Giustino13
.
I DATI MATERIALI
La classificazione e lo studio preliminare dei reperti ceramici provenienti da Isola del Piano
risentono indubbiamente dell’assenza di sequenze stratigrafiche affidabili dal momento in
cui ci troviamo di fronte a contesti prevalentemente aperti, alterati dallo sfruttamento
8 BELLINI, REA 1985, p. 119.
9 HÄGGLUND 2001, p. 48, fig. 38.
10 SALVINI 2003, p. 78, fig. 4.
11 LUNI, UTTOVEGGIO 2002, p. 34 fig. 6
12 CARANDINI 1985.
13 BRACONI 1999, pp. 21-42.
Fig. 8 Cella per lo stoccaggio dei prodotti agricoli
6
Fig. 9 Frammento di piatto in sigillata tarda
dell'Italia centro-settentrionale
agricolo dell’area nel corso dei secoli. In assenza di riferimenti stratigrafici risultano
indispensabili i confronti provenienti da siti romani che presentano fasi di frequentazione
tarde, situati sia in territorio marchigiano che nelle regioni limitrofe.
CERAMICA DA MENSA - Già ad un primo approccio ai reperti ceramici i dati riguardanti
il vasellame da mensa inducono a supporre che tale funzione venisse principalmente svolta
da vasellame comune, perlopiù privo di rivestimento. I frammenti presi in esame in questa
sede rientrano all’interno di quella minoranza di reperti ceramici che presentano un qualche
tipo di trattamento delle superfici e di rivestimento.
Lo scavo ha restituito un solo frammento di sigillata tarda che presenta le caratteristiche
suddipinture brune della cosiddetta sigillata medio adriatica (Fig.9): si tratta di un
frammento di piatto, rivestito da una vernice rosso-arancio con un motivo dipinto in bruno a
cerchi concentrici, proveniente dallo scavo della
Vasca 3; nonostante l’unicità del reperto, esso
costituisce tuttavia un elemento datante di non
poco conto. Tale frammento è stato rinvenuto in
associazione alle classi ceramiche da mensa in
uso tra tarda antichità e alto medioevo nella parte
settentrionale delle Marche e in Romagna, tutte
attestate da poche decine di frammenti:
sigillata tarda di produzione locale che, pur
non presentando motivi suddipinti, può
essere avvicinati dal punto di vista dell’impasto e del rivestimento al frammento in
“sigillata medio adriatica”. Diversa risulta invece la forma, avvicinabile alle
produzioni africane. (7 frr.) (Fig.10)
ceramica comune verniciata, gruppo numeroso di frammenti (72 frr.) che presentano
caratteristiche diverse, soprattutto per quel che riguarda l’impasto, caratterizzate
tuttavia da un rivestimento rosso polveroso e poco tenace; all’interno di questo
macrogruppo emerge una serie di frammenti (17 frr.) che presentano un impasto
rosso-arancio, simile dal punto di vista macroscopico a quello della ceramica comune
e un rivestimento rosso steso in maniera volutamente disomogenea a formare cerchi
concentrici lungo tutto il corpo del vaso;
7
In assenza di indagini archeometriche,
è possibile constatare notevoli
vicinanze tra la ceramica da mensa
proveniente da Isola del Piano e alcuni
contesti limitrofi come il complesso di
Colombarone, 14
in parte la stessa
Forum Sempronii. 15
ma soprattutto la
domus dei mosaici a Tifernum
Mataurense 16
, sito che, a partire dalla
tarda antichità, rimane ai margini dei grandi commerci legati alla via Flaminia: qui la richiesta
di vasellame da mensa veniva soddisfatta principalmente all’interno di un’ottica basata
sull’autoconsumo, che subiva tuttavia il fascino e l’influenza delle merci d’importazione,
prima tra tutte la cosiddetta ceramica medio adriatica. Tra IV e V sec. sono stati infatti datati i
forni rinvenuti in loco assieme ad
alcuni frammenti di scarto, relativi all'
impianto di un'officina che produceva
ceramiche da mensa con rivestimento
rossastro poco tenace e scadenti
imitazioni di medio adriatica.17
Durante l'ultima fase di occupazione si
assiste ad una riduzione delle
attestazioni di sigillata “medio
adriatica”, comunque attestata in
forme tarde, datate tra IV e V sec. d.C.,
e ad un aumento dei rinvenimenti di
ceramica a vernice rossa.
CERAMICA DA FUOCO - La classe ceramica più rappresentata tra i reperti provenienti da
Isola del Piano è costituita dalla ceramica grezza da cucina, produzione ben caratterizzata per
14
Per approfondimenti sulle ricerche condotte a Colombarone vedi: DALL’AGLIO, VERGARI 2001 15
GORI, LUNI 1982, p.129 16
Per approfondimenti sull'area archeologica di Tifernum Mataurense e sui rinvenimenti materiali vedi:
TORNATORE 2006 17
Ivi, p.105.
Fig. 11 Frammento di olla in ceramica comune da fuoco con
decorazione incisa
Fig. 10 Frammento di ciotola in sigillata tarda di produzione
locale
8
Fig. 12 Lucerna di produzione locale la cui forma rimanda a
produzioni africane
quel che riguarda l’impasto, le forme e quando presenti, gli elementi decorativi. L’argilla è di
colore nerastro, ricca di inclusi degrassanti anche superficiali che conferiscono alla superficie
un aspetto poroso ed irregolare al tatto. Dal punto di vista formale il repertorio appare
notevolmente semplificato rispetto alle forme in uso nei secoli precedenti, frutto di un sistema
produttivo che fa dell’esigenza pratica il primo criterio da soddisfare. Le forme attestate in
ceramica grezza sono essenzialmente tre: le olle con orlo estroflesso, le ciotole con orlo
rientrante e i coperchi con presa a bottone. Un altro aspetto di uniformità è rappresentato dalla
decorazione, incisa a pettine con andamento rettilineo, rettilineo e ondulato, più raramente
solo ondulato che occupa principalmente l’orlo, sia internamente che esternamente, e la
parete, soprattutto nella sua parte superiore. Il sito che più di altri ha fornito confronti puntuali
e che ha consentito un inquadramento cronologico per quanto riguarda i reperti in ceramica
grezza rinvenuti a Isola del Piano resta l’insediamento rurale di Monte Torto di Osimo
(AN)18
, dove, con la conclusione della guerra greco-gotica, si assiste alla comparsa di
elementi materiali, strutturali e culturali del tutto nuovi tra i quali una produzione di
vasellame da fuoco in ceramica grezza che si caratterizza per l’assoluta omogeneità di
impasto, forme e decorazione, aspetti che trovano pienamente riscontro nella ceramica grezza
proveniente da Isola del Piano.
LUCERNE - Nonostante ci troviamo di fronte ad un campione quantitativamente ridotto (solo
cinque i frammenti di lucerne
rinvenuti) molte sono le
informazioni scaturite ad un primo
approccio al materiale e, con esse,
anche qualche perplessità.
Un rinvenimento piuttosto
significativo è rappresentato da una
lucerna la cui fattura conferma
l’indubbia provenienza locale la
sua forma rimanda a produzioni
africane, in particolare all’Atlante
VII, databile tra V e VI sec. (Fig.12). Alla produzione locale fa riferimento anche la vasca di
18
G. PIGNOCCHI 2001
9
forma allungata rinvenuta pressoché integra, per la quale non sono stati per ora individuati
confronti puntuali, mentre resta difficile definire se il frammento di firmalampen rinvenuto
all’interno della Vasca 3 sia anch’esso da considerare un’imitazione locale o un prodotto
d’importazione per la pessima conservazione del reperto.
CONCLUSIONE
Ad una prima analisi, i reperti ceramici rinvenuti descrivono un arco cronologico che va dal
III-IV secolo, momento di massima fioritura della cosiddetta sigillata medio adriatica, e il VI
secolo. Si tratta in definitiva di un insediamento sorto ex novo in età tardo antica non distante
dalla Via Flaminia e da Forum Sempronii, città abbandonata tra la fine del IV e l’inizio del V
secolo19
, con ogni probabilità, da mettere in relazione con le strutture individuate nell’AREA
B dove, le geoprospezioni, mostrano la presenza di strutture murarie più consistenti con
evidenti crolli. Tra i materiali da ricognizione spicca la presenza di un frammento di anfora,
forse riferibile al tipo Dressel 620
; se così fosse avremmo un insediamento prima età imperiale
e, poco distante, un impianto tardo antico di dimensioni più modeste, sorto probabilmente in
seguito all’abbandono del precedente, cosa che testimonierebbe comunque un certo
dinamismo nel contesto rurale della media vallata del Metauro.
BIBLIOGRAFIA
ADAM 1988 = J.P. ADAM, L’arte di costruire presso i romani. Materiali e tecniche, Milano
1988.
ALFIERI 1981 = N. ALFIERI, Le Marche e la fine del mondo antico in G. PACI (a. c.),
“Scritti di topografia antica sulle Marche” Tivoli 2000, pp. 221-241
BELLINI, REA 1985 = G.R. BELLINI, R. REA, Note sugli impianti di produzione vinicolo-
olearia nel suburbio di Roma, in SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI ROMA (a. c.), Misurare
la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano. Città, agricoltura, commercio: materiali
da Roma e dal suburbio, Modena 1985.
BRACONI 1999 = P. BRACONI, La villa di Plinio a San Giustino, in P. BRACONI, J.U. SÁEZ (a.
c.), La villa di Plinio il Giovane a San Giustino. Primi risultati di una ricerca in corso,
Perugia 1999, pp. 21-42.
19
GORI-LUNI 1983, p.98 20
GORI 2003, p.34
10
CAGNANA 1994 = A. CAGNANA, Archeologia della produzione fra tardo-antico e alto
medioevo: le tecniche murarie e l’organizzazione dei cantieri, in G.P. BROGIOLO (a. c.),
Edilizia residenziale tra V e VIII secolo, Monte Barro – Galbiate (Lecco) 1994, pp. 39-52.
CARANDINI 1985 = A. CARANDINI, Settefinestre. Una villa schiavistica nell’Etruria romana,
Modena 1985.
DALL'AGLIO-VERGARI 2001 = P. L. DALL'AGLIO - M. VERGANI, Scavi e ricerche nel
complesso tardoantico di Colombarone (Pesaro) in "Scavi Medievali in Italia (1996-1999).
Atti della II conferenza Italiana di Archeologia Medievale", Roma 2001, pp. 151–172.
GORI 2003 = G.GORI, Isola del Piano dalla preistoria a feudo Castiglioni, Urbania 2003
GORI-LUNI 1982 = G.GORI – M.LUNI, Edificio termale a Forum Sempronii. Nota
preliminare in «Picus II», 1982, pp.119-129
HÄGGLUND 2001 = R.V. HÄGGLUND, Gli impianti produttivi di II fase, in SERVIZIO EDITORIA
DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER LE MARCHE (a. c.), Monte Torto di Osimo.
L’impianto produttivo, Falconara 2001, pp. 41-48.
LUNI, UTTOVEGGIO 2002 = M. LUNI, F. UTTOVEGGIO, Il territorio dell’Umbria e dell’ager
Gallicus attraversato dalla Flaminia nelle fonti antiche, in M. LUNI (a. c.), La via Flaminia
nell’ager Gallicus, Urbino 2002, pp. 21-67.
MANNONI et alii 1991 = T. MANNONI, A. CAGNANA, S. FALSINI, P. GHISLANZONI, D.
PITTALUGA, Archeologia e archeometria dei muri in pietra. Superfici e strutture in Liguria, in
G. BISCONTIN, D. MIETTO (a. c.), Le pietre nell’architettura: struttura e superfici, Bressanone
1991, pp. 151-161.
PIGNOCCHI 2001 = G. PIGNOCCHI, Ceramica grezza (Fasi V) in SERVIZIO EDITORIA
DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER LE MARCHE (a. c.), Monte Torto di Osimo.
L’impianto produttivo, Falconara 2001, pp.131-134
PIGNOCCHI, HÄGGLUND 2001 = G. PIGNOCCHI, R.V. HÄGGLUND, Gli scavi (1982-1995), in
SERVIZIO EDITORIA DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA PER LE MARCHE (a. c.), Monte
Torto di Osimo. L’impianto produttivo, Falconara 2001, pp. 25-30.
SALVINI 2003 = M. SALVINI, Area archeologica e museo La Fenice, Senigallia 2003.
TORNATORE 2006 = M. TORNATORE (a. c.), Una domus con mosaici a Tifernum
Mataurense (Sant'Angelo in Vado), Urbania 2006